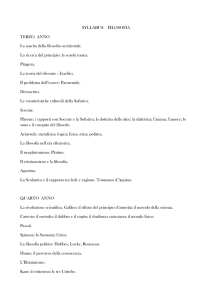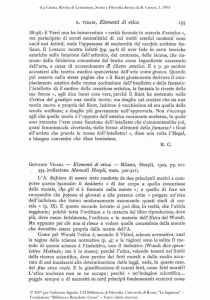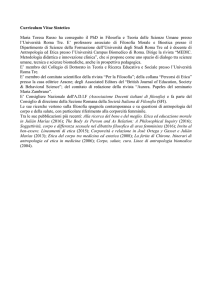NOTIZIE DI FILOSOFIA
EVENTI CULTURALI - LABORATORIO DI IDEE
NOTIZIARIO TRIMESTRALE — N° 7, OTTOBRE 2008
Per una conversazione sull' Etica.
Nuove declinazioni di un pensiero classico
A CURA DI SCILLA BELLUCCI & LAURA BERITELLI
PHILOSOPHICAL MAGAZINE ISSUE N.7, OCTOBER 2008 ‐ ISSN: 1972‐1293 NOTIZIE DIFILOSOFIA
EVENTI CULTURALI
LABORATORIO DI
IDEE
Biblioteca Filosofica © 2007 ‐ Humana.mente, Periodico trimestrale di Filosofia, edito dalla Biblioteca Filosofica ‐ Sezione Fiorentina della Società Filosofica Italiana, con sede in via del Parione 7, 50123 Firenze (c/o la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze) ‐ Pubblicazione regolarmente iscritta al Registro Stampa Periodica del Tribunale di Firenze con numero 5585 dal 18/6/2007. REDAZIONE ‐ Via del Parione 7, Firenze, presso Biblioteca Filosofica ‐ Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze ♦
♦
♦
♦
Direttore editoriale: Alberto Peruzzi Direttore responsabile: Duccio Manetti Vice‐direttore: Silvano Zipoli Supervisore scientifico: Marco Salucci Redattori e Area di Ricerca: Scilla Bellucci ‐ Filosofia del Linguaggio / Antropologia Filosofica Laura Beritelli ‐ Filosofia del Linguaggio / Ermeneutica Filosofica Alberto Binazzi ‐ Filosofia della Mente / Scienze Cognitive Matteo Borri ‐ Filosofia e Storia della Scienza Giovanni Casini ‐ Filosofia della Scienza / Logica Roberto Ciuni —Ontologia/Logica Chiara Erbosi ‐ Bioetica / Filosofia della Mente Marco Fenici – Logica/ Scienze Cognitive Riccardo Furi ‐ Filosofia della Mente Tommaso Geri ‐ Filosofia del Linguaggio / Ermeneutica Filosofica Matteo Leoni ‐ Antropologia Filosofica Stefano Liccioli ‐ Filosofia Morale Umberto Maionchi ‐ Filosofia della Scienza / Logica / Filosofia del Linguaggio Francesco Mariotti ‐ Storia e Filosofia delle Neuroscienze / Filosofia della Mente Giovanni Pancani ‐ Filosofia Politica / Antropologia Filosofica Daniele Romano ‐ Filosofia e Storia della Scienza Silvano Zipoli ‐ Filosofia e Storia della Scienza Segretario di Redazione: Matteo Leoni I contenuti di Humana.mente sono sottoposti a refereeing Il comitato scientifico della rivista è composto dai membri del Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica. Progetto Grafico: Duccio Manetti Sito web: www.humana‐mente.it La struttura del sito è realizzata da Emiliano Mazzetti e Simone Gallorini Per informazioni e collaborazioni: redazione@humana‐mente.it Humana.Mente, Issue 7 – October 2008 INDICE EDITORIALE RUBRICA p. I Per una conversazione sull'etica. Nuove declinazioni di un pensiero classico p. III Filosoficamente scorretto Settima puntata: L'opinione pubblica non è un'opinione Filosofia ‐ Musica ‐ Scienza Evento in onore di Marisa Dalla Chiara Le passioni del presente Presentazione del nuovo libro di Giacomo Marramao Summer School in Cognitive Science Sofia, June 30 ‐ July 19, 2008 p. V ARTICOLI Animal Constructs and Natural Reality, di Ralph R. Acampora p. 1 Prospettive politiche della pratica filosofica, di Neri Pollastri p. 19 Prospettive critiche sul consequenzialismo, di Emiliano Rolle p. 35 Affermazione, etica, corpo, di Laura Beritelli p. 47 La parola (com)promessa, di Paolo Bonari p. 65 Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler, di Stefano Liccioli p. 79 Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza, di Giacomo Cortesi p. 105 Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione, di Maria D. Rigoli p. 121 Etica del Miglioramento Genetico, di Rossella Pisconti p. 139 A proposito dell’etica cristiana, di Paolo Arzani p. 153 RECENSIONI L'invenzione della libertà, di Jean Starobinski p. 161 L’immaginazione e la vita morale, di Cora Diamond p. 165 Contro i diritti umani, di Slavoj Zizek p. 169 Uno studio sul bene, di Nishida Kitaro p. 171 Negative Virtues, di Katleen Higgins p. 175 Citizenship, di W. Norman e W. Kymlica p. 177 Hate Crimes, Literature and Speech, di L. W. Sumner p. 179 Moral Status, di M. A. Warren p. 181 BOOKS REVIEWS The Political Mind, by George Lakoff p. 185 Neuroethics. Challenges for the 21st Century, by Neil Levy p. 189 EVENTI p. VII p. XI p. XIII RILETTURE Etica senza ontologia, di Hilary Putnam p. 193 La cultura del male. Dall’idea di colpa all’etica del limite, di Ugo Bonanate p. 199 I concetti del male, a cura di Pier Paolo Portinaro p. 203 La comunità che viene, di Giorgio Agamben p. 209 INTERVISTE Intervista a Jean Luc Nancy p. 213 Intervista a Bruno Accarino p. 221 Intervista a Collettivo Autistici/Inventati p. 231 Editoriale Per una conversazione sull'etica. Nuove declinazioni di un pensiero classico Il nuovo numero di Humana.Mente che vi apprestate a leggere, consultare o navigare è una nutrita monografia intitolata alle nuove declinazioni dell’etica. Data la quantità e l’eterogeneità dei contributi, ci sentiamo in dovere di spendere alcune parole per presentarne più diffusamente i contenuti. La scelta di impostare questa pubblicazione come una panoramica sulle molte e diverse possibilità in cui si è realizzato il pensiero che va sotto questa dicitura è stata sofferta e non ha mancato di porci spesso di fronte a dubbi di non immediata risoluzione. Questo proprio perché ci siamo posti un obiettivo audace: si tratta di voler riconsiderare, a partire dalla constatazione della diversità delle voci che abbiamo ospitato, quante ambizioni quella tradizionale ricerca persegue e attraverso quali tipi di risorse teoriche agisce; si tratta, ancora, di rispondere alla sfida che ci mettono davanti oggi tanto la fine dei grandi sistemi morali quanto l’aridità della riflessione analitica. Abbiamo quindi privilegiato i lavori in cui si respirasse una certa emancipazione dalle più celebri scuole di pensiero, sperando di poter cogliere in essi un superamento della differenza tra le ricognizioni storico‐filosofiche, tipiche della filosofia teoretica continentale, e le prosopopee logiche, altrettanto tipiche della tradizione analitica. Come sarà facile notare, si è dunque evitato di presentare troppi lavori di bioetica, nella considerazione che non solo, come molte altre di quelle che presentiamo, sia una branca dell’etica normativa border‐line con troppe altre discipline, ma che la discussione attuale sia schiettamente orientata al di fuori della specificità delle riflessioni attraverso cui la buona filosofia contribuirebbe: anche per questo compare spesso nelle veci di mera consulenza tecnica. L’esito delle domande che ci poniamo, come comunità, su eutanasia, aborto ed obiezione di coscienza – tanto per nominare le più ricordate –dipende molto più dai dati che le scienze biologiche ci forniscono, dalla mutevole ed imprevedibile sensibilità del nostro tessuto sociale, dalle pratiche religiose e dalle problematiche d’ordine legale piuttosto che dalle considerazioni che le scienze umane da sempre suggeriscono, non foss’altro su che cosa sia in questione. La grande risonanza mediatica della bioetica fa sì che sia anche troppo chiacchierata ed abbondantemente trattata: questa stessa rivista non ha mai mancato di proporre ad ogni uscita un articolo sulle novità che tale ambito di ricerca produce. In questo numero troverete dunque che la bioetica viene affrontata limitatamente, avendo preferito lasciare uno spazio più ampio a questioni meno dibattute come anche a proposizioni di pensiero cui essa potrebbe comunque essere ricondotta. L’idea che abbiamo seguito nella scelta delle pubblicazioni risponde anche e soprattutto ad un’attenta curiosità verso i modi in cui la filosofia contemporanea affronta il dibattito etico, spesso più come una reale novità che come una riproposizione o un riadattamento di riflessioni che hanno profondamente segnato la nascita e lo sviluppo del pensiero occidentale per secoli. La ricerca di un ‘pensiero nuovo’, che è necessariamente partorito dalla società odierna, non può esimersi comunque dal confronto con le più antiche scuole e tradizioni, ma, III
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 in esso, si rinviene più fortemente la forma del dialogo (seppur acceso) che non quella del rifiuto e del distacco. Questi i motivi per cui ci siamo permessi alcune ‘trasgressioni’ dal discorso analitico – cui sempre, come rivista, facciamo riferimento –, la più evidente delle quali risulterà senz’altro il contributo di Arzani. Di questo lavoro si può dire che rappresenti alcune delle opinioni fin qui espresse dalle curatrici, ossia l’impossibilità di parlare di etica con un solo linguaggio; il confronto con la pratica religiosa che, a fronte di tutte le etiche pratiche di nuova formazione, è indubbiamente legata ad una eredità storica e culturale tanto antica quanto ancora attuale; il recupero, proprio dalla radice più lontana, della primaria importanza della paradossalità della predicazione evangelica, come forza, spinta e movimento essenziale non riducibile a prescrizioni normative. Siamo particolarmente orgogliosi di presentare l’originale contributo del giovane ma già affermato filosofo americano Ralph R. Acampora, della Hofstra University (NY) che ha per noi scritto un incisivo articolo di etica applicata, in cui mette in gioco le risorse del pensiero continentale, attraverso Nietzsche, e quelle della filosofia della scienza, attraverso il pensiero del controverso fondatore dell’etica ambientale, Holmes Rolston. Il paper di Acampora ha soprattutto il pregio di sopperire alla mancanza, in Italia, di una letteratura specifica che non sia anche vittima di altre tensioni. Ancora, interessante è l’intervista al celebre filosofo francese Jean Luc Nancy realizzata da Beritelli: pubblicata in esclusiva, essa costituisce l’ideale proseguimento del lavoro della medesima autrice (presente nella sezione papers), fornendoci, nel complesso, un interessante e documentato affresco del pensiero francese contemporaneo. Delle recensioni che proponiamo, infine, noterete che alcuni saggi sono estratti da collezioni inedite in Italia; in particolare sono stati scelti gli articoli di pensatori americani esponenti di singoli rami di studio dell’Applied Ethics e articoli ricavati dagli interventi tenuti presso il congresso “Virtue Ethics, Old and New” tenutosi all'Università di Canterbury, Nuova Zelanda, nel Maggio 2002. Sebbene la vastità di prospettive possibili in cui è oggi declinato il tema non possa esser stata esaurita, speriamo di esser riuscite ad aprire una finestra sufficiente a poter gettare uno sguardo su molti degli attuali percorsi di questo ‘classico’ pensiero. Scilla Belluci Laura Beritelli IV
Filosoficamente scorretto L'opinione pubblica non è un'opinione Qualche giorno fa il regista Nanni Moretti ha sollevato un polverone mediatico con la sua perentoria affermazione che in Italia "... manca, non esiste, una opinione pubblica ... ‐ ... manca la memoria, si accetta tutto come normale ...". Questa dichiarazione era ovviamente riferita alla situazione politica generale e, più in particolare, al clima culturale che stiamo vivendo così come lo vede, dal suo particolare punto di vista, un uomo di cinema. Il tema della "opinione pubblica" è comunque un tema generale, trasversale, come si dice oggi; e riguarda tutti gli aspetti della vita nazionale, dalla politica allo sport, dalla cultura allo spettacolo, appunto. Vorrei permettermi di riprendere, modestamente, il discorso e proporre, se possibile, una riflessione più ampia. Moretti dice che l'opinione pubblica è morta, che non esiste più, che non dà più segni di vita. Ma questo significa che, allora, è esistito un tempo, molto vicino a noi, in cui essa era viva e vegeta, in cui si faceva sentire e partecipava alla vita pubblica, alla vita della nazione. In realtà, provare questo mi pare già un problema non da poco. E inoltre bisognerebbe cercare di dare una definizione un po' più precisa di tale concetto, notevolmente sfumato e cangiante. Eugenio Scalfari (fondatore del quotidiano nazionale La Repubblica) ha risposto a Moretti qualche giorno dopo sostenendo che invece di opinioni pubbliche ce ne sono più di una e tutte molto agguerrite e influenti. Non sono molto d'accordo con questa analisi (le chiamerei piuttosto "lobbyes allargate" o "movimenti d'interesse") ma non è questo il punto. La vera questione, a mio parere, è che purtroppo, in Italia, mancano le "opinioni private", mancano le "opinioni", semplicemente; mancano le "idee", le idee originali, i "punti di vista" alternativi, manca in una parola l'"originalità" (e spesso proprio dove la si considera uno degli assi portanti del progresso civile, politico e culturale). Ma gli italiani, si sa, sono pigri, indolenti, tendenzialmente portati a delegare ad altri le attività faticose, in particolare, la fatica di pensare in proprio (il clima, secondo alcuni, influisce su questa caratteristica, il clima meteorologico intendo dire, a scanso di equivoci!). E chiunque abbia svolto, anche per un breve periodo, un’attività di tipo intellettuale, può testimoniare quanto sia faticoso esercitare le meningi su un problema o una questione di cui si cerca la soluzione. Quindi, dal momento che "produrre" un’opinione risulta un’attività molto faticosa, l'italiano medio preferisce cercarle (le opinioni) nei grandi magazzini mediatici, in televisione o nelle pieghe delle numerosissime pubblicazioni del chiacchiericcio nazionale. Nei settimanali, ormai presidiati militarmente da un esercito di "esperti" tuttologi, è possibile infatti reperire un'intera collezione di opinioni (non di rado contrabbandate addirittura per "verità") per tutte le occasioni e per tutti i gusti. In effetti, perché affaticarsi pensando in proprio quando possiamo trovare facilmente pensieri già pronti e confezionati accuratamente (come il pollo arrosto delle rosticcerie), pensieri, idee e opinioni già depurati, organizzati e assemblati così bene da non aver bisogno neppure di V
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 essere "digeriti"? Nemmeno all'IKEA sono in grado di offrire un campionario così vasto e variegato di prodotti, per tutte le esigenze e per tutte le tasche! Non ha proprio senso allora rischiare di perder tempo in un’attività sempre più fuori moda, sicuramente improduttiva e spesso malvista. E se pensare risulta faticoso, pericoloso e rischioso, cercare di farsi una propria opinione è addirittura una pretesa assurda. Per produrre un'opinione occorrono strumenti sofisticati, costosi e per di più, oggi, anche difficili da reperire! Le opinioni sono un lusso che non tutti possono permettersi! Alla faccia dei tanto strombazzati "sondaggi d'opinione", alla faccia delle inchieste in cui vengono richiesti a persone normali giudizi su argomenti dei quali spesso non conoscono neppure l'esistenza o che sono comunque molto complessi e difficili, fuori della loro portata. La mia domanda allora diventa questa. Premesso che gran parte delle discussioni sullo stato presente della nostra società "avanzata" vertono sul grado di democraticità e di libertà del cittadino medio, sul modo migliore di promuovere e garantire l'espressione della volontà dei singoli e delle libere associazioni di interessi, non sarebbe forse il caso di riesaminare a fondo i presupposti teorici e pratici del concetto stesso di "opinione pubblica", delle sue condizioni di possibilità, della sua funzione e dei suoi limiti attuali? L'opinione pubblica non è la semplice somma delle opinioni individuali ma da queste non può prescindere. Ma se gli individui non sono (o non sono più) in grado di pensare e ripensare il loro presente, se non possiedono gli strumenti concettuali necessari per interpretare la realtà circostante, quale incisività può avere il loro contributo, quale peso può avere il loro "giudizio", la loro opinione? I valori etici di una civiltà (la morale, il costume, la politica) dipendono strettamente dal livello della conoscenza diffusa tra i suoi membri; ed oggi conoscenza non può che significare "conoscenza scientifica", razionale, pubblica, corroborata dall'esperienza, verificata. Senza questo essenziale presupposto, un alto livello culturale dei cittadini, nessuna civiltà può vivere a lungo. E senza una cornice culturale profondamente radicata e condivisa diventa impossibile anche la politica, una qualsiasi politica che non si riveli semplicemente una banale gestione del'esistente. Umberto Maionchi VI
Eventi Filosofia · Musica · Scienza Evento in onore di Marisa Dalla Chiara Firenze 19‐20 Settembre 2008 Maria Luisa Dalla Chiara è stata docente di Filosofia della Scienza presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze fin dal 1970. È stata presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze, dell' International Quantum Structures Association ed è, attualmente, presidente del Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della Scienza. In occasione del compleanno e del congedo dall’attività didattica, i colleghi dell'area di Logica del Dipartimento di Filosofia1 hanno voluto riconoscerle una sentita gratitudine per l'eccellenza dei suoi studi e delle sue ricerche, dedicandole, in queste due giornate, alcune conferenze intorno a temi a lei cari. Venerdì 19 Settembre‐ Aula Magna dell'Ateneo, Firenze‐ ore 17.30 Venerdì 19 settembre si è tenuta, nell'Aula magna dell'Ateneo, una lezione‐concerto del M° Piero Bellugi, coinvolto per ragioni sia professionali che amicali, con l'Orchestra Florence Simphonietta dal titolo Il direttore d'orchestra fra concertazione e interpretazione. La circostanza non pretendeva, ovviamente, una dissertazione dotta e approfondita sul tema, ma, usando il tempo a disposizione con intelligenza e forte di un eloquio chiaro e leggero, il M° Bellugi è riuscito ad accostarsi a più di uno dei molteplici interrogativi riguardo la funzione del direttore d'orchestra. Non sarebbe certo fonte di informazioni preziose, quanto, sospettiamo piuttosto, di tedio, cercare di riportare fedelmente un discorso svolto con ironia e facilità e accompagnato da gradevolissimi esempi musicali. Tuttavia è possibile cercare di descrivere quanto sia emerso da questa esperienza. Colui, o colei, che sale sul podio si trova nella condizione di dover essere un punto di riferimento costante durante tutto l'arco di un'esecuzione; deve, perciò, disporre, in ogni momento, di una forza affermativa capace di sciogliere qualsivoglia dubbio ed incertezza nello spazio di un'istante. Tale capacità non può certo essere affidata soltanto ad un eventuale alone carismatico, ma deve provenire da uno studio profondo e chiarificatore della partitura musicale. Non poi così dissimilmente da quanto accade per altri tipi di testi, l'appropriazione dei contenuti e la dimestichezza con la materia trattata sono frutto di un faticoso lavoro ermeneutico che, prima di tutto, ma non esclusivamente, pretende il dominio delle strutture grammaticali e sintattiche e della loro evoluzione attraverso le epoche. 1. Il Comitato organizzatore dell'evento era costituito da: Sergio Bernini, Andrea Cantini, Elena Castellani, Pierluigi Minari, Eleonora Negri. VII
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Il passaggio finale, ossia l'esecuzione vera e propria, porterà con sé tutti i segni di questo lavoro interpretativo, poiché sommerà alla scrittura del compositore quanto il direttore avrà saputo leggervi e quanto di ciò sarà stato capace di comunicare all'orchestra. L'ottenimento di un valido risultato sarà perciò deputata anche all'espressione corporea che, a sua volta, richiede una pulizia di movimenti e un controllo della gestualità non trascurabili.2 In questa circostanza abbiamo potuto godere dell'eccellente esempio delle mani del M° Bellugi, la cui forza comunicativa è tale da insinuare il dubbio – ancor più che se fosse stato esplicitato apertamente ‐ che, priva di un qualche dono particolare, anche l'acquisizione di tutti i mezzi necessari non possa esser sufficiente allo svolgimento di questo difficile lavoro. Scilla Bellucci Sabato 20 Settembre – Facoltà di Lettere e Filosofia, Firenze – ore 9.30 Bas C. Van Fraassen Modality in Physics vs Modality in nature L’ipotesi empirista di Bas C.van Fraassen, docente di filosofia della scienza a Princeton, è considerata una tra le più discusse alternative alla tesi del realismo scientifico nel dibattito contemporaneo in filosofia della scienza. Il filosofo ha ricordato come la modalità (locus of possibility) sia naturalmente intrinseca al pensiero scientifico e parte della capacità immaginativa umana. Allo stesso tempo, secondo van Fraassen, non occorre postulare una modalità in natura (inflationary metaphysics) al fine di comprenderne il ruolo per le teorie fisiche. Partendo dall’analisi della definizione di massa in termini cinematici da parte di Mach, tentativo riuscito di eliminare i residui di oscurità metafisica dalla relativa definizione newtoniana – la massa deve essere definita in termini esclusivamente numerici partendo dai rapporti di accelerazione impressi da un corpo a un altro ‐ van Fraassen ha analizzato il rapporto tra le geometrie (euclidee e non euclidee) e lo spazio‐tempo, evidenziando la possibilità che differenti relazioni di congruenza tra due oggetti nello stesso spazio implichino contemporaneamente strutture matematiche euclidee e non euclidee. Lo spazio tempo einsteniano, inoltre, richiede l’assunzione di una infinita collezione di sistemi locali, operanti in spazi a connessione locale, tramite, per esempio, gruppi di trasformazione infiniti. Analizzare il rapporto tra le modalità geometriche e il mondo fisico significa, secondo van Fraassen, valutare criticamente se considerare come primitive le relazioni spazio temporali o le modalità singolari (singular modalities) e parallelamente, condurre un’analisi epistemologica sul rapporto tra le reazioni (di tipo estensionale e intensionale) alla tesi dell’empirismo costruttivo (constructive empiricism). Il filosofo ha concluso analizzando il rapporto tra modelli fisici e verità. Le relazioni tra spazio e tempo, per esempio, vengono incorporate (embedded) nei relativi modelli fisico‐
matematici e le differenti strutture matematiche a fondamento di un determinato fenomeno fisico possono essere incluse in molti, o, all’opposto, in nessuno dei modelli fisici di quello 2. Il Maestro ha voluto qui sottolineare come, in fase esecutiva, i musicisti concentrino lo sguardo primariamente sulla parte e come, quindi, percepiscano i movimenti del direttore perlopiù attraverso la vista periferica. In virtù di ciò risulta evidente come sia preferibile che tali movimenti siano chiari e precisi, a dispetto dell'immagine‐ che ha dunque finito per risultare risibile‐ del direttore che si lascia andare a manifestazioni corporee eccessivamente passionali. VIII
Eventi – Filosofia, musica, scienza stesso fenomeno. Probabilmente, ha terminato van Fraassen, il teorico si deve rassegnare all’idea di una irriducibile non univocità (irriducible non uniqueness) dei modelli teorici a disposizione. Alberto Binazzi Sabato 20 Settembre – Facoltà di Lettere e Filosofia, Firenze – ore 10.25 Giulio Giorello Political Freedom and its Dilemmas J.S.Mill nel celebre opuscolo On freedom, scritto nel 1859, sostenne che il primato delle libertà individuali fosse compatibile con l’accettazione del principio utilitaristico della ricerca del proprio benessere e felicità, a condizione che questo non recasse danno agli altri. Tale assunto, ha ricordato il matematico e filosofo Giulio Giorello, principio fondamentale del liberismo moderno, appare, oggi, alquanto restrittivo, se applicato troppo rigidamente. È noto, infatti, che la ricerca della personale utilità, in alcuni contesti, può condurre a situazioni svantaggiose per la collettività o per l’altrui persona: si pensi, per esempio, al traffico cittadino, caso perfetto di paralisi collettiva a fronte della ricerca della massima utilità da parte dei singoli. Integrando l’analisi del principio utilitaristico classico con i principali contributi offerti dalle recenti teorie in politica economica, Giorello ha affermato la necessità di considerare il livello di informazione del soggetto e, soprattutto, il tipo di procedure o di euristiche messe in atto dal soggetto durante le fasi di presa di decisione (probabilità soggettiva, teoria del prospetto, peso probabilistico, soluzioni bayesiane, teoria dei giochi) per una corretta comprensione del concetto di ‘preferenza’. Tale nozione, sulla quale si basano i relativi assiomi in scienza economica, risulta fondamentale per la definizione del criterio razionale di scelta da parte dell’individuo. È all’interno di una cornice concettuale più ampia, però, definita da Giorello ‘libertarian escalation’, che l’analisi, non più soltanto in termini meramente utilitaristici dei fenomeni politici e economici, assume una fisionomia decisamente più complessa e articolata. Anzitutto, ha ricordato Giorello, la scelta razionale possiede una dimensione temporale e storica e spesso è funzione di ben determinati indirizzi politici; inoltre, secondo Giorello, una possibile evoluzione del principio di libertà risiede nell’atteggiamento che indica come legittima la restrizione della sfera della libertà a condizione che sia “soltanto per il bene della libertà”. Alberto Binazzi, Scilla Bellucci IX
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 X
Eventi Le passioni del presente Per il ciclo PRESENTAZIONE DI LIBRI Biblioteca Filosofica e Istituto Gramsci Toscano 3 Ottobre 2008, Gabinetto Vieusseux, Firenze In occasione della presentazione dell’opera di Giacomo Marramao (Le passioni del Presente, Bollati Boringhieri, 2008), Alberto Peruzzi in qualità di Presidente della Biblioteca Filosofica ha introdotto la conferenza, sottolineando come il testo si impegni in una ricostruzione storico‐semantica della nozione di temporalità, attraverso un esame del rapporto che questa intrattiene con i concetti di modernità e civiltà europea. Una temporalità, ha ricordato Peruzzi, che per Marramao si caratterizza come ricerca di nuove configurazioni di senso, e non soltanto come una temporalità appiattita sul presente o banalizzata in una meccanica “coazione a ripetere”. Secondo Gaspare Polizzi, il libro di Marramao affronta una sfida, “quella di pensare il presente oltre le passioni della crisi, fornendo un lessico composto da concetti nuovi, come, narrazione, καιρός cīvĭtas, hŭmānĭtas”, che collocano l’indagine filosofica della modernità all’interno di uno spazio di riflessione differente da quello tradizionale, anche interessato al confronto con le ambivalenze politiche e culturali di un mondo globalizzato. Il presente filosofico e politico, ha affermato Sergio Givone, è tutt’uno con “l’incompiuto progetto della modernità”, quello che Marramao ha definito come l’unico universalismo possibile: l’universalismo delle differenze. Il luogo della universalità possibile, ha ricordato Givone, era già stato immaginato da Kant, per mezzo della Società delle Nazioni, spazio dove comporre i conflitti istituzionali e fornire un’identità comunitaria. L’analisi di Marramao, ha ricordato Givone, si confronta, necessariamente, con l’eredità hegeliana e, coerentemente con la dialettica hegeliana, la supera. Infatti, Hegel pensa l’universalità nella ragione storica, rispettando le differenze fino alla loro contrapposizione e ricomposizione nell’autocoscienza. “Andamento hegeliano” che, secondo Givone, caratterizza tutto il libro di Marramao, contraddistinto dalla scomposizione e ricomposizione di quattro antinomie fondamentali: globalizzazione ‐ conflitto delle civiltà; religione – scienza; valori – diritti; universalismo giusnaturalistico ‐ relativismo nichilistico. Per una precipua analisi delle differenze, occorre altresì pensare le differenze ‘al singolare’, ha aggiunto Givone. Marramao, continua il filosofo, coglie questa opportunità in una “riscoperta di Marcuse”. L’autore vede in Marcuse la presenza di una “ontologia delle libertà”: se, infatti, questa molteplicità non viene governata dalla ragione storica, allora, occorre approdare a una ontologia delle libertà, a una presa di coscienza del singolo, di fronte al “possibile che si realizza, perché non può non realizzarsi”. Analisi, conclude Givone, condotte anche da Derrida, attraverso l’indagine del concetto di XI
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 responsabilità, ma, soprattutto, da Kant, il filosofo che ha realizzato, più di ogni altro, la fusione tra mondo fenomenico e mondo morale. Secondo Stefano Poggi, il libro rappresenta l’impegno di Marramao in una riflessione intorno alla problematica della temporalità, insieme al ripensamento dello spazio‐tempo politico e geopolitico. La passione del presente è soprattutto – ricorda Poggi – il ‘pathos del presente’; secondo Poggi, però, per una corretta analisi dell’universalismo delle differenze, occorre superare l’eredità marcusiana, dove permangono alcuni residui del marxismo filosofico, muovendosi, invece, verso l’analisi del tema dell’individuo e della singolarità. Se infatti l’universalismo delle differenze è il “rispetto delle medesime”, la presa di coscienza di un “tormentato conflitto” tra ragione e identità, la consapevolezza delle differenze tra pulsioni individuali e dimensione politico‐sociale, allora – conclude Poggi – l’orizzonte teoretico di riferimento, che appare più coerente con tale ricerca, rimane ancora oggi quello kantiano. Viviamo, ha ricordato Marramao, in un mondo caratterizzato da crisi economiche, politiche, morali, identitarie. La soggettività filosofica, non immune dall’ambivalenza del mondo moderno, ha il compito di “delineare una sfera pubblica globale che si riconosca nell’unico universalismo possibile, quello delle differenze”. Riflessione filosofica concepita come viaggio, tragitto, navigazione, esplorazione di un presente che non coincide con l’attualità, ha precisato Marramao. Michel Foucault propose, nell’ambito di una lezione del 1983 tenuta al Collège de France, un accostamento tra presente e attualità. Il presente però – secondo Marramao – è sempre inattuale, vi è, infatti, nel presente, quella che il filosofo ha definito una “piega inattuale” nascosta dal rumore dell’attualità. Un presente, quindi, concepito come campo di tensione, uno spazio di riflessione che stimoli nuove aperture di senso, al di là delle tradizionali coordinate spazio‐temporali. L’unica filosofia possibile, secondo Marramao, è una filosofia orizzontale, “che circuisce il presente da varie angolazioni”, mai depositaria di una visione definitiva, e impegnata a farsi carico di uno sguardo prospettico e profondo. Oggi, ha ricordato Marramao, viviamo dilemmi morali impensabili per il passato: la modernità, infatti, “si caratterizza per averci fornito tecnologie e procedure razionali fino a poco tempo fa nemmeno concepibili”. Il nostro è un mondo multipolare e multicentrico, schiacciato dalla compressione spazio‐temporale della globalizzazione, in cui, continuamente, scaturiscono nuove forme di conflitto sociale e culturale. Il campo di tensione tra ragione e identità, conclude Marramao, non va, però, soffocato razionalmente, “perché le varie forme della razionalità richiamano anche le emozioni”. Esiste, infatti, un campo di tensione tra vita emozionale e razionalità, una razionalità che non può ridursi al paradigma delle preferenze, o alla teoria dei tipi di Russel, ma che deve, altresì, impegnarsi in una approfondita analisi delle proprie – limitate – risorse cognitive. Alberto Binazzi XII
Eventi 15th International Summer School in Cognitive Science New Bulgarian University Sofia, June 30 ‐ July 19, 2008 The 15th International Summer School in Cognitive Science was
organized by the Center for Cognitive Science, at New
Bulgarian University, Sofia1. Ten famous professors from
important universities in the field were invited with the aim of
providing high level courses to Bulgarian master’s and PhD
students, gathering at the same time scholars from the whole
Europe. The classes were arranged in a three-week period: the
first week was devoted to computational linguistics, the second
to computer science and neuroscience, and the third to
developmental psychology and pragmatics.
1. FIRST WEEK: PHILOSOPHY AND COMPUTATIONAL LINGUISTICS During the first week, Margaret Boden (University of Sussex, UK) gave classes about Creativity and Computers. Firstly she analyzed creativity from a philosophical point of view, distinguishing between psychological and social creativity. Then she talked about different ways through which creativity can be achieved (creativity through search, creativity through combination and creativity through transformation), and showed examples on how creativity can be obtained with the aid of computer art. Finally Professor Boden discussed possible aesthetic theories for this topic. Paul Smolensky’s (John Hopkins University, USA) course was about Grammatical Competence and Performance in an Integrated Connectionist/Symbolic Computational Architecture. He started by introducing the basic framework for neural networks and the basic program of generative linguistics. Then he showed how hard it is to implement productivity and recursive methods in a neural network, which is by definition a model with a finite number of possible configurations. Professor Smolensky also proposed his Parallel Distributed Processing approach to linguistics and argued in favour of it. Also Geraldine Legendre (John Hopkins University, USA) dedicated her course to generative grammar, and more specifically to one of its branches: optimality theory. The main idea is that 1
New Bulgarian University was founded in 1989 with the aim to work for reforms in the Bulgarian university. The Center for Cognitive Science was established in 1997 with the aim of carrying out scientific studies and assisting in the preparation of specialists in cognitive science. In the years it has been recognized as a center of Excellence by the European Union. One of its formative activities is the Summer school, which has been regularly taking place in the last 15 years. XIII
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 the observed forms of language arise from the interaction between conflicting constraints. The inviolability of some constraints does not have its origin in some innate cognitive structure, rather it is relative to the priority of the constraints in a hierarchical ranking. Such priority is specific to every language and is fixed through language learning. Professor Legendre reported several studies on different parameters, showing how optimality theory can be applied to Balcanic languages and to other interesting phenomena in children development. Matthew Rabin (University of California, Berkeley) had a short two‐lesson course on the importance of cognitive studies to model bounded rationality. 2. SECOND WEEK: COMPUTER SCIENCE AND NEUROSCIENCE In the second week, Boicho Kokinov (director of the Center for Cognitive Science at New Bulgarian University) gave classes about Analogy and Cognition. He started by shaping the intuitive concept of analogy and by introducing psychological literature on this topic. Professor Kokinov showed then several analogy models both in Artificial Intelligence and PDP approaches. Finally, he merged them into a hybrid model. Kokinov tried to interact with the students, encouraging them to develop and propose new ideas. Bradley Schlaggar (Washington University at Saint Louis, USA) held an introductory course to neuroimaging analysis. He was very critical toward a naïve use of brain mapping methods, which – he claims – do not produce interesting results when scientists are not clear enough in illustrating the methods to contrast the active/non‐active regions. Professor Schlaggar proposed then different methodologies in order to provide meaningful data in controlled experiments. He also stressed the importance of contrasting pathological brain imaging with studies on normal subjects and temporal studies about the development of the brain. Terry Regier’s (University of Chicago, USA) classes were about the relation between Language and Thought. Regier claimed that cognitive science is intrinsically computational, meaning that we have to use computer science in order to approach brain studies. Therefore he presented some interesting interdisciplinary works about the question on whether language affects perception or not. Results were not unanimous. On the one hand some models suggest that color naming reflects optimal partitions of color space – that is, it is not language dependent. On the other, experimental studies with a very simple but strict paradigm clearly show a difference – apparently due to language influence – in the behaviour of the two brain hemispheres in perceptual discrimination tasks. Professor Regier proposed different ways to combine these opposite results, raising an interesting discussion. XIV
Eventi – Summer School in Cognitive Science 3. THIRD WEEK: DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND PRAGMATICS In the last week, Eve Clark (Stanford University, USA) gave a course about language acquisition in children. She concentrated on lexicon learning, while the linguistic classes in the first week were more grammar‐oriented. Professor Clark started by introducing the most shared theories on lexicon acquisition in children, then exposed her personal account, trying to show how we can ascribe to pragmatic reasons, rather than to cognitive development, the development of a wide area of linguistic abilities. She proposed her theories providing a lot of empirical evidence. Also Herbert Clark’s (Stanford University, USA) course was dedicated to a pragmatic approach to language. He described language as a cooperation tool, showing how the pragmatic context of communication is much richer than the linguistic one. Professor Clark referred to the use of indexicals, pauses, assent nods, pointing and other non‐verbal practices to show how the meaning emerges from a complex view instead of being only conveyed by words. Finally, Jeffrey Elman (University of California at San Diego, USA) gave an introductory class to Computation and Language Processing. He started with the historical roots of cognitive science, then explained the early connectionist language models and some more recent developments. The program of the Summer school was quite intense, with three different classes every day plus one last workshop, where students were asked to discuss more deeply the topics of a lesson together with the teacher. A special symposium was organized the first week in order to allow PhD students to present their own research projects and results. Marco Fenici XV
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 XVI
Animal Constructs and Natural Reality: the Import of Environmental Ontology For Inter­Species Ethics¾ Ralph R. Acampora Hofstra University, [email protected] Abstract
Do animals exist for us as meaningful entities only insofar as each may be thought to manifest or
exemplify an ideal type constituted within the set of symbolic values making up the ‘folk
taxonomy’ specific to our culture? Or do we perceive animals directly, by virtue of their immersion
in an environment that is largely ours as well, regardless of the images that we may hold of them,
or of whether we hold such images at all? --T. Ingold, What is an Animal? (London: Unwin Hyman,
1988), p. 12.
Of late, there has been considerable and growing anxiety in the ranks of ecophilosophy and (at least theoretical) environmentalism generally concerning the ontological nature and epistemological status of nature and its constituents. In the face of postmodern (de)constructionism, environmental thinkers have become worried that their own sacred cow—nature—will be the next "grand narrative" to dissolve under the deflationary onslaught of skeptical, relativistic, and/or nihilistic critique. So, for example, we have Soule and Lease's collection Reinventing Nature? Responses to Postmodern Deconstruction.1 And then, to take another instance, Snyder registers his opinion in "Is Nature Real?".2 Holmes Rolston III and Steven Vogel are no strangers to this debate, and I intend to bring their own contributions into the fray as a focal points for reconsidering the controversy. First, though, let us fill out and fine‐tune some of the issues at stake. Recent concern about the reality (and knowability) of nature has particular purchase in regard to the ways in which we understand and appreciate those entities we call animals. Consider: criticism of various wildlife protection measures, such as the establishment and maintenance of zoological gardens and parks, are sometimes mobilized by reference to authenticity factors. (This is not always the case—sometimes these same measures are criticized as forms of maltreatment of specimens rather than misrepresentation of species; still, concerns of authenticity abound in ¾
An earlier version appeared in New Nietzsche Studies 5.3/4 & 6.1/2 (Winter 2003 / Spring 2004): 22‐
34, under the title “The Joyful Wisdom of Ecology: On Perspectival and Relational Contact with Nature and Animality”; the present rendering constitutes a revision and expansion, including contextual updates. 1
2
Washington, D.C./Covelo, CA: Island Press, 1995. Resurgence 190 (Sep./Oct., 1998): 32‐33. 1
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 the debate over wildlife/land protection and it would seem helpful to scrutinize them further.) The question can be put, for example, are we really saving the wild being in or under conditions of captivity or sanctuary? Is the refuge not in effect a prison that changes the ‘true nature’ or autonomy of its keep? Framing this kind of query implies a criterion of judgment, which has been phrased so that “a wild animal achieves a state of authentic well‐being when it survives and reproduces offspring, based on its own genetic abilities and behavioral adaptations, in a truly natural (as opposed to [merely] naturalistic) environment.”3 To assess the legitimacy of this type of criterion, ecophilosophers need to deal with the issue of what a 'real animal' might be, of whether any such entity exists or is knowable. For, at the other end of the ontological spectrum, social constructionists dispute realist authenticators of animal nature by making claims like the following: "Once brought to human attention an animal is no longer an animal in itself‐‐it can only be that away from human sight, experience and thought".4 Neo‐Kantian remarks of this sort raise the specter of what we might call zoological idealism. Consequently, I want here to compare the phenomenal and biological notions of animality: is it possible, I am asking, to discover that elusive beast‐‐the ‘noumenal organism’? If not, can we rehabilitate or replace ideas of biotic authenticity or objectivity without resting on essentialistic illusions?5 These notions have been historically and rhetorically crucial (if not theoretically or conceptually requisite) to the intelligibility of preservation as such, that is, for saving an original or preexisting type of organism (and/or habitat)—which is something different from conservation for anthropocentric utilization (e.g., amusement purposes in the case of zoos). To start, then, let us look at a specific illustration of our problematic. Two sociologists I have already quoted, Mullan and Marvin, risk confusion when they set out to critique the zoo while simultaneously maintaining allegiance to a constructionist stance. They say that "the human experience of a [captive] creature destroys its authenticity (a quality which is linked to its independence) as a wild animal"6 and yet insist that "the notion of a 'real animal' makes no sense" because "animals are human constructions".7 How can their charge of inauthenticity be sustained, given their eschewal of a realist zoöntology?8 One way Mullan and Marvin 3
John Wuichet and Bryan Norton, "Differing Conceptions of Animal Welfare", in Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation, S. Norton et al. eds. (Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1995), p. 239 (see also pp. 240f.). 4
Bob Mullan & Gerry Marvin, Zoo Culture (London: Weidenfeld & Nicolson, 1987), p. 3. 5
The conceptual dialectic that drives this debate is not unlike that of the controversy surrounding the issue of ecosystem or habitat restoration. Like advocates of pristine land, biotic purists insist that (only) the truly wild animal is the 'real' animal (q.v. Paul Shepard, some deep ecologists, et al.); like the restorationists, on the other hand, zoo directors and wildlife rehabilitators are wont to defend the legitimacy of reintroduction and even 'reconstruction' schemes. See, e.g., Claude Guintard and Jacek Rewerski's "The Disappearance of the Aurochs (Bos primigenius) in Poland during the XVIlth Century and the 'Reintroduction' Project of this Reconstituted Animal in the Mazury Region": working on the basis of an 'inverse' breeding program to re‐establish the external appearance of the European domestic cattle's lost ancestor, "an original project combining tourism, nature and tradition ('T.N.T.') is currently being developed to install the so‐called 'reconstituted' aurochs in the northern part of the country" (abstract, italics added). In Animaux perdus, animaux retrouves:reapparition ou reintroduction en Europe occidentale d'especes disparues de leur milieu d'origine, Liliane Bodson ed. (Belgium: University of Liege, 1999). 6
Zoo Culture, p. 73. 7
Ibid., pp. 6, 3. 8
There can be no appeal here to biology as arbiter, because "this [scientific] form of seeing and understanding is itself cultural and in a sense is not more a true picture of the animal than any other" (p. 8). In other words, on the 2
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality attempt to salvage coherence is to soften their anti‐realism into an epistemological position so as to rule out the implication that animals "are not real physical entities living in a real physical world, but rather to emphasize they are also man‐made in the sense that they are thought about by man, and it is the animal as it is thought about rather than the animal itself which is of significance".9 However, metaphysically, this retreat from hard‐core constructionism flirts with neo‐Kantian dualism (with its concomitant ambiguity between a species of perspectivism and some sort of two‐world ontology) and, hermeneutically, it borders on tautology (insofar as significance as such must be thought‐‐i.e., to be at all). The conceptual knots in which these sociologists tie themselves are emblematic of a larger problem regarding the ontological status of nature. Metaphysically speaking, many if not most environmentalists are naive naturalists in the sense that they believe in the ‘objective outdoors’‐‐an external world existing beyond human edifice and mentality, upon which our buildings and theories are based. Some ecophilosophers, however, have rejected this mainstream conviction in favor of a constructionist stance.10 It is important to gauge whether such a stance is meant to express an actual ontology or an epistemology instead.11 Yet ambiguity between ontological claim and epistemological deliverance is a typical feature of constructionist positions. In a generic study of constructionism, Ian Hacking flags just this aspect in asking, “When we say ‘X is socially constructed’, are we really talking about the idea of X, or about an object in the world?”12 It is hard to get, and no doubt difficult to give, a straight answer to Hacking’s question.13 If taken epistemologically (about processes of conception), constructionist assertions appear to be nothing more than reminders that the ineluctable hermeneutic circle binds our construals of the natural world; if taken ontologically (about reality of being), on the other hand, they seem to imply a rather radical‐‐and notoriously dubious‐‐species of idealism.14 Yet, perhaps some ecophilosophers are prepared to bite the idealist bullet. Steven Vogel, for instance, comes quite close to embracing a quasi‐pragmatist, neo‐Hegelian idealism when he claims that human “practice doesn’t constitute [just] some social part of the world‐‐it constitutes the environing world as such, the world of real objects that surround us, a world postmodern front at least, the physical and life sciences yield to a Feyerabendian/Foucauldian skepsis. It will be well to bear this point in mind when we come to consider Rolston’s views (often reliant on uncritical appeals to eco/bio‐
scientific deliverances). 9
Mullan and Marvin, p. 3. 10
See, e.g., Roger H. King's "How to Construe Nature: Environmental Ethics and the Interpretation of Nature", Between the Species 6.3 (Summer 1990): 102. 11
Ibid., 104. 12
"Are You a Social Constructionist?", Lingua Franca 9.4 (May/June 1999): 68. From his book, The Social Construction of What? (Cambridge: Harvard University Press, 1999). 13
King is not alone in this regard. Similar issues arise in others' application of constructionism to nature‐‐see, e.g., Neil Evernden's The Social Creation of Nature (Johns Hopkins U. Press, 1992). My impression is that these thinkers do not want to embrace full‐blooded idealism—my point is only that their writings invite if not entail it. 14
For those unfamiliar with the "hermeneutic circle" alluded to above, the reference is to the feature of interpretation that it has to start somewhere and yet that starting point must itself be interpreted at a later stage in the process of interpreting; this reflexivity is ongoing but virtuous, because each circuit of interpretation reveals new angles of a given text or phenomenon (i.e., articulation 'spirals' informatively rather than repeating trivially in strict circularity). 3
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 that is quite literally ‘socially constructed’.”15 What would tempt anyone to adopt such a robustly constructionist stance? I suspect it is the conviction, voiced by Vogel and others, that there is “no access” to the natural world that does not involve some human/social practice.16 However, from this presumption it does not directly follow that there is no nature apart from such activity; and, in fact, Vogel did elaborate his view to clarify this very matter. Coming to grips with the "hardness and thereness of the world", he indicated that "the environment we inhabit is produced in and through our practices, but … practices themselves are real and material".17 Still, even recognizing this much is insufficient to avoid idealism— at least until Vogel and like‐minded constructionists acknowledge that the natural world is not wholly produced by human practices, that otherness beyond the human is engaged by (and sometimes, as in cases of animal agency, engages with) our activities in the production or poiesis of the phenomena collectively denominated nature.18 To explicate the situation further, when Vogel deconstructs the notion of nature in an attempt to show it is so riven by antinomy and/or ambiguity that it merits decommissioning from the ecosophical lexicon, he ignores or conflates important distinctions between influence and determinism, contact and control, affecting and effecting environment(s). His deconstructive strategy with respect to nature is predicated on a dualistic conception of natural versus artificial: the former is taken to refer only to that which is entirely nonhuman in its status and process, but since traces of the latter can be found everywhere on the planet, it is thereby concluded that there is no nature anymore (at least on Earth). Alternatively, Vogel argues, if nature is taken to include humanity, then conceptually it cannot function as a critical contrast to human activity (since the latter would be “natural” by definition).19 But all this argumentation, I counter, is flawed by its dependence on false dilemmas. It is possible, indeed helpful to ecosophy, for us to reject not the notion of nature itself but rather Vogel’s dualism in respect of it; nature, that is, can be conceived as on a continuum with artifice—and so what matters for environmentalism is not the mere fact of human influence, but rather its degree or extent: that which is effectively under intelligent mastery may fairly be deemed artifactual, while whatever operates in the main from its own pre‐given principles (in 15
"Nature as Origin and Difference: Environmental Philosophy and Continental Thought", Philosophy Today 42 (suppl. 1998) = Conflicts and Convergences: Selected Studies in Phenomenology and Existential Philosophy, Vol. 24, L.M. Alcoff and M. Westphal eds., 175. Cf. Lawrence Hazelrigg's even more emphatic stance in Cultures of Nature (Gainesville: University of Florida, 1995), where he endorses the position that "nature is a product of human making. Not merely 'the idea of nature' or 'nature as we think it is' or 'nature experienced' … but the concrete practical materiality, the substance and support, the actual and potential plenitude of the reality of nature‐‐in sum the whole of the given being and being‐givenness of nature as it is‐‐is a concrete production in/by human labor in the activity of making life" (p. 12, original italics). More cautious, Vogel is careful to recoil from the furthest extremity of such views‐‐by allowing that "the claim that the environing world is socially constructed does not mean that somehow we build it ex nihilo" (177). 16
Ibid., 175. 17
"Environmental Philosophy after the End of Nature", Environmental Ethics 24.1 (Spring 2002): 34, 37 (first italics original, second added). 18
As Eileen Crist’s analysis makes clear, strong constructionism poses as postmodernism, but it ironically leaves “humania” intact or even intensified—in this light, then, it requires a dosage or two of post‐humanism or eco‐
pragmatism. See “Social Construction of Nature and Wilderness”, Environmental Ethics 26 (Spring 2004): 3‐24. 19
“End of Nature”. 4
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality conjunction, of course, with any relevant physical conditions or forces of external necessity) can legitimately be thought of as relatively natural.20 Why protect nature in this sense? Several criterial factors for environmental protection are available: (1) ecosystemic health sometimes calls for trophic and/or cyclic heteronomy rather than monocultures resultant from single‐source mastery; (2) aesthetic predilections often yearn for a manifold of self‐
arising phenomena; (3) organismic identity requires material (and in some cases mental) foils to establish and maintain itself in a dialectical dance of difference and likeness. These criteria are pluralistic in scope, including psychocentric, biocentric, and ecocentric dimensions. Taken together, they stress the need for diversity or alterity—multiple otherness as allowed for by the conception of nature I have proffered above.21 My suggestion is not an idle vestige of nostalgic/romantic speculation. Indeed precisely because it permits us to bypass speculative excess, the posit of an extra‐human horizon becomes attractive. For it is at this juncture that many feel realist compunctions, and a Rolstonian conscience begins to stir. Obviously, we want to say, our interaction or dialogue with nature is socially constructed (what else could it be?)—yet acceptance of that does not automatically commit us to believing all nature is made up by us. Of course, I cannot express anything about that bare world without dressing it up semiotically; nonetheless, the assumption that another reality‐‐besides myself or us‐‐is subject and party to (not merely an object in or construction of) my/our discourse and deeds is more plausible than the idea that I/we make the world entirely out of words and actions. One reason this is so is that the latter proposition implies an untenable interpretation of scientific and technological successes and failures.22 Thus, if we want to come to terms with the many instances of common experience in which people staking a cognitive claim are able (by applying their knowledge) to gain pragmatic results that we who lack that knowledge cannot achieve, then we will abandon full‐
blown idealism (and its postmodern variant of ‘textualism’) in favor of some form of realism (however weak). Why? Because the realistic notion that pragmatic coping is explainable in terms of our epistemic beliefs adequately describing enough of the actual world to get by (not necessarily enough to set up a complete correspondence theory of truth) ‐‐this notion, it seems to me, is to be preferred over any of the standard options open to idealists: confessing ignorance and calling pragmatic success a miracle, or making appeals to supernatural principles such as pre‐established harmony or divine occasionalism. 20
This characterization is inspired by Michael Bonnett’s neo‐Heideggerian notion of nature as primordial phenomena that self‐arise—see his Retrieving Nature: Environmental Education for a Post‐Humanist Age (Blackwell, 2004), esp. chap. 5. 21
Thus I concur with Roy Ellen’s reflection that “we cannot avoid a concept very much like nature to make sense of the world, and that if we try to dispense with it we will have to invent something remarkably similar to replace it.” From “A Response to the Deconstruction of Nature”, his editorial introduction to Redefining Nature: Ecology, Culture, and Domestication (Oxford: Berg, 1996). Cf. Patrick Curry’s argument that “people will think about nature, so it is helpful to have available a good way of thinking about it: one that is more open to the experience of it and encouraging of resistance to its destruction.” From his “Nature Post‐Nature”, accessible via http://www.patrickcurry.co.uk/papers/Nature‐Post‐Nature.pdf, 13 (italics original); also published in New Formations 26 (Spring 2008). 22
See Sergio Sismondo's Science without Myth: On Constructions, Reality, and Social Knowledge (Albany: SUNY Press, 1996), especially chapter 5. 5
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 These provisional ontological commitments are reinforced if we now focus our attention upon the naturalistic realism in which the ecophilosophy of Rolston is embedded. Here is a thinker who reminds us, “There is always some sort of cognitive framework within which nature makes its appearance, but that does not mean that what appears is only the framework.”23 What is salutary about Rolston’s approach is his willingness to forego the polemical pendulum swing between foundationalism and relativism. “We may not have noumenal access to absolutes;” he admits, and yet “we do have access to some remarkable [natural] phenomena that have taken place and continue to take place outside our minds, outside our cultures.”24 This access is not pure‐‐neither purely objective nor purely subjective! It is a transactional dynamic of interrelationship; as such, it is best understood not as impossible transcendence (unlimited by any perspective) nor as stultifying solipsism (trapped within a single standpoint) but rather as taking place between knower and known and capable of yielding enough awareness of the latter by the former to enable a negotiation, or better a navigation of the lifeworld‐‐which is shared with other forms of life (in both the cultural and biotic senses of that term).25 In other words, as Rolston puts it, "One doesn't have to know it all to know something".26 Or, like Hume and a host of American philosophers (such as “pragmatic realist” Hilary Putnam), one learns to accept that functional praxes—most notably those of communication—trump the global doubts of Cartesian‐type skepticism and establish contact, however tenuous or imperfect, with the other(s) beside oneself.27 Suppose we were to take such an approach seriously. What would it look like in application— with respect, say, to knowing other animals? When faced with this kind of issue, Rolston himself readily appeals to the life sciences for reliable knowledge, undaunted by sociologies or histories of science that cast suspicion on the scientific enterprise as such. To be fair, he does shed scientism in acknowledging that "biological claims do not try to get underneath to some noumenal realm;" still, he views science as no worse off for that, because "biology claims that 23
"Nature for Real: Is Nature a Social Construct?", The Philosophy of the Environment, T. D. J. Chappell ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997), p. 43 (italics and bold added). 24
Ibid., p. 49. 25
“A similar view is emerging in the field of environmental history,” notes Alf Hornborg, “where ‘knowledge’ is being recognized neither as a representation of something that exists outside it, nor merely a social construction, but as a negotiated relationship with nature that actually reconstructs nature in the process of representing it” (original italics). From his “Ecology as Semiotics”, in Nature and Society, P. Descola and G. Palsson eds. (London: Routledge, 1996), p. 52. Cf. Roy Ellen’s dialogic portrait: “If culture gives meaning to nature, then nature gives meaning to culture … and so on ad infinitum” (op. cit., p. 31). 26
Ibid., p. 53. On the related point of 'world‐sharing' and knowing something else (i.e. aside from the self/same), compare David Abrams' remarks in his "Language and the Ecology of Sensory Experience: An Essay with an Unconstructive Footnote", Call to Earth 1.1 (March 2000): "the 'society' which constructs this indeterminate world is much vaster than any merely human society‐‐it includes spiders and swallows and subterranean seepages along with us two‐leggeds. …we humans are by no means the sole, or even the primary, agents of the world's construction" (9, italics original). My own metaphors are those of love‐ or war‐making‐‐even if done in the dark, with your partner or enemy out of full view, there is pretty little room to think you are alone. 27
Putting aside Rolston‐the‐botanist’s preference for terrestrial terminology and switching over to aquatic or aerial figuration, one might call such an approach floatational (rather than foundational) philosophy—in the sense that it keeps us abreast of the wide‐waving world and enables us to get where we need to pragmatically speaking, without ever mooring into some adamantine anchorage of total objectivity. 6
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality these [life] phenomena are given in themselves."28 If challenged by contextualist accounts of science‐‐such as, for example, Donna Haraway’s Primate Visions—Rolston's reliabilist epistemology could be defended by pointing out that critics like Haraway are either uncovering misrepresentations (which only makes sense if some idea of truth or its pursuit is still operative) or else their critiques are rendered otiose (for want of a critical foil or fulcrum).29 Even if all epistemic sites are built (i.e. no knowledge is simply given), not anything can count as a cognitive structure and some building methods are better than others. In the case of understanding different animals, then, the choice to characterize other organisms as say ‘merely machines’ or as ‘feeling flesh’ does not reduce to a rhetorical strife between metaphors or a political struggle amongst their arbitrary adherents (which is what pure constructivism seems to leave us with).30 Why not? Well, Rolston would have it that “there is [e.g.] a chimpanzee self out there which can be known not entirely, not ‘absolutely’, but sufficiently so that we find that the intrinsic chimpanzee self‐integrity ought not to be lightly sacrificed”.31 Now, though sympathetic to the idea of integrity, I at least would want to qualify Rolston’s siting of the chimp‐self ‘out there’. If this phrase means ‘external to me or us’, then fine‐‐I do believe personal and cultural horizons are often transcended (in communication, e.g.); but if the term were construed to mean ‘outside the perspectival nexus of the knowing process’, then I would lean a little more toward the constructionist or pragmatist viewpoint: all (at least finite) knowledge is internally relational and inherently positional, I would argue, because cognition itself is a situated relation(ship). Rolston comes perilously close to the latter interpretation given above when he writes of ready‐made natural kinds (such as the wolf, Canis lupus) existing on their own, capable of grounding objectivist projects of discovery.32 What he seems to overlook in such moments of backslide into foundationalism is the impossibility of quarantining some mythically pure realm of being from the maculate aspects of cognition (think, for examples, of the impurities in knowledge‐craft that manifest in the histories and sociologies of science mounted by Kuhn, Feyerabend, Foucault, etc.).33 That there can be—"for us" (in the Kantian or Hegelian sense)—
28
"Nature for Real", p. 56. Thus Rolston in effect collapses the biological into the phenomenal, trusting with an almost Husserlian faith that noumena are not necessary for reliable cognition. 29
Some commentators, in fact, think that postmodern ecosophy may have already hung itself on the latter horn of this dilemma. See, e.g., John Visvader's "Environmental Activism in an Age of Deconstructionist Biology", Human Ecology Review 5. 1 (1998): "The net effect of 'demythologizing' biology and social constructionism is to make environmental values appear to be subjective and relativistic" (32). 30
Perhaps I have caricatured the latter scenario: it may be possible to democratically conduct the politics of such disputes in a respectful, rational fashion (as per Vogel‐‐e.g. "End of Nature", 36ff.). 31
"Nature for Real", p. 60. Cf. Leslie Mitchell’s critique of animal agribusiness in “Discourse and the Oppression of Nonhuman Animals: A Critical Realist Account” (Rhodes University: Ph.D. thesis, 2007). 32
“F/actual Knowing: Putting Facts and Values in Place”, Ethics and the Environment 10.2 (2005): 148f. “We do not think that wolves, coyotes, and foxes come into being when we humans arrive and cut up the world into such objects,” he says, “much less when the scientific systematists arrive and make their decisions about genus, species, and family” (148). 33
Rolston himself still harbors hope for a cleaner/clearer representationalism: looking to polish up pragmatic/relational epistemology, he asks “Does not all this coping require some copying?” (Ibid., 156) Probably so, I would reply—but how much and in what respects is forever indeterminable by us (for whom any checking of ‘originals’ against copies constitutes copying yet again indefinitely, which is why coping is a more helpful model for the process of cognition). 7
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 no protective firewall between epistemological contingency and putatively bedrock Being stems from the very conditions of intelligibility: in order to become knowable, communicable, philosophizable, any ontic space must be rendered accessible and given an account, must become ontologized—and thus submit at once to the influences of epistemic revelation and contamination both.34 “What is getting contaminated conceptually is epistemological making up the world with ontological making up the world, the order of knowing with the order of being.” Rolston rejoins, “True, we humans make up our categories as we know the world; that is epistemology, found as much in science as anywhere else. But it is also true that the world made up these natural kinds once upon a [pre‐human] time; that is ontology, and science convinces us of this too.”35 This conceptual distinction, however, cannot hold in actual practice: any ontology is always already a logos (by definition), and so discursive methods of epistemology unavoidably seep into the account (just as material practices of knowing inevitably affect their objects and thus indirectly any of our eventuating ontologies).36 Proceeding thus, I realize that I am now making Rolston's respect for scientific objectivity groan. What about the ideal of disinterested knowledge, it will be protested—if that's abandoned, can Rolstonian naturalism be sustained as a viable ecophilosophy? My response here is to suggest that Rolston's environmental thought might yield to, or be wedded with, a Nietzschean epistemology. In his On the Genealogy of Morals, Nietzsche provocatively claims that "there is only a perspective seeing, only a perspective 'knowing'; and the more affects we allow to speak about one thing, the more eyes, different eyes, we can use to observe one thing, the more complete will our 'concept' of this thing, our 'objectivity', be" (essay 3, sec. 12). Thus Nietzsche, amplifying his notion of "gay science", redefines objectivity as he attempts to stave off cognitive nihilism once appeals to foundational thinking have been forsaken. The Nietzschean argument here might be reconstructed in the following terms: the view‐from‐
nowhere is an impossible ideal of positivism; the view‐from‐everywhere is a theological invention (but, notoriously, divinity is dead); therefore, objectivity consists not in those formulae, but rather in continual diversification of perspective ('views‐from‐manywhere' if we insist on a label like the others).37 Make no mistake—this is not a pathway a scientific traditionalist like Rolston would likely blaze on his own (indeed, as we have seen, he bears more toward a harder version of realism in his later work on the area at stake). Nonetheless, it 34
This is a point that tells against Richard Evanoff’s endeavor to make too neat a distinction between ontology and epistemology in his “Reconciling Realism and Constructivism in Environmental Ethics”, Environmental Values 14 (2005): 61‐81. Although Evanoff offers a fairly good antidote to Vogel’s idealistic excesses, in the end he veers too far toward uncritical realism. 35
Ibid., 149 (original italics). 36
Hence, in a somewhat dramatic vein, we could say that what makes our knowledge necessary (distance or detachment from the ontic) is paradoxically what also makes impossible the absolute achievement of its telos (pure immediacy or communion with the object in itself). 37
There are a few contemporary proponents of this view. For example, Mark Johnson notes that "Stephen Winter has characterized such a human [neither neutral nor divine] objectivity as a form of transperspectivity, which is the ability of a physically, historically, socially, and culturally [as well as, I would add, ecologically] situated self to reflect critically on its own construction of a world, and to imagine other possible worlds that might be constructed" (italics original). Quoted from "Living without Absolutes", chap. 9 of Moral Imagination (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p. 241. Cf. Rolston on humanity’s creatively transcendent powers of mental genius (“F/actual Knowing”, 160‐66 and 171f.). 8
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality is my contention that (much of) Rolston’s environmental philosophy is compatible with and could benefit from an infusion of Nietzschean perspectivism.38 In the literature of ecophilosophy the closest anyone has come to this kind of synthesis, so far as I can tell, is N. K. Hayles.39 In "Searching for Common Ground" she envisions an ecological form of cognition that involves "imaginatively bringing together the different knowings that all the diverse parts of the world construct through their interactions with it".40 Hayles dubs this epistemology "constrained constructivism" because it retains the notion of a natural world, which comprises a set of (partially) free‐standing and yet (partially) relational entities.41 Another name, from a different vantage point, might be 'footloose realism'; I prefer to think of it in Nietzschean terms as the joyful wisdom of ecology.42 However referred to, the position enables us to absorb epistemological emphases on positionality and interaction of perspectives while maintaining an ontology robust enough to serve adequately as a pivot of ethical criticism. "To sacrifice animals or exterminate species in this model", Hayles claims, "directly reduces the sum total of knowledge about the world, for it removes from the chorus of experience some of the voices articulating its richness and variety."43 That there is a vitally moral upshot to this sort of perspectival/relational onto‐epistemology is nicely brought out by Anthony Weston: If our very mode of approach shapes th[e] world in turn, then ethics itself must be a form of invitation or welcoming, sometimes of ritual invocation and sometimes of literally creating the settings in which new possibilities [of interaction] might emerge. … we will have only inadequate ideas of what other animals are actually capable [of] until we already have approached them ethically: that is, until we have offered them the space and time and occasion to enter into relationship.44 38
The reader may wonder here whether the cure is worse than the disease. It is worthwhile, then, to clarify the diagnosis and defend the therapy (against a prevalent type of a priori worry): the problem is that Rolston's reliance on science (especially ecology) is too flat‐footed, something of a resting place for naïve faith in the deliverances of epistemic authority; the resolution I am proposing, Nietzschean perspectivism, is often said to be self‐subversive—
but I think this charge is mistaken inasmuch as perspectivism does not have to be adopted absolutely to be taken seriously (i.e. it does withstand self‐application—even if it yields infinite regress on the meta‐level, this result is not necessarily equivalent to auto‐refutation of the first‐order move). 39
Writing from and for a geographical context and audience, James Proctor also comes into theoretical vicinity of the vantage point I am scouting and defending—his excellent survey of the relevant philosophic positions ultimately propounds an onto‐epistemology of nature that joins critical realism and neo‐pragmatism in a dialectical tension of complementarity by which each “sees its own shadow”. Refer to his “The Social Construction of Nature: Relativist Accusations, Pragmatist and Critical Realist Responses”, Annals of the Association of American Geographers 88.3 (1998): 352‐76 (esp. 368ff.). 40
In Reinventing Nature?, p. 58. 41
Ibid., pp. 49ff. Cf. Anna L. Peterson's appropriation, what she calls "chastened constructionism", in her Being Human: Ethics, Environment, and Our Place in the World (Berkeley: University of California, 2001), esp. chap. 3. 42
To better appreciate this preference it may be helpful to heed Babette Babich's remarks on Nietzschean epistemology: "Environmental or ecological exigencies tailor perceptions: this is the critical foundation of [Nietzsche's] perspectivalism" (p. 6); "Because all human knowledge is perspectival, human beings are part of the perspectival nature of the 'relational' world" (p. 90). From Nietzsche's Philosophy of Science (Albany: S.U.N.Y. Press, 1994). An interpretive caveat should be noted here as a hedge against tempting overstatements: to avoid intellectual anachronism and ideological ventriloquism, we need to be wary of putting too much ecosophy into Nietzsche's mouth—for more on this point, see my "Using and Abusing Nietzsche for Environmental Ethics", Environmental Ethics 16:2 (1994). 43
"Common Ground", p. 58. 44
“Multicentrism: A Manifesto”, Environmental Ethics 26 (Spring 2004): 32 (italics altered). 9
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 To take an example from the beginning of our discussion, domesticating live nature into a series of zoological parks and botanical gardens would be contraindicated insofar as such endeavors actually and ironically impoverish the very world they seek to save and showcase (because they threaten to collapse the diversity of wild perspectives into a comparatively homogeneous perspective of captivity). And what is wrong with that, I would add to Hayles' point, is not just the numerical decrease in perspectives but also the diminution of interactive complexity and intensity that results from keeping others under control rather than engaging them freely.45 Moreover, looking closer at this last situation, notice that the loss of reality's richness exposes a thick layer of inauthenticity. To appreciate what's at stake here, we can use the lens of another relational theorist—this one in the field of animal studies. In her endeavor to develop “A Taxonomy of Knowing: Animals Captive, Free‐Ranging, and at Liberty”, Vicki Hearne emphasizes that “my terms describe not so much various conditions in which animals in themselves might be as conditions we are in with the animals, social and grammatical conditions and circumstances.”46 Briefly, captive animals are those kept under direct control (think of lab specimens), free‐ranging ones are those beyond human confinement, and those at liberty are paradigmatically working animals (dogs and horses, e.g., under conditions of training that enable the flourishing of species‐being and individual excellences). Leaving aside the tricky boundary issue between the categories of free‐ranging and at‐liberty, it is nevertheless possible to render judgments of inauthenticity when operating on the basis of a relational system such as Hearne’s. So, returning to the example at hand, the promotion and patronage of a zoo presents its keep as wild in the ordinary sense of free‐ranging when the relation of keeping itself falsifies this same representation. In other words, capture and keeping are misleadingly elided and put under erasure. Likewise, the structure of a zoo’s entertainment value plays off a feeling of intimacy with ‘the wild’ in the form of dangerous creatures; yet, in general, it is not zoo inhabitants’ endogenous ferocity that makes them risky relations for human contact but rather, circularly, their very conditions of captivity. Thus animals pressured by cramping or crowding encountered in confinement are much more likely to behave belligerently. As Mullan and Marvin point out (over against zoos' portrayals) the ‘danger’ is not so much inherent as it is “a product of the animal’s predicament in being forced to be in undesired and unnatural proximity to man.”47 To the extent that zoos trade on the allure of such danger, while occluding their role in 45
I conceive this kind of criticism as supplementing (not necessarily replacing) other, standard ethical judgments (re: organismal treatment, systemic stability, etc.). 46
In the Company of Animals, special issue of Social Research 62.3 (Fall 1995): 442 (italics original, bold added). See also Thomas Sebeok's nine‐fold relational taxonomy‐‐which includes categories of predation, partnership, amusement, parasitism, conspecificity, reification, taming, and training. "'Animal' in Biological and Semiotic Perspective", in Ingold's What is an Animal?, pp. 68ff. Cf. Ted Benton's schema (likewise of nine, albeit different categories) in Natural Relations: Ecology, Animal Rights, and Social Justice (London: Verso, 1993), pp. 62‐68. 47
Zoo Culture, pp. 4f. Interestingly, this example also illuminates the side issue of whether the subjects of life sciences' studies are material objects or social objects. Hacking has it that a characteristic property of the latter is their amenability to feedback loops (whereby the object's behavior is reflexively shaped by subjection to a self‐
fulfilling regimen of study)‐‐but his dichotomy between physical and human sciences leaves biology unaccounted for (72). In this light, then, Mullan and Marvin furnish zoological testimony that captive animals are indeed social beings. 10
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality bringing it about, we can again judge these institutions' exhibition of animality to be less than genuine. Moreover, it is important to notice that this judgment does not depend on discovering deviation from an originary truth of animal essence, but is due rather to a structural set‐up that disallows acknowledgment of its own preconditions. Hence, if zoos (and their visitors) were honest about themselves—that what they keep (or see) are captive animals (who do not necessarily display the characteristics of free‐ranging ones)—they would undermine one of their chief reasons for being (or watching).48 Beside but related to the representational dishonesty just revealed, another ethico‐epistemic problem with the zoo is its interruption of the interactive dialectic transpiring between freely engaged parties and their perspectives. What I have called the joyful wisdom of ecology is stifled by captivity's constraints. Obviously, the opportunities for diversifying transperspectival interactivity are reduced and/or marginalized by the architectural barriers and behavioral muting brought to bear under circumstances of confinement. In fact, for most visitors at most zoological parks or gardens, very little interaction is possible and consequently very little exchange of perspectives happens. Thus the experience is not one of creative encounter, but one of dulling spectatorship (for the seer) and monotony (for the seen).49 48
Compare, however, Keekok Lee’s Zoos: A Philosophical Tour (Palgrave Macmillan, 2006): the author argues that zoo residents are rendered “hybrid” creatures through a process of “immuration”, that most visitors intuit as much, that only organizers pretend otherwise, and finally that the zoo could fare well if the last party would just own up to the true situation. Why I think this otherwise revelatory position remains inadequately critical is brought out in the main text’s next paragraph. 49
This line of reasoning also counters Rolston’s charge that “those who can appeal only to their interactive experiences with nature, or to those that their cultures have preferred to choose, unconvinced that they or anybody else can go further [to natural entities ‘in themselves’], really do not have any convincing arguments with those who choose otherwise” (“F/actual Knowing”, 170). 11
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Joyful Exchanges on a Biosophical Theme: A Dialogue between Eco‐
Realism and Gay Science Characters: Holmes, the Rolstonian eco‐realist; Hermes, the Nietzschean 'gay scientist'. Holmes: So that's it? Seems he just about surrenders the substance of autonomy (which has got to be at the root of at least live nature), and replaces it only with a shadow concept in the idea of relational authenticity.50 In that case zoos, for instance, don't violate the inherent nature of animals (because there isn't any intelligible)‐‐they just misrepresent themselves to us, not really the animals as such. Hermes: I think there's more to it than that. His position appears also to be a stance against the kind of biotic idealism that could lead to (at least species, if not subjective) solipsism. I mean if we actually bought into hardline constructionism, then wouldn't we have to regard other animals as being produced by us‐‐not indeed from nothing, but still only and entirely from our own cultural resources? Hol.: I don't deny the implication, but the bold way to avoid it is to posit a really real animal—
you know, something 'out there' in the manner of objective realism. Her.: How, then, could you avoid abstract postulation—what determinate content, in other words, would you propose to flesh out that idea? Hol.: Well, as one researcher puts it, "because of their distinctive properties of transformational growth and non‐repetitive motion, we see animals as such, irrespective of how we might come to describe and classify them".51 Her.: Interesting: if true, that would enable condemnation of captivity itself—insofar, that is, as repetitive movement is a behavioral by‐product of zoo‐keeping. 50
Though the idea of relational authenticity applies here largely to human dealings (i.e. between institutional organizations and their clientele), it can also be used to characterize inter‐species relations. For instance, the zoologist Barbara Smuts has written an edifying account of her relationship with an adopted (feral) dog named Safi: their bond is "marked by reciprocal 'surrender to the dictates of intersubjectivity'" and both parties "intervene in and mutually influence each other's ensemble of behavior." Primary quotes from my essay "Oikos and Domus: On Constructive Co‐Habitation with Other Creatures", Call to Earth: Journal of the I.A.E.P. 3.3 (March 2003): 28; secondary quote from Smuts' "Reflection", in J. M. Coetzee's The Lives of Animals, A. Gutmann ed. (Princeton: Princeton University Press, 1999), pp. 115ff. For more details, see either source. 51
Edward Reed, as paraphrased by Ingold, p. 12. 12
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality Hol.: Precisely. Her.: Of course, we would have to subject the hypothesis to conceptual analysis and further empirical investigation; nor is it clear that these methods can circumvent constructionist objections rehearsed before. But maybe we don't need objectivism, after all: might not the earlier emphasis on (inter)relationships be enough to avoid the sort of solipsism at stake here? Hol.: I'm not sure I follow; please spell it out. Her.: Even if our zoological awareness is not of some essential animal out there, isn't it still the case that our natural experience occurs with those besides ourselves? Hol.: Maybe, but your articulation is spare and leans heavily on unexplicated connotations of certain phenomenologically murky prepositional phrases. Her: One could, at this point, have recourse to the Marxian discourse on the "transindividual". I'm not sure about it myself, but would you prefer that instead? Hol.: Please no, thank you, not at this time.52 Her.: Just let me mention that Marx thematized a felt space of intersubjectival or better interstitial (and I dare say now ecological) reality which, were we to rehabilitate it carefully, could allow us to circumvent the reductionist difficulties both of monadology and nodal ontology‐‐to thread a path, as it were, between the shoals of solipsism and the hollows of holism respectively. Hol.: Come again? Though I appreciate philosophizing with poetic license, I'm afraid you've lost me in your penchant for flowery alliteration. Her.: I'm talking about the way traditional metaphysics of subjectivity never seem to reconnect sufficiently with the social and natural, whereas newer process or Gestalt‐type ontologies appear to reduce us to mere points in a weblike flux of interactivity. Perhaps a doctrine like Marx' transindividualism could help us get beyond that sort of dilemma‐‐a happy result, I might add, for bioethical ecosophies caught up in the debate between individualism and holism. Hol.: Okay, I'm prepared to say I'd be interested in seeing something like that develop. But for now, I'd like to return to the core issue of autonomy. So far, you've only enhanced the 52
Reference for the reader: see Howard L. Parson's Marx and Engels on Ecology (Westport: Greenwood, 1977), pp. 32, 121. 13
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 plausibility of the thesis that the world contains more than one subject or species. That quantitative result hardly excites. Don't you have anything else to say, qualitatively, about the independent status of nature or animality? Her.: No and yes: no, because talk about the "independent status" of reality belies the whole notion of lifeworldly hermeneutics; yes, because even within the latter horizon of conversation we can yet say something substantive about the kinds of entities populating our environmental philosophy. Basically, it comes down to a recognition that the (relative) dependence of a being's meaning on something or someone else does not nullify that being's existence or autonomy. Influencing an entity, in other words, is equivalent neither to extinguishing nor to controlling it.53 Hol.: So you mean we don't have to choose between viewing a natural entity either as absolutely autonomous or else as completely inert? Her.: That's it! Hopefully, we can make room in our ecosophies for acknowledging multiple agencies of natural and cultural forces‐‐because agency itself does not have to be conceived on the model of consciously self‐produced freedom of individual will. It can be thought of instead as occupying permeable centers of power or moving through flexible vectors of force. Hol.: And thereby we permit a measure of construction to coexist with a degree of autonomy? Her.: If you want to put it that way. What I'm getting at is that the authentic need not be sui generis to have a valid (though perhaps impure) identity of its 'own'. If it had to be so, we'd have landed in the odd situation that to escape inauthenticity an animal (or any other natural feature of the world) must be divine. Surely, though, creatures count‐‐ontologically and axiologically‐‐even if they're not themselves gods! Hol.: I should hope so, yes indeed. Still though, there is one thing remaining that bothers me. Her.: What, pray tell, is that? Perhaps we can clear it up before departing… Hol.: This perspectival/relational account we've ended up with—doesn't it say that the more viewpoints or interactions had on or with a being, the better will be our sense of its reality? Her.: That is the gist of it, yes. 53
"Just as we would not doubt the autonomy of a spouse whose speech recalls the words of his partner"—Albert Borgmann, "The Nature of Reality and the Reality of Nature", in Reinventing Nature?, p. 40. To hold the contrary leads to ecologically and anthropologically stultifying results —as Ira Singer (pers. com.) puts it, “If animals are only truly themselves in isolation, free of the metaphysically distorting gaze of the other, then we [humans] need to rip ourselves out of the rest of nature in order to realize our ‘own’ true being.” 14
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality Hol.: Then I find that the nature‐lover in me wonders whether this principle could lend philosophic sanction to a worrisome boom in the genetic re‐engineering of natural species. Her.: Take it easy, and don't let any fears of Frankenstein consume you. First of all, I believe it's been shown that such manipulations of genotypes are not exactly creations but rather alterations.54 Hol.: But that's just the rub—won't we thereby have increased the possible manifold of perspectives and relations upon or toward an animal by restructuring its genome? Her.: Indeed that appears to be part and parcel of the enterprise itself. And then it would seem that the principle of ecology's "joyful wisdom" not merely allows but actually enjoins a forward leap into the brave new world of biotechnology... Hol.: That's right‐‐we'd open the floodgates for a whole hideous horde of GMOs, like Oncomouse (TM) and its ilk! Her.: Hold your gen‐eng horses. All that's required, to deal with your objection, is some sort of weighting factor that might permit us to prioritize perspectives/relations. Hol.: I don't know if that's forthcoming without reversion to the metaphysics of realism, that is in the absence of ontological essentialism and/or epistemological foundationalism. Her.: I'm afraid my constructionist conscience cannot abide such a move. Wait a second, I remember hearing about a contemporary philosopher of technology who offers the "commanding presence and telling continuity" of real (ordinarily occurring) beings as that which privileges them over and above the concoctions of hyper‐reality.55 Hol.: I'm listening, though you're going to have to say more... Her.: The idea is that the more‐than‐human world engenders genuine awe and connects us to evolutionary history and ecological community, experiences beyond the mere fascination and convenience brought forth by the all‐too‐human realm of high technology. Hol.: Okay‐‐there's certainly enough of a vitalist in me to resonate with that, but I must confess it sounds like you've smuggled the old natural/artificial dualism in the backdoor. Her.: Not really: the distinction at hand is less about an object's provenance than about the 54
See Mark Sagoff's "Animals as Inventions: Biotechnology and Intellectual Property Rights", Institute for Philosophy and Public Policy 16.1 (Winter, 1996): http://epn.org/ippp/sagoff1.html. 55
Borgmann, op. cit., p. 38. 15
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 existential element of interactivity and positionality between subject and object. It doesn't matter so much whence an entity's origin came as how you relate to or with it.56 Hol.: Isn't that, however, empirically relative to different experiencers? Her.: Yes, but I suspect there's a great deal of commonality‐‐at least from the frame of reference of any typical experiencer's lifetime. If you want absolutes, you'll have to look elsewhere; just don't blame me, if questing for certainty turns out to be long and fruitless! Hol.: I won't. And though I must say goodbye for now, hopefully the conversation will continue between us and among those who have been listening... We animals do not compose ourselves. We make each other, but not just as we please; we do not do it under circumstances we choose but under those that we find, given and transmitted by our past and our surroundings. We are linked with our fellow creatures and with the environment which transforms with our acts. … Organisms and environment are linked in a decentered, ongoing current of mutual transformation. (Michael Steinberg57) Ralph Acampora Bibliography 1. Bonnett Michael, Retrieving Nature: Environmental Education for a Post‐Humanist Age, Blackwell, 2004. 2. Hacking Ian, The Social Construction of What?, Cambridge, Harvard University Press, 1999. 3. Mullan Bob and Marvin Gerry, Zoo Culture, London, Weidenfeld & Nicolson, 1987. 4. Sismondo Sergio, Science without Myth: On Constructions, Reality, and Social Knowledge, Albany, SUNY Press, 1996. 56
In this respect, then, we could even make worthwhile distinctions within the realm of biotechnology—between unilateral tinkering or control on the one hand and phenomenological prostheses of cross‐species interrelations on the other. See my “Inventionist Ethology: Sustainable Designs for Reawakening Human‐Animal Interactivity”, Antennae (forthcoming in special issue on Mechanical Animals). 57
The Fiction of a Thinkable World: Body, Meaning, and the Culture of Capitalism (New York: Monthly Review Press, 2005), pp. 39f. “The fundamental point here”, we could say with Curry, “is that a genuine and consistent relational pluralism does not restrict the network of relations and perspectives that constitute all entities to human ones alone” (op. cit., 4). 16
Ralph Acampora – Animal Constructs and Natural Reality 5. Soulé Michael E. and Lease Gary, Reinventing Nature? Responses to Postmodern Deconstruction, Washington D.C./Covelo, CA, Island Press, 1995. 6. Wuichet John and Norton Bryan, Ethics on the Ark: Zoos, Animal Welfare, and Wildlife Conservation, Washington D.C, Smithsonian Institution Press, 1995. 17
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 18
Prospettive politiche della pratica filosofica Neri Pollastri [email protected] www.consulenza‐filosofica.it Abstract
The political meaning of philosophical practice has recently emerged in the reflections on this
subject. This is probably due to the complicated present situation of the social and economical
international scene, which plays a role in the difficulties that the individuals experience, and then
discuss with philosophical practitioners. But a political perspective has been implied in
philosophical practice since its origin. Among other reasons, it depends on an essential and
frequently overlooked characteristic of the practice of philosophy: engaging in philosophical
dialogue involves giving dignity to the interlocutor, creating an affective bond with him, that is
friendship (philia). And philia is the basic element for a society (and therefore for a State) to exist.
Consequently, to spread the practice of philosophy and the rigorous dialogue aiming for the right
and the truth means to promote not only an attentive attitude toward people and society, but also
the creation of social bonds, missing in contemporary cultures, and thus to rebuild the political
texture of society.
Keywords: practice of philosophy, philosophical counseling, ethics and politics in the practice of
philosophy.
1.
LA POLITICA NELLA PRATICA FILOSOFICA Nel nostro paese la consulenza e le pratiche filosofiche godono ormai di una certa notorietà, grazie al lavoro di alcuni appassionati1 e alla pubblicazione di un buon numero di seri lavori scientifici2, che hanno destato l’interesse anche delle Università, da qualche anno attive sul versante dei master, ma anche (sebbene in misura minore) della didattica ordinaria e della ricerca. Tale notorietà non è tuttavia servita a dissipare fraintendimenti e critiche: come osservavo nel mio Consulente filosofico cercasi3, è purtroppo ancora frequente sentir parlare della disciplina come di una “applicazione” della filosofia, di una professione d’aiuto geneticamente derivata dalle psicoterapie, di un’attività professionale legata univocamente al principio, deontologico e metodologico, di dare una risposta al bisogno del committente (l’ospite, o consultante) di “risolvere” quei problemi che lo conducono nello studio del filosofo. 1
Per vedere la qualità del lavoro di alcuni di essi, cfr. il sito Internet di Phronesis ‐ Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica: www.phronesis.info, dove è scaricabile in formato PDF anche l’omonima rivista. 2
Si rinvia in primo luogo alla collana “Pratiche Filosofiche” dell’editore Apogeo, diretta da Umberto Galimberti, principale punto di riferimento per la letteratura in lingua italiana, sebbene non l’unico. 3
Apogeo, Milano, 2007. 19
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Queste interpretazioni portano inevitabilmente ad accusare chi si occupa della materia di “strumentalizzare” la filosofia, di asservirla a una logica di mercato, in generale di smarrire l’elemento etico‐politico che caratterizza la filosofia fin dalla sua origine4. Tali interpretazioni sono in realtà frutto della scarsa conoscenza del fenomeno della Philosophische Praxis (così si chiama la disciplina in Germania, dov’è nata e dove ancor oggi è maggiormente esercitata), tanto per quanto riguarda i suoi principi, quanto per quel che concerne le testimonianze scritte di coloro che la praticano da anni. Infatti, relativamente ai principi, sarebbe sufficiente un’attenta lettura dei lavori (ormai tradotti per gran parte anche in italiano) del fondatore della pratica, Gerd Achenbach, per comprendere come l’identità della consulenza filosofica sia non già quella di una professione d’aiuto o di “servizio”, quanto quella di un’autentica pratica del filosofare5. In altre parole, ben lungi dall’essere finalizzata ad aiutare il consultante a risolvere i suoi problemi e fargli raggiungere i suoi obbiettivi, la consulenza filosofica ha di mira solo ed esclusivamente l’esplicitazione, la critica, la comprensione e l’ampliamento dell’orizzonte concettuale di cui il consultante è portatore ‐ cioè della sua visione del mondo. In questo senso, essa deve essere considerata non già una “applicazione”, bensì una vera e propria “pratica” della filosofia, ancorché su piani e contenuti sovente più concreti di quanto non siano quelli su cui si muove la pratica della filosofia nel mondo della ricerca scientifica. E, quel che è più importante, essendo pratica del filosofare, la consulenza filosofica non può che portare con sé necessariamente quel contenuto etico‐politico che è una delle fondamentali ragion d’essere della filosofia sin da Socrate e da Platone: infatti, nel lavoro di esplicitazione e comprensione della visione del mondo e del sistema concettuale del consultante, l’elemento della critica dell’ovvio, dell’ordinario e di tutto ciò che è istituito e affermato, è un momento essenziale e porta inevitabilmente in gioco la messa in discussione dei suoi principi etici e del ruolo che egli si riconosce nella società ‐ ovvero, della sua concezione politica. Tutto questo, come osservato, era già ben presente fin dall’inizio negli scritti dei consulenti filosofici. Basterebbe leggere i molti passi di Philosophiche Praxis di Achenbach6, o le sue critiche alla modernità ne Il libro della quiete interiore7 e in Saper vivere8. Oppure, andare a rivedere le più recenti Reflections di Ran Lahav9, nelle quali viene evidenziato come la riflessività, la profondità, la pratica del dubbio che è propria della filosofia non possano che entrare in conflitto con l’ideologia oggi dominante, fatta di esteriorità e di consumo di beni materiali mai realmente valutati alla luce dei principi etici che pure noi tutti, contraddittoriamente, professiamo. 4
L’esempio più eclatante di questo tipo di giudizi lo si trova nel lavoro di Alessandro Dal Lago, Il business del pensiero (Roma, Manifestolibri, 2007), la cui inconsistenza critica stigmatizzo nella mia Analisi del testo, comparsa in “Phronesis”, 9, 2007. 5
Per brevità mi astengo in questa sede da reiterare riferimenti ai lavori dei principali teorici della materia, come Gerd Achenbach, Ran Lahav, Anders Lindseth, solo per citarne alcuni, che ho in gran copia effettuato in altri miei lavori, in particolare in Il pensiero e la vita (Milano, Apogeo, 2004) e nel già citato Consulente filosofico cercasi. 6
Stuttgart, Dinter, 1983, tradotto in Italia con il titolo Consulenza filosofica (Milano, Apogeo, 2004). 7
Milano, Apogeo, 2005 (ed. or. Das kleine Buch der Inneren Ruhe, Freiburg im Brisgau, Herder, 2000). 8
Milano, Apogeo, 2006 (ed. or. Lebenskönnerschaft, Freiburg im Brisgau, Herder, 2001). 9
Cfr. il suo sito Internet www.ranlahav.net, oppure, per le traduzioni italiane, i numeri 7, 8 e 9 della rivista “Phronesis”. 20
Neri Pollastri – Prospettive politiche della pratica filosofica È tuttavia interessante osservare come il tema della politica sia recentemente balzato in primo piano nelle riflessioni dei teorici della consulenza filosofica. Ciò è accaduto, in particolare, alla IX International Conference on Philosophical Practice, l’ultimo dei periodici meeting della comunità internazionale dei consulenti, tenutosi nel luglio scorso in Italia, a Carloforte10. In questa occasione, dedicata al complesso e controverso concetto di “vita filosofica”11, molti consulenti e studiosi di paesi diversi hanno toccato l’argomento, alcuni intrecciandolo con altri più tipici della riflessione pratico‐filosofica (ad esempio alla critica dell’atteggiamento terapeutico oggi imperante o all’organizzazione del mondo della cultura, che crea lobby di cittadini privilegiati), altri mettendolo a tema dei loro interventi, come nei casi di Petra Von Morstein (uno dei capiscuola della materia), di Thomas Polednitschek (autorevole rappresentante della scuola tedesca) e di chi scrive12. Interrogandosi sul perché il tema della politica sia apparso di particolare importanza alla comunità dei consulenti filosofici proprio in questo momento, una risposta che si presenta è quella che rimanda a quanto sta accadendo nelle nostre società, da un lato inquietantemente assediate da uno smisurato fenomeno di immigrazione da paesi di cultura assai diversa dalla nostra, sempre più attraversate da fermenti razzisti (o quantomeno xenofobici) e caratterizzate dalla rinascita di palesi movimenti violenti, dall’altro poste di fronte a incontrollabili crisi economiche e impressionanti scandali finanziari, accompagnati dalla perdita dei diritti individuali e dalla precarizzazione dell’esistenza. Tutto ciò influisce molto profondamente sulla vita delle persone e, in ragione anche del fatto che mancano drammaticamente risposte lineari ed efficaci da parte degli specialisti dei diversi settori (economia, sociologia, politica istituzionale), produce in essi inquietudine, cioè l’altra faccia di quella meraviglia che è da sempre considerata la “madre” della filosofia. Così ‐ lo dico per esperienza personale nell’attività professionale ‐ diviene naturale che, all’interno dei dialoghi di consulenza filosofica, la riflessione su questi argomenti si intrecci indissolubilmente alla discussione degli aspetti problematici personali e conduca all’esame e alla rielaborazione creativa delle opzioni etiche e politiche individuali, sociali e teoriche. Conseguentemente, è altrettanto naturale che i consulenti ‐ che sono e rimangono dei filosofi non solo “pratici” ma anche teoretici ‐ si interroghino a loro volta sul senso politico del loro agire professionale e sulle prospettive che tale agire concreto ha o può avere tanto sulla riflessione filosofico‐
politica, quanto sull’agire politico stesso. 10
Alla conference hanno preso parte centonovanta persone provenienti da sedici paesi del mondo. Per maggiori informazioni cfr. il sito Internet www.carloforte2008.eu. 11
Con “vita filosofica” si intende in generale l’assunzione di un atteggiamento filosofico nei confronti dell’esistenza, praticato anche nei suoi momenti più “ordinari” ‐ al lavoro, nelle relazioni con gli altri, nel corso delle molteplici attività che costituiscono la vita di ciascun uomo. La “vita filosofica” è un concetto ancora impreciso, l’oggetto di una ricerca che ha per ambiti confinanti la saggezza, l’etica e, appunto, la politica. 12
Avendo avuto l’onore di aprire il convegno, ho accennato all’importanza del tema fin dalla mia prolusione inaugurale, ma gli ho poi dedicato interamente un workshop nel prosieguo dei lavori. 21
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 2. ETICA E POLITICA NELLA FILOSOFIA Che la politica sia parte integrante, anzi essenziale, della filosofia è fin troppo noto e non sarà quindi necessario argomentare a lungo per dimostrarlo. La filosofia, fin dall’antichità greca, trova infatti molto spesso la sua origine in interrogativi di tipo etico e politico. Basti ricordare che la cultura greca era animata da due importanti fenomeni che hanno preceduto e preparato la filosofia: la nascita e lo sviluppo della scienza storica, la quale ‐ prima con Erodoto e poi con Tucidide ‐ è storia politica, anzi, ha di mira la comprensione dei fenomeni del passato proprio per meglio affrontare le difficoltà della politica contemporanea; la tragedia, che mette in scena le inquietudini dell’uomo greco e, nel farlo, sovente si dedica a sceneggiare drammaticamente dilemmi etico‐politici (si pensi, in primo luogo, all’Antigone)13. La filosofia s’innesta su questi fermenti e se ne nutre; cosicché Socrate dedica la quasi totalità delle sue energie alla riflessione etico‐politica, mentre il suo discepolo Platone si spinge sì nei territori astratti della logica e della metafisica, ma lo fa mantenendo sempre ben serrato l’ancoraggio al primo motivo del suo speculare: la ricerca del modo migliore per far convivere i cittadini nella polis. Si potrebbe certo obbiettare che quanto valeva agli esordi non è sempre seguitato a valere nei successivi due millenni e mezzo di pensiero filosofico. Ma tale obiezione vale fino a un certo punto, non solo perché la riflessione etico‐politica è stata ben raramente del tutto assente nel lavoro dei singoli filosofi ed è comunque sempre rimasta parte rilevante delle correnti e delle scuole nelle varie epoche, ma ‐ soprattutto ‐ perché esistono ragioni teoretiche per ritenere che non possa darsi un lavoro filosofico che non presti una parte importante della sua attenzione all’etica e alla politica. 3. LIMITI DELLA FILOSOFIA POLITICA “ASTRATTA” Prima di osservare tali ragioni sarà però opportuno evidenziare quelli che potremmo definire i “limiti” della speculazione etica e politica astratta, cioè quella usualmente condotta dalla ricerca filosofica tradizionale e che si è soliti definire “filosofia pratica”14. La riflessione filosofica, infatti, si muove spesso su un piano troppo distante dalla realtà concreta, dalla complessità dei fenomeni che si verificano ogni giorno nell’interazione degli esseri umani. Si tratta di un tratto caratteristico certo irrinunciabile del filosofare, ma anche di un atteggiamento che può diventare perverso, spingendo a teorizzazioni tanto degne di nota, quanto del tutto inutilizzabili concretamente, talvolta persino come meri orientamenti dell’agire pratico. Inoltre, proprio il carattere “scientifico” della riflessione filosofica astratta e la sua espressione “scritta”15 fanno sì che la riduzione della complessità che sempre caratterizza l’universo teorico rispetto al reale assuma una priorità su quest’ultimo in termini 13
Per una interpretazione della tragedia greca come momento preparatorio della filosofia, cfr. Vittorio Hösle, Il compimento della tragedia nell’opera tarda di Sofocle, Napoli, Bibliopolis, 1986, e Giorgio Colli, La nascita della filosofia, Milano, Adelphi, 2002. Su questi temi rimando peraltro al terzo capitolo del mio Il pensiero e la vita, cit., “Filosofia: la ricerca come modo di vivere”, pp. 129‐194. 14
Sulla storia e il significato concettuale di questa definizione cfr. Enrico Berti, Filosofia pratica, Napoli, Guida, 2004. 15
Le idee scritte, come già insegnava Platone, sono sempre a rischio di assumere un carattere di autorevolezza che sconfina nell’autoritarismo e di perdere il loro senso di idee umanamente finite, fallibili e rivedibili. 22
Neri Pollastri – Prospettive politiche della pratica filosofica di autenticità, che è di fatto ingiustificata: l’astratto è per definizione qualcosa che si ricava per “distillazione” dal concreto e che perciò trova in esso il suo punto di ritorno e la sua verifica. È a partire da considerazioni di questo genere, e certo non per una svalutazione del lavoro della ricerca filosofica tradizionale, che Gerd Achenbach, nei suoi primi scritti sull’allora nascente philosophische Praxis, prendeva le distanze dall’eccesso di astrazione, affermando che «una filosofia “pura” non può mai essere una filosofia pratica e, se lo fosse, diventerebbe terrorismo»16. E sottolineava al contempo l’urgenza, per la filosofia, di porre attenzione a quel “ma” che campeggia sempre nelle risposte ai “retti consigli”: «“sì, lo so che è giusto, ma non posso”. Oppure: “ho preso tutto in considerazione, ma…”. Questa opposizione verso la pretesa razionale, questa ubiquità del “ma” dovrebbe diventare l’interesse della ragione stessa»17, perché questo “ma” ci obbliga a riconoscere che «vogliamo fare i conti “razionali” senza l’oste»18, ovvero che «viviamo delle grazie di altre forze»19. Tutto ciò non significa per niente né una ricaduta nell’irrazionalismo, né l’assenso a un paradigma psicologistico, bensì solo l’assunzione consapevole di un dato: che la complessità dell’umano non è dominabile attraverso la sua sola riduzione alla linearità della ragione e che ogniqualvolta ciò venga tentato è necessario ricordare che i risultati sono per principio parziali e lacunosi, tali che la ricerca di una più profonda comprensione deve sempre e in ogni caso andare avanti. È per le medesime ragioni che Achenbach, nelle stesse pagine, sosteneva che «la consulenza filosofica sulla vita non dispone in senso positivo di alcuna teoria, che sia solo applicabile»20, negando in tal modo che essa sia una mera “applicazione” della filosofia ed affermando viceversa il suo essere vera e propria filosofia, cioé non l’applicazione ma il proseguimento della ricerca filosofica sul piano del concreto. Questa è “la sfida della consulenza filosofica alla filosofia accademica”, a cui lo stesso Achenbach ha più volte accennato: la sfida che la complessità irriducibile del particolare e del concreto pongono al teorizzare e agli universali. Quella stessa sfida che Platone perse, allorché tentò la sua avventura da politico concreto a Siracusa, e che ha spinto ad esempio un teorico della filosofia politica come Vittorio Hösle a ritardare l’uscita e ad ampliare a dismisura il suo Moral und Politik21, di fronte al fallimento di una politica “teoricamente buona” (qual era suo giudizio quella condotta a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 da Michail Gorbaciov) e al suo rovesciamento in una “praticamente cattiva” (quale quella di Boris Eltsin). Riconoscere i limiti della teorizzazione astratta in ambito politico non significa tuttavia il suo abbandono: essa rimane infatti il punto di partenza, il riferimento privilegiato, anzi quel che deve essere rimesso continuamente in gioco nella pratica filosofica. Vi è qui uno snodo, attraversando il quale la filosofia pratica si converte in pratica filosofica: ciò avviene allorché la teorizzazione astratta della prima viene messa in gioco extra muros, nei dialoghi con non filosofi e per affrontare questioni quotidiane. “Messa in gioco”, e non “applicata”, perché in quei dialoghi, in quelle sfide, l’elaborazione della filosofia pratica ‐ cioè 16
Gerd Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 53. Op. cit., p. 52. 18
Ibidem. 19
Op. cit., p. 53. 20
Op. cit., p. 83. 21
München, Beck, 1997. 17
23
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 dell’etica e della politica ‐ si gioca per un lato la sua credibilità (quale potrebbe mai essere il suo senso, se non fosse in grado di offrire qualcosa di reale alla vita degli uomini?) e per un altro la sua stabilità (l’effettiva sua rispondenza alla realtà è condizione della sua sopravvivenza o della sua decostruzione critica e ricostruzione in forme nuove). Occorre peraltro osservare come la riflessione politica in ambito filosofico sia perlopiù condotta quasi esclusivamente considerando la politica solo come estensione sociale dell’etica, ovvero avendo di mira la messa a punto di teorie dello Stato o della società giusti. Questo aspetto della politica è senza dubbio fondamentale, ma non è l’unico, giacché accanto ad esso ne figurano altri, tra i quali i più rilevanti e imprescindibili sono la cratologia (ovvero la teoria dell’agire strategico che possa tradurre nella realtà le teorizzazioni giuste), l’esercizio del potere legittimo (sia esso legittimato da investiture, come avviene negli stati autocratici, o da deleghe, come si verifica in quelli democratici) e l’agire sociale individuale (il comportamento dei singoli cittadini, che ha sempre, anche quando non se ne è consapevoli, un impatto sulla vita sociale e politica). Di questi altri aspetti della politica la riflessione filosofica si è occupata, quando lo ha fatto, in modo marginale. Ad esempio, la riflessione filosofica sulla cratologia è limitata a pochi autori, come Machiavelli e Carl Schmitt, mentre quella sulle modalità dell’interazione umana che originano legame – senza il quale non può esistere quella società che “sostiene” l’esistenza delle istituzioni statali e che da esse viene regolata ‐ è forse ancor più limitata22 e di solito condotta in modo del tutto svincolato dalla riflessione sulle forme dello Stato. È anche per queste ragioni che le teorizzazioni etico‐politiche sono spesso risultate in larga misura avulse dalla vita politica e hanno avuto minore o maggiore influenza solo in funzione della (del tutto accidentale) attenzione che è stata loro dedicata da individui (o gruppi di individui) “illuminati”, che svolgevano de facto attività politica concreta e che le hanno prese in considerazione per trarne ispirazione e orientamento. Tenendo presenti i limiti della “filosofia pratica” cui abbiamo appena fatto cenno, è forse possibile comprendere meglio in tutta la sua portata il valore che la pratica filosofica ‐ più esattamente, la pratica della filosofia con non filosofi e su temi concreti ‐ può avere tanto per la formazione di una più complessa e completa coscienza etico‐politica dei cittadini (siano essi filosofi o meno), quanto per la crescita e il rinnovamento della stessa filosofia intra muros. 4. PRATICA DELL’ARGOMENTARE E FORMAZIONE DELLA COSCIENZA ETICO‐POLITICA L’importanza che il filosofare extra muros può avere per la qualità del clima politico diffuso, cioè della coscienza etico‐politica dei cittadini della polis, si manifesta attraverso l’esplicitazione di tre conseguenze del suo esercizio: 1. la frequentazione delle elaborazioni della filosofia pratica da parte dei cittadini non filosofi e il confronto delle loro individuali opinioni con quanto elaborato in forme rigorose, sebbene astratte, dai filosofi, determina un arricchimento della 22
Vi sono certo autorevoli eccezioni, che vanno da Spinoza a Louis Dumont e Alain Caillé. 24
Neri Pollastri – Prospettive politiche della pratica filosofica coscienza etico‐politica, un miglioramento del dibattito pubblico e una maggiore consapevolezza del significato politico delle scelte individuali23; 2. tale frequentazione, unita all’esercizio pubblico del dialogo rigoroso e ben fondato tra opzioni diverse, origina una progressiva desoggettivazione e deideologizzazione delle opinioni politiche personali, trasformando i conflitti da sterili, quando non deleteri, scontri (quali oggi sempre più si osservano a tutti i livelli del dibattito politico) in utili e costruttivi confronti; 3. infine, la pratica diffusa del dialogo filosofico, intrinsecamente basato sul riconoscimento di un valore all’interlocutore, favorisce la nascita e il rafforzamento del legame tra i cittadini, cementandone la convivenza e la cooperazione sociale. Il primo aspetto è forse il più ovvio, perché lo si può immediatamente derivare dal tradizionale concetto di filosofia, quello “statico” che la identifica quasi interamente con il suo contenuto di sapere, con la “storia” della filosofia e le “opere” dei grandi pensatori. E non c’è dubbio che l’arricchimento culturale dell’universo pubblico del discorso riguardo l’etica e la politica sia un fenomeno decisamente auspicabile a fronte di una cultura, qual è la nostra, crescentemente minacciata di superficialità, nella quale l’accurata fondazione delle proprie idee e il confronto con opzioni diverse da quelle personalmente sostenute vengono sempre più disincentivati. Inoltre, la frequentazione delle elaborazioni della filosofia pratica, caratterizzate da rigore argomentativo, chiarezza, coerenza, esplicitazione dei propri presupposti, sistematizzazione della molteplicità dei principi di valore in un quadro interconnesso, e così via, ha per conseguenza l’affinamento del pensiero politico dei cittadini, con accrescimento generale della qualità del dibattito pubblico. Tuttavia, a dispetto della sua minore immediatezza, il secondo aspetto si rivela già più rilevante del precedente. Infatti, la pratica pubblica del discorso filosofico avviene per mezzo del dialogo (e non dello scontro) tra le diverse posizioni, il quale produce una progressiva comprensione e assimilazione delle opinioni altrui e una conseguente riduzione del valore dogmatico di verità che l’opinione personale assume allorquando sia sostenuta in solitudine, oppure nell’agone di una disputa strategica mirata solo alla propria affermazione. Ben più importante dunque dell’arricchimento, la desoggettivazione e deideologizzazione delle opinioni individuali ha il merito di ricondurre la discussione politica pubblica alle sue origini antiche, non a caso coincidenti con la fioritura della filosofia ad Atene, quando l’assise dei cittadini aveva per ideale obbiettivo l’individuazione e la scelta dell’opzione migliore, e non ‐ come avviene oggi ‐ l’affermazione di un partito ai danni di un altro. Ma l’aspetto più notevole della diffusione extra muros della pratica filosofica è in realtà il terzo, che scaturisce da un elemento essenziale della filosofia, eppure sovente sorprendentemente trascurato: il fatto che il filosofare si basa (e al tempo stesso promuove) la relazione intersoggettiva, la franchezza, la fiducia, la parresia, alla fin fine l’amicizia (philia24). 23
Basti pensare al modo in cui le scelte individuali in merito a consumi e stili di vita hanno oggi, in un sistema politico ed economico globalizzato, sulle condizioni di vita degli abitanti del resto del pianeta. 24
Cfr. Il mio Consulente filosofico cercasi, cit., ma soprattutto Giuseppe Ferraro, Filosofia in carcere, Filema, Napoli, 2006, e L’innocenza della verità, Filema, Napoli, 2008. 25
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Queste ultime affermazioni potranno forse suonare strane a coloro che considerino da filosofia solo uno spersonalizzato ambito di ricerca, un “mestiere” come gli altri, nel quale si svolge il proprio lavoro, si fa carriera, si hanno nei confronti degli altri solo doveri di rispetto formale (come quelli inscrivibili all’interno di un codice deontologico). Ma questa lettura ‐ peraltro molto diffusa ‐ è scorretta, nella misura in cui non riesce a dar conto del modo in cui realmente “funziona” questo curioso e del tutto particolare modo di agire che si è soliti chiamare “filosofia”. Fare filosofia significa praticare una delle molte forme di interazione verbale che sono possibili tra gli esseri umani. Come hanno mostrato nel corso dei secoli (e in particolare durante il Novecento) linguisti e filosofi, nell’agire linguistico in quanto tale sono implicati in modo latente ma imprescindibile determinati principi di valore: allorquando interagiamo linguisticamente con un’altra persona, già diamo per buono che l’interlocutore assegni credibilità alle nostre parole, così come noi stessi l’assegniamo alle sue. Se ciò non avvenisse, sarebbe semplicemente impossibile la comunicazione e lo stesso agire linguistico. È tuttavia vero che in molte forme di agire linguistico questi principi etici impliciti vengono intenzionalmente sospesi e talvolta perfino violati. Un caso in questo senso esemplare è l’atteggiamento strategico che viene messo in atto ogni qual volta il fine dello scambio comunicativo sia l’affermazione del parlante, la conquista di una qualche forma di potere attraverso l’uso della parola, come avviene tipicamente nell’agone politico così come lo pensiamo oggigiorno. Sebbene sia vero che anche nell’ambito del dialogo filosofico possa avere occasionalmente spazio la disputa strategica (la difesa della propria posizione e delle proprie idee profondamente meditate fa parte del lavoro di elaborazione, anche in presenza di un forte elemento di collaborazione), il fine di questa forma di agire linguistico non è mai in ultima istanza quello di far prevalere la propria posizione, quanto piuttosto quello di giungere a costruirne una che tenga conto nel modo migliore dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla ricerca. Ciò perché la verità, oggetto ideale della ricerca filosofica, è qualcosa che si può ottenere solo attraverso la cooperazione intersoggettiva, tanto che perfino per convalidare le proprie idee immutate è necessario esporle alla critica ed elaborare argomenti a sostegno che abbiano cogenza, per gli altri come per se stessi. Da questo punto di vista l’agire linguistico della filosofia è una sorta di gioco nel quale si vince tutti assieme e dove non ha di principio nessuna importanza l’affermazione individuale. È per questa ragione che, se ci preme la buona riuscita del lavoro che stiamo svolgendo e diversamente da forme di agire linguistico di tipo strategico, l’ascolto delle parole dell’altro deve essere attento, rispettoso, completo, privo di riserve personali. In altre parole, si deve prendere l’interlocutore interamente sul serio, a prescindere da ogni pregiudizio si possa avere nei confronti della sua cultura, posizione sociale, nazionalità, colore della pelle, religione, opinione politica o filosofica, età, sesso, e quant’altro. Questo significa al tempo stesso esporre la propria personale opinione alle obiezioni avanzateci dal dialogante, ovvero esporsi ‐ strategicamente parlando ‐ alla possibile perdita di potere nei suoi confronti, condizione senza la quale non è possibile l’efficace collaborazione nella ricerca di una concezione teorica migliore. 26
Neri Pollastri – Prospettive politiche della pratica filosofica Queste condizioni relazionali del filosofare, senza le quali come detto non si dà ricerca filosofica condivisa (e, si noti, la ricerca filosofica è sempre condivisa, perché la ricerca solitaria o presuppone una collaborazione differita, cioè un dialogo attraverso i testi scritti, o è una mera finzione immaginaria), sono però al tempo stesso le condizioni perché possa darsi una buona relazione umana: solo considerando l’interlocutore come un proprio pari, accantonando i naturali pregiudizi cui ciascuno di noi soggiace e prendendo sul serio le sue parole, investendolo di fiducia, confidando nella sua collaborazione per il raggiungimento di un risultato condiviso, è possibile allacciare con il prossimo una relazione che superi la fredda convivenza funzionale (sempre soggetta a trasfigurarsi in ostilità e in scontro) e diventi legame, ovvero un vero e proprio rapporto affettivo. In questo senso, la filosofia è una forma di agire umano capace di far sbocciare sul tronco della razionalità le infiorescenze del sentimento. Ma il legame, ce lo insegnano le riflessioni contemporanee che dalla etnologia alla sociologia giungono fino alla filosofia politica25, è ciò che rende possibile l’esistenza della società e senza il quale sia essa, sia lo Stato che su questa insiste, sono solo un’accozzaglia discontinua di individui, tenuti assieme da regolamenti vissuti come meri vincoli esterni e sempre sul punto di collassare nel caos. Il legame tra i cittadini è appunto ciò che oggi manca nelle nostre società, e questo proprio perché è carente lo spazio pubblico in cui sia possibile, anzi doveroso, dialogare con franchezza e libertà, cooperare intellettualmente alla ricerca del vero e del giusto. Se questo spazio pubblico è carente lo si deve in certa misura sicuramente all’egemonia, in sé accidentale, dei mezzi di comunicazione di massa unidirezionali, che hanno soffocato i preesistenti focolai di dialogo (i circoli, le sedi di partito, i dopolavori) e restaurato un modello di formazione delle opinioni di tipo medievale, che tendeva ad essere superato nelle società democratiche: quello basato sul potere della parola autorevole, un tempo rappresentata da monarchi, nobili e autorità religiose, oggi rappresentato invece da detentori di potere economico, opinion maker della più diversa (e sovente dubbia) origine, leader politici di sempre più bassa statura e ‐ unici reduci del passato ‐ autorità religiose. Ma lo si deve anche, e qui molto meno accidentalmente, alla pervasività di una cultura individualista, poggiante su un’antropologia mai esplicitata ma egualmente condivisa, che fa dell’uomo una monade senza finestre, munita però di una straordinaria e quasi infinita volontà di appropriazione. Quest’antropologia è di fatto falsa, perché l’uomo ha geneticamente le sue radici nell’uomo e perciò sviluppa quell’imprescindibile bisogno di legame che appunto chiamiamo sentimento e che, per la sua irriducibilità alla razionalità economica (quella lineare, matematica, che presiede al calcolo materiale dell’agire meramente appropriativo), viene espulso tout court dalla razionalità e relegato nell’irrazionale26. Ma essa finisce per apparire tuttavia verosimile in una realtà nella quale il potere economico, per riprodurre se stesso, ha la possibilità di operare in modo martellante alla formazione delle opinioni attraverso i messaggi pubblici unidirezionali, trovando anche il consenso prezzolato di chi avrebbe strumenti e ragioni per segnalarne la parzialità ideologica. È solo il disagio degli uomini che vivono in queste società, 25
Cfr. ad esempio gli studi del MAUSS (Movimento Anti Utilitarista delle Scienze Sociali), di Serge Latouche, Pietro Barcellona, Roberto Esposito, Marco Revelli. 26
Cfr. Jacques Godbout, Lo spirito del dono, Torino, Bollati Boringhieri, 1993 (ed. or. L'Esprit du don, Paris, La Decouverte, 1992). 27
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 un disagio oggettivo ma vissuto soggettivamente, a rivelare l’erroneità di quella verosimiglianza: l’incomprensione serpeggiante, la paura crescente, l’erompere dell’insicurezza, il deflagrare dell’orrore sul proprio pianerottolo, spinge prima a rintanarsi nel proprio privato, barricandosi nel calore dei propri cari, ma solo per scoprire un attimo dopo che quell’incomprensione è penetrata come una lama fin dentro il focolare domestico, e scatena una fredda, inattesa e allucinante violenza anche tra madre e figlia, tra moglie e marito, perfino tra sé e sé. È da qui, da questo sconcerto, da questo disorientamento, che nasce il diffuso bisogno di tornare alla pratica della filosofia. C’è chi si sorprende e chi perfino si risente di fronte al fatto che la filosofia, questo momento alto della cultura, venga chiamata in causa non già per volteggiare alti nel cielo, ben al di sopra del fango, della sporcizia e dell’imperfezione che caratterizzano la terra e la vita quotidiana, bensì proprio per avere a che fare con quel fango, con quella sporcizia e con quell’imperfezione27. Eppure, anche in questo caso il percorso che la filosofia compie è del tutto isomorfo a quello che ha seguito alla sua origine: essa si avvia dal bisogno dell’uomo di dare senso allo sconcerto prodottogli dall’incomprensibilità dei concreti fenomeni dei quali si trova in balia. Allora come oggi, è l’individuo, preda di smarrimento ed inquietudine, che sente il bisogno di una riflessione lucida, di un dialogo franco, del filosofare. Ed è dalla soddisfazione di questo bisogno, dalla messa in pratica del filosofare, che si origina una nuova cultura, o meglio che rinasce una cultura antica, una cultura umana, fatta di rispetto, di dialogo, di cooperazione, soprattutto di legame intersoggettivo. 5. MARGINALITÀ DELLA POLITICA NELLA “CURA” PSICOTERAPEUTICA Da questo punto di vista, anche il fatto che una delle forme di maggior successo nelle diverse “pratiche filosofiche” sia la cosiddetta consulenza filosofica ‐ cioè un’attività professionale rivolta ad individui che attraversano crisi esistenziali personali e perciò apparentemente “in competizione” con le psicoterapie ‐ ha un importante significato politico. La pervasività del paradigma terapeutico28 è infatti solidale con la crisi del legame sociale nelle nostre culture. Come evidenzia con acuto senso critico il sociologo anglo‐ungherese Frank Furedi nel libro Il nuovo conformismo29, l’impressionante incremento dell’uso di termini del vocabolario medico (come “trauma”, “stress”, “sindrome”) da parte dei media e l’aumento continuo della classificazione di patologie psichiche nei manuali diagnostici portano con sé l’affermazione di un vero e proprio modo di pensare, funzionale all’aggiramento di un grave limite della nostra cultura: la scomparsa delle tradizionali connessioni di senso. Questa scomparsa ‐ che altro non è che la più completa espressione di quel fenomeno tanto richiamato e deplorato che va sotto il nome di “crisi di valori” ‐ non compensata dalla messa a 27
Uso volutamente questa terminologia solo apparentemente enfatica, per richiamare l’analogo uso linguistico (e gli analoghi intenti) di Martha Nussbaum in L’intelligenza delle emozioni, Bologna, Il Mulino, 2004 (ed. or. Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001). 28
Per un approfondimento del tema cfr. il mio già citato Il pensiero e la vita, particolarmente pp. 90‐98. 29
Frank Furedi, Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana, Feltrinelli, Milano, 2005 (ed. or. Theray Culture, London, Routledge, 2004). 28
Neri Pollastri – Prospettive politiche della pratica filosofica punto di altre connessioni di senso, più adeguate all’evolversi della cultura umana e delle organizzazioni civili, produce l’emergere di «problemi che una volta erano considerati politici, economici o culturali» e che invece vengono «oggi ritenuti psicologici»30. Ma tale slittamento di piani porta con sé un assunto: che le emozioni siano qualcosa di individuale, di privato. Ciò significa dare per buono che l’uomo sia essenzialmente un individuo, appunto una monade senza finestre, e che di conseguenza il suo individuale benessere sia qualcosa a cui dare sempre e comunque la priorità e di cui occuparsi isolatamente. In questo contesto, osserva Furedi, si finisce per dimenticare che in passato «le esperienze dolorose acquisivano senso in quanto parte di sistema comune di significato, piuttosto che come sintomi di un problema emotivo individuale»31. Vengono cioè a sparire i valori condivisi che venivano assegnati alla sofferenza, con due conseguenze di enorme gravità: in primo luogo si smarrisce la capacità di dar senso e quindi di affrontare le difficoltà dell’esistenza, azzerando l’importanza che la sofferenza stessa ha per ogni esperienza di formazione della persona (l’apprendimento di qualsivoglia competenza o abilità richiede necessariamente uno sforzo, una sofferenza, si tratti di passare ore e ore di fronte dei libri, oppure alla tastiera di un pianoforte, o a imparare come smontare e rimontare il motore di un’automobile); in secondo luogo viene meno il terreno comune sul quale era possibile costruire il legame sociale, con conseguente aumento della sfiducia reciproca e della difficoltà di comprendersi tra diversi. È lo stesso sociologo ungherese a trarne le conseguenze politiche: scomparso il senso della sofferenza come necessario tragitto da percorrere per conseguire le virtù, scompaiono ovviamente anche queste ultime, che finiscono per non avere più alcuna importanza nella costruzione che ciascuno fa della propria identità. Ciò si evidenzia a suo parere perfino nell’immagine che i politici trasmettono ai loro elettori, sempre meno incentrata sulle loro effettive qualità e viceversa sempre più basata sulla condivisione, esibita a fini di consenso, delle loro debolezze. La “cultura della terapia” è dunque, secondo Furedi, al tempo stesso causa ed espressione dei «mutamenti intervenuti nella soggettività»32: deresponsabilizza le persone rispetto alla qualità e agli effetti delle loro azioni, assegnandone la responsabilità non più ai loro limiti e alle loro modeste competenze, bensì alle loro patologie (delle quali, in ultima istanza, sono sempre responsabili altri); le distoglie «dall’impegno sociale»33, allentando sempre di più quel legame intersoggettivo e quella partecipazione politica all’agire comunitario che solo potrebbe permettere loro di tornare a dar senso alle stesse vicende dolorose cui si trovano ad essere soggetti. Più in generale, Furedi sostiene la tesi che il trasferimento del luogo preposto ad affrontare le difficoltà individuali e sociali dall’ambito del dialogo pubblico allo psicologico “sportello di ascolto” (spostamento che egli dimostra essere stato realmente messo in atto dalle amministrazioni politiche nei paesi anglosassoni) e la conseguente affermazione del paradigma terapeutico siano tra le ragioni del declino della politica nei paesi occidentali. Fermo restando 30
Op. cit., p. 35. Op. cit., p. 41. 32
Op. cit., p. 247. 33
Ibidem. 31
29
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 che, probabilmente, il sociologo ungherese sarebbe pronto a prendere le armi anche contro un eventuale successo della consulenza e delle pratiche filosofiche, va tuttavia riconosciuto che le sue critiche non si applicano a queste ultime, dato che il tipo di interazione dialogica che la filosofia mette in gioco è tutt’altro che deresponsabilizzante e anzi richiede tanto l’assunzione di responsabilità, quanto l’accettazione preventiva della propria limitatezza (condizione affinché si richieda l’altrui collaborazione), costituendo così la premessa per la costruzione di un sempre rinnovantesi legame interpersonale. 6. UNA PRATICA SOCIALE E NON INDIVIDUALE Abbiamo così potuto osservare da numerosi punti di vista come la pratica filosofica ‐ intesa come prassi diffusa del dialogo argomentativo rigoroso ‐ abbia intrinsecamente un significato politico. Essa lo eredita dalla specificità dell’agire linguistico proprio della filosofia, il quale richiede investimento di dignità e di valore dell’interlocutore e, attraverso la sua pratica, lo consolida. Ma lo deriva anche dal valore etico ‐ e perciò politico ‐ che la filosofia ha in tutte le sue manifestazioni compiute e dal significato che la sua diffusione ‐ sia come mera forma di cultura, sia soprattutto come prassi ‐ produce. Ci si può a questo punto chiedere se questo significato pregiudichi o meno anche alcune possibili direzioni della politica. La risposta sta, a mio parere, già nelle ragioni addotte a prova dell’esistenza del significato stesso: se il filosofare implica l’apertura incondizionata all’interlocutore, l’investimento di fiducia, l’ascolto attento delle sue obiezioni, la collaborazione con esso, la tessitura di un legame (che, in quanto tale, non è “funzione” ma “sentimento”), allora il filosofare ‐ almeno qui, nelle nostre società e culture, e ora, all’alba del nuovo millennio ‐ non è, né può essere neutrale nei confronti di quello che è stato chiamato in modo un po’ tranchant “pensiero unico”, o nei confronti dello strapotere indiscusso e indiscutibile dell’agire tecnico‐strumentale (cioè di quello che viene spesso chiamato “paradigma della tecnica”34). Ovviamente, questo non porta la pratica filosofica ad essere né “di destra”, né “di sinistra”35, ma certo fa sì che la componente politica si manifesti in modo significativamente orientato. Tutto ciò non può del resto stupire, dato che la filosofia è stata fino ad oggi di fatto relegata in un angolo, perché i suoi tempi (solitamente lunghi), la sua gratuità (che non significa assenza di valore in senso lato “economico”, ma semplicemente posizionamento di quest’ultimo più in basso nella scala dei valori), la sua tendenza a differire l’azione per comprenderne a fondo senso e valore, l’hanno fatta accusare di inutilità. È palese che una tale diffusa valutazione sia meramente funzione della previa assunzione ‐ indiscussa e indiscutibile, giacché chi invece di “produrre” discute, viene appunto accusato di “fare il filosofo” ‐ di un ben preciso pre‐giudizio 34
Il riferimento più classico è Umberto Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano, 1999, ma non si può dimenticare l’opera di Günther Anders, in particolare il suo L’uomo è antiquato, Torino, Bollati Boringhieri, 2003 (ed. or. Die Antiquiertheit der Menschen, München, Beck, 1956 e 1980). 35
Bipartisan sono infatti finora state le principali prese di posizioni critiche nei suoi confronti: per quelle provenienti da destra si legga il mio Il consulente filosofico di quartiere, in “aut aut”, 332, 2006; per quelle provenienti da sinistra, esemplare il già citato libro di Alessandro Dal Lago, Il business del pensiero. 30
Neri Pollastri – Prospettive politiche della pratica filosofica di valore: che il “bene” supremo sia quello materiale, tangibile. Potere (sugli altri uomini, sulla natura, perfino su se stessi), possesso (di denaro, di cose, di persone), in generale appropriazione e consumo personale di “beni esclusivi”36 è quanto la cultura dominante ‐ poggiante sull’antropologia individualista ‐ pone al vertice della piramide valoriale, ma è anche quanto viene propugnato, progettato e difeso dalle principali correnti politiche istituzionali contemporanee. Si spiega così sia perché la filosofia goda di così poco credito e venga tanto marginalizzata, sia perché la sua rinascita come prassi diffusa non possa essere neutrale nei confronti della politica oggi attuata dalla maggior parte degli orientamenti istituzionali. In realtà, la filosofia è fin dalla sua origine fondamentalmente sovversiva: non è un caso che il capostipite riconosciuto di tutti i filosofi, Socrate, sia stato messo a morte da quello Stato al benessere del quale aveva dedicato l’esistenza, così come non è un caso che i pochi filosofi che hanno tentato l’avventura politica (a cominciare da Platone) abbiano avuto ben poca fortuna. La ragione sta nel fatto che l’istituzionalizzazione stessa collide con lo spirito di incessante ricerca critica che caratterizza l’atteggiamento filosofico: il filosofo non si appaga del risultato, pretende sempre di ridiscuterlo, e lo fa da un lato aprendosi verso le posizioni minoritarie e critiche, verso il dissenso, che vede come un’opportunità di ampliamento e approfondimento delle posizioni raggiunte, dall’altro sovvertendo ‐ attraverso l’assegnazione di pari dignità a tutti gli esseri razionali dialoganti ‐ gli ordini gerarchici che caratterizzano ogni istituzione, i quali hanno per obbiettivo la messa a regime di un’organizzazione sociale che favorisca l’ordinato svolgimento delle funzioni. Ma se la pratica filosofica come prassi politica diffusa ha poche possibilità di trovare punti di accordo con la politica così come oggi la intendiamo, ha tuttavia possibilità di recuperare forme di socialità politica praticate in passato e che oggi stanno trovando seppur marginalmente una rinascita laddove la politica viene interpretata non già come delega rappresentativa di potere, bensì come stile di vita consapevole, prassi quotidiana fatta di scelte pensate e condivise, responsabilità diretta delle conseguenze del proprio agire, confronto universale del proprio posto nel mondo con quello che le proprie azioni concedono agli altri uomini che vivono sulla terra37. Questo accostamento potrà forse sorprendere, ma le ragioni di un’affinità sono molteplici. Mi limiterò qui a sottolinearne solo le principali, che sono appunto l’abbandono dell’antropologia individualista a favore di una interindividuale, che vincoli esplicitamente la costruzione della soggettività alla pratica dell’intersoggettività, con conseguente centralità dell’apertura verso l’altro e la sua diversità; la ricerca incessante di un criterio, peraltro irraggiungibile in forma definitiva, di giusto (concetto centrale nella filosofia non solo in ambito etico); conseguentemente, lo spostamento del vertice del sistema di valori dalla fruizione dei beni 36
Riprendo qui da Luigi Lombardi Vallauri, Ordinario di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, la distinzione tra beni esclusivi (quelli cioè il cui possesso e la cui fruizione individuale implica l’impossibilità che altri ne fruiscano, come nel caso di quasi tutti i beni materiali e del potere) e beni non esclusivi (vale a dire i beni spirituali come la cultura, l’amicizia, la bellezza, e una parte di quelli materiali, come la salute del corpo). 37
Per un esempio di questo tipo di pratica politica, rinvio a due bei lavori di Francuccio Gesualdi, Sobrietà, Milano, Feltrinelli, 2004, e Dalla parte sbagliata del mondo (intervista a cura di Lorenzo Guadagnucci), Milano, Terre di Mezzo, 2008. 31
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 esclusivi a quelli non esclusivi; l’assunzione di una radicale responsabilità delle proprie azioni, sulla base di una costante attenzione alla costruzione delle idee personali che le ispirano; infine, la pratica dell’agire dialogico come stile di vita, la quale rimanda in ultima istanza all’idea oggi tanto discussa, assieme all’idea di politica, nell’ambito delle pratiche filosofiche: quella di vita filosofica. È appunto ritornando a questo concetto ancora impreciso e sfuggente, che non a caso, come detto, era il tema dell’ultimo congresso internazionale del movimento delle pratiche filosofiche, che è possibile concludere queste note, affermando in via provvisoria che la vita filosofica sia alla fine null’altro che una vita politica. Ma lo sia nel suo significato più pieno, originario, così com’era intesa nell’Atene di Socrate e Platone: come partecipazione pensata e vissuta di ciascun individuo alla vita collettiva, senza deleghe in bianco e con costante attenzione critica e costruttiva da parte di ciascun uomo alle idee, ai principi etici e alle azioni pratiche che guidano la convivenza civile. Perché la società e lo Stato sono sempre, e non possono non essere, il risultato della collaborazione aperta e attiva, intellettuale e materiale, dei suoi componenti: cioè, ciascuno di noi singoli cittadini. Neri Pollastri Bibliografia 1.
2.
3.
4.
Achenbach Gerd, La consulenza filosofica, Milano, Apogeo, 2004 (ed. or. Philosophiche Praxis, Stuttgart, Dinter, 1983). Achenbach Gerd, Il libro della quiete interiore, Milano, Apogeo, 2005 (ed. or. Das kleine Buch der Inneren Ruhe, Freiburg im Brisgau, Herder, 2000). Achenbach Gerd, Saper vivere, Milano, Apogeo, 2006 (ed. or. Lebenskönnerschaft, Freiburg im Brisgau, Herder, 2001). Anders Günther, L’uomo è antiquato, Torino, Bollati Boringhieri, 2003 (ed. or. Die Antiquiertheit der Menschen, München, Beck, 1956 e 1980). 5.
Berti Enrico, Filosofia pratica, Napoli, Guida, 2004. 6.
Colli Giorgio, La nascita della filosofia, Milano, Adelphi, 2002. 7.
8.
9.
Dal Lago Alessandro, Il business del pensiero, Roma, Manifestolibri, 2007. Ferraro Giuseppe, Filosofia in carcere, Filema, Napoli, 2006 Ferraro Giuseppe, L’innocenza della verità, Filema, Napoli, 2008. 10. Galimberti Umberto, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano, 1999. 11. Gesualdi Francesco, Sobrietà, Milano, Feltrinelli, 2004. 12. Gesualdi Francesco, Dalla parte sbagliata del mondo (intervista a cura di Lorenzo Guadagnucci), Milano, Terre di Mezzo, 2008. 13. Godbout Jacques, Lo spirito del dono, Torino, Bollati Boringhieri, 1993 (ed. or. L'Esprit du don, Paris, La Decouverte, 1992). 32
Neri Pollastri – Prospettive politiche della pratica filosofica 14. Hösle Vittorio, Il compimento della tragedia nell’opera tarda di Sofocle, Napoli, Bibliopolis, 1986. 15. Hösle Vittorio, Moral und Politik, München, Beck, 1997. 16. Lahav Ran, Comprendere la vita, Milano, Apogeo, 2004. 17. Lahav Ran, Contributo per un ripensamento critico della filosofia pratica ‐ Riflessioni, in “Phronesis”, nn. 6‐9 (ed or. c/o www.ranlahav.net). 18. Pollastri Neri, Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, Milano, Apogeo, 2004. 19. Pollastri Neri, Il consulente filosofico di quartiere, in “aut aut”, 332, 2006. 20. Pollastri Neri, Consulente filosofico cercasi, Milano, Apogeo, 2007. 21. Pollastri Neri, Analisi di Alessandro Dal Lago, Il business del pensiero, in “Phronesis – Rivista di filosofia, consulenza e pratiche filosofiche”, 9, 2007. 33
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 34
Prospettive critiche sul consequenzialismo Emiliano Rolle [email protected] Abstract
In this paper I will argue for a distinction between descriptive consequentialism (conceived as a
theory of moral justification and motivation) and normative consequentialism (rational choice
theory and game theory). The revision of some classical and critical arguments against descriptive
consequentialism (Anscombe, Williams, Foot, Davidson) converges into a re-interpretation of the
definition of the value of choice in the normative theories. In my view, this re-interpretation can be
read as the opportunity of abandoning consequentialism as a theory of moral justification and
motivation, and thus losing the appeal it has for us.
Keywords: descriptive consequentialism, normative consequentialism, moral justification, rational
choice theory, game theory, Anscombe, Williams, Foot, Davidson.
Consequenzialismo è un termine coniato da Elizabeth Anscombe nel 1958 e denota generalmente un complesso di teorie che hanno in comune la visione per cui le proprietà normative dipendono solo dalle conseguenze.1 In particolare, le teorie etiche consequenzialiste definiscono la correttezza morale di un’azione solo per mezzo delle conseguenze delle azioni oppure di qualcosa a loro correlato, come un motivo o una legge.2 Mi interessa qui presentare e discutere, sulla base di alcune critiche ormai classiche in ambito analitico, il consequenzialismo inteso come teoria della giustificazione e della motivazione morale, che chiamo consequenzialismo descrittivo, per distinguerlo dall’insieme delle teorie dell’azione razionale (teoria della scelta razionale, teoria dei giochi) che chiamo invece consequenzialismo normativo. Distinguo queste due accezioni di consequenzialismo perché, come sarà chiaro in seguito, la trattazione dei rispettivi limiti ha implicazioni diverse rispetto all’interrogativo: che cos’è il consequenzialsimo.3 La definizione di consequenzialismo descrittivo, secondo Phillip Pettit, deve difendere le seguenti affermazioni: 1
G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, “Philosophy”, XXXIII(124), 1958, p. 12. W. Sinnot‐Armstrong, Consequentialism, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. by AA.VV., http://plato.stanford.edu. 3
La teoria della scelta razionale e la teoria dei giochi, una volta individuati nella preferenza di un agente e nella probabilità del verificarsi degli stati di cose due parametri fondamentali, pretendono di fissare alcune regole che consentano di calcolare matematicamente quale sia, nei casi dilemmatici, l’alternativa migliore per l’agente. Le teorie individuano così otto assiomi fondamentali relativi alla preferenza di un agente razionale. In altre parole, un agente che voglia dirsi compiutamente razionale deve, secondo le teorie, uniformare le proprie preferenze a ognuna di queste otto condizioni. Le prime quattro condizioni sono riconducibili a un unico criterio d’ordine. Date le 2
35
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 I. Tutte le conseguenze di un’opzione, e cioè tutti i mondi che possono risultare dalla scelta di una linea d’azione, hanno un valore che è determinato da certi parametri valutativi. Questo valore non è unico e dipende dal variare del rapporto fra questi parametri. II. Ogni opzione, cioè ogni possibilità che un agente può realizzare oppure non realizzare, ha un valore determinato dai valori delle sue conseguenze. Il valore dell’opzione è quindi una funzione dei valori delle sue conseguenze.4 Per Pettit, il consequenzialismo così articolato è la prospettiva che chiede di onorare e di promuovere il valore che un soggetto ha scelto di adottare.5 Vale a dire che se il soggetto sceglie di seguire una linea di azione ispirata a un certo valore si aspetta che le conseguenze di quell’azione comunque determinino uno stato di cose che corrisponde alla promozione di quel valore per lui, e cioè alle migliori conseguenze secondo il suo giudizio. Il soggetto, cioè, sceglie di abbracciare certi tratti o principi di comportamento, i valori, che lo portano ad agire in maniera spontanea, e quindi non calcolatrice, e questo accade solo perché è la scelta di quei tratti o principi a presupporre la stima delle conseguenze delle azioni a loro ispirate.6 Le teorie, che si propongono di definire che cos’è l’insieme dei valori che il consequenzialsimo difende, vengono usualmente indicate come teorie utilitariste. In questo lavoro non mi occupo di utilitarismo e concentro l’attenzione sull’articolazione e sui limiti del consequenzialismo descrittivo. Comunemente si distinguono due forme di teoria morale consequenzialista: il consequenzialismo dell’atto, che sostiene che le azioni di un individuo sono corrette se e solo se determinano le conseguenze migliori, e il consequenzialismo della regola, che sostiene invece che le azioni di un individuo sono corrette se e solo se sono ispirate a un set di principi la cui accettazione determina a priori le conseguenze migliori per tutte le azioni che ne derivano. Il termine migliore nella definizione di Pettit, ad esempio, diventa: conforme al valore che il soggetto sceglie di promuovere, e il consequenzialismo descrittivo di cui mi occupo in queste pagine è un consequenzialismo della regola.7 Più in generale, possiamo dire che il consequenzialismo dell’atto è una forma di consequenzialismo diretto che afferma che la correttezza di un’azione dipende dalle conseguenze dell’azione stessa, mentre il consequenzialismo della regola è una forma di consequenzialismo indiretto che afferma invece che la correttezza di un’azione dipende dalle conseguenze di un fattore a lei collegato come un motivo oppure una legge o altro.8 Di seguito propongo alcune critiche del consequenzialismo inteso come teoria della giustificazione e della motivazione morale. Tali critiche non pretendono di confutare l’assunto espressioni della relazione di preferenza xPy (x è preferito a y) e della relazione di indifferenza xIy (x è indifferente rispetto a y), questo criterio si esprime così: Se xPy, allora non yPx Se xPy, allora non xIy Se xIy, allora non xPy e inoltre non yPx xPy o yPx o xIy, per due qualsiasi risultati rilevanti x e y. 4
P. Pettit, Consequentialism, in A Companion to Ethics, ed. by P. Singer, Blackwell Publishing, Oxford 2003, p. 232; P. Donatelli, La filosofia morale, Editori Laterza, Roma 2001, pp. 112‐113. 5
P. Pettit, Consequentialism, cit., p. 231. 6
Ivi, pp. 235‐236. 7
P. Pettit, Consequentialism, in Consequentialism, ed. by S. Darwall, Blackwell, Oxford 2003, pp. 95‐107. 8
T. Mulgan, The Demands of Consequentialism, Oxford University Press, Oxford 2001, pp. 3‐24. 36 Emiliano Rolle – Prospettive critiche sul consequenzialismo per cui la filosofia morale non può non considerare in certe circostanze le conseguenze dei corsi o delle regole d’azione: semplicemente si limitano a far notare che è sbagliato credere che la filosofia morale debba in ogni circostanza ridursi esclusivamente a ciò.9 La prima critica sostiene che il consequenzialismo è incapace di stimare il valore morale di un’azione indipendentemente dalle sue conseguenze. Tale critica è formulata da Anscombe e procede argomentando che, se è così, allora qualunque individuo può trovare un buon motivo per non aver calcolato precedentemente le conseguenze cattive di un’azione solo all’apparenza conforme al valore che l’individuo intende promuovere, quando queste conseguenze effettivamente si realizzano. Il filosofo consequenzialista, secondo Anscombe, non vieta moralmente nulla e per prevenire problemi reali si limita a concepire situazioni immaginarie molto improbabili o estreme – come ad esempio la richiesta di scegliere fra far uccidere molti ostaggi da un criminale oppure uccidere in prima persona un ostaggio in cambio della salvezza di tutti gli altri – in cui sembra che voglia strapparci la confessione che potremmo scegliere, anche solo in via ipotetica, un’azione che ci ripugnerebbe scegliere.10 È proprio del consequenzialismo infatti lasciare aperta la questione se una procedura come la condanna giudiziaria di una persona innocente, nell’esempio che fa Anscombe, non possa essere talvolta la procedura moralmente corretta da adottare: e sebbene il consequenzialismo conceda la possibilità di scegliere in via di principio di non applicare mai una tale procedura, ammette però che le conseguenze di certi corsi d’azione dovrebbero, quantomeno, contemplarla.11 Dove l’imbarazzo etico che produce una simile considerazione non sta nemmeno nel suo esito ipotetico – e cioè nel compiere un omicidio oppure nel condannare un innocente – ma piuttosto nella disponibilità a banalizzare attraverso un esercizio di mera logica qualcosa che, vissuto altrimenti in prima persona, non potrebbe che far vacillare la capacità razionale, le convinzioni morali e la lucidità mentale di chiunque vi sia coinvolto. Bernard Williams afferma che è impossibile sostenere che tutto ciò che ha valore lo abbia in virtù delle sue conseguenze e suppone invece che, almeno per il consequenzialismo diretto, gli stati di cose debbano avere un valore intrinseco, ovvero un valore indipendente da ulteriori conseguenze.12 La differenza che passa fra un approccio consequenzialista e un approccio non‐
consequenzialista – sostiene Williams – consiste nel concepire o meno la confrontabilità degli stati di cose. La confrontabilità implica che niente possa essere considerato assolutamente vietato: ciò che comunemente è vietato potrebbe eccezionalmente venir giustificato.13 E quindi, nel ragionamento morale consequenzialista, certi corsi d’azione impensabili – e impensabili perché estranei al nostro temperamento, alle nostre convinzioni e alla nostra storia personale – vengono di fatto pensati, violando a un livello astratto ciò che Williams 9
D.O. Brink, Some Forms and Limits of Consequentialism, in The Oxford Handbook of Ethical Theory, ed. by D. Copp, Oxford University Press, Oxford 2006, pp. 380‐423. 10
G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, cit., pp. 12‐13; B. Williams, Una critica dell’utilitarismo, in Utilitarismo: un confronto, a cura di J.J.C. Smart – B. Williams, trad. it. B. Morcavallo, Bibliopolis, Napoli 1985, pp. 119‐124; R. Gaita, Good and Evil: an Absolute Conception, Macmillan, Basingstoke 1991, pp. 9‐22 e pp. 66‐74. 11
G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, cit., p. 19; B. Williams, Una critica dell’utilitarismo, cit., pp. 117‐118; B. Williams, L’etica e i limiti della filosofia, trad. it. R. Rini, Laterza, Roma‐Bari 1987, p. 93. 12
B. Williams, Una critica dell’utilitarismo, cit., pp. 109‐110. 13
Ivi, pp. 114‐117. 37
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 chiama la nostra integrità. Il punto è che per il consequenzialismo ciò che conta sono le conseguenze delle azioni e non chi le compie. Tanto che la responsabilità di fronte a uno stato di cose, in conseguenza a una determinata azione, non varia sia nel caso in cui siamo noi stessi a compiere l’azione, sia nel caso in cui abbiamo permesso oppure non abbiamo impedito ad altri di compierla (responsabilità negativa).14 Non stupisce cioè che il consequenzialismo consenta di confrontare l’eventualità in cui non si impedisce di far uccidere delle persone con l’eventualità in cui si uccide noi stessi una persona in cambio della salvezza delle altre: e non stupisce perché, secondo la sua ottica, la nostra responsabilità morale in entrambi i casi coincide. Il problema di misurare e quindi di confrontare il valore degli stati di cose ritorna anche nella terza critica al consequenzialismo, sostenuta da Philippa Foot. Foot prende spunto dalle considerazioni di Peter Geach sul valore logico‐grammaticale dei termini buono e cattivo: secondo Geach, infatti, buono e cattivo sono aggettivi usati sempre in funzione attributiva e mai predicativa.15 Quindi l’asserzione ‘X è buono/cattivo’ esplica prima di tutto il punto di vista di chi la formula. Questo vuol dire che il consequenzialismo quando istituisce confronti fra stati di cose deve sempre specificare da quale punto di vista lo fa: uno stato di cose per essere buono, oppure migliore rispetto a un altro stato di cose, è buono o migliore sempre e solo per qualcuno. Il consequenzialismo precisa che i confronti fra stati di cose devono essere considerati da un punto di vista impersonale e, secondo Foot, riuscire a vedere lo stato di cose in cui certe persone stanno bene come uno stato di cose oggettivamente migliore rispetto a un altro in cui le stesse persone stanno invece peggio riguarda una parte essenziale dell’etica.16 Tuttavia, l’apprezzamento degli stati di cose cade sempre all’interno della moralità.17 È per questo – sostiene Foot – che, se confronto l’opzione di salvare poche o molte vite umane con l’opzione di salvare alcune vite umane attraverso la soppressione di altre vite, devo saper riconoscere che si tratta di opzioni moralmente diverse e quindi inconfrontabili: il benessere, secondo lei, non cade fuori dalla moralità ma è un esito particolare di una specifica virtù morale.18 Le critiche fin qui esposte riguardano principalmente la concezione consequenzialista della giustificazione morale, formulata dal primo dei due enunciati di Pettit. È bene ricordare un argomento piuttosto influente che critica la concezione consequenzialista della motivazione morale, formulata dal secondo enunciato. L’argomento in questione si appella al fenomeno dell’akrasia (ακρασια), che in greco vuol dire debolezza della volontà o incontinenza.19 Secondo Davidson, la volontà di un individuo è debole se l’individuo agisce intenzionalmente in maniera contraria al suo miglior giudizio. Vale a dire che gli manca la forza di volontà per fare 14
Ivi, pp. 119‐124. P.T. Geach, Good and Evil, “Analysis”, 17(2), 1956, pp. 33‐42. 16
P. Foot, Utilitarianism and the Virtues, “Mind”, 94(374), 1985, p. 202. 17
Ivi, p. 206. 18
Ivi, p. 207. 19
Aristotele, Etica Nicomachea, trad. it. A. Plebe, Laterza, Bari 1990, pp. 164‐170 e pp. 180‐181. 15
38 Emiliano Rolle – Prospettive critiche sul consequenzialismo ciò che sa, o crede, essere tutto sommato la cosa migliore.20 Davidson formalizza così l’argomento: a) l’agente compie l’azione x intenzionalmente; b) l’agente crede che esista un’altra azione y che potrebbe compiere; c) l’agente giudica tutto sommato le conseguenze dell’azione y migliori delle conseguenze dell’azione x.21 Se prendiamo per buona la definizione di consequenzialismo che è data da Pettit e che chiede di promuovere qualunque valore un soggetto sceglie di adottare, notiamo che è in contraddizione con l’argomento di Davidson.22 E sebbene l’argomento di Davidson costituisca una sorta di paradosso empirico (e non una confutazione), è un fatto che il consequenzialismo come teoria della motivazione morale non è in grado di spiegarlo.23 Resta aperta la questione di qual è la ragione per cui un agente sceglie di fare x, se tutto sommato crede che sarebbe meglio fare y. La risposta di Davidson è che la connessione causale fra ciò che x crede e desidera e ciò che x compie viene interrotta e che la particolarità di questa interruzione, quando accade, è l’incapacità da parte dell’agente di comprendere sé stesso, riconoscendo che dietro il suo comportamento intenzionale c’è qualcosa di sostanzialmente irrazionale.24 Davidson, per spiegare l’akrasia, distingue due livelli di giudizi espressi dalla razionalità pratica: giudizi condizionali (per cui solo un aspetto dell’azione è desiderabile) e giudizi incondizionati (per cui l’azione è desiderabile nel suo insieme). Soltanto i giudizi incondizionati sono giudizi intenzionali.25 E infatti la debolezza della volontà per Davidson si presenta non come un errore dell’azione fondato su un giudizio incondizionato, ma come un errore dell’azione fondato su un giudizio condizionale. Non si tratta cioè di una contraddizione logica fra giudizi o credenze di un attore, ma di una violazione pratica del principio per cui chi agisce lo fa sempre in vista di ciò che giudica essere meglio per lui (che Davidson chiama principio di continenza).26 Le critiche rivolte alle concezioni di giustificazione e di motivazione morale consequenzialiste esposte da Anscombe, Williams, Foot e Davidson trovano riposta nei puntuali raffinamenti della teoria consequenzialista.27 Eppure credo che, nel loro insieme, suscitino un dubbio radicale sulla legittimità e soprattutto sull’opportunità da parte dell’etica di continuare a investire sul consequenzialismo inteso come teoria della giustificazione e della motivazione morale. Prima di esporre il dubbio è forse opportuno tentare di contestualizzare meglio la teoria. 20
D. Davidson, Com’è possibile la debolezza della volontà?, in Azioni ed eventi, trad. it. R. Brigati, Società editrice il Mulino, Bologna 1992, p. 63. 21
Ivi, p. 64. 22
S. Tenenbaum, The Juddgement of a Weak Will, “Philosophy and Phenomenological Research”, 59 (4), 1999, pp. 875‐911; J. Elster, Weakness of Will and the Free‐Rider Problem, “Economics and Philosophy”, 1, 1985, pp. 231‐265; D. Davidson, Paradoxes of Irrationality, cit., p. 295; J.R. Searle, Rationality in Action, MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 2001, pp. 219‐238. 23
D. Davidson, Com’è possibile la debolezza della volontà?, cit., pp. 78‐79. 24
Ivi, pp. 81‐88. 25
Ivi, p. 79‐86. 26
Ivi, p. 86‐88. 27
S. Scheffler, The Rejection of Consequentialism, Oxford University Press, Oxford 1994, pp. 1‐13; D. Sosa, Consequences of Consequentialsim, “Mind”, 102 (405), 1993, pp. 101‐122. 39
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Ho infatti l’impressione che i filosofi del tardo Novecento abbiano concepito il problema morale in maniera parziale, come forse mai è accaduto prima, distinguendo due accezioni di etica, l’etica personale e l’etica pubblica, concentrandosi quasi esclusivamente sulle dinamiche di formazione della seconda.28 D’altronde, interrogarsi pubblicamente sull’eredità dei valori del XX secolo equivale in buona parte a non sottrarsi di fronte all’imperativo di pensare l’impensabile rivolto ai suoi innumerevoli orrori.29 Eric Hobsbawm formula così la richiesta: Il mondo che è sopravvissuto alla fine degli effetti della Rivoluzione d’Ottobre è un mondo le cui istituzioni e i cui presupposti sono stati foggiati dai vincitori del secondo conflitto mondiale. Quanti si trovarono dalla parte degli sconfitti, o erano stati loro alleati, non solo tacquero o furono ridotti al silenzio, ma furono virtualmente espulsi dalla storia scritta e dalla vita intellettuale, se non per essere catalogati nel ruolo del “nemico”, che essi impersonavano nel grande dramma morale, recitato sulla scena mondiale, della lotta del Bene contro il Male.30 Mi sembra importante qui sottolineare che è difficile credere che la filosofia morale non abbia risentito del fatto che il male di cui parla Hobsbawm si sia tradotto, da un certo punto in poi della sua storia, nell’unico obiettivo di annientare un’intera forma di vita perché considerata indegna. La domanda che è stata rivolta da più parti è come è potuto accadere che, allora, questo male abbia trovato un consenso unanime presso un intero popolo, ma soprattutto è come impedire oggi a questo male di accadere di nuovo.31 Ebbene, io credo che lo iato fra etica personale e etica pubblica di gran parte della filosofia morale del Novecento nasca proprio da questa domanda. Il libro di John Rawls A Theory of Justice, che è un libro importante per l’etica novecentesca, costituisce forse il tentativo più sofisticato di risposta.32 Il contrattualismo – che Rawls ripropone sullo scenario filosofico – è un metodo che si prefigge di individuare razionalmente i principi morali che dovrebbero ispirare una comunità politica, appellandosi a una posizione originaria che prescinde dall’effettivo ruolo sociale degli attori coinvolti: nessuno infatti si rende disponibile a dare il proprio assenso a un contratto la cui parzialità potrebbe dover subire in prima persona. Al di là delle considerazioni di carattere tecnico sulla posizione originaria, è chiaro che Rawls spersonalizza l’agente morale con l’obbiettivo di delineare i fondamenti universalmente validi dell’etica pubblica. Questo vuol dire rinunciare preventivamente non solo al compito di definire i lineamenti di una possibile etica personale, ma anche alla necessità di istituire un legame fra i due ambiti della riflessione etica. Con Rawls, infatti, la maggioranza dei filosofi morali del 28
Per etica personale mi riferisco a un ambito che riguarda essenzialmente la condotta, la pratica e la riflessione soggettiva come problemi etici inerenti al soggetto. Penso a B. Williams, L’etica e i limiti della filosofia, cit., pp. 39‐
66 e pp. 241‐244, R. Gaita, Good and Evil: an Absolute Conception, cit., pp. 144‐190 e a L. Handjaras, Immaginare un linguaggio. Ricostruzioni in filosofia analitica, FrancoAngeli, Milano 2001, pp. 173‐174. Per etica pubblica mi riferisco invece a un ambito che riguarda essenzialmente le relazioni, i rapporti e le pratiche inter‐soggettive: un ambito cioè che viene definito da cosa ciascuno di noi deve agli altri. Confronta T. Scanlon, What We Owe to Each Other, cit., pp. 6‐7. Per un’ulteriore chiarificazione dei termini soggettivismo e oggettivismo morale (realismo, intuizionismo, naturalismo): P. Singer (ed. by), A Companion to Ethics, cit., pp. 399‐441 e pp. 451‐463. 29
H. Kahn, Thinking About the Unthinkable in the 1980s, Simon&Shuster, New York 1984, pp. 17‐22; R. Gaita, A Common Humanity. Thinking about Love and Truth and Justice, Routledge, London 2002, pp. 131‐186. 30
E. Hobsbawm, Il secolo breve 1914‐1991, trad. it. B. Lotti, Rizzoli, Milano 2004, p. 16. 31
H. Arendt, La banalità del male, trad. it. di P. Bernardini, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 260‐284. 32
J. Rawls, A Theory of Justice, Clarendon Press, Oxford 1972, pp. 21‐60. 40 Emiliano Rolle – Prospettive critiche sul consequenzialismo Novecento decidono di non occuparsi dell’etica personale per concentrarsi esclusivamente sui meccanismi che regolano l’etica pubblica. Il carattere dominante di questi meccanismi è l’impersonalità, e cioè la ricerca nell’ambito dell’etica pubblica di un criterio, o di un insieme di criteri, universalmente validi che, prescindendo dalle particolarità geografiche culturali e storiche degli individui, consenta loro di scegliere come agire in maniera opportuna.33 I criteri, a cui mi riferisco, fondano la loro validità sulla misurabilità delle conseguenze di una data scelta a prescindere dal fatto che un agente morale recepisca effettivamente quelle conseguenze come un’opzione per lui. E la teoria che giustifica e motiva l’applicazione di questi criteri si chiama, appunto, consequenzialismo.34 Le critiche rivolte alla teoria consequenzialista della giustificazione e della motivazione morale, proposte da Anscombe, Williams, Foot e Davidson, hanno la funzione di ricordarci che il consequenzialismo prescinde dall’ambito dell’etica personale. A rinforzare questa consapevolezza intervengono gli aspetti critici della teoria della scelta razionale e della teoria dei giochi che però, a mio avviso, non vanno a intaccare direttamente la struttura del consequenzialismo descrittivo.35 Piuttosto penso che i modelli normativi delle teorie dell’azione razionale, e i loro limiti, offrano uno spunto originale per denunciare la parzialità dell’ottica consequenzialista. Ritengo pertanto che ripensare il significato e il ruolo delle teorie normative dell’azione sia tutt’uno col prendere per buone le ragioni che ci spingono a criticare il consequenzialismo descrittivo come teoria della giustificazione e della motivazione morale. Sono convinto infatti che i modelli normativi rivestano interesse filosofico nella misura in cui, almeno in etica, si può pensare di prescinderne. È difficile, se non sbagliato, ipotizzare che un agente, per quanto razionale, ogni volta che si trova di fronte a una scelta o a un dilemma morale si metta a calcolare a tavolino il suo comportamento ottimale. È più realistico ipotizzare che sia condizionato dallo stato d’animo o dalle circostanze del momento. Questo non significa che le teorie dell’azione razionale siano inutili o inutilizzabili.36 Anzi, credo che la metafora wittgensteiniana delle prescrizioni teoriche come scale che, una volta utilizzate, 33
J. Harsanyi, Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility, “Journal of Political Economy”, 63, 1955, pp. 309‐321. 34
J. Rawls, A Theory of Justice, cit., pp. 29‐33; T. Scanlon, What We Owe to Each Other, cit., pp. 79‐87 e pp. 186‐223; D. Parfit, What We Could Rationally Will, “The Tanner Lectures on Human Values”, 24, 2002, pp. 287‐369; T. Scanlon, Contrattualismo e Utilitarismo, in Utilitarismo e oltre, a cura di A. Sen – B. Williams, trad. it. di S. Veca, Il Saggiatore, Milano 1984, pp. 133‐164. Il contrattualismo di Rawls, secondo Parfit, è una forma di consequenzialismo della regola. Il principio a cui Rawls fa riferimento sostiene infatti che dobbiamo agire sulla base di principi che sarebbe razionale per tutti scegliere, dal momento che sono principi che accetteremmo se nessuno avesse informazioni su sé stesso o sulla propria condizione. Il contrattualismo di Scanlon invece si appella a una sorta di restrizione anti‐consequenzialista che sostiene che noi non possiamo ragionevolmente rigettare qualche principio sulla base delle considerazioni riguardanti il valore degli esiti delle azioni che ne derivano. Per Scanlon infatti un atto è sbagliato se e solo se non è permesso da qualche principio che nessuno può ragionevolmente rigettare. La ‘ragionevolezza’ a cui si riferisce Scanlon ha un significato morale solo in questo senso: che ci possiamo definire irragionevoli se diamo troppo poco peso, o un peso sbagliato, al benessere o ai giudizi morali di altre persone. 35
E. Rolle, I limiti della teoria della scelta razionale, “Annali del Dipartimento di Filosofia”, XI, Firenze University Press, 2005. 36
C. Taylor, La diversità dei beni, in Utilitarismo e oltre, a cura di A. Sen – B. Williams, trad. it. S. Veca, Il Saggiatore, Milano 1984, p. 166. 41
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 possiamo abbandonare sia illuminante in questo contesto.37 Non si chiede alla teoria della scelta razionale o alla teoria dei giochi di far valere ciò che dicono, ma di far valere ciò che in definitiva mostrano. Non si tratta di seguire pedissequamente delle regole e di computare delle linee d’azione, ma comprendere il significato delle regole e la funzione che svolgono nell’arricchire le nostre capacità di azione e di interazione con gli altri. A ben vedere, non c’è nessun argomento a sostegno della normatività delle teorie che dimostri l’assoluta necessità di correggere o regolare le nostre azioni in base a criteri razionali. Piuttosto, c’è la nostra esperienza quotidiana in mezzo ai problemi della convivenza civile che spesso tendono in modi diversi a estraniarci da noi stessi, e c’è anche la consapevolezza che è sempre meglio avere degli strumenti in grado di proteggerci da quell’estraniamento.38 In questo senso la teoria della scelta razionale e la teoria dei giochi hanno rilevanza per la nostra sensibilità etica: nella misura in cui riconosciamo che il fatto stesso di applicare le regole di un gioco e di giocarlo ci insegna qualcosa di fondamentale su noi stessi, ci aiuta a fare chiarezza sulle persone che siamo o che desideriamo essere, sulle ragioni che ci animano e sui bisogni a cui non dobbiamo o forse non vogliamo nemmeno rinunciare. C’è ancora qualcosa di più profondo che possono insegnarci quelle teorie e che si collega strettamente con ciò che le critiche al consequenzialismo sostengono. E cioè che in quanto esseri umani noi non ci comportiamo – non compiamo delle azioni – sempre e solo in vista di uno scopo. Spesso compiamo delle azioni perché prima di tutto, e letteralmente, non ne possiamo fare a meno. Perché c’è una parte fondamentale di questo nostro essere persone che concretamente e etimologicamente chiede di esprimersi. Non parlo di qualcosa di astratto o di vago, ma di un’unità inscindibile di emozione e ragione, di spirito e corpo, di spontaneità e ricezione. Qualcosa che è in continuo fermento dentro di me e che, come tale, tende a sfuggire alle griglie mentali e a qualunque logica, compresa la massimizzazione di un bene morale, che cerchi di ordinarla.39 La massimizzazione di un bene morale, come mi sembra di intuire, non è un obiettivo che si persegue: è sempre e solo una condizione che si riconosce, se si sa riconoscere, oppure che si ignora. La teoria della scelta razionale e la teoria dei giochi, traslando il piano semantico dell’azione umana dagli obiettivi alle strategie di comportamento, ci ricordano che possiamo esistere non tanto o non solo in vista di uno scopo, ma in vista proprio della conservazione di questa possibilità. E dubitare delle proprie scelte (nei contenuti come nelle conseguenze) per quanto sia una prospettiva poco apprezzata in ambito teorico e troppo generale per una definizione analitica, non è una prospettiva priva di significato o di importanza. La rivendicazione del dubbio sulle proprie scelte riguarda quella parte del mio essere che sfugge all’indagine teorica e che si colloca tra due limiti: la razionalità del comportamento morale da una parte (rivendicare questo dubbio non impedisce, ad esempio, di aver cura del prossimo o delle piante o degli animali, oppure di ricercare dietro a ciò una qualche forma di integrità morale) e 37
L. Wittgenstein, Tractatus Logico‐Philosophicus, trad. it. A.G. Conte, Einaudi, Torino 1995, p. 109, §6.54. Sono debitore di questa linea interpretativa a Simona Morini. 38
A. Sen, Lo sviluppo è libertà, trad. it. G. Rigamonti, Mondatori, Milano 2001, pp. 254‐257; A. Sen, Etica e Economia, trad. it. S. Maddaloni, Editori Laterza, Roma‐Bari 2005, pp. 99‐108; A. Sen, Razionalità e libertà, trad. it. F. Alberti – C. Sandri – L. Zarri, Società Editrice il Mulino, Bologna 2005, 145‐193. 39
B. Williams, Una critica dell’utilitarismo, cit., p. 110. 42 Emiliano Rolle – Prospettive critiche sul consequenzialismo la spontaneità del bisogno dall’altra (rivendicare il dubbio sulle proprie scelte ha come nesso diretto lo scegliere e quindi l’agire spontaneo). Non si tratta semplicemente di riaffermare l’unità del corpo o l’unità della memoria.40 Si tratta di riconoscere un limite soggettivo difficilmente valicabile, che oscilla fra la ricezione e le spontaneità dell’esperienza e che, di fronte a una richiesta di giustificazione, si traduce quasi sempre in una risposta del tipo: le mie azioni diranno chi sono.41 Affermare il dubbio sulle proprie scelte, in questo senso, significa rendersi disponibile a una sorta di sospensione del controllo su sé stesso: riconosciuto, cioè, che non è sempre possibile esprimere i propri comportamenti in termini di ragioni e di conseguenze non resta che affidarsi alla forma di vita (intesa come grado zero di natura e storia) che si è.42 In un certo senso, questo dubbio costituisce il limite dell’indagine teorica, e lo costituisce nella misura in cui richiede, prima ancora che l’assenso verso qualche lessico condiviso, il rispetto incondizionato come prerequisito per la sua stessa comprensione: rispetto, cioè, di qualcosa che è anche un mistero, ma che non pretende di rimanere tale come non pretende di svelarsi. È il rispetto che nasce col ritorno dell’io‐filosofico dai limiti al cuore del suo stesso mondo, con tutta la responsabilità e con tutto il dramma prima dell’accettazione e poi della dissoluzione del solipsismo che questo passaggio comporta.43 È, forse, il 40
D. Parfit, Ragioni e persone, trad. it. R. Rini, Il Saggiatore, Milano 1989, pp. 280‐309. J. Raz, Incommensurability and Agency, cit., p. 125. 42
I. Berlin, Uno dei più arditi innovatori nella storia del pensiero umano, in Il potere delle idee, trad. it. G. Ferrara degli Uberti, Adelphi Edizioni, Milano 2003, pp. 102‐104; J.M. Coetzee, La vita degli animali, trad. it. F. Cavagnoli – G. Arduini, Adelphi Edizioni, Milano 2003, pp. 23‐85; J.M. Coetzee, Elizabeth Costello, trad. it. M. Baiocchi, Einaudi, Torino 2005, pp. 109‐136. Fra il 1997 e il 1998 le Tanner Lectures on Human Values sono tenute dallo scrittore John Coetzee. In quelle conferenze Coetzee, affrontando la questione del rapporto uomo‐animale, parla dei limiti dell’etica e di come in realtà potrebbe essere compito della letteratura oltrepassarli per consentire alla filosofia di starle dietro. Coetzee non argomenta la sua tesi, né tantomeno la espone. Semmai, attraverso un’ingegnosa trovata letteraria, la mostra: mostra che è moralmente importante sebbene rischioso (o forse moralmente importante proprio perché rischioso) che la coscienza umana sappia arrendersi in maniera incondizionata all’esperienza dell’altro. Questa resa Coetzee la chiama empatia. Ebbene, senza avere alcuna pretesa di avventurarmi in un campo così scivoloso per la ragione come l’empatia, mi piace pensare che i limiti del consequenzialismo, pazientemente vagliati durante la stesura di questo lavoro, suggeriscano la serietà dell’argomento. Non credo che empatia possa essere un termine facilmente digerito da parte del pubblico filosofico, però dubbio sulle proprie scelte forse sì. E dubitare delle proprie scelte significa prima di tutto rendersi disponibili a sospendere il controllo su sé stessi, riconoscendo che è questo, talvolta, l’unico modo per comprendere chi siamo e cosa vogliamo. Sospendere il controllo su sé stessi – che ovviamente non è un atto intenzionale e non pretende nemmeno di coprire la totalità dell’agire morale – vuol dire sospendere il controllo sulle proprie azioni, rinunciando a misurarne il vantaggio o lo svantaggio e sapendo che non c’è modo di sollevarsi dalla responsabilità e dalla leggerezza, dalla vergogna e dall’onore, dalla colpa e dalla liberazione che ogni decisione necessariamente comporta. Anzi, sospendere il controllo su sé stessi, moralmente parlando, significa proprio scegliere. 43
L. Wittgenstein, Tractatus Logico‐Philosophicus, cit., pp. 88‐90, §§5.6‐5.641; G.E.M. Anscombe, Introduzione al Tractatus di Wittgenstein, trad. it. E. Mistretta, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma 1966, pp. 152‐159; D. Pears, The Originality of Wittgenstein’s Investigation of Solipsism, “European Journal of Philosophy”, 4, 1996, pp. 124‐136; D. Bell, Solipsism and Subjectivity, “European Journal of Philosophy”, 4, 1996, pp. 155‐174. Affermare che il nesso soggetto‐mondo è reciprocante vuol dire, rigorosamente, riconoscermi allo stesso tempo solo senza possibilità di confronto con gli altri e con gli altri ma senza possibilità di confronto con me. Per una penetrante analisi sul solipsismo di Wittgenstein rimando ai seguenti saggi: M. Rosso, Un brano inedito sul solipsismo del Wittgenstein ‘intermedio’, in Ricerche di filosofia contemporanea, a cura di C. D’Amato – L. Handjaras – A. Marinotti, Libreria Alfani editrice, Firenze 1995, pp. 189‐221; E. Palombi, L’esperienza dell’altro. Osservazioni a proposito di un brano del Wittgenstein ‘intermedio’, in Ricerche di filosofia. Tra ermeneutica e filosofia analitica, a cura di L. Handjaras – A. Marinotti – M. Rosso, Libreria Alfani editrice, Firenze 1996, pp. 377‐426. 41
43
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 consapevole abbandono in filosofia morale del primato della teoria, riconosciuta più umanamente e più intimamente come una possibile esperienza conoscitiva.44 Per concludere, non condivido il punto di vista di chi sostiene che il consequenzialismo debba essere battuto sul piano motivazionale o giustificativo e che per batterlo ci sia bisogno di una teoria morale alternativa e altrettanto convincente.45 Io credo che se è vero, com’è vero, che il consequenzialismo pervade il nostro modo di concepire la giustificazione morale e che ciò talvolta può ostacolare o ridurre la comprensione di quella giustificazione, allora non si richiede uno strappo ma una cura per il suo superamento.46 E la cura che propongo prevede una serie di passaggi consapevoli e graduali, all’insegna della sostituzione del valore delle conseguenze col dubbio sulle proprie scelte. L’obiettivo non è quello di battere il consequenzialismo ma semmai è quello di rendersi conto che è possibile dissolverlo dissolvendo prima di tutto l’interesse e l’approvazione che riscuote in noi stessi. La rivendicazione del dubbio sulle proprie scelte, infatti, non è solo qualcosa a cui appellarsi in modo vago o astratto: è il frutto di una pratica morale quotidiana che porta a riconoscere che fra azioni e ragioni sussiste in ultima analisi una tensione personale e che proprio questo aspetto è di gran lunga più degno di essere accolto e protetto rispetto a qualunque altro nesso logico o causale cerchiamo di sostituirgli. Arrivato a questo punto, non mi aspetto però che il riferimento al dubbio sulle azioni o sulle scelte, peraltro ispirato dai libri del sinologo francese François Jullien e dalle penetranti analisi sul linguaggio di Ludwig Wittgenstein, possa risultare ancora del tutto condivisibile o particolarmente chiaro.47 Lo sviluppo di un simile concetto richiede necessariamente ulteriori indagini. In questo articolo ho cercato semplicemente di mettere in luce alcuni limiti del ragionamento morale consequenzialista. Sono convinto che ciò che rimane da scoprire dell’universo etico contemporaneo non possa essere precluso alla conoscenza filosofica. E tuttavia credo che passerà ancora del tempo prima che la filosofia trovi in sé le ragioni, le risorse o l’umiltà necessarie per realizzare una convergenza di sforzi e trovare strumenti concettuali adeguati a questa impresa. Emiliano Rolle Bibliografia 1.
2.
Anscombe G.E.M., Modern Moral Philosophy, “Philosophy”, XXXIII(124), 1958. Anscombe G.E.M., Introduzione al Tractatus di Wittgenstein, trad. it. E. Mistretta, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Roma 1966. 44
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., pp. 147‐148, §§.350‐351, p. 154, §372, p. 156, §.384. T. Scanlon, Contrattualismo e Utilitarismo, cit., p. 133; P. Foot, Utilitarianism and the Virtues, cit., p. 196. 46
P. Winch, Il concetto di scienza sociale e le sue relazioni con la filosofia, trad. it. M. Mondadori – M. Terni, Il Saggiatore, Milano, 1972, pp. 80‐83. 47
F. Jullien, Nutrire la vita. Senza aspirare alla felicità, trad. it. M. Porro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 10, 21‐31; F. Jullien, Trattato dell’efficacia, trad. it. M. Porro, Einaudi, Torino 1998, pp. 99‐119. 45
44 Emiliano Rolle – Prospettive critiche sul consequenzialismo 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Arendt H., La banalità del male, trad. it. di P. Bernardini, Feltrinelli, Milano 2005 Aristotele, Etica Nicomachea, trad. it. A. Plebe, Laterza, Bari 1990. Bell D., Solipsism and Subjectivity, “European Journal of Philosophy”, 4, 1996. Berlin I., Uno dei più arditi innovatori nella storia del pensiero umano, in Il potere delle idee, trad. it. G. Ferrara degli Uberti, Adelphi Edizioni, Milano 2003. Brink D.O., Some Forms and Limits of Consequentialism, in The Oxford Handbook of Ethical Theory, ed. by D. Copp, Oxford University Press, Oxford 2006. Coetzee J.M., La vita degli animali, trad. it. F. Cavagnoli – G. Arduini, Adelphi Edizioni, Milano 2003. Coetzee J.M., Elizabeth Costello, trad. it. M. Baiocchi, Einaudi, Torino 2005. Davidson D., Com’è possibile la debolezza della volontà?, in Azioni ed eventi, trad. it. R. Brigati, Società editrice il Mulino, Bologna 1992. Donatelli P., La filosofia morale, Editori Laterza, Roma 2001. Elster J., Weakness of Will and the Free‐Rider Problem, “Economics and Philosophy”, 1, 1985, pp. 231‐265. Foot P., Utilitarianism and the Virtues, “Mind”, 94(374), 1985. Gaita R., A Common Humanity. Thinking about Love and Truth and Justice, Routledge, London 2002. Gaita R., Good and Evil: an Absolute Conception, Macmillan, Basingstoke 1991 Geach P.T., Good and Evil, “Analysis”, 17(2), 1956. Handjaras L., Immaginare un linguaggio. Ricostruzioni in filosofia analitica, FrancoAngeli, Milano 2001. Harsanyi J., Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility, “Journal of Political Economy”, 63, 1955. Hobsbawm E., Il secolo breve 1914‐1991, trad. it. B. Lotti, Rizzoli, Milano 2004. Jullien F., Nutrire la vita. Senza aspirare alla felicità, trad. it. M. Porro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006. Jullien F., Trattato dell’efficacia, trad. it. M. Porro, Einaudi, Torino 1998. Kahn H., Thinking About the Unthinkable in the 1980s, Simon&Shuster, New York 1984. Mulgan T., The Demands of Consequentialism, Oxford University Press, Oxford 2001. Palombi E., L’esperienza dell’altro. Osservazioni a proposito di un brano del Wittgenstein ‘intermedio’, in Ricerche di filosofia. Tra ermeneutica e filosofia analitica, a cura di L. Handjaras – A. Marinotti – M. Rosso, Libreria Alfani editrice, Firenze 1996. Parfit D., What We Could Rationally Will, “The Tanner Lectures on Human Values”, 24, 2002. Parfit D., Ragioni e persone, trad. it. R. Rini, Il Saggiatore, Milano 1989. Pears D., The Originality of Wittgenstein’s Investigation of Solipsism, “European Journal of Philosophy”, 4, 1996. Pettit P., Consequentialism, in Consequentialism, ed. by S. Darwall, Blackwell, Oxford 2003. Pettit P., Consequentialism, in A Companion to Ethics, ed. by P. Singer, Blackwell Publishing, Oxford 2003. 45
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Rawls J., A Theory of Justice, Clarendon Press, Oxford 1972. Rolle E., I limiti della teoria della scelta razionale, “Annali del Dipartimento di Filosofia”, XI, Firenze University Press, 2005. Rosso M., Un brano inedito sul solipsismo del Wittgenstein ‘intermedio’, in Ricerche di filosofia contemporanea, a cura di C. D’Amato – L. Handjaras – A. Marinotti, Libreria Alfani editrice, Firenze 1995. Scanlon T., What We Owe to Each Other, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1998. Scanlon T., Contrattualismo e Utilitarismo, in Utilitarismo e oltre, a cura di A. Sen – B. Williams, trad. it. di S. Veca, Il Saggiatore, Milano 1984. Scheffler S., The Rejection of Consequentialism, Oxford University Press, Oxford 1994. Searle J.R., Rationality in Action, MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 2001. Sen A., Lo sviluppo è libertà, trad. it. G. Rigamonti, Mondatori, Milano 2001. Sen A., Etica e Economia, trad. it. S. Maddaloni, Editori Laterza, Roma‐Bari 2005. Sen A., Razionalità e libertà, trad. it. F. Alberti – C. Sandri – L. Zarri, Società Editrice il Mulino, Bologna 2005. Sinnot‐Armstrong W., Consequentialism, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. by AA.VV., http://plato.stanford.edu. Sosa D., Consequences of Consequentialsim, “Mind”, 102 (405), 1993. Taylor C., La diversità dei beni, in Utilitarismo e oltre, a cura di A. Sen – B. Williams, trad. it. S. Veca, Il Saggiatore, Milano 1984. Tenenbaum S., The Juddgement of a Weak Will, “Philosophy and Phenomenological Research”, 59 (4), 1999. Williams B., Una critica dell’utilitarismo, in Utilitarismo: un confronto, a cura di J.J.C. Smart – B. Williams, trad. it. B. Morcavallo, Bibliopolis, Napoli 1985. Williams B., L’etica e i limiti della filosofia, trad. it. R. Rini, Laterza, Roma‐Bari 1987. Winch P., Il concetto di scienza sociale e le sue relazioni con la filosofia, trad. it. M. Mondadori – M. Terni, Il Saggiatore, Milano, 1972. Wittgenstein L., Tractatus Logico‐Philosophicus, trad. it. A.G. Conte, Einaudi, Torino 1995. 46 Affermazione, etica, corpo Laura Beritelli laura.beritelli@humana‐mente.it Abstract
The aim of this paper is to show how ontology of the bodies is also an ethical proposal. I explain
Jean Luc Nancy’s thought on Existence and Freedom (Being, Liberty, Evil and Good) and I reduce
the possibility of appreciating transcendence to things and bodies themselves. I avoid the problem
of poetry, which is discussed directly with the French Philosopher in my interview, published in this
issue of Humana.Mente. As a follow-up to this contribution, in the interview I discuss with Nancy
the ethical possibilities of the bodies themselves in literature, from Pier Paolo Pasolini’s lesson.
Keywords: Jean Luc Nancy, ontology, hermeneutics, freedom, existence, ethics.
Per avvicinarsi in modo semplice e diretto alla portata etica del lavoro compiuto da Jean Luc Nancy sui fondamentali ontologici, è possibile partire tanto dalla celebre figura della Comunità inoperosa quanto dalla concezione dell’Essere singolare‐plurale, come anche dalla critica alla mondializzazione o, perché no, dalla decostruzione della metafisica del soggetto nella semantica lacaniana, perché in ognuno di questi argomenti si presenta forte l’intenzione morale del suo ‘pensiero finito’. Quella di Nancy non è però una Weltanschauung comunitaria, cui approcciare da qualsiasi lato, come fosse un sistema; al contrario, essa è soprattutto la gioiosa disattesa del metodo come metodo e del sistema come sistema: è questa sua ricercata ed erudita liberalità di pensiero, il suo giocare sul limite (delle belle arti, della logica e talvolta della pura emozione) a rendere possibile perdersi nella sua originalità. Se, dunque, vogliamo davvero apprezzare il percorso teoretico che il filosofo compie per giungere a pronunciarsi sull’ethos, credo sia doveroso partire dal discorso sulla libertà1: potremo così dare a questa sua forte impronta etica ‐ che non è mai presentata come ‘una’o come ‘la’ etica ‐ una storia, in base alla quale decidere con maggior cognizione di causa se l’orientamento che la sua filosofia propone abbia o non abbia prospettive interessanti. 1. STORIA DI UN PENSIERO FINITO È attraverso Heidegger che Nancy approda alla possibilità di descrivere il pensiero che pensa la libertà, a partire dallo ‘spazio’ che il filosofo tedesco ha ‘lasciato libero’: si tratta della direzione stessa in cui la prassi ‐ l’agire, che resiste alle categorie di teorico e pratico ‐ deve disporsi per 1
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. 47
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 accedere alla sua specifica spazialità. Secondo Nancy, l’interrogazione sulla libertà si è infatti bloccata al ‘salto’2 che Heidegger descrisse, ovvero sul limitare che guarda ad una diversa modalità di pensiero. Esplorata la fine della metafisica del soggetto, è ora necessario uno sforzo affermativo per risolvere il rebus metafisico di un ‘oltre’ esperito emotivamente, giustificativo del nostro stare e che tuttavia rimane indeterminabile, finché sondato nell’ordine di un linguaggio sistematico della ragione. In una ricognizione che senza soluzione di continuità prende in esame Democrito, gli idealisti, Rousseau ‐ e Kant, Schelling, Hegel ‐ Nancy arriva alla considerazione che i filosofi e le loro filosofie non sono mai giunti oltre l’impossibilità di negare la libertà, avendola sempre ricondotta, pur con diversi toni, all’assoluto avulso, in quanto tale, da ogni possibilità di penetrazione e connotato, comunque, al modo di un soggetto. Il suo è un percorso ermeneutico atto ad emanciparci da questo retaggio, ripartendo dalla filosofia come lo spazio (libero) del pensiero in generale, poiché: La filosofia non è affatto la disciplina fondatrice […] ma è, nel discorso, la piega specifica della libertà, che definisce il logos come accesso alla sua stessa essenza. Filosofia = che il pensiero, nella sua essenza, sia la liberazione dell’esistenza per un mondo e che non ci si possa mai appropriare della libertà di questa liberazione come di un ‘oggetto del pensiero’, ma che la libertà dia piuttosto una piega incancellabile al discorso.3 Nancy si prefigge di raggiungere, attraverso la cessazione della compilazione sistematica e l’abbandono del metodo inteso come tassonomia delle ragioni, il cuore pulsante della libertà, e lo fa piratando all’immaginazione una scena, in cui il pensiero spazia, fa spazio, si apre creando spazi non più limitato dalla logica della necessità dettata da un fondamento, da una causa, da un’essenza. La libertà, come liberazione del pensiero per un mondo, interpreta la materia prima di un ordine di materie (e non di ragioni): c’è l’attività del pensiero, c’è l’inconfutabilità di un pensiero che pensa nel pensiero e che è il pensiero libero. Il pensiero è «l’inscrizione nel linguaggio della libertà che lo articola e fa in modo che il linguaggio non possa mai appropriarsi di sé stesso».4 Ciò che nei secoli è stato chiamato Tutto, Dio, o Amore e, con Heidegger, il ‘trascendens puro e semplice’.5 2. SPARTIZIONE C’è una concezione ontologica che coglie l’esistenza non solo come ‘il suo proprio’ (l’autentico heideggeriano) del soggetto o degli altri, ma di ogni essente, una concezione coestensiva a questa proposta ermeneutica: fin dal primo capitolo de L’esperienza della libertà, Nancy invita infatti ad intendere il legame tra esistenza ed essenza, interno ed esterno, per sé ed in sé, come un chiasmo. Volendo riassumere in breve il modo con cui vi approda Nancy, potremmo dire che, alla fine del secolo scorso e ancora con Heidegger, l’ontologia presentava due possibilità formali – e indiscussamente anche materiali, riguardando esse tutti gli esistenti. La prima possibilità è che l’Essere sia singolare, il che però lo presenta come un’estensione, fatto questo 2
Ivi, pp. 44‐ 45, riportato da M. Heidegger, Il principio di ragione, Adelphi, Milano, 1991. J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo VI, Filosofia: logica della libertà, p. 66. 4
Ivi, Capitolo V, Il pensiero libero della libertà, p. 67. 5
M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, Adelphi, Milano, 2001, p. 49. 3
48
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo che contraddice la singolarità che gli si è attribuita poiché, se l’essere fosse un continuum indistinto, in esso non potrebbe esistere ‘l’ogni volta’ ‐ la struttura dell’intervallo che descrive la spaziatura del tempo e dello spazio: poiché se non c’è che una volta, non c’è alcun ‘una volta’. La seconda possibilità è che nell’Essere non ci sia che la singolarità: ma questo nega il generale e il comune, perché contempla soltanto ‘l’ogni volta questa sola volta’. Dunque da nessuna di queste due possibilità discende quella che Nancy chiama l’identità sostanziale di un ‘io’. Va considerato dunque che, tra una volta e l’altra, l’essere si ritira: «l’Essere non è, e possiede essere solo nella discrezione delle singolarità».6 Nancy pensa dunque ‘l’ogni volta questa volta’ come il ‘battito dell’esistenza’, come ogni volta una nascita al mondo, in cui essa è l’apertura al rapporto con le altre volte. Il Mitsein (con‐essere) dev’essere simultaneo e inscritto nel Dasein (esser‐ci), perché il Dasein consiste nell’esistere ‘ogni volta questa sola volta in quanto mio e non suo, tuo’: esso implica simultaneamente non‐identità. La singolarità, se il singolare del ‘mio’ è anche un plurale, è ciò che avviene in questa duplice alterità, in cui ‘l’ogni volta questa volta’ si differenzia, da un lato istaurando un rapporto ‐ che è il venir meno di un’identità ‐ e dall’altro disponendosi alla comunicazione ‐ che è la perdita di comunione. L’essere in comune non è dato alle singolarità, ma sono esse che com‐paiono ogni volta, in comune dinanzi al venir meno del loro essere in comune, spaziate tra loro dall’infinità di questo venir meno –per certi versi, senza alcun rapporto tra loro, ma perciò stesso gettate nel rapporto. L’esistenza dell’esistente ha luogo in questa spartizione della singolarità, e ogni volta è la libertà ad essere in gioco, poiché la libertà stessa è la posta dell’’ogni volta’.7 L’intrecciare rapporti è coestensivo e contemporaneo alla libertà ed è per questo che è impossibile postulare la libertà come autonomia, ovvero considerare gli uomini come unità indipendenti, padroni di sé e delle loro scelte, laddove non potrebbero esercitare questa libertà se non fossero ‘da prima’ nel mondo e nel rapporto. Questa tesi, esposta tanto ne L’esperienza della libertà, quanto ne La comunità inoperosa ed in Essere singolare plurale, è in qualche modo la risposta di Nancy all’ontologia heideggeriana; l’essere‐in‐comune è posto in primo piano per poter definire la separazione delle singolarità con modalità che non richiamino in causa necessariamente il processo di individuazione di un soggetto e che esca, eo facto, non solo dalla metafisica ma anche, ad esempio, dal solipsismo8: come vedremo, si tenterà di comprendere il fenomeno della singolarità come la postura stessa del corpo nel mondo, a partire (e a finire) nella fatticità della sua esistenza come singolare plurale. La libertà, in tutto questo, si colloca ora con maggior evidenza al cuore dell’essere stesso, come libertà del ritirarsi dell’essere e come il nulla che essa stessa è, cosicché Nancy possa scrivere: «[…] la libertà non è, ma libera l’essere e libera dall’essere, il che può essere trascritto nel modo che segue: la libertà ritira l’essere e dona il rapporto»9. 6
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo VII, Spartizione della libertà, p. 70. J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo VII, Spartizione della libertà, p. 70‐71. 8
Pur nella solitudine totale dell’esistente spartito, l’ipseità del solipsismo è dunque ‘soltanto’ spartizione, il venir meno dell’aseità dell’essere (che è ciò che è solo fuori di sé). Infatti, «[…] l’essere del suo “sé” è quel che rimane “sé” quando nulla torna in sé », Ivi, p. 73. Il dato nel solipsismo non è più lo scacco di una soggettività chiusa in sé, ma l’ipseità posta dal ritirarsi dell’essere, come venir meno dell’aseità dell’essere: è, quindi, liberazione per un mondo. 9
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo VII, Spartizione della libertà, p. 71. 7
49
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Se è la libertà a creare il gioco della discrezione in cui ‘l’ogni volta’ ha luogo, poiché è la libertà che si ritira, essa precede la singolarità stessa, ma senza fondarla né contenerla. La pre‐cedenza è attribuita qui alla libertà nel senso in cui essa è la libertà dell’essere che ‘cede’ all’esistenza, ritirandosi. La singolarità, di conseguenza, non proviene ‐ non procede ‐ ma ‘accade’. Ciò che è altro da me non può più essere concepito come il riferimento con cui prendere le misure per la mia libertà finita: sparisce anche la contrapposizione interno‐esterno, in funzione della quale gli altri esistenti limitano il mio proprio incedere, definendo così lo spazio libero entro cui posso muovermi Questo non vuol dire che la mia libertà si misuri in rapporto a quella degli altri […]. Ma significa invece che la libertà è rapporto, o che la libertà è nel rapporto o come rapporto: essa è, o produce, il passo singolare della mia esistenza nello spazio libero dell’esistenza, il passo della comparizione che è la nostra comparizione. 10 Tra le singole esistenze spaziate non c’è qualcosa che non sia la spartizione stessa, non c’è tessuto, estensione, quale vorrebbe un’ontologia leibniziana: non c’è 'essere' ‐ come fosse una 'cosa'‐ tra gli esistenti, l’essere è solo nella forma dell’esistenza, in quanto spartito tra e negli esistenti: «Così, ciò che ci spartiamo è quel che ci spartisce: il ritirarsi dell’essere, che è il ritirarsi della proprietà di sé, o l’apertura dell’esistenza come esistenza». 11 I corpi, invero, secondo questa ontologia, che l’autore stesso definisce ‘materialismo del presente’, vanno a costituire il composto organico con cui si solleva e differenzia la mia singolarità: la materia, la carne stessa di cui è fatto il rapporto che è la mia esistenza. A questo proposito Nancy cita Merleau‐Ponty12, ricordando come anche questi, nell’opera postuma Il visibile e l’invisibile13, e per l’appunto nelle note di lavoro volte ad una rielaborazione del problema dell’ontologia, scrivesse «Si tratta di creare un nuovo tipo di intelligibilità (intelligibilità in virtù del mondo e dell’Essere così come sono, ‐ verticale e non orizzontale)»14, proponendo quella stessa filosofia del contatto15 a cui il pensiero di Nancy è stato ricondotto: «La polpa del sensibile, il suo indefinibile, non è altro che l’unione, in esso, dell’ “interno” e dell’”esterno”, il contatto in spessore di sé con sé – L’assoluto del “sensibile” è questa esplosione stabilizzata interno esterno comportante ritorno.» 16; e come, attraverso un ripensamento del visibile e dell’invisibile: «Se si parte dal visibile e dalla visione, dal sensibile e dal sentire, si ottiene un’idea completamente nuova della “soggettività”: non ci sono più “sintesi”, c’è un contatto con l’essere attraverso le sue modulazioni, o i suoi rilievi»17 avesse sostenuto per primo la possibilità di cogliere l’altro a partire dalla libertà e non come una libertà altra, che può limitare o definire i contorni della mia. Infatti, concludeva Merleau‐Ponty: 10
Ibidem. Ivi, p. 72. 12
Maurice Merleau‐Ponty (Rochefort‐sur‐Mer, 1908 ‐ Parigi, 1961), nei suoi ultimi scritti, pubblicati postumi, cercò di pensare una nuova ontologia. 13
M. Merleau‐Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano, 1969. 14
Ivi, p. 302. 15
Derrida, Le Toucher, Galilée, Paris, 2000. 16
M. Merleau‐Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano, 1969, p. 301 ‐2. 17
Ivi, p. 303. 11
50
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo L’altro non è più tanto una libertà vista dall’esterno, come destino e fatalità, un soggetto rivale di un soggetto, ma è preso nel circuito che lo collega al mondo, come noi stessi, e con ciò anche nel circuito che lo collega a noi – E questo mondo ci è comune, è intermondo ‐ E c’è un transitivismo per generalità – E anche la libertà ha la sua generalità, è compresa come generalità: attività non è il contrario di passività. 18
[…] L’altro è un rilievo come lo sono io, non esistenza verticale assoluta. L’esistenza degli altri è cooriginaria alla mia e certamente ciò comporta che «un’esistenza diversa insista nella mia identità»19; ma, se il rapporto è donato dalla e alla libertà ed esso è anche rapporto a me, allora ‘io’ sono libero non solo in virtù del rapporto con altri ma, coestensivamente, anche in virtù del rapporto con me stesso. Nancy dunque non solo recupera, ma prosegue le ricerche di Merleau‐Ponty sulla necessità di concepire una dimensione terza che spieghi tutti i fenomeni, soprattutto la trascendenza che esistiamo ed attraverso cui siamo aperti a ciò che ci oltrepassa. La singolarità, dunque, istituisce la mia identità destituendola come ‘questa’ e rendendo «[…] l'esistenza discreta e insistente degli altri qualcosa di originario per la mia stessa esistenza.».20 Poichè non coincide più con l’individualità (perché non è la risultante di un processo di riconoscimento di una soggettività), pensare la singolarità comporta reinterpretare la presenza, come presenza a me stesso, la quale mi definisce e, al contempo, condiziona ogni presenza estranea: la singolarità è la de‐presentazione che mi getta fuori di me. ‘Materialismo del presente’ significa qui opporre il fatto della libertà come posizionamento dell’esistente a qualsivoglia ‘processo’ di identificazione di una soggettività, a partire dalla negazione o dalla messa in questione dell’altro in sé o da sé: di contro alla dialettica e all’ex‐
statica, la libertà, come logos della partizione ontologica, indica solo posizionamento ed esposizione, poiché «incarna la logica dell’accesso a sé fuori di sé, in una spaziatura ogni volta singolare dell’essere.»21 Ciò che spazia lo spazio logico della spartizione non lo colma né lo ingloba: lo libera, lasciandolo essere spazio e spartizione. La libertà è ancora la regola dell’esistenza: se l’esistenza ha il suo più proprio nell’essere‐fuori‐di‐sé; se il proprio dell’esistenza è il trascendere e, trascendendo, esistere, allora solo fuori‐di‐sé essa è quel che è. L’essenza dell’esistenza coincide con l’esistenza stessa, poiché la si può ‘e‐scrivere’ solo a partire da ciò che è: essa è, pertanto, essenzialmente in‐essenziale, essendo essenzialmente l’esser‐fuori‐di‐sé. 3. POSTULATI Uguaglianza Qui si tratta di confrontarsi ‐ se l’altro e l’identità non possono comparire come misura l’uno dell’altro ‐ con la im‐possibilità di una misura umana, con la dismisura della libertà. La libertà, per Nancy, è infatti la dismisura comune che funge da misura dell’esistenza. In questo senso 18
Ibidem. J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo VII, Spartizione della libertà, p. 72. 20
Ivi, p. 71. 21
Ibidem. 19
51
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 essa è direttamente uguale all’uguaglianza22 e, transitivamente, anche questa è incommensurabile (da qui la necessità di una misura tecnica che permetta l’accesso a questa incommensurabilità). Un simile postulato non solo disconosce la tradizionale contrapposizione tra libertà e uguaglianza, finora incompatibili principi dei due diversi sistemi liberale ed egualitario; esso registra la crisi della misura stessa dell’individuazione, il ‘ciascuno’. L’equazione libertà=uguaglianza aggira ancora una volta l’idea arbitrale di una libertà intesa come la possibilità di esercitare senza limiti la propria volontà, poiché ciò entra in aperto conflitto con l’impossibilità di definire un diritto simile per le singolarità che spartiscono l’individuo stesso e nelle quali l’individuo esiste. I ‘ciascuno’ sono infatti intesi ora come serie, intrecci di ogni volta singolari, piuttosto che come unità indivise che condividono una pluralità sintetica.23 La comunità si spartisce la dismisura della libertà come uguaglianza spartita tra questi 'ciascuno'. La libertà è, sì, incommensurabile, ma nel senso in cui essa si misura: «dal trascendere in nulla e ‘per nulla’ dell’esistenza. La libertà: misurarsi col nulla».24 Questo 'misurarsi col nulla' non ha più l’accezione sacrificale che Nancy ha contestato ai suoi autori di riferimento (da Nietzsche ad Heidegger fino al suo Bataille)25. Non significa cioè «affrontare eroicamente la pienezza del nulla» dato che, ironizza, «l'abisso si richiuderebbe dopo averci inghiottiti»26. Piuttosto, misurarsi col nulla deve essere inteso come il prendere le misure del fatto stesso dell’esistenza, cosa non meno eroica, anche se certamente meno epica. Come misura si deve guardare ora alla dismisura che inerisce al fatto dell’essere‐in‐comune. Fraternità Come esiste un orizzonte complessivo dal quale contemplare la comunità, esiste anche la possibilità di attribuire una parentela diversa con l’Essere ai ‘ciascuno’ spartiti. Ontologicamente postulata dall’uguaglianza davanti alla dismisura, questa fratellanza viene affrescata da Nancy richiamandosi ad una delle più acute intuizioni di Freud, ovvero come la condizione d’essere di coloro che divennero fratelli condividendo il corpo smembrato del Padre in‐umano: parricidi tutti ‐ e perciò atavicamente responsabili ‐, ma anche involontari protagonisti, piuttosto che autori, della scena mitica e prelinguistica in cui avvenne la perdita della sostanza comune, essi condividono la ferita insanabile dell’abbandono al mondo, alle proprie costitutive libertà e uguaglianza.27 Il senso di afonia trasmesso da questa scena archetipale richiama al contempo un’altra riflessione della tradizione francese contemporanea, ovvero quella di Lévinas. Nancy può infatti concedersi l’uso di una simile suggestione a coprire un passaggio teoretico, perché il nesso tra spartizione e favola arcifondativa è già stato colto da 22
Ivi, p. 74 Ibidem. 24
Ibidem. 25
Il confronto con Bataille è piuttosto sui temi della comunità, a cui questa discussione fa da necessaria premessa. 26
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo VII, Spartizione della libertà, p. 75. 27
Parlando di Totem e tabù, Freud scriveva: “Ho cercato di dimostrare che i destini di quest’orda hanno lasciato tracce indistruttibili nella storia ereditaria del genere umano, soprattutto che lo sviluppo del totemismo, il quale include in sé gli indizi della religione, della moralità e dell’articolazione sociale, va riallacciata all’uccisione violenta del capo supremo e alla trasformazione dell’orda paterna in una comunità di fratelli.” Sigmund Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Borlinghieri, Torino, 1971. Capitolo III, Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), La massa e l’orda primordiale, p. 120. 23
52
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo Lévinas ed elaborato nelle sue sovradeterminazioni ontologiche (della parola talmudica). Il tempo di quei fatti, o del mito, è il “già‐detto in cui si tiene il dato nel suo tema” ed è lo stesso della novella religiosa: è quello che precede le lingue parlate e che Lévinas attribuisce all’an‐
archia, al passato che, pur essendo stato, è irriducibile alla presenza. È l’afonia senza storia della 'persecuzione', in cui il soggetto, toccato senza mediazione del logos, pur portatore della vera fraternità, è incapace di difendersi con il linguaggio dall’accusa di libertà che gli è rivolta e che è, invece, inconfessabile innocenza. Il lavoro compiuto da Lévinas per dire l’esposizione al suo celebre ‘altrimenti che essere’ è superato da Nancy nell’assenza di un soggetto metafisico; tuttavia, quella trama ontologica, che voleva restituire la struttura ultima del reale come etica, è congruente e contigua alla co‐esistenza pensata da Nancy; anche in essa, infatti, la misura comune veniva elargita come e nella prossimità, nell’enunciazione di un noi anteriore all'io. Dunque «Descartes può dire ego sum solo perché può affermare che tutti noi sappiamo che ciascuno di noi esiste. […] per cui si potrebbe anche dire; “si” sa che si esiste ed è così che noi esistiamo, spartendoci la possibilità che, ogni volta, io lo dica». 28 Si può dire che la fraternità, attraverso la cui figura Nancy dice la necessità e la priorità emotiva del noi, è diretta filiazione del tentativo di pensare quello che Lévinas chiamò la non‐
indifferenza in questa differenza e che però lesse ancora nei termini di una soggettività, per quanto irriducibile all’esperienza del soggetto che la fa accadere. Attraverso Freud, il tempo dell’epos è citato nella funzionalità di un rimando che altrimenti si aprirebbe sulle complesse e diverse architetture inventate per pensare l’Essere, ormai troppo distanti ‐ e talune, come quella posta dall’opera di Lévinas, anche in sé problematiche. Tuttavia anche in Freud risuona l’unicità del passivo come risposta al trauma: il tema della separazione, della vulnerabilità, della susceptio pre‐originaria, che in Lévinas è tanto la passività del dire anteriore e immemorabile del trascendente del soggetto separato, quanto riflessione, pensiero: conatus inesauribile alla prossimità. Comunità Se io non possiedo ‐ e non posso presentarmi come ‐ il mio proprio fondamento; se è solo attraverso l’esperienza comune della nascita e della morte altrui che mi si presenta questa impossibilità, che è anche quella, teoretica, di attribuire una pre‐cedenza alla singolarità; allora è nell’esperienza (comune) dell’esposizione che la comunità si fonda, condividendo l’abbandono alla pluralità di sensi di un mondo, il cui senso coincide con l’essere stato affidato a sé stesso. La comunità coincide con la separazione originaria, perché la comune esposizione che siamo non è altro che l’esito coevo e coestensivo (a libertà, giustizia e fraternità) del ritirarsi essenziale della presenza inafferrabile e inappropriabile che è libertà, il nihil che, ritirandosi, ci spazia e che, così facendo – allontanandoci ‐, ci accomuna. Il pensiero oggi affronta il lutto fecondo di questa perdita originaria (che sia la scomparsa degli déi o l’uccisione del padre): la separazione dall’insieme è l’esposizione che ci accomuna e rende fratelli. Per questo stesso motivo, la comunità si fonda anche in virtù della resistenza che fa 28
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo VII, Spartizione della libertà, p. 75. 53
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 all’appropriazione illegittima «da parte di un’essenza collettiva o individuale»29 della sua spartizione o ‘in‐fondazione’. La decisione d’esistenza, che si rinnova di volta in volta e che nello spazio politico incessantemente tenta di misurarsi con l’incommensurabile, risponde ad un’etica originaria ‐ una praxis: resistere a qualsiasi forma di sostanzializzazione o ipostatizzazione della ‘com‐parizione’ che siamo. Il ‘noi’ si fonda dunque anche nella salvaguardia della nostra essenziale im‐proprietà, che è la nostra in‐essenziale esposizione come esistenza singolare plurale. 4. IL BENE E IL MALE. PROLEGOMENI AD UN’ETICA AFFERMATIVA Per secoli la questione principe della metafisica della libertà è stata quella del bene e del male; dalla perentorietà con la quale Nancy scrive: «Il male è l’odio dell’esistenza in quanto tale»,30 si desume quanto il pensiero affermativo e post‐decostruzionista di cui si fa voce abbia la forza di superare ogni possibile arabesco logico la moderna teodicea (o logodicea) possa aver impiegato per affrontare il problema. Tendendo il filo della sua ricognizione ermeneutica dal pensiero moderno ad Auschwitz, Nancy spiega come, al di là e al di qua della spartizione, il male sia la libertà che si scatena contro sé stessa, la furia hegeliana, l’approfondirsi del fondamento dello Schelling heideggeriano. Il bene è invece la libertà per l’esistenza, l’autentica decisione che, nella sua neutralità, nella sua impossibilità di presentarsi a sé stessa e rappresentarsi alla singolarità coincide con la generosità e la generatività del dono. La trattazione è spinosa poiché, se l’esperienza della libertà è ciò che fa spazio all’esistenza, essa sarà anche ciò che ne concreta la più incomprensibile negazione: dunque il male dev’essere necessariamente pensato come ‘qualcosa’ e come qualcosa di inscritto al cuore della libertà. Il pensiero deve sforzarsi di pensare la storia e, con essa, «il paradosso di una tradizione di libertà in seno alla quale è stata, nel modo più atroce e sistematico, negata l’esistenza (i crimini del nazismo e del comunismo, le guerre, i genocidi che hanno macchiato quest’ultimo secolo) ed il proliferare endemico della violenza sotto ogni forma di sfruttamento, abbandono e tortura.»31 La positività del male merita dunque d’essere affrontata alla luce della lezione del sapere moderno, che Nancy riassume nei seguenti punti: 1) il nostro non è più il tempo della teodicea o logodicea: il male va pensato come qualcosa di intrinsecamente ingiustificabile; 2) non è più il tempo di pensare il male come difetto o perversione di un qualsiasi essente, ma come qualcosa di inscritto nell’essere dell’esistenza: il male è una malvagità positiva; 3) il male si è incarnato concretamente nell’orrore dello sterminio e del carnaio; è qualcosa di insostenibile e imperdonabile.32 D’altro canto, oltre agli accadimenti storici, dell’esistenza del male e della sua positività ci parla anche l’attrazione che ne subiamo: è ciò a cui, in letteratura, hanno dato voce i più diversi 29
Ibidem. J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XII, Il male. La decisione, p. 133. 31
E che Nancy connota come: “accanimento, scannamento e carnaio.”, Ivi, p 127. Queste riflessioni sono contenute nella nota n° 6 del paragrafo in questione. 32
Ivi, p. 127. 30
54
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo autori, da Sade a Bataille, da Kafka a Poe e che, mercificata, anima oggi la circolazione dei più disparati prodotti, dai film dell’orrore agli snuff‐movie33: è la fascinazione del male, «L’odio della libertà per sé stessa, strana vertigine e minaccia opprimente».34 Anch’essa affonda le proprie radici nell’esistenza di un male che è determinazione per il male35 ed «[…] è il fascino dell’esasperazione furiosa del proprio […] è il profitto o il godimento di essersi appropriati financo della appropriazione. Il male è la sopra‐venienza riappropriata […] la singolarità identificata, è il rapporto proiettato nella massa –e la massa, nel carnaio.»36 La malvagità è un aspetto del rapporto della libertà a sé, dovuto al fatto che, come sostenne Heidegger, essa cela in sé la provenienza essenziale dell’annientare: è la libera devastazione che lascia in preda alla devastazione e che, con questo movimento, che è lo stesso nullificarsi, intensificarsi e approfondirsi di un niente che essenzialmente si separa da sé stesso, non desidera né preservare né mediare la propria libertà, quanto inseguire infinitamente la possibilità del distacco infinito che la definisce. Nancy scrive che «la malvagità non ha in odio questa o quella singolarità: ha in odio la singolarità in quanto tale, e il rapporto singolare tra le singolarità. Ha in odio la libertà, l’uguaglianza, la fraternità: ha in odio la spartizione».37 Se il male, infine, è l’odio che si scatena al cuore della libertà contro ciò che essa fa esistere, allora quest’odio odia anche i ‘sé’ singolari in cui essa s’incarna; ma ciò significa che il male rappresenta la possibilità più propria per l’esistente, ovvero la decisione di non lasciare che l’essere si ritiri nell’esistenzialità dell’esistenza: il male è il rifiuto dell’esistenza stessa: «ed ecco allora l’ingiustificabile, l’intollerabile: là dove la libertà si annulla, là dove il suo scatenamento la devasta, là dove la propria incandescenza la divora».38 5. LA DECISIONE Per superare la rassegnazione delle filosofie ad identificare la libertà finita, per il bene o per il male, con il potere di una soggettività di accettare il corso delle cose,39 Nancy pensa sia necessario «un passo avanti per dire che: la risposta, in questo caso, risiede nella decisone.»40 Prima ancora del bene e del male, possiamo infatti pensare il piano dello s‐catenamento stesso, 33
Lo snuff‐movie è un filmato distribuito illegalmente in cui l’attore è vittima di un reato reale e, per antonomasia, del suo stesso omicidio. Questa oscenità, che citiamo perché è lo stesso autore a ricorrervi, è la frontiera di ciò che solo il pudore letterario può chiamare ‘fascinazione del male’. Ma Nancy spiega che la specificità di questo genere di esempi chiarisce la positività del male, la sua ingiustificabilità, insostenibilità e imperdonabilità. Ibidem, nota n° 7. 34
Ivi, p. 131. 35
E contesta l’idea di un male relativo pensato solo in contrapposizione al bene – che comunque implicherebbe l’esistenza di un male assoluto come determinazione per il male: ciò che, per l’Occidente, è stato Satana. Il fatto che male e bene siano relativi l’uno all’altro, infatti, non significa che il male vada pensato come qualcosa che non è bene e che, ammesso, lo lascerebbe indenne; è solo il male assoluto ‐dove c’è male, non c’è bene‐ che attesta il bene come ciò che non possiede positività. Il male non è dunque la privazione del bene, ma la sua devastazione. 36
Ivi, p. 134. 37
Ivi, p. 133. 38
Ibidem. 39
Ovvero oltre alla libertà come necessità. L’autore vuole superare anche il modello d’intesa libertaria proposto dal pensiero del male che, in fatto di libertà, non sembra dare soluzioni diverse: si tratta di celebrare la stessa incapacità del soggetto di essere essenza piuttosto che esistenza. 40
Ivi, p. 140. 55
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 in cui esso si conosce come malvagità o liberazione. Su questo terreno, la decisione per il bene o per il male non è riducibile alla sola deliberazione di una soggettività per il suo bene, poiché: […] il “concetto” della decisione rinvia allora a una decisione effettivamente presa dal pensiero stesso. Il pensiero dell’esistenza non può pensare la libera decisione senza risultare, di fatto, deciso per l’esistenza, invece che per la sua devastazione – e questo non in virtù di una scelta o di una preferenza morale preliminari allo svolgimento del pensiero, ma nell’atto stesso del pensare, affermato sul limite del 41
pensiero esistente. Il fatto del pensiero che agisce conferma una decisione già presa per l’esistenza, essendo l’esistenzialità stessa a richiamare l’esistente alla mancanza originaria, a quell’essenziale non‐
appartenersi del Dasein, al suo ‘non‐essere esistendo’, che costituisce la sua radicale estraneità, o im‐proprietà, e che è il proprio dell’essere‐abbandonato. Il pensiero (praxis) rinnova allora una decisione già da sempre presa, la decisione per l’esistenza, per la liberazione. Il Dasein scopre allora di aver già da sempre compiuto l’atto cattivo, poiché è in difetto, in debito con la generosità dell’essere. In questo svelamento si chiarisce che il suo ‘essere‐
malvagio’ è proprio il suo ‘essere‐in‐debito’. L’esperienza di ogni coscienza inizierebbe con questo essere‐in‐debito, quando la coscienza accusa di malvagità il Dasein, additando in realtà la colpa originaria di non‐essere propriamente il proprio essere. L’esistente è colpevole e conosce il male, perché non è innocente: esso incarna, con la sua singolarità, la libertà di decidersi per il bene e per il male, la possibilità esistenziale della decisione. La lettura volgare (psicologica o ‘morale’) della ‘cattiva coscienza’ come indecisione ‐ di non aver abbracciato propriamente e assolutamente il proprio mondo, di non essersi liberato – sposa questa ontologia, che dice con maggior chiarezza l’indecibilità per il bene o per il male come un non‐
decidersi per l’essere‐esistente di un’esistenza. La cattiva coscienza corrisponderebbe quindi all’indecidibilità ontologica del bene e del male morali, anche se il pensiero dell’essere basa tale conclusione sopra un’arci‐decisione dell’esistente, il quale conosce il male non perché abbia già fatto una scelta quanto piuttosto perché è in debito e deve decidere. L’ontologia dunque non può dire di che cosa il singolo esistente debba decidere, se non al prezzo di fraintendere il fenomeno originario dell’esistenza: la decisione si risolve tra uno stato di decisione e uno stato di non‐decisione. Ciò che preme domandare è se il pensiero non si sia già deciso «[…] a partire dalla comprensione dell’essere‐proprio dell’esistente come esistenza decisa, per la decisione che decide a favore dell’esistenza, e non per quella che decide di restare in debito d’esistenza e di appropriarsi dunque di sé stessa sotto forma di un’essenza situata fuori dall’esistenza? »42 Per Nancy la decisione che si rinnova ogni volta è sempre quella di una singolarità per la singolarità, per la libertà: la singolarità decisa si decide emancipandosi dalla non‐innocenza della libertà per la decisione, senza per questo divenire innocente, ma entrando, ex‐istendo, 41
Ivi, p. 142. Ivi, p. 145. L’intero discorso è costellato da questo tipo di suggerimento. Ad esempio, “Il pensiero non si è già deciso, a partire dalla comprensione della non‐innocenza della libertà, per la decisione e per la sua fatticità singolare? “, Ivi, p. 141; e prima: “[…] ma come potremmo così non aver già deciso, infinitamente già deciso, rispetto a ciò che è bene e ciò che è male?” Ivi, p. 143. 42
56
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo nella decidibilità diversa che caratterizza il suo percorso d’esistenza nel rapporto tra le singolarità e tra le decisioni. Tuttavia, è l’indecibilità che rende necessaria la decisione che decide per la decisione stessa, ovvero per il bene di mantenersi aperto ogni volta alla decisione, accettando lo stato d’indecisione; o per il male di una decisione che decide di sopprimere la decisione. Questa conclusione salva la possibilità di parlare di trascendenza, reinterpretando il vocabolario della filosofia dell’essere come quello stesso della finitezza: infatti la singolarità che decide per la spartizione (e quindi per il rapporto) conserva l’essere ritirato, come ritratto; ed espone la finitezza che essa stessa è, come carattere primo dell’esistenza: la limitazione. La singolarità, come limite, impedisce l’infinita concentrazione di sé di un Essere che è s‐catenamento, egoità che s’approfondisce, furia. In conclusione, l’ontologia non ci consegna una morale, ma afferma che l’esistenza di una decisione autentica implica l’esistenza di un fondamento etico. E se l’ontologia non può insegnarci «cosa significhi, e in che modo, e quando, “rispettare gli altri” o “rispettare sé stessi” o “considerare l’uomo come un fine”, o volere l’uguaglianza, la fraternità e la giustizia della comunità umana»,43 poiché essa cerca una determinazione arci‐originaria dell’etica come prassi, che «non si tratta di una legge o di un valore ultimo ma di qualcosa grazie a cui possiamo stabilire un rapporto con la legge e col valore: la decisione, la libertà»,44 tuttavia, attraverso questo percorso, essa ha riconosciuto nella decisione il momento vuoto, l’ethos al fondo di ogni etica. 6. SITUAZIONE, SPAZIO, AREALITÀ Il passaggio che dalla decisione porta allo spazio in cui la singolarità è messa in gioco è infine compiuto richiamandosi direttamente all’analisi della ‘situazione’ contenuta in Essere e tempo: la situazione incarna la località del –Ci, lo stato in cui si trova ad essere45, il che significa che la decisione è essenzialmente ‘aprente’, spaziando essa lo spazio ed il tempo dell’esistenza.46 Con una citazione specifica dal filosofo tedesco47, Nancy vuole valorizzare il carattere preminentemente spaziale dell’esposizione, da un lato attualizzando nella singolarità un aspetto esistenziale proprio del Dasein heideggeriano, dall’altro legittimando teoreticamente l’indirizzo ‘spaziale’ proposto dalla filosofia francese48: il passaggio da Essere e tempo è obbligatorio in questa sede, proprio perché, come dirà l’autore riguardo al suo testo Essere singolare plurale, non è sufficiente dire che il modello spaziale ha sostituito quello temporale.49 Dunque, solo perché è stato esposto e abbandonato in comune, alla presenza di altri, dal fenomeno originario e arcietico del ritirarsi d’essere, in cui la libertà comprende sé stessa come 43
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XIII Decisione. Deserto. Offerta, p. 150. J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XIV, Frammenti, p. 171. 45
La situazione è l’apertura del ‐Ci nella decisione. 46
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XIII Decisione. Deserto. Offerta, p. 151. 47
Nancy cita Essere e tempo, Longanesi & Co., Milano, 1997. Parte prima, sezione seconda, capitolo secondo, § 60, La struttura esistenziale del poter‐essere autentico attestato dalla coscienza, pp. 362‐63. 48
L’interesse per spazialità e spazio sono stati al centro di grande attenzione da parte della filosofia francese, dando luogo per altro ad un felice connubio con l’architettura e l’arte, cui Nancy ha più volte contribuito. 49
Il commento è tratto da R. Esposito e J. L. Nancy Dialogo sulla filosofia a venire, introduzione all’edizione italiana del testo J. L. Nancy Essere singolare plurale, Einaudi, Torino, 2001, p IX. 44
57
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 l’alterità costitutiva e irriducibile alla presenza di un moto di liberazione, generosità, spontaneità e meraviglia, l’esistente singolare si trova posto in situazione; questa, a sua volta, è il luogo, la spaziosità propria dove la decisione sempre si rinnova, decidendo del suo rapporto con l’esistenza ‐ che è un rapporto invece propriamente etico. Lo spaziare proprio della decisione è così tanto la ‘apertura’ di Heidegger, quanto ‘il mettere in libertà i luoghi’ di Bennefoy50 e ‘l’abitare nomade’ di Deleuze e Guttari51. La spaziatura è ciò che dà luogo e perciò dà singolarità d’esistenza. La situazione si risolve ad essere la forma generale dell’esistenza, come spaziatura ed esposizione. La decisone è il taglio inaugurale della singolarità che, esistendo nella situazione, espone la propria differenza, nel rapporto a sé stessa e agli altri. A seguito di questa analisi, il termine ‘situazione’ può essere abbandonato e compreso come la ‘spaziatura dello spazio libero’; a sua volta, questa specifica spazialità, inaugurata dalla decisone, viene chiamata da Nancy ‘arealità’, poiché essa ha il carattere dell’area ‐ che si distingue dallo spazio pubblico della Arendt, non essendo semplicemente ‘dato in dono’, ma coincidendo con la fondazione stessa dell’arealità spartita: non è donata, quanto piuttosto è essa stessa l’offerta e il dono che si genera e che si riproduce attraverso la liberazione dello spazio, senza mediazione alcuna. 7. L’ETHOS DEL SOGGIORNO I luoghi autentici della spaziatura sono allegorizzati da Nancy come ‘deserto’: presa a prestito dal già menzionato immaginario di Deleuze, la visione di una libertà che si dona accrescendosi infinitamente serve a richiamare l’ambivalenza del nulla che, se è ciò che ci accomuna, spartendoci nell’esposizione, è anche ciò che ci allontana, avanzando come l’orrore di una reciproca non‐identità; è questo il paradosso che la filosofia ha il dovere di pensare, comportando la sempre possibile riconversione della libertà nel suo rovescio: «la minaccia di una devastazione dell’esistenza, questo solo possiede, oggi, una realtà positiva».52 Il niente del deserto, davanti alla minaccia della devastazione, è la neutralità dell’esistenza e delle sue ecceità spartite: la spaziatura di luoghi autentici e il dono della libertà come spazio libero che il nomade, abitandovi, accresce. Il nomade, per Nancy, non è solo il vettore di deterritorializzazione che Deleuze vede protagonista di un pensiero che non pensa più il rapporto tra soggetto e oggetto, ma tra la terra ed il territorio; poiché, se ci si concentra meno sull’aspetto dell’erranza (verità) e maggiormente su quello dell’abitazione (ethos), allora il nomade, abitando il deserto, crea lo spazio che è il suo stesso soggiorno e che «è l’ethos stesso come apertura di spazio, riparo spazioso dell’essere nell’esistenza, che decide di restare quel che è nella lontananza da sé, in quella lontananza che lo abbandona al suo ritirarsi, alla sua esistenza, generosamente».53 Nancy parla dell’affermazione della generosità come ethos: perché la libertà che non decida la furia, ma l’esistenza, si rivela generosità prima ancora che 50
Nancy cita Y. Bennefoy, L’improbable, Paris, 1951, p. 181. Nancy cita Deleuze e Guttari, cit. Mille plateaux, pp. 473‐74. 52
Ivi, p. 155. 53
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XIII Decisione. Deserto. Offerta, p. 153. 51
58
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo libertà. Così, rispetto alla mancanza di un baricentro compiuta nel pensiero di Deleuze, qui si riconducono al deserto i concetti di dono e di offerta, intesi come generosità che si concreta nell’offerta della libertà, il dono che si ritrae nel dono stesso e nella sorpresa della propria decisione di dare luogo, di spaziare lo spazio alla singolarità di sé stessa, di affidare all’esistenza singolare un luogo ogni volta spaziato per la decisione ‐ una decisione che resta molteplice. Ma come, ancora e sempre diversamente, esemplificare una siffatta libertà? Nella nota finale al lavoro compiuto, Nancy scrive: La libertà esigerebbe che si pensi – in una regione in cui dovrebbero essere rimesse in gioco le esigenze e le speranza dell’ “arte”, dell’”etica”, del “politico”‐ non un modello inimitabile, non una mimesis senza modello, ma la sorpresa dell’esempio come tale […] una sorpresa più originaria rispetto alla poiesis della stessa mimesis, una praxis dunque, che non sia però un’ “autoproduzione” dell’agente, bensì: la virtù –
forza ed eccellenza‐ di null’altro che l’esistenza. Un’ontologia di quell’esempio sorprendente che l’essere 54
dà. In Nancy etica e ontologia si raccomandano l’un l’altra come etica originaria di una praxis che è il pensiero stesso, ma che è anche, come pratica letteraria del pensiero: «esemplare di ciò che, col nome di praxis (eccellenza, virtù, rivoluzione), si lascia pensare come non‐poiesis o come poiesis del solo agente della poiesis. Il che si può anche interpretare con la poesia stessa».55 8. AFFERMAZIONE, ETICA, CORPO La contropartita di un pensiero che pensa l’esistenza come esposizione è l’aver esposto la filosofia stessa: non si tratta infatti di rigettare la filosofia o proclamarne l’avvenuta morte, ma lasciare che il pensiero agisca ed esista al di fuori dalla metafisica del soggetto. Il pensiero è «esposto all’indecisione tra il discorso e il gesto, l’uno e l’altro appartenenti al pensiero, ma […] sempre in bilico, sempre in pericolo di scivolare fuori di esso. Ed in pericolo dunque di essere solo discorso o solo gesto».56 Da una riepilogazione sommaria quale lo spazio a nostra disposizione concede, può sembrare in effetti che il linguaggio dell’ontologia, attraverso cui Nancy ci parla, nasconda insidie logiche e che una volta trasposto nella koinè in cui esprimiamo la nostra quotidianità comporti, in qualche modo, delle conclusioni che trascendono la sua effettiva portata; in realtà, Nancy è abbastanza esplicito e, come abbiamo visto sulla questione del male, non manca di prendere posizioni: le sue opere mostrano, anzi, la possibilità di parlare in modo più forte del ‘nostro più proprio’, attraverso il ripensamento e la disposizione all’ascolto, per incontrare ‐ non allestire ‐, una nuova orizzontalità di senso, la possibilità di un discorso condiviso (come da tradizione continentale). Per quanto riguarda il discorso sulla libertà, ad esempio, che coinvolge anche e necessariamente quello sulle libertà, il fatto che l’esistenza riposi esclusivamente sulla propria decisone di custodirsi come decisione, e che questo sia l’ethos originario, che riapre ogni volta in sé la differenza propria dell’in‐decisione, non significa altro che 54
Ivi, p. 154, nota n° 9. Ibidem. 56
Ivi, p. 165 55
59
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 […] se non altro, in modo chiaro, che le idee acquisite sulla libertà […] sono “funzionali” a loro volta alle pratiche meno liberatorie di questo mondo spaventoso e disincantato, o sono rese più “obsolete” da questo mondo. Le “libertà” sono anche strumenti della “tecnica”. Per questo è derisorio limitarsi a riproporre […] un valore assoluto della libertà. L’alta densità del linguaggio ontologico, cioè, non nasconde una ricaduta nella teoresi fine a sé stessa e quindi, in questo caso, il fatto che non abbia più senso cercare di capire come e cosa sia un’etica, una morale; e tanto meno significa abbandonare la lotta per il proclamarsi del diritto ad esistere o per il rinnovarsi dei diritti ‐ che è proprio quel commisurarsi continuo a ‘libertà, uguaglianza e fraternità’ che qui s’è esposto: è il politico.57 Se è vero che la filosofia del Novecento è arrivata a comprendere che l’etica non può essere formulata a discendere da un sistema morale, tuttavia questo non ha impedito che, in modo più o meno sapiente, si tentasse di indicarne una. Jean Luc Nancy vuol fare un passo nella direzione che afferma ostinatamente l’etica, senza per questo scalfire in alcun modo quel sapere.58 Scrive infatti: Soltanto l’esistenza, come esistenza e come fatticità singolare della libertà, offre, se non proprio un’etica, comunque quel “riparo” dell’essere che è il suo ethos più proprio, che l’ethos o il soggiorno dell’uomo che soggiorna nella possibilità della sua libera decisione.59 Il pensiero materiale dell’agire, che è ‘un’ pensiero finito, vuol significare dunque la fine della metafisica, dei massimi sistemi, come ciò che per secoli ha fatto della filosofia la continua rivoluzione attorno allo stesso asse: il rapporto tra interno ed esterno, soggetto e oggetto, 57
Nonostante che: “Il motto ‘libertà, uguaglianza e fraternità’ ha per noi qualcosa di ridicolo ed è molto difficile introdurlo nel discorso filosofico”. Ivi, p. 175. Infinito ed incessante, in virtù del carattere di cominciamento e inizialità proprio della libertà, è il carattere rivoluzionario del politico, inteso qui come la continua apertura e ri‐
apertura dello spazio della coesistenza. Il politico, come possibilità che discende direttamente dal fatto dell’esistenza, non può essere una forma di produzione. La difficoltà a riconoscere l’inizialità della politica è ideologica e ha le sue motivazioni del fatto che tale carattere ci è stato trasmesso solamente dalla tradizione rivoluzionaria, ovvero in un retaggio che Nancy sintetizza nel motto: la libertà, la si può solo prendere (p. 80) Nancy affronta la contraddizione di una rivoluzione che ci è stata per lo più trasmessa come liberazione forzata (“e non è assodato che si tratti di questo nemmeno in Marx” Ivi, p. 82); segnala poi il pensiero di Saint‐Just, che invece, e similmente a ciò che ora egli cerca di dire, reclamava una liberazione del popolo “per il suo stesso essere libero, senza limitarsi a conservare le libertà istituite” (Ivi, p. 83)In questa economia ontologica l’aspetto rivoluzionario del politico è fondamentale, poiché è qui che si giustappongono nello stesso ordine di materie, di effettività e fatto, l’inizialità di una rivoluzione e l’originarietà di un’etica: una vicinanza questa che risulta imbarazzante se estrapolata dalla portata destrutturante le ideologie propria del pensiero di Nancy. La rivoluzione ed il politico sono cooriginari alla struttura comune dell’esposizione ‘solo’ perché la libertà si prende, cioè si è già avuta da sé. Niente e nessuno comincia ad essere libero, piuttosto è la libertà che è il cominciamento e come tale non ha fine. Nelle riflessioni che chiudono L’esperienza della libertà, tuttavia, Nancy spiega come, nonostante la connotazione d’orrore con cui oggi riceviamo la parola ‘rivoluzione’, essa designi la comunità esposta a sé stessa, il momento in cui viene alla luce la libertà comune e l’essere è consegnato alla decisione. Non è infatti possibile limitare o nascondere la critica che questo modo di pensare l’evento e l’avvento della libertà come ritirarsi dell’essere e pertanto la liberazione di uno spazio chiamato: ‘politico’, produce. Una riflessione come quella di Nancy è anzitutto una destrutturazione che dà da pensare e ne dà anche e necessariamente sulla possibilità futura di concepire il politico come democrazia: i sistemi di governo che si basano sulla dialettica democratica mancano dell’inizialità di una libertà che, come abbiamo visto, ri‐
comincia sempre, laddove la democrazia concepisce solo la/le libertà ‘acquisita/e’. Una simile aporia tarla ‐ ricorda Nancy ‐ tutto il pensiero politico moderno ed è la stessa denunciata da Kant, quando sostiene che non si può definire maturo o meno un popolo per la libertà, poiché solo nella libertà si possono usare le proprie forze nella libertà (I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, Laterza, Roma‐Bari, 1980, p. 209) 58
Si veda a proposito l’intervista a J. L. Nancy pubblicata in questo numero di ‘Humana.Mente’. 59
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XII, Il male. La decisone, p. 146. 60
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo sofisticato poi in quello tra teoria e pratica. Il retaggio che qui si cerca di superare è infatti il persistere, in ogni filosofia, della dicotomia, della distinzione essenziale tra teoria e pratica. È soprattutto sul superamento di questa differenza (e del solco che essa traccia in ogni tentativo di un dire filosofico diverso) che Nancy ha basato tutto il suo sforzo; e lo ha fatto col presupposto intuitivo che, ammessa la fine della storia della metafisica, la nuova architettura concettuale si debba concentrare su un unico problema: l’esterno è entrato. Lo schematismo trascendentale ha in effetti impostato una separazione ‐ quella tra ragion pura e ragion pratica ‐ insanabile, una distinzione essenziale tra morale e ragione che, per quanto intesa e proposta come unità sintetica, ha invece sottolineato la forza di questa differenza. Se, infatti, si attribuisce il pensiero alla sola attività riflessiva di un Cogito che si proclama prima soggetto e poi esistente e la pratica, invece, alla sola pulsione, al desiderio inclinato verso il bene o il male, o ancora alla volontà ed alla sua in‐comprensibile libertà (che agirebbe in base a norme avulse dal tempo, ma funzionanti su modello comunque causale, invece che ‘cosale’), allora si riconduce anche ciò che c’è di più originale nell’umano a qualcosa che non si può dire ed il compito di proclamare un’etica risulta impossibile, poiché all’elezione, per dirla con Lévinas60, manca il logos: l’etica è pre‐logica ed è da ricercare e comprendere come la struttura che è ‘altro dal pensiero’ (se inteso come ‘ragione’). Scrive Nancy: Bisogna dunque riuscire a pensare, se non una “patologia”, almeno una passione pura della ragion pura, in cui essa si rivela “pratica” in ogni suo aspetto (anche in quanto ragione “teorica”). Ma la “purezza”, in questo caso, non sarebbe altro che l’effettività materiale dell’essere‐nel‐mondo e l’impurezza morale (il male […]).61 Questo pensiero affermativo, figlio di una crisi e di un mutamento radicale del filosofare, non è stato concepito quanto, piuttosto, accade: ci sorprende come la stanchezza stessa per la deiezione ed il gioco delle rap‐presentazioni, il gioco dell’idea sulle idee. La filosofia sistematica non può che prenderne atto, come del suo stesso fallimento e quindi, al contempo, come di tutta la rinnovata necessità di dare la parola al pensiero. Quella di Nancy è tanto l’esplorazione della chiusura di un’epoca quanto improvvisazione narrativa di un’apertura altra, che ha già oltrepassato il liquido pensiero postmoderno: è l’avanguardia che ascolta ed il pensiero che pensa il dovere di pensare. Ciò che insorge, con questo pensiero, è l’esigenza dell’affermazione in forza della propria matericità, in virtù del suo principio arci‐etico che parla di liberazione per un pensiero e resistenza del pensiero, in virtù dell’ethos che lo descrive come la sua im‐
proprietà, il suo nomadismo, il suo soggiorno presso le cose, la sua verità. Secondo la lettura, ovviamente parziale, che qui viene proposta, dal posizionamento si può trarre una conclusione: l’unica cosa a restare rivoluzionaria e sintomatica di verità è il corpo. Non solo uno: i corpi, che giocano, che godono, che soffrono, che urlano, che bruciano, che esultano, che fanno massa per poi disgregarsi in intimità e privato, per ricercarsi di nuovo nella pubblica piazza; che vivono per proclamare il loro diritto ad esistere. I corpi che stanno diversamente, ma tutti per un principio an‐archico di libertà e dal cui posizionamento si deve 60
E. Lévinas, Altrimenti che essere, Jaka Book, Milano, 1999. J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo IX, La libertà in quanto cosa, forza, sguardo, p. 105. 61
61
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 spremere, lasciar venire o e‐scrivere62 un nuovo modo di sentire, di pensare, di proclamare e negare. Non c’è più interno/esterno perché, abbiamo detto, l’esterno è entrato. Si tratta dunque di considerare la tecnica, che oggi sposta il confine tra vita e morte, come Nancy racconta ne L’intruso: Corpus meum e interior intimo meo, i due insieme per dire esattamente, in una configurazione completa della morte di Dio, che la verità del soggetto è la sua esteriorità e la sua eccessività: la sua esposizione infinita. L’intruso mi espone eccessivamente. Mi estrude, mi esporta, mi espropria63; ed i corpi stessi, che si adattano prima della coscienza alle situazioni nuove in cui esistere e che ci impongono di andare incontro a questa evoluzione: «noi, io e tutti i miei simili sempre più numerosi, siamo in effetti l’inizio di una mutazione.»64; e lo spazio in cui esistiamo, che non ha più il carattere di frontiera, ma che si sviluppa in sé stesso articolandosi, moltiplicandosi, definendo un lebenswelt di cui non possiamo che accettare i risvolti: lo spazio […] non è più propriamente dimensionale: la terra si riduce a un punto […] e la coscienza angosciata di questo ripiegamento genera a sua volta un pensiero dello spazio – un pensiero che è al 65
tempo stesso angoscia e lotta contro l’angoscia, punto di partenza di un’altra storia . Se da questo pensiero si sviluppa una proposta, si tratta allora di quella che proclama e afferma il corpo: un’etica che si presenta nel ‘come’ del corpo che si pone nello spazio, l’arealità: è questo che resta oltre la riduzione (o l’espansione) dell’etica al posizionamento d’esistenza. Nonostante, infatti, l’azione libera sia stata compresa come il tratto d’efficacia, la forza della cosa come tale, questo non nega l’effettività dell’atto libero: esso è dovuto, causato, preteso a partire dall’esser‐libero di un Dasein, ma coincide con l’esser‐libera dell’esistenza stessa. In conclusione, essere libero significa esserlo di una libertà effettiva e irriducibile, anche se l’esperienza di questa forza assoluta è quella stessa dell’impenetrabilità del pensiero così che, volendola comprendere come si comprende un elemento in una concatenazione di cause, verrà alternativamente considerata così infima da poter essere negata o talmente decisiva da dover essere celebrata. Libertà è dunque l’incomprensibilità della cosa senza causa e coincide con l’esistenza stessa: la sua realtà si dà attraverso questo stesso corpo, ma come la forza libera che lo trascende, che «non scompare neppure con la distruzione del corpo, e che scompare 62
L’e‐scrizione è il non‐metodo adottato da Nancy per investigare le cose esistenti. J. L. Nancy, L’intruso, Cronopio, Napoli, 2000, p. 35. L’Intruso è un vero e proprio caso filosofico ‐ letterario in cui l’autore si confronta con la malattia e con l’estraneità cui essa ci espone. Dalla sua pubblicazione è cresciuto anche l’interesse per l’orientamento che la riflessione di Nancy ha dato agli interrogativi lasciati in sospeso dall’ontologia del Novecento. L’intrusione, quella di un cuore altrui trapiantato al posto del suo, è lì raccontata in modo da divenire essa stessa immagine dell’esperienza che il pensiero fa, quando inciampa in ciò che lo fa pensare; un simile gioiello di scrittura rende conto del senso stesso della ricerca portata avanti da Nancy, riconciliando, nell’e‐scrizione di una vicissitudine personale, le parti disseminate dal lavoro di una vita su libertà, singolarità, alterità, corpo. 64
Ibidem. 65
R. Esposito e J. L. Nancy, Dialogo sulla filosofia a venire, in J. L. Nancy, Essere singolare plurale, Einaudi, Torino, 2001, p. XI. 63
62
Laura Beritelli – Affermazione, etica, corpo davvero solo se il rapporto tra questa esistenza e un’altra […] si distrugge anch’esso come un rapporto tra esistenze […]».66 Si potrebbe infine parlare, a nostro giudizio, di un’etica dell’effettività dell’esistenza, come di ciò che si compie nei corpi e nelle cose, considerando bene la complessità di questa proposta che, ad esempio, annichilisce (e rigenera poi) un'altra distinzione essenziale, ben radicata nella nostra cultura: quella tra organismo umano e ambiente.67 Si potrebbe parlare quindi anche delle fattezze che il pensiero assume quando s’incarna o si concreta, inaugurando una delle molteplici prospettive che il filosofo insegna a praticare; e, soprattutto, di come, in casi di personalità eccezionali, l’arte abbia anticipato i contenuti di questo pensiero finito68. Per concludere, l’affermatività dell’ontologia di Nancy sembra promettere di in‐comprendere il modo in cui il pensiero è prima di tutto un’apertura emotiva, o il perché i nessi, che faticosamente cerchiamo di ricomporre, prima si esperiscano sulla pelle, nei nervi, tra le idee, come il disagio di ciò che non è conforme al vero di una fede (o credenza) nel mondo ‘in questo o in quel modo’. Ed è questa l’esperienza della libertà, il fatto che la libertà stessa è l’esperienza e che il pensiero la incontra ogni qualvolta «inciampa in ciò che lo rende possibile, in ciò che lo fa pensare».69 Ogni eccedenza cui il pensiero faticosamente giunge verrà poi assimilata in una nuova coerenza semantica. Filosofare è, dunque, la disponibilità del pensiero a farsi carico della sua passione/dolore. In questo senso, il pensiero è anche patologia e sensualità, dolore e piacere: «la libertà, nel suo evento, è forse sempre qualcosa che appartiene al cuore. Ma come pensare un cuore dell’essere?»70 Se anche non ha risposto a questa domanda, tuttavia Nancy ha in effetti aperto la filosofia ad un lavoro che mira al cuore dell’esperienza, in cui la libertà è lasciata significare il cuore dell’essere ed il pensiero che la pensa il pensiero di questo ‘cuore’. A maggior ragione, allora, risultano suggestive le parole che ne L’Intruso emergono a raccontare l’esperienza di un cuore estruso e di un nuovo cuore intruso, che sembrano ancora una volta dar voce al suo pensiero finito: Questa correttezza morale presuppone che si riceva lo straniero annullando sulla soglia la sua estraneità: pretende quindi che non lo si sia affatto ricevuto. Ma lo straniero insiste e fa intrusione. È proprio questo che non è facile accettare e neppure forse concepire…71. 66
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo IX, La libertà in quanto cosa, forza, sguardo, p. 105. 67
Nancy non esclude dalla coesistenza minerali, animali e quant’altro esistente, destituendone, con richiamo spinoziano, il carattere di eterni esclusi dal senso ‐ o dal non‐senso. Essi sono altri, ancora indefiniti, modi dell’ek‐
sistenza: “C’è la fatticità del mondo […] è il “c’è”, con tutta la forza di “presenza reale” che esso implica. […] La fatticità in quanto fatticità è anche […] la fatticità della pietra.” 68
Di questo abbiamo parlato con Jean Luc Nancy: le risposte ad alcune questioni preliminari qui esposte sono pubblicate come intervista in questo stesso numero di ‘Humana.Mente’. 69
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XIV, Frammenti, p. 175. 70
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000. Capitolo XI, Libertà e destino, p. 118. 71
J. L. Nancy, L’intruso, Cronopio, Napoli, 2000, p. 12. 63
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Del cuore dell’essere, o del pensiero stesso come scontro con la sua infinita alterità e incontro con il limite che abitiamo, può essere detto che si introduce in noi come il tarlo di una estraneità, se non che: L’intruso non è altro se non me stesso e l’uomo stesso. Non è nessun altro se non lo stesso che non smette mai di alterarsi, intruso nel mondo come in sé stesso, inquietante spinta dello strano, conatus di 72
un’infinità escrescente. Laura Beritelli Bibliografia 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
72
J. Derrida, Le Toucher, Galilée, Paris 2000. S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Borlinghieri, Torino 1971. E. Lévinas, Altrimenti che essere, Jaka Book, Milano 1999. M. Merleau‐Ponty, Il visibile e l'invisibile, Bompiani, Milano 1969. M. Heidegger, Lettera sull'umanismo, Adelphi, Milano 2001. M. Heidegger, Il principio di ragione, Adelphi, Milano 1991. J. L. Nancy, L'esperienza della libertà, Einaudi, Torino 2000. J. L. Nancy, L'intruso, Cronopio, Napoli 2000. J. L. Nancy, Essere singolare plurale, Einaudi, Torino 2001. J. L. Nancy, La comunità inoperosa, Cronopio 1995. Ivi, p. 37. 64
La parola (com)promessa Aggiustamenti politico‐umanitari ed etica della verità Paolo Bonari [email protected] Abstract
Starting from the publication of two major analytical works in moral philosophy, I argue for a new
understanding of the link between truth and critique, based on the last Michel Foucault’s interviews
and courses at Collège de France, whose efforts are still not enough appreciated by contemporary
moral and political philosophy. Going back to the Greek roots of our culture and to the ancient
practices of subjectivization, the French philosopher tried to create a genealogy of the critical
attitude, which could be a unifying point where all the various philosophical traditions could meet.
A ‘problematization’ of political modernity can be drawn from the recognition of the particular
path chosen by an analytical tradition of the truth, though refusing the reflection of the subject on
itself, the askesis of the self, typical of this tradition.
Keywords: critique, relativism, resistance, self, subject, totalitarianism, truth.
1. SÉ ANALITICO, SÉ CONTINENTALE? Negli ultimi anni, parallelamente all’affievolirsi della novità filosofica rappresentata da approcci relativistici, negli studi letterari e nella filosofia, ma anche nelle più ampie scienze umane e sociali, si è venuta formando un’ondata contraria, che proviene, similmente al suddetto paradigma – divenuto dominante – da ambienti statunitensi. Si tratta, in massima parte, di opere di ispirazione analitica, che hanno avuto una buona eco – ancora, tuttavia, non esattamente quantificabile – e che sono state tradotte nelle principali lingue, tra le quali l’italiano. È del 2005 la traduzione dell’imponente sforzo di Bernard Williams, uno dei filosofi morali più importanti del secondo Novecento, dedicato alla difesa del ruolo della verità nell’ottenimento di migliori condizioni sociali e politiche1. Due anni più tardi, è stata la volta di un’opera non meno ambiziosa2, mossa dagli stessi obiettivi della prima e di quella ideale prosecuzione, non priva di rilievi critici, il cui autore è Michael P. Lynch, già noto per altri studi che si focalizzavano sul concetto di verità, a cavallo tra l’epistemologia e la filosofia sociale e politica. I due filosofi condividono una medesima preoccupazione: quella che il dominio relativistico possa nuocere alla corretta formulazione di approcci interpretativi ed ermeneutici, in discipline che da esso sono state ‘colonizzate’, negli ultimi quattro decenni. Punto di partenza di Williams è la riflessione di colui che viene considerato il precursore di tale linea di pensiero, Nietzsche, 1
B. Williams, Genealogia della verità. Storia e virtù del dire il vero, trad. it. di G. Pellegrino, Fazi, Roma 2005. 2
M. P. Lynch, La verità e i suoi nemici, ed. it. a c. di S. Moriggi, trad. it. di S. Fortuna, Raffaello Cortina, Milano 2007. 65 Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 che Lynch definisce “una specie di pre‐postmoderno”3, almeno nella prospettiva di chi vuole annetterlo al relativismo, questione sulla quale l’autore sospende il giudizio. Williams, invece, ha un’opinione forte, al riguardo, e tenta di scorporare il filosofo tedesco dalle generazioni di pensatori che a lui hanno guardato, nel condurre la propria battaglia contro il nemico di sempre, l’idea di verità, dimostratasi l’ostacolo più resistente al dilagare del soggettivismo epistemologico. Si può parlare di nemico eterno, infatti, in un’interpretazione che leghi i relativisti novecenteschi ai loro precursori antichi, i sofisti: se i primi pongono come fattore determinante il contesto, quale elemento che decostruisce le preteste assolutistiche che essi vedono connaturate a qualsiasi affermazione veritativa, è perché i secondi operarono, nell’Atene antica, una svolta che poneva la vittoria nelle competizioni discorsive – e non il perseguimento della verità – come l’unica meta da raggiungere, per il retore che avesse seguito i loro insegnamenti. Ma che cosa lega davvero generazioni così distanti di pensatori? Un’idea utilitaristica della verità, intesa come ciò che, di volta in volta, risulti decisivo per la sconfitta degli interlocutori o, nel caso del relativismo contemporaneo, per la conclusione della conversazione. Il passaggio può sembrare contro‐intuitivo, ma che non sia eccessivamente azzardato è la convinzione di Lynch, in uno dei passaggi più acuti della sua argomentazione, nel quale egli impiega tutta la propria dimestichezza con la strumentazione epistemologica di indagine sociale, di cui certa filosofia analitica sembra poter fare a meno, ma che punta a risalire direttamente alle fonti primarie e migliori della tradizione anglosassone, quelle fedeli alla salvaguardia del common sense, quale piattaforma epistemica condivisa dalla comunità dei parlanti, nonché potente e non superabile elemento dell’armamentario anti‐ideologico e, nella messa a prova storica, anti‐totalitario4. Ciò che Lynch tenta, con vigore filosofico, di sostenere è il carattere illusorio della democraticità intrinseca all’affermazione, da parte del parlante, della limitatezza del proprio angolo visuale, all’interno di uno scambio conversazionale. All’autore appare dimostrabile che il riconoscimento della diversità di vedute non precede né fonda l’interazione verbale degli attori, ma – al contrario – la porta a precoce compimento, la fa terminare con un ‘nulla di fatto’, si potrebbe dire, stante il perdurante disaccordo che regna tra i parlanti, permettendo una via d’uscita da una situazione d’impasse che potrebbe rivelarsi polemogena. Il relativismo, inteso come attitudine anti‐controversiale e distensiva – meglio, riconciliante, in quanto capacità rigeneratrice di situazioni non compromesse, pre‐polemiche – o cornice entro cui si svolgono le interazioni, svolge una funzione, perciò, inibitoria del conflitto e facilita una risoluzione del contatto verbale che, se non reca danno ai soggetti coinvolti, è soprattutto perché non ne stimola il carattere acquisitivo. Da una discussione, si può uscire ‘indenni’, grazie alla conciliazione relativistica. De gustibus non disputandum est e tanto basti, privilegiando la non alterazione delle relazioni amicali e pre‐verbali. Tale linea argomentativa, in realtà, andrebbe intersecata e fatta reagire almeno con un paio di concetti presi in prestito dall’area continentale, quali quello di ‘risentimento’, di matrice nietzscheana, e quello di ‘stupore’, variamente affrontato o sfiorato, nell’alveo della 3
Ivi, p. 143. Per la spiegazione di un passaggio così ermetico – e, allo stesso tempo, fondamentale – si rimanda alla prosecuzione della lettura: in particolare, al § 2. 4
66
Paolo Bonari – La parola (com)promessa meditazione occidentale, ma che può rinvenirsi addirittura nello scenario originario della cultura greca, quale atteggiamento dell’uomo che inizia la propria interrogazione, punto temporale di scaturigine della stessa filosofia. Allora, se l’atteggiamento relativistico viene adoperato come strumento di pacificazione e fa sì che sia possibile prevenire i contrasti, che vengono addolciti o volatilizzati in rassicuranti ‘questioni di gusto’ (o ‘di contesto’), esso potrà anche avere una funzione repressiva del risentimento – variante culturale e più filosoficamente pregnante della sua declinazione sociale, l’invidia –, ma non può che trainare e facilitare, similmente, il formarsi di una condizione del soggetto che è interamente anestetica, immunitaria, a fronte degli scompensi e delle scosse disequilibratrici connaturate allo stupore. Il sofismo, se la questione è messa in questi termini, sembra collocarsi dalla parte opposta, ma è evidente come sia possibile una diagonalizzazione: nel relativismo non ci sono vincitori, gusti e contesti sono equivalenti e non discutibili razionalmente, esondano dai confini di ciò che può essere sottoposto al vaglio della verifica intersoggettiva; nel sofismo, al contrario, ciò che conta è unicamente la vittoria discorsiva. Ma gli sconfitti si sentono tali per il breve spazio di un’interazione: la volta successiva, provvederanno a dotarsi di armamentari retorici più adeguati e raffinati, al fine di soverchiare gli avversari, non indulgeranno al rischio di una riflessione che li possa portare a contatto con il nucleo pulsante dell’attività critica del mondo e di sé, ovvero questo stesso rapporto che lega il sé a ciò che può vedere, al di fuori di sé stesso. Riprendendo i fili della proposta anti‐relativistica dei due filosofi, c’è da dire che è possibile isolare, all’interno delle riflessioni dei nostri autori, due concetti che sono parzialmente sovrapponibili e che trovano il modo di stabilire un dialogo non casuale anche con acquisizioni provenienti da altri territori filosofici. Williams concentra la propria indagine attorno alla virtù della ‘veridicità’, che ha rappresentato uno dei poli cui, a più riprese, si è avvicinata la riflessione filosofica occidentale, basti pensare al noto scambio di idee che vide Benjamin Constant contrapporsi al più radicale Immanuel Kant. Lynch preferisce affrontare la questione da un punto di vista più allargato, richiamando la categoria dell’‘integrità’, di cui analizza, in particolare, la componente dell’‘integrità intellettuale’. Singolare – significativo, anzi, per noi, come vedremo – è il fatto che, mentre Williams si sente quasi investito del compito di salvare Nietzsche dalle grinfie dei suoi epigoni relativisti, tra i quali sembra annoverare Foucault, seguendo una tradizione ben consolidata e dando prova di non volerla oltrepassare, sia Lynch, che si dichiara non in grado di intervenire sulle questioni di interpretazione dell’opera nietzscheana, a lanciare qualche segnale di apertura nei confronti del filosofo francese, incrociando la sua traiettoria, in qualche rapido accenno, nel capitolo dedicato alle ricadute politiche del relativismo e ai rischi insiti nel suo dominio epistemologico, in relazione ai regimi di potere. In area conservatrice, l’inizio delle repliche politico‐culturali a quella che era sembrata la sempre più estesa corrente relativistica risale, ormai, a qualche decennio fa, al periodo in cui essa veniva affermandosi, fino alla sua completa istituzionalizzazione e colonizzazione del campo progressista, con potenti ripercussioni a livello accademico. Ciò che è più interessante, nelle ricerche di Williams e di Lynch, è che entrambi gli autori sembrano muoversi in un ambito fieramente progressista, che tale posizione non costituisca un segreto e che i loro sforzi siano diretti proprio verso la possibile ridefinizione delle coordinate di un 67
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 pensiero che si trova impreparato e sotto attacco, di fronte alle elaborazioni conservatrici, delle quali i due filosofi non condividono le piattaforme e gli sbocchi politico‐culturali. Come stiamo cercando di dimostrare, non è esclusivamente aggirandosi in territori analitici che è possibile condurre un ripensamento dei modi oggi più in voga di pensare il tema della verità e l’aiuto può esserci fornito proprio da Michel Foucault, uno dei filosofi che maggiormente è stato imputato di primogenitura e di corresponsabilità, riguardo a certo relativismo postmoderno5. L’opera del filosofo francese costituisce ancora un vero e proprio enigma, secondo i suoi più acuti e coraggiosi interpreti, benché egli possa considerarsi, probabilmente, la figura più commentata e studiata della filosofia del secondo Novecento, con un’attenzione che sembra aumentare, di anno in anno, non di rado seguendo percorsi non strettamente scientifici, ma di mediatizzazione del suo pensiero, che non ha smesso di costituire una moda che si auto‐rinnova, anche grazie all’operato di generazioni di lettori poco attenti e molto ideologizzati, i quali hanno finito per fare di Foucault il rappresentante di tutte le (loro) battaglie, con evidente sprezzo dell’accuratezza filologica. L’enigma foucaultiano si configura come tale a partire da un anno preciso della vita del filosofo, il 1980. Precedentemente, la sua ricerca era sì passata da un approccio archeologico ad uno genealogico, facendone emergere le profonde e mai negate – radici nietzscheane, ma di essa si potevano ancora cogliere il disegno d’insieme, le finalità e le ricadute sull’attualità politica, dalla quale il filosofo non prese mai le distanze e nella quale, anzi, si impegnò in maniera continua, in essa trovando il campo di applicazione privilegiato di quella ‘scatola di attrezzi’ che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto sempre essere la sua intera riflessione. Nel 1980, tuttavia, si realizza quel ‘ritorno ai Greci’ che caratterizzerà gli ultimi quattro anni della sua vita e che creerà tanto sconcerto, nelle fila dei suoi più militanti ‘adoratori’. Tra loro, emerge, in quanto a virulenza critica, Judith Butler, filosofa californiana, uno dei nomi più eminenti dell’elaborazione femminista, che arriverà ad avvisare, in uno dei suoi ultimi testi6, la comunità foucaultiana di non tener conto di quest’ultima fase del pensiero del filosofo, in quanto contraddittoria, rispetto a tutto ciò che l’aveva preceduta, e pericolosamente prona alle esigenze normalizzatrici di quei sistemi di potere/sapere che Foucault aveva sempre dato mostra di voler combattere. Ciò che continua a creare un problema interpretativo, dunque, sono i possibili fili che legano la sua prima produzione a quella dei suoi ultimi anni di vita, a partire da quel cruciale 1980, per giungere fino al 1984, data della sua morte. Se le ricerche degli anni Sessanta e Settanta avevano avuto come centro propulsore le relazioni che legano il soggetto al potere e le modalità di assoggettamento che il potere rende disponibili, attraverso meccanismi determinati e determinanti, è nel 1980 che il filosofo, nel corso della scrittura della Storia della sessualità – che non verrà mai completata – arretrerà il proprio spettro d’indagine, fino a spostare la propria attenzione all’Antichità, alle pratiche di sé che, nel mondo greco‐romano, hanno concorso a formare il soggetto antico. Poche altre svolte, nella storia della filosofia occidentale, hanno avuto una storia così tormentata e sono state foriere di tanti 5
Utilizziamo una dicitura tutt’altro che pacifica e che potrebbe essere ampiamente discussa: Lynch ne dà un’interpretazione accurata, che segmenta questa corrente all’interno del più ampio relativismo tout court. 6
J. Butler, Critica della violenza etica, trad. it. di F. Rahola, Feltrinelli, Milano 2006 (in questo caso, ha senso citare il titolo originale, Giving an Account of Oneself: la scelta traduttiva è difficilmente comprensibile). 68
Paolo Bonari – La parola (com)promessa fraintendimenti e polemiche. All’epoca, di ‘adoratori’ del verbo foucaultiano si stavano infittendo le università americane ed europee e fu uno shock, per essi, un tale cambiamento, che sembrava prendere le distanze dall’attualità politica e sociale, alla quale Foucault aveva dedicato le proprie migliori energie, nel corso dei decenni precedenti, che non erano stati privi di plateali prese di posizione pubbliche. Ci sarà, dunque, chi deciderà di abbandonare il filosofo alle proprie speculazioni morali, ormai lontane da qualsiasi possibilità di ripercussione immediata sulle polemiche giornalistiche e politiche. Una volta intrapreso il progetto di delineare una storia della sessualità occidentale che mettesse in rilievo i continui tentativi repressivi attuati sul soggetto da parte dei sistemi di potere tradizionali, lo Stato e la Chiesa, Foucault virerà verso un rifiuto della stessa nozione di repressione, abbandonando la matrice freudiana e quella, non meno pervasiva, del marxismo, sebbene sempre inteso nelle sue versioni più aggiornate ed eterodosse. Le pubblicazioni di Foucault, nei suoi ultimi anni di vita, si diradarono, in ragione dello stallo che aveva subito il progetto iniziale della Storia della sessualità e di una precisa scelta del filosofo: luogo di elaborazione delle nuove idee erano diventati i corsi che egli teneva annualmente nella prestigiosa istituzione del Collège de France, nella quale aveva insegnato, in maniera continua, fin dal 1970. Purtroppo, la pubblicazione di tali corsi non è ancora completata e non poche, sembra, saranno le sorprese e gli stimoli che essa riserverà all’ampio pubblico degli studiosi foucaultiani. In italiano, degli ultimi corsi è disponibile unicamente quello tenuto nel 1981‐1982; in francese, all’inizio di quest’anno è stato pubblicato anche il corso del 1982‐1983, cui sta per seguire una traduzione nella nostra lingua. È possibile isolare due nuclei concettuali, all’interno della vastissima costellazione che il filosofo si troverà a smuovere, a mobilitare, nel proprio quadro di ricostruzione genealogica della soggettività occidentale: il primo è quello legato alla cura di sé, il secondo è un’indagine della parresia7, quel ‘dire tutto’ che costituisce la modalità privilegiata di partecipazione alla discussione pubblica del cittadino ateniese. La cura di sé è quella che, nella Grecia antica, era l’epimeleia heautou: secondo Foucault, il curarsi di sé, anticamente, era preliminare alla stessa conoscenza di sé e più importante, in qualche modo. Solitamente, invece, è il ‘conosci te stesso’ a rappresentare il lascito più duraturo, nell’opinione dei più, della filosofia greca. La questione è della massima rilevanza, è da essa che si delinea uno snodo costitutivo della storia della soggettività occidentale. Foucault pensa che il ‘conosci te stesso’ costituisca l’atteggiamento fondatore della modernità filosofica, di quella tradizione di ‘analitica della verità’ che si è affermata a partire dalla riflessione cartesiana. Da allora, via d’accesso alla verità sarà unicamente l’atto intellettivo, che può essere svolto prescindendo da qualsiasi attività ascetica del sé: il filosofo moderno, l’uomo che vuole raggiungere l’illuminazione, potrà dedicarsi esclusivamente alla pura conoscenza, senza che la sua vita quotidiana debba esserne minimamente modificata. Al riguardo, fu fondamentale, per Foucault, la lettura dei testi del filosofo e filologo Pierre Hadot, le cui ricerche hanno fatto sì che venisse alla luce la concezione 7
In italiano, è possibile rinvenire anche la forma parrhesia: si tratta di una diversa traslitterazione dall’originaria grafia greca, che tiene maggiormente conto degli elementi fonetici. 69
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 specifica che gli antichi avevano della filosofia, intesa come vita filosofica e come esercizio spirituale. Quella che Lynch chiama ‘integrità’ Foucault andò a ricercarla nell’atteggiamento che le scuole di filosofia post‐socratiche offrivano come viatico per la vita buona, ovvero per la vita del filosofo. Di particolare interesse, agli occhi di Foucault, saranno gli stoici, ai quali dedicherà numerose lezioni, nel corso degli anni. L’operazione che il filosofo effettua, se vista da un angolo più ampio, allontanandoci un po’ e non attardandoci in questioni di ricostruzione filologica delle sue analisi, è da leggersi in questa chiave: il soggetto che vuole liberare il proprio sé deve, in qualche modo, liberarsi da sé – senza attardarsi in polemiche tese a delegittimare gli apparati di potere che si sono storicamente costituiti – ma non dal sé, che deve, anzi, essere esercitato in una continua pratica ascetica, che possa renderlo malleabile, a disposizione delle esigenze liberamente formatesi del soggetto. Ma tutto ciò in che relazione sta con il Foucault ‘storico’ e più noto? Come intendere questa attività di controllo del sé su di sé e come accettare pacificamente che si possano formare ‘liberamente’ linee di condotta del soggetto, che non siano influenzate dai centri di potere/sapere pervasivi ed e(s)terni? Sarebbe interessante prestare maggiore ascolto a chi ha provato a ricostruire à rebours il cammino foucaultiano8, leggendo le prime opere alla luce delle ultime riflessioni, che il filosofo considerava, senza alcuna esitazione, un vero e proprio punto di arrivo, interpretando il proprio percorso come fortemente unitario e, soprattutto, tutto mosso dagli stessi interrogativi. 2. SECOLO IDEOLOGICO, IDEOLOGIE SECOLARI: ALLA FINE, LA VERITÀ Le discussioni residue sulla possibilità etica dell’azione politica si limitano a ciò che concerne l’ambito internazionale, in una sorta di tentativo di legittimazione esterna dell’eticità della politica interna. Pochi sono gli sforzi, invece, di tentare una definizione etica che sia rivolta verso i fulcri operanti dell’attualità politica e che guardi al rapporto degli uomini politici con la loro fonte di legittimazione, il corpo degli elettori o un sottoinsieme di questi, i sostenitori del partito cui essi fanno riferimento. Un modello possibile può essere proprio quello parresiastico, che mette al centro la pratica politica del dire la verità, una delle modalità aleturgiche, nell’interpretazione di Foucault. Nell’Atene del V secolo a.C., il cittadino che volesse intervenire nelle assemblee pubbliche aveva il diritto di dire ciò che riteneva giusto e vero, in un regime in cui vigeva la massima libertà di parola. Praticare la parresia significava esprimere la propria opinione, anche nel caso in cui essa fosse radicalmente contraria alla situazione politica. La libertà di critica, tuttavia, comportava l’assunzione di un rischio. Il parresiastes (colui che pratica la parresia), infatti, sa che rivelare tutti i propri pensieri può causargli delle conseguenze negative, esporlo al pericolo, dal momento che egli è sempre meno potente del proprio interlocutore. Ma, nella parresia, assieme alla libertà, necessaria per far sì che il dire ciò che si pensa non avvenga per un’imposizione, svolgeva un ruolo determinante il dovere: il cittadino era libero di comportarsi 8
E. F. McGushin, Foucault’s Askēsis. An Introduction to the Philosophical Life, Evanston (Ill.) 2007. 70
Paolo Bonari – La parola (com)promessa come meglio credeva, poteva scegliere di esprimere i propri pensieri più scomodi, ma poteva anche tacere, preferire il silenzio alla critica. Il vero parresiastes, tuttavia, sente come un dovere morale l’esporsi al giudizio, al rischio della libertà. La parresia fonda l’atteggiamento critico del soggetto occidentale, è la base di qualsiasi opposizione al potere in carica: attorno alla pratica della verità, nel corso dei secoli, si sono organizzate le comunità di resistenza ai soprusi dei governanti. Nella lingua greca, il termine, letteralmente, significa ‘dire tutto’: tutto ciò che si pensa, senza nasconderlo, senza tacerne nulla. Il parlante dovrà essere franco, esprimersi senza inibizioni, remore, paure. L’analisi della parresia viene affrontata, in particolar modo, nel ciclo di lezioni che Foucault tenne al Collège de France nel 1983‐1984 (Le courage de la vérité) e in una serie di sei seminari organizzati dall’Università di California a Berkeley nell’autunno del 1983. La parresia, innanzitutto, è un “atteggiamento fondamentale dell’uomo verso la realtà”9, è un comportamento: è quanto i cittadini liberi della polis greca fanno, quando si trovano a discutere dei problemi importanti, riuniti nella loro tradizionale assemblea pubblica, l’ecclesia, è la libertà del privato cittadino di dire quanto crede, come crede, contro chi crede. Egli parla liberamente, dice ciò che pensa, non fa a meno di esprimere le critiche più severe al governo politico. La comunicazione parresiastica era venuta costituendosi come un diritto, consisteva nella possibilità dell’espressione libera del proprio pensiero e rivestiva «una funzione intrinsecamente critica degli altri e di se stessi»10. Un diritto, ma anche un dovere, come abbiamo ricordato: ovvero, l’obbligo morale di parlare in tutta franchezza, l’impegno preso da ciascuno di sentirsi libero di esprimere la propria opinione nel modo che sia ritenuto più opportuno, quando siano in causa affari pubblici. Inventato nella seconda parte del V secolo a.C., il termine fa la propria comparsa nel momento in cui divenne problematico l’effettivo esercizio del diritto parresiastico. Essendo l’età d’oro della democrazia ateniese quella di Pericle (462‐429 a.C.) ed essendo la parresia legata a quell’esperienza politica, è al termine di questo periodo che Euripide, in una sua tragedia, nomina per la prima volta questo particolare diritto, conia il termine stesso, nel momento in cui esso gioca un ruolo non marginale nel mettere in crisi le stesse istituzioni ateniesi. Nella parresia, il parlante diceva ciò che pensava e diceva anche la verità: è questa la sfida più grande che viene posta alle possibilità ricettive della filosofia contemporanea, sta tutta in questa formulazione così intollerabilmente anti‐moderna. Che cosa significa? La democrazia politica ateniese si reggeva sulla peculiare forma deliberativa che veniva impiegata. Nel processo decisionale, assumeva un ruolo fondamentale la parola dei cittadini, che potevano esprimersi attraverso la libertà concessa loro dal diritto alla parresia. Ciò che da essi veniva detto, infatti, corrispondeva alla verità. Ma in virtù di che cosa? Tutto ciò sembra ci sembra esotico e lontanissimo, ma, nell’Atene del tempo, il possesso della verità era garantito, agli occhi degli ascoltatori, dal dimostrare certe qualità morali. Il parresiastes è sincero e dice la sua opinione, che corrisponde alla verità. La sua parola, frutto di una determinata ed evidente condotta di vita quotidiana, sarà vera ed egli si sentirà chiamato a dirla, in virtù di questa 9
P. Napoli, L’ultimo Foucault tra cura socratica e libertà, in E. Lojacono (a cura di), Socrate in Occidente, Firenze 2004, p. 274. 10
Ibidem. 71
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 consapevolezza. Egli sa che è la verità e sa che essa servirà alla polis: in gioco potrebbe esserci il benessere o, addirittura, la salvezza dell’intera città. Letta attraverso le categorie della filosofia morale, è facile constatare come la parresia consista in una procedura di selezione di un sé determinato: il parresiastes compie una scelta decisiva, opta per un certo sé ed esclude tutti gli altri. Egli sceglie di essere uno che dice la verità, piuttosto che uno che ha paura di esporsi. Ciò che contraddistingue il dire parresiastico da altre modalità discorsive in cui la verità possa egualmente venire alla luce è la presenza del rischio, del pericolo: la minaccia della ritorsione del più forte. Non può esserci parresia “senza quei pericoli che l’individuo assume consapevolmente decidendo di vivere nel vero piuttosto che nel falso”11: questi pendono sul capo del parresiastes, lo costringono a fare uso della virtù del coraggio. La parresia è anche un particolare tipo di relazione tra il parlante e ciò che viene detto: un’identificazione. Il parresiastes mette in gioco se stesso, assume su di sé l’intera responsabilità di quelle parole di verità e fonda un legame, istituisce un patto, si lega alla verità. Tale legame dovrà essere suggellato dal comportamento del soggetto, dal modo in cui egli effettivamente vive: è l’aderenza del logos al bios che viene (pro)posta, la coerenza tra le proprie parole (logoi) e le proprie azioni (erga). La verità detta è sì verità pensata, ma anche vissuta e conserva il proprio rapporto fondante con l’esperienza. La parresia è quell’adæquatio tra colui che parla e che dice la verità e colui che agisce e si comporta come tale verità esige. Sono più d’una le possibili somiglianze che è lecito ravvisare tra il periodo di crisi della democrazia ateniese, successivo alla morte di Pericle, e quello odierno. Come accennato, il diritto alla parresia viene ‘problematizzato’ verso la fine del V secolo a.C.: ciò che, prima, veniva dato per scontato, in quanto prerogativa e cardine di quella democrazia, viene dibattuto, messo in discussione, contestato, avvertito come una fonte di corruzione del dibattito pubblico. Che cos’era successo? Si era manifestata, in tutta la sua importanza, la necessità di riconoscere un parresiastes. Quali sono le qualità morali che questi dovrà avere? Come distinguere, in mezzo ai tanti che tali non sono, i dicitori di verità? Dopo la scomparsa di Pericle, sono questi gli interrogativi ateniesi. La crisi della democrazia ateniese è, in primo luogo, la crisi della parresia: è la chiacchiera vuota e facile a proliferare. Il parlare non è più un dovere morale, ma un piacere, anche un passatempo. Sono i tempi dell’athuroglossos12: egli è colui che, letteralmente, ha la lingua senza una porta, una bocca che non riesce a tappare. L’athuroglossos non si cura delle circostanze, delle persone alle quali si rivolge, parla a sproposito. Invece, la parresia conservava uno stretto rapporto con il kairos, il momento opportuno, che andava individuato e sfruttato. Così, la libertà di parola si vede degenerata nel malcostume del parlare per parlare. Isocrate arriverà a sostenere che la parresia è incompatibile con la democrazia, in un completo rovesciamento dei termini originari della questione. Il tentativo di risollevare le sorti della democrazia, avvelenata dalla parola retorica e sofistica dei demagoghi, e di risolvere il problema del riconoscimento del parresiastes è rappresentato dalla risposta socratico‐platonica, che parte dalla fine della parresia politica e compone una visione filosofica basata sulla centralità dell’epimeleia heautou (quella che, in latino, sarà la cura sui e, nel francese di Foucault, la souci de soi), la cura di sé. È Socrate colui 11
12
Ibidem. Nella variante attica, il doppio sigma viene sostituito dal doppio tau: si ha athuroglottos. 72
Paolo Bonari – La parola (com)promessa che spinge alla cura di sé. In Grecia, esisteva una pietra che poteva decretare l’autenticità dell’oro, il basanos: Socrate è un basanos. Infatti, attraverso l’interazione verbale, il confronto con le sue parole, il soggetto può conoscersi e riconoscersi, vedere la verità del proprio sé, decidere di cambiare la propria vita, convertirsi al bene. Si dà una forma, attraverso atti coraggiosi che lo plasmano e che fanno sì che il suo sé abbia la forma voluta: l’‘estetica dell’esistenza’ consiste nel fare di sé una statua, modellata e scolpita dall’atteggiamento parresiastico. Dire – e dirsi – la verità agisce su di noi, a mo’ di scalpello. Come fare, però, per sgombrare la piazza della polis dagli innumerevoli millantatori e sofisti, che sembrano gli unici padroni dell’epoca? La cura di sé viene indicata da Socrate quale fondamento imprescindibile nella formazione del buon cittadino e di colui che dovrà dedicarsi alla gestione del potere pubblico: governare se stessi è il passo necessario per arrivare al buon governo degli altri. La parresia si declina come pratica del dire la verità su se stessi, capacità che permette di decifrare il proprio sé e di controllarlo, al fine di poter giungere a dire la verità sugli altri e sul mondo, una volta conquistati ruoli di rilevanza politica. Emerge, allora, il legame tra la parresia e la cura di sé, i due pilastri della vita filosofica greca e della partecipazione all’attività politica: la prima è parte della seconda, che è un modo d’essere del soggetto nel quale c’è chi ha visto uno dei lasciti più profondi della civilizzazione europea13. Foucault, a partire dalla fine degli anni Settanta, si fece sempre più vicino ai dissidenti che, nell’Europa delle cosiddette ‘democrazie popolari’, cercavano di forzare le maglie di quei regimi, attraverso l’esempio offerto dalle proprie vite esemplari: vengono in mente i nomi del ceco Václav Havel e del polacco Adam Michnik. In Polonia, peraltro, non è da sottovalutare il ruolo decisivo della Chiesa cattolica locale, vero centro ideale e culturale delle agitazioni anti‐totalitarie. Al riguardo, è ancora da scrivere la storia filosofica di quello che appare come il conflitto più duro e duraturo del secolo, quello che ha opposto il diritto naturale, sostenuto dalla religione cristiana, al nichilismo giuridico propugnato dagli imperi totalitari. Attraverso il paradigma foucaultiano, appare oggi manifesto il carattere parresiastico delle lotte e delle vite di tanti dissidenti. Jan Patočka, organizzatore di corsi di filosofia clandestini e figura socratica quant’altre mai, morì dopo un estenuante interrogatorio delle autorità cecoslovacche. Soggetti legati alla verità, si trovavano a fronteggiare un potere dalle mille facce e sempre mutevole, camaleontico e meccanizzato: una terribile Idra di Lerna, una creazione inedita, in termini di zoologia politica. Ciò che caratterizzava tale forma epistemologica di dominio era il relativismo elevato a filosofia di governo, a ‘governamentalità’, per dirla con lessico foucaultiano. 3. AFFERRARE L’INFORME: COME DISTRUGGERE I MURI DI GOMMA Dalla politica metafisica del progetto hitleriano, condotta all’acme anti‐umana della distruzione finale degli ebrei d’Europa, al regime bolscevico, si può dire che ciò su cui si sono basati gli esperimenti totalitari è il loro tentativo di ri‐creare la realtà, di erigere, a futura 13
Penso, per esempio, a Jan Patočka, attivista anti‐totalitario e fenomenologo ceco. Non sia ingannevole il carattere spiritualistico delle culture asiatiche, orientali: in esse, sembra più corretto ravvisare una tendenza all’annullamento dei confini del soggetto, verso una fusione pacificatrice con l’oggetto. 73
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 testimonianza della grandezza del progetto originario, una vera e propria costruzione di realtà alternativa a quella visibile, presente e quotidiana. Ed è interessante studiare, in parallelo, le opposte fini dei due maggiori totalitarismi. Il primo, quello nazista, si estingue con un’accelerazione, fomentando gli ultimi fuochi della macchina infernale che era stata approntata per la ‘soluzione finale’ al problema ebraico, realizzando un’escalation di esecuzioni, di uccisioni seriali che sono e saranno un buco nero nella storia dell’uomo, un luogo nel tempo in cui non c’è spazio per la luce: Auschwitz. La grande macchina comunista avrà il tempo di entrare nella propria fase di declino e si trasformerà in qualcosa d’altro. Abdicando, per mancanza di forze ideologiche e per eccesso di ‘resistenza’ da parte della realtà, al progetto di sostituzione della stessa con una sua imitazione, in cui sfolgorassero le bandiere dell’Idea e nessun elemento fosse ulteriormente perfezionabile, giacché tutto era già finto e perfetto, optò per un’altra soluzione: fare cadere ogni certezza, distruggere qualsiasi possibilità di riferirsi a qualcosa che avesse a che fare con idee come la natura e la verità, impedire il discernere, il distinguere, che è alla base dell’ideale democratico. Soltanto in questi ultimi anni, sembra che il concetto di totalitarismo sia, infine, giunto a qualcosa che somigli alla sua serena accettazione, da parte della comunità accademica. Tuttavia, da ciò non segue che del fenomeno totalitario sia stato compreso il cuore pulsante, quello più inafferrabile e nascosto, perché non strettamente legato a componenti riconoscibili nel quadro dei tradizionali paradigmi della teoria politica. Infatti, è ben facilmente intuibile come, da questo punto di vista, la capacità scientifica di comprendere quanto sembrò andare oltre ogni immaginazione umana è ancora manifestamente inadeguata. Ciò verso cui sembrano tendere gli sforzi più significativi di oltrepassare una lettura dei totalitarismi considerata troppo aderente agli assiomi della scienza politica, in particolare nei suoi schemi più illuministici e razionalistici, necessita ancora di un nome, che può agevolmente essere coniato qui, senza timore di distaccarci troppo da una futura collocazione scientifico‐
accademica: si tratta di un’‘epistemologia politica’. Si pensi anche soltanto a quanto è significativo il fatto che, per primo, fu l’epistemologo Alexandre Koyré, nel 1943, ad affrontare la terribile attualità che si trovava di fronte attraverso categorie non direttamente mutuate dagli studi politici, ma da quelli a lui più prossimi. Il suo brevissimo testo14, ancora oggi semi‐
sconosciuto, costituisce il primo tassello, nella costruzione di un possibile approccio allo studio dei totalitarismi che adotti la denominazione da noi proposta. Dieci anni più tardi, fu Hannah Arendt15, sulle pagine di The Review of Politics, ad aggiungere altre preziose acquisizioni a quelle di Koyré. Il testo arendtiano confluirà nella seconda edizione de Le origini del totalitarismo, distaccandosi sensibilmente, però, dai restanti capitoli, più aderenti alla chiave di storia sociale e politica del fenomeno che fu scelta dall’autrice. In queste pagine, la filosofa sceglierà di focalizzarsi sulle caratteristiche più sfuggenti del totalitarismo, ovvero la sua essenza giuridica e lo studio di quei dispositivi di produzione della forma di dominio epistemologico sulla società e sulle menti dei cittadini‐sudditi. Un’ipotetica linea interpretativa che concorra a fondare una prospettiva di epistemologia politica deve, però, aspettare l’arrivo 14
A. Koyré, Riflessioni sulla menzogna politica, trad. it. e c. di B. Lumi, De Martinis & C., Catania 1994. 15
H. Arendt, Ideologia e terrore, in S. Forti (a cura di), La filosofia di fronte all’estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Einaudi, Torino 2004, pp. 43‐70. 74
Paolo Bonari – La parola (com)promessa dei contributi più determinanti dall’Europa dell’Est, nella quale molti dissidenti avevano già capito il funzionamento della macchina di dominio. E, quarant’anni dopo l’intuizione pionieristica di Koyré, sarà il polacco Kolakowski16, in un testo del 1983, a confermarla e a continuare l’indagine nella stessa direzione, approfondendo la peculiarità inedita della menzogna di tipo totalitario. Di che cosa si tratta? Vorremmo tirare le fila della nostra breve – ma densa – argomentazione, farle culminare in ciò che sembra legare le punte di relativismo nichilistico del dibattito contemporaneo a certe forme di ‘epistemologia di regime’, che erano in auge negli Stati totalitari. In un contesto in cui il potere decida di abolire l’idea stessa di verità, viene eliminata, al tempo tesso, anche ogni possibilità di criticare l’ordine esistente. Pier Paolo Pasolini, nel suo film Salò o le 120 giornate di Sodoma, cita una frase di De Sade che ben spiega il concetto: “La sola vera anarchia è quella del potere”. Riallacciandoci al discorso dei due filosofi statunitensi dai quali eravamo partiti, è illusorio pensare che il relativismo ‘al potere’ crei condizioni più liberali e sia più accomodante nei confronti delle istanze dei vari soggetti sociali. Storicamente, un esperimento di questo tipo è stato fatto non nelle democrazie occidentali, ma nei regimi totalitari, in particolar modo in quelli declinanti delle ‘democrazie popolari’. L’incapacità di distinguere tra vero e falso, il tentativo epistemologico di annullamento delle differenze e delle coscienze critiche sono stati gli strumenti che quei governanti utilizzarono al fine di mantenere il proprio dominio, per quanto in condizioni di evidente appannamento dell’ideologia originaria. L’unica arma resasi disponibile per i dissidenti, allora, fu la verità, che diventava rivoluzionaria e che operava ai fini di una sorta di ‘ri‐attivazione’ della realtà politica e del senso comune. In questo senso, vanno anche le ingiunzioni ai movimenti di critica dell’ordine esistente, che Foucault fece con sempre maggiore insistenza, di dimostrarsi più morali dell’immoralità del potere. La critica, insomma, non può che riposare su una qualche verità, che viene opposta agli arbitrii del potere. Senza la verità, non c’è la critica: nella nebbia elevata dai totalitarismi declinanti, invece, tutto è vero e tutto è falso. Di conseguenza, ogni sforzo di resistenza è vano. Taylor sembra intuire l’importanza del nesso che lega i due concetti, quando scrive che “questa relatività della verità di regime significa che noi non possiamo alzare la bandiera della verità contro il nostro stesso regime”17. Foucault, in maniera crescente nel corso degli anni, decise di affidare le proprie riflessioni alla forma dell’intervista, ritenendo che il metodo dialogico, quasi alla maniera platonica, fosse quello più utile alla produzione filosofica. Una delle più significative, riguardo al modo in cui l’ultimo Foucault guardava alla politica, è una che egli rilasciò nel maggio del 1984, poco prima di morire, nella quale espresse la propria sfiducia nei confronti della possibilità, nell’agone politico, di perseguire la verità18 e già questo può dirla lunga sulle possibilità di annessione del 16
L. Kolakowski, Il totalitarismo e la virtù della menzogna, in S. Forti (a cura di), La filosofia di fronte all’estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Einaudi, Torino, pp. 125‐139. 17
Ch. Taylor, Foucault on Freedom and Truth, in D. Couzens Hoy (ed.), Foucault: A Critical Reader, Blackwell, Oxford 1986, p. 94 (trad. mia). 18
M. Foucault, Polemica, politica e problematizzazioni, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978‐
1985: estetica dell’esistenza, etica, politica, a c. di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 240‐
247. 75
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 filosofo francese all’ampio novero dei relativisti. Questo testo, se fatto interagire con un pamphlet di Simone Weil, appena ripubblicato in italiano19, permette di rintracciare un filone di critica della politica contemporanea che non si configura direttamente come anti‐politica, bensì anti‐partitica – nel senso della costituzione storico‐empirica di queste forme di strutturazione politica –: in essa, si dà importanza a forme alternative di organizzazione politica del consenso che richiedano uno sforzo etico supplementare ai partecipanti e che non conducano all’oblio di sé. La capacità ideologica di deformazione e ricreazione della realtà, operata dai totalitarismi, ma attiva anche nel dibattito contemporaneo, contagiato dagli effluvi sprigionati dall’implosione degli stessi, necessita di una resistenza che si fondi su una ‘critica della critica’, di stampo etico e che può costituire un terreno d’incontro per tradizioni variegate e, non di rado, conflittuali, quali quelle delle filosofie morali e politiche d’ispirazione analitica e le altre, provenienti da territori europei e più attente all’evoluzione storica delle filosofie del dominio. Oggi, come dopo la morte di Pericle, però, compito primario dell’intellettuale e del filosofo è di scoprire e rinnovare la propria capacità ‘diacritica’. Nella nebbia, quando si incontra qualcuno, non si può che fare quel qualcosa che ci spetta: riconoscere e smascherare. Paolo Bonari Bibliografia 1. Arendt, H. (2004), Ideologia e terrore, in S. Forti (a cura di), La filosofia di fronte all’estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Einaudi, Torino, pp. 43‐70. 2. Butler, J. (2006), Critica della violenza etica, trad. it. di F. Rahola, Feltrinelli, Milano. 3. Di Marco, C. (1999), Critica e cura di sé. L’etica di Michel Foucault, FrancoAngeli, Milano. 4. Flynn, T. (1988), Foucault as Parrhesiast: His Last Course at the Collège de France (1984), in J. Bernauer and D. Rasmussen (eds.), The Final Foucault, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 102‐118. 5. Foucault, M. (1996), Discorso e verità nella Grecia antica, a c. di A. Galeotti, Donzelli, Roma. – (1997), Illuminismo e critica, a c. di P. Napoli, Donzelli, Roma. – (1998a), Il ritorno della morale, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978‐1985: estetica dell’esistenza, etica, politica, a c. di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano, pp. 262‐272. – (1998b), La filosofia analitica della politica, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978‐1985: estetica dell’esistenza, etica, politica, a c. di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano, pp. 98‐113. – (1998c), La follia e la società, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978‐
1985: estetica dell’esistenza, etica, politica, a c. di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano, pp. 64‐84. 19
S. Weil, Manifesto per la soppressione dei partiti politici, trad. it. di F. Regattin, Castelvecchi, Roma 2008. 76
Paolo Bonari – La parola (com)promessa –
(1998d), L’etica della cura di sé come pratica della libertà, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978‐1985: estetica dell’esistenza, etica, politica, a c. di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano, pp. 273‐294. – (1998e), Polemica, politica e problematizzazioni, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978‐1985: estetica dell’esistenza, etica, politica, a c. di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano, pp. 240‐247. – (2001a), La cura della verità, in Id., Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969‐1984, a c. di M. Bertani, Einaudi, Torino, pp. 333‐346. – (2001b), Un’estetica dell’esistenza, in Id., Biopolitica e liberalismo. Detti e scritti su potere ed etica 1975‐1984, a c. di O. Marzocca, Medusa, Milano, pp. 205‐213. – (2003), L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981‐1982), ed. stabilita da F. Gros, Feltrinelli, Milano. – (2008), Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France (1982‐1983), édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros, Seuil / Gallimard, Paris. 6. Kolakowski, L. (2004), Il totalitarismo e la virtù della menzogna, in S. Forti (a cura di), La filosofia di fronte all’estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Einaudi, Torino, pp. 125‐139. 7. Koyré, A. (1994), Riflessioni sulla menzogna politica, trad. it. e c. di B. Lumi, De Martinis & C., Catania. 8. Lynch, M. P. (2007), La verità e i suoi nemici, ed. it. a c. di S. Moriggi, trad. it. di S. Fortuna, Raffaelle Cortina, Milano. 9. McGushin (2007), Foucault’s Askēsis. An Introduction to the Philosophical Life, Northwestern University Press, Evanston, IL. 10. Napoli, P. (2004), L’ultimo Foucault tra cura socratica e libertà, in E. Lojacono (a cura di), Socrate in Occidente, Le Monnier Università, Firenze, pp. 258‐280. 11. Taylor, Ch. (1986), Foucault on Freedom and Truth, in D. Couzens Hoy (ed.), Foucault: A Critical Reader, Blackwell, Oxford, pp. 69‐102. – (2004), La topografia morale del sé, a c. di A. Pirni, ETS, Pisa. 12. Weil, S. (2008), Manifesto per la soppressione dei partiti politici, trad. it. di F. Regattin, Castelvecchi, Roma. 13. Williams, B. (2005), Genealogia della verità. Storia e virtù del dire il vero, trad. it. di G. Pellegrino, Fazi, Roma.
77
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 78
Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler Stefano Liccioli [email protected] Abstract
In this article the following questions have been addressed: does a unifying point exist in Scheler’s
philosophy? Who is Man? The author argues that Scheler defines man as person. A person is a
unifying centre of actions: he interacts with other people and with God. Also God is person and
man has a constitutive relation with Him.
Keywords: Max Scheler, man, person, community, God.
Premessa Scrive Hans‐Georg Gadamer: Può sembrare incredibile, eppure se oggi si interroga un giovane o anche un anziano, interessato alla filosofia, si scopre che non sa chi sia Max Scheler. Vi potrà dire molto vagamente che egli era un pensatore cattolico, autore di un’importante etica materiale dei valori, e apparteneva al movimento fenomenologico che aveva in Husserl il suo fondatore e in Heidegger, right or wrong, il suo continuatore. In ogni caso, la coscienza filosofica contemporanea non riserva a Scheler una presenza paragonabile a quella di Husserl o Heidegger. Come mai? Chi era realmente Max Scheler1? Personalmente ritengo che l’analisi di Gadamer sia appropriata: è indubbio infatti che tra i filosofi la conoscenza di Max Scheler sia piuttosto approssimativa. Invece, leggendo i suoi scritti, ci si rende conto che questa scarsa fama di cui gode è immeritata. Il pensiero di Scheler offre oggi come allora delle intuizioni originali, che a volte rimangono ‘in nuce’, non vengono sviluppate in modo adeguato, ma sono ugualmente importanti per chi vuol comprendere a pieno il quadro della filosofia tedesca ed europea all’inizio del Novecento. Anche la critica è piuttosto concorde nel riconoscere la grandezza intellettuale di Scheler. Basta pensare ad Arnold Gehlen che considera fondamentale per la storia dell’antropologia filosofica l’opera scheleriana Die Stellung des Menschen im Kosmos: «Tutti gli scritti contemporanei e posteriori nell’antropologia filosofica che abbiano in un qualche modo un valore, sono dipesi nei loro punti principali da questo scritto, e così rimarranno le cose»2. Se è davvero così, come mai i filosofi sembrano non aver riservato molta attenzione per Scheler? A mio parere, la ragione principale è il modo con cui il filosofo espone le proprie idee: il suo stile di filosofare 1
Hans Georg Gadamer, Philosophische Lehrjahre: eine Rückschau, Frankfurt am Main, Klostermann, 1977 [tr. it. Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo, Brescia, Queriniana, 1980, p. 56]. 2
Arnold Gehlen, Philosophische Anthropologie und Handlungslehre (= Gesamtausgabe 4), Frankfurt am Main, Klostermann, 1983 [tr. it. Antropologia filosofica e teoria dell'azione, Napoli, Guida, 1990, p. 309]. 79
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 non è molto sistematico, a momenti «appare arruffato e irrituale, ma sempre partecipe e appassionato»3. A tal proposito mi sembra piuttosto adeguata la descrizione che Nicolai Hartmann fa di Scheler nel necrologio in suo onore: «Egli non era un costruttore di sistemi, anche se tutto ciò che egli affrontava prendeva, sotto le sue mani, forma sistematica. Non aveva nessuna simpatia per coloro che partendo da una tesi, sia pure ben fondata, ne traggono comodamente le conseguenze senza rivederne essi stessi continuamente i fondamenti. Egli era fondamentalmente un pensatore di problemi»4. Anche Bobbio è più o meno dello stesso parere ed afferma che Scheler non è mai uno scrittore sistematico, anche quando, come nell’Etica e nei Problemi della Religione, tenta il sistema; è caratteristico che tutte le sue opere tranne l’Etica e qualche altra secondaria, siano raccolte di saggi messi insieme con intenzioni giustificative talvolta assai deboli. Ma anche l’Etica è opera tutt’altro che organica; già nel titolo e nel sottotitolo [Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus], rivela le due parti diverse di cui è costituita, e che, essendo composte in tempi diversi e con diversi oggetti, appaiono, riunite in un sol volume, più accostate che fuse […]. Egli è essenzialmente un ricercatore, la cui ricerca è mossa da un profondo interesse per i problemi morali5. C’è anche un altro motivo che impedisce a Scheler di avere una giusta considerazione: nel corso della sua vita egli ha cambiato frequentemente idea su alcuni grandi temi come l’uomo, Dio, la società. Questa mutevolezza non ha certo favorito l’interesse verso di lui, perché chi lo affronta sa di trovarsi su un terreno insidioso; infatti bisogna stare attenti a fare affermazioni nette e definitive sulle varie teorie di Scheler perché potrebbero essere smentite da alcuni suoi successivi ripensamenti. Il cammino filosofico di Scheler si può suddividere in tre momenti. Il primo è quello formativo in cui egli entra in contatto con vari pensatori (Eucken e Husserl, per citarne due) che poi lo influenzeranno nell’elaborazione delle sue concezioni filosofiche. Il secondo periodo è definito cattolico, teistico e personalistico ed è compreso tra il 1915 circa e il 1922, anche se l’annuncio ufficiale dell’abbandono del teismo fu dato nella conferenza del 17 gennaio 1925 presso la Lessing‐Hochschule di Berlino. La terza e ultima fase, chiamata panenteistica, viene fatta coincidere con gli anni che vanno dal 1922 circa all’anno della morte del filosofo (1928). Come tutte le suddivisioni cronologiche, anche questa non pretende di essere rigorosa e definitiva in maniera assoluta: è solo un modo per indicare che in alcuni anni la riflessione scheleriana ha determinati contenuti che, in altri momenti, vengono ripensati e modificati, a volte anche 3
Bruno Accarino, Tra libertà e decisione: alle origini dell’antropologia filosofica, in AA. VV, Ratio imaginis: uomo e mondo nell'antropologia filosofica, a cura di Bruno Accarino, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, p. 7. 4
Nicolai Hartmann, Max Scheler, in «Kantstuiden», XXXIII (1928) 1/2, p. XV. Cfr. anche Giovanni Ferretti, Scheler (Introduzione bibliografica e antologica), in AA. VV., Questioni di storiografia filosofica, a cura di A. Bausola, 4/1, Brescia, La Scuola, 1978, pp. 93‐120. 5
Norberto Bobbio, La personalità di Max Scheler, in «Rivista di filosofia» XXIX (1938) 2, p. 98. La mancanza di sistematicità nel pensiero di Scheler dipende anche dalla sua idea di filosofia: «La filosofia è qualcosa come il tirare dei burattini con i fili» (H. G. Gadamer, Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo, cit. p. 58). In questa ottica la filosofia sembra consistere nel dare degli stimoli, degli impulsi come quando si tirano dei fili: non c’è un metodo preciso e sistematico. Su questo tema Cesare Luporini osserva che l’unità dell’opera di Scheler è soprattutto «un’unità di temperamento, in cui emergono soprattutto gli interessi vitali del moralista e la preoccupazione religiosa e nell’appariscente varietà e tumultuosità dei problemi da lui toccati […] è facile riscontrare una direttiva costante segnata da questa doppia esigenza» (Cesare Luporini, Filosofi vecchi e nuovi: Scheler, Hegel, Kant, Fichte, Leopardi, I, Firenze, G. C. Sansoni, 1947, p. 4). 80 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler radicalmente. D’altra parte è importante «non chiudere Scheler in gabbie cronologiche»6, non considerare il suo pensiero come diviso in “contenitori” che non comunicano fra di loro. Infatti sia nella seconda che nella terza fase del pensiero scheleriano ci sono alcuni motivi speculativi che rimangono costanti. Ad esempio al di là delle loro differenze, il teismo e il panenteismo condividono questa identica condizione di base: la realtà suprema è lo ‘spirito’, caratterizzato da efficacia causale e produttiva; inoltre in questi suoi due periodi Scheler sostiene che la persona, grazie allo ‘spirito’ che la anima, non possa essere né oggettivata né conosciuta oggettivamente. Un altro esempio ci è offerto dalla riflessione del filosofo sull’amore: amare Dio significa partecipare al suo stesso atto di amore per tutte le creature, ciò comporta amare in lui tutte le creature; questa tematica dello ‘amare mundum in Deo’ è presentata all’incirca negli stessi termini sia nello scritto Liebe und Erkenntnis del 1915 sia in quello intitolato Die Stellung des Menschen im Kosmos del 1928. L’ultimo e, a mio parere, più importante tema che rimane costante nel corso della filosofia scheleriana è la riflessione sull’uomo. In questo ultimo caso non è tanto il contenuto della riflessione a restare identico (che anzi, cambia notevolmente), quanto il fatto che il filosofo durante tutta la sua vita si è sempre preoccupato di che cosa fosse l’uomo. In questo senso mi sembra esemplare ciò che scrive Scheler nel 1928: Fin dal primo destarsi della mia coscienza filosofica domande come Che cos’è l’uomo? e Qual è la sua posizione nell’essere? mi hanno coinvolto più intensamente e ampiamente di qualsiasi altra questione filosofica. I lunghi anni di lavoro, dedicati a considerare questo problema sotto ogni punto di vista, si sono concretizzati in un’opera dedicata a questo argomento, ed è con gioia crescente che ho potuto constatare 7
come in essa venissero a convergere la maggior parte dei problemi filosofici che avevo trattato . Anche se non è esplicitamente detto, mi sembra chiaro che capire quale sia la posizione dell’uomo nell’essere, vuol dire anche capire quale sia il rapporto dell’individuo con l’essere. In questa sede cercherò proprio di mettere in luce la visione dell’uomo secondo Scheler, ritenendolo un tema fondamentale in quanto unifica tutte le riflessioni del filosofo: «Alla base, ciò che guidò tutta la vita per i suoi intricati sentieri fu un unico problema: il problema dell’uomo. Psicologia e metafisica, gnoseologia e sociologia, etica e ontologia, tutto lo fece convergere in un unico oggetto, il più lontano e al tempo stesso il più vicino»8. Nell’affrontare questo argomento mi limiterò alla fase teistica sia per dovere di sintesi sia perché dovendo prendere in considerazione questo uomo aperto costitutivamente all’essere (che in questo periodo possiamo chiamare Dio), mi sembra più sensato concentrarmi in un momento in cui i due poli della relazione sono ben distinti e dove è piuttosto chiaro anche il nesso fra questi due elementi. D’altra parte nell’ultima fase, quando Dio è in tutto, come fare a distinguere dove finisce l’uomo e dove invece inizia il divino? Il nostro filosofo, per risolvere 6
Roberto Racinaro, Il futuro della memoria: filosofia e mondo storico tra Hegel e Scheler, Napoli, Guida, 1985, p. 246. 7
Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, IX, Späte Schriften, Bern, Francke, 1976 [Tr. it. La posizione dell’uomo nel cosmo, Milano, Franco Angeli, 2000], p. 9 [73]. Nel corso di questo lavoro, le citazioni tratte da tutte le opere di Scheler, sono indicate con le pagine delle Gesammelte Werke e, tra parentesi quadra, con quelle corrispondenti alla traduzione italiana segnalata (ove presente). 8
Hartmann, Max Scheler, p. XVI. 81
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 questi problemi, ha dato alcune indicazioni, ma, a mio avviso, sono incomplete, anche perché la sua morte ha interrotto ulteriori sviluppi ed elaborazioni. Max Scheler viene considerato un grande moralista, ma, grazie a queste sue riflessioni sull’uomo, su Dio e sulla loro relazione, ha dato il proprio contributo anche allo sviluppo della filosofia della religione. Sebbene sia interessante, non è questo il luogo per valutare l’entità di tale apporto né quanto possa aver influenzato le correnti teologiche a lui contemporanee. Scheler, com’è nel suo stile, non affronta in maniera sistematica il problema della filosofia della religione, ma fa vari accenni, più o meno ampi, in diversi suoi scritti. Alcune indicazioni esplicite sono già rintracciabili nella sua monumentale opera Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik in cui, ad esempio, vengono teorizzati alcuni temi che offrono spunti di filosofia della religione: l’assiologia con al vertice i valori religiosi, l’antropologia che vede la natura specifica dell’uomo alla luce dell’idea di Dio, il personalismo metafisico che considera l’idea di Dio come fondamento di ogni persona sia individuale che comunitaria. In Vom Ewigen im Menschen, dove gli spunti di filosofia della religione sono più sistematici, Scheler sostiene che la disciplina filosofica fondamentale circa la religione, è la fenomenologia essenziale (Wesensphänomenologie). Questo metodo, a suo parere, permette di cogliere, attraverso l’intuizione eidetica9, i significati essenziali delle esperienze umane concrete. In sostanza il nostro filosofo ci vuol dire che, cercando il posto della religione nella struttura della ragione umana, la filosofia deve mostrare il fondamento, ma anche il presupposto della religione nello spirito umano, cioè quella originaria tensione amorosa verso l’assoluto che costituisce metafisicamente ogni persona. Uno degli aspetti più importanti del pensiero di Scheler è proprio questa idea secondo cui il rapporto Uomo – Dio non è fra due entità qualsiasi, ma fra due persone. Però questo incontro con la realtà divina può avvenire soltanto grazie a quegli atti religiosi specifici con cui si accoglie la rivelazione di Dio, da parte sua la filosofia si ferma prima. Infatti studiando da un punto di vista essenziale la natura degli atti religiosi, la fenomenologia non può sostituirli nel cogliere la realtà dell’oggetto religioso: la filosofia può solo indicare la natura della via con cui si giunge alla partecipazione all’assoluto, ma non può mai giungervi autonomamente. In conclusione la soluzione di Scheler permette di costruire una filosofia della religione che salvaguarda la peculiarità e l’indipendenza del fenomeno religioso, ma allo stesso tempo è capace di affrontare il problema della sua fondazione. Con il presente lavoro non ho certo la pretesa di rendere giustizia a Scheler: mi preme però mettere in luce la grande pregnanza di alcune sue tesi filosofiche, come quelle elaborate sul problema dell’uomo. D’altra parte, come si può trascurare l’acutezza di certe sue osservazioni che difficilmente si appiattiscono su luoghi comuni, su affermazioni già fatte? Ritengo che troppo spesso le tormentate vicende biografiche di Scheler e il suo carattere volubile, il quale si è riflesso anche nel suo modo di filosofare, abbiano in parte oscurato la sua grandezza intellettuale, impedendogli di essere considerato meritatamente uno dei più grandi pensatori del Novecento. 9
È questo un tema in cui Scheler è debitore alla fenomenologia di Husserl: il primo considera l’intuizione eidetica, un’astrazione ideante, un modo unico per accedere all’essenza costitutiva del mondo. 82 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler 1. SULL’IDEA DELL’UOMO «In un certo senso tutti i problemi fondamentali della filosofia si possono ricondurre alla domanda che cosa sia l’uomo e quale posto e posizione metafisica egli occupi entro la totalità dell’essere, del mondo, di Dio»10. Come testimoniano queste parole tratte dal saggio Zur Idee des Menschen, Scheler, già nel 1915, afferma che nella filosofia il problema dell’uomo e del posto che occupa nel mondo ha un ruolo centrale. In questo stesso anno il filosofo si era convertito per la seconda volta al cattolicesimo, ma l’importanza che egli attribuisce al tema dell’uomo va al di là della sua credenza religiosa; infatti il passo con cui ho chiuso il capitolo precedente e che rivendica anch’esso l’importanza del problema dell’uomo, è del 1927, quando ormai Scheler ha abbandonato da tempo la fede cristiana. Se dunque vogliamo trovare le prove di una certa sistematicità nel pensiero scheleriano, la riflessione sull’uomo può essere una: essa è una costante nel corso degli scritti del nostro autore. Come sostiene Nicolai Hartmann11, il centro unificatore della filosofia scheleriana è il problema dell’uomo. Prendendo in considerazione attentamente Zur Idee des Menschen possiamo evincere quale sia per Scheler la vera costituzione dell’essere umano: esso è “ripiegato” in se stesso oppure è aperto ad una dimensione trascendente, ad un Oltre? È la domanda a cui dobbiamo rispondere per capire se il rapporto con Dio è un rapporto essenziale, costitutivo per l’uomo oppure è una relazione qualsiasi, non necessaria. Prima di risolvere questo problema, ritengo doveroso illustrare le principali questioni toccate da Scheler nel suo saggio. Prima di tutto egli afferma che le definizioni dell’uomo che sono state date nel corso dei secoli, sono parziali ed insoddisfacenti. Infatti, a suo avviso, non è esauriente dire, secondo la teoria classica greca, che l’uomo è un animale razionale, valutando esclusivamente la sua capacità contemplativa e trascurando la struttura corporea specifica che fonda il suo comportamento pratico; ma è altrettanto insoddisfacente sottolineare esclusivamente l’elemento corporeo, definendo l’uomo solo in base a ciò che sa fare, come ‘homo faber’. Positivisti e pragmatisti sono gli esponenti di questa posizione. Scheler non specifica a chi si riferisca in particolare, quindi è lecito pensare che abbia in mente il positivismo ed il pragmatismo in generale e non qualche corrente precisa. Queste teorie filosofiche sostengono che l’uomo non è più l’animale contraddistinto dalla ragione, ma l’animale che sa parlare e fabbricare strumenti. Per Scheler, questa continuità tra animali e uomini che i positivisti ed i pragmatisti sostengono, si basa sul fraintendimento della natura della ‘parola’ e dello ‘strumento’. Infatti, per quanto riguarda la parola e il linguaggio, il filosofo pensa che gli animali esprimano, attraverso suoni e gesti, un’esperienza vissuta, un sentimento (es. il dolore, la paura…). Non si può pensare però che la parola ed il linguaggio umano sorgano per semplice evoluzione di questi sistemi di espressione delle bestie, dato che fra i primi ed i secondi esiste una profonda differenza qualitativa. La voce, o meglio il suono espressivo degli animali, ben diverso da un 10
Max Scheler, Zur Idee des Menschen, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, III, Vom Umsturz der Werte, Bern, Francke, 1955; tr. it. Sull’idea dell’uomo in La posizione dell’uomo nel cosmo ed altri saggi, Fabbri, Milano, 1970, p. 176 [100]. 11
Hartmann, Max Scheler, p. XV. 83
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 mero rumore, esprime il sentimento che l’animale prova, il suo vissuto; la parola invece ci rimanda, di per se stessa, ad un oggetto del mondo. Essa indica qualcosa, che non s’identifica né con l’elemento corporeo del suo suono, né con l’esperienza vissuta di un sentimento che il soggetto potrebbe manifestare con un’esclamazione. La parola può ‘intendere’ il vissuto interiore di chi parla, ma lo fa in modo diverso da una semplice espressione; infatti un conto è gridare ‘ahi’, altro è dire ‘io sento un dolore’. L’intenzionalità propria della parola distingue sostanzialmente la comunicazione umana dal semplice contagio psichico dei sentimenti, che può aver luogo anche fra gli animali quando ad esempio un cane abbaia ed anche altri cani vicini cominciano ad abbaiare. Scheler afferma che comprendere ciò che uno dice con parole equivale ad intuire ciò che tali parole intendono, ad esempio il fatto che ‘oggi il sole splende’12. Questa concezione della parola, che vede nell’intenzionalità la sua natura specifica, serve al filosofo per non cadere nel nominalismo che erra nell’identificare la parola con il nome, e il nome con un semplice segno convenzionale di una o più cose. «L’essenza, il nucleo della parola sono per l’appunto costituiti da quel passaggio, che si verifica nell’Erlebnis, da suono a significato, e questi fungono esclusivamente da punto di partenza e di arrivo per un movimento intenzionale dello spirito»13. Senza la parola, sarebbe impossibile costituire le convenzioni che stanno alla base degli altri segni e dei nomi. In questa ottica non ha senso indagare sull’origine storica della parola, come non vale la pena ricorrere alla capacità anatomica e fisiologica di formare “suoni articolati” per spiegare la capacità umana di parlare, perché «la parola è un fenomeno originario», nato con l’uomo stesso. Per sintetizzare la sua posizione, Scheler usa un’espressione di W. Von Humboldt che recita così: «L’uomo esiste solo in virtù del linguaggio; nondimeno, per inventare il linguaggio egli doveva già esser uomo»14. Grazie al concetto d’intenzionalità, proprio di tutto il movimento fenomenologico, Scheler analizza la specificità della parola umana, che il naturalismo dei positivisti e dei pragmatisti, aveva completamente perso, fraintendendo in tal modo radicalmente anche la natura stessa dell’uomo15. L’altro fraintendimento imputato ai positivisti ed i pragmatisti, riguarda la interpretazione dello ‘strumento’. È significativo rilevare che anche in questo caso Scheler usa il concetto d’intenzionalità per analizzare fenomenologicamente lo ‘strumento’. A suo parere, una cosa è resa strumento non dall’uso che se ne fa per conseguire un certo scopo, come possono fare anche gli animali usando occasionalmente degli oggetti esterni come mezzi per soddisfare meglio certe necessità biologiche; bensì l’utensile è tale in base al significato unitario imposto ad una data materia dall’azione dell’uomo. È importante osservare che questo significato 12
Per completezza espositiva aggiungo che nell’ottica scheleriana comprendere ciò che uno dice con parole equivale ad intuire ciò che tali parole intendono, ad esempio il fatto che “oggi il sole splende”; non si tratta di un giudizio dato per contagio psichico, ma non vuol dire neanche cogliere che “X dice che oggi è bel tempo”, riferendosi così solamente all’atto del soggetto che esprime il giudizio. Intendersi fra persone, comprendere una persona, non vuol dire farla oggetto della mia conoscenza, ma capire, appunto, ciò che essa dice. Cfr. M. Scheler, Zur Idee des Menschen, cit., p. 180 [103]. 13
È interessante notare come contro il nominalismo Scheler sostenga che, mentre nel segno la percezione dell’elemento sensibile materiale è separata dalla comprensione del significato, che il segno solo per convenzione indica, nella parola invece si presenta a noi una realtà significante semplice, unitaria, in cui solo una analisi riflessa può dividere l’elemento acustico da quello significante. Cfr. M. Scheler, Zur Idee des Menschen, cit., p. 180 [103]. 14
M. Scheler, Zur Idee des Menschen, cit. p. 182 [106]. 15
G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, I, Milano, Vita e Pensiero, 1972, p. 107. 84 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler trascende ogni uso occasionale dello strumento così che esso si colloca quasi sul piano di un’opera d’arte che ha senso in se stessa, indipendentemente da ogni finalità biologica. Per chiarire questa idea Scheler usa questo esempio: «Se io uso una chiave come battente di porta, la chiave rimane chiave, e non diventa battente di porta»16. Inoltre, l’intenzionare i significati oggettivi unitari, che sono così indipendenti dalla contingenza delle esigenze vitali, è ciò che caratterizza lo spirito. Esso dunque si rivela in atto nell’uomo, già nel fabbricare strumenti, come qualcosa che lo distingue essenzialmente dall’animale. L’altra obiezione importante che il nostro filosofo rivolge alla teoria dei positivisti riguarda lo strumento considerato dal mero punto di vista della sua funzionalità biologica: in esso vedono una tappa propria dell’evolversi progressivo della vita, che arriverebbe nello ‘homo faber’ a formarsi, con gli strumenti, quasi dei nuovi organi per l’azione. Scheler invece pensa che se lo strumento è considerato esclusivamente dal punto di vista biologico, esso non è il frutto di un progresso, bensì di una deficienza vitale, della mancanza di organi adatti alla vita17. Perciò l’intelletto, considerato come ‘capacità di fabbricare’, non è il culmine dell’evoluzione vitale, bensì un segno di ristagno della vita, un surrogato dell’istinto che è venuto a mancare, il quale è capace di risolvere i problemi vitali in modo più immediato che non l’intelletto18; ovviamente anche l’intelletto può sbagliare, ma solo in casi rarissimi e per lo più in seguito a un intervento voluto dall’uomo. In questa visione mi sembra sia evidente l’influsso della lezione di Nietzsche, anche se questi, secondo Scheler, ha sbagliato ad accettare il presupposto positivistico che considera l’intelletto come la caratteristica specifica dell’uomo, invece di ritenere l’individuo dotato di intelletto e di strumenti, «come un animale costituzionalmente malato, nel quale la vita ha fatto un faux pas e che si è smarrito in un vicolo cieco»19. Ho voluto fare una breve rassegna di queste concezioni dell’essere umano, per mettere in luce l’originalità della posizione scheleriana riguardo il problema dell’individuo, posizione che non è assolutamente appiattita su altre teorie antropologiche. Scheler afferma che dal punto di vista 16
In questa ottica emerge con evidenza, a mio parere, che solo secondariamente lo strumento è tale in relazione al fine biologico contingente per cui è usato. Quando viene costruito lo strumento si deve vedere all’opera quella stessa “forza spirituale” che agisce nella costruzione della cultura spirituale, con una differenza però: nella formazione di strumenti tale forza spirituale si pone liberamente al servizio del soddisfacimento di necessità biologiche, mentre nella formazione delle opere culturali, se ne mantiene totalmente libera. Cfr. M. Scheler, Zur Idee des Menschen, cit., p. 182 [106]. 17
Questa idea di Scheler richiama in un certo senso quella di Kant secondo cui la natura ha lasciato un vuoto nell’uomo, «la natura ha voluto che l’uomo traesse interamente da se stesso tutto ciò che va oltre la costituzione meccanica della sua esistenza animale e che non partecipasse ad altra felicità o perfezione se non a quella che egli stesso, libero da istinti si crea con la propria ragione» (Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinem Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784; tr. it. Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Torino, UTET, 1965, p. 126). La visione di Scheler si oppone anche a quella di Marx il quale vede la produzione degli strumenti come un progresso dell’uomo (Karl Marx, Die Deutsche Ideologie…, Frankfurt am Main ‐ Moskau, 1932; L' ideologia tedesca…, Roma, Editori Riuniti, 1967, p. 8). 18
Ferretti sostiene che “Scheler fin da questo saggio, fa propria la concezione bergsoniana dell’intelletto come facoltà dell’homo faber, distinguendolo nettamente sia dallo spirito che dall’istinto. Mentre però in questo saggio l’attività spirituale dell’uomo appare nell’esercizio stesso delle attività biologiche, e l’istinto è visto perfino come una forma dello spirito, in seguito Scheler, soprattutto nell’ultimo periodo della sua filosofia, distinguerà e contrapporrà più nettamente spirito da un lato e intelletto e istinto, biologicamente condizionati, dall’altro” (G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, cit., p. 115). 19
M. Scheler, Zur Idee des Menschen, cit., p. 185 [109]. 85
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 biologico, non si può definire l’uomo in modo specifico e neppure individuarlo come specie animale unitaria; in accordo con la teoria evoluzionistica l’animale e l’uomo formano un continuo, per cui una distinzione tra l’uno e l’altro, che si fonda sulle qualità naturali, rappresenta un taglio arbitrario operato da noi20. Il nostro filosofo contrappone alla concezione naturalistica dell’uomo, a cui anche Nietzsche era rimasto legato, una visione decisamente spiritualista e personalista. La peculiare natura dell’uomo non è nell’ambito del vitale, ma nel suo trascendere il vitale. «L’animale malato, l’animale intelligente e capace di costruirsi degli utensili diviene subito magnifico, grande e nobile, quando si consideri la sua possibilità di trasformarsi in un essere che trascende ogni forma di vita»21. L’uomo è l’essere che, pur attraverso attività biologicamente finalizzate, come la fabbricazione di strumenti, trascende ogni forma di vita22 e se stesso in quanto semplice vita. Per chiarire questo concetto, sono illuminanti le parole di Scheler: L’uomo […] è l’intenzione e il gesto della trascendenza stessa, l’essere che prega e cerca Dio. Anzi l’uomo non prega, egli è la preghiera che la vita eleva al di sopra di se stessa; non cerca Dio, egli è quello X vivente, che Dio cerca! E tutto ciò, esattamente nella misura in cui il suo intelletto, i suoi utensili e le sue macchine sono in grado di garantirgli un ozio libero per contemplare e amare Dio. Dunque ciò che può giustificare il suo intelletto e l’opera di questo, la civilizzazione, è solo il fatto che essi rendano sempre più permeabile il suo essere a quello spirito e a quello amore che, in tutti i loro moti e in tutti i loro atti, si orientano come i segmenti di un unico arco verso qualcosa che si chiama Dio. Dio è il mare, essi sono i fiumi: e fin dalla loro 23
sorgente i fiumi presentono il mare verso cui corrono . Inoltre Scheler sostiene che sia impossibile trovare per l’uomo una fissa stazione fra la vita e Dio, per definirlo in se stesso. All’essenza dell’uomo appartiene l’indefinibilità: «Questi è solo un infra, una frontiera, un passaggio, un apparire di Dio nel corso della vita, e una eterna trascendenza della vita oltre se stessa»24. Il passaggio è appunto tra il regno inferiore a lui e quello a lui superiore, il regno di Dio25: l’esistenza dell’uomo è proprio questo ‘trapasso’ dall’uno all’altro regno, un ‘ponte’, un movimento tra di essi; «e l’uomo non può ‐ come intuì Pascal – sottrarsi all’alternativa di far parte dell’uno o dell’altro. Perché persino la non decisione si configura come decisione di essere un animale, e, come tale… un animale degenerato. Il fuoco, la passione di trascendersi ‐ si chiami la meta, superuomo o Dio ‐ costituisce l’unica sua vera umanità»26. Condivido la lettura di chi pensa che questa descrizione fatta da Scheler ha chiari accenti nietzscheani27. Ma al superuomo, scopo intenzionale della trascendenza nietzschiana 20
Ivi, p. 193 [118]. Ivi, p. 185 [109]. 22
Anche in Der Formalismus, Scheler sostiene che “l’autentica definizione essenziale dell’uomo è: egli è una cosa che trascende se stessa e la propria vita ed ogni vita” (Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, II, Bern, Francke, 1954; tr. it. Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, Torino, Edizioni San Paolo, 1996, cit., p. 293 [357]). 23
Ivi, p. 186 [110]. 24
Ibidem (Corsivi miei). 25
Cfr. M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 293 [357]. Anche qui Scheler afferma che l’uomo è la tendenza, il punto di passaggio verso l’ambito del divino. 26
M. Scheler, Zur Idee des Menschen, cit., p. 195 [120] (Corsivi miei). 27
In Fenomenologia e antropologia personalistica (in Max Scheler, cit., p. 117) Ferretti mette a confronto questa descrizione di Scheler con quella fatta da Nietzsche in, Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Kein, Chemnitz, Schmeitzner, 1883 sgg. [tr. it. Così parlò Zarathustra, Milano, Adelphi, 1991, p. 8]: «L’uomo è un cavo teso tra la 21
86 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler dell’uomo sulla vita, Scheler sostituisce Dio, la persona infinitamente perfetta. È proprio la tensione a questa Persona che caratterizza ogni cultura spirituale, tanto che si può considerare Dio come la «radice di ogni cultura» nell’uomo e, dunque, di tutti quegli atti spirituali intenzionali che una considerazione meramente naturalistica dell’uomo non può spiegare e che, invece, costituiscono l’uomo come persona. Degna di nota è questa affermazione di Scheler: «Pertanto, tra le convinzioni più sciocche dei pensatori moderni c’è quella che l’idea di Dio sia antropomorfica. Cosa che appare tanto più falsa, quanto più si riflette sul fatto che l’unica idea dell’uomo che abbia senso è precisamente quella teo‐morfica di un X che sia immagine finita e vivente di Dio, una sua analogia, una delle sue innumerevoli ombre sul grande sfondo dell’essere»28. Quindi: «L’idea di persona applicata a Dio non è dunque l’espressione di un antropomorfismo! Dio è piuttosto l’unica persona perfetta e pura, mentre quel quid che può chiamarsi col nome di uomo è solamente una persona imperfetta e analogicamente intesa»29. Solo in virtù di questo Fondamento, di questa persona perfetta, l’uomo acquista una sua unità, relativa al pensiero, alla coscienza e al sentimento, nonostante i dati delle scienze naturali, non dimostrino alcuna unità specifica nell’uomo. Per Scheler questo fatto costituisce la prova rigorosa che la nostra idea di unità non si fonda affatto sulla struttura naturale dell’uomo, inteso come un tutto unico, ma che il fondamento ultimo di questa unità riposa, a sua volta, su qualcosa di completamente diverso. A questo punto ci sono tutti gli elementi per rispondere alla domanda con cui ho iniziato il paragrafo e cioè: “Per l’uomo il rapporto con Dio è essenziale e costitutivo?” La risposta è sì: in questo saggio emerge la caratterizzazione specifica dell’uomo come apertura e tensione all’Infinito ed anche come trascendenza sulla vita. Questo slancio verso l’Infinto, eleva l’uomo dalla sua naturalità: «Là ove il desiderio di Dio chiama prepotentemente alla riscossa tutto l’essere e tutto lo spirito contro ciò che è solo mondo, ecco l’homo bestia naturalis trasformarsi in un homo. […] Colui che cerca Dio, rientra con i suoi attributi sostanziali in una nuova classe eidetica oggettiva»30. L’errore del positivismo, per Scheler, sta proprio nell’aver negato che la tendenza metafisica dell’uomo sia un suo costitutivo essenziale, considerandola invece un’abitudine, un effetto storico accidentale, che successivamente potremo abbandonare. Ma, se definiamo l’uomo senza riferimento a Dio e dunque senza lo spirito, la cultura, la religione, il risultato è un uomo privato di ogni dinamismo: non è più un ricercatore di Dio, bensì un individuo pago di sé31. Inoltre è interessante rilevare che questa essenziale bestia e il superuomo, un cavo al di sopra dell’abisso. Un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo: ciò che si può amare nell’uomo è che egli sia una transizione e un tramonto». Oltre l’immagine del ponte, dell’uomo come passaggio dalla bestia a qualcosa di trascendente, anche l’immagine del fiume e del mare è presa da Nietzsche: «Davvero un fiume immondo è l’uomo. Bisogna essere un mare per accogliere un fiume immondo, senza diventare impuri. Ecco io vi insegno il superuomo: egli è questo mare, nel quale si può inabissare il vostro grande disprezzo» (Ivi, p. 7). 28
M. Scheler, Zur Idee des Menschen, cit., p. 188 [111]. (Corsivi miei). Cfr. Der Formalismus, cit., p. 293 [357]. 29
Ivi, p. 190 [114]. Sul tema di Dio come persona vedi il paragrafo successivo. 30
Ivi, p. 190 [115] (Corsivi miei). Scheler arriva a dire che l’uomo che cerca Dio rientra in una nuova classe di essenze. C’è dunque una forte discontinuità, anche dal punto di vista essenziale, tra l’uomo ripiegato su se stesso e l’uomo proteso verso il divino. 31
Ferretti scrive che un uomo pago di sé, cioè non proteso verso Dio, così come vuole il positivismo, è per Scheler il ritratto del borghese (G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, cit., p. 119). Credo 87
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 tendenza metafisica dell’uomo, la sua apertura alla sfera dell’Assoluto, è ritenuta da Scheler una condizione necessaria per la possibilità della religione, sebbene, come vedremo in seguito, la religione non sia metafisica. Sorge dunque un altro problema non meno facile: “Come può essere soddisfatta questa apertura dell’uomo a Dio? Con una conoscenza dell’essere e del bene reale assoluto che non deriva da una rivelazione?” Se è così l’uomo è appagato nella sua tendenza metafisica e non ha più bisogno della religione. In caso contrario, questa apertura può essere soddisfatta solo con un’autocomunicazione di Dio all’uomo: una rivelazione appunto. Successivamente spiegherò tutti questi termini, ma prima di fare questo e sopratutto prima di mostrare la soluzione al problema appena menzionato, ritengo doveroso approfondire brevemente l’analisi dell’uomo e della persona, dal momento che questa fase del pensiero di Scheler che sto trattando è anche quella della sua filosofia personalistica. È per questo che nel paragrafo successivo metterò in luce, in maniera piuttosto schematica e riassuntiva, i punti principali del personalismo scheleriano. 2. LA PERSONA Per impostare il suo studio dell’uomo Scheler comincia dal concetto di spirito e di persona. Com’è esplicitamente affermato in Der Formalismus: Quanto emerge nell’uomo come nuovo elemento in una determinata fase della sua evoluzione è propriamente, da un punto di vista biologico, una certa ridondanza d’attività spirituale: è come se in lui e nella sua storia si fosse aperta una fessura da cui appaia, sovrapposto ad ogni forma di vita un ordine di atti e di contenuti (valori). Tutto ciò si manifesta in concomitanza ad una nuova configurazione unitaria di tale ordine, analoga a quella che abitualmente cogliamo come unità della persona (a differenza cioè dell’io, dell’organismo ecc.): la sua interiore articolazione è costituita dall’amore e dalla pura giustizia che su di esso si fonda32. In questo passo Scheler accenna anche al rapporto che intercorre tra spirito e persona. Se lo spirito è la sfera di tutto quanto presenti l’essenza di atto, d’intenzionalità e di pienezza di senso, la persona è la forma unitaria in cui questa sfera può solamente concretizzarsi: «Persona è invero quella unità che sussiste in funzione del compimento di atti sempre diversi in ragione della propria essenza e nella misura in cui tali atti vengono pensati come compiuti»33. In termini metafisici la persona si costituisce grazie allo spirito dal momento che questo ultimo viene visto come principio in antitesi ad ogni forma di vita, anche a quella umana, colte nel loro aspetto naturale34, allo stesso tempo però «ogni spirito è personale per necessità di natura eidetica e l’idea d’uno spirito impersonale è un controsenso»35. Nella prefazione alla seconda edizione di Der Formalismus, Scheler afferma coerentemente che che Ferretti abbia ragione, infatti come osserva acutamente Norberto Bobbio, il concetto di borghesia «funziona per Scheler come una specie di scatola a sorpresa in cui sia racchiuso tutto il male del mondo» (Bobbio, La personalità di Max Scheler, p. 109). 32
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 293 [356]. 33
Ivi, p. 382 [473]. 34
Condivido pienamente questa interpretazione di Giancarlo Caronello (Pref. a Il formalismo, cit., p. 80). 35
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 388 [481]. 88 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler anche «un fondamento spirituale del mondo (quale ne sia la natura) può essere definito in se stesso come Dio solo nella misura in cui sia personale»36. È interessante rilevare il motivo per cui Scheler, per indicare il principio ‘transbiologico’ caratterizzante l’uomo, preferisca il termine ‘spirito’ a quello di ‘ragione’. Infatti quest’ultima è sempre stata usata per indicare il pensiero logico, che si articola per idee e concetti. Alla base di tale uso, fatto proprio anche da Kant, sta la convinzione che solo il pensiero logico apra l’uomo al mondo transbiologico, d’altra parte tutto ciò che nell’uomo non è razionale viene relegato nel campo della sensibilità. Invece Scheler, usando il termine spirito per tutta la sfera degli atti, pensa che la trascendenza sul mondo biologico, e dunque l’apertura a dati assoluti, riguardi ogni tipo di conoscenza intuitiva, cioè tutti gli atti emozionali e volitivi, diretti a contenuti essenziali. Per spirito dunque il filosofo intende la completa sfera di atti, di natura intenzionale, emozionali, teoretici, volitivi, che trascendono il dato empirico per rivolgersi ad essenze valide a priori37. Come abbiamo visto la critica di Scheler al pensiero morale di Kant si estende anche alla sua concezione della persona. Infatti, da una parte i due filosofi concordano nel riconoscere alla persona la dignità più alta e nel riaffermare l’imperativo per cui la persona non debba mai essere considerata esclusivamente come mezzo; in questo senso Kant avrebbe ragione nel far vedere come ogni etica dei beni e dei fini sminuisca la dignità della persona, subordinandola a qualcosa d’estraneo da se stessa. D’altra parte Scheler contesta l’identificazione kantiana della persona con il soggetto di atti razionali conformi alla legge morale. Così facendo, per Scheler, si attua un’autentica spersonalizzazione, una neutralizzazione della persona individuale e concreta; dunque Kant sbaglierebbe nel concepire la persona unicamente come ragione, escludendo la vita emozionale: «È corretto pensare che la persona non può in alcun modo venir pensata come una cosa o una sostanza che disponga di determinate facoltà o capacità tra cui quella facoltà o quella capacità che è appunto la ragione»38. Infatti la ragione, separata dalla concretezza dell’individualità, del suo carattere, della sua vita emozionale e anche delle sue inclinazioni sensibili, resta solo una pura universalità astratta e non può presentarsi come una vera e propria individualità spirituale. Per Scheler se, come vuole Kant, la ragione è ciò che ci connota ed anche in un modo più universale e generico, noi siamo veramente persone, quanto meno siamo individui, cioè soggetti singoli con caratteristiche diverse da tutti gli altri: si crea così un’incompatibilità tra individualità e personalità. Inoltre Scheler critica in termini piuttosto precisi anche la definizione kantiana dell’uomo attraverso la nozione di noumeno: Kant identifica, infatti, questa X con l’uomo noumeno, cioè con l’uomo quale cosa in sé, contrapponendo poi questo ultimo allo homo phainomenon. Ora, l’homo noumenon è […] il concetto della (comunque inconoscibile) cosa in sé come costante ontologica, applicato però all’uomo. La medesima costante 36
Ivi, p. 16 [10]. È evidente che Scheler voglia tutelare la funzione dello spirito nella costituzione della persona e lo fa in maniera decisa a tal punto che si può legittimamente affermare che «Scheler si arrocca a difesa dello spirito» (B. Accarino, Tra libertà e decisione: alle origini dell’antropologia filosofica, in AA. VV, Ratio imaginis: uomo e mondo nell'antropologia filosofica, cit., p. 25). 38
Ivi, p. 371 [458]. 37
89
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 inconoscibile vale però, senza differenziazione, anche per ogni pianta e minerale. Come potrebbe essa quindi garantire all’uomo una dignità diversa da quella minerale?39. L’intento di Scheler è di cogliere (che cosa?) in un modo che salvaguardi contemporaneamente sia la spiritualità sia l’individualità della persona. Per fare ciò egli innanzitutto sgombra il campo dalla teoria della metafisica razionalistica che fa corrispondere la persona all’anima. Anche questa entità è infatti del tutto indeterminata da un punto di vista individuale. Da parte sua la tesi metafisica tradizionale, di tipo scolastico, vede l’individualità come il risultato della materializzazione dell’entità spirituale (l’anima appunto) per mezzo di una corporeità. Ciò però contrasta, secondo Scheler, con il forte senso d’unità psicofisica in cui la persona avverte se stessa: essa non si percepisce come costituita da due sostanze diverse. Inoltre «come potrebbe l’anima essere ciò che percepisce esternamente, mentre essa stessa o il suo fondamento intuitivo possono darsi solo nella forma specifica della percezione interna?»40. Dunque Scheler vuole mostrare come la sua tesi dell’individualità della persona, non sia riconducibile a nessun fondamento ontologico, come l’anima appunto. Anche in questo caso desidero mettere in luce che Scheler, dovendo definire filosoficamente la persona, non si basa su presupposti ontologici, come ha già fatto, a mio parere, nella “costruzione” del sistema dei valori, non ancorando la loro sussistenza e la loro autonomia all’Essere. Il filosofo sostiene che la persona indica un essere umano considerato nella ricchezza della sua vita emotiva, non il soggetto incolore, animato da una mera attività di pensiero: un soggetto capace di pensare e che sia autocosciente, non è ancora una persona. A tal proposito il filosofo confuta un vecchio pregiudizio di stampo illuministico secondo cui le persone sono tanto più simili quanto più sono attive nell’esercizio delle facoltà razionali, mentre sono tanto più diverse quanto più vivono nelle necessità biologiche; Scheler sostiene proprio il contrario: le persone raggiungono la loro completa individualità, quando esercitano le facoltà superiori dello spirito, invece diventano tanto più simili, quanto più la loro esistenza è ridotta al campo delle funzioni vitali. 2.1 PERSONA E ATTI Ma che cos’è allora la persona? In Der Formalismus Scheler definisce la persona come «l’unità‐
di‐essere concreta e in se stessa essenziale di atti di diversa natura, tale da darsi in sé prima d’ogni essenziale differenza d’atto e, in particolare, prima della differenza tra percezione interna ed esterna, tra volontà interna ed esterna, tra sentire, amare, odiare nella propria interiorità o nella sfera dell’alterità ecc. L’essere della persona fonda tutti gli atti essenzialmente diversi»41. Quindi la persona precede e fonda i diversi tipi di atti. Occorre 39
Ivi, p. 373 [461]. Ivi, p. 376 [465]. 41
Ivi, p. 382 [473]. Questa concezione è stata più o meno ripresa anche in ambito cristiano da Karol Wojtyla. Questi sostiene che l’uomo è persona perché compie atti. L’atto è il dato fondamentale per l’analisi del soggetto cosciente, giacché in esso si manifesta nel modo più chiaro il suo essere personale. L’uomo, nell’atto, sperimenta se stesso come causa efficiente del suo agire, vale a dire come qualcuno che liberamente determina se stesso nell’azione. (Karol Wojtyla, Osoba i czyn ora zinne studia antropologiczne, Lublino, KUL, 1969, 19942; tr. it Persona e atto, Santarcangelo di Romagna, Rusconi libri, 1999). 40
90 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler ricordare che per ‘atti’, Scheler intende i moti della persona nel suo aprirsi al mondo: essi, pur rimanendo distinti dal piano dello Io e del mondo, non nascono dalla sfera psichica, ma direttamente dalla persona e rivelano l’intenzionalità con cui essa si rapporta al mondo e agli altri. Ad esempio l’atto d’ascoltare una musica si serve dell’udito, ma si tratta d’un ascoltare che ha un’intenzionalità che invece è assente nella funzione sensibile dell’udire, ed in cui è dato qualcosa che prima rimaneva invisibile. Altri atti del genere sono quelli che ho descritto nel capitolo precedente: amare, odiare, ricordare, preferire, posporre. Inoltre, sia gli atti che la persona, afferma Scheler, sono psicofisicamente indifferenti, nel senso che sono dati precedentemente al senso interno ed esterno a cui corrispondono la sfera psichica e fisica. L’atto, dunque, ha una sua precisa natura e non deve essere identificato con la funzione42: essa regola il rapporto fra il corpo vivente e il mondo‐ambiente. Così il gustare un cibo, l’odorare, l’usare il tatto sono funzioni che servono a raccogliere informazioni importanti sul mondo circostante. Inoltre esse possono essere oggetto della percezione interiore, possono essere studiate e osservate, «dati i concomitanti organici proprio‐corporali da cui sono accompagnate»43, mentre non è così per gli atti perché mai un atto è anche un oggetto, cioè gli atti possono oggettivare le funzioni, ma non se stessi: Un atto non è però mai anche un oggetto; alla natura d’essere degli atti perviene invero di venir intuitivamente esperiti nel loro stesso compimento e d’esser dati solo nella riflessione. Un atto non può quindi in alcun modo divenire un oggetto grazie ad un secondo atto che sia, in un certo senso, retrospettivo. La stessa riflessione che può render consapevole l’atto al di là del proprio (ingenuo) compimento non fa mai 44
dell’atto un oggetto: il sapere riflessivo accompagna l’atto, ma non l’oggettualizza. Soprattutto le funzioni formano la sfera che regola l’attività dell’Io psichico e si svolgono, a differenza dagli atti, nella sfera psichica: grazie ad esse l’uomo riesce ad avere una visione oggettiva del mondo. Vi possono essere relazioni fra atti e funzioni, nel senso che i primi possono intendere le seconde, ‘usarle’ per arrivare a cogliere il proprio oggetto, ma in nessun modo atti e funzioni possono essere confusi: «È da notare come tali funzioni non abbiano nulla in comune con gli atti»45. Inoltre è significativo osservare che la persona non si riduce allo psichico. La psiche manca della partecipazione agli atti che vengono compiuti perché essa non ha il senso della reciprocità interpersonale che caratterizza una dimensione propria dello spirito. Infatti l’animale esercita funzioni perché è dotato di psiche, ma l’uomo compie funzioni solo quando la partecipazione con la sua vita personale viene vissuta parzialmente. Ma anche in tal caso il suo esser‐persona non viene mai meno. Scheler sostiene che anche la più grave delle alienazioni mentali, che non rende l’uomo più imputabile per delle sue azioni, non annulla il suo esser persona, ma ne impedisce solo il manifestarsi in determinate azioni. Così «la malattia 42
Può sembrar difficile distinguere concretamente atti e funzioni, ma per Scheler la differenza è ben definita. Infatti, egli in Der Formalismus, critica Stumpf, reo, a suo parere, d’aver identificato atti e funzioni, affidandone lo studio alla psicologia. (Cfr. Der Formalismus, cit., p. 387 [479] ). 43
G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, cit. p. 155. 44
Ibi, p. 374 [462]. 45
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 387 [479] (Corsivi miei). Su questo tema si veda la riflessione di Andrea Zhok, Intersoggettività e fondamento in Max Scheler, Firenze, La Nuova Italia, 1997, p. 9. 91
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 e la salute non possono affatto porsi come eventuali predicati della persona, ma dell’uomo, dell’anima. Vi sono malattie dell’anima, ma non malattie della persona»46. Un altro aspetto importante da rilevare è che quando Scheler afferma che la persona fonda gli atti, egli dice che: La persona non è un vuoto punto di cominciamento di atti, bensì è l’essere concreto senza il quale ogni discorso circa gli atti non potrebbe mai far riferimento all’essenza completamente adeguata di un atto qualsiasi, ma solo ad un’essenza astratta; solo in quanto inerenti all’essenza di questa o quella persona individuale, gli atti si concretizzano trasformandosi da essenze astratte in essenze concrete. Per tal ragione non è mai possibile cogliere in maniera adeguata ed esaustiva un atto concreto senza una precedente 47
conoscenza intenzionale dell’essenza della persona stessa. La concretezza della persona è data, per Scheler, non dal riferimento ad un agente in generale, formale e vuoto, ma dal riferimento all’essenza di questa o quella persona individuale. Il filosofo vede la persona come unità degli atti spirituali, basandosi sull’esperienza che l’uomo fa del riferimento complessivo alla stessa persona individuale di vari atti spirituali di stampo diverso: questo riferimento è talmente essenziale che gli atti non possono esistere che come atti di una certa persona. D’altra parte ritengo che questa ultima affermazione sarebbe quantomeno fuorviante, se Scheler non precisasse che non dobbiamo commettere l’errore di pensare la persona come una cosa o una sostanza capace di condurre a compimento di atti nel senso d’una causalità sostanziale. Ciò non vuol dire che la persona sia inconsistente, ma solo che non è un substrato: essa non può essere concepita come un punto fermo su cui si appoggiano i suoi atti, o, un ente oggettivato che si pone al di sopra del processo di compimento dell’atto stesso48. Infatti, come sottolinea Scheler, «la persona esiste e si esperisce in maniera vissuta solo come essenza che porta a compimento atti, come pur è certo che non esiste, in alcun senso, al di sotto o al di sopra di questi atti o addirittura come un qualcosa che, analogamente ad un punto fermo, sussista al di sopra del processo di compimento e scorrimento dei propri atti»49. Dunque la persona non fonda l’atto dall’esterno, ma vive nell’atto stesso: è vivendo in ogni suo atto che la persona lo caratterizza con il suo peculiare modo d’essere. 2.2 L’ INOGETTIVABILITÀ DELLA PERSONA La già citata differenza tra atti e funzioni ci porta ad affrontare un’altra distinzione fatta da Scheler: quella tra ‘persona’ ed ‘io’, dal momento che la loro differenza è fondamentale: «Una persona possiede, rispetto all’io, il carattere di una totalità che è sufficiente a se stessa. Una persona, ad esempio, agisce, va a passeggio o simili; un io, al contrario, non ha la possibilità di farlo. Gli io non agiscono, né vanno a passeggio»50. Dunque gli ‘io’ non fanno nulla, non vivono 46
Ivi, p. 479 [596]. Ivi, p. 383 [474]. 48
G. Cusinato, Scheler. Dio in divenire, cit., p. 31. 49
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 384 [475]. 50
Ivi, p. 389 [482]. 47
92 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler in una dimensione fondamentale di reciprocità. Cosa che invece fanno le persone. Confondere la ‘persona’ con l’ ‘io’ significa oggettivarla, farne un oggetto di studio e di ricerca. Infatti l’ ‘io’ è il luogo di funzioni che si possono studiare in modo oggettivo, mentre la persona partecipa degli atti che essa stessa compie e l’atto di una persona non è mai qualcosa di neutralmente oggettivo che si può osservare come un evento naturale o psichico. Particolarmente significativo è il fatto che Scheler critichi ogni oggettivazione della persona che non ne preservi l’essenziale soggettività spirituale. Per quanto detto precedentemente, si può affermare che per Scheler la persona è inoggettivabile, dal momento che essa è ‘l’unità‐di‐
essere concreta e in se stessa essenziale di atti di diversa natura’ e gli atti sono inoggettivabili. L’inoggettivabilità della persona si manifesta nel fatto che appartiene alla sua essenza il lasciarsi conoscere o meno. Una pietra non può compiere questa scelta, solo una persona può decidere quando e con chi confidarsi, se nascondersi o no. La persona si distingue da un oggetto in quanto supera le coordinate spazio‐temporali: così facendo è libera di cambiare, sfuggendo alle leggi della causalità meccanica. Appurato che persona ed atti sono inoggettivabili, Scheler afferma che è possibile, grazie alla riflessione che può sempre accompagnare gli atti intenzionali, conoscere la loro qualità specifica cioè le loro proprie leggi essenziali. Vale la pena osservare che oggettivare la qualità di un atto, non vuol dire oggettivare l’atto stesso. Quando io ricordo di aver compiuto un atto determinato, ad esempio che ho ricordato una cosa, il mio ricordo non ha per oggetto l’atto precedente del ricordo, ormai compiuto, ma solo la qualità di quello atto come ricordo51. Dunque se gli atti non sono oggettivabili, ma conoscibili unicamente grazie alla riflessione che li accompagna, allora essi possono essere conosciuti, solo attraverso il loro compimento effettivo; da ciò segue che un vero studio dell’uomo si fonda sull’esperienza vissuta più vasta dell’uomo. Ritengo che questa tesi rechi con sé una conseguenza con dei risvolti importanti: la persona può conoscere se stessa solo compiendo i propri stessi atti e grazie alla riflessione che li accompagna. Ciò comporta che anche Dio, essendo persona, non può essere conosciuto come un oggetto, ma solo nel partecipare alla sua stessa vita e cioè nel ‘cogitare, velle et amare in Deo’52. 2.3 PERSONA E MONDO L’inoggettivabilità della persona è connessa al problema della sua apertura al mondo: «Come correlato effettivo della persona in genere noi abbiamo posto il mondo»53. Infatti, come l’oggetto è il correlato dell’atto, così il mondo è il correlato oggettivo della persona: non il mondo biologico inteso come l’insieme degli oggetti empirici reali, che si presentano all’uomo nell’atteggiamento naturale e costituiscono il suo mondo‐ambiente (Umwelt), ma un sistema più vasto, che non è neanche assimilabile al mondo kantianamente inteso come un’idea. 51
G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler cit., p. 154. Vedi M. Scheler, Wesen und Formen der Simpatie, in Gesammelte Werke, a cura di Manfred Frings, VII, Bern, Francke, 1973 [tr. it. Essenza e forme della simpatia, Roma, Città Nuova Editrice, 1980], p. 220 [320]. 53
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 392 [486]. 52
93
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Questo sistema più ampio, di cui l’ ‘Umwelt’ è solo una parte, è formato dall’insieme dei dati oggettivi in cui l’essere si manifesta così com’è in se stesso. È interessante rilevare che se «ad ogni persona corrisponde un mondo, ad ogni mondo corrisponde una persona»54: la persona non è mai parte del mondo in cui vive, ma è il suo correlato. Da parte sua ogni mondo individuale deve certamente avere le caratteristiche essenziali generali a priori proprie di ogni mondo possibile, allo steso tempo esso può essere correlato alla persona solo se presenta le peculiarità essenziali che corrispondono alla concretezza individuale della persona. Da tutto ciò consegue che non abbiamo un unico mondo uguale per tutte le singole persone, ma un mondo che è concreto e individuale, anche se è dato in se stesso ed assoluto. Scheler tratta questa idea dei ‘mondi individuali personali’ e della loro unificazione, in una sezione55 di Der Formalismus. La questione è importante perché potremmo arrivare ad una sintesi dei vari mondi personali: essi potrebbero essere visti come microcosmi, aspetti di un unico superiore macrocosmo. Il filosofo, a mio avviso, non dà una risposta precisa, però sostiene che l’idea di un unico mondo identico e reale richiama necessariamente l’idea d’una persona‐spirituale infinta e perfetta, cioè l’idea di Dio: «Se quindi noi ponessimo come reale un solo mondo concreto, risulterebbe essere privo di senso […] il fatto di non porre contemporaneamente anche l’idea di uno spirito concreto»56. Analogamente ogni comunità di persone individuali non si fonda su una qualche astratta idea della ragione, ma sulla comunità di queste persone con la persona delle persone, cioè con Dio. È bene ricordare che qui non si fa riferimento alla posizione di realtà dell’essenza di Dio57 perché, come vedremo, la concreta personalità divina si dà solo in ambito religioso. 2.4 L’IDENTITÀ DELLA PERSONA Un altro aspetto importante è quello dell’identità personale: l’identità della persona non è una relazione di uguaglianza come A=A, non è un oggetto che si mantiene stabile nel succedersi del tempo; anzi, l’identità della persona è come uno stile peculiare cha fa riconoscere subito un individuo dall’apparire dei suoi atti. Essi infatti si concretizzano ed hanno un significato in quanto ineriscono all’essenza della persona. Quest’ultima, dunque, si configura come un’identità nel cambiamento, dal momento che è ‘un centro dinamico in movimento che regola gli atti d’un individuo’. Tale cambiamento deve essere inteso come un mutamento dell’identità personale, non sul piano oggettivabile, ma su quello della libertà, intesa come possibilità che una persona ha di mutare un ordinamento di atti. Infatti la persona, nel suo poter ‘divenire altro’, cambia la sua identità, si ‘muove’, contrariamente al soggetto che rimane immutabile58. Perciò l’identità della persona può cambiare, anche in maniera profonda ad esempio attraverso l’atto del pentimento59 o del 54
Ivi, p. 394 [489]. Mikro und Makrokosmos und Gottesidee [Tr. it. Microcosmo e macrocosmo e l’idea di Dio], cit., p. 395 [489]. 56
Ivi, p. 395 [490]. 57
Ivi, nota (31) p. 396 [490]. 58
Per la differenza tra persona e soggetto vedi sopra. 59
Vedi il saggio di Scheler, Reue und Wiedergeburt, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954 [tr. it. Pentimento e rinascita, in L’eterno nell’uomo, Milano, Fabbri, 1972]. 55
94 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler perdono: il risultato è una ‘fisionomia’ particolare che, pur essendo in mutamento, presenta una coerenza di sviluppo. Precedentemente abbiamo visto che in ogni atto concreto la persona si esprime nella sua interezza, senza però esaurirsi in essa; così nel compimento di ogni atto la persona sperimenta una variazione, ‘diventa altro’. È proprio grazie a questo atto del divenire, del trascendersi (la cui più alta espressione è l’amare), che la persona è tale. Il centro dell’identità personale è dinamico in quanto si trasforma nella misura in cui fa sviluppare la persona. 2.5 PERSONA E COMUNITÀ Prima di concludere non possono non fare un breve riferimento alla dimensione comunitaria della persona. Farò un rapido accenno allo scritto Wesen und Formen der Simpatie, tralasciando però di approfondire i vari temi e spunti offerti da questa opera. Già in Der Formalismus Scheler sostiene che «nel compimento di ogni suo atto la persona ha di se stessa un vissuto tale da sapersi membro d’una comunità personale collettiva d’un determinato tipo in cui la simultaneità e la successione (delle generazioni) sono ancora indifferenziate»60. Ma è soprattutto in Wesen und Formen der Simpatie, che Scheler sviluppa questa tesi dell’originaria comunitarietà delle persone umane, aperte alla sfera di un ‘tu in generale’, già prima di ogni esperienza dei ‘tu’ empirici concreti altrui. Per spiegare meglio questa posizione, in questa opera61 il filosofo riprende un esempio già fatto in Der Formalismus: Robinson era un uomo che mai aveva percepito l’essenza dei suoi simili né qualsivoglia genere di segni e tracce dei medesimi, e dell’esistenza di tali esseri non aveva mai fatto esperienza alcuna. Ebbene […] io posi la questione se un tale Robinson potesse avere o no una qualche conoscenza circa l’esistenza della comunità e di soggetti psicospirituali simili a lui; e se potesse sapere che egli apparteneva ad una tale comunità. […] Io risposi affermativamente ad entrambe le domande. […] L’evidenza che il Robinson ha dell’esistenza d’un qualche tu in generale e della sua appartenenza ad una comunità ha un determinato fondamento intuitivo. Questo fondamento intuitivo, cioè è dato dalla coscienza, determinata e ben circoscritta del vuoto.62 Per coscienza del vuoto Scheler intende quel vissuto che si ‘crea’ quando a determinati atti sociali (l’amare, il comandare, l’obbedire, il lodare, il promettere) non corrisponde l’atto sociale di risposta che è loro proprio: al comando l’obbedienza, all’amore l’amore di contraccambio…È questo vuoto, così aperto da tali atti, che forma questa idea del tu, questa idea della comunità in generale, a cui mancherebbe solo il darsi di esemplari concreti. Scheler precisa che la persona non si costituisce solo di atti sociali, ma anche di atti singolarizzanti: la coscienza di sé, l’amore di sé, la stima di sé. Così il correlato degli atti singolarizzanti forma il mondo del singolo, il correlato degli atti sociali costituisce il mondo comunitario. Questo però non è la mera somma di mondi singoli, né la persona comune è la 60
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 509 [633]. Faccio riferimento alla seconda edizione di Wesen und Formen der Simpatie (1923). 62
M. Scheler, Wesen und Formen der Simpatie, cit., p. 229‐230 [332‐333]. L’esempio di Robinson Crusoe è un topos più volte sfruttato in filosofia. In questo caso Scheler lo usa per indicare un uomo che, pur essendo stato sempre completamente isolato dal mondo e dagli uomini, può avere l’evidenza dell’esistenza di qualche tu in generale. 61
95
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 somma di persone singole. Esse sono una ‘realtà vissuta’ in ogni possibile persona finita concreta. D’altra parte la persona singola non può essere considerata una parte della persona comune. Esse infatti si ‘rapportano’ a vicenda63, senza che l’una sia il fondamento dell’altra: «L’Io non è solo un membro del Noi, ma anche il Noi è un membro necessario dell’Io»64. In questa ottica ogni persona è altrettanto originariamente persona singola e comune, dal momento che entrambe sono subordinate «all’idea di quella persona infinta in cui viene a mancare ogni distinzione tra persona singola e persona collettiva, essenziale invece per tutte le persone finite»65. È importante anche la suddivisione, operata da Scheler, sui vari tipi fondamentali d’unità sociali. Così la ‘massa’, che negli animali è rappresentata dal gregge, si forma solo in base al ‘contagio affettivo’; la ‘comunità di vita’ nasce dal condividere i medesimi contenuti intenzionali, è caratterizzata dalla mancanza di ogni distinzione tra il vissuto mio o tuo e forma un’unità corporeo‐vitale, rivolta ai valori vitali; la società è invece un’unità artificiale di singoli, basata su convenzioni e contratti: «Le diversità reali e di valore si manifestano nella società e tra i suoi membri solo grazie ai diversi valori di prestazione dei singoli, cioè rispetto all’orientamento della società versi i valori del piacevole e dell’utile»66. Al grado più elevato si colloca la ‘persona comune’ che sorge dall’unione di «persone singole, autonome, spirituali, individuali articolatesi in una persona collettiva, autonoma, spirituale, individuale»67, fino ad arrivare alla piena comunità di ogni persona con Dio, persona delle persone; questa forma di unione è caratterizzata «dal principio di solidarietà insostituibile: la persona singola è corresponsabile di tutte le altre persone singole, non solo all’interno della persona collettiva e come suo membro per il fatto di rappresentare una funzione […], ma lo è pure in quanto individuo personale, unico e dotato di una coscienza morale individuale»68; tutto dipende da quali valori vengono accentuati: abbiamo la nazione, se hanno particolare rilievo i valori spirituali della cultura, invece abbiamo la chiesa, se sono in primo piano i valori religiosi. Nell’ottica di Scheler, questa appartenenza della persona a vari gruppi sociali non esaurisce tutto il suo essere persona perché essa, oltre ad una sfera sociale costituita da quell’insieme di esperienze che può condividere con gli altri, ha anche una sfera intima fatta di esperienze che fa solo lei e non può comunicare. Questa sfera è caratterizzata, nell’ambito delle persone finite, dalla solitudine assoluta che cessa solo nei confronti della relazione comunitaria con Dio, che non è né persona singola, né persona comune: è così che davanti a Dio la persona si apre per tutto ciò che è, con la consapevolezza di essere al contempo giudicata e protetta. Ai fini delle mie indagini sul rapporto tra uomo e Dio, occorre sottolineare ciò che Scheler scrive: «L’unità delle persone collettive tra di loro, nonché della persona singola o della persona collettiva è possibile peraltro solo in Dio»69; risulta chiaro che, per il filosofo, ogni rapporto comunitario fra gli uomini, dipende dalla nostra relazione con Dio. Anche in Wesen 63
Condivido pienamente questa interpretazione di Ferretti (G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, cit., p. 225). 64
M. Scheler, Wesen und Formen der Simpatie, cit., p. 225 [327]. 65
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 514 [640]. 66
Ivi, p. 519 [645]. 67
Ivi, p. 522 [649]. 68
Ivi, p. 523 [650]. 69
Ivi, p. 527 [656]. 96 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler und Formen der Simpatie, il filosofo offre degli spunti interessanti di filosofia della religione o meglio, in questo caso, di sociologia della religione. Così egli pensa che il ‘personalismo’ da lui sostenuto sia comprensibile solo mettendolo in corrispondenza con il teismo: «La persona e il tutto esistono in modo indipendente e l’una per l’altro, ma mai esclusivamente l’una per l’altro, ma l’una e l’altro esistono al contempo per Dio come persona, e solo in Dio esistono anche l’una per l’altro»70. L’altro spunto riguarda il ‘tu altrui’ e i diversi gruppi sociali: secondo Scheler, infatti, l’apertura alla sfera del ‘tu altrui’ segue l’apertura dell’uomo alla sfera dell’assoluto, e precede la relazione alla sfera del mondo esterno naturale. Trattando del problema dell’uomo, ho scelto d’aprire questa lunga parentesi sul tema della persona perché, secondo Scheler, l’uomo è essenzialmente persona. Essa è, per il filosofo, un percorso: è il ‘divenir‐persona’ contraddistinto dall’atto dell’amore, con cui l’uomo va oltre se stesso, in direzione del valore del ‘sacro’. Questo processo del ‘divenir‐persona’ non può essere concepito come un atto autonomo e autosufficiente dell’uomo, come il moto di una sostanza separata dal divino: nel divenir‐persona si esprime una continuazione dell’atto creativo divino e tale divenire risulta possibile solo grazie alla presenza salvifica del divino71. Non dobbiamo dimenticare che anche Dio, nella concezione scheleriana, è persona: «Un fondamento spirituale del mondo (quale ne sia la natura) può essere definito in se stesso come Dio solo nella misura in cui sia personale»72. Dunque, il rapporto tra uomo e Dio, non è fra due entità qualsiasi, ma fra due persone. 2.5 UOMO E DIO: UN RAPPORTO FRA DUE PERSONE Per Scheler la persona umana può raggiungere alcune evidenze ultime riguardo l’Essere Assoluto (Dio), mediante la conoscenza filosofica. Essa si configura come animata da quello slancio morale, con cui il nocciolo della persona cerca di raggiungere la partecipazione all’essenzialità tramite la conoscenza73; ciò che ognuno può conoscere dipende dal grado dello slancio. La prima evidenza a cui giunge la filosofia è che ‘qualcosa’ esiste e dunque ‘il nulla’ non è; questa affermazione, apparentemente scontata, è per Scheler fondamentale: «Certamente chi non ha guardato nell’abisso del nulla assoluto non s’accorgerà dell’eminente positività del contenuto dell’intuizione, che in genere qualcosa esista anziché nulla»74. La ragione dell’esistenza di qualche cosa dipende da un’entità assoluta, un’entità tramite cui ogni altro ente non‐assoluto riceve l’essere che gli compete: questa intuizione è la seconda evidenza. Tale entità assoluta è, come la chiama Scheler, l’Ens a se, che ha nella sua essenza la ragione 70
M. Scheler, Wesen und Formen der Simpatie, cit., p. 227 [329]. G. Cusinato, Scheler. Dio in divenire, cit., p. 33. Questa affermazione di Cusinato, a mio parere forse troppo netta, pone però bene in risalto il legame tra la persona‐Dio e la persona‐uomo. 72
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 16 [10]. 73
Max Scheler, Vom Wesen der Philosophie und den moralischen Bedingungen des philosophischen Erkennens, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954 [tr. it. L’essenza della filosofia e condizione morale della conoscenza filosofica, in L’eterno nell’uomo, Fabbri, Milano, 1972], p. 83 [196]. Si noti l’evidente richiamo all’immagine platonica del filosofo proteso verso il mondo dell’essenzialità. 74
Ivi, p. 93 [207]. Su questo punto si veda l’affinità di pensiero tra Scheler e M. Heidegger che in Einführung in die Metaphysik, scrive: “Perché vi è, in generale, l’essente e non il nulla?” (Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen, Max Niemeyer, 1966; tr. it. Introduzione alla metafisica, Milano, Mursia, 1968, p. 13). 71
97
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 del suo essere; essa è anche Sommo bene, quale bene distinto dagli altri beni relativi. La realtà dell’ ‘Ens a se’ è evidente e non è il frutto d’un’inferenza razionale: «L’illuminante luce di questa verità non è anzitutto dipendente da precisione logica»75; nonostante ciò è sempre difficile non cadere nell’errore d’identificare l’Essere assoluto con uno dei tanti enti relativi che possiamo esperire. La terza evidenza è che ogni ente finito ha un’essenza ed un’esistenza distinte, mentre solo nell’Essere assoluto esse si identificano; perciò la filosofia, prescindendo dall’induzione, è un’intuizione a priori dell’essere e coglie le essenzialità e le loro interdipendenze, prima di qualsiasi osservazione empirica. Perciò la filosofia, per spiegarsi come mai esistano enti che potrebbero anche non essere, stabilisce che c’è l’ ‘Ens a se’ e che esso è causa del mondo; queste due proposizioni sono le sole affermazioni evidenti che la filosofia può fare intorno a Dio. Se si vuol andare avanti si entra nella metafisica applicata al reale e dunque nel campo delle ipotesi perché l’evidenza si ha solo nell’intuizione eidetica dei rapporti fra essenze; se la metafisica vuole essere una scienza del reale essa deve dunque applicare quei principi che nascono dai rapporti fra le essenze, a realtà esistenti, e giudizi sulla realtà possono esserci forniti solo dalle scienze particolari, che sono basate sull’induzione e perciò raggiungono solo la probabilità e non l’evidenza76. In Probleme der Religion Scheler afferma chiaramente che: un’intera serie di questioni fondamentali […] possono con l’aiuto della metafisica anche filosoficamente essere provate. Tra di esse pongo (solo a guisa d’esempio) l’esistenza di un essere, che ha l’esistenza solo per la sua stessa essenza; l’esistenza di questo Ens a se come prima causa di tutto l’essere contingente […], la spiritualità e la razionalità di questo Ens a se e la sua natura come summum bonum e meta finale di tutte le attività del mondo; la sua infinità. Ma in nessun caso vi annovero la sua effettiva personalità (neretto nostro)77. 75
Ivi, p. 94 [209]. Sofia Vanni Rovighi, Filosofia e religione nel pensiero di Max Scheler, in Religione e filosofia (Relazioni e comunicazioni all’XI Congresso Nazionale di filosofia), Milano, 1968, p. 151. Con questa interpretazione Sofia Vanni Rovighi mette in luce un’apparente incongruenza che emergerebbe nella concezione scheleriana della metafisica; infatti ella sostiene che è strano che Scheler applichi da una parte il metodo husserliano della riduzione fenomenologica, della messa fra parentesi dell’esistenza, dall’altra invece sostenga che la prima evidenza filosofica sia che “qualcosa esiste”. Per Vanni Rovighi questa difficoltà concettuale è teoreticamente inspiegabile, mentre si può spiegare storicamente, se si vede nel pensiero di Max Scheler un momento di transizione fra la fenomenologia di Husserl e la filosofia esistenziale di Heidegger. Personalmente ritengo che l’obiezione della Vanni Rovighi sia importante, ma non pienamente condivisibile. Infatti Scheler nell’etica, pur parlando di Dio, mette tra parentesi la sua esistenza. Come si concilia ciò, secondo Vanni Rovighi, con la netta affermazione filosofica che qualcosa esiste? Penso che la soluzione stia nel tener presente che “mettere tra parentesi” ad esempio la realtà di Dio, non vuole dire cancellarla, ma solo non considerarla. Dunque, a mio parere, Scheler può affermare che la filosofia arrivi ad intuire l’esistenza di un Ens a se, senza però entrare in contraddizione quando opera la riduzione fenomenologica. Infatti nell’etica mettere tra parentesi la realtà di Dio, non vuol dire negare la sua esistenza, bensì significa che l’etica può fare a meno della sua esistenza concreta (non però della sua presenza come valore ultimo, valore di uno spirito personale infinito che fonda gli altri valori). 77
Max Scheler Probleme der Religion, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954 [tr. it. Problemi di religione, in L’eterno nell’uomo, Fabbri, Milano, 1972], p. 141 [257] (Grassetto mio). Non concordo con Ubaldo Pellegrino che traduce il verbo ‘erweisen’ con ‘dimostrare’. Infatti parlando della filosofia preferisco dire che essa può ‘provare’, ma non ‘dimostrare’ questioni fondamentali che anche la religione pone come vere. Il dimostrare infatti rimanda a dei procedimenti logici, a delle conclusioni inferenziali, che sono estranee al modo in cui l’uomo riesce a possedere certe evidenze filosofiche. Ad esempio l’esistenza di questo ‘Ens a se’, come prima causa di tutto l’essere contingente, è frutto di un’intuizione, non di una dimostrazione. La filosofia dunque può ‘provare’ alcune questioni fondamentali che anche la religione pone come vere. 76
98 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler Mi interessa sottolineare il fatto che per Scheler è impossibile una dimostrazione metafisica dell’esistenza di Dio come Persona, partendo dalla realtà esistente nel mondo, proprio perché il mondo nei suoi valori è colto nell’essenza e non nell’esistenza; la realtà esistente invece è conosciuta solo induttivamente e quindi ipoteticamente. Inoltre l’affermazione che l’uomo, con la metafisica, può raggiungere solo il concetto di Dio come ‘Ens a se’, come causa di tutto il contingente, ma non come persona è, a mio avviso, gravida di conseguenze; infatti, nel paragrafo precedente ho illustrato come la personalità sia una caratteristica essenziale per l’uomo, ma anche per Dio (un fondamento spirituale del mondo può essere definito in se stesso come Dio solo nella misura in cui sia personale)78: dunque non cogliere Dio come Persona, cioè come amore, vuol dire non conquistare il suo intimo nucleo. A mio avviso si può concludere che uomo è capace di giungere a Dio come Persona solo attraverso la religione: essa ha per oggetto il Sacro, per mezzo la fede, per fine la salvezza, per modello il santo. Unicamente nell’ambito dell’esperienza religiosa l’uomo riesce a raggiungere pienamente l’Assoluto che si rivela come Principio Primo degli enti, vivo, reale e personale, e non come il Dio della metafisica, freddo e vuoto. Ritengo che nella concezione scheleriana la filosofia sembri fermarsi sulla soglia della piena conoscenza di Dio: per andare oltre, per arrivare ad una partecipazione perfetta all’Assoluto ci vuole la religione. Che ne è dunque della filosofia? È qualcosa di inutile da superare? Su tale questione sono d’accordo con Vanni Rovighi che afferma che il riconoscimento dell’insufficienza della filosofia è sempre una conclusione filosofica «perché la stessa limitazione della filosofia non avrebbe diritto di essere affermata se non come autolimitazione». Questo tipo di conoscenza resta dunque necessario, ma come una fase preparatoria, introduttiva alla religione, anche se non fondativa della religione. È in questo senso, secondo Scheler, che deve essere interpretata l’espressione ‘philosophia ancilla theologiae’: la filosofia, mostrando l’impossibilità di una metafisica come conoscenza della realtà dell’assoluto, non solo libera la coscienza dai miti della metafisica, ma aiuta lo spirito a ricevere la luce della rivelazione, e fa posto così alla fede nell’ambito dello spirito umano. Nel saggio del 1915 Absolutsphäre und Realsetzung der Gottesidee, Scheler afferma: Poiché l’idea essenziale a priori della divinità è costituita dall’idea di una persona infinitamente santa, vi è un solo modo decisivo in cui sia pensabile, per persone finite, la possibilità dell’esperienza della realtà di un soggetto che corrisponda al contenuto di questa idea: che l’idea della divinità si ripresenti – nel senso più stretto del termine – alle persone finite in una persona reale, la quale in qualche modo ne medi la conoscenza […]. Ciò deve intendersi nel senso che un soggetto reale, corrispondente a questa essenza, giunge ad esperienza solo tramite il con‐esperire e post‐esperire l’esperienza vissuta di Dio che ha questa persona. L’essenza e l’idea di una possibile persona reale, presso la quale e nella quale possa aver luogo un possibile afferrare la realtà della divinità, io la chiamo l’idea del santo originario […]. Ciò che noi espressamente contestiamo è ogni dottrina che ritenga possibile, da parte di persone finite, una comprensione della realtà della divinità anche per qualche altra via che non sia l’autorivelazione della 79
divinità di un santo originario. 78
M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 16 [10]. Max Scheler, Absolutsphäre und Realsetzung der Gottesidee, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, X, Schriften aus dem Nachlass I, Bern, Francke, 1957, p. 181. In questo brano Scheler sostiene che Buddha, Mosè, Cristo, Maometto sono esempi di “santi originari”. 79
99
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Già in questo scritto, in cui c’è un primo abbozzo della filosofia della religione di Scheler, emerge l’idea che la realtà della persona divina non può essere conosciuta con il ragionamento di una persona finita, ma esclusivamente attraverso la sua autorivelazione cioè la rivelazione che Dio stesso compie. I motivi a sostegno di questa tesi sono tre. Il primo riguarda la concezione scheleriana della persona: come ho mostrato nel paragrafo precedente, essa può essere conosciuta in se stessa solo se volontariamente si lascia capire, s’apre all’altro; in caso contrario possiamo cogliere il corpo della persona umana, ma non il suo nucleo più intimo. Anche Dio è persona, ma, dal momento che è incorporeo, invisibile, perfetto, infinito e assolutamente libero, se non si manifestasse sarebbe impossibile coglierlo: è chiaro che la sua stessa natura non esclude che essa nasconda non soltanto il contenuto del suo spirito, ma anche la sua stessa esistenza. Egli chiama questa argomentazione, ‘prova dell’indimostrabilità di Dio come persona’, sottolineando che «per quanto una visione razionale – senza luce di rivelazione – possa riconoscere l’esistenza di un Dio nel senso delle definizioni: ‘Ens a se’, ‘res infinita’, ‘summum bonum’, e possa anche stabilire teoreticamente che il carattere di persona è proprio dell’essenza del sommo bene, tuttavia l’affermazione: il Dio esistente è persona è superiore ad ogni conoscenza razionale»80. La seconda ragione a sostegno della tesi sull’autorivelazione di Dio, riguarda proprio la sua natura che è caratterizzata da amore e bontà universali. È proprio grazie all’amore che Dio non può tacere e nascondersi all’uomo perché l’amore porta questa persona infinita a manifestare la propria realtà in modo spontaneo, ad aprirsi all’uomo: «Quindi è nell’essenza di un Dio personale, il fatto che la conoscenza della sua esistenza può essere possibile soltanto in forza di questo atto fondamentale dell’aprire se stessi, del lasciarsi illuminare dal tutto del significato del mondo, che è imperniato su Dio e che viene a nostra conoscenza attraverso il suo amore universale e la rivelazione fondata su di esso»81. È importante notare che l’uomo conserva la libertà d’accettare o meno questa rivelazione: la sua colpa infatti consiste nel non accogliere questa luce, rimanendo legati alla finitezza degli oggetti. Il terzo ed ultimo motivo riguarda il fatto che il divino è un valore ed un essere infinito, la cui essenza implica che non possa essere colta partendo da realtà finite. Su questo punto mi pare significativo che Scheler condivida la critica che Kant compie di tutte le possibili prove (cosmologiche, ontologiche) che pretendono di cogliere l’esistenza di Dio, partendo da realtà finite. In particolare Kant sottolinea che tali prove sono insufficienti perché esse al massimo ci portano ad una realtà più grande, una causa finita del mondo, ma mai ad un essere e valore infinito. Ritengo che Scheler riprenda questa argomentazione quando afferma che tali prove non soltanto non ci conducono alla personalità, alla santità di Dio, ma neanche ad un creatore del mondo dal momento che il concetto di creazione richiede, per Scheler, l’attribuzione a Dio della libera volontà personale. Sempre nel saggio Absolutsphäre und Realsetzung der Gottesidee, il filosofo critica un altro tipo di prova, quella ‘teoretico‐assiologica’; infatti l’insoddisfazione che l’uomo prova per i beni e i valori finiti e la sua ricerca di un valore assoluto, di per sé non sono una prova per 80
81
Max Scheler, Probleme der Religion, in Vom Ewigen im Menschen, cit., p. 332 [466]. (Corsivi miei). Ivi, p. 333 [467]. 100 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler dimostrare l’esistenza di Dio. Alla base di questa esigenza umana d’arrivare a Dio c’è la costituzionale tendenza metafisica dell’uomo. L’apertura della persona all’Assoluto, lungi dall’essere il frutto di un mero effetto storico contingente, è un tratto essenziale della natura umana. Abbiamo visto che tale tendenza non può essere appagata da una metafisica cioè da una conoscenza dell’essere e del bene reale assoluto che nasce dall’uomo. Ciò che questi può fare è solo una metafisica relativa, che riguarda alcuni campi particolari dell’essere, come l’anima, la natura. Essa è costruita collegando i dati scientifici sulla realtà con i dati essenziali della filosofia. I suoi risultati sono però solo ipotetici e probabili, non potendo avere che il grado di certezza proprio delle premesse più deboli, in questo caso le premesse scientifiche82. In questa ottica appare che l’unica via per giungere a Dio è quella tracciata dalla religione: è proprio nella fede che ci viene dato quel vero Dio conosciuto tramite la rivelazione. Stefano Liccioli Bibliografia A) TESTI DI SCHELER 1. Scheler M., Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler e Manfred Frings, Bern, Francke, 1954 sgg., (voll. II – III – V –VII – IX – X). 2. Scheler M., Absolutsphäre und Realsetzung der Gottesidee, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, X, Schriften aus dem Nachlass I, Bern, Francke, 1957. 3. Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, II, Bern, Francke, 1954; tr. it. Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, Torino, Edizioni San Paolo, 1996. 4. Scheler M., Die Stellung des Menschen im Kosmos, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, IX, Späte Schriften, Bern, Francke, 1976; tr. it. La posizione dell’uomo nel cosmo, Milano, Franco Angeli, 2000. 5. Scheler M., Probleme der Religion, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954; tr. it. Problemi di religione, in L’eterno nell’uomo, Milano, Fabbri, 1972. 6. Scheler M., Reue und Wiedergeburt, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954; tr. it. Pentimento e rinascita, in L’eterno nell’uomo, Milano, Fabbri, 1972. 82
Cfr. Giovanni Ferretti, Filosofia della religione, in Max Scheler, II, Milano, Vita e pensiero, 1972, p. 58. Condivido questo commento di Ferretti soprattutto perché egli fa riferimento ad un tema interessante: l’apporto della scienza alla metafisica. Scheler critica la cosiddetta metafisica scientifica, perché il metodo scientifico mira a costruire deduttivamente una serie di proposizioni, anche se solo verosimili, che servono per dominare il mondo. Questo metodo non considera il problema dell’intuizione delle essenze né il valore degli oggetti, mancanze che impediscono a questa metafisica scientifica di arrivare ad una conoscenza certa ed esaustiva dell’Assoluto e quindi a soddisfare la propensione metafisica dell’uomo. 101
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 7. Scheler M, Vom Wesen der Philosophie und den moralischen Bedingungen des philosophischen Erkennens, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954; tr. it. L’essenza della filosofia e condizione morale della conoscenza filosofica, in L’eterno nell’uomo, Milano, Fabbri, 1972. 8. Scheler M, Wesen und Formen der Sympathie, in Gesammelte Werke, a cura di Manfred Frings, VII, Bern, Francke, 1973; tr. it. Essenza e forme della simpatia, Roma, Città Nuova Editrice, 1980. 9. Scheler M., Zur Idee des Menschen, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, III, Vom Umsturz der Werte, Bern, Francke, 1955; tr. it. Sull’idea dell’uomo in La posizione dell’uomo nel cosmo ed altri saggi, Milano, Fabbri, 1970. B) TESTI DI ALTRI AUTORI 10. Bobbio N., La personalità di Max Scheler, in “Rivista di Filosofia”, XXIX (1938) 2, pp. 97–
126. 11. Gadamer H. G., Philosophische Lehrjahre: eine Rückschau, Frankfurt am Main, Klostermann, 1977; tr. it. Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo, Brescia, Queriniana, 1980. 12. Gehelen A., Philosophische Anthropologie und Handlungslehre (= Gesamtausgabe 4), Frankfurt am Main, Klostermann, 1983; tr. it Antropologia filosofica e teoria dell'azione, Napoli, Guida, 1990. 13. Hartmann N., Max Scheler, in «Kantstuiden», XXXIII (1928)1/2, pp. IX‐XVI. 14. Heidegger M., Einführung in die Metaphysik, Tübingen, Max Niemeyer, 1966; tr. it. Introduzione alla metafisica, Milano, Mursia, 1968. 15. Kant I., Idee zu einer allgemeinem Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784; tr. it. Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Torino, UTET, 1965. 16. Marx K., Die Deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Re präsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, un des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten, in MEGA, V, Frankfurt am Main ‐ Moskau, 1932; tr. it. L'ideologia tedesca: critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del socialismo tedesco nei suoi vari profeti, Roma, Editori Riuniti, 1967. 17. Nietzsche F., Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Kein, Chemnitz, Schmeitzner, 1883 sgg.; tr. it. Così parlò Zarathustra, Milano, Adelphi, 1991. 18. Wojtila K., Osoba i czyn ora zinne studia antropologiczne, Lublino, KUL, 1969, 19943; tr. it Persona e atto, Santarcangelo di Romagna, Rusconi libri, 1999. C) LETTERATURA CRITICA 102 Stefano Liccioli – Il problema dell’uomo nel pensiero di Max Scheler 19. Accarino B., Tra libertà e decisione: alle origini dell’antropologia filosofica, in AA. VV., Ratio imaginis: uomo e mondo nell'antropologia filosofica, a cura di Bruno Accarino, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, pp. 7–63. 20. Bosio F., Invito al pensiero di Max Scheler, Milano, Mursia, 1995. 21. Bosio F., Religione e filosofia in Max Scheler: scritti in onore di Ubaldo Pellegrino, in AA. VV., Azione e contemplazione, Milano, IPL, 1992. 22. Bosio F., Scheler interprete di Nietzsche, in «Criterio» V (1987) 3, pp. 192 – 209. 23. Caronello G., Saggio introduttivo a Max Scheler, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, Torino, Edizioni San Paolo, 1996. 24. Cusinato G., Scheler. Dio in divenire, Padova, Edizioni Messaggero, 2002. 25. Ferretti G., Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, I, Milano, Vita e pensiero, 1972. 26. Ferretti G., Filosofia della religione, in Max Scheler, II, Milano, Vita e pensiero, 1972. 27. Ferretti G., Scheler (Introduzione bibliografica e antologica), in AA. VV., Questioni di storiografia filosofica, Il pensiero contemporaneo, a cura di A.Bausola, 4/1, Brescia, La Scuola, 1978, pp. 93‐120. 28. Luporini C., Filosofi vecchi e nuovi: Scheler, Hegel, Kant, Fichte, Leopardi, I, Firenze, G. C. Sansoni, 1947. 29. Mader W., Max Scheler, Reinbek bei Hamburg, Rowolht, 1995. 30. Pellegrino U., Religione e metafisica in Max Scheler, in AA. VV., Studi di filosofia e di storia della filosofia in onore di F. Olgiati, Milano, Vita e pensiero, 1962. 31. Racinaro R., Il futuro della memoria: filosofia e mondo storico tra Hegel e Scheler, Napoli, Guida, 1985. 32. Riconda G., Introduzione al pensiero di Max Scheler, Torino, Giappichelli Editore, 1985, 2 voll. 33. Spielberg H., The phenomenological movement: a historical introduction, The Hague, Nijhoff, 1982. 34. Staude J. R., Max Scheler: 1874‐1928: an intellectual portrait, New York, The Free Press; London, Collier McMillan, 1967. 35. Vanni Rovighi S., Filosofia e religione nel pensiero di Max Scheler, in Religione e filosofia (Relazioni e comunicazioni all’XI Congresso Nazionale di filosofia), Milano, 1968, pp. 147 – 158. 36. Zhok Andrea, Intersoggettività e fondamento in Max Scheler, Firenze, La nuova Italia, 1997. 103
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 104 Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza Giacomo Cortesi [email protected] Abstract
After stressing that ethics is of central importance in Hans Jonas’s philosophy, the article analyzes
Jonas’s opposition to the re-definition of death proposed by the 1968 Harvard Ad Hoc Committee.
The author proposes a reflection on the subject in a way that connects bioethics with science –
intended as the construction of rationality and truth – and with philosophy – intended as an allcomprehensive discipline. When the boundaries between pure science and social sciences become
fluid, it is possible to foresee the complex plot that holds together social activity, human life, and
our way of intending it.
Keywords: Hans Jonas, ontology, ethics, practical philosophy, science, technology, medicine, brain
death, transplants, responsibility.
Premessa Hans Jonas si è sempre tenuto a distanza dalle correnti più importanti della filosofia contemporanea, in particolare da quelle della filosofia “analitica” [1993, p. 28; 1990, pp. 53‐
64]. Anche per questo motivo non è facile stabilire se l'orizzonte predominante della sua riflessione sia “classico” o contemporaneo. Passato e presente sono qui fusi in un’interpretazione poliedrica ed originale della modernità, capace di allargare la mappa dei sentieri della conoscenza verso nuove direzioni che accolgono insieme linee di continuità ed elementi di rottura, tra passato e presente come tra filosofia e scienza. Se è facile dividere il percorso teoretico di Jonas in tre fasi che riguardano rispettivamente lo studio del passato (filosofia della religione), del presente (filosofia della biologia) e del futuro (filosofia della responsabilità) [1987, pp. 13‐14], risulta ancora parzialmente da chiarire il respiro profondo che le anima e collega l'una con l'altra. Sono stati opportunamente messi in luce da più di un'interprete la centralità e la continuità di alcune tematiche ‐ ad esempio il problema del dualismo1, la riflessione sulla natura2, o la teologia speculativa3 ‐ e la filosofia di 1 Secondo P.P. Portinaro “L'apparente eterogeneità di interessi e tematiche delle tre stagioni di Jonas” non deve occultare “la sostanziale continuità d'intenti di tutta l'opera”, che sta nel ricondurre “le fondamenta stesse della moderna concezione del mondo” “al dualismo originario tra Dio e mondo, tra uomo e mondo” che oggi si è tradotto “nella separazione tra una concezione idealistica del creato [...] e una concezione meccanicistica della materia”. Cfr. Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino, 1990 [1979], p. XIX. 105
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Jonas viene normalmente riconosciuta come uno sforzo volto alla comprensione delle radici del nichilismo contemporaneo e alla ricerca di un fondamento dell’etica per la civiltà tecnologica. Ma La contemporaneità è spesso di ostacolo per comprendere un pensiero che abbraccia l'ambito in cui noi stessi siamo, con il nostro pensare e il nostro agire. In questi casi il discorso interpretativo deve svincolarsi dalla storia della filosofia e dall'interpretazione filologica, per immergersi nel presente, nell'esperienza concreta della nostra vita, nelle domande attuali sul “mondo” e sulla nostra posizione al suo interno. Proprio Jonas suggerisce di accogliere nella filosofia, come in ogni processo conoscitivo, l'esperienza personale, “il condizionamento del tempo, la storicità propria del soggetto che interpreta” [1987, p. 12]. È infatti l'esperienza di soldato, lo “shock della realtà” [1987, p. 31] degli anni della seconda guerra mondiale trascorsi al fronte, che determina il destino teoretico di Jonas come un continuo tentativo di pensare la catastrofe dell'uomo contemporaneo entro un ambito di totalità che si articola in una biologia filosofica e nel suo superamento in una filosofia pratica. Al di là dei suoi maestri – ricordo tra tutti Husserl ed Heidegger – e al di là delle sue articolazioni tematiche e cronologiche, la parabola intellettuale di Jonas è motivata dall'esigenza di ridare spazio e dignità filosofica alla realtà materiale e inter‐relazionale che ci costituisce e in cui siamo sempre immersi, dimenticata dalla filosofia come dalla politica. Di fronte al mancato riconoscimento tra l'uomo e il mondo (e tra l'uomo e l'uomo) che caratterizza la conquista del mondo ad opera della cultura occidentale occorre iniziare a pensare la realtà e non soltanto i pensieri4, occorre sapere chi siamo e se dobbiamo fare qualcosa contro i fenomeni inquietanti che lastricano la strada del progresso tecnico e scientifico. In ogni sua articolazione la filosofia di Jonas dà voce al misconoscimento uomo‐natura e impone alla filosofia contemporanea problemi per lo più ignorati o mal compresi: la genealogia e la fenomenologia del corpo, dei sensi ed il loro ruolo nelle prestazioni spirituali dell'uomo; la dinamica formale della tecnica nella sua unione con la scienza e l'economia; l'utopia di un progresso illimitato; la vulnerabilità della natura e il problema della “fine dei tempi e del tempo della fine”, per usare un'espressione del suo amico di università Günther Anders. Ciascuno di questi problemi si riverbera e trova spazio negli altri poiché sono tutti compresi in un unico sfondo ontologico la cui declinazione essenzialmente etica sta nella ricerca di una via che conduca “dall'essere al dover essere” [1979, p. 55 sgg., p. 101 sgg.] sulla base di un “valore in sé” dell'essere. Questa istanza etica prende la forma di una filosofia della responsabilità e, insieme, una responsabilità della filosofia nel contribuire alla comprensione delle possibilità apocalittiche di 2 Paolo Becchi afferma che “il problema della natura (specificamente della natura organica) consente di cogliere l'unità dell'ispirazione filosofica” di Jonas “nella solo apparente eterogeneità degli argomenti trattati". Cfr. H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 1999 [1963], p. XI. 3 Nicola Russo, concorde con Becchi nello scorgere nell'idea “di un'ontologia come filosofia della natura [...] il principio unificatore” di tutta produzione filosofica di Jonas, afferma però che lo sviluppo di tale ontologia è sempre affrontato da Jonas nei termini di una teologia speculativa più che di una metafisica laica. Cfr. N. Russo, La biologia filosofia di Hans Jonas, Guida, Napoli, 2004, p. 19, pp. 153 sgg. 4 Jonas ripete più volte questo concetto in tutti i suoi scritti a carattere autobiografico, che risultano fondamentali per comprendere l'evoluzione e l'articolazione del suo pensiero. Cfr. H. Jonas, Prefazione a [1970]; Id., Prefazione a [1985]; Id., [1987]; Id., [1993]; Id., [1993']; Id., [2003]. 106
Giacomo Cortesi – Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza cui il presente è gravido e nell'affiancare la tutela politica dell'ecosistema [1979 pp. 10‐11]. Ma il principio responsabilità che ha reso celebre questo autore non va cercato in un'opera piuttosto che in un'altra, né bisogna insistere troppo nelle esegesi puntuali o nelle verifiche dei fondamenti teoretici e dei riferimenti filosofici. L'etica di Jonas, prima che filosofia, è vita, è reazione di fronte alla storia, è la spinta a realizzare il proprio ruolo sociale di filosofo in un mondo i cui problemi stanno diventando catastrofe. Come per molte altre cose la Seconda guerra mondiale ha rappresentato uno spartiacque anche per la filosofia [...]. Al pensiero abituato a vivere in alto, nel cielo, sopraggiunse la visione sconvolgente delle forze che lottavano in basso, sulla terra, ed esso fu costretto a mescolarsi al corso delle cose [...]. L'impegno morale penetrò di sé la ricerca teorica5. Per cogliere il senso dell'etica di Jonas è necessario aprirsi ad un pensiero la cui aderenza alla realtà sta nel denunciare la non‐aderenza della filosofia e della scienza alla realtà, all'essere, nel proporre nuovi modelli conoscitivi e nell'aprire uno spazio per un cambiamento necessario. Non solo interpretare il presente, ma valutarlo sulla base di criteri etici condivisi che siano in grado di guidare il giudizio e l'azione umana. In luogo di rendere conto della fondazione ultima dell'edificio etico jonasiano e dell'orizzonte globale e politico che tale etica assume nel declinarsi come etica della responsabilità cosmica, porteremo qui un esempio di etica pratica6 la cui importanza è oggi al centro di importanti dibattiti scientifici, bioetici e giuridici. Riguarda la medicina, in particolare la sperimentazione medica sui pazienti e i trapianti di organi ma, come vedremo, è uno specchio del processo sociale. 1. ETICA, MEDICINA E SOCIETÀ Iniziata nel 1958 con il saggio The practical uses of theory [1959] la filosofia della tecnica jonasiana si declina via via come filosofia della responsabilità, come etica per la civiltà tecnologica. Tuttavia la scoperta dell'importanza etico‐pratica della filosofia nelle riflessioni di questo autore emerge da alcune fondamentali questioni legate alla medicina, che negli anni '60 coinvolsero l'opinione pubblica mondiale. Nel settembre del 1968 si svolse a Boston il secondo convegno dal titolo “Aspetti etici della sperimentazione sui soggetti umani”, patrocinato congiuntamente dal National Institute of Healt e dall'American Accademy of Art and Sciences7. Entrambi i convegni furono occasionati da due eventi di capitale importanza per la medicina: il 3 dicembre 1967 il chirurgo sudafricano Christiaan Barnard effettuò il primo trapianto di cuore (su un paziente che morì 18 giorni dopo) 5 Hans Jonas, La filosofia alle soglie del Duemila. Una diagnosi e una prognosi, a cura di Carlo Angelino, Il Nuovo Melangolo, 1994, p. 42. 6 Nelle sue applicazioni concrete l’etica della responsabilità di Jonas sembra fare a meno di quella fondazione metafisica dell’etica a lungo cercata negli altri scritti. A questo riguardo vedi P. Becchi, L’etica pratica di Jonas può fare a meno della metafisica?, in “Paradigmi”, n. 66, sett.‐dic. 2004, numero monografico su Hans Jonas. 7 Gli atti del secondo convegno sono stati pubblicati dalla rivista “Daedalus”, 98, 1969. Il primo convegno, dallo stesso titolo, si svolse nel 1967. 107
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 e il 5 agosto 1968 una commissione della Harvard Medical School nominata a tal scopo pubblicò un importante articolo che proponeva una ridefinizione della morte8. Jonas partecipò al convegno con una relazione dal titolo Philosophical reflections on experiments with human subjects, il cui scopo era quello di orientare la capacità di giudizio dei medici nelle inedite circostanze rese possibili dalla tecnologia applicata in campo medico. Le posizioni qui presentate suscitarono un tale scalpore che le discussioni si protrassero a lungo e in maniera così vivace che il filosofo fu addirittura invitato in sala operatoria per assistere ad un intervento a cervello aperto e ad un trapianto di rene [cfr. 1985, p, 173; 2003, p. 240]. Grazie a queste esperienze dirette e al ruolo di professore associato all'interno di uno dei primi istituti di bioetica americani, l'Hastings Center9, gli scritti di Jonas in materia10 risultano tutt'oggi importantissimi per capire le profonde implicazioni dell'ambito bioetico e per riflettere, oltre che sulla medicina e sulla scienza, sui valori e sui principi di coesione sociale. Cosa succede quando il metodo scientifico passa dalla sfera della fisica alla sfera della biologia, fino ad essere applicato all'uomo stesso? In che orizzonte ci affacciamo quando l'esperimento non è più circoscritto al rapporto tra uno scienziato e un oggetto liberamente manipolabile, ma si estende fino a coimplicare una relazione tra soggetti di diritto? Il problema eccede l'ambito medico e scientifico, diventando di interesse sociale, giuridico ed etico; non riguarda soltanto l'arte di guarire e il diritto di essere guariti, né può essere compreso dalla capacità di giudizio relativa ai soli fatti specifici. Per rispondere alla domanda su cosa sia o non sia moralmente lecito in medicina ‐ oggi che la tecnologia ha reso possibile trapianti di organi, fecondazione assistita, stato vegetativo prolungato, incubazione, clonazione di cellule e di interi organismi, chirurgia estetica, controllo del comportamento ‐ il discorso è per sua natura chiamato ad allargarsi ad un ordine storico‐sociale, fino a richiamare le basi stesse del contratto sociale e il tema del consenso nelle società di massa11. 8 A Definition of Irreversible Coma: Report of the Ad Hoc Committee at Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death, “Journal of American Medical Association”, vol. 205, 5 agosto 1968, n. 6 pp. 337‐340. 9 Fondato nel 1969 come gruppo interdisciplinare di studiosi indipendenti, l'Institute of Society, Ethics and the Life Sciences, noto come Hastings Center, ha come scopo dichiarato “to address fundamental ethical issues in the areas of health, medicine, and the environment as they affect individuals, communities, and societies”. [Da http://www.thehastingscenter.org/About/Default.aspx?id=892]. 10 Le pubblicazioni di Jonas in materia bioetica si stendono nell'arco di più di venti anni. Quelle che hanno un riferimento diretto all'etica medica e che saranno prese in considerazione in questo articolo sono: Jonas, [1968]; Id., [1970]; Id., [1978]; Id., [1983]; Id., [1986]; Id., [1991], e la loro traduzione italiana è in Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 1997. Nell’economia del presente saggio devo tralasciare le interessanti osservazioni di Jonas sul “nuovo ruolo di creatore dell'uomo” [1984] e sulla clonazione come “fissazione dell'evoluzione in contrasto con la strategia dominante della natura” [1974]. 11 La parola bioetica, che Jonas non utilizza quasi mai, fu coniata nel 1970 dall'oncologo statunitense Von R. Potter con un orientamento affine a quello di Jonas, ma che resterà minoritario nello sviluppo di questa disciplina. Secondo Potter abbiamo bisogno una nuova teoria etica che sappia fronteggiare le preoccupazioni che derivano dall'invasività dell'agire tecnoscientifico dell'uomo. Il fine di questa nuova teoria etica deve essere quello di portare all'attenzione e far rispettare i limiti biologici dell'uomo ed ecologici del Pianeta: la bioetica è un “ponte verso il futuro”, una “scienza della sopravvivenza” necessaria per capire e prevenire la catastrofe. Cfr. V. R. Potter, Bioetica, Ponte verso il futuro, Messina, 2002. Le definizioni comunemente accettate sono due, riportate in date diverse dall'“Encyclopedia of Bioethics”. Entrambe sottintendono che noi già disponiamo di un patrimonio etico‐morale adeguato al fare dell'Homo faber. 1978: “La bioetica è lo studio sistematico del comportamento umano nel campo delle scienze della vita e della salute quando questo comportamento è esaminato alla luce di valori e principi morali”; 1995: “Bioetica è un termine composto, derivato dalle parole greche bios e ethikè. Essa può essere definita 108
Giacomo Cortesi – Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza Secondo Jonas occorre innanzitutto chiarire cosa la società possa permettersi nei termini comunemente accettati del contratto sociale. Ovvero se, in che occasioni e perché la società abbia il diritto di infrangere i diritti fondamentali dei cittadini. Per quanto riguarda il primo tra tutti i diritti, l'inviolabilità del proprio corpo, solo in casi eccezionali ‐ quando ad esempio lo Stato, in accordo con la maggioranza dell'opinione pubblica, sospende temporaneamente il normale stato di diritto e impiega i propri figli in una “guerra giusta” [1968, p. 180] – la società può permettersi di richiedere l'eventuale sacrificio dei suoi membri. Ma questa giustificazione, “fondata sull'assoluta emergenza collettiva”, non riguarda “le normali transazioni del contratto sociale” [1968, p.183], di cui fa parte l'assistenza medica. Dato che “le malattie e la mortalità che ne consegue non costituiscono [...] una sventura 'sociale'”, ma anzi rientrano “nell'ordine delle cose” [1968, p. 187], come può accadere che non solo scienziati, medici e pazienti, ma anche la maggioranza dell'opinione pubblica sia favorevole alla sperimentazione su soggetti umani? In nome di cosa si è spinti a donare il proprio corpo alla scienza se non si è scienziati? Quale è la forza di questo argomento medico‐scientifico, tale da renderlo moralmente vincolante, socialmente accettato, eticamente doveroso? Come può succedere che la società si aspetti, e che io sia lieto di donare il mio corpo per un possibile vantaggio futuro di altri, facendo tramontare così il principio dell'habeas corpus integrum, inserito in tutte le carte dei diritti a partire dalla Magna Charta Libertatum del 1215? Questa assoluta novità sociale richiama organizzazioni psichiche arcaiche, “l'amara verità secondo cui l'ultima ratio della vita sociale è ed è sempre stata il sacrificio forzato, vicario, delle vite individuali”. “Qualcosa di sacrificale – scrive Jonas – esiste nella violazione selettiva dell'integrità personale e nell'esposizione ritualizzata al rischio gratuito della salute e della vita, giustificato da un bene sociale che si presume maggiore” [1968, p. 179 e 181]. La disponibilità a rinunciare all'inviolabilità del proprio corpo scaturisce da una dimensione etica, dalla stessa “sacra fonte” che ci fa rischiare la vita tuffandoci in acqua per salvare un uomo che sta annegando. Per illuminare un po' il quadro della lenta evoluzione del ‘tutto sociale’ che ha reso possibile qualcosa come la sperimentazione medica occorre integrare questa prospettiva di tempo lunghissimo – la quasi astoricità delle sopravvivenze delle dimensioni psichiche – con una prospettiva di lungo periodo del divenire storico. Nel già citato saggio The practical uses of theory [1959] Jonas sostiene che la scienza moderna ha finito con il dominare la razionalità umana, col sussumere la nostra immagine del mondo e il nostro modo di conoscere: l'idea di “un progresso potenzialmente infinito permea il moderno ideale della conoscenza con la medesima necessità del moderno ideale della civilizzazione”, della moderna idea della natura e della realtà stessa. Il concetto di progresso deriva dall'inscindibilità di teoria e prassi del metodo sperimentale in un quadro ontologico riduzionista: nel laboratorio la scienza “usa la prassi al fine della teoria”; fuori del laboratorio la teoria così ricavata viene usata al fine della prassi, permettendo una nuova serie di acquisizioni teoriche che saranno poi la base di nuovi come lo studio sistematico delle dimensioni morali, incluse la visione morale, le decisioni, la condotta e le politiche, delle scienze della vita e della cura della salute, usando diverse metodologie etiche in un quadro interdisciplinare”. 109
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 esperimenti e nuove applicazioni, in un ciclo infinito che conduce al sapere “attraverso la manipolazione delle cose da sapersi” [1959, p. 256‐259]12. La scienza, la filosofia e il senso comune dell'uomo moderno, l'intera società di massa del boom economico, demografico, tecnico e scientifico percepisce il progresso non solo come infinito, ma anche come valore in sé. La dinamicità stessa è un valore, andare avanti diventa persino più importante del porsi la domanda “verso dove?” [1959, p. 259]. L'immaginario concettuale privato e pubblico, etico e politico, di chi vive l'era delle ferrovie, dell'elettricità, del telefono, dei mass‐media, del motore a scoppio, degli aeroplani, della scomposizione dell'atomo, degli acceleratori di particelle, dei viaggi spaziali, della realtà virtuale, è stato progressivamente purgato del concetto di limite. “Per quando sarò vecchio l'umanità abiterà su Marte, perché la Terra sarà distrutta dall'inquinamento”, ho sentito dire ad un bambino. Questa situazione ideologica muta lo stesso concetto di razionalità, e di conseguenza il contratto sociale. Oggi il cittadino demanda alla società “il miglioramento attivo e costante in tutti gli ambiti della vita” e per questo scopo è orgoglioso di donare alla società il proprio contributo, consapevole o meno, “alla sua incessante realizzazione” [1968, p. 188]. L'irresistibile avanzata di questo progresso illimitato ‐ costituito dall'unione di scienza, tecnica ed economia capitalista, baconianamente alleate per alleviare le fatiche dell'uomo ‐ si è saldata con gli strati arcaici della nostra psiche a tal punto da farci sembrare normale il sacrificio di noi stessi, persino il sacrificio del pianeta, per la società il cui fine ultimo è proprio quel progresso. Noi mostriamo questa sindrome: il progresso è per nostro volere un interesse voluto dalla società, e noi vi siamo cointeressati a vari livelli; la ricerca è uno strumento necessario della scienza; infine, nella scienza medica la sperimentazione sui soggetti umani è uno strumento necessario della ricerca. Perciò, la 13
sperimentazione umana ha finito per diventare un interesse sociale . Il sacrificio in nome del progresso non è codificato, né può essere di ordine prescrittivo (dato che non c'è nessuna urgenza di progredire, almeno per noi ricchi occidentali), e come si è detto richiama da un lato un ordine meta‐morale ‐ una dimensione “trans‐etica” [1968, p. 183] di identificazione tra sacrificio di sé e bene comune ‐ e dall'altro il divenire storico della stessa razionalità occidentale dalla rivoluzione scientifica ad oggi. Dunque il bene da ottenere è il progresso e la leva su cui si appoggia è “il potenziale trascendente dell'uomo”, la dimensione “trans‐etica” qui richiamata brevemente. A questa figura manca solo il fulcro, che a ben vedere dovrebbe essere la consapevolezza del senso e del valore del progresso stesso. Per sacrificare noi stessi con entusiasmo dobbiamo essere sicuri che il nostro sacrificio sia buono e giusto, o quantomeno possedere la solida speranza che non sia vano. Ma una società basata sul progresso illimitato, della scienza come dell'informazione, 12 Per un panorama filosofico sulla tecnica moderna nei suoi legami con la scienza e la società segnalo M. HORKHEIMER, Teoria tradizionale e teoria critica, in Teoria Critica. Scritti 1932‐1941. II, Einaudi, Torino, 1974; M. HEIDEGGER, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1976 [ed. orig. 1953]; Id., L'epoca dell'immagine del mondo, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze, 1968 [ed. orig. 1938]. 13 HANS JONAS, Philosophical reflections on experiments with human subjects [1968], in ID., Dalla fede antica all'uomo tecnologico, a cura di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 188.
110
Giacomo Cortesi – Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza ci informa esattamente su ciò a cui andiamo incontro, e per quali motivi? Quali sono realmente le straordinarie conquiste scientifiche che cambieranno la vita dell’uomo, e di quali uomini? Oppure ci informa esclusivamente sul dinamismo incessante del progresso, elevandolo a valore in sé in nome del quale dobbiamo credere, vivere e morire? Se questo nuovo leviatano è il progresso materiale, delle nostre vite e degli oggetti di scienza, in che direzione ci sta portando? Per quale motivo? 2. DEFINIRE LA MORTE? The boundaries which divide Life from Death are at best, shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins? Edgar Allan Poe, 1844, p. 532 Tenterò di affrontare queste domande prendendo in considerazione quel tipo particolare di sperimentazione su soggetti umani che non riguarda i vivi, bensì i morti (o almeno quelli che la società considera tali), cioè la trapiantologia post mortem. Come abbiamo detto in apertura del paragrafo precedente, il 5 agosto 1968 è una data storica per il progresso della medicina. Secondo Il comitato di studiosi che redasse in quella data il Report of the Ad Hoc Committee at Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death l'accertamento medico‐legale della morte dei pazienti non doveva più essere basato sulla sua evidenza empirica (cessazione della respirazione e arresto cardiocircolatorio), ma sul responso scientifico di uno strumento (elettroencefalogramma piatto) e sull'assenza di qualsiasi attività corporea dipendente dal cervello. Questa definizione del coma irreversibile come morte cerebrale e della morte cerebrale come morte fece il giro del mondo, e di lì a poco venne adottata da gran parte dei legislatori occidentali. In questo modo i pazienti vennero tutelati da un coma protratto all'infinito, i medici dall'accusa di omicidio, e la tecnologia medica ebbe la strada spianata nel progresso delle tecniche di trapianto d’organi. La relazione di Jonas che abbiamo a lungo citato si concludeva con un paragrafo, On the redefinition of death14, in cui l'autore esprime un'inequivocabile opposizione a questo tentativo teorico di ridefinire la morte. La tesi centrale di Jonas è che la definizione di morte deve aderire alla sua constatazione empirica, come d’altronde è sempre stato, e che occorre attendere questo stato di cose prima di procedere ad eventuali trapianti: Poiché noi non sappiamo dove si trovi l'esatto confine tra la vita e la morte, nulla meglio di una tale definizione della morte – la morte cerebrale più la cessazione dei battiti cardiaci più qualunque altra indicazione pertinente – lo potrà dire, prima che si sia autorizzati a compiere la violenza finale. […] 14 Questo paragrafo conclusivo sarà poi integrato in un ampio scritto del 1970 dal titolo Against the stream: comments on the definition and redefinition of death, pubblicato nel 1974 in Dalla fede antica all'uomo tecnologico, cit., cap. VI. Il saggio apparirà in seguito in molte pubblicazioni mediche e fu a lungo discusso, ma purtroppo non varcò i confini dell'ambito medico. Sarà riproposto dall'autore in una versione più ampia (in Tecnica, medicina ed etica, cit., cap. X) che raccoglie in modo organico il Poscritto del 1976, il Post‐poscritto del 1985 e varie presentazioni di Jonas. 111
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Chi può dire se uno shock, un trauma finale, non sia inferto ad una sensibilità diffusa ovunque tranne che nel cervello e ancora capace di reagire alla sofferenza, una sensibilità che noi stessi abbiamo mantenuto viva?15. Né la scienza né la tecnica medica hanno bisogno di decidere il momento esatto della morte, e devono lasciare che la natura mostri da sé questo processo biologico che avviene ogni volta che un organismo, con la propria morte, attraversa l'intero spettro degli stadi di transizione tra la vita e la morte. La precisa individuazione di un punto di non‐ritorno ‐ l'assenza completa di attività cerebrale ‐ può essere usata per uno soltanto dei due obiettivi dichiarati dal Rapporto16, ovvero per stabilire un criterio che consenta di porre termine al prolungamento artificiale delle funzioni respiratorie e cardiache. Ciò significa che quando ad un paziente in coma viene diagnosticata l'irreversibilità del suo stato, ovvero una situazione di morte cerebrale, il medico può permettere al paziente di andare incontro alla propria morte; può (e addirittura deve, dal punto di vista etico) “staccare il respiratore e lasciare così che la 'definizione della morte' provenga da ciò che inevitabilmente accadrà” [1970, p. 214]17. È il secondo obiettivo del Rapporto, il “reperimento degli organi per i trapianti”, che suscita le perplessità di Jonas, sollecitandolo ad un discorso di più ampio respiro, poiché è precisamente sotto la spinta di questo interesse estraneo alla relazione medico‐paziente che si passa da un criterio per identificare la futura morte ad una definizione di morte. Ma nessuna certezza teorica può essere usata per “anticipare il momento in cui si può dichiarare morto il paziente”, continuando in seguito a far uso del respiratore artificiale e di altri ausili, allo scopo pratico di “operare sui suoi organi e tessuti nella condizione teorica di quella che prima avremmo chiamato 'vivisezione'”, cioè per procurarsi materiale in buone condizioni per i trapianti o per motivi di ricerca scientifica [1968, p. 204‐205]. Le argomentazioni di Jonas furono aspramente criticate dai medici, con l'accusa di opporre a precisi fatti scientifici vaghe considerazioni di ordine filosofico e di non aver chiara la differenza tra “morte dell'organismo come un tutto” e “morte di tutto l'organismo” [1970, p. 210]. Le risposte, nel saggio Controcorrente [1970], sono un caso esemplare dell'importanza della filosofia applicata al metodo e ai risultati della scienza. Bisogna anche notare che il principio di precauzione, qui invocato vanamente, è un primo esempio del principio etico di responsabilità e di quella “scienza delle previsioni ipotetiche” [1979, p. 34] basata sulla massima “in dubio pro malo”18 che renderanno famoso questo autore. 15 HANS JONAS, Philosophical reflections on experiments with human subjects [1968], in ID., Dalla fede antica all'uomo tecnologico, a cura di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 205‐206. 16 ID., A Definition of Irreversible Coma, cit. A p. 337 il comitato dichiara che il suo obiettivo principale è quello di “definire come nuovo criterio di morte il coma irreversibile. La necessità di una definizione si impone per due ragioni: (1) il miglioramento delle misure di rianimazione e di prolungamento della vita ha prodotto un impegno sempre maggiore per salvare persone affette da lesioni disperatamente gravi. A volte questi sforzi hanno un successo soltanto parziale e quello che ci troviamo di fronte è un individuo il cui cuore continua a battere, pur in presenza di un cervello irrimediabilmente danneggiato. Il peso di questa situazione è enorme non solo per i pazienti, ormai totalmente privi di intelletto, ma anche per le loro famiglie, per gli ospedali e per tutti coloro che hanno bisogno di posti letto già occupati da pazienti in coma. (2) L'uso di criteri obsoleti per la definizione di morte cerebrale può ingenerare controversie nel reperimento degli organi per i trapianti”. 17 Nella dichiarazione di Papa Pio XII del 1957 anche la chiesa concorda con la sospensione della terapia e con il lasciare morire il paziente [Jonas 1985, p. 168]. 18 H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica, cit., p. 48. 112
Giacomo Cortesi – Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza Per quanto riguarda l'accusa di indeterminatezza Jonas ribadisce che, data la vaghezza intrinseca del fenomeno “morte”, cercarne una definizione esatta e un momento misurabile equivale a travisarlo: “Certe forme del reale – tra cui forse l'ambito vita‐morte – possono essere in se stesse 'imprecise' o può esserlo la conoscenza che si può raggiungere di esse” [1970, p. 212]. Per difendersi dall'accusa più importante ‐ quella di proporre un concetto inesatto e per così dire accresciuto di “organismo”, Jonas fa notare che quando un uomo in coma irreversibile è attaccato al respiratore ed è alimentato ed idratato per via endovenosa presenta un’attività continua del suo metabolismo globale, e molte funzioni organiche (ad esempio l'attività ghiandolare) sono attive in ogni sua parte, non solo a livello locale. La respirazione e la circolazione, per quanto supportate da strumenti, si estendono infatti al sistema complessivo e garantiscono il perfetto funzionamento di tutto l'organismo, ad esclusione del solo cervello, per l'intera durata del trattamento. Un corpo in coma cerebrale “in realtà, può essere capace, penso, di quasi tutto ciò che non implica un controllo neurale” [1970, p. 213], cioè la maggior parte dei processi biochimici. Secondo Jonas ci troviamo qui di fronte ad un “caso evidente di principiis obsta” [1970, p. 217]: il semplice dubbio che la morte cerebrale possa ancora essere una condizione di vita dovrebbe essere più che sufficiente per proibire qualsiasi violazione dell'integrità del corpo delle persone in “una condizione ambigua ed estrema” [1970, p. 219] che andrebbe tutelata. Al contrario, i medici vanno cercando un criterio che permetta di “trasferire concettualmente il corpo del paziente nella categoria delle cose morte” [1970, p. 216], mentre i suoi organi rimangono nella categoria del vivo. In che orizzonte si può collocare la ricerca scientifica di una definizione di morte che implica parti del corpo vive in un tutto morto? Secondo Jonas il tentativo di equiparare la morte cerebrale alla morte dell'intero organismo può essere giustificata e convalidata solo all'interno di una concezione dualistica cervello‐
corpo, “un curioso revenant del vecchio dualismo anima‐corpo” [1970, p. 218]: il Rapporto di Harvard sottintende evidentemente che la persona (quantomeno la persona come soggetto di diritti e di cure) ha la sua sede nel cervello, e che il corpo non è che uno strumento di tale centro superiore e direttivo. Se Jonas concorda sul fatto che il cervello è decisivo per definire l'uomo e la vita come tali, afferma che non si può negare “che il corpo extra‐cerebrale sia una componente essenziale dell'identità della persona”, unico ed irripetibile (come dimostra l'unicità filogenetica delle impronte digitali); né si può negare “che l'identità è l'identità dell'intero organismo, anche se le funzioni più elevate della mia persona risiedono nel cervello”19. Dunque sembra che non sia il filosofo a proporre una concezione troppo larga di “organismo”, ma al contrario che siano i medici a dare per scontato una concezione che riduce la vita di un corpo alla sola attività cerebrale di questo. La metafora di “vegetale umano”, largamente usata nei casi di coma, tradisce l'orizzonte culturale dualistico e riduzionistico dominante: come se 19 “Come potrebbe altrimenti – continua qui Jonas – un uomo amare una donna e non semplicemente il suo cervello? Come potremmo perderci nello sguardo dell'altro? Essere sensibili alla delicatezza di una forma? Essa è propria di questa persona, e di nessun altra. Perciò, per quanto il corpo del comatoso – anche se con l'aiuto della tecnologia – ancora respira, pulsa e funziona, deve essere considerato come ciò che perdura del soggetto che amava ed era riamato, e come tale ha ancora diritto all'inviolabilità che le leggi di Dio e degli uomini hanno accordato a tali soggetti. Questa inviolabilità impone che non lo si usi come mero strumento” [1970, p. 218]. 113
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 un vegetale non fosse una cosa viva, ma morta, e su di essa si potesse operare senza limite alcuno. Per capire la necessità di anticipare la morte dei malati terminali occorre calarla nel suo contesto storico‐sociale, ovvero collegarla alla questione generale di una definizione “dell'uomo e di ciò che costituisce una vita umana”, chiamando in causa l'attività sociale ‐ discutendo “il presunto dovere del medico di prolungare la vita in ogni caso” [1970, pp. 214‐5] ‐ e infine la questione del progresso, che deve essere “una scelta, non un imperativo incondizionato”, e il cui scopo non può certo essere quello di sconfiggere “il fardello” della nostra mortalità [1968, p. 207]20. Di fronte ad un “'organismo come un tutto' meno il cervello” mantenuto in vita dalle tecniche di rianimazione la domanda da porsi non dovrebbe essere “il paziente è morto?”, bensì “come ci si deve comportare nei suoi confronti, visto che è ancora un paziente?” [1970, p. 214]. La prima domanda tradisce “il pragmatismo dominante della nostra epoca” [1970, p. 219], al cui servizio si può concepire un uomo ancora non totalmente morto come oggetto, come puro “fondo per l'impiego”21. La seconda domanda, al contrario, sottolinea l'immoralità e l'assurdità di prolungare artificialmente la vita di un corpo privo di cervello. L'opzione per l'una o l'altra delle domande già pregiudica la risposta, “è di carattere assiologico, e non dipende dalla effettiva situazione clinica” di morte cerebrale [1970, p. 214]. All’epoca in cui Jonas scrisse questo saggio la comunità medico‐scientifica aveva già optato per la prima delle domande, per una sua risposta positiva e per il conseguente trasferimento medico e giuridico dei pazienti in coma cerebrale nel regno delle cose morte. Probabilmente è anche per questo motivo che negli scritti di Jonas l’obiezione etica ai trapianti e alla sperimentazione medica su soggetti umani si colora di previsioni inquietanti: perché staccare il respiratore? Cosa vieta a quel punto di “prolungare artificialmente la vita e tenere il corpo del 'deceduto' a disposizione, come fosse una banca da cui prelevare organi freschi, oppure un'industria per la fabbricazione di ormoni o [...] una banca del sangue”, oppure un oggetto di numerosi esperimenti medici e corsi di anatomia? [1970, pp. 215‐6]. Queste fosche previsioni di Jonas, purtroppo, cominciarono subito a divenire realtà “nella luce accecante della sala operatoria” [1985, p. 181]. I trapianti divennero sempre più numerosi e le statistiche sui pochissimi casi di successo cominciarono lentamente ad aumentare. Vennero create banche di organi, di ossa, di tessuti, e al di fuori di questo mercato apparvero i contrabbandieri di queste nuove e redditizie materie prime. La definizione di Harvard, frutto del contesto culturale che contribuì a determinarla, seminò nell’opinione pubblica il germe del dovere etico della donazione, in nome del dovere scientifico verso il costante ed ulteriore cammino del progresso. Tuttavia il clamore di popolo che accolse i trapianti come un beneficio per l’umanità per lo più ignora che c’è stato bisogno 20 Nel saggio Peso e benedizione della mortalità [1991] Jonas si chiede, sia dal punto di vista del bene comune dell'umanità, sia da quello del bene proprio individuale, “se sia giusto combattere non solo la morte prematura ma anche la morte in genere, vale a dire se prolungare a piacere la vita sia un obiettivo legittimo della medicina” (p. 216). Le sue risposte vanno in direzione del dovere sociale di combattere la morte prematura a livello mondiale, intervenendo sulle sue cause (fame, malattie, guerre), e in direzione del dovere biologico individuale di accettare la propria morte come senso della propria vita (p. 221). In quest'ultimo senso Jonas annovera come “benedizione della mortalità” “l'aspetto evoluzionistico della morte” (p. 215). 21 Cfr. Martin Heidegger, La questione della tecnica, cit. 114
Giacomo Cortesi – Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza di una definizione teorica della morte basata su parametri tecnico‐strumentali; ignora i costi spesi e le risorse impiegate in questa direzione; ignora le modalità effettive in cui si svolgono gli espianti, ovvero il fatto che il respiratore del cadavere viene spento soltanto “a espianto avvenuto” [1985, p. 181]. Occorre ricordare che per garantire le massime probabilità di riuscita dei trapianti di organi la prima fase ‐ ovvero l’espianto dal “donatore cadavere” ‐ richiede un'ottima circolazione sanguigna e una temperatura del "donatore cadavere" attorno ai 37°C. Dunque, la differenza tra questa ed una normale operazione chirurgica praticamente scompare, se si eccettua il fatto che in un caso la vita bisognosa di cure e di attenzioni è quella del paziente, mentre nell’altro sono uno o più organi ‘vivi’ in un corpo che la società ha decretato morto. La vigliaccheria della moderna società secolarizzata, che inorridisce di fronte alla morte come al male assoluto, ha bisogno dell’assicurazione (o della finzione) che la morte si sia qui verificata quando bisogna decidere. La responsabilità di una decisione carica di valori è sostituita dall’automatismo di una routine priva di valori. Per quanto i ridefinitori della morte dicendo ‘è già morto’ cerchino di rimuovere lo scrupolo di staccare il respiratore, essi favoriscono una moderna vigliaccheria, la quale ha dimenticato che la morte 22
può avere una sua giustezza e dignità e l’uomo il diritto che lo si lasci morire . Il diniego del ‘valore’ della morte da parte del pragmatismo dominante della moderna civiltà occidentale porta la dimensione della morte dalla sfera dell’essere alla sfera del fare, dall’ambito privato a quello sociale e giuridico, riducendola alla dimensione del permettere e del vietare. La morte è oggi sottoposta ad una tecnologia raffinatissima e ad una burocrazia intricata che per il comune cittadino è incomprensibile. Dubito non solo che i cittadini, ma che anche i legislatori, e perfino molti tra gli stessi medici, sappiano ad esempio che il corpo del “morto” è a volte così poco morto da dover richiedere, oltre all'anestesia, un liquido muscolo‐
paralizzante per facilitare l'espianto e per evitare che i suoi movimenti intralcino il lavoro dei chirurghi23. 3. SCIENZA, LEGGE E VERITÀ Durante l'arco temporale coperto dagli scritti sull'etica medica di Jonas [1968‐1991] la definizione di Harvard è entrata a far parte della legislazione di quasi tutti gli Stati occidentali, e pian piano i criteri di verifica della morte cerebrale si sono allentati in varie direzioni, per 22 H. Jonas, Morte cerebrale e banca degli organi umani: sulla ridefinizione pragmatica della morte, in Tecnica medicina ed etica, cit., p. 181. 23 Le fonti contrarie ai trapianti sono estremamente difficili da reperire, e in Italia sembrano quasi sotto censura. Di recente la stampa inglese ha pubblicato una serie di interessanti Lettere. Segnalo, sul “Daily Teleghaph” del 16 gennaio 2008, una lettera di David Hill, anestesista‐rianimatore dal titolo There is something deeply unpleasant in the proposal to assume consent which is not given voluntarily [http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/01/16/nosplit/dt1601.xml] e una lettera di Tony Calland, un consulente cardiologo apparsa su “The Independent” 23 gennaio 2008, dal titolo How dead are organ donors? [http://www.independent.co.uk/opinion/letters/letters‐.htmlssion‐fears‐772196.html]. 115
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 favorire ulteriormente i trapianti24. Non c'è mai stata una vera e propria discussione nei luoghi appropriati, come ad esempio i mass‐media, che in tutto il mondo civilizzato hanno sempre presentato i trapianti come una grande conquista per l’intero genere umano. La medicina è infatti entrata a far parte a pieno titolo in quelli che Roland Barthes chiama “miti d'oggi”25, acquistando lo status di vero e proprio totem del progresso. Si è creata una specifica “cultura del trapianto”, patrocinata anche da soldi pubblici. In Italia già nel 1975 la legge si è adeguata al criterio della morte cerebrale, prevedendo il trapianto di organi anche da persone la cui morte è accertata “mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata”26. Successivamente, nel 199327, il legislatore ha confermato la legge del 1975, demandando però le specifiche modalità di accertamento della morte ad un Decreto emanato dal Ministero della Sanità, il cui Allegato 1 si diffonde su tali e tanti parametri e metodologie strumentali da sembrare più un testo scientifico che legislativo28. Ma è del 1999 la vera legge che disciplina la morte ed i trapianti in Italia29, prevedendo 1800 milioni di lire per “le attività di prelievo e trapianto” e 200 milioni di lire per la “promozione dell'informazione”. Già da subito, a costo zero, la stessa legge informa i cittadini “che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione” [Capo II, Art. 4, comma 1], demandando al Ministro della Sanità il compito di istituire un archivio informatizzato e l'onere di notificare “alla generalità dei cittadini” il fatto che in assenza di un’esplicita dichiarazione di volontà in materia di trapianti essi sono considerati donatori. Dal 2004 ad oggi sono state proposte varie leggi in materia che prevedono “la donazione del corpo ai fini di ricerca scientifica” per la durata di un anno, sulla base di un “testamento olografo in duplice copia”30 redatto dai singoli cittadini. Se qualcuna di queste leggi venisse approvata, i cittadini potranno decidere se ‐ dopo sole sei ore dalla dichiarazione di morte del proprio cervello ‐ essere tenuti per un anno in quello stato come oggetti di ricerca scientifica, prima di essere riconsegnati ai parenti. A quarant’anni dal rapporto di Harvard, siamo informati su ciò che accadrà dopo la certificazione della nostra morte? Siamo informati del freddo ambito tecnoscientifico in cui 24 Non sono un medico, né uno scienziato, e non entro nel merito delle formule chimiche o dei modi di rilevazione dell’attività neuronale del cervello umano. Tuttavia il fatto che in quasi tutti i Paesi il tempo di verifica necessario per l’accertamento di morte cerebrale sia passato da 24 a 6 ore mi sembra un caso evidente, più che di una maggiore precisione degli strumenti, dell’interesse sociale verso i trapianti. 25 Roland Barthes, Miti d'oggi, Einaudi, 1995, ed. orig. 1970. Sottolineo che l’autore non include la medicina e la scienza nei miti d’oggi, ma la produzione sociale di simboli e di “verità”. 26 La Legge 2 dicembre 1975, n.644, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n. 334, 19‐12‐1975 reca il titolo “Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico”. 27 Legge 29 dicembre 1993, n. 578, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n. 5, 8‐1‐1994, dal titolo “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte”. 28 DM 22 agosto 1994, n. 582, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n. 245, 19‐10‐1994, “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte”. 29 Legge 1° aprile 1999, n. 91, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” n. 245, 15‐04‐1999, “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”. 30 Cfr., ad esempio, PdL n. 5083, 23 giugno 2004, PdL n.1020, 8 giugno 2006, entrambi sul “testamento biologico”. In questi giorni questi progetti di legge sono in discussione alla Camera del Parlamento italiano. 116
Giacomo Cortesi – Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza oggi viene a cadere la morte? Sappiamo che in alcuni paesi poveri l’unico medico che i cittadini incontrano nella loro vita potrebbe essere colui che gli asporterà un rene in cambio di denaro? Da quando esistono “banche di organi” al di fuori degli ospedali e delle accademie, nella dura realtà, è accaduto di tutto, dalla civilissima California alle favelas di Rio, dai sotterranei del Policlinico di Roma al suk di Marrakech. Ma non mi risulta che questi avvenimenti siano stati discussi e problematizzati a sufficienza. Non è fonte di inquietudine che ci si trovi disinformati dagli imbonitori inconsapevoli del progresso della medicina, della “cultura del trapianto”, dell’etica del “un dono per la vita”, quando al di là del Mediterraneo centinaia di migliaia di bambini muoiono per non aver accesso alle cure più elementari? Non è ancora più inquietante constatare che pochissimi studiosi si interessino oggi della dimensione sociale e globale dell’ambito medico e scientifico? Infine, non è assurdo scoprire che proprio nei primi anni novanta, mentre la comunità scientifica e qualche filosofo iniziarono ad assumere un atteggiamento critico ‐ volto a “ripensare” o ad abbandonare la nozione di morte cerebrale31 ‐ in Italia il legislatore promulgava una legge il cui Articolo 1 recita per intero “La morte si identifica con la cessazione irreversibile delle facoltà dell’encefalo”32? Per fortuna, tra l’inquietudine e la difficoltà nel difficile reperimento della bibliografia in materia, è motivo di speranza leggere che non tutti hanno perso gli occhi per vedere la realtà, né il cuore per interessarsene. Concludiamo questo paragrafo con la citazione di un passo tratto da un articolo di una Professoressa di Epidemiologia clinica che si interessa degli aspetti etici e sociali della tecnologia applicata in campo medico, e che illustra in modo esemplare il collegamento tra progresso tecnoscientifico e verità: […] technological ‘progress’, primarily in the areas of life support and electroencephalography, literally created brain‐dead bodies and dictated their defining features (respectively). And that Harvard's definition 33
of brain death by committee constituted a net loss of autonomy for medicine . CONCLUSIONI La medicina, da tradizionale “arte di guarire” basata sulla facoltà di giudizio riguardo al singolo paziente e sulla cura generale della persona è oggi diventata “tecnica medica”, normalizzazione della malattia e cura del solo corpo. Ma quali ripercussioni comporta il dominio dell'aspetto tecnico per l'ethos del medico? La relazione medico‐paziente si muove troppo al di là delle normali "regole della natura", "servendo bisogni di felicità diversi dalla salute" [1983, p. 112], ad esempio assicurando la bellezza, la fertilità, la gravidanza, la riproduzione, allungando la vecchiaia, trapiantando organi, permettendo a maschi di partorire. 31 Tra i filosofi, cfr. P. Singer, Rethinking Life & Death. The Collapse of Our Traditional Ethics (1994), trad. it. Ripensare la vita, Milano 1996; tra gli scienziati è famoso l’articolo di due studiosi della stessa università di Harward, R.D. Truog e J.C. Fackler, Rethinking Brain Death, in “Critical Care Medicine”, 20, 12, 1992, pp. 1705‐1713. 32 Legge 29 dicembre 1993, n. 578, cit. 33 MITA GIACOMINI, A change of heart and a change of mind? Technology and the redefinition of death in 1968, Social Science & Medicine 44, No. 10 (1997), pp. 1465‐1482, Elsevier Science [www.elsevier.com/locate/socscimed]. 117
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Questa nuova situazione dell'ethos medico ‐ che già nel 1967 era così forte da manifestare da sé l'esigenza di una ridefinizione tecnico‐scientifica della morte che ne nega l'evidenza naturale ed empirica, assegnandole così un posto del tutto nuovo nell’attività sociale34 ‐ è giusta? La vita e la morte, la stessa medicina, possono ancora dirsi tali quando sono in balìa della tecnica e del suo irresistibile avanzare? Queste e le molte altre domande che ho qui posto, più che suscitare risposte intendono portare l’attenzione sulle profonde implicazioni della scienza e della tecnologia applicate in campo medico. A volte alcune questioni che sembrano normali in realtà trascendono il loro ambito immediato ed investono direttamente le strutture profonde della società, l'immagine che l'uomo ha di se stesso, la religione, la metafisica, la stessa filosofia, persino la politica. La sperimentazione sui soggetti umani e i trapianti di organi sono esempi paradigmatici della “sindrome del progresso”, dello specifico carattere di eccedenza della tecnologia che la eleva ad oggetto primo di filosofia. Proprio questi esempi secondo Jonas esemplificano l'azione combinata di tutti quei fattori che ci dispongono a dare via libera a nuove conquiste della tecnica in vista di vantaggi immediati, a piegarci al diktat tecnologico della reificazione anche di noi stessi, ad adattare persino il nostro sentire irrazionale, la sensibilità insita nel profondo, a quanto è divenuto fattibile35. Diventa sempre più necessario mettere in discussione l’apparato tecnoscientifico che domina i nostri pensieri e i nostri desideri, producendo sempre nuove “verità” alle quali noi corriamo docili ad adattarci. Quando lo strapotere della tecnologia informa di sé l'abitare umano della terra e travolge la vita in ogni suo aspetto, dall'istante della nascita a quello della morte, la filosofia deve tornare a comprendere le condizioni materiali di questo abitare e metterlo in relazione alle implicazioni storiche e sociali che lo hanno reso possibile, per suggerire criteri di condotta pratici. In questa direzione appare indispensabile aprirsi all’incontro e al dialogo con tutte le forme del sapere che l’uomo ha di sé e del proprio mondo. Scienze, religioni, psicologie, antropologie, ingegnerie, filosofie, mitologie, sono solo maschere sociali rette da uomini in grado di parlare tra loro, uomini che possono mettere in circolo le loro conoscenze per cambiare le cose sbagliate e cercare di dare un altro senso alla realtà quotidiana. La realtà è un arazzo la cui complessa trama può essere seguita solo in un consapevole gioco di specchi tra teoria e prassi, filosofia e storia, scienza e tecnologia, etica e politica. Ogni speculazione, ogni teoria, è già nel tutto sociale che sostiene la nostra esistenza; ogni immagine è distorta, quando non prodotta, dagli occhiali che la società ha fornito ai nostri padri e che noi abbiamo ereditato da loro. Non esistono pensieri innocenti come non esistono verità assolute, solo pensieri di parte e verità relative al contesto in cui sono validate. Nell'era delle possibilità apocalittiche poste in essere dalla tecnoscienza la responsabilità della filosofia, e in questo senso la sua verità, sta nel continuo tentativo di spezzare il cerchio magico della teoria per lasciar fluire i pensieri nel mondo; la sua misura nell'affrontare le sfide del presente e nel 34 Un interessante approccio sociologico alla morte cerebrale è in Allan Kellehear, Dying as a social relationship: A sociological review of debates on the determination of death, Social Science & Medicine 66 (2008) 1533‐1544, Elsevier Science [www.elsevier.com/locate/socscimed]. 35 ID., Against the stream: comments on the definition and redefinition of death [1985], in ID., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 1997 [1985], p.184.
118
Giacomo Cortesi – Hans Jonas, il progresso medico e le verità della scienza prendere posizione sulle questioni pratiche dell'attualità. Il passaggio dalla filosofia pura ad una filosofia vissuta, pratica e interdisciplinare è un dovere se si vuole mantenere il pensiero all’altezza del fare, se si vuole osare incidere un solco verso un futuro diverso. Giacomo Cortesi Bibliografia 1. Becchi P., Barcaro R. (a cura di), Questioni mortali. L’attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti, Napoli, E.S.I., 2004. 2. Paolo Becchi, L’etica pratica di Jonas può fare a meno della metafisica?, in “Paradigmi”, n. 66, sett.‐dic. 2004, numero monografico su Hans Jonas. 3. Roland Barthes, Miti d'oggi, Einaudi, 1995. 4. M. Cini (a cura di), Dalla biologia all'etica e viceversa, Cuen, 1999. 5. Mita Giacomini, A change of heart and a change of mind? Technology and the redefinition of death in 1968, Social Science & Medicine 44, No. 10 (1997), pp. 1465‐1482, Elsevier Science [www.elsevier.com/locate/socscimed]. 6. Hans Jonas, The practical uses of theory [1959], in Id., Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 1999 [1963]. 7. Id., Philosophical reflections on experiments with human subjects [1968], in Id., Dalla fede antica all'uomo tecnologico, a cura di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna, 2001. 8. Id., Against the stream: comments on the definition and redefinition of death [1970], in Id., Dalla fede antica all'uomo tecnologico, cit. 9. Id., Biological engineering – A preview [1974], in Id., Dalla fede antica all'uomo tecnologico, cit. 10. Id., The right to die [1978], in Id., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 1997 [1985]. 11. Id., Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino, 1990 [1979]. 12. Id., Ärztliche Kunst und Menschliche Verantwortung [1983], in Id., Tecnica, medicina ed etica, cit. 13. Id., Technik, Ethik und biogenetische Kunst. Betrachtungen zur neuen Schöpferolle des Menschen [1984], in Id., Tecnica, medicina ed etica, cit. 14. Id., Against the stream: comments on the definition and redefinition of death [1985], in Id., Tecnica, medicina ed etica, cit. 15. Id., Rechte, Recht und Ethik [1986], in Id., Tecnica, medicina ed etica, cit. 16. Id., Scienza come esperienza personale. Autobiografia intellettuale, Morcelliana, Brescia, 1992 [1987]. 17. Id., Anima & Corpo. Conversazione di Vittorio Hösle con Hans Jonas, in «Ragion Pratica», 15, 2000, pp. 53‐64 [1990]. 119
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
La ripresa video di una parte di questa intervista è disponibile su internet all'indirizzo http://www.filosofia.it/RaiPerlacultura/Video/Jonas_etica_responsabilita.swf Id., Last und Segen der Sterblichkeit [1991], in Id., Tecnica, medicina ed etica, cit. Id., Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura, Einaudi, Torino, 2000, [1993] Id., La filosofia alle soglie del Duemila. Una diagnosi e una prognosi, a cura di Carlo Angelino, Il Nuovo Melangolo, 1994 [1993']. Id., Souvenirs. D'après des entretiens avec Rachel Salamander, Payot & Rivages, Paris, 2005 [postumo, 2003] A. Kellehear, Dying as a social relationship: A sociological review of debates on the determination of death, Social Science & Medicine 66 (2008) 1533‐1544, Elsevier Science [www.elsevier.com/locate/socscimed]. M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, 1976 [ed. orig. 1953]. Id., L'epoca dell'immagine del mondo, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze, 1968. M. Horkheimer, Teoria tradizionale e teoria critica, in Teoria Critica. Scritti 1932‐1941. II, Einaudi, Torino, 1974. M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell'Illuminismo, Einaudi, Torino, 1966. Poe. E. A. (1844) The premature burial. In The Complete Poems and Stories of' Edgar Allan Poe, Volume 1, A. H. Quinn and E. H. O'Neill. pp. 532‐542. New York. N. Russo, La biologia filosofia di Hans Jonas, Guida, Napoli, 2004. P. Singer, Rethinking Life & Death. The Collapse of Our Traditional Ethics (1994), trad. it. Ripensare la vita, Milano 1996. R.D. Truog, J.C. Fackler, Rethinking Brain Death, in “Critical Care Medicine”, 20, 12, 1992, pp. 1705‐1713. Legge 2 dicembre 1975, n.644, “Gazzetta ufficiale” n. 334, 19‐12‐1975. Legge 29 dicembre 1993, n. 578, “Gazzetta ufficiale” n. 5, 8‐1‐1994. DM 22 agosto 1994, n. 582, “Gazzetta ufficiale” n. 245, 19‐10‐1994. Legge 1° aprile 1999, n. 91, “Gazzetta ufficiale” n. 245, 15‐04‐1999. PdL n. 5083, 23 giugno 2004. PdL n.1020, 8 giugno 2006. 120
Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione. L'eredità filosofica di Kant in Rawls Maria Diletta Rigoli [email protected] Abstract
The present article focuses on the relationship between I. Kant and J. Rawls, reinterpreted in the
light of globalization: it's an attempt to draw an imaginary line between the two great thinkers,
through which the reader could retrieve the basic themes that link Kant to Rawls..
Keywords: Kant, Rawls, globalization, contractualism. La prima parte del lavoro1 si concentra su somiglianze più o meno evidenti, dal costruttivismo all'idea del contratto sociale2 dall'impostazione liberale all'imperativo categorico3, tra Immanuel Kant e John Rawls; la seconda parte che invece è qui riportata, si apre su una prospettiva di respiro più ampio: laddove Bloom e Honig pongono in discussione per aspetti diversi il rapporto Rawls/Kant, dall'interno, potremmo dire, del pensiero kantiano, le critiche di Sen e della Nussbaum si rivolgono piuttosto alle implicazioni attuali, alla luce della globalizzazione e delle tematiche riguardanti il genere, che la filosofia di Rawls, innestata sul quella di Kant, porta nella discussione attuale. Il contesto di relativizzazione della cultura e dei valori di riferimento della società occidentale, pone al centro dell'attenzione, oggi come al tempo dell'emergere del modello del contratto sociale4, la necessità di ritrovare un humus comune sul quale costruire un nuovo modello sociale. Tale modello, se si sviluppano le tesi di Rawls, non può che essere la democrazia rappresentativa. Tuttavia, la grande sfida che si pone alla filosofia politica contemporanea, è quella di riuscire a democraticizzare anche gli ambiti che attualmente non sono sottoposti a tale controllo, in primis, il campo economico e finanziario internazionale che costringono nella miseria gran parte del pianeta. 1 L'articolo riassume le linee generali e i punti più salienti della Tesi di Laurea in Etica dell'età moderna: L'eredità filosofica di Kant in Rawls, discussa presso l'Università degli Studi di Firenze facoltà di Lettere e Filosofia, il 17 Giugno 2008. 2 È possibile considerare J. Rawls uno dei più grandi neocontrattualisti del secolo appena trascorso, proprio in virtù del suo esplicito riferimento ai principali contrattualisti del 1700, quali Kant, Locke, Rousseou ecc...Cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia, traduzione di U. Santini, revisione e cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano 1999 3 L'imperativo categorico kantiano è sussunto da Rawls in quello che lui chiama “velo d'ignoranza”, e che descrive accuratamente non solo in, Una teoria della giustizia (vedi nota 1), ma anche e con maggior interesse per il tema trattato in: J. Rawls, Kantian Constructivism in Moral Theory, Journal of Philosophy (September 1980), 77 (9): 515‐
572. 4 Il contrattualismo nasce nel 1600, quando la riforma protestante e la successiva controriforma, si trovarono ad essere le basi culturali per le guerre di religione. Il contratto sociale era il tentativo di trovare una piattaforma comune in un mondo che non possedeva più un orizzonte culturale omogeneo, per poter gettare le basi condivise della società. Cfr. J. Rawls, Lezioni di storia della filosofia morale, Feltrinelli, Milano 2004. 121
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 1. CONTRATTO SOCIALE E CONTRATTUALISMO: LE CRITICHE DI BLOOM E HONIG AL RAPPORTO RAWLS ‐ KANT La Teoria della Giustizia, si può paragonare ad una procedura universalizzabile di costruzione capace di trovare un accordo nelle società democratiche e costituzionali, dove la richiesta di libertà di base e di una partecipazione giusta alla vita sociale permette la presenza di diverse credenze religiose e concezioni filosofiche al suo interno. Secondo quanto dice Rawls: "una teoria della giustizia caratterizza la nostra sensibilità morale quando i giudizi che formuliamo tutti i giorni trovano accordo con i principi della teoria stessa”5. Possiamo dunque comprendere i principi fondamentali della teoria della giustizia rawlsiana nel momento in cui li leggiamo in questo contesto fondante, ovvero come il risultato di una procedura capace di fondare i criteri normativi, così come ad esempio le regole grammaticali fondano la possibilità di leggere e comprendere la lingua di una determinata popolazione e come una razionalità funzionante è presupposta alla comprensione dei giudizi e del pensiero. Con la pubblicazione di Una teoria della giustizia, Rawls ha suscitato un vivace dibattito intorno alle tematiche di filosofia politica che quest’opera espone. Tra i vari punti che sono sotto le lenti d’ingrandimento del dibattito filosofico troviamo il rapporto che Rawls tesse con i contrattualisti da lui stesso citati: Locke, Rousseau, Hobbes e Kant. Proprio in relazione a quest’ultimo i commentatori si sono trovati a riflettere sul suo impiego all’interno del pensiero del filosofo statunitense. Tra i più acuti lettori di Rawls, è Allan Bloom colui che, sebbene in maniera critica e a tratti pungente, esamina attentamente come e a quale scopo Rawls si rifaccia al contrattualismo e in particolare a Kant. Il saggio apparve nel 1975 su “The American Political Science Review” e già dal titolo che Bloom aveva scelto: Justice: John Rawls Vs. The Tradition of Political Philosophy6, faceva intendere il disappunto del critico nei confronti della filosofia rawlsiana, soprattutto riguardo al tentativo di Rawls di creare un parallelismo tra i contrattualisti classici e la sua ripresa del contrattualismo. In questo modo Bloom voleva fin dal principio mettere in luce che, a suo parere, la pretesa di Rawls di rifarsi al contrattualismo e nello specifico al contrattualismo di Kant, in definitiva risultava un’operazione non riuscita di estrapolazione di alcune tematiche care a quella tradizione. Queste tematiche, che finivano per diventare il 'punto di Archimede' per la teoria di Rawls, non conservavano le caratteristiche che avevano nel loro contesto originario, proprio perché estrapolate da esso. Per Bloom, Rawls, invece di farsi erede e interprete delle istanze contrattualiste, si opponeva ad esse e alle vere intenzioni che animavano originariamente il contrattualismo senza accorgersene e, dunque, a causa di questi significativi cambi di prospettiva derivanti da un contesto diverso, Rawls non poteva considerarsi parte di quella tradizione, alla quale invece nelle sue intenzioni voleva rifarsi. 5 Rawls J., Una teoria della giustizia, traduzione di Santini U., revisione e cura di Maffettone S., Feltrinelli, Milano 1999 6 A. Bloom, Justice: John Rawls Vs. The Tradition of Political Philosophy ,in The American Political Science Review, 69, 1975. È questa probabilmente la critica più spinosa e non priva di interesse rivolta a Rawls riguardo il rapporto tra i contrattualisti, specie Kant, e la propria pretesa di ergersi a continuatore di tale tradizione. 122
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione Infatti, le motivazioni che stanno alla base e le conclusioni a cui approda Rawls, segnano per Bloom una distanza invalicabile tra Rawls e i contrattualisti, una distanza che in definitiva li vede l’uno opporsi agli altri. La critica di Bloom verte su due punti principali: il primo riguarda la volontà di Rawls di conciliare la sua propria teoria con il contrattualismo, il secondo riguarda più precisamente l’interpretazione di Kant. Per quanto concerne il contrattualismo, Bloom sostiene che Rawls si allontani sostanzialmente dalla concezione di contratto nel momento in cui pone come motivazione e fine del contratto sociale qualcosa che non stava alla base del contratto inteso così come i filosofi lo avevano inteso originariamente. Rawls pone come diritto basilare di ogni uomo, non la proprietà, come avrebbe voluto Locke, bensì ciò di cui ogni uomo pensa di aver bisogno in relazione alla realizzazione completa del proprio progetto di vita, qualunque esso sia. Così ugualmente Rawls minimizza un aspetto che nell’originaria concezione di contratto sociale era fondamentale, ovvero che l’uomo prima di tutto entra nella società perché ha paura di perdere la propria vita. È la paura il sentimento che muove l’uomo ad entrare in società e questa paura accomuna tutti gli uomini e li accompagna lungo il corso dell’intera esistenza. Questo sentimento è talmente potente da far sì che i disaccordi tra interesse pubblico e privato scompaiano. La legge e la sua efficacia derivano da questo forte sentimento di paura che sta alla base di tutto. La società si costituisce dunque per difenderci l’uno dall’altro. Quando Rawls descrive la posizione originaria, dice Bloom, dimentica l’ insegnamento fondamentale che essa ci fornisce. Egli descrive una posizione originaria in cui la paura della morte non è più il motivo principale dell’entrata nella società, ma così facendo non fornisce motivazioni stringenti per cui l’uomo dovrebbe abbandonare lo stato di natura per entrare in essa. Questo perché Rawls volutamente tace sul merito della natura umana evitando di descriverla come originariamente propensa alla bontà oppure alla malvagità.7 Questo punto è molto interessante perché, nel momento in cui il rispetto del patto stretto con gli altri non poggia sul timore di cadere nuovamente in uno stato d’incertezza per la propria vita, allora non ci sarà niente che possa servire come deterrente per impedire agli uomini di non rispettare la legge ogni qual volta essi ritengano che possa impedire la loro piena realizzazione. Rawls in sostanza crede che all’uomo basti comprendere la nobiltà del sacrificare il proprio interesse a favore del bene pubblico, perché accetti di fare ciò, per questo al posto del timore Rawls dà all’uomo la prospettiva dell’equità: “What Rawls give us in the place of fear is fairness. But that is merely the invention of a principle to supply a missing link.” 8 7 La discussione sulla natura umana e la propensione originaria al bene o al male era stata nel contrattualismo il punto di partenza per le varie teorie. Oggi, molti studiosi ritengono che tale discussione non possa più essere fatta con profitto. Le cause dell'abbandono di questo punto sono molteplici, alcune interne all'evoluzione autonoma del pensiero filosofico, altre invece si possono ritrovare nelle condizioni storiche mutate radicalmente rispetto all'epoca di nascita del contratto sociale. La tragedia delle due guerre mondiali e sopratutto dell'olocausto hanno posto in discussione la possibilità di parlare di originaria bontà o malvagità dell'uomo. Cfr. H. Arendt, La banalità del male. Eichman a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 2003. 8 A. Bloom, Justice: John Rawls Vs. The Tradition of Political Philosophy ,in The American Political Science Review, 69, 1975. Pag. 652 123
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 In definitiva se si basa l’uscita dallo stato di natura non sulla paura, ma sull’aspettativa che nella società l’uomo possa realizzare la propria concezione di bene, allora una volta entrati nella società l’uomo potrebbe scoprire che le condizioni che la regolano paradossalmente vanno a suo svantaggio: in questo modo il vincolo stretto è molto debole. Questa debolezza è tanta che l’uomo, una volta formato lo Stato, potrebbe accorgersi che il proprio progetto di vita non si accorda con la democrazia liberale, che è invece il modello proposto da Rawls, per il quale ha di fatto abolito la paura in favore dell’equità. L’errore fondamentale di Rawls nell’interpretare il modello del contratto sta nel cercare di renderlo più “attuale” in senso liberale, togliendo quel vincolo essenziale che era la paura di perdere la propria vita, in favore di un vincolo più debole come è quello basato sul volontario accordo in vista della maggiore possibilità, per il maggior numero di persone, dunque equo, di realizzare la propria felicità; ma in definitiva fallisce anche nel tentativo di costruire un modello di democrazia liberale pieno, poiché anche la democrazia liberale esclude alcuni progetti individuali di felicità, ad esempio la mia felicità potrebbe consistere nel vivere all’insegna delle pulsioni, anche quando tali pulsioni mi portano a ledere la libertà o la vita altrui, oppure la mia felicità potrebbe consistere nel vivere entro uno stato che applichi interamente il mio ideale di società senza considerare che esso potrebbe opprimere gli altri. La seconda critica che Bloom rivolge a Rawls investe più direttamente il rapporto con Kant. Bloom ritiene che come ha fatto per gli altri contrattualisti, anche nei confronti di Kant, Rawls prende ciò di cui ha bisogno per supportare la propria teoria senza curarsi se tale uso sia legittimo e rispetti l’iniziale volontà del filosofo. Kant serve principalmente a Rawls per ammantare la propria teoria di una certa importanza, quasi una gloria che il concetto di moralità kantiano si porta dietro nell’immaginario filosofico collettivo. Ma nel fare questa operazione di scelta delle argomentazioni, Rawls finisce per perdere la vera sostanza della filosofia di Kant. La moralità per Kant, non è quella che si ritrova nel contratto sociale, infatti, nel modello del contratto, la moralità è vista come un mezzo obbligato per raggiungere il fine che ciascuno si propone nella propria concezione di felicità. Questa impostazione però sarebbe caratterizzata dall’eteronomia, contravvenendo alla condizione fondamentale che è quella dell’autonomia della moralità rispetto a qualsiasi altro obbiettivo o interesse. Nel contratto sociale, la moralità si caratterizza come il risultato dell’accordo tra gli uomini in relazione a quale sia la strada migliore per permettere a ciascuno di raggiungere le proprie aspirazioni. Questa concezione è chiaramente distante dal concetto di moralità che Kant sostiene, infatti la moralità per essere tale deve non tener conto delle conseguenze.9 9 Lo stesso Kant dichiara che le leggi che governano una società pur dovendo per forza di cose essere ispirate dalla legge morale, non sono da essa dipendenti in senso diretto, ma anzi lasciano un margine di autonomia che deve tener conto della situazione in cui si trova il governante e del tipo di società che si ha davanti. In oltre, la moralità non può essere imposta tramite una legge, poiché non è questa la funzione primaria della legge stessa, benché alla legge giusta sia richiesta una ispirazione morale e che sia a sua volta ispirante moralità. La metafora della repubblica di diavoli è in questo processo chiarificatrice perché ci fa capire bene che la funzione della legge è diversa sostanzialmente da quella della morale. Così è segnato il primato della morale sulla politica e sul diritto, un primato che Rawls non condivide e che quindi supera, andando ad usare la filosofia morale di Kant in campo squisitamente politico. Cfr.I. Kant, Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant, in Kant, Scritti di storia politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Editori Laterza, Roma – Bari 1999. 124
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione Rawls, sempre secondo Bloom, crede di poter trattenere l’insegnamento di Kant sulla moralità separando il concetto di autonomia, libertà e razionalità da quello di universalità, senza comprendere che la razionalità e la libertà esistono grazie all’universalità e che un uomo agisce autonomamente quando riesce ad agire in accordo con la legge universale e quando riesce a universalizzare con successo la propria massima facendo di essa una legge per tutti: “Rawls’s fuzziness about morality is summed up in his denigration of the primary importance of generality or universality in Kant’s thought. For him the essential element of Kant’s moral teaching is autonomy, the combination of freedom and rationality. But Rawls fail to see that what Kant means by freedom and rationality is universality.” 10 La nobiltà della filosofia morale di Kant che tanto Rawls vorrebbe ereditare è contraddetta dalla filosofia dello stesso Rawls. Bloom ritiene che proprio il velo d’ignoranza sia un punto nel quale Rawls dimostra di non aver rispettato l’originario dettame della filosofia di Kant; nella posizione originaria infatti gli uomini, mossi dal desiderio di raggiungere la propria felicità e realizzazione, secondo Ralws scelgono i principi che regoleranno la propria società sotto un velo d’ignoranza, ovvero senza sapere se tali principi favoriranno o meno il proprio personale progetto di vita. Questo non può essere ammesso da Kant, per il quale la scelta dei principi morali, proprio per essere morali, richiede che l’uomo conosca bene la propria condizione e cosa potrà succedergli dopo che avrà fatto la sua scelta. È qui che si trova la moralità: nello scegliere i principi della stessa, senza tenere conto di niente altro se non dell’autonomia della ragione attraverso la prova dell’universabilità. La nobiltà della morale kantiana si trova proprio nello scegliere, da parte dell’uomo, la moralità con la consapevolezza che questa scelta potrebbe danneggiarlo e chiedergli il sacrificio dei desideri o della propria felicità. Rawls tradisce tutto ciò, poiché si scorda che la legge universale e i desideri individuali solo occasionalmente combaciano. Bloom allora conclude che se veramente applicassimo il modello della moralità kantiana all’uomo nella posizione originaria nella filosofia di Rawls, dovremmo concludere che esso non agisce secondo la legge universale e di conseguenza non è né autonomo né in definitiva razionale. Per Bloom dunque, Rawls commette errore nel tentare di trattenere le idee Kantiane di libertà e razionalità senza adottare al contempo il principio dell’universalità. Rawls vorrebbe trattenere la teoria kantiana della moralità, accorgendosi che il bisogno di moralità è un bisogno costitutivo delle persone, senza però includere l’eroico sacrificio dei principi morali. Un'altra critica all'interpretazione rawlsiana di Kant, proviene da Bonnie Honig, il quale ritiene che Rawls nell’interpretare il filosofo tedesco lo fraintenda. Per Honig, Rawls contraddice il progetto di Kant e il suo proprio intento se crede che, contestualizzando la propria teoria della giustizia, la possa rendere sostanzialmente più politica rispetto a quella di Kant. Ovvero, secondo Honig, Rawls commette un errore nel momento in cui sceglie di applicare la filosofia morale di Kant in un contesto politico, poiché il modello liberale che entrambi i filosofi riprendono e sostengono mostra i propri limiti proprio perché non riesce a responsabilizzare civilmente i membri dello Stato, ovvero i cittadini. Kant ha compreso tutto ciò e in base a questo sa bene che la filosofia politica è il frutto di un fallimento della moralità, è il rimedio ad 10 A. Bloom, Justice: John Rawls Vs. The Tradition of Political Philosophy ,in The American Political Science Review, 69, 1975 pag. 656. 125
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 una situazione di incapacità da parte degli uomini di vivere moralmente in assenza di regole coercitive e senza la paura di una pena. Kant infatti non presuppone la moralità delle persone per formare lo stato, anzi crede che l’unica cosa necessaria per vivere in società sia il rispetto della legge pura e semplice, indipendentemente dai motivi che spingono le persone a rispettarla. Rawls invece pone come fondamento della società il procedimento dell’imperativo categorico, procedimento che Kant non ritiene idoneo all’ambito politico, bensì a quello morale. Il liberalismo politico, secondo quanto sostiene Honig, non riesce a politicizzare i cittadini o ad insegnare loro il funzionamento del potere individuale e collettivo. Sia Kant che Rawls si comportano come se la politica fosse un segno del fallimento, una caduta. Tuttavia la maggiore differenza tra Rawls e Kant, secondo Honig, è che Kant si rende conto che la propria teoria politica soppianta la morale, mentre Rawls non riesce ad accorgersene. 11 Le critiche portate da Bloom e Honig sono puntuali e severe, ma ciò che mi rende perplessa in relazione ad esse, non si trova nella loro acutezza critica, bensì in due punti che ritengo essenziali in quanto coordinate entro le quali leggere tutta l’operazione rawlsiana di recupero del contratto sociale e di Kant in particolare. Prima di tutto è necessario chiedersi se Rawls fosse o meno consapevole di riprendere una tradizione superata da tempo e che presenta limiti non certo nascosti o di poco conto, oppure se, al contrario, ritenesse di poter rilegittimare senza esporsi a critiche serie questo modello. Leggendo Una teoria della giustizia, mi sembra abbastanza chiaro che l’intenzione di Rawls non sia quella di cogliere e selezionare, come sostiene Bloom, per rilegittimarle le parti di Kant, Hobbes, Locke e Rousseau che più si adattano al suo modello, bensì quella d’inserirsi in un contesto per superarlo, ovvero cogliere le intuizioni migliori del contrattualismo e della morale kantiana per evidenziarne gli aspetti positivi e superarne i limiti emersi sia per le difficoltà strutturali interne al modello, sia per le difficoltà portate da contesti culturali e sociali cambiati. La legittimità dell’operazione di Rawls va ricercata nell’intenzione dell’autore, prima ancora che nella correttezza formale di essa. Ciò che infatti Bloom ritiene un limite insormontabile, l’aver cioè sostituito la paura con l’equità, è, a mio avviso, uno dei punti forti della teoria di Rawls. Siamo davanti a due visioni dell’uomo profondamente diverse: mentre per Bloom l’uomo ha necessariamente bisogno della coercizione per vivere in società e rispettarne le regole, per Rawls, l’uomo del Novecento non ha più bisogno di questo vincolo. Rawls proietta uno sguardo di fiducia sull’uomo, facendogli compiere un ulteriore passo verso la 'maggiore età' morale: siamo davanti ad una sorta di nuovo illuminismo per il quale l’umanità è in grado di riconoscere la necessità di vivere seguendo la giustizia piuttosto che la paura. Questa riflessione è l’evoluzione naturale di quell’intuizione originale di Kant e degli altri contrattualisti, ovvero che alla luce della storia, allorquando l’uomo usi la propria ragione, non potrà che rendersi conto che la giustizia e l’equità devono sostituirsi alla paura e alla coercizione, per poter vivere in una società veramente libera. Ecco perché anche le critiche di Honig, pur non senza fondamento, sbagliano prospettiva: poiché per Rawls l’uomo è capace di riconoscere il giusto in autonomia, è possibile applicare il concetto d’ “imperativo categorico”, che in Kant rientrava nel campo della morale, al campo della politica senza cadere nel 11 B. Honig, Political Theory and the Displacement of Politics, Ithaca: Cornell University Press, 1993. 126
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione paternalismo e senza per questo ritenere la politica come il segno del fallimento della morale. Forse, la vera novità del neocontrattualismo di Rawls è proprio questa, sostituire i vecchi vincoli della società con dei vincoli nuovi, più moderni e che guardano positivamente all’umanità. 2. NUSSBAUM E SEN: LE CRITICHE DI DUE ALLIEVI DI RAWLS SULLE IMPLICAZIONI ATTUALI DELL'IMPOSTAZIONE CONTRATTUALISTICA DEL MAESTRO. Un punto interessante, sul quale è possibile fare una critica a Rawls, è proprio il passaggio dalla soggettività della procedura corretta all’oggettività dei principi che devono essere universalmente condivisi. Ciò che Rawls presuppone è una ragione pratica da tutti condivisa, la quale giustifichi il passaggio ad un accordo politico generale e dunque possibile. Questa impostazione, se sviluppata fino in fondo, potrebbe paradossalmente portare al risultato opposto, cioè all’impossibilità di trovare comuni principi morali. Partendo infatti, come lui stesso fa, dalle situazioni soggettive ed empiriche dei singoli potremmo imbatterci in sensibilità e razionalità estremamente diverse tra loro, le quali potrebbero portare non solo a compiere una procedura differente rispetto alle altre, ma sulla cui correttezza sarebbe impossibile controbattere, oppure, anche nel caso in cui si arrivasse ad un accordo su alcuni principi, tale accordo potrebbe assumere una connotazione di generalità eccessivamente ampia, tale che il passaggio dalla sfera della moralità a quella del diritto diventerebbe impraticabile, salvo la messa tra parentesi dei principi morali stessi. Sembra, leggendo Rawls, che questa problematica gli fosse presente, e che l’introduzione del velo d’ignoranza fosse una risposta a questo possibile problema. Tuttavia il velo d’ignoranza, se salva dai condizionamenti esterni, non salva da quelli inerenti alla natura stessa degli agenti morali. Prendiamo ad esempio i diversi approcci alla scelta dei principi che dovrebbero regolare la società, nei casi in cui tali principi vengano proferiti da un uomo oppure da una donna. La differenza di genere non è qualcosa che può essere messa da parte o sulla quale è possibile tacere rispetto a scelte così importanti, e non è credibile pretendere da coloro che prendono parte a questo processo di mettere in un angolo il proprio essere. Tale problema sembra emergere ancora di più se si pensa che lo stesso Rawls è intenzionato a partire dalla condizione empirica dei singoli: il velo d’ignoranza che si trova su gli occhi dei partecipanti riguarda le condizioni future, non le condizioni attuali e imprescindibilmente legate alla natura umana. Già molti studi sulle differenze di genere hanno messo in luce i diversi atteggiamenti morali e le diverse priorità che le donne hanno rispetto a quelle degli uomini. Tale diversità non può non condizionare la scelta originaria dei principi che regolino la società, il velo d’ignoranza è insufficiente e forse anche non opportuno, in questo caso. Le differenze di genere non sono infatti un qualcosa sul quale tacere, un elemento da non considerare, ma una ricchezza su cui puntare e un’espressione della pluralità che fin dall’origine s’ impone come valore morale. Così ritorna nuovamente l’intuizionismo, ma un intuizionismo che non trova i principi fuori, in qualche cielo, ma dentro di sé, dentro l’umano in quanto essenzialmente portatore di diversità. L’errore di Rawls non si troverebbe nell’interpretare Kant in senso costruttivistico, ma nel 127
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 ritenere che alla base della società ci sia un procedimento e non il riconoscimento di valori condivisi, e andando oltre, nel fraintendere che cosa significhi riconoscere valori condivisi. È nel riconoscere che gli uomini sono intrinsecamente diversi l’uno dall’altro e non solo per quello che ritengono essere il proprio modello di felicità, ma anche per differenziazioni inerenti al genere, che si possono gettare le basi per una società liberal‐democratica, così come vuole fare Rawls. Non è dalla comune ragione pratica che deriva, una volta considerato l’altro come fine e non come mezzo, il rispetto delle differenze, ma dalla differenza originale che deriva il rispetto dell’altro. È dunque dalla consapevolezza della propria unicità e diversità che s’impone alla ragione un principio fondante della società: il rispetto della diversità. Tale rispetto fonda ogni altro principio, ma oltre al fondare eticamente la scelta delle regole della società, fornisce all’uomo la premessa metodologica per fondare dall’inizio una società giusta. Anche lo stesso principio di differenza12, che tanto sta a cuore a Rawls, non si capisce fino in fondo se non si presuppone una disuguaglianza originaria, e non lo si sviluppa fino alla fine se tale disuguaglianza non la si applica alla natura umana nel suo più profondo essere. Ciò che credo tragga in errore Rawls su questo punto, è proprio il substrato contrattualistico, nella fattispecie kantiano. Ritengo infatti che la prospettiva che si trova alla base dell’impostazione kantiana, e che porta Rawls a formulare il Velo d’ignoranza, sia quella prettamente illuministica per cui l’aspirazione più alta degli individui è quella di essere il più possibile considerati in maniera uguale in situazione eguali. Cioè una prospettiva egualitarista. Mi chiedo però se questa prospettiva sia quella più adatta a rispondere alle esigenze della società contemporanea nella quale Rawls vive. Credo infatti che il principio di uguaglianza debba essere integrato dalla tutela della diversità. Ovvero, a differenza di quanto ritiene Rawls, non dobbiamo considerare le diversità come un qualcosa da eliminare, ma come una ricchezza da tutelare, per l'arricchimento dell'intera società. Solo con una concezione di questo tipo si può pensare di eliminare tutti quegli impedimenti che rendono irraggiungibile la piena realizzazione delle diverse sensibilità, esigenze e progetti di vita. Gli uomini e le donne di oggi non vogliono essere “uguali”, ma vogliono poter vivere in pienezza le proprie diversità di genere, di religione, di razza e di modi di pensare, senza dover rinunciare alla realizzazione delle proprie aspettative. Ciò che non si trova in Rawls è l'intuizione che per andare incontro a questo nuovo modo di vedere, non è sufficiente trattare la diversità come una situazione di svantaggio da colmare, ma è necessario non solo considerare, bensì valorizzare i diversi approcci e i diversi bisogni anche quando si tratti di fondare la società. Forse più che mettere un “velo d’ignoranza” sugli occhi dei partecipanti alla stipulazione del contratto sociale, dovremmo stendervi un “velo di rispetto”. Credo che Rawls talvolta rischi di confondere la differenza con la disuguaglianza: è chiaro che una società in cui la disuguaglianza economica crescesse in modo esagerato non potrebbe essere considerata una società complessivamente giusta ( per questo in materia economica è stato ampiamente contestato, ad esempio da Sen13, il metodo del PIL per calcolare la ricchezza di un paese, comprendendo che ad un paese con un alto PIL non necessariamente corrisponde 12 Rawls J., La giustizia come equità, Saggi (1951‐1969), Liguori 1995, a cura di Ferrant G., Napoli, Liguori, 1995. 13 A. K. Sen, La disuguaglianza, un riesame critico, il Mulino, Bologna 2002. 128
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione l’assenza di disuguaglianza e povertà interna, oppure la presenza di libertà civili equamente distribuite tra la popolazione), ma il velo d’ignoranza in Rawls ottiene un duplice risultato: da una parte corregge le diseguaglianze economiche, tuttavia dall'altra impedisce di manifestare tutte quelle differenze che contribuiscono a comporre la società in maniera plurale e ricca. Il metodo del Velo d’ignoranza, se da una parte tende a correggere le disuguaglianze economiche tra gli individui, dall’altra non tiene di conto di tutta una serie di fattori che non si riducono all’aspetto economico che, seppur importante, non è l’unico e non può essere considerato sufficiente per vivere con dignità all’interno della società. Ciò che sta alla base di questa concezione quasi asettica della persona è da ricercarsi proprio nella cultura razionalista dell’età moderna, da cui anche Rawls trae la sua impostazione. Per questa cultura si tende a considerare la persona come divisa in due parti, l’anima razionale e il corpo; alla cura e all’attenzione data alla prima corrisponde la poca rilevanza data al secondo. Devo dire che questa impostazione è decisamente limitante, non solo perché pretende di ridurre l’uomo alla somma di due staccate unità, ma perché semplifica la complessità senza considerarne fattori decisivi. Laddove altre culture, ad esempio quella semita ebraica, per cui l’uomo è indicato con il termine di “nepesh” che sta a descrive la debolezza, la volontà, la fisicità e il sentimento, ma anche la originaria relazionabilità, l’Occidente ha tendenzialmente appoggiato una visione bipartita della persona. Proprio questa visione è stata uno dei cardini su cui si è incentrata la critica femminista come ad esempio la Gilligan14 e i suoi studi di genere; anche oggi, e Rawls ne è un esempio, per altri aspetti, si tende a considerare l’uomo come qualcosa di semplice, di scomponibile in parti, senza guardare all’insieme della persona. Questo è il motivo per cui non ci possiamo permettere di considerare l’uomo in grado di realizzare ogni progetto di vita solo dando ad esso beni economici sufficienti per poter vivere. Il concetto di uguaglianza e di disuguaglianza non può più essere misurato in termini meramente economici, ma anche in questo caso è necessario considerare la persona nel suo insieme. In questa prospettiva s’inseriscono due serie di considerazioni critiche nei confronti di Rawls poste in maniera diversa da Amarthya C. Sen, che oltre ad essere stato suo “discepolo” ha anche formulato nei confronti di Rawls critiche importanti e Martha Nussbaum, teorica del femminismo e anch’essa allieva di Rawls. Per quanto riguarda Sen, egli all’interno del libro La disuguaglianza15, pone nei confronti di Rawls una serie di critiche che investono esattamene il campo della definizione di che cosa sia la disuguaglianza. Sviluppando queste difficoltà, è importante notare come benché anche Rawls comprenda l’importanza della “tolleranza” in quanto elemento in grado di garantire l’applicazione della giustizia in presenza di democrazia, tuttavia non capisca, come invece fa Sen, la necessità di riformulare concezioni di giustizia applicabili in situazioni che mancano di tolleranza, come nei regimi totalitari dove comunque possono essere presenti situazioni di disuguaglianza sociale ed economica. Se esistono, come esistono, paesi in cui le libertà fondamentali vengono negate da parte di regimi totalitari, allora è necessario anche riformulare il concetto di disuguaglianza e soprattutto di uguaglianza: sono le domande 14 C . Gilligan, Con voce di donna .Etica e formazione della personalità, Feltrinelli, Milano 1987 15 A.K.Sene, La diseguaglianza, un riesame critico, il Mulino, Bologna 2002. 129
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 fondamentali del pensiero filosofico di ogni tempo che investono questo campo: chi è l’uomo e che cos’è che fa l’uomo veramente uomo. L’uguaglianza economica di partenza, sebbene importante, non è tutto. Ci sono infatti dei fattori come le libertà fondamentali, ma anche le condizioni generali ambientali che portano le persone a non poter godere in maniera eguale di eguali risorse economiche. Se dunque come sostengo, il velo d’ ignoranza non può essere applicato per le condizioni che riguardano differenze sostanziali ed interne, come il genere, esternamente può essere applicato solo a livello soggettivo e non ambientale. Mi spiego: mettiamo il caso che le persone nella posizione originaria si trovino sul punto di scegliere i principi che regoleranno la società e mettiamo che appartengano tutti allo stesso genere e ammettiamo pure che siano tutti in buona salute e fisicamente in condizioni omogenee; sembrerebbe che necessariamente i principi scelti, dato il velo d’ignoranza, non possano che essere condivisi e universalmente accettati. Se questo può essere vero, ci dobbiamo però chiedere se tali principi sarebbero gli stessi se fossero scelti in condizioni di scarsità di risorse o all’opposto in condizioni di abbondanza di risorse. Sinceramente mi risulta difficile credere che situazioni ambientali diverse possano portare alla scelta di principi identici. Questa critica, se rettamente fondata, smentisce ciò che Rawls vuole asserire di Kant servendosi di lui. È piuttosto evidente come la libertà, la razionalità e l’autonomia di cui parla Kant siano di una natura diversa, di una natura che non dia la possibilità di disaccordo, proprio perché passate attraverso il test dell’universalizzazione, universalizzazione che Rawls tende a mettere da parte in favore del concetto di autonomia. In questa prospettiva mi preme sottolineare come, a mio avviso, l’ordine dell’evoluzione del pensiero e di una teoria della giustizia, debba seguire un'altra successione logica rispetto a quella proposta da Rawls, ovvero, come il principio di tolleranza, anzi, di rispetto delle diversità, debba precedere logicamente la scelta dei principi basilari della società, e di conseguenza le scelta della democrazia come forma stato. Per quello che invece riguarda le critiche mosse a Rawls dalla Nussbaum, relativamente all’importanza di considerare i fattori che rendono capaci di realizzare pienamente il proprio progetto di vita, ritengo importante porre attenzione all’elenco di quelle che lei stessa chiama “capacità funzionali fondamentali” e che sono il frutto di ampie discussioni interculturali condotte dalla stessa pensatrice sul tema del femminismo; i risultati raggiunti dalla Nussbaum nelle sue ricerche relativamente alla problematica della differenza di genere dimostrano che il femminismo non è morto, come molti sostengono, con gli anni ’80, ma è qualcosa di vivo e inalienabile alla discussione politica, sempre infatti ci sarà bisogno di una correzione, di una sensibilità che tenga conto di quanto poco, nei fatti e nelle teorie, le donne hanno preso parte al processo di costruzione della società. Questo processo, non tenendo conto delle donne, ha condotto ad un sistema che oggi risente fortemente di questa mancanza, e che, anche a livello di teoria politica ha bisogno di nuove formulazioni e nuove prospettive. Non è sorprendente notare come tra le Capacità funzionali umane fondamentali trovino posto voci come “sensi, immaginazione e pensiero”, oppure “sentimenti” ed ancora “gioco”, solo per citarne alcune16. Il pensiero di genere, nonostante si tenda a considerarlo marginale, esprime oggi quanto di più innovativo possa esserci nel panorama filosofico, Rawls, non comprendendo questa differenza sostanziale mostra i limiti di un a teoria che sforzandosi di essere perfetta risulta 16 M. Nussbaum, Diventare persone, il Mulino,2001 130
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione irrimediabilmente segnata da automatismi. La Teoria della giustizia scorre in maniera logicamente coerente, ma in questa sua coerenza non si accorge che cercando di garantire la libertà, non trovano spazio le diversità e dunque la libertà da lui proposta è una libertà mutilata di tanti fattori. Anche quando Rawls riprende Kant lo fa cercando la coerenza con il suo pensiero, più che la volontà di riprendere fedelmente il pensiero kantiano. Da un lato in ciò si trova la sua innovazione, dall’altro vi si possono trovare i limiti. A conclusione di questa panoramica su alcuni critici di Rawls per quanto riguarda il diretto rapporto con Kant (Bloom e Honig), oppure il rapporto con le conseguenze della ripresa di Kant in maniera indiretta (Sen e Nussbaum), credo che tra Kant e Rawls esista un rapporto di sintesi, ovvero di un’ interpretazione che, tra differenze e somiglianze, voglia porsi come rielaborazione critica di un’intuizione filosofica, quella di Kant, che Rawls ritiene essenzialmente giusta. È impossibile oggi non considerare Rawls, sia per quanto riguarda gli studi su Kant, sia per quanto concerne la portata rivoluzionaria della sua teoria della giustizia, una teoria che è divenuta il caposaldo di tutta una tradizione filosofica politica liberale democratica e che è la pietra di paragone per chiunque voglia fornire la propria teoria politica,uno tra i più importanti interpreti e filosofi del Novecento. 3. RIPENSARE LA DEMOCRAZIA ALLA LUCE DEL DIBATTITO SU RAWLS. Le considerazioni finali su quanto detto fin ora, non possono essere niente di più che un punto di partenza per una riflessione più ampia la quale, secondo quanto ritengo, deve investire dalla base la filosofia politica proposta da Rawls. Per quanto riguarda il rapporto con Kant, che è poi il centro della tesi, credo che si possa parlare nei termini di un’eredità kantiana in Rawls, ovvero di una ripresa di alcuni elementi che risalgono a Kant, per superarli e impostare la propria filosofia in maniera moderna ed adeguata al mutare dei tempi. Ma se il debito con Kant fosse solo di questo tipo, potremmo concludere con Bloom che Rawls taglia e sceglie quei passaggi che servono ad avvalorare la propria filosofia, senza considerare le intenzioni vere dell’autore da cui attinge. In realtà il tentativo di Rawls è un altro. Rawls cerca, rifacendosi a Kant e ai contrattualisti, di recuperare un’idea di fondo che era propria di questi filosofi; egli pensa che per fondare la società ci sia bisogno di un patto tra persone e che tale patto sia ciò che più di tutto garantisce l’uguaglianza e la possibilità per ciascuno di raggiungere, nei limiti del patto stesso, la felicità personale. Per questo il “velo d’ignoranza” è così importante per Rawls, perché ritiene che esso possa garantire nel miglior modo possibile la maggiore equità e libertà personale. Ciò che colpisce in Rawls è il profondo legame che l’autore intesse tra libertà e giustizia, due parole che solo apparentemente contrastano tra di loro: la giustizia, intesa come equità è ciò che garantisce la libertà fondamentale dell’uomo e la libertà è come misurata moralmente dal rispetto dell’equità che deve governare la società. L’equità inoltre è ciò che garantisce la possibilità della libertà per ciascuno. Le critiche di Bloom, seppur non infondate dal punto di vista strettamente filosofico, lasciano 131
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 però un senso d’incompiutezza perché si limitano a dire ciò che non è lecito fare, senza cercare, come invece fa Rawls, di progettare un’alternativa. Bloom, sebbene legittimamente, si ferma solo alla critica, talvolta anche pungente, di un tentativo di costruzione della società. Rawls invece va oltre e ricompone i resti della tradizione contrattualista in un nuovo mosaico. Non vuole riaccendere le ceneri ormai spente di un pensiero passato, ma seguendo il proprio pensiero tenta di fornire una chiave di lettura e un progetto per la società a lui contemporanea. Anche la critica che compie Honig è il segno di un’incomprensione di fondo del pensiero di Rawls. Rawls non vede la politica come il segno del fallimento della morale, ma anzi, la vede come la sentinella della morale, colei che permette, poiché basata sul procedimento dell’imperativo categorico di Kant, un procedimento incentrato sull’autonomia e l’universalizzazione, che ognuno possa essere garantito nella propria autonomia, e che individuo e comunità possano convivere insieme. A mio avviso, invece, le critiche mosse da Sen, per certi versi, e dalla Nussbaum, per altri, sono le più importanti che si possano muovere a Rawls, perché, non affrontando in maniera diretta il tema del contrattualismo kantiano, vanno a colpire aspetti che dipendono direttamente da questa impostazione, cioè l’eredità kantiana in Rawls. Infatti, il concetto di diversità e della sua tutela, oppure il problema di stabilire l’equità all’origine e in condizioni diverse, sono sicuramente tematiche attuali. Riguardo a questo però, credo che oggi la nostra società, (prevalentemente quella occidentale, ma anche quella dei paesi in via di sviluppo, come la Cina e la stessa India, paese di origine di Sen) abbia compiuto, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, primo fra tutti Internet, e alla globalizzazione, un passo in più che rende estremamente difficile definire in primo luogo quelli che possiamo ritenere beni primari e quelli che invece possiamo catalogare ancora beni di consumo e in secondo luogo quale sia l’identità fondamentale dell’uomo. L’approccio delle “capacità”, approccio che Sen e la Nussbaum con sfumature tra loro diverse, elaborano a partire dalla critica che muovono a Rawls, rende in parte conto di questa difficoltà, ed è forse un primo passo sulla strada da percorrere per poter elaborare una teoria della giustizia in grado di rispondere al nuovo. Rawls, e anche Sen, credono che una società giusta sia tale quando riesce a fornire ad ogni uomo un paniere di beni primari adeguato (Rawls) e la possibilità per ciascuno di poter usufruire di tali beni (Sen). Sul piano economico, a mio avviso, questa impostazione continua a risultare giusta e a segnare un punto importante per lo sviluppo di una teoria politica ed economica sufficientemente garantista delle libertà e della possibilità per ciascuno di poter godere del maggior numero di esse, ovunque si trovi a vivere. Tuttavia, sebbene tale concezione sia accettabile e venga in parte incontro alle esigenza di una società multietnica e globale, credo che sia necessario porci una domanda radicale, che vada a coinvolgere quei punti fermi della filosofia di Rawls e in questo caso anche di Kant; la domanda è se quella concezione Kantiana di uomo, inteso da una parte come agente morale e dall’altra come fine e mai come mezzo, concezione ripresa da Rawls, possa valere anche oggi nel contesto in cui ci muoviamo. La formazione dell’io incontra nuove frontiere e nuove esperienze, e se fino a poco tempo fa, l’altro, riconoscendo il quale potevo definire il mio io politico, era facilmente individuabile, grazie al concetto di nazione, che forniva le coordinate 132
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione geografiche entro le quali sviluppare la propria identità, oggi, il processo della globalizzazione ci ha proiettati in un contesto allargato e non più segnato da limiti precisi. Internet, dal canto suo, ha rivoluzionato le categorie di tempo e di spazio (usando una terminologia kantiana) che erano la base del senso comune del vivere, per contrarle e ridurle, almeno virtualmente. Da una parte, sembrerebbe che finalmente, quello che nell’ “imperativo categorico” kantiano era una prova compiuta semplicemente con il pensiero, ovvero l’universalizzazione, oggi prenda corpo non più semplicemente come una necessità morale, ma come una necessità pratica, cosicché nei fatti il mio agire morale è costantemente sottoposto alla considerazione della possibilità dell’universalità delle azioni. Dall’altra però, è facile rendersi conto di come l’abbattimento fisico delle barriere abbia dato il via ad un processo inverso di diminuzione degli individui che possono usufruire dei beni primari, delle capacità e delle conoscenze nel campo del sapere che invece dovrebbero poter circolare con maggiore facilità. Questo è facile riscontrarlo anche nella povertà estrema che investe la maggioranza della popolazione mondiale, di contro all’opulenza in cui vive solo una parte che si aggira intorno al 20% della popolazione. Così sembra che, nonostante nella teoria potremmo agire come cittadini del mondo, nei fatti una larga maggioranza di coloro che fanno parte del 20% ricco del mondo, continua a vivere come se il proprio io e il proprio agire non influenzasse che se stesso e le poche persone che stanno intorno. La situazione mondiale di povertà diffusa in tante parti della terra e l’apertura dei confini e delle barriere hanno generato, non l’ottimismo o la reciproca accoglienza unita ad una nuova “carta d’identità” dell’io, ma il sentimento di una crescente paura e l’istinto di chiudere se stessi nella difesa di un’identità fondata sulla tradizione e sull’esclusione di tutti coloro che non fanno parte di tale tradizione. È evidente come questo sentimento di chiusura entro i limiti di un recinto comodo e sicuro sia comprensibile emotivamente, ma è altrettanto evidente come la difesa oltranzista di alcuni valori socio‐culturali, elevati al ruolo di scudo, ma ormai incapaci di rielaborare se stessi in una prospettiva nuova, non porti ad affrontare quei problemi che sono figli della globalizzazione e la cui soluzione non può più essere rimandata. C’è dunque bisogno di riprendere quella spinta all’universalità che Kant proponeva, facendole compiere qualche passo in avanti. Ad esempio è necessario incominciare a considerare se stessi responsabili di tutto il genere umano, non solo nel presente, ma anche per quel che riguarda le generazioni future. Questo significa a mio avviso essenzialmente una cosa: non aver paura di elaborare una concezione culturale nuova e inclusiva, senza però per questo rinunciare ad essere propositivi e venir meno alla democrazia, la forma che più di tutte può garantire la libertà individuale e la giustizia sociale. Rawls aveva compreso tutto ciò e la teoria della giustizia da lui proposta è il tentativo di dare una qualche risposta a nuove problematiche emergenti fin dal tempo in cui ha scritto la sua opera principale. Tuttavia, l’intuizione che lui ha avuto e che in potenza era stata formulata anche dallo stesso Kant, ha bisogno di essere sviluppata e resa sempre attuale. La globalizzazione, che non è affatto qualcosa di negativo in sé, ma che anzi, lo stesso Kant, in forme seppur diverse, vedeva come auspicabile in Idea per una storia universale dal punto di 133
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 vista cosmopolitico17, deve riuscire ad evolversi da semplice liberismo economico a progetto culturale per un mondo che possa vivere privo di violenze e disuguaglianze oppressive. La sfida che si svolge, a mio parere, è tutta culturale e non può che partire dall’Europa e dalla sua cultura. Il che significa ad esempio ridisegnare ed allargare la mappa dei diritti. Penso ad esempio all’accesso ad Internet, il quale è e deve poter essere un diritto per tutti, poiché può rivelarsi il veicolo dell’informazione e il mezzo della libertà di espressione18 e dunque la possibilità dello sviluppo umano e sociale di intere popolazioni. Penso inoltre, seguendo il pensiero di Jonas e del suo “Principio Responsabilità”19, anche alle problematiche legate all’ambiente e alla necessità di progettare politiche globali che salvaguardino il nostro patrimonio ambientale anche in una prospettiva futura e delle prossime generazioni (anche in questo caso è tristemente famosa la Cina, che è stimata essere la maggiore produttrice, insieme agli Stati Uniti, di inquinamento atmosferico). Ripensare una cultura condivisa, Rawls lo aveva ben compreso, come possiamo evincere da Liberalismo Politico20, non significa far passare un pensiero unico e non curante delle differenze sostanziali che la diversità del genere umano in tutte le sue sfaccettature ci propone, ma significa garantire che queste diversità abbiano modo di esprimersi al meglio. La differenza si trova tutta nella concezione d’individuo e di comunità. Se crediamo che l’individuo abbia la priorità nei confronti della comunità a cui appartiene (e oggi la comunità è globale), finiamo per cadere nell’individualismo che confina sostanzialmente con l’ egoismo; se invece crediamo che la comunità abbia la priorità rispetto al singolo, cadiamo nel comunitarismo che a sua volta confina con l’annullamento dell’io in favore di un noi che schiaccia il singolo. Il giusto rapporto tra individuo e comunità si trova nella democrazia rappresentativa. La libertà che la democrazia propone è una libertà che non si scontra con il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, né con la possibilità per ciascuno di vivere sapendo di avere almeno la possibilità di migliorare, basandosi sulle proprie capacità, la propria condizione di vita. Ecco perché credo che la democrazia sia l’unica forma di governo che possa adattarsi ai doveri e alle responsabilità che l’uomo ha nei confronti dell’altro presente e futuro. In questa prospettiva Kant prima e Rawls poi sono stati in modi diversi anticipatori di un destino globale che attende l’uomo e che lo spinge a vivere insieme agli altri in una terra relativamente piccola e con risorse limitate. Ma il concetto di democrazia deve andare di pari passo con un nuovo concetto d’individuo, un concetto che Rawls non approfondisce e che invece credo debba essere ripensato, superando in questo caso lo stesso filosofo. Se, come ho detto, il giusto equilibrio tra l’individualismo e il comunitarismo è la democrazia rappresentativa, il concetto filosofico entro cui pensare l’individuo che deve muoversi all’interno di questo spazio è quello del “personalismo comunitario”. Con personalismo comunitario intendo un modello di democrazia che consideri la persona 17 Kant I., Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Kant, Scritti di storia, politica e diritto, a cura di Gonnelli F., Editori Laterza, Roma – Bari 1999. 18 È ormai famoso il caso della Cina che negli ultimi anni ha imprigionato dissidenti che avevano espresso il loro parere contrario al regime proprio usando Internet. 19 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 2002. 20 J. Rawls, Liberalismo politico, traduzione di G. Rigamonti, a cura di S. Veca, Milano, Edizioni di Comunità, 1994. 134
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione come centro dell’agire politico, ma che veda essa stessa inserita all’interno di una comunità d’individui uniti da vincoli di solidarietà. Quella critica che Bloom muoveva a Rawls, accusandolo di aver sostituito la paura con l’equità, è forse l’intuizione più bella di Rawls, ovvero pensare che un popolo può sentirsi veramente unito solo quando non è la paura a tenerlo insieme, ma il riconoscimento del valore intrinseco ad ogni uomo e di conseguenza la solidarietà. Ciò che Rawls propone, ma che a mio avviso non sviluppa pienamente, ci fa capire come dalla società di massa siamo passati alla società dell’individuo, senza comprendere che è tenendo insieme la persona in quanto inserita in una comunità e la comunità in quanto composta di singole persone con le proprie differenze, le proprie storie e i propri obiettivi, che è possibile proporre un modello sostenibile di società. C’è però da compiere un’ulteriore riflessione: Data l’attuale situazione mondiale, ha ancora senso parlare di contratto sociale? Oppure le diversità tra individui e culture impediscono alla base il meccanismo puro e semplice del contratto? E ancora, è il “velo d’ignoranza” lo strumento adeguato per poter salvare oggi il modello del contratto sociale e renderlo attuale? Il processo del contratto sociale si basa sull’idea che gli agenti che lo stipulano condividano tutti la stessa ragione e che possano, alla luce di questa ragione, dare il proprio assenso ad alcuni principi. Ma è ancora possibile parlare di uomo in senso univoco, e la ragione è ancora oggi l’unico elemento che può garantirci la possibilità di un accordo? Il cambiamento dell’identità dell’io è, insieme alla necessità di parlare non più di beni primari ma di capacità, il sentore che l’appello alla sola ragione umana ha ormai fatto il suo tempo. Nel progettare il futuro, cercando di programmare la pacifica convivenza dei popoli, è necessario partire dalle diversità per trovare l’accordo sulle libertà fondamentali, ovvero rovesciare il processo che i contrattualisti e Rawls ci propongono, il quale invece, si basa su un “velo d’ignoranza” sul proprio futuro prossimo ed in definitiva anche sul proprio presente. Credo che tale approccio limiti dall’origine il concetto di democrazia, che è invece il concetto che ci preme salvaguardare. Se invece fin dall’origine le differenze sono considerate un elemento essenziale del processo e un elemento positivo, è auspicabile che il concetto di democrazia si allarghi per facilitare il passaggio da semplice regola di maggioranza, che pure è indispensabile per arrivare a compiere delle decisioni, a democrazia piena e salvaguardia delle minoranze. Forse allora lo strumento del contratto sociale può e deve essere superato, così come lo strumento del “velo d’ignoranza”, come ho sostenuto nel secondo paragrafo del secondo capitolo, seguendo le critiche fatte dalla Nussbaum a Rawls. Lo strumento del contratto sociale deve dunque essere superato, poiché non è più possibile considerarlo il mezzo attraverso il quale costruire la democrazia. Anche il concetto di io deve ricollocarsi all'interno di una prospettiva nuova, poiché deve essere capace di declinare su se stesso il concetto di responsabilità, laddove responsabilità significa anche valorizzazione e rispetto delle proprie ed altrui differenze. Nonostante ciò, le intuizioni di Rawls rimangono attuali, specie nel suo concetto‐chiave, ovvero il 'maximin', il quale rimanendo valido nella sua essenza, deve comunque essere ripensato alla luce della globalizzazione, staccandosi definitivamente dal contratto sociale. 135
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 La difficoltà più grande, a mio avviso, è come fare a ricreare, in un nuovo contesto, le condizioni adeguate per continuare a parlare di democrazia, seppur ripensata e in termini nuovi; il vero problema è che il modello democratico attualmente, vale entro le mura chiuse dei singoli stati (quelli democratici, ovviamente) e non riesce a superarle. D'altra parte, proprio la globalizzazione ha creato le condizioni affinché la libera circolazione delle idee e delle culture producesse da una parte omogeneità culturale, laddove non è la democrazia rappresentativa, ma sono le leggi, queste sì universali, del commercio e del capitale a dettare le regole della sopravvivenza e degli stili di vita, e dall’altra, l’accentuazione esasperata del conflitto tra il “mondo occidentale” e quelle minoranze integraliste che non si rassegano a conformarsi al nostro “stile di vita”. La nostra riflessione filosofica dovrà necessariamente investire il campo dell’economia e della finanza, come terreni sui quali confrontare lo strumento democrazia. Quanto infatti, il potere economico e quello finanziario a livello mondiale possono essere controllati attraverso un sistema di rappresentanza democratica? Il problema che si pone è evidentemente quello di fornire spazi vitali al concetto di democrazia e non relegarlo all’interno del solo meccanismo della rappresentanza politica (senza contare che in molti paesi del mondo, in cui vigono regimi totalitari, la democrazia politica sarebbe di per sé una grande conquista), ma riuscire a vincere lo schema secondo il quale è solo il fattore economico e finanziario a muovere gli interessi del mondo, senza che i suoi abitanti abbiano la possibilità di essere tutelati e possano attuare politiche di controllo diretto. Questo compito non spetta unicamente ai politici e ai governanti, spetta in primo luogo ai filosofi. È la filosofia politica che oggi deve assumersi il ruolo propositivo di saper interpretare la realtà in prospettiva, come già hanno saputo fare filosofi tra i quali Kant e più recentemente Rawls, e così facendo elaborare un progetto culturale ampio e innovativo. La sfida che si apre davanti ai nostri passi è quella di saper tracciare l’identità culturale di quei paesi che in tutto il mondo si dicono democratici, per far sì che tale parola non rimanga una pia illusione o un lusso per quei soli paesi che se la possono permettere. È la filosofia che può salvare l’uomo dai rischi dell’omogeneità culturale da una parte e dell’individualismo dall’altra, riuscendo a gettare basi condivise di rispetto, allargando la sfera dei diritti e dei doveri e rileggendo, alla luce della globalizzazione, il concetto di democrazia per allargarlo dal solo campo politico nazionale a quello internazionale, legandolo ai processi economici che, senza regolamentazione adeguata, rischiano di tenere sotto scacco la possibilità dei paesi poveri di emancipare loro stessi. Diletta Rigoli Bibliografia 1. Arendt H., La banalità del male. Eichman a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 2003. 2. Bloom A., "Justice: John Rawls versus The Tradition of Political Philosophy," in American Political Science Review 69 , 1975. 136
Diletta Rigoli – Rawls e Kant, dal contrattualismo alla globalizzazione 3. de Filippis B., Il problema della giustizia in Rawls, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1992. 4. Freeman S.(a cura di), Cambridge Companion to Rawls, Cambridge University Press, Cambridge 2002. 5. Galeotti A. E., Multiculturalismo: filosofia politica e conflitto identitario, Liguori, Napoli 1999. 6. Gilligan C., Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, Feltrinelli, Milano 1987. 7. Honig B., Political Theory and the Displacement of Politics, Ithaca: Cornell University Press, 1993 8. Iorio V., Istituzioni pubbliche e consenso in John Rawls, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995. 9. Jonas H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 2002. 10.Kant I., Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Kant, Scritti di storia, politica e diritto, a cura di Gonnelli F., Editori Laterza, Roma – Bari 1999. 11.Kant I., Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant, in Kant, Scritti di storia, politica e diritto, a cura di Gonnelli F., Editori Laterza, Roma – Bari 1999. 12.Magni S.F., Etica delle capacità, il Mulino, Bologna 2006. 13.Nussbaum M., Diventare persone, il Mulino, Bologna 2001. 14.Rawls J., La giustizia come equità. Saggi (1951‐1969), Liguori 1995, a cura di Ferrant G., Napoli, Liguori, 1995. 15.Rawls J., Liberalismo politico, traduzione di Rigamonti G., a cura di Veca S.,Milano, Edizioni di Comunità, 1994. 16.Rawls J., Una teoria della giustizia, traduzione di Santini U., revisione e cura di Maffettone S., Feltrinelli, Milano 1999. 17.Sciacca F., ( a cura di), Libertà fondamentali in John Rawls, presentazione di Veca S., Milano, A. Giuffré, 2000. 18.Sen A. K., La disuguaglianza, un riesame critico, il Mulino, Bologna 2002. 137
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 138
Etica del Miglioramento Genetico Rossella Pisconti [email protected] Abstract
In bioethical practice the interventions involving genetic mutations are frequent. Such mutations
can be operated not only for therapeutic purposes, but also for enhancing ones. The latest kind of
genetic interventions seems to completely transform, in some cases, the conceptual meaning that
we usually ascribe to the term ‘human being’.
This paper compares some reflections that Jürgen Habermas and Michael J. Sandel have recently
provided about the ethics of genetic enhancement, while paying particular attention to the concept
of human being. Therefore, the aim of the proposed analysis is that of considering such ethical
questions as: ‘Is the transformation of concepts connected to the way human beings change in the
course of time?’, ‘If the concept of human being changed, would it be a disaster?’, ‘Is that man who
underwent some biotechnological intervention still a “natural man”?’
Keywords: Jürgen Habermas, Michael J. Sandel, enhancement ethics, eugenics, transformation of
concepts, human being.
1. RESPONSABILITÀ SIMMETRICA TRA “PEERS” Le scienze biologiche e le biotecnologie, oltre ad intervenire con crescente frequenza in quelle circostanze in cui un soggetto necessita di cure, operano anche un diverso tipo di interventi. Essi possono soddisfare i desideri di coloro che pur non necessitando di miglioramenti terapeutici aspirano al “perfezionamento” genetico di alcuni caratteri. A partire dalla distinzione tra una trasformazione genetica terapeutica e quella volta a progettare organismi più efficienti, o rispondenti a un canone estetico specifico, Habermas ne Il futuro della natura umana1 si occupa delle questioni di carattere etico connesse agli interventi dell’ingegneria genetica sull’essere umano. Egli, in particolare, osserva che coloro che possono intervenire sulla dotazione genetica utilizzando nuovi strumenti possono farlo o in modo autonomo oppure in modo arbitrario. Nel primo caso, essi agiscono seguendo indicazioni di natura normativa che si sono formate in modo democratico. La scelta a favore di pratiche eugenetiche o contro le stesse sarà, quindi, determinata a maggioranza. Diversamente, favorendo o avversando in modo soggettivo alcuni interventi, costoro premieranno una scelta che si collocherà in un certo modo in base alle dinamiche di mercato. Con riguardo a quest’ultimo modo di operare, Habermas sostiene che l’ingegneria genetica, alleata con gli 1 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt, Suhrkamp, 2001; trad. it. Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino 2002. 139
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 interessi espressi dagli investitori di capitali, minaccia di travolgere ogni processo di scelta normativa che ha luogo nella sfera pubblica2. Habermas sostiene, innanzitutto, di non voler essere ‘pregiudizialmente critico’ verso le conquiste della scienza. A suo parere, il punto critico della questione coinciderebbe invece con la relazione che intercorre tra progresso scientifico e agenti responsabili. In particolare, Habermas si preoccupa di come alcune scoperte del sapere modifichino l’autocomprensione degli esseri umani come agenti responsabili. La possibilità di intervenire e modificare il genoma umano è una vicenda del tutto nuova. A tal proposito si osservano due tipi di visioni estreme. Da un lato si intende disciplinare sul piano normativo la crescita di una libertà smisurata. Dall’altro non autolimitare nessuna delle possibili richieste di trasformazione. Habermas osserva che un primo passo per limitare i possibili danni di una genetica “negativa”3 consisterebbe nell’optare a favore di una disciplina normativa sui nuovi interventi genetici. Se in passato si dava per scontato che le predisposizioni genetiche del neonato fossero sottratte alla manipolazione da parte di terzi, oggi vi è la possibilità di intervenire sulla natura umana. Habermas sembra rifiutare la manipolazione della procreazione poiché teme che ciò comporti il mutare del concetto stesso di procreazione inteso come processo contingente e indisponibile. Egli nota che in passato non vi era la possibilità di prevedere le combinazioni cromosomiche. Attualmente, invece, sembra sempre più possibile controllare il processo di procreazione e modellare il corredo genetico dei nascituri. Qui Habermas estremizza la propria preoccupazione, considerando l’ipotesi in cui sarà possibile ideare un “design” che soddisfi le esigenze del genitore. Nel caso in cui il genitore potesse progettare completamente il corredo genetico dei propri figli, secondo Habermas, questi ultimi potrebbero ritenere i genitori responsabili di un cambiamento che non avrebbero accettato se avessero avuto la capacità per farlo. Si considera in tale riflessione l’eventualità che la mutazione genetica operata possa apportare delle conseguenze negative nella vita di una persona. Inoltre, non si trascura l’ipotesi in cui le pratiche di bioingegneria siano considerate in futuro indesiderate dal soggetto sottoposto a trattamento. Habermas concentra la sua attenzione su tali eventualità per sostenere che i progressi della genetica inaugurano “un nuovo tipo di rapporto interpersonale”. Tale rapporto intercorre tra una persona che sta nascendo e coloro che intervengono sulla sua dotazione “naturale”. A tal proposito egli osserva: Questo rapporto, di tipo nuovo, ferisce la nostra sensibilità morale, in quanto rappresenta una sorta di 4
corpo estraneo nei rapporti di riconoscimento giuridicamente istituzionalizzati delle società moderne . 2 Crf. J. Habermas, op. cit., p. 21. 3 Habermas opera una distinzione tra genetica negativa e genetica positiva. Egli definisce la prima come corrispondente all’intervento genetico ritenuto giuridicamente lecito, mentre considera la seconda la pratica genetica che non viene permessa giuridicamente. Cfr., J. Habermas, op. cit., p. 21; p. 53. 4 J. Habermas, op. cit., p.16. 140
Rossella Pisconti – Etica del miglioramento genetico Per Habermas l’intervento di un soggetto x sui caratteri genetici di y rappresenta il costituirsi di un rapporto asimmetrico tra soggetti che sono liberi ed eguali5. Quindi, Habermas argomenta la propria posizione contro i progressi della genetica sostenendo 6
che tali sviluppi violano i principi liberali dell’autonomia e quelli dell’uguaglianza . Più esattamente, egli osserva che quando un soggetto è capace di intendere può decidere in prima persona di gestire ogni questione che necessita di essere affrontata. Questa capacità di scelta responsabile non si può riscontrare, invece, nel momento in cui si ammette la possibilità di interventi genetici sull’individuo, già’ nella sua fase prenatale. Il problema per Habermas consiste nel fatto che il soggetto su cui è stata operata una manipolazione genetica non può intervenire successivamente per cancellare tale intervento. Non è possibile quindi, per tale soggetto, retroattivamente far valere la propria posizione etica a riguardo. Una opinione che gli individui geneticamente modificati formeranno in futuro non potrà opporsi al processo di trasformazione avvenuto nel passato. In tale circostanza non vi sarebbero le condizioni per formare una relazione tra “peers7” ossia un rapporto simmetrico di responsabilità. I genitori con una scelta a favore della modificazione genetica interverrebbero su un individuo che non essendosi ancora formato non ha al momento della scelta un’opinione da far valere. Ciò secondo Habermas potrebbe condurre al risentimento colui che non accetta l’intervento di modificazione genetica e che invece lo ha subito in passato. In tali situazioni, Habermas ritiene che la decisione dei genitori di modificare geneticamente i figli non deve essere considerata come un’espressione della preoccupazione da parte di questi. Piuttosto tale scelta soddisfa 8
una forma d’agire strumentale , supportata dal desiderio di disporre del futuro di altri esseri umani, come se fossero degli oggetti. In alternativa all’esempio qui analizzato, in cui un soggetto non può decidere nei confronti di un eventuale intervento di modificazione genetica, Habermas esprime disappunto anche nei confronti della situazione in cui un adulto sia in grado di scegliere se optare per un intervento sul proprio genoma. Anche in questo caso, secondo Habermas vi sono delle difficili questioni morali da dover considerare. 2. AUTOCOMPRENSIONE ETICA DELL’UMANITÀ. DISTINZIONE TRA SPONTANEAMENTE CRESCIUTO E TECNICAMENTE PRODOTTO Con la nozione di “autocomprensione etica dell’umanità” Habermas si riferisce in particolare 9
alle riflessioni etiche concernenti quei casi di autocorrezione del genoma che comportano una 5 Ivi, p. 17. 6 M. J. Sandel, The case against perfection. Ethics in the age of genetic engineering, Harvard University Press, Harvard 2007; trad. it, Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 85. 7 J. Habermas, op. cit., p. 17. 8 Ivi, p. 47. 9 In forma più generale, tali discussioni sono riassumibili nel dibattito classico ‘natura vs cultura’. Per un approccio rinnovato, in cui vi è un superamento di tale dicotomia, si veda l’analisi che Rupert Read propone applicando la filosofia di Wittgenstein al tema. R. Read, Culture, Nature, Ecosystem ( or Why Nature Can’t Be Naturalized), in Feminist Interpretations of Ludwig Wittgenstein, N. Scheman e P. O’Connor ( a cura di ) The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania 2002, p. 408‐431. 141
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 mutazione completa dello stesso per fini diversi da quelli terapeutici. La riflessione sui progressi dell’ingegneria genetica conduce la riflessione habermasiana a tutelare una universalità antropologica a difesa di un certo concetto di “vita giusta”10. In particolare, Habermas lamenta la scarsa attenzione nei confronti della differenza etica che intercorre tra interventi terapeutici e interventi migliorativi. Se entrambi questi interventi fossero consentiti in base alla scelta individuale ciò comporterebbe una crescita indiscriminata dell’una o dell’altra pratica in base alla domanda e all’offerta delle stesse sul mercato. In particolare Habermas rivolge la sua preoccupazione alla diagnosi pre‐impianto e alla ricerca sulle cellule staminali sostenendo a riguardo che la prospettiva di convergenza tra queste si lega alla: auto strumentalizzazione e auto‐ottimizzazione che l’uomo sta per intraprendere a partire dai fondamenti 11
biologici della sua esistenza . In tal senso per Habermas si dovrebbe considerare immorale il rispetto narcisistico delle preferenze individuali a scapito dei “fondamenti naturali12”. Sembra che l’interesse di Habermas nei confronti della discussione sulla manipolazione genetica sia volto soprattutto ad osservare quello che egli ritiene un processo di sproporzione (operato tramite l’ingegneria genetica) nel rapporto tra ciò che è spontaneamente cresciuto e ciò che è tecnicamente prodotto, nettamente a favore di quest’ultimo. Difatti, i nuovi sviluppi della genetica intervengono sulla natura umana trasformando il concetto stesso di essere umano rispetto a quello in uso nel passato. Secondo Habermas le moderne scienze, mediante la sperimentazione, hanno contemplato la natura con un atteggiamento tecnico. Ma il rivoluzionamento genetico delle pratiche non è svincolato dalle dinamiche della natura. La sperimentazione operata dall’ingegnere biologo è vista da Habermas come un intervento che non produce la distinzione tra ciò che si è formato spontaneamente in natura e ciò che è artificialmente prodotto13. In questo modo è come se l’ingegneria genetica cancellasse la distinzione tra spontaneo e artificiale. L’annullamento di tale distinzione produrrebbe una trasformazione della nostra auto comprensione comportando un cambiamento del concetto di essere umano anche sul piano etico. Per Habermas la trasformazione del concetto di essere umano intacca sul piano morale quelli che 10 J. Habermas, op. cit., p. 18. 11 Ivi, p. 23. 12 Come osserva Sandel, l’argomentare contro l’uso della manipolazione genetica per scopi non terapeutici facendo appello alla difesa di ciò che è “naturale” è legato a delle convinzioni di natura religiosa. In tal senso, riferendosi ad Habermas, egli nota: che «la sua tesi contro l’eugenetica liberale è particolarmente interessante perché egli è convinto che poggi su premesse rigorosamente liberali, e non implichi l’accettazione di convinzioni spirituali o teologiche». Sulle conseguenze di un’etica fondata su leggi universali ritenute naturali perché volute da Dio, E. Lecaldano scrive «L’appello a una ragione universale non solo non spiega, negandolo, il fatto storico della pluralità di concezioni morali divergenti ( e la realtà dei disaccordi su questioni etiche), ma non è nemmeno in grado di offrire un qualche suggerimento circa i criteri percorribili per attenuare e ridurre gli esiti di diverse convinzioni etiche, di indicare cioè le procedure che sole permetterebbero la convivenza pacifica tra gli individui […] L’appello alla natura e alle leggi immutabili in essa presenti, allo scopo di orientare la nostra vita morale, equivale a fare appello a un criterio del tutto insoddisfacente e comunque errato. [...] Coloro che presentano la loro morale come tesa ad affermare ciò che è naturale per l’uomo in realtà definiscono natura o secondo natura attraverso decisioni preventive e funzionali a quanto vogliono impedire o condannare o concedere» E. Lecaldano, Un’etica senza Dio, Laterza, Roma Bari 2006, p. 16‐17. 13 Ivi, p. 49. 142
Rossella Pisconti – Etica del miglioramento genetico chiamo i Bedingungen der Naturwüchsigkeit (“requisiti di naturalità”)14. In mancanza di tali requisiti non possiamo intenderci come autori della nostra vita e membri alla pari in una comunità morale. Habermas descrive tali “requisiti” come indispensabili affinché non si crei un “disturbo alla naturalezza”. Egli intende con ciò riferirsi ad una asimmetria tra parti naturali e parti artificiali. Precludendo interventi di natura genetica si vuole evitare una relazione di asimmetria tra le persone dovuta all’introduzione di elementi artificiali in alcune di esse. 3. LA RIVOLUZIONE GENOMICA E LA VISONE MORALE Sandel, opponendosi alla posizione assunta da Habermas, osserva che lo sviluppo della genetica ci propone una promessa e una difficoltà15. La promessa corrisponde all’auspicarsi che in futuro sia possibile curare e perfino prevenire un gran numero di gravi malattie. La difficoltà compare, invece, nel discorso morale e politico quando esso considera certi tipi di ingegneria genetica come un turbamento. In particolare, a ogni forma di bioingegneria viene mossa l’obiezione che, prestabilendo la composizione genetica di un soggetto, questo viene privato del diritto a un futuro di diverso tipo rispetto a quello che si sarebbe dovuto formare. I figli su cui si interviene geneticamente potrebbero essere considerati, ad esempio, non pienamente liberi. Anche quei cambiamenti che potrebbero migliorarne le prestazioni in alcune attività risulterebbero prestabiliti compromettendo il modo in cui la loro esistenza avrebbe dovuto, invece, prendere forma. Sandel mette in luce alcuni aspetti della discussione etica sui progressi della genetica considerando innanzitutto che l’argomento dell’autonomia non è convincente se adoperato per far cogliere alle persone i pericoli legati alla manipolazione genetica. Vi sono in particolare due punti da dover considerare riguardo la questione dell’autonomia: 1) Si trascura erroneamente che in mancanza di un genitore “progettante” i figli non sono liberi di scegliere le caratteristiche biologiche di cui potranno dotarsi. In tal caso, difatti, questi si formerebbero a discrezione della casuale combinazione genetica. 2) La preoccupazione riguardo l’autonomia, anche qualora fosse intesa come colpevole creatrice di prototipi di essere umano, non spiega la riluttanza morale nei confronti di coloro che apprezzano la possibilità di un miglioramento genetico che possa produrre dei vantaggi personali. Sandel osserva che il disagio morale16 che sorge quando le persone ricorrono alle terapie genetiche corrisponde a un rifiuto di quegli interventi che non sono compiuti al fine di curare una malattia. Tali manipolazioni genetiche, consentirebbero di apportare dei miglioramenti con vantaggi estranei alla finalità del mero voler star bene in salute. Ad ogni modo, anche se 14 Ivi, p. 44. 15 M. J. Sandel, op. cit., p. 23. 16 Ivi, p. 24. 143
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 inverosimilmente considerassimo l’autonomia immorale e decidessimo di rifiutarla, ciò non implicherebbe di conseguenza un annientamento del disagio nutrito nei confronti dell’ingegneria genetica. A tal proposito Sandel osserva: «è un disagio giustificato? E se lo è, quali sono i motivi?»17. La rivoluzione genomica conduce a una specie di vertigine quando il vocabolario morale che usiamo non ci fornisce indicazioni su come procedere in nuove situazioni che non avevamo previsto. Per affrontare i temi dell’etica del miglioramento genetico non dobbiamo trascurare la portata che le biotecnologie hanno nei casi particolari in cui esse sono in uso. Difatti osservando quanto sostiene Habermas sul concetto di responsabilità simmetrica tra ‘peers’ sembra che si debbano sempre distinguere (ammettendo che ciò sia possibile) delle implicazioni di natura morale differenti tra il curare e migliorare un essere umano. Se riflettiamo a fondo su tale distinzione potremmo sostenere in primo luogo che un atleta geneticamente modificato acquisisce un ingiusto vantaggio sugli altri avversari in gioco che non si sono sottoposti allo stesso genere di cambiamenti. Come osserva Sandel “la pecca fatale” contro l’argomento dell’equità18 in tema di miglioramento genetico risiede nel fatto che da sempre alcuni atleti possono considerarsi geneticamente più dotati rispetto ad altri. Questo non è stato considerato un elemento lesivo dell’equità nei confronti degli altri atleti che competevano nelle medesime gare. Se consideriamo fondamentale la parità tra concorrenti in una gara possiamo constatare che la disuguaglianza data dalla manipolazione genetica pone le stesse problematiche della genetica naturale. Nel caso in cui non si ritiene che la diversità genetica artificiale possa creare disparità tra concorrenti, lo stesso dovrà dirsi della disuguaglianza naturale. In tal senso il problema dell’equità non è un motivo che ci consente di considerare problematica l’accettazione del miglioramento genetico. 4. EUGENETICA E COERCIZIONE POLITICA L’eugenetica liberale, se intesa come un movimento di riforma della società, conferisce importanza alle scelte individuali ma comporta al contempo, per Sandel, la necessità di una coercizione statale. Al di là del caso in cui i difensori del miglioramento non riscontrino delle differenze morali tra un miglioramento delle capacità intellettuali di un soggetto conseguito con l’istruzione o con la manipolazione genetica l’importante per la visione liberal‐eugenetica è che la manipolazione non violi l’autonomia19 del soggetto a cui si applicano tali modificazioni. Il 17 Ivi, p. 25. 18 Ivi, p. 28. 19 La violazione del diritto all’autonomia non si avrebbe in tal caso perché, come osserva Dworkin «il diritto all’autonomia di una persona è semplicemente il diritto a che siano rispettate le sue decisioni presenti, non quelle passate». Dworkin si riferisce, in particolare, al caso specifico in cui una persona sottoscrive un testamento per disporre in merito al trattamento che vorrebbe gli fosse riservato nell’eventualità in cui diventasse insana di mente. Tuttavia, il concetto di autonomia qui proposto può essere applicato al caso in cui si debba considerare una distinzione temporale tra l’incapacità di un embrione di esprimere il proprio giudizio sulle modificazioni genetiche in tale stadio e la possibilità che egli in futuro possa esprimersi diversamente in merito. R. Dworkin, Life’s Dominion: an 144
Rossella Pisconti – Etica del miglioramento genetico miglioramento operato è moralmente accettabile se è un mezzo20 risolutivo per qualsiasi tipo di esigenza che il soggetto vorrà soddisfare nel futuro e non lo indirizza verso un particolare tipo di attitudine e quindi carriera. Rispettando l’autonomia del bambino, su cui sono intervenute trasformazioni genetiche, l’eugenetica liberale non condanna l’azione coercitiva sull’ingegneria genetica da parte dello Stato. Si immagini in primo luogo una situazione in cui il livello di miglioramento prodotto dalla mutazione genetica, espresso in termini quantitativi, sia determinato dalle dinamiche di mercato. Si potrebbe rappresentare tale situazione graficamente come illustrato nella Fig.121. Costi/
Benefici
CM(E)
BM(E)
Enhancement
0
E(M)
Fig.1 Tale rappresentazione potrà confrontarsi con quella riportata nella Fig.2, che corrisponde, invece, ad una situazione in cui vi è l’intervento dello Stato. Questo, mediante l’introduzione di una norma, limita il livello di miglioramento operabile. argument about abortion and euthanasia, Harper Collins, London 1993; trad. it., Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Edizioni di Comunità, Milano 1994, p. 312. 20 Ivi, p. 84. 21 Cfr. R. H. Frank Microeconomia, McGraw‐Hill, Milano 1998, p. 52‐56. 145
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Costi/
Benefici
CM(E)''
Traslazione prodotta
dalla norma
CM(E)
BM(E)
Enhancement
0
(S)
E
(M)
E
Fig.2 Nelle Figg. 1 e 2 si evidenzia come ad ogni miglioramento incrementale (E), leggibile sull’asse delle ascisse, corrispondano dei costi e dei benefici marginali, leggibili sull’asse delle ordinate, rappresentati, rispettivamente, dalle curve BM(E) e CM(E). In particolare, conformemente ai dettami dell’economia neoclassica, i benefici marginali decrescono al crescere dei livelli di miglioramento. I costi marginali, invece, assumono un andamento crescente (produrre un’unità aggiuntiva di miglioramento costa sempre di più). Alle condizioni di mercato illustrate, si sceglierà di operare un miglioramento fino al livello indicato con E(M). Tale livello corrisponde, infatti, all’incontro tra domanda e offerta di mercato (rappresentate rispettivamente dalle curve BM e CM). Tuttavia lo Stato potrebbe interviene per operare una modificazione di tale livello di miglioramento. Nel caso rappresentato in Fig.2 si tratta di una riduzione, ottenuta rendendo più oneroso l’impiego di interventi di miglioramento (causando in tal modo la traslazione verso l’alto della curva dei costi marginali, che passa da CM(E) a CM(E)’’). Confrontando la situazione in cui dinamiche di mercato operano liberamente e il caso in cui lo Stato interviene modificando il punto di incontro tra domanda e offerta, Sandel osserva che Habermas22 sviluppa la propria argomentazione anche in opposizione alla sperimentazione eugenetica nazista operata in passato dallo Stato23. Per questo Habermas, pur dichiarandosi a 22 Il lavoro di John Harris si propone come alternativa alle analisi elaborate da Michael Sandel e Jürgen Habermas. J. Harris, Enhancing evolution. The ethical case for making better people, Princeton University Press, Princeton 2007. In particolare si vedano i capitoli 7 e 8 del testo, pp. 109‐142. 23 Ivi, p. 85. 146
Rossella Pisconti – Etica del miglioramento genetico favore di una norma posta dallo Stato sulle pratiche del miglioramento genetico, al contempo, ritiene che l’unico modo per evitare il riproporsi dei vecchi fantasmi della storia risieda nell’opporsi alla manipolazione genetica, finanche al semplice screening embrionale per scopi non terapeutici. Habermas per evitare i problemi del passato, perorando, quindi, una giusta causa, propone una soluzione contraddittoria. Difatti, se il problema è di natura politica e riguarda il controllo da parte delle persone di ciò che lo Stato può senza riserve imporre, la soluzione della questione non è sicuramente quella di limitare la libertà delle persone, come invece propone Habermas. L’intervento genetico per migliorare le future generazioni è per Habermas criticabile perché viola il principio dell’autonomia e dell’uguaglianza. In particolare, gli individui programmati non possono considerare se stessi autori del proprio futuro. Inoltre, l’intervento genetico distrugge l’eguaglianza in cui vi sono reciproci e simmetrici rapporti di riconoscimento in una comunità morale e politica. I genitori decidendo per i propri figli stabiliscono con loro un rapporto asimmetrico assumendosi la responsabilità per conto dei figli stessi. Per Sandel, la contraddizione della riflessione di Habermas non sta nell’essere contrario a genitori eugenetici ma nell’affermare che gli argomenti contro questa pratica possono reggersi in opposizione al pensiero liberale. Difatti, i difensori dell’eugenetica liberale obiettano alle riflessioni di Habermas che la preoccupazione riguardo l’asimmetria che lega il rapporto genitori/figli è legittima anche quando i genitori costringono i propri figli a esercitarsi costantemente in una attività. La questione su cui insistono i liberali è quella di valutare se gli interventi genetici richiesti dai genitori o quelli di altra natura scelti sempre da questi per i propri figli (ad esempio l’iscrizione a una scuola elementare privata al posto di una pubblica), ne pregiudichino la libertà di decidere in che modo indirizzare il corso della propria vita. Così, secondo Sandel, la scelta eugenetica dei genitori non pregiudica l’autonomia dei figli in misura differente rispetto all’operare della lotteria naturale. La scelta di migliorare i propri figli geneticamente potrebbe essere criticabile qualora recasse un atteggiamento sproporzionato di padronanza e di dominio verso il mondo nella sua interezza24. 5. IL CONCETTO DI ESSERE UMANO E IL TIMORE PROMETEICO NEI CONFRONTI DELLA SUA TRASFORMAZIONE In ultimo, consideriamo quali sono i vantaggi della trasformazione genetica. Come rilevato nel corso della trattazione, nella pratica bioetica si interviene frequentemente con mutazioni genetiche. In questi casi potremmo ravvisare dei cambiamenti che sembrano trasformare completamente il significato concettuale che conferiamo ad alcune parole nella pratica d’uso del linguaggio. La trasformazione in oggetto potrebbe essere tale da stravolgere i limiti in cui si muove il nostro pensiero morale. In alcuni casi, le trasformazioni intervengono sul concetto di natura. In particolare ciò avviene quando esse interessano ad esempio i nostri concetti di procreazione e di nascita. La trasformazione può avvenire in vari modi e in alcuni casi essa equivale alla dissoluzione dei vecchi concetti. Come abbiamo visto, la perdita delle risorse 24 Ivi, pp. 68‐69. 147
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 concettuali che ci consentono di pensare a noi stessi come esseri umani è uno degli argomenti centrali della discussione di Habermas25. Possiamo leggere il quadro filosofico che egli propone adottando anche una prospettiva attenta alla sfera concettuale26. Habermas descrive kantianamente come la possibilità di trattarsi come eguali dipenda da quella che egli chiama un’autocomprensione etica del genere umano come esseri biologici ben definiti27. Consideriamo innanzitutto che i concetti della nostra vita morale dipendono in particolare da una distinzione tra lo sfondo naturale e le attività degli esseri umani che si muovono su tale sfondo. Per Habermas modificando la natura per fini non terapeutici si corre il rischio di perdere il concetto di essere umano biologico – che egli reputa di un certo tipo, ossia incontingente e indisponibile. Habermas sostiene che la scelta di usare nuove tecniche di miglioramento genetico comporta uno spostamento del confine che separa lo sfondo naturale e gli esseri umani che svolgono delle attività su quello sfondo28. Sul piano concettuale la trasformazione del concetto stesso di essere umano potrebbe produrre un senso di avversione nei confronti di queste scelte. Contrariamente a quanto sostenuto da Habermas, l’operare scelte volte a curare e il porre l’attenzione nei confronti della nascita naturale garantisce che il concetto di essere umano non è perduto. Come ha dimostrato Donatelli, la posizione di Habermas su cosa significhi avere o perdere concetti non è difesa in modo chiaro sul piano concettuale29, poiché possiamo considerare un tipo di azione come moralmente sbagliata solo quando comprendiamo il tipo di esseri umani coinvolti in essa30. Vi sono diverse cose, attività, atteggiamenti reazioni naturali, che concorrono al formarsi del concetto di essere umano. Pertanto, l’uso di un’espressione non è immodificabile ma è correlata agli illimitati modi di impiego. O meglio: «nuovi tipi di linguaggio sorgono […] e altri invecchiano e vengono dimenticati».31 Gli usi dei concetti che ci sono stati tramandati possono essere depositari di immagini di un certo tipo che ignorano altri modi in cui un concetto potrebbe essere impiegato nel corso della storia umana. Pensiamo ad esempio alla trasformazione che avverrebbe nel concetto di uomo di sesso maschile, geneticamente non in grado di condurre una gravidanza32, qualora una modificazione genetica gli consentisse di scegliere di vivere questa particolare condizione. Ci si 25 J. Habermas, op. cit., pp. 28‐82. 26 Cfr., P. Donatelli, L’etica, l’immaginazione e il concetto di natura umana in Rivista di Filosofia, Agosto 2008, pp. 229‐262. 27 J. Habermas, op. cit., p. 28. 28 Ivi, p. 30. 29 Ivi, p. 29 e vedere anche il Poscritto, p. 82. 30 P. Donatelli, op. cit. 31 L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino 2004, §.23. 32 Si pensi, ad esempio, alla recente storia di Thomas Beatie dell’Oregon che secondo la stampa americana è il primo uomo in gravidanza. La notizia è apparsa sulla rivista The Advocate March 26, 2008. 148
Rossella Pisconti – Etica del miglioramento genetico potrebbe domandare se sia moralmente accettabile una teoria che difendendo il concetto di essere umano come vincolato a una nozione di “natura contingente e indisponibile” impedisce a coloro che non si conformano ai suoi dettami di essere liberi. Si potrebbe, inoltre, riflettere su quanto ci sia di naturale nell’impedire la realizzazione di un desiderio umano che, come in questo caso, non arreca danno agli altri che non lo condividono. Le attività di intervento genetico precedentemente menzionate trasformano il concetto di essere umano rendendolo più vicino a ciò che esso si presta a descrivere, ossia l’eterogeneità degli individui e l’esplicarsi di essa nella pratica. Collocando le ragioni da cui trae ispirazione il lavoro di Habermas in un contesto filosofico più ampio, egli sembra sostenere che corriamo un pericolo se un certo tipo di concetto di “essere umano” si perde. Tale pericolo sarebbe insito al cambiamento che le nuove pratiche apporterebbero sul piano concettuale. Al contrario, Sandel sostiene che l’intento del pensiero critico non è tanto dimostrare se tali pratiche siano corrette o meno sul piano morale, quanto se esse non conducano a mutare la nostra natura. Ad esempio, se l’attività sportiva modifica la stessa natura biologica di chi la pratica non è possibile sapere in quali circostanze un soggetto possa dirsi ancora “uno sportivo” inteso come colui che, si presume, metta alla prova le proprie capacità fisiche. Tale interrogativo concerne in particolare il concetto di sport e il cambiare o perdersi dello stesso33. Lo sviluppo della scienza nel campo della bioetica ha fatto riaffiorare il timore che si possa perdere il concetto di natura come qualcosa che costituisce uno sfondo su cui opera l’attività umana. Nei confronti della trasformazione della natura umana vi è un timore prometeico34 da parte di Habermas che si traduce sul piano concettuale. Affermare, come fa Habermas, che il concetto di essere umano è un universale antropologico, significa guardare con timore a un cambiamento nei modi di vita degli esseri umani. Habermas, sul piano della morale, intende proteggere un concetto di essere umano che non è soggetto al cambiamento, poiché il suo timore è quello che «la specie umana possa, a breve termine, prendere nelle sue mani la propria evoluzione biologica»35. Egli trascura che i concetti sono in connessione tra di loro e che, ad esempio, il concetto di nascita è legato alla nozione di scelta e di responsabilità. Interrogarsi sulla vita di questi concetti non equivale ad applicare un principio di giustizia che fissi stabilmente come si debba agire in ogni caso. Al contrario, se consideriamo sul piano morale che i concetti sono disomogenei, ciò comporterà che volta per volta, in ogni situazione differente, ci si possa mettere in gioco responsabilmente, stimolando il pensiero critico a confrontarsi con la trasformazione che le attività hanno operato all’interno dei nostri concetti. 33 M. J. Sandel, op. cit., pp. 26‐27. 34 Il timore prometeico di Habermas è ravvisato nella concezione secondo cui il concetto di essere umano non deve mai mutare. In tal modo, è come se Habermas volesse sottrarre il concetto di essere umano all’uso che nella vita può farsi di esso. 35 J. Habermas, op. cit., p. 24. 149
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Un argomento che è frequentemente invocato contro l’intervento eugenetico è che esso è moralmente sbagliato36. La domanda che ci si è posti in questo contributo è se debba ritenersi sempre immorale operare questo genere di interventi. Come abbiamo visto, per Habermas l’intervento sui caratteri genetici nel periodo di gestazione ferirebbe la sensibilità morale sia perché impedisce la formazione di un rapporto paritetico tra genitore e futuro figlio, sia perché arrecherebbe dei danni al concetto di procreazione, mutandolo. In particolare Habermas sostiene che nel futuro un soggetto non potrà far valere il proprio dissenso retroattivamente su un eventuale intervento genetico operato su di esso in passato. Pertanto, un soggetto al cui genoma sono state apportate delle modifiche, si troverebbe in una condizione di inferiorità nei confronti di coloro che, invece, hanno scelto di operare tale intervento. Confrontando la posizione di Habermas con quella di Sandel, sono stati posti in evidenza dei punti di convergenza e divergenza tra le stesse. Sandel, opponendosi alla visione habermassiana, nota che i figli non sono comunque liberi di scegliere le caratteristiche biologiche di cui potranno dotarsi, anche in mancanza di un genitore “progettante”37. Dall’altro canto, la visione di Habermas riguardo le pratiche eugenetiche sottolinea l’importanza che riveste il rispetto morale dei cosiddetti “requisiti di naturalità”38. Su questo punto anche Sandel sostiene che l’intento del pensiero critico non è tanto dimostrare se tali pratiche siano corrette o meno sul piano morale, quanto se esse non conducano a mutare la nostra natura. Sia Habermas che Sandel temono che la manipolazione dell’embrione comporti una trasformazione del concetto stesso di essere umano. L’impulso a cambiare la natura umana attraverso la genetica è condannabile, secondo Sandel, perché esprime una volontà di dominio che rifiuta di identificare come “dono”39 quelle caratteristiche che dobbiamo invece accettare in ciascun essere umano. Sul piano politico Sandel reputa che l’eugenetica liberale conferisca importanza alle scelte individuali e che comporti al contempo la necessità di una coercizione statale. Il problema di natura politica riguarda il controllo da parte delle persone di ciò che lo Stato può senza riserve imporre. Tuttavia Sandel osserva che la soluzione della questione non è sicuramente quella di limitare la libertà delle persone, come invece propone Habermas. Esula dagli intenti di questo contributo l’entrare nel merito delle posizioni qui oggetto di discussione, poiché si è inteso solo mostrare come sia eccessivamente pessimistico pensare al cambiamento come qualcosa di necessariamente sbagliato, in grado di arrecare 36 Sul considerare l’intervento eugenetico sbagliato moralmente perché offre un sotterfugio, delle ‘easy shortcut’ a ciò che è problematico, si veda il recente contributo di M. Schermen, Enhancements, easy shortcuts, and the richness of human activities, in Bioethics, Volume 22 numero 7, 2008 pp. 355‐363. 37 M. J. Sandel, op. cit., p. 87. 38 J. Habermas, op. cit., p. 44. 39 Sul preservare il concetto di dono, opponendosi alle pratiche eugenetiche, Sandel scrive «l'impulso a cancellare il contingente e padroneggiare il mistero della nascita sminuisce il genitore progettante e corrompe l'essere genitori come pratica sociale governata da norme di amore incondizionato. Il che ci riporta ai doni naturali. Anche se non danneggia il figlio e non pregiudica la sua autonomia, lo stile parentale eugenetico è criticabile perché manifesta e rende radicato un certo atteggiamento verso il mondo, un atteggiamento di padronanza e di dominio che non riesce ad apprezzare il carattere di dono della potenza e dei successi umani e a cui sfugge quella caratteristica della libertà che consiste in un negoziato permanente con ciò che è dato», M. Sandel, op. cit., pp. 87‐88. 150
Rossella Pisconti – Etica del miglioramento genetico esclusivamente dei danni40. Si è considerato questo aspetto incanalando il quadro filosofico, in ultimo, in una prospettiva attenta alla sfera concettuale. La dimensione dei concetti è data dalle attività che gli esseri umani svolgono, definendosi volta per volta. La visione di Habermas e quella di Sandel pretendono, invece, entrambe di aver esaurito, mediante una definizione dogmatica della natura umana (concernente dei requisiti per l’uno, intesa come dono per l’altro) la descrizione degli aspetti dell’essere umano nel suo complesso. Entrambi, in tal modo, sembrano eludere le molteplici prassi d’uso in cui ogni ‘essere umano’ forma, potremmo dire con Wittgenstein as we go along 41, il concetto di essere umano. Non si nega che gli interventi di eugenetica sull’embrione potrebbero condurci a uno stato di incertezza, ossia a preoccuparci delle conseguenze che un cambiamento può comportare nel modo in cui intendiamo nel presente il concetto di essere umano. Tuttavia, tale incertezza consente di interrogarci sull’uso del concetto volta per volta nel caso particolare, valutando la problematicità o al contrario l’arricchimento che il cambiamento può determinare. Rifiutare di separare l’analisi dei concetti – tra cui, quindi, anche quello di essere umano – dall’uso degli stessi consente di essere aperti a nuovi modi di intendere i concetti che non ci sono stati insegnati nel passato. Porre attenzione a tali possibilità permette di guardare al concetto di essere umano come libero da quelle teorie che pensano di poterlo definire mediante un dogma e come aperto a nuove direzioni di sviluppo anche quando queste non sono state ancora tematizzate. Rossella Pisconti Bibliografia 1. Cascione G., Le regole della comunità. Utopia e linguaggio tra Nancy e Wittgenstein, Progedit, Bari 2004. 2. Donatelli P., L’etica, l’immaginazione e il concetto di natura umana in Rivista di Filosofia, Agosto 2008. 3. Dworkin R., Life’s Dominion: an argument about abortion and euthanasia, Harper Collins, London 1993; trad. it., Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Edizioni di Comunità, Milano 1994. 4. Frank R. H., Microeconomia, McGraw‐Hill, Milano 1998. 40 Sull’opposizione dei pensatori conservatori all’enhancement, si veda la ricostruzione proposta da James Wilson, Transhumanism and moral equity, in Bioethics, Volume 21, numero 8, 2007, pp. 419–425. In particolare nell’introduzione si propone un prospetto sintetico sulla questione, p. 419‐420. 41 L. Wittgenstein, op. cit.,§.83. Sulla fertilità che l’applicazione del metodo di Wittgenstein apporta in ambiti della conoscenza anche diversi da quello linguistico, logico ed epistemologico si veda Read R., Applying Wittgenstein, Cook L. ( a cura di), London Continuum, 2007. In particolare, sul vagliare lo spirito etico del lavoro di Wittgenstein con riguardo all’analisi dei concetti e delle regole si vedano G. Cascione, Le regole della comunità, Progedit, Bari 2004; e il mio R. Pisconti, Sulla questione delle regole in Wittgenstein. Etica e Politica nelle “Ricerche Filosofiche”, Il Filo, Roma 2008. 151
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 5. Habermas J., Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt, Suhrkamp, 2001; trad. it. Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino 2002. 6. Harris J., Enhancing evolution. The ethical case for making better people, Princeton University Press, Princeton 2007. 7. Lecaldano E., Un’etica senza Dio, Laterza, Roma Bari 2006. 8. Pisconti R., Sulla questione delle regole in Wittgenstein. Etica e Politica nelle “Ricerche Filosofiche”, Il Filo, Roma 2008. 9. Read R., ‐ Culture, Nature, Ecosystem (or Why Nature Can’t Be Naturalized), in Feminist Interpretations of Ludwig Wittgenstein, N. Scheman e P. O’Connor (a cura di) The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania 2002. ‐ Applying Wittgenstein, Cook L. (a cura di), London Continuum, 2007. 10. Sandel M. J., The case against perfection. Ethics in the age of genetic engineering, Harvard University Press, Harvard 2007; trad. it, Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008. 11. Schermen M., Enhancements, easy shortcuts, and the richness of human activities, in Bioethics, Volume 22 numero 7, 2008. 12. Wilson J., Transhumanism and moral equity, in Bioethics, Volume 21, numero 8, 2007. 13. Wittgenstein L., Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino 2004. 152
A proposito dell’etica cristiana Paolo Arzani [email protected] Abstract
Talking about Christian ethics is not meant to be a discussion on a rational adjustment to some
moral rules, even high. The matter is the consequence of a deep spirit’s movement that constitutes
the chance for a new life to emerge from interiority. This perspective relies on the idea that only
such an opening could let our spirit direct us to unthinkable love’s possibilities.
Keywords: Christian ethics, man, faith, God.
È impossibile parlare di etica cristiana a prescindere da Dio. Impossibile, anche se oggi, da più parti, si propaganda e valorizza un’etica cristiana laica, una sorta di insieme ateo di valori umani e religiosi che anche un non credente, appunto, potrebbe condividere quale fondamento della società1. Quando parlo di Dio non intendo il Dio che, simbolicamente, sul Sinai, in mezzo a fiamme di fuoco e squilli di tromba, tuoni e terremoti, detta le sue leggi a Mosè. Non intendo, cioè, Dio in quanto autore e fondamento ultimo della legge morale. Il Dio trascendente, il Totalmente altro, il Dio creatore, il Dio che, spesso, è stato utilizzato come necessità logica per spiegare il perché esista qualcosa anziché il nulla. Intendo Dio come quel mistero di fuoco, di luce, di amore assoluto che, sebbene ‘altro’ rispetto a noi, coincide però col fondo di noi stessi. È il Dio dei mistici. È il Dio di Eckhart, il quale così si esprime in un Sermone: «… il piccolo testo che vi ho presentato dice: Dio ha inviato il suo unico Figlio nel mondo. Non dovete intendere come mondo esterno, in quanto egli mangiava e beveva con noi, ma dovete intenderlo in relazione al mondo interiore. Così come il Padre, nella sua semplice natura, genera il Figlio, altrettanto naturalmente lo genera nella parte più intima dello spirito, e quello è il mondo interiore. Qui il fondo di 2
Dio è il mio fondo, e il mio fondo è il fondo di Dio . Qui io vivo secondo il mio essere proprio, così come Dio vive secondo il suo essere proprio. Per chi ha gettato anche solo un istante uno sguardo in questo 1
Al di là di posizioni prese da filosofi dell'essere, a esempio Gianni Vattimo, si tratta di un fenomeno in piena diffusione: politici, intellettuali, giornalisti che, anche se non credenti dichiarati, tendono a difendere le idee e le posizioni della chiesa cattolica anche in materia di morale, contrapponendosi contemporaneamente all'Islam e alla visione laica. Il fenomeno è diffuso anche fuori d'Italia, come testimoniano i Teocon negli Stati Uniti. Alcuni esponenti della chiesa stessa appoggiano questa tendenza, vedendo in essa una prova che è possibile uniformarsi alle regole di convivenza prescritte dalla chiesa anche senza il bisogno di credere. Cf. ad esempio G. Lerner, La santa alleanza degli atei devoti in La Repubblica 8 gennaio 2008. 2
L’identificazione del fondo dell’anima col fondo di Dio avviene in quanto il fondo è l’Uno, nella sua semplicità. L’ ‘Uno semplice’ (einvaltic ein) coincide col ‘fondo’ e indica il ‘luogo’ dove avviene la nascita del Logos nell’anima, in quanto «unico essere indiviso di Dio e dell’anima» (M. Eckhart, Sermoni Latini 117). Cf. M. Eckhart, I Sermoni, trad. it. Roma 2002, 126‐127, nn. 7 e 10. 153 Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 fondo, per costui mille marchi d’oro rosso coniato sono come un soldo falso. È a partire da questo fondo più intimo che tu devi operare tutte le opere, senza perché»3 . Ne deriva, a sentire Eckhart, che la distinzione tra credente e non credente non si gioca più tanto, in ultima analisi, sull’annosa questione se esista o meno un dio al di fuori di noi, un dio che ha creato in qualche modo il mondo e via di seguito, ma se io coincido con il mio Io psichico (l’Ego) e con le altre sfere psichiche, oppure se il mio autentico Io è altro dal mio Ego, altro dalla mia psiche, paradossalmente altro da me. L’ardito pensiero di Eckhart ha naturalmente un fondamento biblico. La riflessione dell’evangelista Giovanni sull’operato di Gesù di Nazaret fa di Gesù il Verbo di Dio (cf. Gv 1,1), colui che porta a compimento l’opera creatrice del Padre (cf. Gv 19,30). Quell’orma divina che c’è nell’uomo fin dalle origini, in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gn 1,26‐
27), giunge a pieno compimento nella ‘nuova creazione’, nella trasformazione del credente in ‘figlio di Dio’ a opera dello Spirito di Cristo: «A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati»4 . E questo non ‘alla fine dei tempi’, al compimento della storia che segue il ritorno glorioso di Cristo, oppure in un ‘al di là’ non ben definito, ma qui e ora grazie allo Spirito che prende possesso del credente dal profondo. Giovanni parla, infatti, di ‘inabitazione’ dello Spirito e di Cristo nel credente. Nel lungo discorso dell’ultima cena, il suo ‘testamento’, Gesù si rivolge ai discepoli con queste parole: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore5 perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi»6 . E, più avanti, aggiunge: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23). In maniera più razionale e assai meno poetica rispetto al vangelo di Giovanni, anche le lettere di San Paolo, anteriori di circa mezzo secolo, esprimono la medesima idea: l’uomo è tempio di Dio (cf. 1 Cor 3,16; 16,17‐18; 2 Cor 6,16). Nella lettera ai Colossesi sembra addirittura che la presenza di Cristo nel credente, una presenza dinamica, mai pienamente compiuta, sempre in divenire e sempre perfettibile, sia il nucleo centrale della predicazione, ‘il mistero nascosto da secoli’ adesso finalmente rivelato: 3 Sermone 5b, 4, in M. Eckhart, I Sermoni, trad. it. Roma 2002, 126. Gv 1,12‐13. 4 5
‘Consolatore’, in greco παράκλητος, ovvero ‘colui che è chiamato in aiuto’, ‘avvocato’, ‘difensore’, ‘patrono’, è un termine col quale è indicato lo Spirito Santo. παράκλητος può essere tradotto con ‘consolatore’ poiché era compito dell’avvocato consolare il cliente (cf. F.Zorell S.I., Lexicon graecum novi testamenti, Roma 1999, 993). 6 Gv 14,16‐20. 154
Paolo Arzani – A proposito dell’etica cristiana «Di essa [della Chiesa] sono diventato ministro – scrive San Paolo –, secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola, cioè il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunziamo, ammonendo e istruendo 7
ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo» . Questa visione delle cose trova in Paolo un fondamento ontologico e antropologico. Anche se non possiamo affermare che Paolo voglia, nelle sue lettere, dare i lineamenti di una precisa antropologia8 , certamente egli non intende l’essere umano come un composto duale, costituito primariamente in corpo e anima, considerati come principi in costante lotta tra di loro, secondo la formula, cara alla filosofia platonica, che il corpo è una tomba per l’anima. Per la sua antropologia Paolo utilizza quattro termini: σω̃μα, σάρξ, ψυχή e πνευ̃μα. I primi due sembrano sinonimi in quanto vengono di solito tradotti rispettivamente con ‘corpo’ e ‘carne’, ma in realtà non lo sono. σω̃μα non va inteso nel senso di corpo, tronco, persona, forma visibile, perché in Paolo non indica soltanto una parte dell’uomo, ma l’uomo considerato sotto un certo aspetto. «σω̃μα indica l’io (1 Cor 13,3; 7,4) – scrive H.Conzelmann – e l’io in quanto percepibile da se stesso e dagli altri come possibile oggetto dell’azione fatta da altri o da se stessi. σω̃μα sono io, in quanto posso stare di fronte a me stesso, dominarmi e compromettermi. σω̃μα sono io, in quanto desidero (Rom 6,12; cf. Gal 5,16 s). σω̃μα è quindi l’io come soggetto che agisce e come oggetto sul quale si agisce, specialmente l’io come colui che agisce su se stesso. σω̃μα designa anche l’uomo come soggetto e oggetto della vita sessuale (1 Cor 6,15 s; 7,4; Rom 1,24)»9 . Allo stesso modo σάρξ, ‘carne’, non indica un aspetto esteriore dell’uomo, ma l’uomo in quanto sottomesso e schiavo della fragilità. In Rom 2,28 s. σάρξ è la sfera del visibile, del passeggero, del transitorio. Afferma ancora H. Conzelmann: «Paolo qui va molto al di là dell’Antico Testamento: σάρξ è la sfera nella quale vivo e dalla quale sono determinato. Sfera significa di fatto potenza. Essa ha la sua επιθυμία e i suoi έργα. Il σω̃μα è dominato 10
dalla σάρξ. Se la σάρξ è annientata, il σω̃μα è liberato dalla sua prigione (Rom 8,9)» . In sintesi si può dire che, per Paolo, σω̃μα è l’uomo che può cadere e che di fatto è caduto vittima del peccato e della morte, mentre σάρξ indica l’uomo in quanto caduto11 . Con ψυχή, termine che comunemente viene tradotto con ‘anima’, Paolo non vuole in alcun modo alludere alla dottrina greca dell’anima; vuole invece esprimere quanto significato dal termine ebraico nefeš, cioè la vitalità della carne12 . Non esiste nel pensiero ebraico l’idea di un’anima che, una volta liberata dal corpo mediante la morte di quest’ultimo, possa vivere, imponderabile, nella purezza. La morte è la sua fine, così com’è la fine del corpo. Il termine 7 Col 1,25‐28. Cf. H. Conzelmann, Teologia del Nuovo Testamento, trad. it. Brescia 1972, 222. 8 9
H. Conzelmann, op. cit., 225. 10
H. Conzelmann, op. cit., 227. Cf. H. Conzelmann, op. cit., 227. 11 12 H. Conzelmann, op. cit., 228. 155
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 ψυχή può quindi a buon diritto essere tradotto con ‘vita’. L’io (σω̃μα) vivente (ψυχή) caduto nel peccato (σάρξ) ha però uno spirito (πνευ̃μα). Con questo termine Paolo designa lo Spirito Santo (cf. Rom 8,16), lo Spirito di Dio (cf. 1 Cor 2,11) così come anche lo spirito umano (cf. Rom 8,16). Lo spirito umano può essere considerato come l’organo di comunicazione col trascendente, il segno dell’origine divina dell’uomo, ciò che lo rende connaturale all’Essere (Dio) del quale è partecipe13 . Lo spirito dell’uomo è il punto d’incontro con lo Spirito di Dio (cf. Rom 8,16), il ‘tempio’ interiore (cf. Rom 1,9), la camera nuziale dove si realizza la fusione, quella trasformazione in figli di Dio, in Cristo, per cui l’uomo (σω̃μα) non è più dominato dalla σάρξ ma, «riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore» viene trasformato «in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore» (2 Cor 3,18). «Voi però – scrive sempre Paolo ai Romani – non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo (σω̃μα) è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. [...] Tutti 14
quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio» . Accolto nella fede, lo Spirito di Dio inabita nello spirito umano, si fonde con esso e lo rinnova. Come la ψυχή vivifica il σω̃μα e lo rende essere vivente, così lo spirito umano e lo Spirito di Dio, ora uniti in una sorta di matrimonio, ‘pneumatizzano’ l’essere umano intero, trasformandolo sempre più a immagine di Cristo. In tal modo si trasforma anche l’operato dell’uomo, così che Paolo può parlare di ‘frutto dello Spirito’ contrapposto alle ‘opere della carne’ (cf. Gal 5,19): «Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). Qual è, possiamo a questo punto domandarci insieme a Paolo, la realtà più profonda dell’uomo, la sua più autentica identità? Non certo la ψυχή che è la pura vitalità. Non certo il σω̃μα che rappresenta l’Io relazionale dell’uomo e che ha bisogno di essere liberato dalla σάρξ a opera dello spirito. La realtà più profonda dell’uomo, la sua più autentica identità è dunque il suo spirito (πνευ̃μα), l’orma del divino in lui, che, però, non è in grado da solo di ‘spiritualizzare’ la persona perché anch’esso è prigioniero della σάρξ. È come se il mio Io più autentico, la mia verità più vera giacesse prigioniera, incatenata e soffocata nel profondo. Prigioniero del σω̃μα e della σάρξ l’uomo vive, opera, agisce, ma in modo alienato da se stesso, straniero a se stesso. Soltanto quando, grazie all’apertura della fede, lo spirito dell’uomo si fa tutt’uno con lo Spirito di Dio che adesso vi inabita, l’uomo viene restituito a se stesso, alla sua verità, e l’immagine divina che da sempre è in lui, fin’ora soffocata e incatenata, può librarsi e giungere al suo pieno compimento che è Cristo stesso. Si tratta di un vero e proprio parto. Una nuova nascita. E infatti Paolo, nel suo lavoro apostolico, si percepisce come una madre che partorisce i suoi figli, ovvero i credenti, nel dolore, il cui parto, la loro vera nascita, si ha soltanto quando Cristo è pienamente formato in essi: 13 Cf. Gregorio di Nissa, Grande discorso catechetico 5, 5 Rom 8,9‐11.14. 14 156
Paolo Arzani – A proposito dell’etica cristiana «È bello… essere circondati di premure sempre – scrive Paolo ai Galati – e non solo quando io mi trovo presso di voi, figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi!»15 . «Cristo in voi!». L’espressione è vertiginosa. Si potrebbe dire che l’esperienza della fede e dello Spirito se, da un lato, restituisce l’uomo a se stesso, alla propria autentica verità, dall’altro sembra portare a tal punto a compimento le sue potenzialità divine intrinseche da estraniarlo da se stesso e radicarlo nell’altro‐da‐sé, nel mistero. Il credente si trova così collocato su una sorta di crinale, su la linea di una soglia, in bilico tra l’umano e il divino in quanto la sua più profonda identità, il suo ‘fondo’, corrisponde con lo Spirito di Dio, con il fuoco di un amore che trascende infinitamente le sue possibilità umane. È esattamente questa esperienza di coincidere misteriosamente e paradossalmente con l’altro‐da‐sé che fa dire a San Paolo: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Ma qual è l’Io che ‘non vive più’, l’Io dal quale Paolo si sente come estraniato? È l’Ego, con tutto il suo bagaglio di schemi mentali, pregiudizi, difese, razionalizzazioni, col suo modo ristretto e rigido di vedere la vita e il mondo; è l’Io razionale e volitivo, sicuro di sé, che si presume libero e autonomo mentre, in realtà, è prigioniero di ogni tipo di ansia e paura inconsce. È l’Io prigioniero dei suoi ideali, delle sue aspettative sempre troppo alte, dei doveri e dei sensi di colpa. È l’Io che, per angoscia, tende a schiacciare ogni anelito dell'anima e dello spirito. Paolo avverte che oramai non vive più a partire dal suo Ego, ma che vive a partire dalla sua interiorità, ‘dal basso’, dal profondo, dallo Spirito di Cristo che è in lui, Spirito che ha trasformato l’intera sua persona al punto che l’Ego, adesso, lungi dall’essere stato annullato, si pone al suo servizio. Nel suo quadro sulla conversione di San Paolo, esposto nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma16 , Caravaggio ritrae Paolo a terra, caduto da cavallo, con le braccia aperte verso l’alto per accogliere la luce divina, mentre il suo mantello, l’elmo e la spada sono tutti scompaginati, fuori posto. L’elmo, soprattutto, è così fuori posto da liberare il capo. Mantello, elmo, spada sono simboli della forza del suo Ego, della potente sovrastruttura del suo Io che ora è andata come in frantumi nell’incontro‐scontro col divino. La conversione, l’apertura alla luce e al calore dello Spirito, sembra suggerire il dipinto del Caravaggio, sono possibili soltanto se l’Ego, con le sue rigidità e sicurezze, si incrina, e, viceversa, ogni autentico incontro col divino provoca quell’incrinatura dell’Ego che permette allo spirito di essere e di librarsi. Incrinare l’Ego è dunque la chiave per aprire la porta dello spirito, per permettere le nozze dello spirito e far sì che l’immagine divina dell’uomo possa giungere alla piena maturità di Cristo (cf. Ef 4,13). Un chiaro tentativo di incrinare l’Ego con la sua corazza è la predicazione di Gesù nei vangeli. L’evangelista Matteo, da buon ebreo che compone il suo vangelo strizzando l’occhio a cristiani provenienti dall’ebraismo, presenta Gesù di Nazaret come un grande e innovativo esegeta della Torà (la Legge), ma un esegeta che porta l’interpretazione della Scrittura a delle 15 Gal 4,18‐19. 16
Conversione di san Paolo, 1600‐1601. Olio su tela, cm 230 × 175, Roma, Santa Maria del Popolo, cappella Cerasi. 157
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 conseguenze così estreme e mozzafiato da trasportare l’uomo in una dimensione che è totalmente ‘altra’ a se stesso. Ecco che, in Matteo, Gesù così insegna: «Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da’ a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»17 . Parole assai note, che non vanno prese come un insieme di nuove e più perfette regole da intendere alla lettera e da mettere conseguentemente in pratica, come se i dieci comandamenti e l’intera riflessione etico‐normativa ebraica fossero stati avvertiti carenti, deficitari e insufficienti, e tutti noi fossimo in attesa di nuove, decisive e definitive norme. Parole che, invece, tendono a incrinare l’Io, a frantumarlo, a ‘crocifiggerlo’ sui legni della sua impotenza, perché possa cedere e così dare spazio al mistero di un amore che, per lui, è completamente sconosciuto, è ‘altro’. Lo scontro con l’Io, con le sue rigidità, aspettative e pretese, è lo scontro frontale del cristianesimo. «Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti» scrive Paolo nella prima lettera ai Corinzi (1,19), citando Isaia 29,14. Per poi continuare: «Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini»18 . La croce del Cristo, luogo ‘scandaloso’ e ‘stolto’ dell’autentica e piena manifestazione del volto d’amore di Dio, è anche il punto di crisi dell’Io che, davanti al paradosso e all’assurdo, non può che chiudersi nel rifiuto oppure lasciarsi incrinare e aprirsi all’altro‐da‐sé. Paradossale ‘morte’ che prelude alla vita, anzi alla pienezza della vita, in quanto libera l’essere, lo spirito, amore universale, gratuito, «senza perché» direbbe Eckhart, normalmente sottomesso e soffocato dall’Ego con le sue volontà, aspettative e paure. Si comprende, così, perché è assolutamente impossibile parlare di un’etica cristiana a prescindere dalla fede nel Dio vivente di Gesù Cristo. Perché l’etica cristiana, se così vogliamo chiamarla tanto per intenderci, coincide con la vita e con l’amore stesso di Dio, l’αγάπη (cf. 1 Cor 13,1‐13). Con qualcosa, cioè, che è ‘altro’ rispetto al nostro Ego, ‘altro’ rispetto alla nostra volontà e ragione. Infatti, né i vangeli né tantomeno Gesù di Nazaret parlano esplicitamente di un’ ‘etica cristiana’. Certamente molti loro valori sono ripresi dalla riflessione ebraica 17
Mt 5,38‐48. 1 Cor 1,20‐25. 18 158
Paolo Arzani – A proposito dell’etica cristiana dell’Antico Testamento e non solo, valori pienamente condivisi dall’Io individuale e collettivo del loro e del nostro tempo, come nel caso, per esempio, del comandamento ‘non rubare’. Ma quando essi parlano di valori, quando entrano nella sfera dell’etica, ecco che il loro linguaggio sfuma, perde i connotati della pura logica e razionalità, diventa simbolico e si smarrisce nel paradosso. Perché in gioco non è la proposta di un’etica diversa e nemmeno di un’etica superiore. In gioco è l’irruzione dello Spirito, capace di impossessarsi dal profondo della persona, di trasformarla, di far sì che diventi veramente e pienamente quello che già era: ‘imago Dei’, e molto di più. Cristo libera il fondo divino della persona e fa sì che la persona ritrovi se stessa in Dio e Dio stesso si ritrovi in lei. Ai credenti di Roma, che ancora non conosce, Paolo scrive: «Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (12,2). Paolo invita a non conformarsi al modo di agire e di pensare di questo mondo che passa, a non far propri in modo acritico e passivo la logica e i valori della società, a non adeguarsi passivamente all’Io individuale e collettivo. Perché l’Io dell’autentico credente, al contrario dell’Io collettivo che vuole affermarsi e dominare, cede, lascia andare le redini, abbandona ogni ambizione e presunzione di controllo, e si lascia trasformare ‘dal basso’, a partire, cioè, dall’interiorità, dallo Spirito, il solo che è in grado di allargare in modo smisurato le capacità dell’Io rendendolo finalmente in grado di aprirsi a un amore che trascende le possibilità umane. Un simile cambiamento di baricentro, dall’Io allo Spirito, non può non aver conseguenze nel modo di essere e di agire. Comprensibilmente, nel corso dei secoli, la chiesa ha cercato, anche per preoccupazioni pratiche, istituzionali, mossa certamente anche da oscuri desideri di controllo delle persone e dell’esistente, di delineare e di definire i tratti del comportamento di chi vive la vita nuova nello Spirito. È quella che, oggi, viene chiamata ‘Teologia morale’. Si tratta di tentativi utili soltanto se intesi come indicazioni di piste di ricerca, immagini evocative di un ‘oltre’, paradossi per incrinare le anguste certezze dell’Io. Sono invece illusori tentativi destinati al fallimento se intesi come norme definitive. Sia perché, se non c’è la vita nuova nello Spirito, le indicazioni della Teologia morale diventano pesi insostenibili che ingenerano deleteri sensi di colpa e, in molti casi, rifiuto. Sia perché, quando in gioco è lo Spirito, qualunque definizione rappresenta un’inevitabile riduzione e banalizzazione. È tuttavia comprensibile che, davanti soprattutto alle nuove possibilità che la ricerca scientifica ci presenta, ci si sforzi di individuare l’agire più giusto. Ma ‘giusto’ in relazione a che cosa? Alla ragione? Al buon senso? Ai narcisistici bisogni dell’Io? Ai dettati di Dio? I vangeli e Gesù di Nazaret non rispondono a questa domanda. Si limitano per lo più a incrinare il nostro Io e le sue certezze per aprire lo spazio non a delle norme divine, ma allo Spirito, a Dio stesso, a una capacità di amare che va al di là di ogni confine razionale e ragionevole, fino ad allargarsi all’assurdità dell’amore per il nemico e alla follia della croce. Paolo Arzani 159
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Bibliografia 1. Althaus Paul, La lettera ai Romani, trad. it. Brescia 1970. 2. Barbaglio Giuseppe , Fabris Rinaldo, Le lettere di Paolo,voll. 3, Roma 1980. 3. Conzelmann Hans, Teologia del Nuovo Testamento, trad. it. Brescia 1972. 4. di Nissa Gregorio, Opere, a c. di C.Moreschini, Torino 1992. 5. Eckhart Meister, I sermoni, a c. di Marco Vannini, trad. it. Milano 2002. 6. Hillman James, Re‐visione della psicologia, trad. it. Milano 1983. 7. Lerner Gad, La santa alleanza degli atei devoti, in La Repubblica 8 gennaio 2008. 8. Mateos J.‐ Barreto J., Il vangelo di Giovanni, trad. it. Assisi 1995. 9. Mello Alberto, Evangelo secondo Matteo, Comunità di Bose, Magnano (VC), 1995. 10.Zorell Franciscus, S.I., Lexicon graecum novi testamenti, Roma 1999. 160
Recensione L'invenzione della libertà 1700­1789 Jean Starobinski Abscondita, Milano 2008 Questo testo, come precisa l'autore nell'avvertenza, fu scritto per rispondere all'intenzione dell' editore ginevrino Skira di pubblicare una collana intitolata “Art, idéès, histoire” che ripercorresse la storia dell'arte europea attraverso una prospettiva interdisciplinare1. Questa particolare occasione ha fatto sì che oggi possiamo godere di una rilettura curata e originale delle vicende del diciottesimo secolo fino al periodo prerivoluzionario, in cui l'attenzione alle forme artistiche che esso ha sviluppato si esplica tramite una riflessione ponderata intorno allo spirito di quel tempo. La scelta del titolo già mostra molto delle intenzioni dell'opera: Il titolo che ho dato al libro si fonda sui principali significati della parola «invenzione»: l'antico significato dell'invenzione che ritrova un oggetto sacro ( come quando si parla dell'«invenzione della Santa Croce» o del corpo dei santi ) e il significato che ne fa l'azione di creare innovando, sia che si tratti di uno stile, di una macchina o di un sistema di governo [...] Questo titolo riflette un'ambizione inventiva che fu al tempo stesso di restituire e di istituire. Per illustrare, più di quanto non facciano già le immagini presenti nel volume, la complessità di un secolo tanto vivace e straordinariamente produttivo come il ' 700, Starobinski lo ripercorre attraverso i mutamenti di importanza e significato attribuiti al 'sentire' e al 'volere'. Quello che sarà il ''Secolo dei Lumi' si presenta, non di rado e per fondate ragioni, anche come un periodo di abbandono a frivolezze estetiche e mascheramenti, affascinato da un esotismo fittizio e legato ad una certa immagine di libertinaggio che perdura ancora oggi. Starobinski riconosce anche in questo aspetto le radici di un pensiero che ha voluto, prima di tutto, liberarsi e innovarsi, conferendo la posizione più alta all'uomo in quanto libero e cosciente di se stesso. Il libertinaggio, a cui si è stati tentati di ridurre lo spirito del secolo, non gli è estraneo. Rappresenta una delle esperienze possibili della libertà, nasce da una insubordinazione di principio senza la quale, d'altra parte, il lavoro serio della riflessione non avrebbe potuto svilupparsi. Questo secolo (almeno nei suoi rappresentanti più qualificati ) si voleva libero d'inseguire la felicità come di conquistare la verità. [...] 2
sentire, e sentire fortemente, è un modo di accedere alla coscienza d'esistere. 1 Per le vicende della pubblicazione di suddetta collana vedi Jean Starobinski, L'invenzione della libertà 1700‐1789, Abscondita, Milano 2008, pp. 10‐11. 2 Op. cit., p.17. 161
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Gli artisti del '700 si sono misurati con tutte le trasformazioni sociali del loro tempo: l'esaltazione del piacere, la ricerca di un equilibrio tra 'ordine' e 'varietà' 3; la ritrattistica e l'imitazione della natura, attraverso cui la personalità dell'artista cominciò a manifestarsi in maniera più eminente rispetto a quella del committente; la passione per le rovine della classicità, l'architettura dei palazzi e dei giardini insieme a quella di intere città: L'accesso di una città è destinato a facilitare l'uscita degli abitanti e l'ingresso dei forestieri; è necessario che tutto vi sia assolutamente libero e sgombro.[...] Sarebbe inoltre auspicabile che all'entrata di una grande città si trovasse una vasta piazza a zampa d'oca aperta su molte strade. L'ingresso a Roma per la Porta del Popolo è press'a poco così, ma a Parigi non esiste nulla di simile.4
Il diciottesimo sarà anche il secolo delle straordinarie scoperte della nuova scienza e dell'industrializzazione e l'arte raccoglierà anche l'abbandono de 'l'idillio' e la sensazione di lotta contro la natura; nasceranno la satira e la caricatura e il principio dell'idea di decadenza : “Lo spirito si vota alla passione dell'assenza, alla meditazione senza fine su un desiderio che non trova più oggetti a sua misura”.5
L'invenzione della libertà risulta infine corrispondere alla originaria proposta editoriale, potendo, a buon diritto, essere annoverato tra i libri di storia dell'arte e, contemporaneamente, intendendo l'arte come mezzo di trasmissione delle tendenze politiche, culturali, filosofiche e sociali del suo tempo. Lo stile disteso e riflessivo dell'autore accompagna una ricerca che si intuisce essere stata condotta con passione, ma anche con un discernimento profondo ed una non comune padronanza della materia. Scilla Bellucci Indice Avvertenza L'INVENZIONE DELLA LIBERTÁ, 1700‐1789 I. Lo spazio umano del XVIII secolo Agire e sentire; le esperienze della libertà; Fasto e lusso; Lo stile rocaille; Sinuosità; Voci critiche; Ordine e varietà: la città nuova; Le piazze e le dimore: 3 Ivi, pp. 40 e segg. 4 Marc‐Antoine Laugier (1713‐1769) , cit. in J.Starobinski, L'invenzione della Libertà, Abscondita, 2008, p.44. 5 Op. cit, p.139. 162
Recensione – L’invenzione della libertà II. Filosofia e mitologia del piacere La giurisdizione del sentimento, p.51; Il regno fittizio della donna, p. 54; La rappresentazione, l'illusione, p.61 ; Dai minuti piaceri..., p. 66; ...al piacere nero, p. 69. III. L'inquietudine e la festa La festa e il suo domani Chi è di scena? La festa iconoclasta La vita negli scenari IV. L'imitazione della natura La visione fedele; Il segreto dei volti; L'energia e il genio; Privilegi dell'artista; V. Nostalgie e utopie L'idillio impossibile; Vedute inglesi; La melanconia fra le rovine; Storie gotiche; L'universo circoscritto; I sogni della ragione; Lo stile della volontà; Il piacere di vedere; Indice dei nomi Bibliografia 163
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 164
Recensione L’immaginazione e la vita morale Cora Diamond Carocci, Roma 2006 I saggi di Cora Diamond raccolti in L’immaginazione e la vita morale si collocano a una notevole distanza dagli orientamenti dell’etica analitica contemporanea. In particolare, è noto il debito che il pensiero della filosofa britannica ha nei confronti della filosofia wittgensteiniana, nonché, come ricorda l’autrice in apertura, nei confronti della filosofa Iris Murdoch. Il filosofo austriaco, ricorda Diamond, ci invita a “non trascurare la varietà e le differenze tra i fenomeni”e a concepire la vita umana come ricca, articolata e composta da elementi non del tutto cristallizzabili nel linguaggio. Ora, tale varietà, tale dinamismo, secondo Diamond, sono requisiti fondamentali che la filosofia, e la filosofia morale in particolare, devono possedere in comune con la vita stessa, così da rinsaldare quel rapporto autentico tra filosofia e vita, spesso nascosto dalla naturale tendenza della mente ‐ osservava William James ‐“alla semplificazione eccessiva dei suoi materiali”.1 Come opporsi, allora, a un atteggiamento così naturale da parte della mente umana? La risposta di Diamond è racchiusa nella sua visione dell’etica concepita come una disciplina in grado di valorizzare i “vari modi in cui differiamo l’uno dall’altro, in virtù dei concetti con cui viviamo”.2 Una volta ammessa la naturale evanescenza e la mutevolezza dei concetti morali, osserva Diamond, occorre superare la tradizione analitica classica, insieme alle inadeguate concezioni contrattualistiche e utilitaristiche in etica, e arricchire la riflessione in filosofia morale con contributi che valorizzano il rapporto tra le nostre concettualizzazioni e le differenti concezioni di una ‘vita etica’. A tal fine, diventa fondamentale, sostiene Diamond, ribadire l’importanza dei “nostri atteggiamenti concettuali profondi” per il pensiero morale.3 La cultura illuministica, sostiene Diamond, ha influenzato moltissimo la visione della personalità umana: crediamo, sostiene la filosofa britannica, “di essere in grado di descrivere il mondo attraverso l’uso della ragione e dei sensi, e prendiamo a modello di questa descrizione della realtà, l’applicazione del linguaggio scientifico”.4 Così, l’essere umano ha imparato a contrapporre a questo lato di se stesso (ragione e capacità percettive) gli aspetti legati all’emozione, al desiderio, e alla volontà. Da questa frattura deriva l’utilizzo di un vocabolario molto povero anche in filosofia morale: basti pensare alle dicotomie concettuali classiche come buono‐cattivo, giusto‐sbagliato, ecc., che impediscono di individuare nitidamente “i fraintendimenti filosofici del linguaggio connessi all’incapacità di vedere la nostra vita concettuale”.5 È come se attraverso il linguaggio noi guardassimo per mezzo di una lente opaca che ci impedisce di percepire la vitalità concettuale che risiede dietro alle nostre denominazioni. Si prenda, per esempio, il concetto di ‘essere umano’. Secondo Diamond, 165
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 cogliere l’essenza del concetto di ‘essere umano’ non sta tanto nel catturare il concetto per mezzo della definizione di “membro della specie biologica Homo Sapiens”, quanto nel prendere atto del riconoscimento che i “pensieri, le azioni e gli avvenimenti contribuiscono a dare forma alla storia umana”.6 Utilizzare il concetto di ‘essere umano’, sostiene Diamond, implica, soprattutto, esser parte della vita stessa e conoscere “quello che succede in essa”.7 Perché, si domanda Diamond, l’analisi filosofica tradizionale in etica si è, da sempre, concentrata sul concetto di ‘agente razionale’ piuttosto che su quello di ‘essere umano’? Perché non deve essere legittimo che “il semplice fatto di essere umani” possieda un ruolo significativo nel pensiero morale? È frutto di un’amnesia concettuale dei filosofi morali o è la deliberata ricerca di metodi liberi da ben determinati pregiudizi? La tradizione analitica classica, secondo Diamond, non è in grado di descrivere a pieno l’esperienza di una vita morale: essa è vittima, infatti, dell’illusione di poter cogliere, attraverso la descrizione, il contenuto concettuale pensato come staccato dal resto del contesto di vita e dagli interessi umani; ma, afferma Diamond, è proprio questo, invece, che caratterizza la nostra capacità di utilizzare le parole, la capacità, cioè, di partecipare alla vita di quelle parole, alle molteplici attività da cui i nostri concetti provengono.8 Concepire il linguaggio nei termini di regole che fissano rigidamente ciò che può essere detto, non permette di cogliere pienamente cosa significhi saper utilizzare un dato termine; infatti, “saper utilizzare un termine significa introdursi nella vita con quel termine, le cui possibilità sono in larga misura ancora da determinare”.9 Come messo in luce dalla filosofa Iris Murdoch, la filosofia morale contemporanea è fortemente influenzata da una visione della natura umana distorta e limitante: essa scompone l’io, pura volontà, dalla scelta e dall’azione, e questa tendenza, precisa Diamond, che “separa il modo in cui una persona è (incluso il suo stile di pensiero) dalle sue capacità come agente morale” ha delle profonde conseguenze sul tipo di vocabolario e sul nostro modo di pensare le questioni etiche.10 Se per Kant, osserva Diamond, il rispetto per la persona altrui, passava dal rispetto della propria e altrui razionalità, filosofi come Baier e Rorty, identificano nel ruolo dell’immaginazione la condizione fondamentale per cogliere l’esperienza dell’altro. Secondo questi autori, la capacità immaginativa è alla base del nostro interesse morale per le persone, della condivisione simpatetica dei sentimenti dell’altro, insieme agli elementi della nostra e della altrui sfera emozionale. Per Rorty, in particolare, ‘l’identificazione immaginativa’ è ciò che ci permette di interessarci agli altri e ai loro destini.11 È attraverso lo sviluppo immaginativo che si passa alla costruzione del sé, e l’interesse morale non è una capacità che l’essere umano possiede in quanto essere razionale, ma in quanto componente di una comunità all’interno della quale esistono “vari usi di noi contrapposti a loro” in grado di esprimere, così, i sentimenti di solidarietà e appartenenza al gruppo. ‘L’identificazione immaginativa’, precisa Diamond, è tipica della poesia e della letteratura, attività umane che non pretendono di cogliere una verità essenziale, ma che, piuttosto, ne colgono una accidentale, individuale, e, non per questo, meno autentica e significativa: l’interesse per ciò che ci fa esseri umani non è soltanto una prerogativa dei filosofi, ma è una caratteristica che la filosofia condivide con la letteratura, la poesia, l’espressione artistica. Ciò che caratterizza l’essere umano, secondo Diamond, è “il suo rimodellare immaginativo”, 166
Recensione – L’immaginazione e la vita morale l’utilizzo costante della sua elaborazione immaginativa: peccato, osserva la filosofa britannica, che tale attività immaginativa sia stata, in gran parte, rimossa o esclusa dalla filosofia tradizionale; infatti, osserva Diamond, anche se tale capacità è tradizionalmente considerata come una peculiare caratteristica dell’essere umano, a volte, l’essere umano, “può sembrarci invisibile quando siamo impegnati a fare filosofia”.12 Per Murdoch, precisa Diamond, una metafora centrale per la consapevolezza morale è la consapevolezza visiva: noi afferriamo il mondo visivo più o meno accuratamente in funzione della qualità della nostra attenzione, concepita non come “attenzione acuta, volta a determinati interessi e attività”, ma come “un tipo di meraviglia e di freschezza percettiva” che è, contemporaneamente, consapevolezza visiva e consapevolezza morale.13 Ciò che Murdoch ha sottolineato, conclude Diamond, è la necessità di considerare concetti come ‘visione personale’ e ‘trama dell’essere’ come parte della filosofia morale, alla pari di concetti come ‘scelta’ e ‘azione’. La visione dell’etica che ne deriva è quella di una disciplina che “include una varietà di risposte complesse a problemi che, spesso, identifichiamo in modo distorto”.14 Occorre, allora, che la filosofia ridimensioni la sua tendenza a semplificare eccessivamente i fenomeni della vita e del pensiero morale: non è fondamentale “cercare una singola caratterizzazione dell’esperienza morale”, quanto, piuttosto, portare alla luce quella vivace molteplicità di concezioni della vita morale che l’analisi filosofica ha reso, il più delle volte, impercettibili o assenti. Alberto Binazzi Indice 1. Concetti, sentimenti e immaginazione. Un’introduzione al pensiero morale di Cora Diamond di Piergiorgio Donatelli 2. Prefazione 3. Perdere i propri concetti 4. L’importanza di essere umani 5. Le fonti della vita morale 6. Fatti e valori 7. La difficoltà della realtà e la difficoltà della filosofia 8. Differenze e distanze morali Note 1 C.Diamond,L’immaginazione e la vita morale, Carocci, Roma, 2006, pp.53. Ivi, pp.54. 3
Ivi, pp.56. 4
Ivi, pp.67. 5
Ivi, pp.69. 2
167
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 6
Ivi, pp.71. Ivi, pp.73. 8 Ivi,Ibidem. 9
Ivi, pp.75. 10
Ivi, pp.78. 11
Ivi, pp.91. 12
Ivi, pp.101. 13
Ivi, pp.173. 14
Ivi, pp.226. 7
168
Recensione Contro i diritti umani Slavoj Zizek Il Saggiatore, Milano 2005 Žižek opera una critica radicale delle società occidentale, che identifica con l’appellativo di società liberal‐capitalistica. Lo fa attraverso quella che egli stesso definisce come «una lettura sintomale marxista»1, che lo porta a demolire la tradizionale nozione dei diritti umani, frutto, a suo dire, di uno «specifico orientamento ideologico borghese: i diritti umani universali –continua‐ sono in realtà i diritti dei bianchi, maschi e benestanti, di operare liberi scambi sul mercato, di sfruttare gli operai e le donne e di esercitare il predominio politico». Secondo Žižek gli appelli ai diritti umani, tanto frequenti nelle nostre società, si fondano su tre presupposti: l’opposizione ai metodi del fondamentalismo, il richiamo alla libertà di scelta e alla libera ricerca del piacere, e infine la loro efficacia contro gli eccessi del potere. Tre pilastri su cui si regge ogni appello ai diritti umani, pilastri che però egli si propone di demolire evidenziandone la sostanziale inconsistenza. Per ciò che concerne il fondamentalismo Žižek, parafrasando Hegel, ritiene che il male risieda proprio nell’occhio che lo percepisce: prendiamo ad esempio il caso dei Balcani durante gli anni novanta, teatro di diffuse violazioni dei diritti umani. In quale momento i Balcani, da regione sudorientale dell’Europa, sono diventati “i Balcani”, con tutto ciò che significa oggi per l’immaginario ideologico europeo? La risposta è: a metà del XIX secolo, proprio quando i Balcani furono investiti dagli effetti della modernizzazione europea. […]. Da dove anno avuto origine, dunque, i tratti fondamentalisti –l’intolleranza religiosa, la violenza etnica, la fissazione su 2
un trauma storico‐ che ora l’Occidente associa ai “Balcani”? Evidentemente dall’Occidente stesso. La libertà di scelta offerta dalle democrazie liberali, secondo presupposto, si rivela per l’intellettuale croato una libertà meramente illusoria, che consente soltanto una «pseudoscelta»3; la nozione di libera scelta si rivela non essere altro che uno strumento per il mantenimento dello status quo e della disuguaglianza: la concreta efficacia del concetto ideologico di scelta libera all’interno della democrazia capitalista è stata ben illustrata dalla sorte del programma di riforma sanitaria, assai moderato, varato dall’amministrazione Clinton. La lobby della sanità (due volte più potente della famigerata lobby della difesa) è riuscita a 1
S. Žižek, Contro i diritti umani, Il saggiatore, Milano 2005, p. 67. Ibidem, p.15. 3
Ibidem, p. 21. 2
169
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 convincere l’opinione pubblica che un sistema sanitario per tutti avrebbe minacciato la libertà di scelta in questo campo.4 Infine, il richiamo ai diritti umani e all’umanitarismo come forma di contrasto agli eccessi di potere, è ancora, secondo Žižek, un’altra mistificazione: dietro una politica apparentemente depoliticizzata, quale è quella che si appella ai diritti umani, spiega l’autore, si nasconde sempre l’ideologia dell’interventismo militare a sostegno di precisi scopi socio‐economici. Tuttavia, condannare come prodotto di una reificazione la nozione dei diritti umani, ossia dei diritti universali appartenenti ad ogni uomo, è solo una parte del percorso disegnato da questo testo. Per Žižek, che nella pars destruens della sua analisi recuperava in buona parte la lezione marxista ortodossa, esiste anche il processo opposto, da lui giudicato molto più interessante: gli appelli ai diritti umani, che appartengono originariamente all’edificio ideologico imposto come sovrastruttura dalle società borghesi, possono essere improvvisamente fatti propri dagli schiavi e divenire mezzo per sollevare rivendicazioni autentiche. Richiamarsi ai diritti umani contro il proliferare delle disuguaglianze, dunque, è ancora possibile. Matteo Leoni Indice
Tre presupposti Scelta non libera La politica della jouissance Difesa contro il potere? Purezza umanitaria Il ritorno dell’universalità Note 4
Ibidem, p. 23‐24. 170 Recensione Uno studio sul bene Nishida Kitarō Bollati Boringhieri, Torino 2007 Sebbene per noi questa risulti essere una prima edizione, Uno studio sul bene è l’opera prima di Nishida e fu pubblicata, per la prima volta, nel 1911. Questa precisazione non vuole valere soltanto come dato bibliografico, ma anche come avvertimento a chiunque desiderasse consultarla. Tale parere è confortato sia dalle annotazioni di Giangiorgio Pasqualotto, a cui si deve l’ introduzione, sia dalle parole dello stesso autore nella premessa alla seconda edizione del 1921 «..l’insoddisfazione che provo nei confronti di questo scritto è cresciuta via via e alla fine non volevo più farlo ristampare..»1. Si tratta di un giudizio estremamente severo e possiamo senz’altro essere contenti che quell’intenzione non sia stata portata a risoluzione, tuttavia la composizione del testo, le cui parti non godono di una perfetta uniformità e i cui contenuti non sempre sono esplicitati in maniera esaustiva, soffre di alcuni difetti che necessitano di una spiegazione. Sempre l’autore, nella prefazione alla prima edizione, ci fornisce ulteriori chiarimenti ..All’inizio volevo esporre con precisione la parte dedicata alla realtà e pensavo di pubblicarla appena possibile, ma sono stato bloccato dalla malattia e da diverse circostanze…Mentre trascorrevano in questa maniera alcuni anni, anche il mio pensiero è in parte cambiato…Innanzitutto avevo completato la seconda e la terza parte, e solo dopo ho aggiunto, nell’ordine, la prima e la quarta…La ragione per cui ho intitolato questo testo Uno studio sul bene è che a mio giudizio, anche se la ricerca filosofica ne occupa la prima metà, i problemi che ne costituiscono il centro e il compimento sono quelli che riguardano la vita degli esseri umani.2 La parte dedicata alla ‘ricerca filosofica’ è quella che risulta di più difficile comprensione. L’autore, che ha dedicato molto tempo e molte energie allo studio della filosofia occidentale, producendo dei risultati straordinari – ad esempio la traduzione giapponese della terminologia filosofica occidentale –, dà l’impressione di non riuscire fino in fondo a rendere leggibile il suo pensiero perché, forse, troppo legato ad un sistema espositivo che non gli è del tutto proprio. Il pensiero che l’autore ci propone è fondato sulla convinzione che i gradi di separazione presenti tra le varie forme dell’esistente siano da attribuire alla concettualizzazione, ma che il ‘reale concreto’ sia un tutto unico in cui ogni contrapposizione e perfino ogni contraddizione trovano la loro ragione d’essere in un flusso continuo di trasformazione che, in virtù di questo 1
2
Nishida Kitarō, Uno studio sul bene, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 5. Ivi, p. 3. 171
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 movimento ‘contiene’ in sé tutte le possibilità dell’essere, anche quelle che non si attualizzano in enti. L’idea che ciò che unifica e ciò che è unificato siano due cose distinte è opera del pensiero astratto, mentre nella realtà concreta ciò che unifica e ciò che viene unificato non si possono separare… Per questo la modalità fondamentale della realtà è di essere uno e insieme molti, molti e insieme uno, qualcosa che possiede la differenza nell’uguaglianza e l’uguaglianza nella differenza… Una realtà che, come quella appena descritta, è davvero uno e molti, deve per forza essere automoventesi senza pause. Uno stato di quiete è uno stato che esiste indipendentemente e che non si contrappone ad altro, cioè è lo stato dell’uno che esclude i molti. Ma in tale stato non può costituirsi la realtà.3 Si comprende come, da una siffatta concezione, non possano che scaturire conseguenze a cui il pensiero occidentale non è abituato. Nishida non cerca mai di dividere e di categorizzare, non crea un modello gerarchizzante di gradi ontologici, non mira ad un’unità metafisica, ma ad un’unità organica che, necessariamente, deve trovare ragione della propria coerenza all’interno di se stessa. Questa è la forza che produce l’unificazione, identica per ogni forma ed eternamente generatrice. «La volontà è l’attività unificante fondamentale della coscienza e immediatamente l’espressione della forza unificante che è l’origine della realtà. La volontà non è attività per altro, ma in virtù di se stessa. Non resta che cercare nella volontà stessa l’origine a partire da cui determinare il valore della volontà.»4 A questo punto l’autore compie un’operazione di pensiero che, per quanto apparentemente più clemente verso la nostra intuitività, si conclude con un ragionamento che è sostanzialmente estraneo alla nostra tradizione. Assume che l’attività della volontà (lo assume tramite argomentazione) sia originata da bisogni connaturati, ‘cause della coscienza’5 e qualifica questi bisogni come espressione del modo d’essere del sé. L’agire, allora, diventa agire buono, cioè bene, quando è conforme alla piena realizzazione del sé inteso come facente parte di un eterno movimento unificante. In questo senso, il bene che è sviluppo e compimento del sé ha il senso di seguire le leggi della realtà del sé. Per questo le leggi morali vengono a essere incluse tra le leggi della realtà e il bene può essere spiegato a partire dalla vera natura della realtà del sé. I bisogni intimi che sono fondamento dei cosiddetti giudizi di valore e la forza unificante della realtà sono un’unica e identica cosa. La separazione di essere e valore deriva da un’attività di astrazione che distingue l’oggetto della conoscenza dall’oggetto del sentimento e della volontà, ma a livello di vera realtà concreta questi due elementi sono in origine una cosa sola. In altre parole, cercare il bene e tornare al bene vengono a coincidere con la verità del sé…Ma la conoscenza astratta e il bene non coincidono senz’altro. Nel nostro caso conoscere deve avere il senso di «comprendere col corpo». Simili idee costituiscono il pensiero fondamentale di Platone in Grecia e delle Upanishad in India, e io penso che rappresentino quanto di più profondo sia stato pensato riguardo al bene.6 Scilla Bellucci 3
Ivi, pp. 67 e seg. Ivi, p. 131. 5
Nishida Kitarō, Uno studio sul bene, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 131. 6
Ivi, p. 134. 4
172
Recensione – Uno studio sul bene Indice Introduzione al pensiero di Nishida Kitarō Di Giangiorgio Pasqualotto Prefazione Prefazione alla seconda edizione In occasione della riedizione Parte prima L’esperienza pura L’esperienza pura Il pensiero La volontà L’intuizione intellettuale Parte seconda La realtà Il punto di partenza della ricerca I fenomeni di coscienza sono l’unica realtà Il vero manifestarsi della realtà La vera realtà segue sempre lo stesso schema formale La modalità fondamentale della vera realtà L’unica realtà Differenziazione e sviluppo della realtà La natura Lo spirito Dio in quanto realtà Parte terza Il bene L’agire (1) L’agire (2) La libertà della volontà Uno studio sul valore Varie dottrine etiche (1) Varie dottrine etiche (2) Varie dottrine etiche (3) Varie dottrine etiche (4) Il bene (l’energetismo) Il bene della persona L’impulso dell’atto buono (la forma del bene) Il fine dell’atto buono (il contenuto del bene) L’atto buono completo 173
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Parte Quarta La religione Il bisogno religioso L’essenza della religione Dio Dio e mondo Conoscenza e amore Postfazione di Enrico Fongaro Ringraziamenti Glossario Bibliografia Indice dei nomi 174
Recensione Negative Virtues: Zhuangzi’s Wuwei Kathleen Marie Higgins Il saggio di Kathleen Marie Higgins, Negative Virtues: Zhuangzi’s Wuwei, è tratto dal libro Virtue Ethics, Old and New, che raccoglie gli atti di un congresso che si è tenuto presso l’Università di Canterbury in Nuova Zelanda nel maggio 2002. Secondo l’autrice, le più importanti teorie morali che sono state elaborate dalla filosofia occidentale hanno sempre connotato la virtù come qualcosa che scaturisce dalle azioni della persona agente. Secondo Kathleen Marie Higgins però, questo modo di intendere la virtù, come la capacità attiva di voler agire in una certa maniera piuttosto che in un’altra, non comprende e non esaurisce tutto il dominio di azioni e comportamenti che possiamo definire virtuosi. Esiste infatti una particolare categoria di virtù che viene definita “virtù‐ negativa” che, secondo la Higgins, è stata completamente ignorata dal pensiero occidentale ma che ha avuto invece un ruolo fondamentale in alcune scuole di pensiero orientali. È all’analisi di questa “virtù negativa” che la Higgins dedica il suo saggio. Se l’idea occidentale di virtù è quella di un ideale da seguire e corsi di azione da intraprendere, le virtù negative orientali sono da intendersi invece come astensione, abbandono dei progetti e non‐azione. Questa concezione della virtù è frutto dell’idea che il mondo sia in continuo e costante cambiamento. La virtù consiste nel riconoscere sia questo, sia la nostra partecipazione al flusso e al movimento di tutte le cose. Noi possiamo conoscere il mondo, tuttavia la nostra conoscenza non è mai oggettiva ma sempre prospettica. Conosciamo sempre a partire da un punto di vista. La virtù della non‐azione è il riconoscimento che tutto è in movimento e che in nessuno modo possiamo intervenire per cambiare il corso del mondo. Possiamo solo fluttuare in esso e lasciarci trasportare. Da qui la filosofia della non‐azione che deve essere intesa come la non interferenza nel naturale, spontaneo e armonioso processo della vita. Questo modo di concepire la virtù comporta delle notevoli differenze rispetto al modo di concepirla nel mondo occidentale. La filosofia della “virtù negativa” rifiuta infatti l’idea che la virtù sia strettamente legata ad una chiara distinzione tra azioni giuste e azioni sbagliate. Chi si ispira a tale pensiero infatti ritiene che il comportamento di una persona si adegui ad una certa situazione, la cui percezione però, come precedentemente detto, è prospettica e non oggettiva e quindi non si possono dare regole per stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato perché sarebbero sempre viziate dalla nostra percezione delle cose. Per tale filosofia è dunque assolutamente impossibile stabilire regole costanti per la nostra condotta perché tutto cambia ed è in continuo movimento. Un’altra differenza è che molti filosofi occidentali contemporanei descrivono i comportamenti virtuosi come da premiare e i comportamenti viziosi come da biasimare. Nella tradizione occidentale c’è dunque la tendenza a mettere in relazione virtù e vizi con premi e punizioni. Ma per la filosofia della “virtù negativa” essi sono assolutamente irrilevanti, anzi sono nocivi in quanto spingono l’agente a cercare di intraprendere quelle azioni che portano alla lode e al riconoscimento. Infine mentre la filosofia occidentale dà una grande 175
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 importanza alle motivazioni che stanno alla base delle azioni, il pensiero della “virtù negativa” non ritiene essenziale il motivo di un comportamento vizioso perché ciò che è fondamentale è la spontaneità dell’azione che consiste nel lasciarsi trasportare dal continuo flusso delle cose e del mondo. Chiara Erbosi 176 Recensione Citizenship W. Norman e W. Kymlica in A Companion to Applied Ethics Blackwell Publishing, 2006 Introduzione al volume
Il volume A Companion to Applied Ethics, affronta il vasto campo
dell’etica applicata. Questo termine, apparso negli anni settanta, indica
temi di riflessione che riguardano momenti particolari della morale
collettiva. In particolare l’etica nelle scienze biomediche e negli affari.
Il manuale consta di cinquanta contributi, ognuno dei quali affronta
una specifica problematica.
Questo contributo sviluppa una riflessione critica sull’uso del termine “cittadinanza”, divenuto oggi centrale per inquadrare la vita sociale e politica. In primo luogo gli autori ricordano come esso rimandi all’appartenenza di un individuo a una comunità politica. Già in questa accezione il termine risulta articolato e complesso: se in linea di massima un cittadino risulta classicamente appartenente ad uno stato, in realtà oggi esso può intendersi come appartenente anche a una regione o a un aggregato di stati. Inoltre cittadinanza rimanda ad altre realtà e situazioni come l’appartenenza a organizzazioni che hanno motivi di aggregazione diversi da quelli strettamente politici. L’articolo affronta alcuni tra i punti centrali del dibattito attuale sulla natura e sulle dinamiche dei rapporti che intercorrono fra singolo individuo, aggregazione sociale e organizzazione dello stato. Gli autori ricordano come il termine cittadinanza sia divenuto – a partire dagli anni Novanta – estremamente pervasivo e indichi tutta una serie di problematiche. Esse sono sintetizzabili in insiemi concettuali quali: cittadinanza come status legale; cittadinanza come identità; cittadinanza come solidarietà; cittadinanza come virtù civica. Fra questi temi uno particolarmente pregnante riguarda il nuovo profilo che può caratterizzare l’essere cittadino oggi. La concezione classica della figura di cittadino rimandava alla appartenenza della persona ad un luogo, ad una organizzazione statale o alla sua possibilità, più o meno ampia, di partecipazione alla vita politica. Oggi emergono nuove forme di aggregazione che contribuiscono tutte a disegnare la cittadinanza come appartenenza a identità ‘diverse’. Fra queste, gli autori indicano ad esempio 177
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 il femminismo, i nazionalismi etnici e il multiculturalismo. Emerge dunque, sia a livello teorico che pratico, la necessità di ridefinire il cittadino, in termini di pratiche di cittadinanza attiva e responsabile. Questo comporta il compito di integrare i temi della giustizia di tipo liberale con visioni diverse e plurali di appartenenza ad una comunità. Altro tema affrontato dagli autori è quello relativo allo status dell’eguaglianza. Le dinamiche che emergono dalla presenza di minoranze, pongono problemi concreti e richiedono strategie per l’integrazione. Le attuali strategie partono dal rispetto della differenza fino ad arrivare a una attiva valorizzazione delle varie specificità culturali o etniche. Risulta che questi percorsi favoriscano l’integrazione sociale. Nello svolgimento delle riflessioni sulla cittadinanza, gli autori riconoscono poi un ruolo importante ai percorsi formativi. Se classicamente lo stato liberale offriva una partecipazione passiva alla vita civile, oggi le dinamiche sociali e culturali pongono sempre più pressante la domanda su come i cittadini possano essere educati in termini di consapevolezza e di partecipazione attiva: dimensioni queste emerse alla fine degli anni Novanta e oggi affrontate con programmi educativi sempre più pervasivi. Concludendo l’analisi critica dei vari aspetti che concorrono a definire il termine cittadinanza, Norman e Kymlicka riconoscono come questo non possa essere termine unico e univoco per tutti i tipi di società. Essi indicano pertanto un percorso operativo per ampliare e definire meglio il concetto di cittadinanza attraverso specifici studi di caso. Le dinamiche dei gruppi sociali e la dimensione del multiculturalismo spostano la questione su come le strutture della società civile e i percorsi educativi possano essere usati per promuovere le virtù civiche. La necessità, sempre più sentita, di promuovere una più alta qualità di partecipazione democratica conduce la teoria della cittadinanza a legittimare l’inserimento del concetto di moralità politica nella concezione moderna di uno stato democratico. Matteo Borri 178
Recensione Hate crimes, literature and speech L. W. Sumner Il saggio di L. W. Sumner, Hate crimes, literature and speech, è tratto dal libro A companion to applied ethics dedicato a questioni morali, sociali e politiche di etica applicata. In questo saggio l’autore affronta lo stretto e sottile legame che intercorre tra libertà di espressione e uguaglianza dei cittadini e il problema di quale sia il dovere di una società nei confronti di chi pratica e predica l’odio contro le minoranze. Se da una parte infatti abbiamo il dovere di rispettare e proteggere tutti i membri di una società, senza nessuna eccezione, e di evitare ogni tipo di discriminazione, dall’altra è vero anche che alla nostra società è affidata la tutela del diritto di espressione che richiede il rispetto delle opinioni altrui. Ma fino a che punto una società deve essere preparata a tollerare i comportamenti e soprattutto le parole di coloro che sono intolleranti nei confronti di altri individui o minoranze? Se per quanto riguarda i comportamenti la questione è più semplice, essa diventa più spinosa quando dalle azioni si passa a considerare il piano delle parole. Le parole infatti, se è vero che non possono raggiungere la violenza delle azioni, possono comunque insultare ed offendere gruppi sociali con forme di discriminazione e intolleranze basate sulla razza, le origini, l’orientamento sessuale e altro ancora. L’autore cerca di affrontare questa spinosa questione ponendosi l’interrogativo se la libertà di espressione possa essere una giustificazione per qualunque forma di espressione e lo fa portando gli esempi degli Stati Unti e del Canada che hanno limitato il diritto alla libertà di espressione specificando e sottolineando che esso non include forme di espressione come la diffamazione, le invettive razziali e qualunque discorso che possa ledere minoranze sociali e singoli individui. Chiara Erbosi 179
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 180 Recensione Moral Status Mary Anne Warren in A Companion to Applied Ethics Blackwell Publishing, 2006 Introduzione al volume
Il volume A Companion to Applied Ethics, affronta il vasto campo
dell’etica applicata. Questo termine, apparso negli anni settanta, indica
temi di riflessione che riguardano momenti particolari della morale
collettiva. In particolare l’etica nelle scienze biomediche e negli affari.
Il manuale consta di cinquanta contributi, ognuno dei quali affronta
una specifica problematica.
Il contributo di Mary Anne Warren, Moral Status1, problematizza le caratteristiche attraverso le quali è possibile definire le condizioni necessarie e sufficienti per avere uno stato morale. Questo emerge dalle diverse interazioni fra gli agenti morali e si estrinseca negli obblighi morali che essi potrebbero o dovrebbero avere in relazione a diritti di base, quali il diritto alla vita e alla libertà, e comporta, quindi, il considerare da un lato le proprietà intrinseche agli agenti morali e dall’altro proprietà di tipo relazionale. Godere di stato morale “pieno” significa essere una entità verso la quale gli agenti morali – e non – hanno o possono avere obblighi e che a sua volta può averli verso questi. Nel saggio Warren passa in rassegna una serie di teorie “uni‐criteriali”, per proporne poi un modello complesso che le interrelazioni. La Moral Agency Theory applica lo statuto di agente morale agli esseri umani, così come già compiutamente specificato da Kant. Le “persone” – in quanto agenti morali razionali – hanno fini la cui moralità è intrinseca. Tali fini non sono assoluti ma sono compatibili con quelli di altri agenti morali. Secondo tale prospettiva non viene assegnato un valore intrinseco ad agenti non razionali, sebbene venga ammessa la possibilità di obblighi morali verso di essi. Il punto di forza della Moral Agency Theory consiste nell’attribuire pieno ed eguale stato morale ad ogni individuo che abbia la capacità di un agire morale, non ammettendo così una discriminazione legata a criteri quali la razza o il genere. Emergono tuttavia, secondo l’autrice, 1 In A Companion to Applied Ethics , Blackwell Publishing 2006. 181
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 tre punti che limitano la validità generale di questa teoria. Il primo riguarda la relazione con gli animali non‐umani, collocati al di fuori degli obblighi morali in quanto non agenti morali. Il secondo punto analizzato da Warren è relativo al fatto che tale concezione sembra escludere gruppi importanti come i neonati o i disabili mentali in quanto li riconosce come privi di quella razionalità “necessaria” per essere agenti morali. L’autrice presenta come terzo punto critico la “pericolosità” che le applicazioni di una tale teoria possono avere nel gerarchizzare e classificare gli esseri umani in gruppi sociali e generi a cui negare lo statuto di agente morale conforme. L’esclusione di quelle tipologie di esseri umani quali i neonati o i disabili mentali è colmata dalla Genetic Humanity Theory che riconosce lo statuto morale a tutti gli individui della specie Homo Sapiens. Ogni uomo, in virtù del proprio portato genetico, gode di tutti i diritti di base, dalla nascita alla morte. La Genetic Humanity Theory è dunque condizione necessaria e sufficiente per avere stato morale? La Warren non è di questo avviso. L’autrice riconosce come punto di forza il garantire la condizione di pieno stato morale a ogni individuo, neonati e disabili mentali compresi, ma muove la sua critica non considerando tale teoria esaustiva. Il portato genetico non è condizione necessaria qualora si includano nei rapporti morali tutti quegli esseri “non‐umani”, costituiti dalla nostra base genetica come potrebbero ad esempio essere gli extra‐terrestri. Altresì la Genetic Humanity Theory non può essere condizione sufficiente perché automaticamente escluderebbe ovuli umani fecondati che – sebbene appartenenti alla stessa specie – non appartengono a individui senzienti. La Sentience Theory assume come condizione necessaria e sufficiente per godere dello stato morale, la capacità di avere stati mentali coscienti. Tale teoria ha portato differenti autori a concettualizzazioni differenti. La versione forte della Sentience Theory sostiene che gli obblighi morali possano essere estesi oltre la specie umana, riconoscendo ad animali non‐umani (mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi) una caratteristica “senziente” simile a quella umana, legata ad esempio a sensazioni quali dolore o piacere. La versione debole della Sentience Theory pone l’accento sulla difficoltà di riconoscere verso tutti gli esseri senzienti una uguale importanza morale. Sarebbe difficile trattare la sofferenza di animali semplici come quella di un uomo. Risulta così che l’essere senziente può essere considerato sufficiente per avere stato morale a patto di assumere alcune limitazioni. Nella Organic Life Theory gli organismi viventi sono intesi come sistemi teleologicamente organizzati e ogni organismo come possessore delle proprie abilità, determinate dalla sua specifica forma di vita. Il loro telos deve essere moralmente rispettato. Tale teoria concepisce la possibilità di nuocere agli altri organismi solo per autodifesa o per preservare la vita (umana). Così, ogni giorno, per sopravvivere, distruggiamo milioni di microorganismi e piantiamo il grano. Ma tali organismi non hanno il nostro stesso statuto morale. La Organic Life Theory è – secondo la Warren – sufficiente per alcuni stati morali minimi ma al tempo stesso non è sufficiente per uno stato morale pieno ed eguale per tutti gli esseri. Le Two Relationship‐Based Theories concepiscono lo stato morale come dipendente dalle relazioni sociali che connettono tra loro con agenti morali umani. L’autrice assume una posizione critica verso questo approccio, affermando che le relazioni sociali e/o ecologiche possono sì portare a obblighi morali specifici ma esistono anche alcuni obblighi di base verso 182
Recensione – Moral Status gli altri esseri senzienti che non presuppongono tali relazioni. Per Warren nessuna delle teorie uni‐criteriali finora presentate è condizione necessaria e sufficiente per godere dello stato morale. Il combinare le differenti teorie tra loro e metterle in relazione con aspetti sociali ed ecologici porta l’autrice a sviluppare una teoria più complessa. La strategia adottata da Mary Anne Warren è "esprimere ogni criterio come principio generale, permettendo ad ogni principio di chiarire gli altri".2 Seguendo questo schema l’autrice propone i suoi 7 principi che vengono elencati qui di seguito: 1.
Il principio rispetto per la vita: gli organismi viventi non devono essere danneggiati o distrutti senza buone ragioni (che non violino altri principi morali). 2.
Il principio anti‐crudeltà: gli esseri senzienti non devono venire uccisi o resi soggetti a dolore o sofferenza, a meno che non esistano alternative per rendere possibili o raggiungibili scopi che: (1) consistano con altri principi morali e (2) siano vitali per gli esseri umani o per altre entità che abbiano uno stato morale più forte che non si basi solo sull’essere senziente. Più altamente senziente e più mentalmente sofisticato è un essere, più forte è l’obbligo di non nuocergli. 3.
Il principio dei diritti dell’agente: gli agenti morali hanno eguali diritti morali di base, inclusi il diritto alla vita e alla libertà individuale. 4.
Il principio dei diritti umani: entro i limiti delle proprie capacità e del principio 3, gli esseri umani che sono senzienti ma che non sono capaci di agire moralmente, hanno gli stessi diritti morali di base degli agenti morali. 5.
Il principio interspecifico: nei limiti dei principi 1‐4, i membri non‐umani di comunità sociali miste hanno uno stato morale più forte di quello di ogni singolo senziente del gruppo. 6.
Il principio eco‐sistemico: ogni cosa vivente che appartiene a specie importanti per il loro ecosistema e minacciata da attività umane, nei limiti dei principi 1‐5, ha uno stato morale più forte di quello fondato sulle loro proprietà estrinseche. 7.
Il principio della transitività del rispetto: nei limiti dei principi 1‐6 e nella misura in cui sia possibile e permissibile moralmente, gli agenti morali dovrebbero rispettare le attribuzioni reciproche di stato morale più forte a certe entità rispetto alle loro proprietà intrinseche. Matteo Borri 2 M. A. Warren, Moral Status, in A Companion to Applied Ethics , Blackwell Publishing 2006, p.446. 183
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 184
Book Review The Political Mind Why you can’t understand 21st‐Century American Politics with an 18th‐
Century Brain Penguin Group (USA), 2008 The study of the mind presents several implications; one of these is certainly political. Politics is not only an abstract concept concerning administration and power; it is also an embodied idea involving different cognitive functions instantiated by our brain. Any cognitive ability, like the communicative skills we use every day, as well as our aptitude to recur to moral evaluations, is strictly related to various bodily features characterizing each of us. Understanding the ways our natural constitution shapes our mind represents today a new challenge that could change the manner we approach the study of social phenomena in the future. Lakoff’s Book is a description of some of the main scientific theories that make possible a naturalistic analysis of different aspects of our social world, revealing the importance of the unconscious mechanisms regulating political life. This book is an instrument for all readers interested in knowing how science can be successfully involved in the development of the social studies and, at the same time, it represents an acute analysis of the major cognitive strategies adopted by the principal political alignments of the United States. The Political Mind is principally a work about politics; but it’s also an attempt to link together salient outcomes of cognitive science, neurobiology and linguistics, with the explicit philosophical aim of defining a more complete understanding of “what it means to be a human being”. For Lakoff we are facing the necessity to abandon the traditional way we conceive our rational thought, as well as to change the established role we attribute to rationality in the foundation of our democratic systems. The old enlightenment’s ideal of (pure) reason, involving notions such as universality, evidence and abstractness, employed for many centuries to justify the main ideas of the progressive tradition, clashes today with evidences coming from empirical research. Recently, cognitive inquires, as well as functional and anatomical brain studies, have revealed a different imagine of rationality, characterized by natural contingences, unconscious mechanisms and embodied aspects. These represent a deep change of paradigm in the way we conceive rationality, involving necessarily modifications also in the way we understand aspects of our life, such as communication, morality and politics. To understand what exactly drives Lakoff to propose an innovative twenty‐first‐century conception of the human mind, it’s necessary to begin with one of the basic assumptions of his book. For Lakoff, an adequate analysis of the political context begins necessarily from the fact 185 Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 that we think with our brain, that is, from the fact that we have no choice but to assume that all human cognitive life is subject to the rules governing the behavior of our neurons. In its practical dimension politics involves many cognitive abilities, such as communication, evaluation and conceptualization, all of these inseparably related with different natural features of our brain. For this reason, for Lakoff, the study of politics can be considered an analysis of a particular human activity about changing the brain through the individuation and the use of the adequate cognitive strategy. One of the main purposes of Lakoff’s work is to show how a deeper awareness of the way different brain mechanisms are involved in our cognitive life can be considered a useful instrument for the understanding and the development of a political behavior. Far to propose a kind of deterministic neuro‐politics, or a sort of rhetorical neuro‐liberalism, Lakoff intends to suggest an original way to analyze the political context introducing measures of evaluation updated to the actual level of scientific knowledge. To be aware of the natural constraints regulating fundamental aspects of our social life, such as emphatic attunements and moral judgments, is for Lakoff indispensable to promoting a mindful approach to the complex world of political thought. Lakoff’s argumentation follows two principal lines. On the one hand he develops an exam of some neurobiological features generally involved by political thought, on the other he produces an analysis of the main cognitive frames present within the actual American debate. At the end of his work Lakoff shows the possibility of creating a strict correlation between these two different approaches to the political discussion, underlining the role that a naturalistic point of view can assume in the examination of our social life. At the basis of Lakoff’s analysis is the relatively recent discover about the behavior of particular neural circuits present in the human brain (and in the brain of other primates) called Mirror Systems. Well confirmed experiments show the role of these kind of neurons for the development of imitative process involved by social abilities such as intentional understanding and emphatic attunement. In light of these results, Lakoff proposes an original unification between some aspects of his célèbre studies of cognitive linguistics and recent acquisitions of neuroscience, showing how an original description of the cognitive processes involved by the political thought (and praxis too) is starting to be available also from a biological level of description. In Lakoff’s Book politics assumes the aspect of a cognitive strategy involving both a qualified use of language and deep understanding of what determines moral evaluations. The first task passes through the introduction of the notion of frame, that is through the awareness that the understanding of any meaning is always strictly dependent from the understanding of the conceptual and evaluative parameters related to it. In this way, the success of a communicative process is made possible by the ability to evoke the right frame in whom the message is directed. For Lakoff, language is a matter of neural connections. To be aware of the mechanisms with which our brain makes possible semantic understanding, that is by the activation and the neural recruitment of just present synaptic relations, as well as by the construction of new neural circuits, gives us a new appreciation for language, how it is exploited in different 186 Book Review – The Political Mind circumstances and what the limits are for its use in communicative contexts such as politics for example. Political praxis involves the use of the right words within the opportune circumstances, pointing to “activate” the right cognitive associations between the semantic features characterizing any linguistic frame. Working within the framework of an adversary, evoking his cognitive associations rather than the proper, represents a typical error committed by politicians who ignore the basic cognitive and biological rules at the basis of any communicative process. Questions concerning the explanation of our common social behaviors are central for Lakoff’s argumentation. The understanding of the natural processes that makes empathy a feature of our common social life represents, for the author, a crucial point in the definition of what he calls a Cognitive Policy. A Cognitive Policy, as Lakoff defines it, is a strategy to getting an idea, for example a moral idea, into the normal public discourse, using the adequate communicative approach to produce a desired “change in the brain of millions of people”. Far from being a proposal involving the use of scientific knowledge to instill opinions or manipulate minds, Lakoff’s book intends to show with clear language what political understanding really involves on the biological ground, directing the attention of the reader to the presence of natural, but unconscious, mechanisms of our everyday thought. Lakoff’s aim is to make mindful both the general public and the politicians of the hidden dimension of any political process, making possible a more responsible way to understand and practice political life. In his book Lakoff doesn’t hide his personal purpose to suggest a new way to intend the progressive conception of politics. Analyzing the contemporary political language he makes explicit the conceptual and moral differences that distinguish the two main ways to intend social life in United States, revealing the different cognitive metaphors used by the conservative and the progressive alignments. The book represents a criticism to the communicative strategy pursued by the American left during the last fifty years, underlining its inability to compete with the more efficacious tactics of the conservative part. Lakoff’s work also represents an analysis that, with the appropriate translation, could be adopted to describe the actual political state of many European countries, illuminating the presence of some shared critical aspects of the contemporary progressive strategy all around the world. The supremacy of the conservative frames in the political discussion, beyond to be frequently imputable to a question of mass media control, is also the consequence of an inadequate communicative approach of the great part of the progressive movements. The choice to adopt a communicative strategy characterized by the evocation of enlightenment values, such as universal rationality, or logical evidence, is now revealing its cognitive limits, forcing the progressives to face the dominance of the more effectively conservative frames in the actual political language. Beyond to be an excellent example of scientific popularization, Lakoff’s book represents a pioneering work in the definition of an original multidisciplinary approach to the world of politics, proponing a new interaction between natural and social sciences. In doing this, Lakoff is motivated by an optimistic stance about the possibility to give novel life to an Enlightenment revolution, based on the diffusion of a new conception about reason and cognition that, differently respect the past a priori stance, might be developed in accordance with the actual 187
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 scientific acquisitions. For Lakoff, furnishing a natural explanation of the hidden processes regulating our cognition, makes possible to consciously create a new conceptual framework, that is an imaginary and an emotional tone in which to develop a novel approach to the political dimension, characterized by moral consequence too. Lakoff’s book shows that we are in front of one of the most important challenges of the scientific history. The by now plausible possibility to develop a naturalistic approach to complex aspects of our everyday life represents an exciting promises concerning the future development of the scientific research toward a new understanding of our social nature. From some years cultural and economical interests together exert a great pressure in support of a rapid development of applicative outcomes of (Social) Neuroscience and in this field the expectations appear to be enormous. Now, to know what practical changes the diffusion of a “21st century” updated awareness of the social dimension will produce in our individual life is just a matter of time. Table of Contents Introduction: Brain Change and Social Change How the Brain Shapes the Political Mind Anna Nicole on the Brain The Political Unconscious The Brain's Role in Family Values The Brain's Role in Political Ideologies Political Challenges for the Twenty‐first‐Century Mind A New Consciousness Traumatic Ideas: The War on Terror Framing Reality: Privateering Fear of Framing Confronting Stereotypes: Sons of the Welfare Queen Aim Above the Bad Apples Cognitive Policy Contested Concepts Everywhere The Technical Is the Political Exploring the Political Brain The Problem of Self‐interest The Metaphors Defining Rational Action Why Hawks Win The Brain's Language Language in the New Enlightenment Afterword: What If It Works? 188 Book Review Neuroethics. Challenges for the 21st Century
Neil Levy Cambridge University Press, 2007 On June 2008, in the Indian state of Maharashtra, for the first time a judge has convicted a woman of murder based on evidence from a brain scanning procedure named BEOS (The New York Times – 09/15/2008, p. A8). The Brain Technology Oscillation Signature test (BEOS) registers data from an electroencephalogram with special software that, according to the inventor, detects the activation of specific region of the brain connected with the memory of really occurred facts. The Indian jurisdiction has been the first to accept BEOS as relevant legal evidence of guilt, but it’s certainly not the unique to be interested in to develop such revolutionary technologies. Actually other jurisdictional institutions are seriously evaluating the possibility of accepting brain based tools of investigation, commercial enterprises are also starting to invest capital in the research of brain based predictive models concerning consumers choices. In view of facts like these, it appears reasonable to suppose that a revolution concerning the way we evaluate people’s behaviors is near to occur. If so, from a philosophical point of view, two preliminary questions appear to be of primary importance: What kind of awareness regarding the brain’s functions can improve our understanding of the people’s moral status? And more generally, how can the experimental research be used in our future studies concerning Ethics? A new challenge to the traditional philosophical studies comes from one of the most hopeful scientific fields: Neuroscience. Today, the advancement of neurobiological research and the availability of new methodologies of inquiry promise to solve ancient dilemmas, showing us the natural constraints regulating our moral judgments. The recent methodological progress into the brain’s anatomical and functional analysis, made possible by technologies as PET, fMRI, EEG or single neuron investigation, today makes accessible new data concerning the occurrence of simultaneous states of mind, behavior and brain. These new information, for many years the object of conjectures and speculations, are now accessible for the development of exciting interdisciplinary studies between science and philosophy. In this context Neuroethics represents a good example of multidisciplinary field of research, offering an analysis of the way investigation of the biology of the brain can be employed into different research contexts, including social, political and ethical studies. As shown by the 189 Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 increasing number of scientific publications and the copious quantity of items present on the web, neuroethics is today the center of a lively discussion, attracting interest from such diverse fields as Philosophy, Neuroscience, Psychology and Cognitive Science. Moreover, it’s impossible to underestimate the role that public understanding of science plays in the development of studies so correlated with our common life. The announcements that fit the pages of newspapers, regarding surprising discoveries about the neural basis of our ordinary life, as for example of our sentiments, tastes and decisions, participate with these frequent emphatic account to increase the general interest and the expectations that support, in their turn, new researches and new discoveries. Before analyzing the main thesis of Levy’s book, it’s necessary to introduce a preliminary distinction. Internal to the subject of Neuroethics, two main different branches can be defined: the ethics of neuroscience and the neuroscience of ethics. The former regards the definition of an ethical framework for regulating the neuro‐scientific enquiry and its application to the human beings, the latter concerns the effects of the neuro‐scientific knowledge upon the development of ethical theories. Into his book, Levy aims to point out how neurobiological knowledge promises to be, more than a solution of ancient philosophical questions, a practical instrument useful for different moral troubles that afflict our social life. Far from proposing an enthusiastic approach, Levy opts for an examination of various instances characterizing the relation between the two, apparently distant, worlds of ethics and experimentation. It’s important to note that Levy’s intention is not coincident with the attempt to develop a theory of moral behavior starting from a biological point of view. For this, Levy’s proposal is not subject to classical objections against the role of factual knowledge within our moral understanding. Despite the potential confusion related to the introduction of empirical information into moral analysis, a condition well known since Hume’s distinction between descriptions and prescriptions, and despite the limits imposed by the naturalistic fallacy introduced by Moore, Levy is successful in giving a representation of the effective practical and theoretical opportunities associated with the study of the relationship between brain and behavior. Instead of a source of theoretical or pragmatic solutions, Levy appears to conceive Neurosciences as a special instrument, the use of which is central to producing a deeper understanding of the ethical and moral troubles that confront us. Essential to Levy’s argumentation is the definition of Extended Mind (EM). With the EM notion Levy aims to show the possibility of considering our mind in a more broad sense than usual, that is not only as an abstract object, neither as a part of our body confined in our skull. According to the EM notion we can conceive our mind as the whole set of mechanisms and resources with which we think, including the set of technical tools we have developed for this purpose, as for example calculators, books and any other part of the environment that supports our cognition. If the definition of EM proposed by Levy is certainly vague and open to objections, at the same time it furnishes an interesting suggestion about the way the relationships between our mind and our brain’s mechanisms could be understood. Starting from the EM hypothesis, the techniques of inquiry we use to scan our brain become integral parts of our vision of the world, 190 Book Review – Neuroethics directly influencing our conceptions and our actions. As a new perceptive skill, neuroscience gives us the possibility to contemplate problems with a richer set of information and conceptual parameters, illuminating hidden links between our behavior and the natural circumstances that influence it. In light of this, Neuroethics emerges as a new frame of analysis, involving the introduction of different conceptual parameters of evaluation than traditional approaches, as represented by the recourse to experimental corroborations for the development of ethical analyses. Another important purpose of Levy’s book is to sketch a more familiar image of neuro‐
biological research. Despite the dramatic perception popularized by some fictions, Levy shows how implausible is the progress of neuroscience toward fearful forms of mental control. As Levy notes, other traditional researches, more than the study of our brain’s mechanism, permit today the development unconscious mental manipulations devoid. Without the necessity to refer to complex scientific notions, our social environment alone could be considered a powerful instrument of everyday influence on our perceptions. As well demonstrated by surprising experimental researches, relevant cognitive aspects of our life, such as memory, self identity and judgment skill, are usually modified starting from the influence of our common social relations. After all, for many years the commercial use of psychological strategies to attract customers and increase business is a common aspect of our life, a typical form of mind control that doesn’t require any particular kind of neuro‐biological intervention. In particular, a theoretical limit appears to interfere with the development of the “ambitious” projects concerning the realization of efficacious mind reading machines, based on the knowledge of our brain mechanisms. The definition of a standard procedure of analysis, designed for all kinds of mental processes and for any effective cerebral instantiation of them, presupposes that salient aspects of our thought and behavior present the same functional realization in all different brains. If in some respects, this great deal of commonality appears certainly evident in various aspects of our social life, is still far from established for the practical purposes involved in the development of universal mind‐reading machines. Far from being able to control our memory and our behavior in a more efficacious manner than other environmental influences (social or chemical as drugs), neuroscience today can offer a sub‐personal descriptions of some recurring features that characterize the moral choices of our life. The neurobiological explanation of impairments concerning the coordination of different “modules” of our cognition, as for example involved in syndromes as autism, Capgras’ delusion, or in case of brain damage, offers us the possibility to understand better the natural limits characterizing the way we perceive the world and consequently control our body and behaviors. Ascertained cases of crimes committed in consequence of brain’s pathologies, underline the necessity to enlarge the range of legal facts including in them the domain of neuroscience, moreover they also encourage a more accurate awareness about the way our biological constitution is involved in making possible the moral judgments we use every day to live in our social environment. Cases such as that of the Indian jurisdiction reflect the real importance of an accurate epistemological analysis of the effective level of knowledge today available in the field of 191
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 neuroscience. As Levy notes, the reliability imputable to new techniques of mind‐reading, such as the BEOS legal test, is strictly connected with the presence of real supporting data and independent controls, both fundamental aspects of serious scientific research that commercial and political interests are frequently inclined to eclipse. Leaving aside Orwellian scenarios with fantastic speculations, for Levy the importance of Neuroethics is represented by the opportunity to define a revision of our conception of morality on an empirical basis. Enlarging the conception of our mind to the whole set of methodological instruments involved by the development of our knowledge, Levy tries to show troubles concerning morality instead to be only a priori matters, present relevant natural constraints, well represented by the anatomical and functional futures of our brain. The work of Levy is an appreciable attempt to discuss necessities and limits related to the introduction of experimental methodologies also within classical philosophical debates concerning ethics and morality. Despite the general analysis of the interactions between science and philosophy requires a discussion outside the aspirations of the Levy’s book, the studies relating neurological and ethical questions contained in this book represent today an opportunity of progress along the way toward an integrated conception of our mind and our body. This is nothing but an old challenge that still persists also in the 21st Century. Silvano Zipoli Caiani Table of Contents 1. Introduction 2. Changing our minds 3. The presumption against direct manipulation 4. Reading minds/Controlling minds 5. The Neuroethics of memory 6. The self of “self” control 7. The Neuroscience of freewill 8. Self‐deception: the normal and the pathological 9. The neuroscience of ethics 192 Idee per una rilettura Etica senza ontologia Hilary Putnam Mondadori, Milano 2005 Etica senza ontologia nasce da due cicli di lezioni che il filosofo americano Hilary Putnam ha tenuto nel 2001, presso i dipartimenti di Filosofia dell’Università di Perugia (Hermes Lectures) e Amsterdam (Spinoza Lectures). Secondo il filosofo americano, una riflessione proficua sull’etica deve confrontarsi con argomenti e problemi comuni ai vari settori della ricerca filosofica (epistemologia, filosofia della matematica, logica, filosofia della scienza, filosofia del linguaggio, ecc.). Il problema dell’antirealismo in etica e dell’antirealismo in filosofia della matematica, per esempio, sollevano, secondo Putnam, interrogativi analoghi: perché i filosofi che respingono gli argomenti dell’antirealismo in matematica, non respingono anche gli argomenti dell’antirealismo in etica?1 In che mondo il tentativo di dare una spiegazione di carattere ontologico dell’etica può essere accostato allo sforzo di conferire oggettività ontologica agli oggetti della matematica? E in che senso possiamo definirci ‘riduzionisti’ o ‘eliminativisti’ in etica? Per rispondere adeguatamente a tali questioni, occorre ripensare l’idea stessa che abbiamo di filosofia, concepita non come insieme di campi specifici, ma come attività intellettuale volta al raggiungimento di una visione integrata e comune a questioni filosofiche apparentemente lontane e differenti .2 Discostandosi, in parte, dagli orientamenti dell’etica analitica tradizionale, Putnam afferma che il primo obbiettivo del filosofo morale non è l’elaborazione di un ‘sistema’, ma è quello di fornire un contributo a soluzioni di problemi di carattere pratico. Occorre, allora, che l’etica faccia propria la lezione del pragmatismo americano e condivida l’eredità di quelli che il filosofo definisce i “tre illuminismi”: il primo legato al pensiero di Platone e Socrate, il secondo, appartenente al XVII e al XVIII secolo, e il terzo, non ancora concluso e associato al nome di John Dewey .3 Putnam mette in evidenza come il carattere monistico, riduzionistico ed eliminativistico delle varie metafisiche sia in contrasto con la visione ‘pragmatista’ dell’etica: infatti, esse o riducono tutti i fenomeni etici a un’unica questione, la presenza o l’assenza di un’unica ‘super‐entità’‐ il Bene ‐ o riducono “qualcosa a qualcos’altro”, come, per esempio, gli enunciati etici in espressioni di sensazioni.4 Il nominalismo, poi, altro genere di ontologia deflazionista, afferma che le proprietà non sono altro che nomi, e nega l’esistenza di “cose come le proprietà”.5 Occorre, sostiene Putnam sulla scia degli insegnamenti wittgensteiniani, considerare l’ipotesi di un ‘pluralismo pragmatico’, e riconoscere l’utilizzo, nel linguaggio ordinario, di vari registri di discorso, conformi a regole differenti, con caratteristiche logiche differenti. L’idea che esista un solo linguaggio in grado di descrivere l’intera realtà, è, secondo questa concezione, un’illusione: “Il pluralismo pragmatico non richiede di individuare oggetti misteriosi e soprasensibili che trascendono i nostri giochi linguistici”; e questo, precisa Putnam, vale anche 193 Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 per gli enunciati etici.6 Con il termine ‘etica’, infatti, non si intende “un nome per un insieme di principi”, ma, piuttosto, “un sistema di elementi correlati che si puntellano reciprocamente in tensione oppositiva”.7 Qualsiasi tentativo di ridurre l’etica a una teoria dell’essere, o di fondare l’etica su una ontologia tradizionale, come messo in luce dal filosofo Lévinas, è fallito miseramente.8 Anche il grande Kant può essere considerato “un ontologo inflazionista suo malgrado”; infatti, pur rinunciando al progetto metafisico tradizionale di descrivere il mondo in sé, lo fa basandosi su una teoria che “esalta il potere della mente” e che ha l’ambizione di precedere la metafisica stessa..9 L’attualità del pragmatismo per l’indagine etica contemporanea, è individuabile, in particolare, negli scritti di John Dewey. Secondo il filosofo americano, il fine dell’indagine filosofica ed etica non è quello dell’infallibilità, ma quello di sviluppare un “metodo per affrontare i problemi degli uomini”.10 Concepire l’etica come attività pratica significa, però, anche storicizzarla e, data la natura contingente dei problemi stessi, riconoscere la naturale fallibilità delle soluzioni proposte. Come ricordato nel saggio Il pragmatismo: una questione aperta, Putnam ritiene che in etica sia necessario assumere l’atteggiamento antiscettico tipico del pragmatismo americano: il dubbio, secondo questa corrente di pensiero, necessita di una giustificazione tanto quanto la credenza, concepita come priva di garanzie metafisiche e, perciò, fallibile, rivedibile.11 Gli enunciati etici, infatti, devono essere considerati come “forme di riflessione governate da norme di validità e verità” e, come qualsiasi altra forma di attività cognitiva, sottoposti agli stessi criteri fallibilisti che dominano l’indagine sul ragionamento pratico.12 Occorre, allora, che l’indagine filosofica contrasti l’atteggiamento che Putnam definisce “platonizzante”: cedere, cioè, alla tentazione di trovare delle entità misteriose, dietro ai concetti, che garantiscono i giudizi formulati su ciò che è ragionevole e ciò che non lo è.13 In questo senso, l’ontologia, osserva Putnam, “non può essere di alcun aiuto all’etica”, così come non lo è per la matematica, la logica, o la teoria del metodo scientifico.14 Si pensi, per esempio, al concetto di insieme come entità non localizzata nello spazio: se, infatti, di un oggetto come una fragola possiamo individuare la posizione nello spazio, non ha senso chiederci se la classe delle fragole sia localizzabile da qualche parte; essa non è da nessuna parte.15 Ora, questo non significa che gli insiemi e le rispettive parti (i sottoinsiemi) concepiti come ‘entità astratte’, non esistono realmente; potremmo chiederci, infatti, se l’insieme potenza esista realmente, ma, secondo Putnam, è la domanda stessa a essere priva di significato. Allo stesso modo, non ha senso porsi la questione dell’esistenza o meno di particolari proprietà morali, dato che gli enunciati etici, così come i simboli logici, non hanno un significato univoco, ma presentano una “pluralità di usi possibili”.16 L’atteggiamento platonizzante si manifesta per mezzo di due idee filosofiche ricorrenti: l’idea che se un asserto è oggettivamente vero, allora, ci devono essere oggetti con i quali tale asserto è in corrispondenza, e l’idea che se non ci sono oggetti naturali, le cui proprietà rendono vera la tesi, allora, devono esserci oggetti ‘non‐naturali’ che assumono il ruolo di produttori di verità.17 Tali principi, se applicati all’etica, portano a ritenere che “se esistono verità come la bontà di certe situazioni, allora, ci deve essere una proprietà non naturale, ‘il bene’, che ne rende conto”.18 194
Idee per una rilettura – Etica senza ontologia Pensiamo al concetto di verità matematica: che cosa significa conoscere la verità matematica? La risposta, in pieno stile wittgensteiniano, va rintracciata nell’apprendimento delle pratiche e dei criteri della matematica stessa, incluse le pratiche della matematica applicata. In questo senso, afferma Putnam, non serve supporre che le verità matematiche siano rese vere da un qualche insieme di oggetti, ma è la pratica della matematica a metterci d’accordo su cosa considerare una verità matematica (e questo, aggiungiamo, dovrebbe valere anche per la logica e la filosofia della matematica). Allo stesso modo, non è necessario chiedersi se il linguaggio dell’etica è vero di un qualche insieme di oggetti, anzi, asserisce Putnam, il linguaggio dell’etica contiene giudizi etici che non possono essere formulati adeguatamente ricorrendo alle classiche parole preferite dai filosofi: dovere, bene, obbligo, giusto, buono e così via. Inoltre, l’etica spazia dall’indagine di principi molto astratti come i diritti umani, fino a considerare soluzioni per problemi pratici molto specifici; in tal senso, i principi astratti (si pensi all’imperativo categorico kantiano) devono essere considerati, più prudentemente, come “guide fallibili per la soluzione di problemi pratici”.19 L’indagine etica deve farsi scienza empirica, attività pratica al servizio della vita umana: in quest’ottica deve essere concepito il “terzo genere di illuminismo”, associato alla figura di Dewey e non ancora completamente realizzato. È, inoltre, percepibile, qui, il legame del pensiero di Putnam con le tesi di Quine espresse in Two Dogmas of Empiricism: l’affermazione dell’inseparabilità della dimensione logico‐linguistica da quella fattuale ed empirica, e il riconoscimento del valore epistemologico della continuità tra scienza e filosofia. Sulla scia delle posizioni antifondazionaliste quiniane, Putnam ritiene, infatti, di dover rinunciare al valore fondazionale dell’ontologia per l’indagine etica, a favore, invece, del riconoscimento del legame di dipendenza che gli enunciati etici hanno nei confronti dell’esperienza. Come ammoniva William James, infatti, la filosofia deve essere considerata come attività volta alla eliminazione dei dualismi metafisici tradizionali e impegnata nell’affermazione del primato dell’esperienza per una descrizione comprensiva dell’esperienza stessa. Fornire spiegazioni di tipo ontologico per l’oggettività degli enunciati etici, affema Putnam, “sarebbe come un tentativo di fornire ragioni che non sono parte dell’etica a favore della verità degli enunciati etici”.20 Come impostare, allora, una corretta analisi delle questioni etiche? La risposta, lo abbiamo già ricordato, è individuabile nel terzo genere di illuminismo, l’illuminismo che Putnam definisce “pragmatista” e che, come auspicava Dewey, deve diventare “critica dei criticismi”, attività pratica che “prenda le distanze” e che analizzi “persino il modo in cui siamo abituati a criticare le idee”.21 La lezione di Dewey e del ‘terzo illuminismo’, ricorda Putnam, sta nel considerare l’esistenza di fatti etici da scoprire per mezzo dell’indagine empirica. Con Dewey, ricorda il filosofo, si passa dalla “Ragione” alla “applicazione dell’intelligenza ai problemi”, un segnale, questo, di grande mutamento interno al pensiero filosofico tradizionale. Attraverso la “Ragione”, infatti, la filosofia tradizionale pensava di poter impadronirsi di un insieme di verità immutabili. Dopo gli empiristi e grazie ai contributi di Peirce, James e Dewey, Mead, Mill, questa concezione dominante sarà in gran parte indebolita: il pragmatismo si caratterizzerà per essere fallibile e antiscettico. E lo sarà anche nei confronti dell’indagine dei fenomeni sociali, un’indagine di carattere empirico e orientata politicamente.22 Occorre, precisa Putnam, tenere presente un insegnamento fondamentale del pensiero di Dewey: “Come Aristotele, Dewey crede che le 195
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 ragioni del comportamento etico non si possano comprendere in una prospettiva ‘non‐etica’ o ‘pre‐etica’; una persona deve essere educata alla vita etica, e questo presuppone che la persona sia già in una comunità”.23 Da qui l’importanza accordata dal filosofo americano all’educazione: una concezione dell’educazione che non può consistere nell’insegnamento meccanico e passivo di nozioni senza una credenza critica di ciò che viene insegnato. L’atteggiamento critico, la capacità di problematizzare, di imparare a pensare con la propria testa, non sono soltanto caratteristiche fondamentali per ogni singolo essere umano, ma lo sono anche per qualsiasi democrazia partecipativa. Ecco che, allora, il pluralismo pragmatico ci invita a considerare l’etica non più come “una questione che riguarda il decidere tra differenti famiglie di tradizioni, tra differenti varietà di kantismo o di utilitarismo”, né come “un angolino professionale della filosofia” dotato di un vocabolario prefissato e rigido, ma come “qualcosa in cui s’impegnano tutti gli esseri umani, quando praticano la critica dei criticismi”.24 Ciò che accomuna filosofi come Aristotele, James, Peirce, Dewey, Wittgenstein, secondo Putnam, è “il primato della ragion pratica”: per comprendere gli enunciati etici, occorre condividere una ‘forma di vita’, e questa, ricorda Putnam, non può essere catturata per mezzo di un “metalinguaggio‐positivistivico” o assiomatizzata in un qualche linguaggio formale. La questione dell’etica, conclude Putnam, è rilevante almeno quanto la questione del rapporto tra filosofia e vita: ogni problema umano, infatti, “nella misura in cui ha un impatto individuale e collettivo, è, in senso generale, un problema etico”.25 Alberto Binazzi Note 1 H.Putnam, Etica senza ontologia, Mondadori, Milano, 2005, pp.7. 2 Ivi, ibidem. 3 Ivi, pp.13. 4 Ivi, pp.31. 5 Ivi, pp.32. 6 Ivi, pp.34. 7 Ivi, pp.35. 8 Ivi, pp.36. 9 Ivi, pp.37. 10 Ivi, pp.47. 11 H. Putnam, Il pragmatismo: una questione aperta, Laterza, Roma‐Bari, 2003, pp.27. 12 H.Putnam, op. cit., pp.112. 13 Ivi, pp.106. 14 Ivi, pp.107. 15 Ivi, pp.53. 16 Ivi, pp.57. 17 Ivi, pp.79. 18 Ivi, pp.81. 196
Idee per una rilettura – Etica senza ontologia 19 Ivi, pp.113, Ivi, pp.10. 21 Ivi, pp.145. 22 Ivi, pp.149. 23 Ivi, pp.153. 24 Ivi, pp.159. 25 Ivi, pp.160. 20 197
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 198
Idee per una rilettura La cultura del male. Dall’idea di colpa all’etica del limite Ugo Bonanate Bollati Boringhieri, Torino 2003 Il breve volume di Bonanate tenta con successo un’analisi descrittiva delle caratteristiche di fondo del fenomeno religioso, con particolare attenzione al cristianesimo. Partendo dai concetti di colpa e di caduta ed attraverso un complesso percorso, Bonanate rileva le più diverse visioni di Cristo, della sua figura e del suo ruolo nella storia umana: già all’interno dei Vangeli il ruolo di Salvatore e di Redentore, di colui che opera esclusivamente come strumento della volontà di Dio è presente solo in Marco ed in Matteo mentre il Gesù di Giovanni vede prevalere la figura di un Cristo che è tanto autore della salvezza del mondo quanto fermo nel condannare radicalmente l’uomo come fonte del male in sé. Quest’ultimo tratto, è specifico del vangelo di Giovanni e sarà più tardi adottato da due figure centrali della futura storia Chiesa, Agostino e Paolo di Tarso. Questo è il primo, e probabilmente il più rilevante, di vari “slittamenti di senso” che andranno a costituire il corpo dottrinario della Chiesa nei secoli a venire: due diverse immagini antropologiche rappresentate dai Vangeli da una parte e da Paolo ed Agostino dall’altra. Di queste due immagini storicamente prevarrà la seconda: la visione più “possibilista” del destino dell’uomo e del ruolo della sua volontà nel plasmarlo, visione ereditata da Pelagio, verrà condannata nel 418 dal Concilio di Cartagine, che decretò l’impossibilità da parte dell’uomo di pervenire alla salvezza con le sole sue forze quindi la necessità di una speciale grazia divina. La visione evangelica del ruolo della volontà umana quale coautrice della salvezza dell’uomo non finì però dopo il concilio di Cartagine: come tendenza di fondo la si potrà ritrovare in vari momenti e tendenze della storia della Chiesa e nei tempi moderni i diretti eredi ne furono i gesuiti, in piena opposizione alle tendenze radicali dei giansenisti. Le due concezioni che Bonanate ritrova nelle più varie vicende della storia della chiesa si dirameranno anche al di fuori dell’ambito strettamente cristiano: dopo una carrellata che comprende Pelagio ed il Paradiso Perduto di Milton, Anselmo d’Aosta e Kant, fino ad approdare alla Dogmatica Ecclesiale di Karl Barth, Bonanate arriva a proporre una svolta radicale con due pensatori che, appunto, con il cristianesimo hanno poco a che fare Nietzsche e Freud. Nietzsche dopo aver ribadito il ruolo fondamentale del peccato originale quale “germe di tutti i peccati”, assimila la conquista della coscienza ad un atto di quella libertà che i preti condannano opponendovi la morale: addirittura per il Nietzsche dell’Anticristo “la morale non è nient’altro che questo” e “l’intero ordinamento morale del mondo è stato escogitato contro la scienza”. Il cristianesimo appare a Nietzsche come uno strumento di controllo che 199 Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 instilla nell’uomo “il verme del peccato”: l’uomo diventa così “necessariamente dipendente, un uomo che non può disporre di se stesso come scopo”. In altri scritti ‐ La genealogia della morale, Umano troppo umano, Al di là del bene e del male – Nietzsche arriva ad affermare che il cristianesimo “schiacciò e frantumò l’uomo completamente” ed all’origine di queste accuse secondo Nietzsche, vi sarebbero le dottrine di Paolo. Anche Freud elabora una complessa struttura argomentativa, radicalmente differente da quella nicciana, basata su dati antropologici – dai quali ricavare la genesi dei concetti di colpa e di rito – e sul mito di Edipo. È interessante notare che vi sono due punti di contatto tra Nietzsche e Freud: l’estrema importanza delle lettere paoline e la nozione di peccato originale, rappresentato in Nietzsche dal tentativo di Adamo di pervenire alla conoscenza, in Freud dall’omicidio del padre; in questo sembra emergere che uno dei tratti distintivi dell’uomo sarebbe il rifiuto dell’autorità costituita. Il passo ulteriore delle riflessioni di Bonanate è rappresentato, nel quinto capitolo, da un discorso aperto sulla natura e sulle forme di quella che appare essere all’autore l’erede contemporaneo di quell’autorità costituita, ovverosia la Chiesa cattolica. Suoi frutti ‐ non esclusivi ‐ sono quel generale ed assai pervasivo sentimento di sconfitta che prevale in molti ambienti culturali, di costume e di mentalità corrente, di critica della modernità e di quell’umanesimo razionale che denunciava come sterile l’inevitabilità di uno scacco per la condizione umana. Tra le varie distinzioni operate dall’autore rimane importante quella tra esistenzialismo e nichilismo, corrispondenti rispettivamente alla presa di coscienza dei limiti intrinseci della conoscenza e dell’agire umani ed alla possibilità conseguente di prendere decisioni positive sulla base di questa consapevolezza. Diverso il discorso sul nichilismo: esso nega alla radice ogni possibilità di affrancamento da una condizione che per Bonanate è perfettamente dipinta da scritti quali Religione e futuro di Sergio Quinzio. L’analisi che Bonanate dispiega in questo capitolo è convincente e riesce a penetrare vari aspetti di una questione sfuggente e però anche necessaria: il “risorgere” di una presenza religiosa – tipicamente il cattolicesimo – nella vita sociale Occidentale, unita a settori più o meno ampi di intellettuali e figure della vita pubblica che assieme sono i portatori più o meno consapevoli di un nichilismo diffuso, che si presenta in una varietà di sfumature di intensità variabile. Il prezzo di questa risorgenza è alto e viene pagato in primis dalla società italiana in varie forme; a questa tendenza è però possibile opporre un’antropologia positiva, delineata da Bonanate nel sesto ed ultimo capitolo del volume. Qui si apre quella che è probabilmente la parte più esplicita del volume: etica laica ed etica cattolica si vengono a confrontare in modo diretto, lasciando al lettore la possibilità di un giudizio proprio. Etica laica, in senso lato, è per Bonanate il franco riconoscimento che non si danno riferimenti assoluti, garanzie ultime per l’azione, ma che queste garanzie sono anzi il prodotto ultimo di quegli atti che riteniamo massimamente probabili di essere nel giusto ed ispirati ad una generale apertura intellettuale, tolleranza e rispetto dell’altro. Uno dei primi presupposti a cui rinunciare per un’etica laica è quello storicismo teologico che per l’autore ha sempre lottato contro l’autodeterminazione dell’uomo: la storia è multiforme, 200
Idee per una rilettura – La cultura del male aperta e per così dire si muove in base a quei principi ben espressi da Isaiah Berlin, secondo cui “i fini sono creati, non scoperti”. Nelle pagine finali si avverte come molto presente la celeberrima metafora coniata da Otto Neurath, secondo cui gli uomini sono come marinai che dispongono di un’imbarcazione che deve essere riparata nel corso della navigazione senza che sia mai possibile portarla in un cantiere per una ricostruzione da cima a fondo con materiali non deperibili o modificabili: la filosofia in particolare dovrebbe riprendere la via che le era stata assegnata da Platone nell’Eutidemo (288e – 290d), ovverosia uso del sapere a vantaggio dell’uomo. Giovanni Pancani 201
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 202
Idee per una rilettura I concetti del male Pier Paolo Portinaro (a cura di) Einaudi, Torino 2002 Il volume si presenta come un testo eterogeneo che si articola in ventitré interventi ai quali hanno contribuito intellettuali e filosofi, tutti italiani, del calibro di Bodei e Givone. Come in un “convivio” letterario, gli autori sono chiamati a presentare un aspetto di quella problematica categoria ontologica che gli uomini chiamano “il male”. Dalla filosofia alla medicina, dall’antropologia alla psicologia, dalla teologia alla sociologia; ognuna di queste discipline ha dato diverse interpretazioni sull’origine, la natura e la funzione di questo concetto. Fin dai primi insediamenti umani, ogni gruppo (etnico, religioso, sociale) ha cercato di fondare il proprio agire sulla definizione del male come forza negativa nei confronti della vita, sacrificando notevoli sforzi, materiali e intellettuali, al fine di evitarlo, fuggirlo, superarlo. L’intera storia dell’umanità, per lo meno quella occidentale, dall’antica Grecia ai giorni nostri, attribuisce al male un ruolo da protagonista incontrastato nel giudizio delle azioni umane. Non ci sono periodi storici in cui non ci sia stato il male, ma solo il XX° è stato definito da più parti come “il secolo del male”; con tale constatazione Portinaro apre l’introduzione dell’opera. La selezione dei “concetti del male”, sistemata per ordine alfabetico, rappresenta un percorso ermeneutico in cui i nostri autori si confrontano e rapportano con le argomentazioni di alcuni tra i più grandi pensatori politici e religiosi della storia che ci sostengono e ci sollecitano nella realizzazione di questo percorso. Nell’introduzione, Portinaro non può che prendere le mosse dalla contemporaneità per delineare i contenuti dell’opera. I regimi totalitari, le deportazioni, i campi di concentramento hanno dato una nuova dimensione al male conosciuto dall’uomo fino allora. Dopo Auschwitz anche la sensibilità religiosa si è dovuta confrontare con un male privo di qualsiasi riscatto, in un contesto in cui assordante è stato il «silenzio di Dio»1. 1. IL MALE NELLE RELIGIONI La questione dell’origine e senso del male ha una rilevanza fondamentale in tutte le dottrine religiose; il fondamento ontologico del male viene sostanzialmente definito da tre posizioni: esso è un arredo originario dell’universo; è una perversione dello spirito incarnato nel corpo; o 1
Pier Paolo Portinaro, I concetti del male, Giulio Einaudi editore, Torino 2002, p. XII. 203 Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 il prodotto di una volontà totalmente malvagia; talvolta è un principio inerente al divino, talvolta è fuori da tale controllo, altre è un prodotto esclusivamente umano. Nella dottrina del peccato originale o privatio boni, argomentata da S.Agostino, il male viene definito in senso negativo, come privazione del bene, una mancanza deficitaria, un allontanamento dalla pienezza del bene assoluto ereditato da Adamo e conseguente alla “caduta” dell’uomo. Il principio del male viene identificato in Adamo, il quale, disubbidendo a Dio, ha condannato il resto dell’umanità alla sofferenza. Al centro della concezione agostiniana e della tradizione culturale cristiana c’è la tensione tra colpa e destino: La connessione tra il male e la colpa è costitutiva dell’immaginario delle religioni della redenzione. Il significato della sofferenza è nella punizione e questa ha la sua giustificazione nella colpa […] L’elementare dispositivo della compensazione ultraterrena è la risposta del cristianesimo all’enigma del male dell’Antico 2
Testamento. In tale interpretazione, quindi, il male non inerisce a Dio, bensì è una conseguenza del libero arbitrio offerto ad Adamo. Come viene sostenuto nell’intervento di Giovanni Filoramo,3 la risposta di Agostino soccorre la difficoltà razionale di far convivere l’onnipotenza e la bontà divina con la presenza del male nella natura e nell’uomo: “Di qui il moltiplicarsi di filosofie e teologie che, da Agostino a Leibniz fino ai loro epigoni contemporanei, i sono sentiti in obbligo, attraverso teodicee ruotanti intorno ad alcuni temi di fondo, di spiegare l’enigma di questa coesistenza, con esiti in genere fallimentari.”4 La risposta agostiniana non è, tuttavia, né il primo né l’ultimo tentativo di giustificare il male davanti agli attributi divini; in “Finitudine e colpa” di P. Ricoeur5, il filosofo francese delinea una mappa in cui raggruppa in quattro tipi fondamentali le strategie usate dalle dottrine religiose per spiegare l’origine e la natura del male: 1 – il male è una forza caotica che si oppone alla creazione; 2 – il male ha origine da una caduta in disgrazia nei confronti del divino; 3 – il male rappresenta il fato tragico dell’uomo e suo destino inevitabile; 4 – il male e la sofferenza sono prodotti dell’esilio conseguente alla caduta. La prima posizione è rinvenibile nel primo monoteismo di cui si riportano testimonianze. Mentre la seconda concezione riguarda quella Agostiniana citata sopra, la terza è propria della realtà tragica greca, per la quale il male ha un nesso stretto con il senso del limite dell’essere umano; nell’immaginario dell’uomo greco esso è ricondotto ad una duplice origine: la violenza dell’uomo o la sofferenza per malattia o catastrofi naturali. Nella tragedia, l’eroe tenta con tutte le sue forze di opporsi al male, alla tensione primigenia verso la crudeltà, come recita Anassimandro «cose devono subire la punizione e la vendetta della loro ingiustizia, che è l’ingiustizia dell’essere nate»6. La situazione tipica che ricorre nella tragedia è la consapevolezza dell’impossibilità di una libera azione senza colpe davanti ad un 2
Pier Paolo Portinaro, I concetti del male, Giulio Einaudi editore, Torino 2002, pp. XII‐XIII. Ivi, p. 91.
4
Ivi, p. 94. 5
Pubblicato nel 1970 da il Mulino.
6
Pier Paolo Portinaro, I concetti del male, Giulio Einaudi editore, Torino 2002, p. XIII. 3
204
Idee per una rilettura – I concetti del male destino infausto; diversamente dalla dottrina cristiana, la strategia salvifica attuata dal mondo greco si appella direttamente alla Filosofia, in special modo al paradigma socratico per cui la conoscenza consente di godere con moderazione dei piaceri e, con moderazione, affliggersi per i mali. Se per un fato tragico non c’è salvezza, ma solo una rassegnata consapevolezza, la conoscenza può sicuramente evitare all’uomo il male morale, reggendosi su di un’etica intellettuale. La quarta strategia, sempre di matrice agostiniana, rovescia il punto di vista greco, sviluppando l’idea della necessità di un destino di sofferenza che l’uomo deve subire al fine di espiare il peccato che ha causato la caduta; tuttavia l’intellettualismo etico greco non si esaurisce con l’avvento della cristianità ma si rinnova durante l’illuminismo moderno, quando, con Kant, appare un nuovo termine nel lessico filosofico: male radicale. 2. IL MALE RADICALE L’analisi del concetto di male radicale fatta da Kant, ottimamente spiegata da Maria Antonietta Pranteda, si riallaccia alle precedenti considerazioni, fin qui esposte dagli altri autori sul rapporto tra il male e le dottrine cristiane. Attraverso l’espressione male radicale il filosofo tedesco tenta di rielaborare il concetto di peccato originale; è doveroso sottolineare che questo tipo di locuzione è raramente presente nelle definizioni del male all’interno delle Sacre Scritture come nei testi dei padri della chiesa; essa viene citata come metafora di radice malevola. A conferma della profondità con cui questa concezione è impressa nella cultura umana, si rivela interessante l’intervento precedente: “Maleficio” di Francesco Remotti, il quale, con un taglio nettamente antropologico, riporta una credenza diffusa tra alcune tribù africane che ricalca proprio questa concezione: Tra i BaYaka della Repubblica Centraficana [del Congo. N.d.r.], ad esempio, Louis Sarno ha potuto constatare – nonostante il loro pronunciato realismo – un improvvisa e stupefacente diffusione della credenza nel gundu, una sostanza che si trova in certi individui, a cui è possibile far risalire la causa dei 7
mali che affliggono i componenti della società: malattie, disgrazie, morte [SARNO 1993, trad. it. P. 315]. Il gundu dei BaYaka, il mangu degli Azande, il kunda dei Lesi, sono concetti che individuano il male all’interno di alcuni individui facenti parte della società da cui esso sgorga, come da una fonte, “inquinando” la serenità sociale con malattie, disgrazie e morte. Una “radice” del male, insita per natura negli individui, deresponsabilizza, però, l’azione malvagia; l’esistenza di una radice del male ereditata dal genere umano, in conseguenza del peccato originale, presenta non pochi problemi di coerenza logica ed etica; così, dopo il Concilio Vaticano II8, la comunità ecclesiastica ha preferito dare più enfasi alla redenzione del peccato in Cristo, come anche Ricoeur, in Finitudine e colpa, sintetizza: «l’atto con cui il male è assunto su di sé non è il punto di arrivo ma di partenza» di un percorso che porta dalla consapevolezza della possibilità del male, in seguito alla perdita dell’innocenza, alla redenzione, attraverso l’espiazione e l’intervento divino. 7
8
Ivi, p.157. Indetto da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959. 205
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Nell’intervento presente, Pranteda delinea come si è sviluppato storicamente il concetto di peccato originale in relazione all’idea di radicalità del male. Seguendo uno schema analitico, la relazione tra questi due concetti si può riassumenre in quattro passaggi: 1 – la metafora della “radice” esprime un concetto antropologico sulla fallibilità del genere umano, un principio che si realizza nella perversione dell’agire dell’uomo, quando è posto nella più totale libertà, indipendentemente dal fatto che il soggetto voglia agire per il bene; 2 – viene svalutata l’idea di azione volontaria in cui si ammette un limite, un condizionamento, insuperabile; 3 – l’inapplicabilità di un’imputabilità totale in presenza di colpe; 4 – la necessità di un intervento “sovrannaturale” che argini la “radice” e favorisca l’azione positiva. Da un punto di vista storico si può osservare una sovrapposizione tra il concetto di peccato originale e male radicale, nel periodo che va da Agostino a Lutero, mentre nel periodo che va da Lutero a Kant si avvia un processo di distinzione tra i due concetti, distinzione nettamente conclusa dal lavoro del filosofo tedesco. Kant si interroga sulla possibilità di sostenere, con gli strumenti della sola ragione, l’affermazione che la malvagità naturale dell'uomo non costituisce né una limitazione della sua libertà, né, dunque, della sua responsabilità Kant intende conciliare l’assunto della radicalità con la difesa delle leggi della libertà, vale a dire con l’obbligatorietà della legge morale e l’imputabilità delle azioni. Il fatto che esista «una tendenza al male» ascrivibile alla natura dell’uomo non toglie che essa sia «in se stessa moralmente cattiva», tuttavia la causa della cattiveria va ricercata nel liberto arbitrio «e quindi può essere imputata». Il che significa, in altri termini, che ammettere questa tendenza non esime dall’osservanza della legge morale e non diminuisce il gradus imputationis della colpa.9 Il limite dell’argomentazione di Kant si trova nella premessa per cui nessuna ragione umana potrebbe concepire il male per se stesso, ma solo se erroneamente percepito come bene e, quindi, a seguito di una 'corruzione' del giudizio morale; il limite di questa posizione verrà drammaticamente evidenziato dagli eventi accaduti nel novecento sotto i regimi totalitari. quando l’impossibile è stato reso possibile, è diventato il male assoluto, impunibile e imperdonabile, che non poteva più essere compreso e spiegato coi malvagi motivi dell’interesse egoistico, dell’invidia, dell’avidità del risentimento, della smania di potere, della vigliaccheria […] È conforme alla nostra tradizione filosofica non poter concepire un “male radicale”, e ciò vale tanto per la teologia cristiana, che ha concesso persino al demonio un’origine celeste, quanto per Kant, l’unico filosofo che, nella terminologia da lui coniata, deve aver perlomeno sospettato l’esistenza di questo male, benché l’abbia immediatamente razionalizzato nel concetto di perversione della volontà, spiegabile con motivi intelligibili. Quindi non abbiamo nulla a cui ricorrere per comprendere un fenomeno che ci sta di fronte con la sua mostruosa realtà […] un’unica cosa sembra certa: possiamo dire che il male radicale è comparso nel contesto di un sistema in cui tutti gli uomini sono diventati egualmente superflui.10 9
Pier Paolo Portinaro, I concetti del male, Giulio Einaudi editore, Torino 2002, p. 169. Hanna Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni Comunità, Torino 1999, pp. 628‐29. 10
206
Idee per una rilettura – I concetti del male 3. LA BANALITÀ DEL MALE Il termine “genocidio”11 è stato coniato nel ‘900 appositamente per determinare, come categoria giuridica, lo sterminio perpetrato dal regime nazista. A fronte di questa indiscutibile realtà, rimarrebbe tuttavia difficile non convenire con Portinaro laddove scrive: «il genocidio non è una novità della storia più recente; al contrario può essere considerato una costante in quel lugubre “mattatoio” che è la storia universale». 12 Nell’intervento di Portinaro segue l’analisi del contesto in cui si può sviluppare la pratica genocidaria, cullata da sentimenti di odio religioso e/o ambizioni di conquista; tuttavia ciò che lascia perplessi e, dunque, interessa è la motivazione che ha spinto un’intera nazione di individui a mettere in atto, nel cuore dell’Europa del XX secolo, in modo pianificato e sistematico, il più grande eccidio della storia umana, dopodiché, letteralmente il “male” non è stato più lo stesso. Alcune risposte le fornisce la Arendt, alla quale dobbiamo anche la locuzione “banalità del male”, titolo del proprio reportage sul processo Eichmann, nonchè titolo del contributo di Simona Forti, la quale, in maniera estremamente efficace, tratteggia il pensiero della celebre intellettuale. Il paradosso della definizione arendtiana risiede nell’impossibilità di credere che uno sterminio di simili proporzioni sia stato progettato, sostenuto e realizzato solo da individui “assolutamente malvagi”. Davanti a tanto orrore è necessario e inevitabile supporre la collaborazione di una numerosa “mano d’opera” di individui comuni senza la quale ciò non sarebbe potuto accadere. Assistendo al processo di un funzionario del governo nazionalsocialista, la Arendt si trova così a scavare nelle motivazioni dell’uomo medio; è dalla prospettiva del “docile funzionario” che l’orrore del totalitarismo si rivela drammaticamente banale. Egli osservava, infatti, con zelo e lealtà l’imperativo del nuovo ordinamento. E il nuovo comandamento, appunto, non recitava più «non uccidere», ma «tu devi uccidere»; non un pericoloso nemico, ma esseri colpevoli di fuoriuscire dai parametri di umanità stabiliti dal regime. Il principio supremo, condiviso da numerosi suoi connazionali, la virtù per eccellenza, consisteva per lui nell’obbedienza, convinto che senza 13
obbedienza nessuna comunità politica si possa mantenere. Eichmann non faceva altro che ascoltare la voce della sua coscienza che lo esortava a seguire l’esempio della “buona società”. Se, così convenendo con la Arendt, l’assenza di pensiero critico sta alla base della possibilità del totalitarismo e, di conseguenza, è la prima causa delle peggiori nefandezze; se la radicalità del male, il male assoluto, si nasconde nel “banale” orrore quotidiano di un piccolo burocrate, che tolta la divisa di funzionario vestiva la faccia della normalità e che, come qualsiasi di noi era padre, marito e figlio; allora, per questo motivo, non dovremmo sentire l’avvertimento della Arendt, la necessità di pensare con la propria testa, come sempre attuale e presente? 11
Il termine genocidio deriva dal greco (ghénos razza, stirpe) e dal latino (caedo uccidere) ed è stato definito dall'ONU come "Gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso". 12
Pier Paolo Portinaro, I concetti del male, Giulio Einaudi editore, Torino 2002, p. 105. 13
Ivi, p. 34. 207
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 4. CONCLUSIONI Per motivi di spazio, purtroppo non è possibile riportare tutti i contenuti degli interventi con la dovuta accuratezza che occorre, tuttavia le tematiche che abbiamo ripassato in questa sede coinvolgono buona parte degli argomenti trattati; la lettura, tuttavia, grazie alla struttura del testo, è molto agile e permette di cimentarsi, saggio dopo saggio, sia sui singoli contenuti che su le tematiche generali che segnano trasversalmente tutta l’opera. L’agilità di lettura non significa però superficialità, gli argomenti trattati meritano un’impegnata concentrazione e riflessione, essendo questi sempre di estrema attualità; “I concetti del male” non è un trattato che pretenda uno studio rigoroso e sistematico, ma neanche una lettura evasiva, contiene una serie di riflessioni destinate a lasciare il segno. Riccardo Furi 208
Idee per una rilettura La comunità che viene Giorgio Agamben Bollati Boringhieri, Torino 2001 “L’essere che viene è l’essere qualunque1”. L’incipit del libro di Giorgio Agamben ha ben poco a che vedere con i favoleggianti moniti di Guglielmo Giannini degli anni ’40 e ’50 del secolo scorso. Elitario e vagamente popolar‐
intellettuale il secondo, tanto quanto Agamben è dedito alla riflessione filosofico‐politica che cerca (anche attraverso l’uso e lo specchio di un linguaggio di tradizione filologica di matrice heideggeriana) un paradigma della collettività. Che cos’è che ci caratterizza come società, come insieme vivente e pulsante di relazioni? La risposta di Agamben non è (e non può essere) l’individuo ‐ concetto di derivazione innanzitutto hegeliana in senso di comunità storica, poi ripreso da Marx in chiave di comunità di classe e infine approdato al capitalismo e alla sua parcellizzazione olistica del tutto. Né può essere la persona, concetto stavolta cristiano, in un’epoca che ha vissuto la morte di Dio e sta vivendo ancora i postumi ‘del tempo della povertà’ di cui ammoniva Hölderlin nella famosa lirica di inizio ‘800 Pane e vino. Secondo Agamben il quid che caratterizza la nostra epoca, che sembra aver lasciato alle spalle definitivamente la modernità per entrare in uno spazio in cui il tempo si è rimodulato e compresso verso l’immediatezza, è il Qualunque. Scrive Agamben: Il Qualunque che è qui in questione non prende, infatti, la singolarità nella sua indifferenza rispetto a una proprietà comune (a un concetto, per esempio: l’essere rosso, francese, musulmano), ma solo nel suo essere tale qual è. Con ciò, la singolarità si scioglie dal falso dilemma che obbliga la conoscenza a scegliere fra l’ineffabilità dell’individuo e l’intelligibilità dell’universale2. Al di là del linguaggio (spesso ostico, quasi intriso di misterismo), il filosofo romano, che dal 2003 insegna presso l’Istituto Universitario di Architettura (IUAV) di Venezia, ci informa della malattia del secolo a venire: non l’indifferenza del singolo verso l’Altro, ma il singolo che diventa genericamente uguale annegando se stesso nel mare della ‘improprietà’ e quindi della povertà: “qualunque è una somiglianza senza archetipo, cioè un’Idea3”. E poco più avanti Agamben aggiunge: “L'essere che viene: né individuale né universale, ma qualunque. 1
Giorgio Agamben, La comunità che viene, Bollati Boringhieri Torino, p. 9. Ibidem. 3
Op. cit. p. 42. 2
209
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Singolare, ma senza identità. Definito, ma solo nello spazio vuoto dell'esempio. E, tuttavia, non generico né indifferente4”. L’incipit sopra ricordato si salda con la Postilla che chiude lo scritto (aggiunta nel 2001, mentre il libro è del 1990). È qui che si comprende l’autentico messaggio dell’intero scritto; un messaggio che è interamente filosofico. Anzi, che riguarda la stessa sopravvivenza della filosofia intesa come avventura intellettuale. L'autore sostiene che non soltanto «la possibilità di scuotere l’esistenza storica di un popolo» è svanita da un pezzo, ma che perfino l’idea stessa di una chiamata, di un popolo o di un compito storico assegnabile – di una klesis o di 5
una «classe» – dovrebbe essere ripensata da cima a fondo . A essere in discussione è innanzitutto la filosofia, non come forma mentis, ma come quell’anelito che soffia nel cuore della società e la plasma. Un potere che a noi uomini del Terzo Millennio sembra avere l’odore acre della polvere delle biblioteche. Eppure c’è stato un tempo in cui filosofare non era un ‘mestiere’, un combattere giorno per giorno per affermarsi sul mercato delle idee. In una parola: non era il Qualunque. Ma se la nostra epoca, questa è la domanda finale di Agamben, è sottomessa proprio al Qualunque, come è possibile, come sarà possibile la filosofia, ovvero quell’arte che trae la propria origine e la propria forza dal domandare e quindi, di per sé, dalla distinzione? Nell’indistinto mare della collettività di oggi, tramonta la filosofia. In questo senso la democrazia diventa potere del numero, la politica mera amministrazione, la vita cieco bios assoggettato alla techne, l’etica un banale aut‐aut. Ma nonostante lo scenario disegnato, Agamben tiene fermo il timone senza eccedere (o cadere) in facili commiserazioni: per l’autore la condizione di sopravvissuto non autorizza comunque né cinismo né disperazione. Se “l’assenza di opera, la singolarità qualunque” da ipotesi iniziale è invece diventata realtà, l’irreparabile non è ancora giunto. Una filosofia e una politica, un’etica, in fondo, è ancora possibile. Da dove ripartire, dunque, per la riformulazione di un’etica? Il fatto da cui deve partire ogni discorso sull’etica è che l’uomo non è né ha da essere o da realizzare alcuna essenza, alcuna vocazione storica o spirituale, alcun destino biologico. Solo per questo come un’etica può esistere: poiché è chiaro che se l’uomo fosse o avesse da essere questa o quella sostanza, questo o quel destino, non vi sarebbe alcuna esperienza possibile – vi sarebbero solo compiti da 6
realizzare . Allora l’uomo è consegnato nelle mani del nulla e/o del fato? Affatto. Ciò che l’uomo ha da essere, scrive Agamben, “è il semplice fatto della propria esistenza come possibilità o potenza7”. Da notare che il filosofo usa sempre l’espressione “ha da essere” e mai “ha il compito di”, ulteriore prova del fatto che l’umanità non porta con sé nessuna consegna particolare (o qualunque, come direbbe Agamben) riguardo a un metafisico, né tanto meno 4
Op. cit. p. 56. Op. cit. p. 91. 6
Op. cit. p. 39. 7
Ibdem. 5
210
Idee per una rilettura – La comunità che viene terreno, destino. Il singolo può scegliere soltanto la propria esistenza: il fare dell’uomo è tutto compreso in questa aristotelica potenza (il richiamo ad Heidegger e a Nietzsche è qui fin troppo evidente). Il riconoscimento di tale condizione rende evidente e fa emergere anche il problema della negazione della potenza che ripiega nell’impotenza: il male. Scrive Agamaben: Il male è unicamente la nostra inadeguata reazione di fronte a questo elemento demonico, il nostro ritrarci impauriti davanti a lui per esercitare – fondandoci in questa fuga – un qualunque potere di essere. Solo in questo senso secondario l’impotenza o potenza di non essere è la radice del male. Fuggendo davanti alla nostra stessa impotenza, ovvero cercando di servirci di essa come di un’arma, costruiamo il maligno potere col quale opprimiamo coloro che ci mostrano la loro debolezza; e mancando alla nostra 8
intima possibilità di non essere, decadiamo da ciò che rende possibile l’amore . Per Agamben l’uomo è un oscillare continuo in questo essere e non‐essere; e in tale oscillamento, in fin dei conti, diventa con‐essere come destino comune, come potenza e scelta che tutti condividiamo con tutti. Ovvero è in questo luogo che lascia essere una contingenza per quella che è, che dice sì alla propria esistenza e ai suoi limiti, che diventiamo una comunità. Michele Morandi 8
Op. cit, p. 32. 211
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 212
Intervista A colloquio con Jean Luc Nancy, di Laura Beritelli Da sempre Jean Luc Nancy1 sostituisce l’‘e‐
l’inoperosa disposizione scrizione’2, all’ascolto, al ‘metodo’, per aprire lo spazio logico ad una condizione non questionante del pensiero ‐ all’interrogazione che non interroga ‐, poiché sa che solo l’offrirsi del pensiero, senza intenzionalità altre, è all’altezza dell’evento/avvento del trascendente: scrittura e filosofia hanno quindi, ai suoi occhi, il compito di mantenere l’apertura (all’inedito, alla sorpresa, alla generosità ontologica). Gettare le basi di quello che l’autore chiama: un pensiero finito3, significa dunque contemplare gli infiniti modi di fare filosofia, tra i quali l’uso della contaminazione linguistica, che rivendica l’illegittimità necessaria al pensiero per pensare. Quello di Nancy è un caos che si organizza, lo stesso che aiuta noi a gettare un ponte tra una sua opera e l’altra, attraverso la parola che ha scandito la sua vita e che si trasforma, così, in quello che Kant avrebbe detto ‘la chiave di volta dell’intero edificio della ragion pura’: si tratta del cuore, il cuore duro delle cose4, il cuore dell’essere5, il suo cuore malato6. Nancy, ancora, propone una forma di resistenza della comunità al tentativo, da parte delle istituzioni tecniche, di appropriarsi dell’in‐appropriabile, dell’esperienza che ci fa essere, della comune esposizione: è il ‘comunismo letterario’7, che egli dice dovuto ad un’esigenza politica irrinunciabile. Esso sfida l’immanenza senza parola e la trascendenza del Verbo, per accedere ai quali non possono bastare le risorse “del comunismo e dei comunisti, da una parte, e la letteratura e gli scrittori dall’altra”8. Il comunismo letterario è dunque una forma possibile di quella nouvelle critique che vuole dalla letteratura “l’iscrizione della nostra resistenza futura”.9 L’intervista10, che scandisce un percorso attraverso le sue proposte più problematiche, chiarisce se esso non sia più di una provocazione e chi, o cosa, possa incarnarne l’effettività. Alla domanda se Pier Paolo Pasolini possa essere stato un degno rappresentante di quella proposta ‐ nonché anticipatore dell’etica dei corpi11 ‐, Nancy risponde di sì, giustapponendolo a Bataille. Ne segue un dialogo che disegna i contorni di un possibile collegamento tra affermatività, corpo ed etica. Per quanto concerne la questione della libertà, il dubbio riguarda piuttosto le intenzioni che possono aver spinto il filosofo a presentare un’ontologia della libertà che non disdegna la riflessione sulle conseguenze ideologiche (o anti‐ideologiche) di un suo diverso orientamento:12 una scelta che andava chiarita, soprattutto alla luce dei 213
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 trascorsi biografici dell’autore13 e considerando che egli stesso per primo definisce la politica filosoficamente fondata l’anticamera del totalitarismo14 Infine, tento15 di chiedere al filosofo se il suo pensiero, così puntuale nell’assolvere alle speranze che Martin Heidegger rimetteva ai posteri nella Lettera sull’umanismo,16sia anche una lettura retrospettiva del filosofo tedesco: un ricondurre al proprio luogo d’origine, al cuore dell’essere, le intuizioni di diversi suoi autori di riferimento, in particolare quelle di J. Derrida.17 L’intervista18 1. J’ai lu que L’expérience de la liberté est votre thèse de doctorat. Je voudrais savoir quelle intention (interprétative) a prédominé dans le choix d’écrire sur la liberté. Je me demande si les raisons de ce choix sont liées à la de‐costruction du langage politique, ou si elles doivent être reconduites plus franchement à l’ontologie. Franchement à l’ontologie, oui, mais en tenant compte de ceci : le mot ‘liberté’ est depuis longtemps confisqué par la droite et toutes les formes de libéralisme, dans une opposition liberté/égalité : je voulais ressaisir la liberté autrement. 2. Est‐ce qu’au moment de l’écriture de l’œuvre, votre volonté était déjà d’orienter vers la communauté, les études et les opinions des auteurs que vous prenez en considération, à travers la recognition historique conceptuelle? Cet essai se positionne‐t‐il, lui aussi, dans un plus grand projet de reformulation politique? Non, pas un projet de ‘reformulation politique’: plutôt la visée, à très long terme, de reformuler LE ou La politique MEME ; il n’y a pas de variation possible dans l’espace ‘politique’, désormais ; c’est lui qu’il faut redéfinir… 3. En outre, quelles sont les perspectives que vous‐même, en tant qu’auteur, vous avez reconnu s’ouvrir dans le débat (politique, ontologique), après la publication de votre ouvre? Je crois simplement qu’il faut encore à nouveau rouvrir la liberté à elle‐même = à l’absolu toujours déjà présent et ouvert. 4. Je souhaiterais savoir si pour vous, aujourd’hui, le questionnement concernant la liberté revête un rôle d’autant plus fondamentale. Dans ce cas, serait‐il nécessaire que la philosophie puisse attendre une émancipation vis‐à‐vis de la pensée légalitaire libérale et/ou moraliste, afin de récupérer la valeur positive de la liberté, considérée en tant qu’autonomie? Cela même au pris d’éliminer le mot même de liberté, qui ne semble plus adapté au monde contemporain? 214
Intervista – Jean Luc Nancy Non! La liberté n’est pas l’ ‘autonomie’! Celle‐ci est le contenu plus classique de la liberté, mais la ‘liberté’ c’est d’aller dehors, c’est d’être poussé, lancé, jeté dehors ‐ hors de l’autonomie, justement. 5. Ainsi, faudrait‐il réaffirmer la primauté de la philosophie en tant que recherche pure, au‐delà des finalités pratiques (telles que la de‐costruction du langage politique) auxquelles elle a été constamment ramenée? Non, cette opposition n’a pas de force: pas de recherche ‘pure’, car tout travail philosophique libère ‐ justement ‐ des sens, des valeurs ou des concepts qui agissent (indirectement, médiatement) dans le monde; et pour la politique, je me répète: ce n’est pas le ‘langage politique’ qu’il faut déconstruire, c’est la politique ou le politique même. Qu’est que c’est ? Est‐ce la seule assomption du commun? Et l’art, et le religieux ? Où sont‐ils? 6. Quelle est votre opinion concernant Pier Paolo Pasolini en tant qu’exemple du communisme littéraire que vous proposé dans La communauté deseuvrée (il me semble que vous le citez aussi dans L’expérience de la liberté)? Pasolini a été le seul, peut‐être (pas loin de Bataille, sans doute –et qui d’autre?) le seul, donc, à percevoir l’insupportable limite du communisme humaniste – ( je ne parle pas du stalinisme, bien sûr! C’est un problème que je considère réglé pur Pasolini. Même s’il a lui aussi été myope…). Pasolini savait que ce que le ‘communisme’ exigeait était au‐delà de l’homme, était l’homme lui‐même au‐delà de l’homme. Toute sa grandeur est là. 7. Au lendemain du travail que vous avez accompli sur la liberté, sur la communauté, sur le corps et la comparution que nous sommes, comment vous vous rapportez à la confiance que Pasolini, colloquait dans le corps et dans la parole comme étant véritablement révolutionnaires?19 Oui, il avait raison –mais ‘révolutionnaire’, c’est quoi?20 8. Les corps en tant qu’exposition et vérité, le seul qui déstabilise la situation, peut‐il générer la possibilité d’une étique? En ce sens, serait‐il possible d’affirmer que l’étique réponde à une forme de pensée affirmative et non questionnant? Bien sur, de toute façon il n’y a d’étique qu’affirmative: l’étique, c’est ‘se tenir’, c’est ‘posture’, ‘attitude’, ‘allure’, corps ‐ c’est‐à‐dire façon d’aller dehors, de sortir de chez soi, de marcher, d’avancer21. 9. A ce sujet je fais référence aussi à la partie de votre texte (que j’analyse dans ma thèse), dans laquelle vous dites que la liberté est différente des libertés. Cela parce 215
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 que ces immanences se consomment, et elles doivent être constamment animées de sens par quelque chose d’autre. Mais alors, ce quelque chose d’autre, pourrait‐
il être ce qui existe grâce au mouvement pré étique de la liberté, c'est‐à‐dire le corps? Oui, si vous voulez dire que le corps va vers lui‐même, vers son ethos: posture, allure –à la fin, le corps mort laisse son ethos inscrit quelque part…il se libère… 10. Nous pourrions aussi poser la question suivantes: pourquoi l’être singulier et pluriel n’est pas aussi une multitude (entendue dans le sens de moltitudo et non pas dans celui utilisé dans la politique alter mondialiste d’Antonio Negri) ?22 Bien sûr, ‘pluriel’, c’est ‘multiple’ ‐ mais ‘pluriel’ insiste sur le fait que c’est un pluriel de singuliers! 11. Le communisme littéraire peut‐il concilier ce qui peut être dit avec ce qui se montre uniquement? Concilier, non: car le dire jamais ne rejoint le ‘montrer’, mais il peut l’indiquer, il peut l’écrire. 12. Peut‐il aussi ‘décrire le devenir ou quelque chose advient’, le vécu de la communauté, la situation en train de se dérouler et qui n’est pas encore devenue histoire codifiée? Non, il n’y a pas à ‘décrire’, mais à ‘laisser venir’, à ouvrir les oreilles et les yeux pour ce qui vient. 13. De quelle manière vous avez été influencé par la différance de Derrida? Peut‐on affirmer que, si la différance est la différence ‘ontico ontologique’ de Heidegger23, de cette façon alors, vous ne la ramenez pas à la maison? Non la différance emporte la différence ontico ontologique du côté où c’est l’être lui‐
même qui (se) diffère: voilà l’essentiel; Heidegger lui‐même avait senti comment sa différence pouvait figer deux termes ‐ être et étant‐ alors que l’ ‘être’ n’est pas un terme ‐ l’être n’est pas, il se diffère. 24 Seconda parte. Chiarimenti25 14. […] je vous ai demandé si la conclusion du chapitre sur le communisme littéraire était un rappel de la conclusion du Tractatus de Wittgenstein. Je ne possède pas la version originale en français mais je peu vous soumettre l’extrait auquel je me 216
Intervista – Jean Luc Nancy réfère en Italien. Vous adressez directement au lecteur et vous ecrivez : «Qui è necessario interrompermi: sta a te che venga lasciato detto ciò che nessuno, nessun soggetto, potrebbe dire e che ci espone in comune”, (J. L . Nancy, La comunità inoperosa, Cronopio, Napoli, 1992, p 163). Non, je n’ai pas pensé à Wittgenstein ; certes, ce n’est pas très loin, mais il y a une différence : Wittgenstein parle de ce qui doit rester silencieux, tandis que je parle de ce qui n’est dicible par aucun sujet (‘sujet’ valant ici comme ‘individu’) mais qui est pourtant ‘exposé en commun’, c’est‐à‐dire qui circule entre nous comme un ‘sens’, bien que non langagier, mais tout de même en quelque façon ‘sensé’ ; ainsi, la communication entre nous de formes, de tonalités, de couleurs, de parfums, de sensations de tout ordre et de ‘valeurs’ aussi bien économiques qu’esthétiques ou morales... – par exemple : aujourd’hui vous et moi pouvons être sensibles à une oeuvre de Pennone, à des graffiti sur des murs ou sur des trains, à une musique de rap ou de raï, au bruit des marteaux‐
piqueurs, à un sentiment troublé au sujet du sens de la ‘politique’ en général, etc, etc... – voilà ce qui ‘s’expose’ : un en‐commun... 15. La sémantique de ce passage m’a rappelée celle du Tractatus et j’ai émis l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’une citation. Le professeur Marino Rosso, pendant le jury de diplôme, a aussi noté à quel point votre pensée rappelle les derniers écrits de Wittgenstein, puisqu’elle se résout pour le rapport et dans la communauté. Vous avez déjà répondu conceptuellement à cette question mais je trouvais approprié vous signaler plus exactement ma référence à votre ouvrage. Je suis d’accord pour cette référence à Wittgenstein, et j’aimerais en savoir plus car je ne sais pas ce qu’il a dit du rapport et du commun, mais je sais que ce qu’il écrit dans ses Remarques sur le Rameau d’Or montre une sensibilité très fine aux différences de ‘partage’ ou de ‘commun’ entre des cultures. 16. Je voulais vous demander si dans votre façon d’envisager les choses, ne prévaut pas la praxis interprétative ou l’empreinte de Heidegger, plutôt que celle des auteurs français. Sans doute, oui! 17. Je parle aussi du Heidegger exhortant à la pensée (Méditation!). Tache que vous avez considérablement atteint à travers vos textes. Oui, certainement la ‘méditation’ me paraît la plus juste attitude de pensée : non la problématisation, ni l’analyse, mais la méditation, la contemplation de l’impensable 18. Lorsque j’ai relu la Lettre sur l’humanisme, j’ai pensé que vous avez eu avec Heidegger un dialogue spécial. En somme, malgré votre position ontologique, j’ai pensé que vous pourriez être un Heideggérien. 217
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Pourquoi dites‐vous ‘malgré votre position ontologique’? parce que j’ai écrit qu’il faudrait repenser l’ontologie à partir de l’en‐commun? Mais cela même, pour moi, est une manière rigoureuse de recommencer à partir de l’ ‘être’ heideggerien: si cet être ‘n’est pas’, s’il est ‘sous rature’ et si l’homme est son ‘berger’, c’est parce qu’il ‘est’ (dans être) en commun et seulement en commun. 19. Certes, vous pensez et vous écrivez différemment par rapport à tous ces illustres philosophes et je n’entends pas remettre en cause votre évidente originalité : Ainsi, je m’excuse de vous avoir posé certaines questions dont la finalité était de documenter, pour la thèse, votre capacité à englober des expériences de pensé différentes, et parfois considérées incompatibles pour des raisons historiques. Je ne crois pas être si original, je m’efforce plutôt de méditer ce que notre époque nous donne à méditer, et qui, bien entendu, résonne déjà à travers toutes ces grandes pensées. 20. Je voulais aussi vous demander quelque chose concernant les traditions de la pensée: pensez‐vous qu’il est possible de retracer une histoire de la ‘pensée matérielle de l’agir et de la pensée’ ou de l’étique originaire? La pratique d’une pensée, s’autoproclamant comme telle, cœur pulsant de chaque assomption du commun, n’apparaît pas‐t‐elle cycliquement dans l’histoire de la philosophie? Je pense par exemple à Epicure ou à Spinoza (pardonnez‐moi le saut temporel), tout comme à Kant et Heidegger. Oui, Epicure et les Stoïciens, Duns Scot et Ockam, Spinoza, Leibniz aussi (de façon moins visible), Kant, Hölderlin, Kierkegaard, Nietzsche, Marx (ce n’est pas un hasard si cela se précipite dans cette période), Heidegger, Bataille, Artaud, Derrida – Deleuze aussi autrement: tous ceux chez qui la pensée appelle visiblement, expressément un geste qu’elle est elle‐même mais qui la dépasse en même temps 21. Combien le religieux et l’art, font‐ils partie de votre formation? Et combien votre pensée s’enracine dans l’expérience esthétique ou l’e‐scription dans l’approche laïque à la transcendance? J’ai grandi dans un catholicisme de gauche, assez intellectualisé (influencé par la démythologisation protestante) et je pense que c’est cela qui m’a donné du goût pour la philosophie très tôt (dès le lycée). L’art y était mêlé dans la mesure où il représentait pour moi comme la religion la possibilité d’une célébration de l’incommensurable, de ce qui dépasse infiniment. Je pense que c’est cela qui me poussait avant tout: comment ‘célébrer’, comment ‘adorer’ la ‘transcendance’ en effet, c’est‐à‐dire le mouvement de passer (dépasser, aller au‐delà, al di là senza un altro ‘la’…26) 218
Intervista – Jean Luc Nancy 22. Je voudrais vous poser encore tellement de questions, mais je n’ose pas vous déranger ultérieurement. En vous remerciant encore pour l’attention que vous voudriez bien accorder à cette lettre, je vous prie d’agréer, monsieur Nancy, l’expression de mes salutations distinguées. Bien amicalement à vous Note 1
Jean Luc Nancy nasce a Caudéran, in Francia, nel 1940. Si laurea in filosofia a Parigi nel 1962 e conclude il dottorato con Paul Ricoeur nel 1973. Nel 1987 è eletto Dottore di Stato a Toulouse, con relatore G. Granel. È stato maitre de conférence e docente all’Università Marc Bloch di Strasburgo fino al pensionamento, avvenuto nel 2003. 2
“E‐scrizione della cosa significa che il nome della cosa, inscrivendosi, inscrive anche fuori di sé la sua proprietà di nome, in un fuori che esso solo mostra, ma in cui mostrandolo, mostra questa propria esteriorità a sé che fa la sua proprietà di nome” J. L. Nancy, Un pensiero finito, Marcos y Marcos, Milano 1992. 3
J. L. Nancy, Un pensiero finito, Marcos y Marcos, Milano, 1992. 4
Ivi, p 125. 5
J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino, 2000, p 118. 6
J. L. Nancy, L’intruso, Cronopio, Napoli, 2000. 7
J. L. Nancy, La comunità inoperosa, Cronopio, Napoli, 1992, p 147. 8
Ibidem. 9
Ivi,p. 163. 10
Ho raggiunto Nancy via e‐mail grazie al gentile interessamento della Segreteria del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Strasburgo, dove ha insegnato fino al 2003. 11
Pier Paolo Pasolini fu l’intellettuale italiano per antonomasia: poeta, scrittore, giornalista e regista, fu comunista e del comunismo del PCI seppe anticipare e denunciare errori e distorsioni (di cui egli stesso diversamente fu vittima, come gli rimprovera Nancy). Pasolini, attraverso l’esposizione dei corpi caratteristica della sua poetica, espone ‐ senza dire ‐ la forza e la trascendenza, la rivoluzionarietà del corpo posto in una situazione: da Teorema a Petrolio, da Sodoma a Il fiore delle mille e una notte, il corpo esiste ed espone ciò che lo eccede ed è sintomo ultimo di una verità indicibile che è anche libertà (dismisura, giustizia, fraternità). In Pasolini il portamento stesso del corpo diviene proposta etica, dell’ethos al fondo di ogni etica. In Pasolini, un corpo è sempre rivoluzionario perché rappresenta l’incodificabile e il non falsificabile. 12
Ne L’esperienza della libertà, Nancy riconsidera categorie comuni tanto all’ontologia quanto alla filosofia politica, o all’arcipolitico: libertà, uguaglianza, fraternità, giustizia. Nello stesso testo, rilegge il politico come rivoluzione, sottolineandone il carattere di inizialità: per Nancy, un sistema di governo che si basi sulla dialettica democratica, contemplando essa solo libertà acquisite, non apre lo spazio per alcuna differenziazione possibile. 13
Dal 1980 al 1984, col collega e amico Ph. Lacoue‐Labarthe, fonda e dirige il ‘Centre de recherches philosophiques sur la politique’, uno spazio per ripensare la politica e che si prefigge come specifico obiettivo l’evasione dalla retorica delle democrazie occidentali. 14
Come spiega egli stesso nell’intervista a Chiara Cappelletto Nancy: penso, con il mondo negli occhi, pubblicata sul quotidiano ‘Il Piccolo’ del 30/08/2001, parlando del fagocitamento della politica, ma anche dell’arte e dell’amore, da parte della filosofia. 15
La mia parca dimestichezza con la lingua francese ha distribuito qualche difficoltà nel discorso. 16
Nancy assolve, forse per un’esigenza storica a lungo rimandata, il discorso programmatico sul futuro della filosofia contenuto nel testo del 1946. Dalla negazione della distinzione tra teoria e pratica nel pensiero (M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, Adelphi, Milano, 2001, p 33) all’etica originaria della decisione e dell’agire (Ivi, p 78); dalla condanna dell’umanismo come metafisica (Ivi, p 39) all’invito alla meditazione dopo la disfatta della filosofia del soggetto (Ivi, p 103); infine, assolve l’auspicio che un pensiero a venire rifletta non solo cosa e come dire l’essere, ma anche se si possa dire, in quale rapporto con la storia e in base a quale pretesa: un pensiero che non potrà che pensare l’essere a partire dall’e‐sistenza e come eccellenza dell’esistenza (Ivi, p 65). 17
In Francia, a causa dell’affaire, la taccia di collusione di Heidegger con il nazismo, vige una forte censura nei confronti di chi cerca di pensare rifacendosi ad filosofo tedesco, come spiega lo stesso Nancy nei frammenti posti in calce a L’esperienza della libertà. 18
La corrispondenza ha inizio nell’ottobre 2005. 19
In questo caso, riferendomi appunto alla poetica di Pasolini, intendo con ‘rivoluzionario’ propriamente ciò che de‐
stabilizza e perciò rivoluziona la situazione. Il corpo in Teorema porta, col suo silenzio, una verità inascoltabile, 219
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 invisibile ma potente, che impone nel plurale della famiglia borghese, attraverso decisioni singolari e soluzioni personali, una rivoluzione totale della situazione codificata: «questa situazione che viviamo quotidianamente, di scelta non compiuta, di dramma irrisolto per ipocrisia o debolezza, di falsa ‘distensione’, scontento per tutto ciò che ha dato una seppur inquieta pienezza alle generazioni che ci hanno preceduto», Pier Paolo Pasolini, Osservazioni sull’evoluzione del ‘900. in Passione e Ideologia, Milano, Garzanti, 1960, p 330. 20
Diceva P. P. Pasolini: “Parole come ‘rivoluzione’, ‘ragione’, ‘realtà’, ‘storia’, ‘popolo’, ‘proletariato’, ‘sottoproletariato’ ecc. sono parole particolarmente polisemiche: tanto polisemiche che da sole non significano nulla, e quindi hanno sensi diversi a seconda del contesto […]E i sensi che questa parola ha assunto nel mio uso sono tanti quanti i sintagmi in cui l’ho usata”. Tommaso Anzoino, Pier Paolo Pasolini, La Nuova Italia, Firenze, 1975, p 6. 21
Chiedo se l’etica risponda o meno ad un pensiero affermativo; non se sia affermativa, quindi, ma se sia ciò che discende da un pensiero/prassi non questionante: in sostanza, se dalla libertà di Nancy ‘discende’ non solo un bisogno di etica (così come in conclusione de L’esperienza della libertà), ma un’etica, e se l’affermatività di questo corpo è etica. Il corpo è l’affermatività del pensiero di cui chiedo a Nancy se possa ‘fare etica’. 22
Facendo riferimento al senso latino del termine, un singolare che in grammatica indicava il plurale stesso, prendiamo le distanze dalla terminologia di Antonio Negri, che Nancy contesta nel suo articolo Un peuple ou des moltitudes?, comparso su ‘L’Humanité’ del 26/12/2003. 23
Mi riferisco all’intervista che J.Derrida rilasciò nel 1968 e che introduce l’edizione italiana de La voce e il fenomeno, Jaca Book, Milano, 1983. 24
Ovviamente la differenza ontico‐ontologica e la differenza ontologica non sono la stessa cosa, tuttavia dal loro ripensamento in Nancy risulta fondamentale per entrambe il riconoscimento della libertà come logos . 25
Seconda corrispondenza, maggio 2006. 26
In italiano nel testo. 220
Intervista Bruno Accarino Etica: il/la fine della politica Bruno Accarino è docente di Filosofia della storia presso l’Università di Firenze. Attraverso lo studio dei classici della sociologia (Simmel, Weber), della filosofia politica (Arendt, Hobbes) e dell’antropologia filosofica (Blumenberg, Plessner), la sua ricerca si è concentrata sulle categorie del pensiero politico moderno e sulle questioni del tempo e dello spazio, del male e della razionalità. Ultime opere: "Confini in disordine. Le trasformazioni dello spazio", Roma 2007; "Le frontiere del senso. Da Kant a Weber: male radicale e razionalità moderna", Milano 2005; "Daedalus. Le digressioni del male da Kant a Blumenberg", Milano 2001. Ha curato "La bilancia e la crisi. Il linguaggio filosofico dell'equilibrio", Verona 2003. 1. Professore, questo numero di Humana.Mente ha come argomento l’etica e la sua possibile ripartizione nel quadro della distinzione analitici/continentali, che ancora impegna il dibattito filosofico. Secondo Lei, ha ancora un senso mantenere questa linea di discrimine? Il Suo approccio è fortemente segnato in senso continentale e vede l’area tedesca al centro delle Sue riflessioni. Questa netta preferenza ha origini accidentali e legate alla Sua biografia o in ciò si può notare anche una Sua critica della tradizione statunitense? La mia impressione è che, principalmente nella sua corrente dominante, che è di segno progressista o liberal, ciò che in essa si viene a perdere è la centralità del conflitto, viceversa presente in aree a noi più vicine – e non unicamente per l’influenza del marxismo. Altro avviene, invece, sul versante del conservatorismo o neo‐
conservatorismo americano, lo studio del quale, però, sembra ben lontano dall’essere adeguatamente approfondito, dalle nostre parti, andando oltre la prevedibile censura politico‐ideologica di larga parte della classe intellettuale. La distinzione tra analitici e continentali è stata a suo tempo molto gonfiata – le vie della costruzione di nicchie microidentitarie sono come quelle della provvidenza: infinite. Per quel che capisco, il suo nucleo di razionalità era racchiuso in una certa vena antistoricistica che ancora oggi non si può fare a meno di salutare come benefica. Quando il problema interseca le aree di fondazione epistemologica della scienza, un passaggio non peregrino, anzi quasi uno spartiacque, è dato dal saggio di Heidegger sull’epoca dell’immagine del mondo, con una 221
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 proposta di ripensamento della tradizione ermeneutica cosiddetta continentale, ma anche di possibile rivisitazione delle piattaforma epistemologiche care al versante analitico. Lì la frattura sembra ricomporsi. Ad ogni buon conto, se è vero che l’Europa ha spesso usato la storia come deterrente contro i canoni di pensiero di un continente giovane, è anche vero che il rispetto per la storia racchiude un fondo di umiltà nei confronti di un groviglio quasi mai dipanabile. Dal punto di vista geofilosofico, del resto, mi pare che la distinzione da tempo non rispecchi le due sponde dell’Atlantico e che sia stata attenuata dagli stessi americani, quando si sono europeizzati anche in forme che Gramsci definirebbe psittacistiche, cioè importando e scimmiottando le stars della filosofia europea. Quanto alla mia biografia, non ho certo la presunzione di pensare che sia diretta da chissà quale meditazione metafilosofica: molte scelte sono state casuali, meno casuale fu la linea Hegel‐Marx, inaggirabile per la generazione alla quale appartengo e forse essa stessa fonte di un qualche irrigidimento dogmatico. Se poi l’orientamento analitico contenga una componente polemofobica, non saprei dire. Di sicuro l’Europa ha grande dimestichezza, sin dalle origini, con il polemos, il quale non viene ignorato dal neo‐conservatorismo americano, semmai esorcizzato o riletto in chiave imperiale. Anche qui, però, non capisco perché si cerchino con insistenza vidimazioni europee, quali quelle che potrebbero derivare da una presunta filiazione del neo‐conservatorismo dal magistero di Leo Strauss, attraversato da motivazioni di tutt’altro genere e da una quasi maniacale tensione filologica – nell’appropriazione del patrimonio filosofico classico –, che nell’apparato spesso puramente propagandistico di uno staff al servizio dell’amministrazione americana in carica è destinato davvero a non lasciare alcuna traccia. 2. Quali sono gli spazi oggi disponibili per l’azione etica in politica? La questione, forse, andrebbe radicalmente ripensata, anche grazie all’ausilio di una strumentazione non legata all’esperienza marxista o che con essa entri definitivamente in opposizione. La vicenda totalitaria e quella della dissidenza non permette di affrontare sotto una nuova luce il nesso verità/politica? Dire la verità al potere, come nella riscoperta della parresia operata dall’ultimo Michel Foucault, e mettersi in gioco attraverso il rischio della parola libera sono pratiche di soggettivazione di cui, nel corso dell’ultimo secolo, si è riscoperta l'importanza (letteralmente) vitale, in una temperie culturale segnata dalla cecità ideologica e dal ruolo inedito che gli intellettuali vi hanno svolto, quello di abili manipolatori della realtà ai fini della dominazione sull’uomo. Data la sua iper‐ricettività nei confronti delle ideologie totalitarie, l’intellettuale può ancora sperare di avere una credibilità o è legittimo nutrire dei sospetti nei confronti di una vita culturale che si struttura secondo linee di demarcazione più interessate all’utile che al vero? Trovo incongruo l’odierno, incontenibile interesse per il totalitarismo, quando sarebbe facilmente aggredibile il compagno fedele, ancorché fedifrago, della democrazia, che non è il totalitarismo ma l’autoritarismo. Sospetto anzi che si tratti di una vera e propria strategia di schivamento. Il totalitarismo nasce dalla convergenza di circostanze storiche fortunatamente irripetibili, l’autoritarismo è una delle morfologie congenite della civiltà politica e della sua storia. Vedo una certa schizzinosità aristocratica nella decisione di concentrare l’attenzione 222
Intervista – Bruno Accarino sull’uno piuttosto che sull’altro, quasi che le battaglie anti‐autoritarie fossero poco degne e poco entusiasmanti, perché inevitabilmente coinvolte nella tutela dei livelli dati dell’assetto democratico. Ma questo è un errore micidiale: la democrazia si conquista e si perde ad un ritmo quotidiano. Vero è, invece, che almeno in Italia la dissidenza dell’Europa orientale prima della dissoluzione dell’impero sovietico ha incontrato supponenza e distrazione, mi riconosco anche autobiograficamente nel novero di coloro che non percepirono appieno l’orrore dell’oltrecortina (o ne subordinarono la valenza, e le dolorose vicende individuali e collettive da esso generate, ai peraltro macchinosi tentativi di razionalità sociale egualitaria) e non fornirono sostegno al ceto politico emergente dei paesi dell’Europa orientale nell’immaginare una transizione meno traumatica e meno votata al passaggio dal capitalismo di Stato al capitalismo criminale, secondo quanto ci offre lo spettacolo odierno. Non direi però che si sia trattato di un deficit di sensibilità etica, perché a spazzare via qualsiasi dubbio sulla priorità dell’utile è l’onnipotenza del mercato, che in fatto di scrupoli etici ha una propensione al genocidio sicuramente non inferiore a quella delle esperienze totalitarie del ventesimo secolo. Per il resto, ‘cecità ideologica’ è certamente una formula efficace, ma altrove ho voluto richiamare l’adorniano Verblendungszusammenhang, il ‘contesto di accecamento’ che rende irriconoscibili i tratti del dominio. Ora, sarebbe ingeneroso attribuirlo ai soli intellettuali, per quanto smisurata possa essere la loro voluptas servitudinis: l’accecamento è penetrato in ampie zone della società civile (forse segnando anche il tramonto di questa categoria, dotata di un alto lignaggio nella storia delle scuole hegeliane) e fa tutt’uno con le debolezze del sistema democratico. 3. È recente la traduzione italiana di un brevissimo e folgorante testo di Simone Weil, risalente al 1957, dal titolo Note sur la suppression générale des parties politiques1: la filosofa vi esprime una critica senza appello di tali forme di organizzazione politica, che sarebbero interamente basate sulla menzogna e sul volontario oblio di sé che operano i loro iscritti. Mi verrebbe da accostare queste riflessioni a un’intervista2 che Michel Foucault rilasciò, poche settimane prima di morire, nella quale il filosofo mostra una sfiducia radicale nei confronti della figura discorsiva della polemica, contestandone l’appropriatezza, ai fini della ricerca della verità. Questa affermazione, tra l’altro, lo escluderebbe dal novero dei relativisti, dai quali, approssimandosi alla fine, cercò sempre più di distaccarsi. Rinvenendo nella discussione culturale e politica nient’altro che la matrice teatrale e bellica, Foucault scrive che «forse un giorno bisognerà scrivere la lunga storia della polemica come figura parassitaria della discussione e ostacolo alla ricerca della verità»3. Ovviamente, non sono mancate, al riguardo, le accuse sulla presunta anti‐democraticità delle ultime posizioni del filosofo, che sembrava non fare più affidamento nelle dinamiche dialettiche dell’universo culturale. Il giorno di cui parlava Foucault è arrivato? 1
S. Weil, Manifesto per la soppressione dei partiti politici, trad. it. di F. Regattin, Castelvecchi 2008. M. Foucault, Polemica, politica e problematizzazioni, in Archivio Foucault: interventi, colloqui, interviste. 3. 1978‐
1985: estetica dell’esistenza, etica, politica, a c. di A. Pandolfi, trad. it. di S. Loriga, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 240‐
247. 3
Ivi, p. 241. 2
223
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Temo di sì, ma in una direzione che mi sembra essere quella della crisi irreversibile dei meccanismi della rappresentanza, più che del venir meno delle forme di appartenenza veicolate dai partiti politici. Quanto al versante teatrale della politica, oggi francamente fastidioso, non bisogna dimenticare che esso è anche figlio della retorica: senza la quale, è d’obbligo pensare, il polemos sarebbe solo scontro frontale e sanguinoso. Simone Weil, come Hannah Arendt, è nemica giurata della rappresentanza. Ma Hannah salvava, in realtà, un fondo di teatralità ‘sana’ nei rapporti di interazione che designano l’orizzonte della sfera pubblica. Ciò che oggi ci appare intollerabile non è il respiro teatrale della politica, che io considero insopprimibile, ma il fatto che centri di potere incontrollabili rendano inutili le prestazioni di qualsiasi ‘protagonista’ o ‘attore’, e spesso per ragioni sistemiche irresistibili, non già per la malevolenza di questo o di quel ‘personaggio’. Magari fossimo in grado di resuscitare scenari controversiali non artefatti, non deformati da squilibri nei poteri mediatici e corrispondenti a fronti polemici autentici, come una volta ebbe a dire Habermas. Se la polemica è destinata ad essere squalificata, è per l’impotenza del logos, troppo spesso pateticamente impegnato a ricomporre, per citare ancora una volta Habermas, conoscenza e interesse, e altrettanto spesso condannato a non riuscirci. 4. Un autore che lascerà un’impronta molto forte – e lo possiamo capire già adesso, prima della sua scomparsa – è René Girard, la cui teoria vittimaria è in grado di generare un possibile modello per l’azione etica in quell’arena di lotte per il potere/sapere che è l’ordine culturale e politico. Salvare il capro espiatorio, schierarsi dalla sua parte, spendere una parola in sua difesa può considerarsi la più limpida delle scelte etiche, la pietra su cui costruire o ricostruire? Più che mai, si chiede al vero intellettuale (non organico, ma ‘specifico’, nella dizione foucaultiana), al ‘soggetto a rischio’, di operare delle fratture e di operare delle ricomposizioni che non ci lascino in balia di ciò che è taken‐for‐granted, nelle sue modellazioni più abusate e mediatiche. Parlare per difendere il proprio avversario accerchiato dai ‘nostri’: questo mi pare tutto ciò che ci rimane – ma è tanto, tantissimo – per riscoprirci soggetti soltanto a noi stessi. Ammiro molte cose in Girard, non da ultimo la capacità di gestire un’intera biografia scientifica attorno ad un solo nucleo di pensiero, con un inevitabile strascico di ripetitività e con la tentazione di colonizzare territori allotri. Riutilizzerei il suo approccio in direzione della coppia opposizionale forti/poveri, che è considerata un esempio di infantilismo teorico ma non dispiaceva ad un filosofo come Rousseau. Purtroppo, quella coppia è stata demonizzata da una filosofia marxista della storia anch’essa sagomatasi sul modello della forza (quella del proletariato contro la limitatezza del modo capitalistico di produzione). Quanto al capro espiatorio, il suo destino non può che peggiorare a fronte dell’odierna propensione ad incamerare elementi puritani di colpevolizzazione dei poveri e dei deboli. Probabilmente non riusciamo ancora a misurare la crisi di un modello di altissima qualità teologico‐politica, quello della carità, che questo problema lo aveva affrontato alla radice eliminando le fonti della paura e della minaccia. Anche la carità, sia detto da un non credente, tematizzava l’esigenza di porre 224
Intervista – Bruno Accarino fine alla cattiva infinità della vendetta, ma è stata sopraffatta dalle urgenze identitarie della storia delle istituzioni ecclesiastiche. Intellettuale non organico ma specifico? Non vedo altra griglia di lettura disponibile che quella offerta dal concetto weberiano di ‘competenza’, ma temo che non porterebbe acqua al mulino di Foucault. Rimaniamo nel solco di Weber: più che la possibilità di difendere il proprio avversario, è in gioco la possibilità di intendere che è facile scatenare una guerra, ma è difficile mettere ad essa la parola fine, perché la rinuncia al vae victis richiede lungimiranza politica, non perdono e compassione. Non è la peraltro proverbiale pavidità degli intellettuali ad impedire di cogliere certe costellazioni, ma il modo nevrotico e sconnesso in cui la procede la storia, e che soffoca in partenza la capacità di guardare oltre il proprio naso: l’unica virtù che possa aspirare ad una valenza metastorica e al ruolo di stella fissa in qualsiasi firmamento politico e civile. 5. È da qualche tempo che rifletto su una possibile dicotomia, che mi pare operare, anche se sotto la superficie, all’interno delle culture politiche: quella che divide il gramscismo dal maoismo. Avendo origini interne alla tradizione operaia (anche ci sarebbe da discutere su quanto il rivoluzionario cinese possa esserne considerato parte), mi pare essersi estesa in culture e partiti anche da essa distanti. Mi riferisco a una delle motivazioni per cui il pensiero gramsciano può essere orientato anche nel senso liberale – e del liberalismo più puro: il suo concepire la lotta politica non in chiave costitutivamente polemologica, ma per fini più alti. C’è, in Gramsci, un’idea di questo tipo: se il tuo avversario politico concorda con te, non può che essere un bene e una conquista per l’intero movimento operaio, che vede espandere il proprio consenso. Oltre a ciò, ricordo anche i suoi inviti a tener conto degli elementi positivi – o da piegare in senso progressivo – contenuti nell’ideologia del campo avverso, qualora essa diventi egemonica. Di Mao, invece, ho scovato un motto che rècita così, pressappoco: quando il nemico ti dà ragione, vuol dire che stai sbagliando. A me sembrano davvero due modelli non conciliabili di visione politica del mondo, che mi porterebbero a concludere che una delle influenze totalitarie più decisive è stata quella orientale, nella versione del ‘satrapo’ Stalin o in quella di Mao. Che ne pensa? Il concetto stesso di egemonia è fuori dell’orizzonte di Mao, che pensa in termini di guerra civile e che di sicuro non ha mai incrociato un’esperienza di tipo industrialistico‐torinese quale quella che tenne a battesimo la formazione del giovane Gramsci. Quanto al lascito orientale, si tratta di qualcosa che aspetta ancora un monitoraggio completo, e penso anche a registri filosofici e teologici come quello dell’escatologia. Gramsci elaborò una complessa teoria della rivoluzione passiva, che in sé configurerebbe un’anomalia ossimorica, per render conto del travaso di contenuti e di modi di pensiero tra conservatori e rivoluzionari, ma quella teoria è difficilmente esportabile, stante il suo indebitamento con figure molto italiane come Gaetano Mosca o come lo stesso Gobetti; e stante, soprattutto, la specificità del passaggio storico dal giolittismo al fascismo. Fu la rivoluzione culturale cinese che tentò di arricchire e di rimpolpare un bagaglio politico e teorico indubbiamente povero, scuotendo dal basso certe ossificazioni di potere. Ma l’esito, com’è noto, è poi sfuggito alle mani dei promotori. 225
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Credo però che la dissociazione del liberalismo cosiddetto ‘puro’ da un registro polemologico corrisponda alla sua autointerpretazione, intrisa di un ideologismo irenico che non ha riscontri storico‐empirici. La politica è per sua essenza polemos, guai se non lo fosse, ed il liberalismo non ne è immune. Gramsci, peraltro, pensava in chiave di ‘principe moderno’, dunque a distanza siderale da una mera proposta dialogica, semmai in direzione di una fitta negoziazione con il nemico, che però, come ogni negoziazione (anche al mercato della frutta), implica un’esibizione di muscoli. Solo un guitto, quale è toccato in sorte all’Italia come premier, può immaginare la politica come prosecuzione di conviviali riunioni di un consiglio di amministrazione o di private performances affabulatorie di stampo conversazionale e salottiero. 6. Nel corso del seminario che Lei ha tenuto per la Scuola di Dottorato nella prima metà di quest’anno, sono stato colpito da una sua annotazione, riguardo al diverso modo di concepire il ruolo dell’intellettuale nel contesto europeo e in quello statunitense, ma si potrebbe dire anche anglosassone tout court, almeno a partire dall’esperienza di Margaret Thatcher e, successivamente, di Tony Blair, i quali hanno liquidato l’apporto che tale figura può offrire alla politica o, addirittura, ne hanno evidenziato i pericoli, riassumibili nell’elitarismo che caratterizzerebbe le condotte ispirate alle loro parole. Prescindendo dagli eventi dell’ultimo secolo, le radici di tale atteggiamento possono essere ricercate in una diversa matrice illuministica? Ovvero: di illuminismi ce ne sono stati almeno due e quello inglese e scozzese sembra, fin dal principio, avere radici alternative a quelle francesi e tedesche. Non credo che il problema sia quello di diverse matrici illuministiche, è semmai quello del fiuto politico di chi capisce che una democrazia a forte impronta populistica può raccogliere molti consensi in direzione anti‐elitaria. L’esperienza inglese degli ultimi decenni ha in qualche caso anticipato il delirio di semplificazione (con un ministro all’uopo) oggi diffuso in Italia. Quando ci si affida agli spiriti selvaggi del mercato, o ci si sdraia su alleanze atlantiche con uno stile più realista del re, rimane poca disponibilità ad ascoltare gli intellettuali. È anche vero che, forse, l’intellettuale cortigiano, nel senso del nostro Castiglione, è estraneo alla tradizione britannica. D’altro canto, è proprio l’esperienza insulare ad aver coltivato con la massima cura un cipiglio classista ed elitario che l’esperienza continentale ha tentato di ammorbidire nel crogiuolo delle classi e dei ceti. In definitiva, poi, anche se il disprezzo della Thatcher per gli intellettuali può ferire la nostra suscettibilità, è difficile pensare che esista ancora un potenziale critico immanente ad ogni esperienza conoscitiva in quanto tale, quando i centri di potere della criminalità organizzata possono contare su adepti che hanno alle spalle almeno un master ad Harvard. Sui fin troppo comodi pronunciamenti anti‐elitari occorre poi esser chiari: il veleno filo‐elitario è connaturato alla democrazia, digerire la quale è meno ostico che digerire alcuni processi di massificazione. Il sogno erotico ricorrente di molti è un’autostrada nella quale una Ferrari non sia costretta a convivere, e a condividere la lentezza di marcia nella volgare coda di popolo, con una Seicento, oppure una spiaggia quasi deserta nella quale sbocci 226
Intervista – Bruno Accarino l’innamoramento del protagonista di Morte a Venezia di Thomas Mann, che a Rimini d’estate sarebbe letterariamente improbabile. 7. Alcuni autori (René Girard e i suoi allievi e continuatori, nonché, per esempio, Pascal Bruckner e Alain Finkielkraut) accennano a una possibile vittimocrazia per designare certi sviluppi del politically correct, in un universo culturale in cui mascherarsi da vittima sembra la strategia più efficace, ai fini del riconoscimento sociale. Si pone, però, il problema dello smascheramento delle false vittime e dell’individuazione dei veri perseguitati, spesso in ombra. Lei avverte un pericolo in questa deriva o il politically correct Le sembra una conquista di civiltà, un risultato di lotte per i diritti? Non vorrei soffermarmi sulle questioni di edulcorazione linguistica del disagio, senza volerne sminuire la portata, ma su qualcosa di più profondo: l’odio di sé, che sarebbe l’ultimo conformismo degli intellettuali – europei e non. La vittimocrazia ha il suo luogo filosofico proprio nella raffinata tradizione della teodicea, nella quale si fa acuta e filosoficamente puntigliosa la domanda sull’origine del male. Non metto in dubbio che in certi casi l’intreccio tra vittime e carnefici sia sconcertante, ma credo che la vittimocrazia abbia lo stesso grado di verità della paranoia, quando la parola viene usata con disinvoltura e in totale spregio del suo retroterra clinico e psichiatrico. In America, probabilmente, sono classificati come paranoici anche gli homeless. Detto questo, mi appare irresistibile la tendenza a costruire percorsi elitari che hanno bisogno anche di una verniciatura vittimocratica, mentre esprimono solo un’umanissima domanda di potere e di riconoscimento: ma le donne in carriera, mi si consentirà, evocano il politically correct in un modo diverso da quello degli immigrati di colore. Quanto ai diritti, sono una bomba ad orologeria che smaschererebbe parecchi estremismi fasulli e molta paccottiglia ideologica raccoltasi attorno al ‘politicamente corretto’, accostumato a vedere la pagliuzza ma non la trave: la questione è certamente complessa, perché non è facile distinguere il territorio del privilegio da quello del diritto. Le vittime, in linea di principio, hanno sempre ragione: se tracimano nel territorio del privilegio, è perché esso è sempre confinante con quello del diritto. 8. È possibile interpretare l’odio di sé come una forma estrema e perversa della cura di sé (epimeleia heautou), altro interesse degli ultimi anni di vita di Michel Foucault? Cerco di spiegarmi meglio: come, un tempo, era comodo allinearsi alle posizioni governative e non prestare ascolto a chi rimproverava, magari, i peccati colonialisti degli Stati europei, ora non sarà troppo facile e persino una scelta estetizzante o pubblicitaria ingrossare le fila di chi attacca a testa bassa l’assolutismo e la violenza delle culture occidentali? A connotare come etica una scelta non è la presenza del rischio? Più che di odio di sé, parlerei di disorientamento: un fenomeno di fanatismo cieco come quello dei kamikaze orientali sconcerta oggi come sconcertò durante la guerra mondiale del Pacifico. L’Occidente ha prodotto un certo tipo di Kulturpessismismus che cova sempre sotto la cenere: è vero che la sua matrice non è necessariamente progressista, anzi non lo è quasi mai. In un filo‐orientalismo disinvolto e superficiale, la componente estetizzante è all’ordine del giorno, 227
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 ma non è detto che non possa essere tenuta sotto controllo. C’è qualcosa di estetizzante perfino nei subaltern studies, ma tutt’altra cosa è il monitoraggio serio e documentato delle sofferenze inferte dall’Occidente a popoli colpevoli solo di essere ‘asincronici’ rispetto all’Occidente stesso. Per il resto, il gregarismo si annida ovunque, propiziato dall’impopolarità del rischio. Ma per un filosofo è interessante osservare che oggi la più sicura cittadinanza del rischio non è nell’etica, ma nelle strategie dell’impresa. 9. Lei si sente ancora parte della tradizione marxista, per quanto su posizioni eterodosse – anche se è difficile, ormai, rinvenire un centro di irradiazione di ortodossia – e crede in una funzione civile per il filosofo? Quasi per paradosso, si potrebbe dire che, se la funzione civile sarà simile a quella del secolo dei totalitarismi, ben venga l’irrilevanza. Ma, appunto, è un paradosso: e la mia stessa scelta a favore della filosofia, dati miei studi in scienze della comunicazione, deriva proprio dall’intendere questa disciplina, seguendo l’insegnamento di Foucault, come una sorta di ‘giornalismo radicale’ e di ‘diagnosi del presente’. No, non mi sento più parte della tradizione marxista, anche se di sicuro non mi piace avere nemici a sinistra. Vedo che una certa cornice marxista ha inibito l’ingresso, anche nel patrimonio di pensiero del movimento operaio organizzato, di elementi di democrazia radicale, in Italia soffocati dal duopolio democristiano‐comunista stabilizzatosi, magari per lodevoli ragioni di pedagogia politica, nell’immediato dopoguerra. Mi chiedo oggi perché una cultura azionista non abbia mai attecchito in Italia, e sarebbe facile e deprimente rispondere che, se avesse attecchito, si sarebbe intanto scontrata con il modo inquietante in cui nella penisola è stato allegramente declinato, o semplicemente ignorato, il settimo comandamento. Quanto alla funzione civile dei filosofi, Dio ce ne scampi. La verità è che il sapere filosofico non è immanentemente progressista, anche se quella che Asor Rosa chiamava la fortuna della politica ha fatto il paio, in Italia, con la fortuna della filosofia, dando un’impressione diversa. Ma l’apologia dell’esistente convive, in filosofia, almeno alla pari con la critica dello stesso, quando non la sopravanza. Lei cita molto Foucault ed è ben comprensibile per un giovane, ma io sarei più tignoso e più malizioso e mi chiederei se un paese come la Francia, che di sicuro non ha prodotto solo la Vandea o forme di tradizionalismo cattolico, ma anche punte raffinate del conservatorismo europeo, non abbia la diabolica capacità di trasformare molti dei suoi intellettuali in presunti barricadieri senza alterare gli equilibri di potere, anzi accompagnando la deriva a destra dell’Europa. Lo stesso Foucault, credo, si riconoscerebbe a fatica nell’immagine oleografica che lo vuole simbolicamente a capo di tutte le potenziali sommosse del quartiere latino. 10. Io sono sempre convinto che la storia ci dia quotidianamente l’opportunità di divenire soggetti e di scegliere il coraggio, di rifiutare l’omertà. A parte il caso della più nota Ayaan Hirsi Ali, non trova che ci sia un silenzio immorale sui casi di violazione della libertà di parola più clamorosi, quando professori o vignettisti vengono minacciati di morte dagli islamisti per aver osato esprimere le proprie idee? Mi riferisco ai casi di 228
Intervista – Bruno Accarino Robert Redeker, professore francese di liceo, e del vignettista danese Kurt Westergaard. Se mai l’Europa ha bisogno di un’identità – e ne ha, per chi crede ancora al sogno unitario –, non pensa che possano essere l’attitudine critica e la rivolta antitotalitaria a potergliene fornire una? Non bisognerebbe difendere con più forza queste conquiste, la scandalosa irriverenza che ci fa riottosi, instabili, deboli, ma liberi? La nostra reattività è anestetizzata in questo come in molti altri casi, che forse non bucano il video e rimangono nascosti, condannati alla loro ineloquenza. L’Europa rimane afasica perché, a parte le difficoltà intrinseche di un’impresa titanica come quella di gestire l’obsolescenza degli Stati nazionali (peraltro sopravvalutata), si autoincatena in una linea asfittica e punitiva di controllo ossessivo della virtuosità nei conti pubblici. Lo stato mediamente miserabile dell’istruzione pubblica in molti paesi europei la dice lunga sulla volontà del continente di darsi un’identità culturale condivisa, e abbastanza penosa è stata anche la vicenda della costituzione europea. Per avere le carte in regola sul terreno della tutela e della orgogliosa valorizzazione delle conquiste europee, che sono irrinunciabili, occorrerebbe aver ripulito il rapporto con l’Islam da ogni incrostazione eurocentrica e razzista, ma è sotto gli occhi di tutti che si va in tutt’altra direzione. Oggi un’Europa avveduta metterebbe al centro dell’attenzione non le scaramucce, e nemmeno le guerre sante, con l’Islam, ma le grandi religioni monoteistiche in quanto tali, che forse sono arrivate ad un appuntamento con la storia foriero di molti interrogativi per il loro destino. Allora davvero si imboccherebbe la strada giusta per fare i conti, dopo un lungo cammino, con pratiche mostruose come l’infibulazione. La nemesi consiste in questo: un mondo trainato dalla tecnica e dalla globalizzazione dei mercati non produce un surplus di laicità, ma un inasprimento dei settarismi religiosi, all’interno dei quali trova ospitalità, non bisogna dimenticare, anche il cristianesimo. A cura di Paolo Bonari 229
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 230
Intervista Collettivo Autistici/Inventati Computer Ethics La Computer Ethics è una disciplina ancora piuttosto sconosciuta, benché la sua prima formulazione
risalga agli anni settanta, quando Walter Maner la definì lo studio dei classici dilemmi etici
‘aggravati, trasformati o creati dalla computer technology’. Negli anni il dibattito ha assunto
maggior rilievo a causa della diffusione capillare della tecnologia in questione, differenziandosi in
diversi partiti quali, ad esempio, quello di Donald Gotterbarn (1991), che concentra il suo interesse
sulla figura professionale dell’informatico riducendo, al contempo, la questione dell’ information
technology ad una specifica dell’etica del lavoro; o quello della Gorniak-Kocikowska (1996) che, al
contrario, ha sottolineato la possibilità rivoluzionaria offertaci dalla rete di elaborare collettivamente
un codice comportamentale (improntato alla difesa dei diritti umani).
Autistici/Inventati, è una comunità informatica che, pur fornendo una piattaforma dei ‘consueti’
servizi gratuiti di posta elettronica, website, blog etc., analogamente cioè agli altri gestori o società
privati, costituisce una concreta alternativa ad essi, poiché inserisce tale attività in un contesto etico
e politico volto a promuovere un uso consapevole di quei media. In Italia, Autistici/Inventati non è
un caso isolato, ma per la sua efficacia rappresenta al meglio la reazione della comunità pensante
all’evoluzione dell’esperienza comunicativa. Poiché dunque questo progetto costituisce in sé una
risposta eloquente alle questioni poste dalla Computer Ethics (e non solo), abbiamo chiesto loro
un’opinione su alcuni dei punti topici individuati da questa giovane branca dell’etica applicata.
1. In che misura è possibile garantire la sicurezza delle proprie informazioni sensibili e quindi della propria privacy? Innanzitutto è necessario distinguere il problema reale dalla percezione che comunemente si ha della privacy, sopratutto in ambito digitale. Quotidianamente usiamo determinati servizi ‐ da Facebook a G‐mail ‐ per comodità od abitudine. Quel che spesso perdiamo di vista, proprio per la relativa facilità d’uso di questi servizi, è che non sono esattamente gratuiti: li stiamo ‘barattando’ con i nostri dati. Ciò di cui bisognerebbe essere consapevoli è che i dati inseriti, da quelli anagrafici alle varie preferenze espresse spesso con un semplice click, sono memorizzati in grandi database e messi in correlazione in modo sistematico e massiccio, quello che tecnicamente si chiama profilazione, per ottenere risultanze statistiche significative. L’uso finale di tutti questi dati, acquisiti ed elaborati in modo del tutto legittimo, sfugge all’utente medio che rimane convito della ‘gratuità’ mentre sta pagando un servizio con delle informazioni sensibili che in alcuni casi non svelerebbe nemmeno ad un parente stretto. Quindi la sicurezza delle propria privacy passa per la consapevolezza, sia degli strumenti che si utilizzano sia di quei diritti a cui si rinuncia con un click dato al momento della sottoscrizione di un contratto. 231
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 2. Parliamo di un’impressione che pregna il nostro quotidiano, ovvero che chi gestisce le reti telematiche ne controlla anche i contenuti. È una paura sensata e la censura in Cina rappresenta l’esempio più banale ma la lista è lunga (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship), molto semplicemente la gestione delle infrastrutture su cui passano i dati è un oligopolio, in cui enti nazionali e grandi compagnie agiscono spesso ai margini della legge. La difesa della libertà e della privacy non può essere lasciata solo a figure istituzionali, come il Garante della privacy, ma necessita di un controllo sociale attraverso associazioni come la EFF (http:// www.eff.org) od il progetto Winston Smith (http://www.winstonsmith.info/) e di realtà come la nostra, che fuori dalle dinamiche commerciali forniscano servizi orientati al rispetto dei dati dell’utente più che alla commercializzazione. Per esempio con Noblogs, un servizio di blog anonimo dal lato server (noblogs, il blog senza log…) che consente di tenere il proprio diario on line senza lasciare tracce telematiche pensiamo di fare un gesto concreto nella degli difesa di spazi di libertà. A livello personale ed individuale la difesa della propria privacy, oltre all’uso consapevole degli strumenti, necessità di sistemi di crittografia ed altri e simili accorgimenti, che sembrano più complicati di quanto non siano, ma sono i soli che possono realisticamente tutelare i propri dati da occhi indiscreti. 3. Quali devono essere dunque i diritti fondamentali nell' Information Society? Sicuramente i diritti d’accesso alle informazioni e alle risorse; tuttavia questo discorso deve essere legato al diritto in generale, ovvero incluso in un ‘pacchetto di diritti’. In sostanza, è fuorviante parlare di diritti fondamentali dell’ information society, bisogna parlare di diritti fondamentali tout court. 4. Come selezionare i contenuti in una rete dominata da servizi commerciali o di entertainment? Teoricamente il web garantisce la stessa visibilità a tutti i contenuti, tuttavia già l’azione di ‘filtro’ effettuata dall’uso di un motore di ricerca mette in discussione questo principio. In generale per poter selezionare è prima necessario che venga coltivata e mantenuta la libertà di pubblicazione e quindi la diversità. Noi ci proviamo con il progetto Autistici/Inventati, che ha come obiettivo dichiarato ‘quello di garantire spazi liberi sulla rete, dove appunto discutere e lavorare su due piani: da un lato, il diritto/bisogno alla libera comunicazione, alla privacy, all'anonimato e all'accesso alle risorse telematiche, dall'altro i progetti legati alla realtà sociale’. Stiamo cercando ora di creare uno strumento che quotidianamente possa evidenziare le tematiche comuni trattate dalla comunità dei bloggers, che ospitiamo con il progetto Noblogs, fornendo una possibilità in più per orientarsi tra gli argomenti e le discussioni in corso al suo 232
Intervista – Collettivo Autistici/Inventati interno ed offrendo appunto una selezione per chi nella comunità legge, oltre che il servizio per chi nella comunità scrive. 5. Come giostrarsi tra innovazione tecnologica e affidabilità dei computer? È sempre una questione di percezione; il computer non è un mezzo che dia alcuna sicurezza in termini di conservazione dei dati come anche di riservatezza dei propri dati sensibili. L’innovazione va accolta con consapevolezza e non con spensierata incoscienza. 6. Etica hacker e reati informatici. Le due cose non sono connesse, nella pratica: esiste solo in un luogo comune, usato soprattutto dai mass media. Il nostro è un collettivo di hacker, ovvero un gruppo di persone impegnate nell'affrontare sfide intellettuali in modo creativo, non solo nel nostro abito d'interesse, che ovviamente è l'informatica, ma in tutti gli aspetti della nostra vita. Proprio da una simile esperienza, che significa condivisione delle risorse, della conoscenza, e non è sinonimo di crimine, nasce l’esigenza di proporre una serie di servizi come i nostri. Alla base dell’etica hacker così come è comunemente pensata nel mondo c’è la condivisione. Nella nostra pratica, essa viene associata ad una precisa visione, che abbiamo sintetizzato nel nostro manifesto ‘politico’, in cui citiamo così Primo Moroni: ‘socializzare saperi, senza fondare poteri’. Non a caso pensiamo di avere ‘compagni di strada’ piuttosto che degli ‘utenti’. 7. Privacy e anonimato Privacy ed anonimato sono per noi due facce della stessa medaglia. Difendere la prima a discapito della seconda è una battaglia di retroguardia, perchè prevede che il diritto alla privacy sia normato a tutte le latitudini (e come abbiamo detto ciò spesso non accade). La posizione di mera difesa della privacy è una questione da ‘paese ricco’, dove questi diritti sono sanciti e dove si crede che siano anche sempre rispettati ‐ salvo poi scoprire che in ‘caso di strutture che già sorvegliano tutto e tutti emergenza’ ci sono (http://it.wikipedia.org/wiki/Information_Awareness_Office). 8. Per quanto riguarda l’Italia, invece? In Italia la legislatura per molti aspetti è seria, ma spesso inapplicata. Prendiamo la videosorveglianza, una pratica normata dal Garante fin dal 2004: per legge essa deve essere consentita ed applicata secondo ‘il principio di necessità’; in pratica, invece, si è diffusa in tutti gli ambiti urbani (dalle case private ai negozi, dalle scale condominiali alle piazze) ed in modo illegittimo, dato che quasi mai viene segnalata la presenza della videocamera e quasi sempre vengono omesse le dettagliate informazioni richieste dalla legge (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1002987). 233
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 Analogamente, nel campo informatico, nonostante i dati dei provider debbano essere distrutti dopo quattro anni, è stato conclamato nel recente caso Telecom (http://it.wikipedia.org/wiki/Scandalo_Telecom‐Sismi) come ciò non accada. Quindi la questione di impedire l’anonimato perché può offrire una qualche impunità a dei malfattori e, in cambio, difendere la privacy è sostanzialmente poco realistica. La battaglia, in questo caso, deve essere radicale per ottenere, probabilmente, il minimo. 9. Mentre nei Paesi dove non c’è Stato di diritto? Anche e soprattutto in quei Paesi è necessario poter garantire l’anonimato. A tal proposito i ‘giornalisti senza frontiere’ hanno scritto un manuale (http://www.rsf.org/IMG/pdf/guide_gb_md.pdf) che insegna a tenere un blog da posti, come la Cina, dove c’è un controllo capillare dei mezzi di comunicazione da parte di un apparato repressivo governativo. In questo caso, tu devi poterti tutelare rendendoti anonimo: il ‘rischio reato’ va considerato anche in rapporto ai mezzi tecnologici di cui uno Stato dispone per perseguirti (dal tracciamento del cellulare, tramite triangolazione del segnale, ai satelliti). 10. Quest’anno il BIG BROTHER AWARD Italia, premiazione ‘in negativo’ che assegna premi a chi in tutto il mondo ha più danneggiato la privacy, vi ha elargito il ‘premio in positivo’ Winston Smith ‐ eroe della Privacy. Abbiamo vinto solo perchè abbiamo degli strumenti che sensibilizzano e tutelano le persone a cui offriamo i servizi, pur agendo all’interno della legislazione vigente. La domanda è: perchè non lo fanno tutti? Perché non è politicamente e commercialmente utile, evidentemente. A maggior ragione la questione anonimato‐privacy risulta una questione etica, da dibattere nell’ambito del diritto umano. 11. Approfondiamo la differenza tra ‘sensibilizzazione’ e ‘tutela’. Ciò che cerchiamo di fare è sensibilizzare la nostra collettività rispetto al fatto che la tutela del dato non deve essere delegata a noi (o ad altri) in modo incondizionato. Le vicende legate alla violazione di un nostro server ospitato presso il provider Aruba (http://www.autistici.org/ai/crackdown/) ha svelato infatti che il rapporto di fiducia dei nostri utenti superava l’effettiva protezione che possiamo offrire. Ciò che incentiviamo col nostro lavoro è quindi un uso consapevole degli strumenti: facciamo sempre l’esempio che se non vuoi che il messaggio destinato ad un tuo amico venga letto anche dal postino, non devi mandargli una cartolina, ma una lettera (e se non vuoi che la lettera possa essere intercettata e letta a tua insaputa, devi metterci un sigillo di ceralacca, e così via). Una e‐mail, per come la usiamo comunemente, è identica ad una cartolina. È necessario quindi non solo la scelta di un servizio di posta, web, blog od altro che sia sensibile alla tua privacy, quanto l’uso consapevole degli strumenti. C’è un limite a quanto l’utente può essere tutelato da noi ed i nostri seminari puntano a far capire che sta al singolo curarsi della reale segretezza dei propri dati sensibili ed i 234
Intervista – Collettivo Autistici/Inventati mezzi sono di facile accesso ed uso, ad esempio per le e‐mail la crittografia a chiave pubblica (http://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy). 12. Proprietà intellettuale…Richard Stallman, fondatore del Free Software Foundation, pensa che non debba essere permesso il copyright sull’innovazione o creazione di software; gli rispondono che i privati non investirebbero più in ricerca. Adesso però è in questione il copyright degli algoritmi (ad esempio l’mp3), che dovrebbero essere pubblici; si tratta di impedire di usarne anche solo una parte, cioè della matematica! A/I ha nel suo manifesto (http://www.autistici.org/it/who/manifesto.html) lo sposalizio con l’open source, il copyleft (storicamente introdotto dal progetto GNU e dalla licenza GPL ‐ GNU Public License), le licenze ‘creative commons’. Il comune retroterra di tutti i soggetti confluiti in questo progetto ‐ un contesto ben più ampio dei suoi effettivi gestori ‐, è la già menzionata sensibilità hacker, che reclama per tutti proprio il diritto alla conoscenza e vuole la diffusione dei saperi. La nostra politica è quindi di non ospitare contenuti coperti da copyright. Quella degli algoritmi è invece una questione scottante e riguarda la privatizzazione dello sviluppo stesso: si tratta di negare la libertà alla ricerca, il che porta spesso al paradosso ‐ basti vedere le battaglie per difendere il diritto d’autore su film e musica, una battaglia ostinata in cui il diritto si svela completamente slegato dalla realtà, dalla prassi comune. 13. Globalizzazione: Krystyna Gorniak‐Kocikowska nel suo paper The Computer Revolution and the Problem of Global Ethics (1996) dice che la Computer Ethics sta diventando una ‘Global Information Ethics’ in virtù della forza della storia. Non è banale comprendere che la rete non arriva davvero dappertutto e per questioni tecniche che possono sembrarci distanti, come la mancanza di elettricità. Noi siamo immersi nella rete ma, astraendosi da questo livello di pervasività, si nota che in ampie parti del cosiddetto ‘terzo mondo’ non c’è. In Africa oggi questo viene superato in parte con collegamenti satellitari, in parte con ponti radio (dove non ci sono monti!). Siamo troppo anglo‐centrici, di che etica e di quale rivoluzione nel mondo stiamo parlando? 14. Infine l’educazione globale ed il divario ricchi‐poveri. Una società più informatizzata è capace di dare a chi prima ne era tagliato fuori preziose notizie e conoscenze. Che effetto devastante avrà questo ‐ si domandano i moralisti americani ‐ sugli stati dittatoriali, sulle comunità isolate, sulle pratiche religiose? Se le università ricche offriranno lauree on line, non ne soffriranno le università minori? Se digitalizziamo l’educazione, gli affari e la sanità, non estrometteremo di fatto chi alle risorse di rete non riesce ancora ad accedere? In America, almeno a livello teorico, non sembra esistere scollamento tra un diritto sancito (es. diritto all’informazione) e la realtà. In Europa la cosa è diversa e questo rende una pseudo‐
questione questa del divario. Sono piani diversi. Per noi l’etica non è sancita attraverso la legislazione, ma da una scelta spesso vissuta come fenomeno privato, quasi individuale. Dal 235
Humana.Mente – Issue 7 – October 2008 punto di vista potenziale l’impatto della globalizzazione delle conoscenze è enorme e positivo, però non vedo aprirsi questioni quali l’aumento del gap tra ricchi e poveri o la possibilità di far un torto culturale a qualcuno. Questo atteggiamento deriva probabilmente dalla loro sensibilità alla questione del colonialismo culturale. Laura Beritelli 236
Humana.Mente — Issue 7 — October 2008 www.humana‐mente.it MAGAZINE OF PHILOSOPHICAL STUDIES ‐ ISSN: 1972‐1293