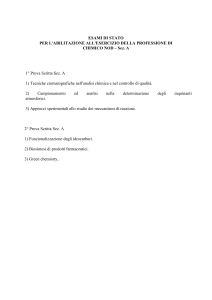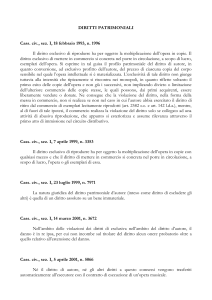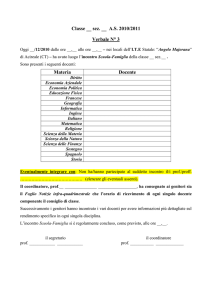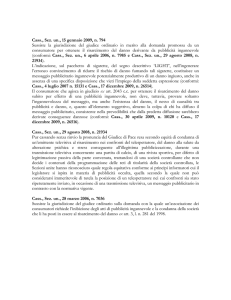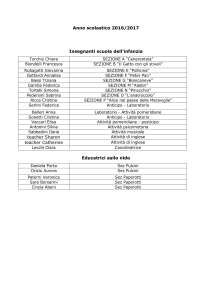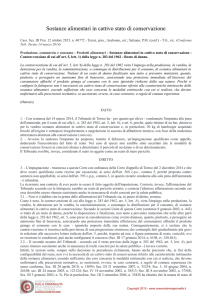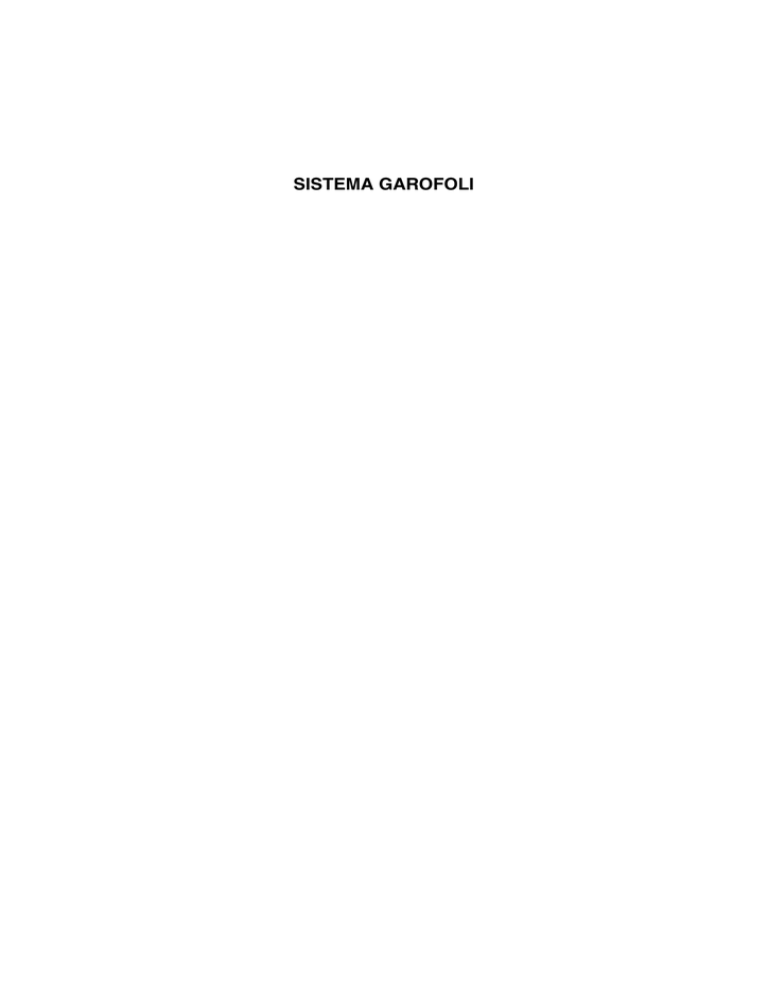
SISTEMA GAROFOLI
La collana “SISTEMA GAROFOLI” comprende:
DIRITTO CIVILE
Volume I – Teorico
Volume II – Pratico
Volume III – Giurisprudenziale
DIRITTO PENALE
Volume I – Teorico
Volume II – Pratico
Volume III – Giurisprudenziale
con elaborazione e coordinamento
a cura di
Floriana LISENA
Viviana RASCIO
DIRITTO PENALE
GIURISPRUDENZIALE
con coordinamento del volume a cura di
Floriana LISENA
CONCEPT E GRAPHIC DESIGN
Pantaleo MEZZINA
Aranea Internet Marketing s.r.l. - Molfetta (Ba)
www.araneamarketing.it
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MAGGIO 2015 DA:
Arti Grafiche Editoriali Srl
Via della Stazione, 41
61029 URBINO (PU)
Italy
© NELDIRITTO EDITORE srl, Piazza Galeria, 17 - Roma
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono
riservati per tutti i paesi.
ISBN 978-88-6657-499-6
I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono visitare il sito web www.neldirittoeditore.it o scrivere a [email protected]
PREMESSA
La collana “SISTEMA GAROFOLI” intende fornire una trattazione completa, schematica e approfondita su
tutti gli istituti e le questioni problematiche del diritto civile e del diritto penale, finalizzata alla preparazione
all’esame per la professione forense.
A tal fine, per i settori del diritto civile e del diritto penale sono stati predisposti tre volumi:
•
•
•
Vol. I – Teorico: contiene l’illustrazione degli istituti articolata in due sezioni: Disciplina normativa e
Questioni giurisprudenziali, collegate a possibili tracce di pareri e di atti;
Vol. II – Pratico: contiene lo svolgimento di 50 pareri e di 30 atti, con svolgimento “guidato” per
agevolare l’apprendimento del metodo di redazione delle prove da parte dei candidati;
Vol. III – Giurisprudenziale: contiene l’illustrazione di 50 schede di giurisprudenza, con
segnalazione dei diversi orientamenti interpretativi e delle relative argomentazioni sviluppate a
sostegno.
In tal modo si è inteso offrire un panorama completo della materia che, partendo dalle nozioni teoriche
fondamentali, affronta i casi pratici alla luce dei più rilevanti e recenti indirizzi giurisprudenziali.
In questo volume “Diritto penale – Giurisprudenziale”, sono contenute 50 schede di giurisprudenza,
nelle quali vengono affrontate le questioni problematiche all’attenzione del dibattito giurisprudenziale degli
ultimi anni. In ogni scheda, vengono segnalati:
– la questione;
– i diversi orientamenti interpretativi emersi;
– le argomentazioni sviluppate a sostegno di ogni orientamento.
La scheda si conclude con una breve indicazione della soluzione della traccia alla luce dei principi
giurisprudenziali esposti e con l’estratto delle motivazioni della sentenza di riferimento.
Maggio 2015
L’Autore
V
SOMMARIO
Schede di giurisprudenza
PARTE GENERALE
1.
I criteri discretivi tra abolitio criminis e abrogatio sine abolizione (Cass. pen., Sez. Un.,
16 giugno 2003, n. 25887)
2
Requisiti essenziali della delega (Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 29415; Cass. pen.,
Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420)
10
Delega e posizioni di garanzia (Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084; Cass. pen.,
Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4123)
16
4.
Causalità omissiva (Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328)
26
5.
Offensività e reati di falso (Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2012, n. 25409; Cass. pen., Sez.
Un., 27 novembre 2008, n. 6591)
39
Diffamazione e diritto alla libera espressione del pensiero (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio
2014, n. 10337; Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2012, n. 69021)
48
Scriminanti e attività medica (Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2009, n. 2437; Cass. pen.,
Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132)
57
Vizio di mente e disturbi della personalità (Cass. pen., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n.
9163)
70
Dolo eventuale e colpa cosciente (Cass. pen., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 20465; Cass. pen.,
Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588; Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411)
83
10.
La colpa professionale (Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237)
99
11.
L’elemento psicologico nella preterintenzione (Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2006, n.
13673; Cass. pen., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 27161)
106
La responsabilità dello spacciatore per morte dell’assuntore (Cass. pen., Sez. Un., 22
maggio 2009, n. 22676)
115
L’errore sulla legge extrapenale: la distinzione fra errore sul fatto ed errore sul
precetto (Cass. pen., Sez. VI, 3 settembre 2012, n. 33590)
127
La distinzione fra circostanze ed elementi costitutivi del reato (Cass. pen., Sez. II, 15
ottobre 2013, n. 44446; Cass. pen., Sez. Un., 15 ottobre 2013, n. 44446)
134
2.
3.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
VI
15.
Tentativo ed elemento soggettivo (Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2005, n. 543; Cass.
pen., Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 37516)
147
16.
L’applicazione del principio di specialità (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537)
154
17.
La natura del reato continuato (Cass. pen., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 3286)
166
18.
L’obbligo di impedire il reato altrui: il concorso mediante omissione (Cass. pen., Sez. I,
23 settembre 2013, n. 43273)
174
I presupposti soggettivi del concorso anomalo (Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014, n.
9770; Cass. pen., Sez. V, 6 agosto 2013, n. 34036)
183
19.
PARTE SPECIALE
20.
Rapporti fra gli artt. 270 e 270 bis c.p. - Aggravante della finalità di terrorismo (Cass.
pen., Sez. V, 2 aprile 2012, n. 12252)
192
L’“oggettivizzazione” del dolo specifico nell’associazione con finalità terroristiche
(Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34989)
202
Corruzione in atti giudiziari susseguente (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n.
15208)
208
23.
La finalità dell’apposizione di sigilli (Cass. pen., Sez. Un., 10 febbraio 2010, n. 5385)
219
24.
Esercizio abusivo della professione di esperto contabile (Cass. pen., Sez. Un., 23 marzo
2012, n. 11545)
225
25.
Favoreggiamento e diritto di difesa (Cass. pen., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327)
235
26.
Reato associativo e reati fine: configurabilità del vincolo della continuazione (Cass.
pen., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 39726; Cass. pen., Sez. I, 22 giugno 2007, n. 24750)
241
L’associazione per delinquere e la circostanza aggravante della transnazionalità (Cass.
pen., Sez. Un., 23 aprile 2013, n. 18374)
247
Concorso esterno in associazione mafiosa e sua evoluzione giurisprudenziale (Cass.
pen., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727)
259
Maltrattamenti in famiglia e rilevanza della diversità culturale (Cass. pen., Sez. VI., 16
dicembre 2008, n. 46300)
277
La scelta fra pena detentiva e pena pecuniaria per il reato di diffamazione (Cass. pen.,
Sez. V, 13 marzo 2014, n. 12203)
282
Induzione alla prostituzione minorile: la condotta penalmente rilevante (Cass. pen.,
Sez. Un., 14 aprile 2014, n. 16207)
288
21.
22.
27.
28.
29.
30.
31.
VII
32.
Pornografia minorile e tentativo (Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2013, n. 41776)
298
33.
Violenza sessuale e sequestro di persona (Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2013, n. 22940)
304
34.
Violenza sessuale di gruppo e concorso nel reato di cui all’art. 609-bis c.p. (Cass. pen.,
Sez. III, 8 maggio 2014, n. 18901)
309
Il problema della configurabilità della violenza privata in relazione al picchettaggio
ostruzionistico e all’ostruzionismo stradale (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 603)
315
Accesso abusivo ad un sistema informatico da parte del soggetto autorizzato (Cass.
pen., Sez. Un., 7 febbraio 2012, n. 4694)
322
37.
Tentativo di rapina impropria (Cass. pen., Sez. Un., 12 settembre 2012, n. 34952)
334
38.
Rapporti fra truffa e frode fiscale (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2011, n. 1235)
345
39.
Rapporti fra il reato di truffa e il reato di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p. (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537,
Cass. pen., Sez. Un., 27 aprile 2007, n. 16568 )
358
40.
Omesso versamento delle trattenute (Cass. pen., Sez. Un., 20 ottobre 2011, n. 37954)
371
41.
Ricettazione e dolo eventuale (Cass. pen., Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 12433)
381
42.
Concorso fra reato associativo e delitti di riciclaggio o illecito reimpiego per i beni
ricavati dallo stesso reato associativo (Cass. pen., Sez. Un., 13 giugno 2014, n. 25191)
390
Il problema della rilevanza delle molestie arrecate con mezzi diversi dal telefono (Cass.
pen., Sez. I, 7 giugno 2012, n. 24670)
401
Inquinamento elettromagnetico e configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p. (Cass.
pen., Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 23262)
408
45.
Rapporti tra il reato di cui all’art. 707 c.p. e furto (Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2010, n. 19047)
418
46.
Uso di gruppo di sostanze stupefacenti (Cass. pen., Sez. Un., 5 aprile 2013, n. 25401)
422
47.
L’ipotesi del fatto di lieve entità (Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 14288)
436
48.
La circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti (Cass. pen.,
Sez. Un., 20 settembre 2012, n. 36258)
444
49.
Pubblicizzazione di semi di piante stupefacenti (Cass. pen., Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 47604)
454
50.
Il problema dell’applicabilità del reato di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. 286/98 allo straniero
irregolare e i rapporti con il giudicato penale (Cass. pen., Sez. Un., 27 aprile 2011, n.
16453)
462
35.
36.
43.
44.
VIII
SCHEDE
DI
GIURISPRUDENZA
Parte generale PARTE GENERALE
Scheda di giurisprudenza n. 1
I criteri discretivi tra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione
TRACCIA
Nel gennaio del 2004, Tizio, docente universitario, nel corso di un colloquio con la studentessa Mevia, le
prospettava la possibilità di superare agevolmente l’esame che avrebbe dovuto sostenere a breve qualora
avesse accettato di avere un rapporto sessuale con il professore. Accettata la proposta di Tizio e fornita la
prestazione, Mevia superava l’esame universitario.
Caio, assistente del professor Tizio, avendo ascoltato il colloquio intercorso tra quest’ultimo e l’allieva, si
asteneva per lungo tempo dal denunciare il fatto per evitare di subire ripercussioni sulla propria carriera; la
denuncia di quanto appreso giungeva infatti solo dopo il pensionamento del professore. A seguito di richiesta
a rinvio a giudizio formulata dal Pm nel febbraio 2012, Tizio veniva tratto a giudizio per il reato di cui all’art.
317 c.p. e per il medesimo condannato nell’ottobre 2012 alla pena di quattro anni di reclusione.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 190
del 6 novembre 2012, dopo aver esaminato le questioni sottese alla traccia ed in particolare la problematica
della disciplina della successioni delle leggi penali nel tempo, rediga motivato parere in ordine alla possibilità
di proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
1. La questione.
La necessità dell’individuazione di un criterio che distingua l’ipotesi di abolitio criminis da
quella dell’abrogatio sine abolitione nasce dalle diverse conseguenze che la disciplina
dettata dall’art. 2 c.p. prevede per l’una e per l’altra fattispecie: quel che infatti è necessario
comprendere, all’indomani dell’introduzione di una nuova norma che disciplini un fatto già
considerato reato da una norma precedente, è se si tratti di abolitio criminis o di abrogatio sine
abolitione, poiché mentre nel primo caso la nuova norma potrà estendere i suoi effetti favorevoli
anche a fatti ad essa precedenti, potendo travolgere anche un eventuale giudicato già formatosi,
non così nella seconda ipotesi.
Entrambi i casi rientrano nell’ambito della tematica della successione delle leggi penali nel
tempo, che contempla, appunto, le ipotesi in cui una nuova norma intervenga a regolare un fatto
delittuoso commesso sotto la vigenza di una legge ad essa precedente; tale fenomeno è sorretto,
per un verso, dal principio di irretroattività, di cui sono espressione l’art. 25, co. 2, Cost.
(“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso”) e l’art. 2 c.p. e, per altro verso, dal principio di retroattività della legge favorevole
(espressione del favor libertatis), esplicitato invece solo dall’art. 2 c.p.
Tale norma detta la disciplina precipua della successione delle leggi penali nel tempo, prendendo
in considerazione le ipotesi che in concreto possono verificarsi e regolando ognuna in maniera
autonoma. In particolare, l’art. 2 c.p.
2
Scheda di giurisprudenza n. 1 •
•
•
•
•
afferma, in generale, il principio di irretroattività della nuova incriminazione (co. 1);
regola l’ipotesi dell’abolizione di un’incriminazione, sia totale che parziale (abolitio
criminis), in ragione della quale opera il principio di retroattività della legge
favorevole, pervasivo al punto da poter travolgere un eventuale giudicato di
condanna (co. 2);
precisa che, qualora ci sia stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore
preveda esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva si converte
automaticamente in pena pecuniaria, in applicazione dell’art. 135 c.p. (co. 3);
prevede l’ipotesi di successione di leggi solo modificative (abrogatio sine abolitione),
in ragione della quale trova applicazione il principio di irretroattività della legge
sfavorevole e di retroattività della legge favorevole, fatto salvo il caso in cui si sia
già formato un giudicato di condanna (co. 4);
prevede alcune deroghe in relazione a leggi temporanee ed eccezionali (co. 5).
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, occorre dare atto dei tre teorie elaborate in dottrina e in giurisprudenza per
distinguere l’ipotesi di abolitio criminis (art. 2, co. 2, c.p.) da quella di abrogatio sine
abolitione (art. 2, co. 4, c.p.) e dunque comprendere quando una nuova norma sia effettivamente
abolitiva di una precedente incriminazione e quando invece sia solo modificativa della stessa. Tale
esigenza nasce nei casi in cui la norma successiva non sia chiara
2.1. Il primo orientamento: Il criterio del fatto concreto o della doppia
punibilità in concreto.
Un primo orientamento preme, al fine di distinguere fra abolitio criminis e abrogatio sine abolitione,
sull’esatta perimetrazione del fatto delittuoso in concreto commesso, lasciando in disparte il
raffronto fra le norme di legge cui in astratto è riferito.
Argomento: Valutazione del fatto concreto. Per accertare se il rapporto fra legge
anteriore e legge posteriore sia da inquadrare nell’ambito del secondo o del quarto comma dell’art.
2 c.p., una parte della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio 2005, n. 6775) ritiene
opportuno verificare se il fatto in concreto commesso, punito dalla legge anteriore, sia punito
anche da quella posteriore, a prescindere da una valutazione in astratto delle due norme,
che ben potrebbero prestare anche elementi del tutto eterogeni fra di loro (prima punibile, dopo
punibile, quindi punibile).
Tale tesi, tuttavia, ha prestato il fianco a tre tipi di obiezioni:
• in primo luogo, è possibile che un fatto delittuoso rientri in concreto seppur per
aspetti diversi in entrambe le norme incriminatrici: ciò comporterebbe la possibile
violazione del principio di irretroattività, finendo per ipotesi con l’attribuire
rilevanza penale ad elementi che in precedenza ne erano invece privi;
• ancora, far dipendere far dipendere l’accertamento del rapporto in esame dal
criterio del fatto concreto vorrebbe dire esporre la soluzione del problema a criteri
del tutto causali, non predeterminati dal legislatore, lasciando così il confine fra
3
Parte generale •
il lecito e l’illecito a valutazioni compiute ex post dal giudice;
infine, nel momento in cui il legislatore sceglie fra abolitio e mutatio criminis,
quel che preme in favore dell’una o dell’altra non sono i fatti concreti che danno
luogo a punibilità, ma valutazioni su condotte generali ed astratte prese in
considerazione poiché contrastanti con i valori tutelati dall’ordinamento.
2.2. Il secondo orientamento: La continuità normativa.
Un secondo orientamento (Cass. pen., Sez. I, 7 dicembre 2005, n. 44702) ritiene invece
necessario risolvere la questione alla luce di un criterio valutativo, affermando o negando la
continuità fra le norme sulla scorta di un’attenta valutazione sia dell’interesse protetto che della
modalità di aggressione.
Argomento: Valutazione della continuità del tipo di illecito. In ragione dell’applicazione
di tale criterio, l’abolitio criminis sarebbe da escludere ogni qualvolta la norma posteriore
regoli una fattispecie delittuosa in termini sostanzialmente omogenei sotto il profilo del
bene giuridico e della tipologia di offesa; in tal caso, sarebbe unica la ratio incriminatrice dei due
illeciti, differenziandosi le due norme solo in relazione alla tecnica di repressione del reato.
Anche tale orientamento non è però risultato esente da critiche:
• per un verso, la perfetta identità sia del bene giuridico che della tipologia di offesa
sarebbe rinvenibile solo in presenza di fattispecie di reato anch’esse perfettamente
identiche: verrebbe meno in tal modo l’utilità del criterio;
• per altro verso, anche tale criterio lascerebbe eccessivo spazio alla
discrezionalità del giudice, che si troverebbe a dover risolvere la questione in
base a valutazione meramente sostanzialiste.
2.3. Il terzo orientamento: Il rapporto strutturale.
Un’ultima tesi, oggi maggioritaria, ritiene infine di poter giungere alla soluzione del problema
applicando un criterio di tipo strutturale.
Argomento: Necessarietà di un approccio formalistico. Entrambi i criteri menzionati
peccano di un eccessivo sostanzialismo che mal si concilia con le esigenze di garanzia insite nel
diritto penale. In virtù di ciò, tale orientamento preme sulla necessità che il problema sia risolto alla
luce di un approccio del tutto formale. In tal senso, è necessario analizzare il rapporto
strutturale fra le fattispecie interessate al fine di verificare l’esistenza o meno di una continuità
normativa fra le stesse.
Il criterio alla luce del quale comprendere se si sia in presenza di abolitio criminis o di
abrogatio sine abolitione sarebbe un criterio cd. di specialità o di continenza, per il quale c’è
continuità normativa (e dunque una successione solo modificatrice) fra due norme qualora fra
le stesse sussista un rapporto di specialità in senso logico-formale e, dunque, una norma
contenga tutti gli elementi dell’altra ed uno o più elementi specializzanti (una delle due norme
contiene un elemento specializzante rispetto ad un elemento dell’altra) o in aggiunta (una delle
due norme può esser definita come generale rispetto ad un’altra che, pur avendo la medesima
struttura, contiene uno o più elementi in aggiunta).
4
Scheda di giurisprudenza n. 1 In particolare, solo in presenza di un rapporto di specialità di tal fatta potrebbe
applicarsi l’art. 2, co. 4, c.p., e non anche, naturalmente, nella contrapposta ipotesi di
incompatibilità eterogeneità delle norme in successione, in cui dovrebbe essere invece affermata
una vera e propria abolitio criminis.
Alla verifica della sussistenza di un rapporto di specialità (e dunque una verifica in
astratto), deve poi necessariamente accompagnarsi anche una verifica di tipo concreto, volta ad
accertare che il fatto delittuoso posto in essere dal soggetto agente sia effettivamente
compreso in entrambe le norme in successione: qualora l’analisi superasse anche questa
seconda verifica, non vi sarebbe più alcun dubbio circa l’identità del nucleo di disvalore penale del
fatto in entrambe le disposizioni in successione, cosa che fonda pienamente l’applicabilità dell’art.
2, co. 4, c.p.
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Accoglimento del
criterio fondato sul rapporto strutturale fra le norme in successione.
Il criterio che fonda la distinzione sul rapporto strutturale fra le norme, da valutare in astratto, è
oggi quello maggiormente utilizzato della giurisprudenza (Cass. pen., Sez. II, 2 dicembre
2014, n. 5723; Cass. pen., Sez. IV, 24 ottobre 2014, n. 50047; Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 2013,
n. 11792; Cass. pen., Sez. IV,12 marzo 2013, n. 11794; Cass. pen., Sez. I, 15 febbraio 2013, n.
7495; Cass. pen., Sez. Un., 12 giugno 2009, n. 24468; Cass. pen., Sez. I, 18 gennaio 2006, n.
3999); in particolare, la Corte di Cassazione, in una sentenza resa a sezioni unite (Cass. pen., Sez.
Un., 16 giungo 2003, n. 25887), oltre a confermare la validità del criterio fondato sul rapporto
strutturale, ha altresì criticato la distinzione fra specialità per aggiunta e specialità per
specificazione.
Per quel che concerne tale distinzione, a ben vedere, asserisce la Corte, sia nell’uno che
nell’altro caso, infatti, è presente quella situazione di doppia punibilità in astratto espressione
di continuità normativa; in secondo luogo, a voler valutare il singolo elemento di una fattispecie si
correrebbe il rischio di ricadere in quell’incertezza normativa, naturalmente connessa a valutazioni
di tipo sostanziali, che ha giustificato l’abbandono dei criteri del fatto concreto e della continuità
normativa.
Per quel che riguarda l’applicazione del criterio della continenza, la Corte ha infatti affermato che
“in tema di successione di leggi penali, perché sia applicabile la regola del terzo (ora quarto)
comma dell’art. 2 c.p., occorre che il fatto costituente reato secondo la legge precedente sia tuttora
punibile secondo la uova legge, mentre non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e
rimasti fuori dal perimetro della nuova fattispecie. Tale situazione va verificata in base al criterio
della coincidenza strutturale fra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza
che sia necessario, di regole, fare ricorso ai criteri valutativi del bene tutelato o delle modalità di
offesa. L’art. 2 c.p., infatti, pone, nei commi che lo costituiscono una sequenza di regole fra loro
collegate in modo che s chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo (oggi quarto)
comma deve essere esclusa l’applicabilità del primo e del secondo comma. Ne consegue che un
fatto è punibile se, astrattamente considerato e sulla base dei criteri enunciati, rientra nell’ambito
normativo di disposizioni che si sono succedute nel tempo e, quando ciò accade e nei limiti in cui
accade, non opera l’effetto abolitivo della disposizione successiva”.
5
Parte generale Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene di dover sconsigliare a Tizio la proposizione di un appello avverso la sentenza di
primo grado di condanna, nei confronti, per il reato di cui all’art. 317 c.p., e dunque per concussione. Invero,
come ha avuto modo di affermare di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre
2013, n. 12228), facendo applicazione del criterio fondato sul rapporto strutturale, sussiste continuità
normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317
c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale. Per la Suprema Corte, dunque,
la suddivisione operata dal legislatore della novella del reato di cui al previgente art. 317 c.p. nelle due figure
di concussione per costrizione, di cui all’attuale art. 317 c.p., e di induzione a dare o promettere utilità, di cui
all’art. 319 quater c.p., non ha comportato alcuna depenalizzazione, ma solo una vicenda modificativa delle
fattispecie sotto il profilo della pena, più grave nella disciplina attuale.
Un eventuale giudizio di appello non potrebbe dunque che confermare quanto deciso dal giudice di primo
grado.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 16 giugno 2003, n. 25887
Estratto
[...Omissis...]
I diversi criteri adottati hanno giustificato, anche sulla base delle scelte operate di volta in volta dall’interprete,
soluzioni contrapposte e originato nei tempi più recenti contrasti giurisprudenziali, che hanno dato causa a
numerosi interventi delle Sezioni unite.
Secondo una teoria tradizionale per stabilire se c’è o meno continuità normativa occorre verificare se esiste
la doppia punibilità in concreto e dunque se il fatto punito dalla legge anteriore è punito anche da quella
posteriore (“prima punibile, dopo punibile, quindi punibile”). Si è però giustamente obiettato che è possibile
che un fatto concreto rientri per aspetti diversi nella previsione di due norme incriminatici che si succedono,
in una situazione cioè in cui in realtà tra le due leggi penali c’è un rapporto di contiguità temporale ma non
una coincidenza contenutistica, di modo che debba concludersi che il fatto previsto dalla norma successiva
prima non costituiva reato, anche se la nuova legge è diretta a regolare una situazione che in precedenza,
ma per aspetti diversi, era regolata dalla norma incriminatrice abrogata. Se si optasse per la continuità
quando un fatto concreto commesso sotto il vigore della legge abrogata rientra, per aspetti diversi, nella
previsione della nuova legge si farebbe di questa un’applicazione retroattiva, in quanto quel fatto verrebbe
punito solo per aspetti che prima erano privi di rilevanza penale. Esempi di una situazione del genere
possono rinvenirsi nel reato dell’art. 2 d. lg. 10 marzo 2000, n. 74, in rapporto a quello dell’art. 4, lett. d), d. l.
10 luglio 1982, n. 429, perché, come hanno chiarito Sezioni unite (sent. 25 ottobre 2000, Di M., in Cass. pen.,
2001, p. 448), il fatto previsto dalla legge successiva non era punibile in base alla legge precedente, la quale
prevedeva invece solo un antefatto “meramente strumentale e prodromico”, e nel reato dell’art. 22, comma
10, d. lg. 25 luglio 1998, n. 286, in rapporto a quello dell’art. 12, comma 2, l. 30 dicembre 1986, n. 943,
perché, come anche in questo caso hanno chiarito le Sezioni unite (sent. 9 maggio 2001, D., in Cass. pen.,
2002, p. 502), il fatto previsto dalla legge successiva (occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno) è radicalmente diverso da quello previsto dalla legge precedente abrogata (occupazione di
lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro).
Esclusa così la teoria della doppia punibilità in concreto le tesi elaborate muovono da due approcci diversi:
6
Scheda di giurisprudenza n. 1 quello di tipo strutturale e quello di tipo valutativo. Il primo si svolge su un piano essenzialmente formale,
richiedendo che la fattispecie della legge successiva comprenda in tutto o in parte fatti rientranti nella
previsione della legge sostituita o abrogata, ossia che tra le fattispecie incriminatrici che si susseguono esista
un rapporto logico - strutturale di genere a specie (o viceversa), mentre il secondo ricerca una continuità tra
le leggi attraverso valutazioni concernenti il bene giuridico e le modalità dell’offesa e può essere considerato
sia alternativo al primo, sia cumulativo, cioè tale da operare attraverso una verifica ulteriore, dopo il
superamento del vaglio logico - strutturale, aggiungendo così all’impiego dei criteri formali quello di criteri di
tipo sostanziale o valutativo.
La questione circa i rapporti tra le norme e l’individuazione di una situazione di continuità o discontinuità si
intreccia, complicandosi ulteriormente, con le regole processuali della cognizione o dell’esecuzione, e ha
indotto talvolta alla ricerca di soluzioni complessive o a conclusioni totalmente abolitrici, giustificate con la
considerazione che le regole processuali comunque impedirebbero l’accertamento degli elementi del fatto
previsti dalla legge incriminatrice successiva. Il groviglio tra le norme dell’art. 2 c.p. e quelle processuali però
va districato tenendo distinti i due campi, sicché il nodo dell’alternativa continuità o abolizione va sciolto
prescindendo dai profili processuali, vale a dire senza pensare ai processi in corso o alle condanne
irrevocabili, come se la questione riguardasse un fatto per il quale il procedimento penale non è ancora
iniziato, un fatto, in ipotesi, commesso il giorno prima dell’intervento legislativo, e si dovesse stabilire se quel
fatto, per il quale il processo deve ancora iniziare, rimanga o meno punibile.
I criteri elaborati dalla dottrina hanno talvolta messo in ombra quelli fissati legislativamente, di modo che la
soluzione delle questioni ha finito con l’essere ricercata in tali criteri piuttosto che nelle disposizioni dell’art. 2
c.p., dalle quali invece occorre muovere.
L’art. 2 c.p. pone nei commi che lo costituiscono una sequenza di regole tra loro collegate in modo che si
chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo comma deve essere esclusa l’applicabilità sia del
primo, sia del secondo comma. Ciò significa, da un lato, che in una vicenda di successione di leggi penali,
perché un fatto rimanga punibile, occorre non solo che sia tale in base alla nuova legge ma anche che la
nuova fattispecie costituisse reato già in base alla legge precedente (altrimenti, come si è detto, si avrebbe
un’applicazione retroattiva della nuova legge, in contrasto, oltre che con l’art. 2, comma 1, c.p., anche con
l’art. 25, comma 2, Cost.) e, dall’altro, che i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della
nuova fattispecie non sono più punibili “e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione egli effetti penali”
(art. 2, comma 2, c.p.).
Il primo e il secondo comma dell’art. 2 c.p. individuano un rapporto diretto tra norma e fatto, rimanendo da
stabilire quali siano gli aspetti di questo rilevanti, se solo quelli descritti dalla fattispecie incriminatrice o anche
quelli che siano frutto di qualificazioni esterne, cioè se rilevi o meno una successione di leggi richiamate da
elementi normativi. Esempio ricorrente in giurisprudenza è quello della calunnia, per la quale si pone la
questione se è o meno applicabile la regola dell’art. 2, comma 2, c.p. nel caso in cui sia abrogata la
disposizione che prevedeva come reato il fatto oggetto dell’incolpazione (v., da ultimo, Sez. VI, 21 maggio
1999, Z., in Cass. pen., 2000, p 2254). Il terzo comma invece, che non a caso parla di reato e non di fatto,
individua un rapporto prima tra le norme e solo dopo tra queste e il commesso reato.
Perché dunque non vi sia una totale abolizione del reato previsto dalla disposizione formalmente sostituita
(oppure abrogata con la contestuale introduzione di una nuova disposizione collegata alla prima) occorre che
la fattispecie prevista dalla legge successiva fosse punibile anche in base alla legge precedente, rientrasse
cioè nell’ambito della previsione di questa, il che accade normalmente quando tra le due norme esiste un
rapporto di specialità, tanto nel caso in cui sia speciale la norma successiva quanto in quello in cui speciale
sia la prima. Però se è la norma successiva ad essere speciale ci si trova in presenza di un’abolizione
parziale, perché l’area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendone espunti
tutti quei fatti che pur rientrando nella norma generale venuta meno sono privi degli elementi specializzanti.
Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costituiscono reato e quindi restano assoggettati alla regola
del secondo comma dell’art. 2 c.p., anche se tra la disposizione sostituita e quella sostitutiva può ravvisarsi
7
Parte generale una parziale continuità. Perciò per questi fatti non opera il limite stabilito dall’ultima parte del terzo comma
dell’art. 2 c.p. e quando è stata pronunciata una condanna irrevocabile il giudice dell’esecuzione deve
provvedere a revocarla a norma dell’art. 673 c.p.p.
Risponde al senso comune, oltre che al disposto dell’art. 2 c.p., la regola che mantiene la punibilità di un fatto
se questo, astrattamente considerato, rientra nell’ambito normativo di due disposizioni che si sono succedute
nel tempo. Quando avviene ciò infatti, e nei limiti in cui avviene, di regola non opera, e non avrebbe ragione
di operare, l’effetto abolitivo retroattivo della disposizione successiva.
Si è obiettato che l’applicazione della legge successiva speciale a fatti commessi prima si risolve in ogni caso
in un’applicazione retroattiva di questa, in quanto dà rilevanza a elementi specializzanti che in precedenza
non l’avevano, ma l’obiezione non coglie nel segno, non solo perché, come è stato rilevato, condurrebbe a
conclusioni assurde e inaccettabili (e nell’interpretazione l’argumentum ab absurdo non è da sottovalutare),
ma anche e soprattutto perché in un caso del genere si è puniti per un fatto previsto come reato anche dalla
legge precedente, sicché la punibilità non è determinata da un’applicazione retroattiva della legge
successiva. Questa, a ben vedere, quando risulta speciale rispetto alla precedente, si limita a ritagliare una
porzione della vecchia, ad individuare una sottofattispecie, di cui conserva la punibilità impedendo che
rispetto ad essa l’abrogazione abbia un effetto retroattivo abolitivo.
Insomma, mantenere la punibilità di un fatto commesso nel vigore di una norma generale quando essa è
stata sostituita con una norma speciale non significa fare un’applicazione retroattiva di questa ma piuttosto
escluderne l’efficacia abolitrice per la porzione della fattispecie prevista dalla norma generale che viene a
coincidere con quella della norma speciale successiva. C’è da chiedersi, anche con riferimento all’art. 3 Cost,
quale razionalità potrebbe avere una regola, diversa da quella indicata, in base alla quale verrebbe esclusa
la punibilità di un fatto costituente reato, commesso prima dell’entrata in vigore di una nuova legge che ne
conferma il carattere di illecito penale.
Un’evenienza del genere non può essere esclusa in modo assoluto, ma deve trovare una sicura fonte nella
nuova legge. Le regole dell’art. 2 c.p. infatti sono derogabili sia nel senso della c.d. ultrattività o meglio della
perdurante attività (art. 2, comma 4, c.p.), quando manca la continuità, sia nel senso della esclusione della
continuità, quando ne ricorrerebbero le condizioni. È quindi possibile che nella legge successiva vi siano
elementi indicativi della volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei reati commessi in precedenza,
benché esistano le condizioni per l’applicabilità della regola dell’art. 2, comma 3, c.p.
Si pensi per esempio a reati collegati con una particolare situazione politica, economica, sociale o giudiziaria
e a una legge, diretta al tempo stesso a modificare tale situazione e la disciplina penale, la quale, pur
stabilendo che alcuni fatti continuano a costituire reato, intenda escluderne per il passato la punibilità:
chiudere con il passato senza indulgenze per il futuro, nel presupposto che la situazione politica, economica,
sociale o anche giudiziaria che quei reati aveva originato, e in qualche modo giustificato, o che ne ha reso
comunque problematico e discutibile il perseguimento richieda un cambiamento che si proietti verso il
passato fino al punto della totale abolizione dei reati precedentemente commessi.
Dunque un’evenienza che non può essere esclusa, ma che nell’ambito della disciplina della successione di
leggi penali non costituisce certo la regola. Perciò il criterio normale deve essere quello che porta a ricercare
un’area di coincidenza tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza che sia necessario
rinvenire conferme della continuità attraverso criteri valutativi, come quelli relativi ai beni tutelati e alle
modalità di offesa, assai spesso incapaci di condurre ad approdi interpretativi sicuri, come dimostrano i
numerosi contrasti che si sono manifestati tanto nella giurisprudenza quanto nella dottrina quando si è
trattato di farne applicazione in numerose recenti vicende legislative in materia penale.
È vero che le sentenze delle Sezioni unite 25 ottobre 2000, Di M., cit., 9 maggio 2001, D., cit. e 13 dicembre
2000, S. hanno fatto riferimento, oltre che ai criteri strutturali, a quelli valutativi, ma è da ritenere che il
passaggio ai secondi non sia di regola necessario e debba avvenire solo se vi sono elementi univocamente
indicativi di una volontà legislativa totalmente abolitrice, che nei casi esaminati dalle prime due sentenze
citate era già desumibile, come si è visto, dall’esame logico - strutturale delle norme in successione.
8
Scheda di giurisprudenza n. 1 È da considerare che chi di recente in dottrina ha sostenuto la necessità di un controllo bifasico, nell’idea che
andrebbe sempre ricercata la conferma della punibilità facendo seguire alla verifica strutturale una verifica
valutativa, ha riconosciuto che nel caso in cui dovesse giungersi all’esclusione della punibilità di fatti che
continuano ad essere previsti come reato ci si troverebbe in presenza di un esito assimilabile a quello tipico
dell’amnistia, e questa ricostruzione convince che l’abolizione senza una formale discontinuità costituisce
una situazione, eccezionale o quanto meno anomala, che richiede sicuri indici di una volontà legislativa in tal
senso, in mancanza dei quali debba, senza necessità di ulteriori conferme, trovare applicazione la regola del
terzo comma dell’art. 2 c.p.
È da aggiungere che la conclusione cui si è pervenuti in tema di successione di leggi incriminatrici non
riguarda anche la diversa ipotesi in cui l’abrogazione di una disposizione rende applicabile un’altra
disposizione preesistente, come è avvenuto nel caso dell’abrogazione della disposizione relativa al reato di
oltraggio, sulla quale sono intervenute le Sezioni unite con la sentenza 27 giugno 2001 A. (in Cass. pen.,
2002, p. 483) affermando che “la detta vicenda legislativa... non configura una ipotesi di successione
intertemporale di leggi penali, di cui al comma 3 dell’art. 2 c.p.”, perché “quest’ultima disposizione ha per
presupposto una diversità di norme incriminatrici, di cui una cronologicamente precedente all’altra”.
Affermazione che non esclude concettualmente l’esistenza di un’ipotesi di successione di leggi ma più
semplicemente nega che si tratti di un’ipotesi regolata dall’art. 2, comma 3, c.p., e soprattutto dall’ultima parte
della disposizione, relativa alle condanne irrevocabili, dato che secondo le Sezioni unite, nel caso
considerato, resta ferma, nel giudizio, la possibilità di “applicazione degli artt. 594 e 61 n. 10 c.p., sempre che
ricorra in concreto la condizione di procedibilità della querela, specificamente richiesta in relazione
all’ingiuria”.
Nell’ipotesi di sostituzione, formale o sostanziale, di una disposizione incriminatrice la nuova disposizione
esprime di per sè un giudizio di disvalore che giustifica, nei limiti già detti, una conclusione di continuità;
invece nell’ipotesi di abrogazione di una disposizione speciale, con possibile espansione applicativa della
disposizione preesistente generale, ci si trova in presenza di una valutazione legislativa meramente negativa
della disposizione abrogata, sicché non ci si può non interrogare sul significato dell’abrogazione e, a ben
vedere, può anche prospettarsi la possibilità che l’abrogazione si risolva in un’abolizione del reato previsto
dalla disposizione abrogata, non solo per il passato ma anche per il futuro, come una parte della
giurisprudenza e della dottrina ha ritenuto in seguito all’abrogazione dell’art. 552 c.p. (procurata impotenza
alla procreazione), che risultava speciale rispetto all’art. 583, comma 2, n. 3, c.p. (lesioni da cui sia derivata
la perdita della capacità di procreare).
In ogni caso si tratta di un’ipotesi in cui, anche ove si ritenesse applicabile il terzo comma dell’art. 2 c.p., le
determinazioni sulla continuità normativa e soprattutto quelle più specifiche sulla conservazione o sulla
revoca di un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile (si pensi al caso dell’oltraggio) dovrebbero
normalmente, attingere, oltre che a criteri strutturali, anche a criteri valutativi.
[...Omissis...]
9
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 2
Requisiti essenziali della delega
TRACCIA
Tizio è legale rappresentante della Alfa trasporti S.r.l. che si occupa di effettuare trasporti mediante
autoarticolati in tutta Europa.
In data 5 maggio 2014, uno degli autoarticolati è coinvolto in un grave sinistro: l’autista Caio, perdendo il
controllo del mezzo mentre viaggiava nella corsia di destra dell’autostrada, nei pressi di una curva viene a
collidere con un’auto che si trovava alla sua sinistra, provocando la morte del conducente Sempronio e del
passeggero Mevio.
Durante le indagini, si scopre che il sinistro è dovuto a un malfunzionamento dell’impianto frenante e che
l’automezzo era privo del certificato di revisione previsto dalla legge. Il consulente tecnico nominato dal PM
accerta altresì che l’incidente non è in alcun modo addebitabile a Caio in quanto egli viaggiava a velocità
inferiore ai massimi consentiti e comunque conforme alle condizioni atmosferiche e del traffico e ha compiuto
tutte le manovre d’emergenza possibili.
Il mezzo pesante, infatti, privo dell’impianto frenante aveva accumulato velocità lungo una discesa e,
nonostante i tentativi dell’autista di fermarne l’inerzia, era uscito di strada in prossimità di una curva,
dapprima scontrandosi con il guardrail di destra e poi scartando improvvisamente a sinistra e schiacciando
l’auto di Mevio e Sempronio contro la barriera di cemento che separa le due carreggiate autostradali.
Infine, secondo il medico legale, il decesso di Mevio e Sempronio era certamente addebitabile al sinistro, in
quanto proprio lo scontro con la barriera in cemento aveva provocato gravi traumi agli occupanti da cui era
conseguita la morte.
Tizio, quindi, viene tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo plurimo commesso in
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per aver consentito che il mezzo viaggiasse
senza aver previamente effettuato la prescritta revisione, accertamento dal quale sarebbe certamente
emerso il difetto all’impianto frenante dovuto all’usura.
Tizio, preoccupato delle conseguenze dell’accaduto e consapevole di aver delegato la verifica della
conformità dei mezzi e i relativi adempimenti all’Ing. Primo, dirigente responsabile dei mezzi, con atto scritto
datato 1 aprile 2013 e accettata contestualmente dal delegato, si rivolge ad un legale per avere
delucidazioni.
Il candidato, premessi cenni sui requisiti della delega di funzioni in ambito penale, rediga motivato parere.
1. La questione.
Posta l’ammissibilità della delega di funzioni (per il cui approfondimento si rinvia alla Scheda di
giurisprudenza n…), il d. lgs. n. 81/2008 ne ha definitivamente fissato i requisiti di validità ed
efficacia.
L’art. 16 infatti afferma che “la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
10
Scheda di giurisprudenza n. 2 d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di
funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso
i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
2. L’apporto della giurisprudenza.
Prima dell’intervento chiarificatore del d. lgs. n. 81/2008, la giurisprudenza si era interrogata su
quali dovessero essere i parametri cui il datore di lavoro avrebbe dovuto attenersi per conferire
delega; i requisiti individuati così in via pretoria hanno finito con l’essere assorbiti dalla citata
normativa.
In ragione di ciò, risulta interessante un approfondimento dei medesimi.
2.1. Atto scritto recante data certa (art. 16, co. 1, lett. a).
Il requisito della necessità della forma scritta della delega, con data certa, deve essere
interpretato quale forma ad substantiam della delega medesima, in assenza della quale dunque
nessuna efficacia potrà essere ricondotta all’atto. Per vero, prima del d.lgs. n. 81/2008, in
giurisprudenza una corrente minoritaria (Cass. pen., 11 marzo 1999, n. 3255; Cass. pen., 13
dicembre 1995, n. 12360; Cass. pen. 11 luglio 1995, n. 7662; Cass. pen. 13 novembre 1992, n.
10978) aveva cercato di affermare la validità della delega anche qualora questa potesse essere
provata mediante fatti concludenti o avvalendosi di testimoni, pur affermandosi comunque che
la stessa dovesse essere puntuale, espressa e specifica.
Ciò, tuttavia, com’è facile intuire avrebbe potuto creare notevoli margini di incertezza e
discrezionalità, soprattutto in considerazione del fatto che il momento del conferimento avrebbe
potuto non coincidere con quello dell’accettazione della medesima, creando così ovvie difficoltà in
relazione all’accertamento della responsabilità penale.
2.2. Professionalità ed esperienza del delegato (art. 16, co. 1, lett. b).
Anche tale parametro era stato definito come imprescindibile dalla giurisprudenza ancor prima del
d.lgs. n. 81/2008 (Cass. pen., 2 aprile 1997, n. 3045; Cass. pen., 13 dicembre 1995, n. 12360;
Cass. pen., 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen., 23 febbraio 1993, n. 1760; Cass. pen., 5 luglio
1993, n. 6576), che anzi già pretendeva che la delega fosse conferita “ad un soggetto in possesso
delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di
particolare esperienza nell’organizzazione dei c.d. presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro,
anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa”.
Era ed è naturalmente necessario che tali qualità permangano nel soggetto delegato e che tale
permanenza sia verificata periodicamente. Infatti, la mancanza ab origine della professionalità
nel soggetto delegato o il suo venir meno nel corso del tempo, potrebbero condurre
11
Parte generale all’affermazione in capo al delegante di una culpa in eligendo, per aver scelto una persona
professionalmente e tecnicamente incapace di assolvere alle funzioni oggetto di delega, oppure di
una culpa in vigilando, per non aver svolto le opportune verifiche e la necessaria vigilanza sul
soggetto delegato.
2.3. Attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (art. 16,
co. 1, lett. c).
Anche prima del d.lgs. n. 81/2008, la giurisprudenza ha sempre sostenuto la necessità che il
contenuto della delega fosse dovesse esser chiaro nell’indicare in modo specifico i poteri
conferiti al soggetto delegato (Cass. pen., 20 ottobre 2000, n. 10752; roibadito di recente da
Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2013, n. 44482).
2.4. Attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, co. 1, lett. d).
La piena autonomia di spesa è un requisito tanto ovvio quanto necessario e per tale motivo
richiesto in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen. 2 aprile
1997, n. 3045; Cass. pen. 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen. 23 febbraio 1993, n. 1760) ai fini
dell’efficacia della delega già tempo prima del d.lgs. n. 81/2008: il trasferimento delle funzioni al
soggetto delegato deve essere effettivo. Da ciò deriva che la delega deve essere corredata
dalla concreta possibilità, soprattutto in termini economici, di poter porre in essere tutte le
attività necessarie all’espletamento dei compiti trasferiti. In mancanza, il trasferimento
dell’autonomia decisionale sarebbe solo apparente e dunque privo di qualsiasi efficacia.
Di conseguenza, si affermava per altro che il delegato dovesse esser libero di poter decidere
se effettuare o meno una spesa per l’apprestamento dei mezzi idonei all’attuazione dei compiti
delegati a prescindere da qualsiasi autorizzazione da parte del soggetto delegante, nell’ambito
di una soglia massima di spese stabilità in base ad un principio di congruità (Cass. pen., 30
gennaio 2001, n. 3492).
2.5. Accettazione della delega per iscritto (art. 16, co. 1, lett. e).
La delega deve essere conferita per atto scritto, avente data certa e deve essere altresì
accettata dal soggetto delegato; si tratta del resto di atto recettizio.
Com’era avvenuto in relazione al requisito della forma ad substantiam, anche in tal caso la
giurisprudenza aveva avanzato l’idea che l’accettazione potesse esser valida anche in base alla
semplice manifestazione del consenso da parte del delegato, espresso anche in modo tacito;
si trattava, tuttavia, di un orientamento minoritario (Cass. pen., 2 aprile 1997, n. 3045; Cass.
pen., 28 dicembre 1994, n. 12762; Cass. pen., 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen., 23 febbraio
1993, n. 1760), cui era agevole opporre le medesime censure di discrezionalità ed
indeterminatezza mosse contro la tesi che intravedeva la validità dell’atto di delega anche qualora
fosse stato concluso per comportamenti concludenti.
12
Scheda di giurisprudenza n. 2 2.6. Pubblicità della delega (art. 16, co. 2).
Il d.lgs. n. 81/2008 richiede che alla delega debba esser data adeguata e tempestiva pubblicità;
in tal senso, anche la giurisprudenza precedente aveva infatti affermato la necessità che fossero
prestabilite “precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, atte a disciplinare il
conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima” (Cass. pen., Sez. III, 27 maggio
1996, n. 5242).
2.7. Obbligo di vigilanza (art. 16, co. 3).
Anche in tal caso, il d.lgs. n. 81/2008 ha recepito l’indirizzo maggioritario in giurisprudenza che
vedeva il residuare di un obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante anche all’indomani del
conferimento della delega. In tal senso infatti, si affermava che “la responsabilità del datore di
lavoro, per violazione delle norme antinfortunistiche, qualora si faccia coadiuvare da un dirigente
nel controllo delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello per il rispetto delle citate norme,
viene meno solo se (…) controlli che colui al quale ha conferito la delega la usi concretamente”
(Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 1995, n. 12297).
Posto dunque un nucleo di intrasferibilità di compiti primari che devono necessariamente
restare in capo al datore di lavoro (per il quale si rinvia alla Scheda di giurisprudenza n…), per quel
che concerne i compiti delegabili ed effettivamente trasferiti, quel che residua sempre in capo al
delegante è appunto un obbligo di vigilanza, non solo del fatto che i requisiti di professionalità
(art. 16, co. 1, lett. b) non vengano meno ma anche della concreta attuazione degli adempimenti
cui il delegato è preposto in ragione della delega. Solo in presenza di un comportamento di tal
fatta, il datore di lavoro potrà andare in ipotesi esente da responsabilità.
In un recente intervento la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “ciò che
maggiormente interessa è che la vigilanza, quale ne sia l’esatta estensione, di certo non può
identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta minuta conformazione delle singole
lavorazioni che la legge affida al garante. Se così non fosse l’istituto della delega si svuoterebbe di
qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché
non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri cui demanda i pertinenti
poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne
consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda
come si è accennato precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte
del delegato medesimo e non impone il controllo momento per momento delle modalità di
svolgimento delle lavorazioni” (Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 1072).
In chiusura, deve essere precisato inoltre che i sistemi di verifica e controllo, cui fa riferimento l’art.
16, co. 3, sono quelli individuati in relazione al modello di organizzazione e gestione previsto dal
d.lgs. n. 231/2001.
13
Parte generale Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che Tizio possa incorrere nella prospettata responsabilità penale. Alla luce dei
principi pacifici in giurisprudenza ed oggi accolti anche a livello normativo, la delega dallo stesso conferita
all’Ing. Primo non può essere ritenuta sufficiente a far andare esente da responsabilità l’imputato.
A ben vedere, seppur vero che la delega presenta i requisiti di forma prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, essendo
stata conferita con atto scritto, avente data certa, ed essendo stata contestualmente accettata, in base all’art.
16, co. 3, del citato decreto, residua pur sempre in capo a Tizio un obbligo di vigilanza, obbligo che, qualora
fosse stato adempiuto, avrebbe comportato la scoperta dell’evidente inottemperanza ai compiti affidati all’Ing.
Primo e dunque alla mancata revisione dell’autoarticolato.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 29415
Estratto
[...Omissis...]
In relazione al primo profilo questa Corte ha più volte affermato che in materia ambientale, per attribuirsi
rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la
delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo
discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo
svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base
alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve
riguardare non solo te funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega
deve essere giudizialmente provata in modo certo, (da ultimo Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007 Rv. 238980).
Nell’occasione si è evidenziato come tale orientamento - dapprima limitato al campo dell’inquinamento idrico
- è stato successivamente esteso anche al settore dei rifiuti, pervenendo a conclusioni analoghe a quelle
elaborate in tema di sicurezza sul lavoro. E, dunque, solo l’esistenza di una prova compiuta in relazione a
tutti gli aspetti indicati si sarebbe potuta ritenere decisiva per elidere la responsabilità del ricorrente. In
mancanza di essa non è possibile escludere, come correttamente ritenuto dal tribunale, la responsabilità
dell’imputato quantomeno concorrente con quella di altri soggetti.
I riferimenti a questi ultimi sono peraltro del tutto generici. Non è dato sapere con certezza da chi ed in quali
forme sia stata conferita a quest’ultimi la delega nè le ragioni per le quali non sia stata contestualmente
revocata all’imputato.
Correttamente pertanto il tribunale, in mancanza di allegazioni sul punto il cui onere non poteva che ricadere
su chi contestava la situazione formalmente accertata, ha ritenuto di non attribuire decisività alle dichiarazioni
citate nel motivo di ricorso. Nè è prospettabile alcun profilo di illogicità della motivazione al riguardo. Va
anzitutto premesso al riguardo che “dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione significa
dimostrare che il testo del provvedimento è macroscopicamente carente di logica e non già opporre alla
logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione degli stessi, magari
altrettanto logica” (ss.uu., 19 giugno 1996, Di Francesco) e ciò per la evidente ragione che la interpretazione
e valutazione degli atti è quaestio facti riservata al giudizio di merito, soltanto nel quale, dunque, è legittimo
contrapporre, nella dialettica delle parti, logica a logica. Ne consegue che il giudice di legittimità deve limitarsi
ad accertare se il giudice di merito abbia fatto propria, logicamente, con correttezza logica, una delle possibili
interpretazioni o valutazioni degli atti e, accertato il rispetto delle regole della logica, non può che
14
Scheda di giurisprudenza n. 2 disattendere la censura di manifesta illogicità che sia stata proposta affermandosi - ed è quod plerumque
accidit - che alla interpretazione o valutazione degli atti data dal giudice di merito è possibile opporne
un’altra. Ciò posto deve ritenersi correttamente motivata la decisione che si limita ad evidenziare l’esistenza
di una delega formale solo in capo all’imputato. E ciò in quanto l’esistenza di deleghe attribuite al solo
imputato e la mancata iniziativa per formalizzare l’attribuzione di compiti a terzi esonerando il primo, proprio
sotto il profilo logico, ben può trovare spiegazione nella volontà della società di mantenere una responsabilità
concorrente per l’imputato quantomeno a titolo di vigilanza sul comportamento di altri incaricati.
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420
Estratto
[...Omissis...]
Quanto alla prospettata “delega di funzioni”“ al dipendente L., va rilevato che alcune pronunzie di questa
Corte hanno negato in modo assoluto la rilevanza penale della delega in materia ambientale (vedi, in tema di
inquinamento idrico, Cass., Sez. 3^, 8.1.1992, Furlani; 8.2.1991, Bortoluzzi; 11.4.1989, Pomari).
L’indirizzo prevalente, però - dapprima limitato al campo dell’inquinamento idrico e successivamente esteso
anche al settore dei rifiuti - perviene a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul
lavoro, affermando la rilevanza della delega in presenza di precisi requisiti (vedi Cass., Sez. 3^, 24.9.1990,
Manghi);
la delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali
di tipo discrezionale (Cass., Sez. 3^, 22.6.1998, Moscatelli);
il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del
compito affidatogli (Cass., Sez. 3^, 14.5.2002, Saba);
il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa (Cass., Sez. 3^,
14.5.2002, Saba) o, quanto meno, alle esigenze organizzative della stessa (vedi Cass., Sez. 3^, 29.5.1996,
Bressan);
unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;
l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo
[...Omissis...]
15
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 3
Delega e posizioni di garanzia
TRACCIA
Tizio, amministratore unico della società Beta costruzioni S.r.l., in vista della realizzazione dei lavori di
demolizione di un edificio situato nel Comune di Roma, provvedeva a nominare Caio, suo dipendente, quale
responsabile dei lavori, delegandolo per iscritto alla progettazione e alla realizzazione dell’opera nonché alla
verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere. Tuttavia, Caio in
seno all’organizzazione aziendale risultava in concreto sfornito di qualsiasi potere autonomo di decisione e di
spesa.
In data X, Sempronio, operaio della ditta Beta Costruzioni, mentre era intento ad effettuare dei lavori in cima
ad una scala alta quasi sei metri, cadeva al suolo, subendo un forte trauma cranico dal quale derivava la
morte.
Durante le indagini veniva accertato che il lavoratore era privo delle misure di protezione individuale
prescritte dalla legge. Pertanto, Caio, nella sua qualità di responsabile dei lavori, veniva iscritto nel registro
delle notizie di reato per il delitto di omicidio colposo aggravato (589, co. 1 e 2 c.p.), avendo cagionato la
morte di Sempronio per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e nell’inottemperanza alla
disciplina di cui agli artt. 105 e ss. del T.U. 81 del 2008.
Per il medesimo reato veniva altresì sottoposto ad indagini Tizio, in qualità di amministratore unico della
società committente.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi cenni sul reato omissivo improprio e, nello
specifico, sulla possibilità del garante di delegare a terzi le proprie funzioni, rediga motivato parere.
1. La questione.
La questione dell’individuazione della posizione di garanzia, e dunque in particolare della relativa
fonte, si è imposta all’attenzione della giurisprudenza in tempi recenti soprattutto in relazione alla
problematica della responsabilità nell’ambito di enti ed imprese dalla struttura più o meno
complessa.
È necessario, per meglio comprendere la tematica, fare un passo indietro.
I reati omissivi sono tradizionalmente in reati omissivi propri ed impropri o commissivi
mediante omissione; in particolare, fra i criteri che sono stati proposti al fine di operare un
distinguo fra le due tipologie, vi è quello che fa perno sulla verificazione dell’evento: mentre nei
primi (che rinvengono la loro fonte in espresse disposizioni di legge; ad es., art. 593 c.p.) rileva il
solo mancato compimento di un’azione che la legge penale prescrive come doverosa, i secondi
(che trovano la loro fonte nell’art. 40, co. 2, c.p., in ragione del quale “Non impedire un evento,
che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) sono integrati dalla
verificazione dell’evento dannoso che l’azione comandata dalla legge avrebbe scongiurato.
Da ciò deriva, nell’ambito dei reati omissivi impropri, la giurisprudenza ha ormai da tempo
accolto il principio della giuridicità formale dell’obbligo di agire, retius di impedire l’evento: non
tutti i consociati possono essere infatti gravati da esso, pena un vulnus della libertà di agire di
ognuno. L’obbligo giuridico di agire graverebbe dunque solo su determinati soggetti legati al bene
giuridico che la norma penale tutela da un particolare vincolo, obbligo giuridico di agire che viene
16
Scheda di giurisprudenza n. 3 altresì distinto in due specie (da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 3899): da un
lato, gli obblighi cd. di protezione, ravvisabili nell’obbligo di proteggere un determinato bene
da tutte le fonti di pericolo, che presuppongono un rapporto giuridico fra garante e titolare del
bene, tale che al primo sia affidata la tutela del secondo (ad es., gli obblighi di tutela dei figli posti in
capo ai genitori), e, dall’altro lato, gli obblighi cd. di garanza, che gravano il garante dell’obbligo
di controllare determinate fonti di pericolo a tutela di tutti i beni che potrebbero subire
lesioni a causa dell’esposizione ad esse e che presuppongono un potere di signoria del garante
sulle fonti medesime (ad es., gli obblighi dei proprietari o dei custodi).
In particolare, al fine di individuare i cd. garanti del bene giuridico protetto dalla norma penale,
e dunque dei soggetti sui quali grava l’obbligo giuridico di agire, sono state elaborate tre tesi:
• la tesi formalistica, per la quale il soggetto garante andrebbe individuato in relazione alla
qualifica rivestita dal soggetto; in tal senso, le fonti dell’obbligo erano individuate: a)
nella legge, sia penale che extrapenale; b) nel contratto (si pensi, ad es., al caso della
baby sitter); c) nella precedente azione pericolosa (chi pone in essere un’azione
pericolosa, sarebbe tenuto poi ad impedire le possibili conseguenze dannose);
• la tesi funzionale (Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2000, n. 7386) a mente della quale
sarebbe necessario analizzare le mansioni in concreto svolte dai soggetti;
• la tesi organica, in ragione della quale è necessario tener conto sia della qualifica
rivestita dal soggetto, nell’ambito dell’organizzazione ed in base alla regolamentazione
interna, sia della concreta distribuzione delle funzioni all’interno dell’ente o
dell’impresa.
Quest’ultima tesi ha trovato accoglimento a livello legislativo, in particolare, per quel che
concerne la materia della sicurezza sul luogo di lavoro; l’art. 2, co. 1, lett. b), d. lgs. n.
81/2008, ha infatti precisato che è datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo o l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, la giurisprudenza si è interrogata circa la possibilità che la cd. delega di
funzioni (definita come “l’atto organizzativo interno all’impresa, con il quale un soggetto a ciò
abilitato (delegante) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi –
trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso o
negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale”; ALDROVANDI, Orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv. Trim. Dir.
Pen., 1995, 699) possa essere considerata quale fonte della posizione di garanzia,
individuando così il soggetto in ipotesi responsabile: il problema si è posto infatti in relazione alle
cd. organizzazioni complesse, nell’ambito delle quali, proprio a causa delle dimensioni
dell’impresa e dei correlati adempimenti volti a fronteggiare i pericoli, sorge l’esigenza di
individuare ulteriori soggetti, oltre dunque il datore di lavoro, su cui far gravare obblighi protettivi e,
di conseguenza, cui addossare in ipotesi di violazione dei suddetti obblighi, la responsabilità
penale.
17
Parte generale In merito, due le tesi in campo.
2.1. Il primo orientamento: esclusione dell’ammissibilità della delega
di funzioni.
Un primo orientamento esclude che la delega possa essere fonte dell’obbligo giuridico di
agire tale sgravare del tutto il soggetto originariamente gravato del medesimo obbligo.
1° Argomento: incompatibilità con il principio di legalità. Una simile impostazione
sarebbe infatti contraria al citato principio liddove permetterebbe al titolare degli obblighi,
individuato per legge, di dismetterne la titolarità attraverso un atto di autonomia privata ad
un soggetto scelto in base a valutazioni del tutto discrezionali.
La conseguenza sarebbe naturalmente, a prescindere dagli effetti, l’esclusione, a monte,
dell’ammissibilità della delega di funzioni.
2.2. Il secondo orientamento: ammissibilità della delega di funzioni.
Un secondo orientamento (Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007; Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre
2007, n. 7714) preme invece per l’ammissibilità della delega di funzioni e dunque sulla
possibilità che la stessa incida sulla distribuzione della responsabilità all’interno
dell’organizzazione dell’ente.
1° Argomento: necessità della distribuzione delle funzioni a causa delle dimensioni
dell’ente. Proprio le dimensioni dell’ente o dell’impresa potrebbero infatti comportare un blocco
nell’attività produttiva qualora di ogni adempimento dovesse essere oberato un unico soggetto e,
d’altro canto, non potrebbe neanche individuarsi tout court il soggetto responsabile esclusivamente
nell’organo di vertice solo perché tale, integrandosi altrimenti un’ipotesi di responsabilità
oggettiva.
2° Argomento: dettato legislativo. L’art. 16, d.lgs. n. 81/2008 prevede quali siano le
condizioni ed i limiti di validità della delega, implicitamente ammettendola in base a requisiti di
natura requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.
A detta di tale orientamento, dunque, nascerebbero, in ragione del conferimento della
delega, ulteriori posizioni di garanzia in capo ai delegati, di modo che gli originari obblighi di
garanzia posti in capo al delegante si trasformino in obblighi di controllo e vigilanza
sull’operato dei primi (motivo per cui la tesi risulterebbe compatibile con il principio di non
derogabilità delle posizioni di garanzia). Se da una parte la responsabilità penale continua a
poter essere in ipotesi addossata al delegante, è anche vero tuttavia che, portata all’estreme
conseguenze, tale tesi permettere a quest’ultimo di andare esente da responsabilità qualora
dimostri di aver adempiuto diligentemente i propri doveri.
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Ammissibilità
temperata della delega di funzioni.
La giurisprudenza maggioritaria (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 49670; Cass. pen.,
Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084; Cass. pen., 4 novembre 2010, n. 38991; Cass. pen., Sez. IV,
18
Scheda di giurisprudenza n. 3 10 giugno 2008, n. 23090; Cass. pen., Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6280; Cass. pen., Sez. IV, 14
gennaio 2003, n. 988), accogliendo il secondo orientamento, per un verso, ammette la possibilità
del conferimento della delega di funzioni ma, per altro verso, lo fa con il dovuto rigore. In tal
senso, si afferma che “pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente
da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in
generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica
aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa
realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza” (Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n.
4123).
1° Argomento: necessità della delega nelle imprese di grandi dimensioni. Pur essendo
vero che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di
assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione
antinfortunistica (come è agevole desumere, a prescindere dal d.lgs. n. 81/2008, dall’art. 2087
c.c.), è del pari vero che la delega si rende necessaria sia per distribuire gli adempimenti
prescritti dalla legge sia per evitare che il datore di lavoro, solo perché tale, sia considerato
automaticamente responsabile.
La giurisprudenza maggioritaria oggi dunque è incline all’ammissibilità della delega di
funzione, ma sempre che la stessa sia conferita nel rispetto di determinati requisiti (per i quali si
rinvia alla Scheda di giurisprudenza n…) e che il suo contenuto sia limitato alle sole attività
effettivamente trasferibili.
D’altra parte, viene altresì specificato in tanto la delega può essere ritenuta valida ed
efficace, in quanto emerga che in concreto il delegato abbia la possibilità di far fronte agli
adempimenti su di lui gravanti, conferendo anche un potere autonomo sia di decisione che
naturalmente di spesa. Dato questo che trova conferma anch’esso nel d.lgs. n. 80/2008, liddove
l’art. 16 esige che la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate nonché poteri di organizzazione, gestione e controllo.
2° Argomento: limitatezza della delega quanto ai contenuti. Ammessa la possibilità che
il datore di lavoro conferisca delega, è altrettanto vero che questa non possa essere illimitata; il
datore di lavoro non può andare esente da responsabilità per eventi verificatisi in danno dei
lavoratori qualora questi abbiano tratto origine da violazioni od omissioni di norme
antinfortunistiche i cui obblighi ricadevano esclusivamente sul destinatario originario.
Tale conclusione risulta del resto avallata anche dal dettato normativo: il d.lgs. n. 81/2008,
art. 17, elenca infatti specifici obblighi del datore di lavoro non delegabili, sia a causa
dell’importanza dagli stessi rivestita sia per la loro connessione con le linee guida aziendali,
attribuite naturalmente al potere/dovere del datore di lavoro.
Si tratta, in particolare, sia dell’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza, contenente non solo l’analisi valutativa dei rischi ma anche l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate, sia della designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
19
Parte generale Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che Tizio possa incorrere nella responsabilità per il delitto di omicidio colposo
aggravato. In particolare, la delega conferita a Caio, si rivela inefficace per un duplice ordine di ragioni.
In primis, a ben vedere, la delega era stata fornita non solo allo scopo di procedere alla progettazione e alla
realizzazione dell’opera ma anche alla verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori
all’interno del cantiere: si tratta, invero, di un’attività oggetto di divieto di delega da parte del d. lgs. n.
81/2008.
Per altro, la delega, pur essendo stata conferita per iscritto, e dunque ottemperando ai requisiti richiesti per la
sua validità formale, risulta carente della devoluzione di un autonomo potere decisionale e di spesa in capo a
Caio, il quale in concreto non avrebbe mai potuto far fronte ad una reale situazione di pericolo.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4084
Estratto
[...Omissis...]
Va, quindi, ancora una volta ribadito che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche
previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all’art. 2087 c.c., è il “garante”
dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene addebitato in forza
del principio che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (art.
40 c.p., comma 2).
È bensì vero che nelle imprese di grandi dimensioni occorre un puntuale accertamento, in concreto, della
gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare la eventuale
predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento
esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale (così, Sez. 4, n. 4123 del
10/12/2008 - dep. 28/01/2009, Vespasiani; Sez. 4, 9 luglio 2003, Boncompagni; Sez. 4, 27 marzo 2001,
Fornaciari, nonchè Sez. 4, 26 aprile 2000, Mantero). In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è
possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di
sicurezza, occorrendo sempre esaminare l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire,
all’interno di questo, al responsabile di settore.
Altrettanto consolidato è però il principio che la delega non può essere illimitata quanto all’oggetto delle
attività trasferibili.
Invero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore
di lavoro allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza,
attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze organizzative e strutturali,
rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza
(v., tra le altre, Sez. 4, n. 4123 del 10/12/2008 - dep. 28/01/2009, Vespasiani, Rv. 242480; Sez. 4, n. 12794
del 06/02/2007, Chirafisi, Rv. 236279).
È da ritenere, quindi, senz’altro fermo l’obbligo per il datore di lavoro di intervenire rispetto a rischi connessi a
scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali o organizzative di fondo, rispetto
alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza.
Tali principi hanno trovato conferma nel D.Lgs. n. 81 del 2008, che prevede, infatti, gli obblighi del datore di
lavoro non delegabili, per l’importanza e, all’evidenza, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di
20
Scheda di giurisprudenza n. 3 fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro (art. 17). Trattasi: a) dell’attività di
valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento previsto dal cit.
D.Lgs., art. 28, contenente non solo l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate; nonchè b) della designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
La sentenza impugnata - nel l’attribuire decisivo rilievo, ai fini in esame, alle deleghe conferite dal T. a terzi in
materia di sicurezza - omette sostanzialmente di confrontarsi con tali fondamentali aspetti della disciplina in
materia.
3.1. Ed invero l’assunto, evidentemente sotteso alla riferita lettura della fattispecie da parte del giudice di
merito, secondo cui tali deleghe siano da considerare idonee ad esonerare il datore di lavoro delegante
d’ogni compito e responsabilità connessi al fattore di rischio individuato ad origine dell’evento letale si rivela
insufficientemente motivato, trascurando di considerare che trattavasi di aspetto non contingente
dell’organizzazione del lavoro all’interno del cantiere (sia perchè determinata dall’esigenza di operare degli
scavi per la realizzazione di opere fognarie, sia perchè comunque risalente, come chiaramente detto in
sentenza, a “mesi prima rispetto ai sinistro”).
Ciò del resto è confermato dalla circostanza, pure contraddittoriamente evidenziata in altra parte della
motivazione, che l’organizzazione del cantiere, con la individuazione delle zone di pertinenza degli uffici,
dell’officina e delle aree dove dislocare il materiale scarificato - dislocazione concepita in modo tale da
assicurare distanze di sicurezza tra le aree percorse dei dipendenti operanti presso gli uffici e quelle invece
attraversate dei mezzi impegnati nei lavori di scarificazione - costituiva aspetto espressamente considerato
nel documento di valutazione dei rischi, tanto che fattore determinante del sinistro è stato individuato in
sentenza “nella successiva modifica apportata a tale disposizione a seguito degli scavi relativi a opere
fognarie”, modifica alla quale “non ha fatto seguito un’integrazione al documento di valutazione dei rischi”.
Il fatto stesso, dunque, che si trattasse di aspetto dell’organizzazione ricompreso nel documento di
valutazione dei rischi avrebbe dovuto condurre ad escludere che i compiti e le responsabilità connesse al suo
governo potessero formare oggetto di valida ed efficace delega a terzi, alla luce del testuale disposto dell’art.
17 T.U. cit. che, come detto, espressamente esclude la delegabilità della valutazione di tutti i rischi e della
elaborazione del relativo documento (previsto dall’art. 28):
attività che, come correttamente rimarca il P.M. ricorrente, ai sensi dell’art. 29, comma 3, deve essere
“immediatamente” nuovamente eseguita “in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In tale prospettiva nessun rilievo potrebbe ovviamente assumere l’esistenza di “omissioni informative” da
parte dei collaboratori del datore di lavoro, non valendo queste comunque ad esonerare da responsabilità il
datore di lavoro per la condotta omissiva di per sè riferibile anche alla mancata predisposizione di canali
informativi adeguati e idonei a far emergere con la dovuta tempestività la sopravvenienza di circostanze
incidenti sulla valutazione dei rischi (responsabilità tanto più predicabile in presenza di mutamenti risalenti
“mesi prima rispetto al sinistro”).
3.2. Giova peraltro rammentare che la delega di funzioni, anche nei casi in cui essa è ammessa, non esclude
comunque, siccome espressamente previsto dall’art. 16, comma 3, del T.U. citato, l’obbligo di vigilanza in
capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite:
obbligo che può intendersi assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’art. 30, comma 4, del medesimo testo normativo.
Anche in relazione a tale sussidiario profilo si rivela non perspicua l’osservazione contenuta in sentenza
secondo cui “la vigilanza sul modello organizzativo di cui ... (al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 30) ... attiene il
profilo di organizzazione aziendale complessa più direttamente dipendente dalle figure apicali e non, come
nel caso di specie, le modifiche che attengono al variare di elementi connessi alla operatività del singolo
cantiere”.
Tale inciso sembra sovrapporre i due piani, ossia: da un lato, la riferibilità della violazione identificata ad
21
Parte generale origine dell’evento dannoso a doveri e responsabilità suscettibili di delega da parte del datore di lavoro;
dall’altro, sul presupposto di una risposta positiva a tale primo quesito, l’assolvimento di residuali doveri di
vigilanza comunque permanenti in capo al datore di lavoro delegante.
Il giudice di merito affronta entrambi i temi con l’unico argomento secondo cui, se ben si comprende, il fattore
determinante del sinistro - costituito dalla sopra descritta modifica dell’organizzazione del cantiere di
(OMISSIS) - non investirebbe un “profilo di organizzazione aziendale complessa più direttamente dipendente
dalle figure apicali” ma piuttosto rappresenterebbe una variazione di “elementi connessi alla operatività del
singolo cantiere”.
Tale argomento, oltre ad apparire in sè non persuasivo per le ragioni sopra illustrate, non è comunque
spendibile in entrambi i sensi.
L’attinenza del fattore di rischio ad aspetti non relativi a scelte di fondo dell’organizzazione aziendale quand’anche effettivamente riscontrabile nel caso concreto (cosa della quale può fortemente dubitarsi alla
luce dei superiori rilievi) - può valere infatti a consentire il trasferimento degli obblighi propri del datore di
lavoro e la connessa posizione di garanzia ad altri soggetti attraverso valide deleghe, nel rispetto dei requisiti
previsti dall’art. 16, ma non esonera comunque, come detto, il delegante dall’obbligo di vigilanza, controllo ed
intervento sostitutivo.
Quantunque si tratti, come è stato condivisibilmente evidenziato, di una vigilanza “alta”, distinta da quella
gravante sullo stesso delegato, che riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del
rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di
svolgimento delle lavorazioni (v. Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012, Mangone, Rv.
252675), cionondimeno l’assunto secondo cui il relativo obbligo non verrebbe nella specie in rilievo si rivela
sostanzialmente immotivato, sembrando la riportata affermazione postularne in radice l’inoperativita piuttosto
che argomentarne in concreto l’irrilevanza in rapporto alla natura ed alle cause del fattore di rischio che ha
determinato l’evento (motivazione tanto più necessaria in considerazione dell’anteriorità della collocazione
temporale delle modifiche dell’organizzazione del cantiere in altra parte della sentenza indicate come risalenti
a “mesi prima rispetto ai sinistro”).
Nè a dimostrare l’assolvimento del detto obbligo residuo di vigilanza in capo al datore di lavoro possono
bastare il mero riferimento allo stesso sistema di deleghe di cui si è detto e la considerazione,
sostanzialmente tautologica, che “se c’è stata un’omissione informativa utile a consentire la modifica del
piano di sicurezza”, essa “e la connessa dovuta vigilanza, non possa farsi risalire fino ai livelli a pica li della
società, atteso che il sistema delle deleghe ... serve a consentire il reale controllo dei fattori di rischio,
assicurando che la prevenzione si attui mediante un più pregnante controllo strutturato sin dalla base
dell’organizzazione aziendale”.
È agevole difatti di contro rilevare che si da in tal modo per dimostrato quel che occorreva invece dimostrare,
ossia che il funzionamento e l’efficacia di tale sistema di deleghe sia stato sottoposto alle dovute verifiche da
parte del datore di lavoro delegante, in particolare secondo il modello organizzativo prefigurato dal già citato
art. 30 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (dimostrazione tanto più, ripetersi, necessaria a fronte del
dato temporale sopra riferito).
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4123
Estratto
[...Omissis...]
La sentenza, invece, appare solida e immeritevole di censure nella ricostruzione del nesso eziologico e nel
collegamento del fatto alla condotta omissiva del V..
La Corte di merito, infatti, nel richiamare la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, ha innanzitutto
22
Scheda di giurisprudenza n. 3 evidenziato che il fuoco sviluppatosi all’interno del laminatoio (OMISSIS), per la vastità della zona
interessata, per le difficoltà di spegnimento e la diffusività delle fiamme, aveva già assunto le caratteristiche
dell’incendio quando erano intervenuti i vigili del fuoco, che impiegarono ben 3 giorni (dalle ore 12,43 del 24
alle ore 6 del 26 marzo) per domare le fiamme, con l’utilizzo di 270 uomini e 20 mezzi fissi sul posto.
L’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito con logicità argomentativa sulla sussistenza di tali
requisiti per la configurabilità dell’incendio, in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte (v., tra le
altre, Sez. 4, 2 luglio 2007, Di Giovanni) è incensurabile in questa sede di legittimità.
È stato poi evidenziato, alle luce delle risultanze della consulenza del PM, che tale situazione era stata la
conseguenza della inadeguatezza dei presidi antincendio che, se solo fossero stati più efficienti, avrebbero
consentito di evitarla La carenza è stata individuata, così confermando l’ipotesi accusatoria, nella omessa
compartimentazione dei locali sottostanti il laminatoio e degli altri ad esso asserviti, nella mancanza di un
sistema di intervento ad attivazione automatica e nella mancata dotazione di un sistema a video, o a circuito
chiuso, che consentisse l’immediata percezione del pericolo con l’entrata in funzione degli esistenti rilevatori
di fumo.
La sentenza impugnata si è altresì soffermata sulla ipotesi prospettata dalla difesa secondo la quale la causa
del propagarsi delle fiamme era da individuare nel comportamento dei vigili del fuoco, affrontando
adeguatamente la questione della possibile esistenza di un fattore causale, alternativo o quantomeno
concorrente, tale da potere costituire elemento di smentita o di correzione della ricostruzione ipotizzata ed
accolta.
Ciò il giudicante ha fatto escludendo la sussistenza di elementi di responsabilità ascrivibili ad essi con
motivazione convincente che esclude che qui possa porsi alcun profilo di rilevanza di detta condotta.
La ricostruzione operata dalla difesa si poggia infatti su un’asserita condotta colposa dei vigili del fuoco che il
giudicante ha escluso, attraverso una analitica disamina critica del materiale probatorio, pur dando atto di
maldestre procedure (apertura di botole con l’immissione di aria che aveva favorito la combustione, utilizzo
dell’acqua per lo spegnimento delle fiamme che aveva determinato il traboccamento dell’olio, che così era
fuoriuscita dalle vasche) seguite per fronteggiare la situazione nella fase iniziale.
Affrontando la questione della possibile rilevanza causale di dette condotte, la Corte di merito ha innanzitutto
escluso, effettuando un giudizio controfattuale meramente ipotetico - in linea con quanto puntualizzato dalla
nota sentenza delle Sezioni unite 10 luglio 2002, Franzese, improntata al rispetto della regola della certezza
processuale - che senza dette manovre l’incendio si sarebbe estinto, evidenziando, alle luce delle risultanze
della CTU, che lo stesso sarebbe stato comunque alimentato da altre correnti di aria che avevano accesso
dall’esterno e ribadendo la grave carenza dei presidi antincendio come condicio sine qua non del rapido
propagarsi e della estesa diffusività delle fiamme.
A ciò aggiungasi che proprio l’iniziale improvvido intervento dei vigili del fuoco, come esattamente
sottolineato nella sentenza gravata, sotto certi aspetti, anziché togliere i profili di responsabilità, li aveva
accentuati, dando la prova che la particolarità del luogo, caratterizzato da elevato rischio d’incendio per la
presenza di olio di raffreddamento, non era stata fatta oggetto di particolari segnalazioni di rischio e di
accorgimenti in grado di indirizzare eventuali interventi emergenziali.
Il diverso assunto del ricorrente al riguardo si risolve in una diversa ricostruzione fattuale ed in un diverso
apprezzamento di circostanze fattuali, non utilmente prospettabili in sede di legittimità, rivelandosi le
doglianze del ricorrente meramente assertive. Non potrebbe quindi il giudice di legittimità sostituirsi ai giudici
di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione dei medesimi, non essendo la sentenza impugnata
incorsa in alcun vizio logico.
Anche il terzo motivo è infondato.
A base dell’affermato giudizio di colpevolezza i giudici di merito hanno posto l’apprezzamento del ruolo svolto
dal V. all’interno del comitato direttivo dell’azienda, capo del settore di produzione e sicurezza, con
autonomia gestionale e di spesa.
La Corte di appello, attraverso la disamina degli atti di causa, ha ampiamente argomentato sui profili della
23
Parte generale ritenuta responsabilità dell’imputato, corrispondendo del resto puntualmente rispetto alle doglianze proposte
con l’appello.
I giudici di appello, richiamando anche le argomentazioni del primo giudice, hanno ritenuto che la delega
operata dal V. non valeva ad esonerarlo da responsabilità, essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i
rischi connessi all’attività di impresa e di individuare le misure di protezione, ontologicamente connessi alla
funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente trasferibili.
Il ragionamento della Corte territoriale è logico e corretto e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità.
È utile in proposito ricordare taluni principi affermati da questa Corte in tema di delega del datore di lavoro.
È vero che nelle imprese di grandi dimensioni, come sostenuto dalla difesa, si pone la delicata questione,
attinente all’individuazione del soggetto che assume su di sè, in via immediata e diretta, la posizione di
garanzia, la cui soluzione precede, logicamente e giuridicamente, quella della (eventuale) delega di funzioni.
In imprese di tal genere, infatti, non può individuarsi questo soggetto, automaticamente, in colui o in coloro
che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva
situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare la
eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto
funzionamento esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale (così, esattamente,
Sezione 4, 9 luglio 2003, Boncompagni; Sezione 4, 27 marzo 2001, Fornaciari, nonché Sezione 4, 26 aprile
2000, Mantero). In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court
all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre
apprezzare l’apparato organizzativo che si è costituito, si da poter risalire, all’interno di questo, al
responsabile di settore.
Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con l’addebitare all’organo di vertice quasi una sorta di
responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perchè devolute alla cura ed
alla conseguente responsabilità di altri.
È altrettanto vero che il problema interpretativo ricorrente è sempre stato quello della individuazione delle
condizioni di legittimità della delega: questo, per evitare una facile elusione dell’obbligo di garanzia gravante
sul datore di lavoro, ma, nel contempo, per scongiurare il rischio, sopra evidenziato, di trasformare tale
obbligo in una sorta di responsabilità oggettiva, correlata tout court alla posizione soggettiva di datore di
lavoro.
Sul punto, costituisce affermazione consolidata che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli
obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione
antinfortunistica. Ciò dovendolo desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso
posti a carico dello stesso datore di lavoro dal decreto legislativo in commento, dalla “norma di chiusura”
stabilita nell’art. 2087 c.c., che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di
lavoro di farsi tout court garante dell’incolumità del lavoratore.
Va, quindi, ancora una volta ribadito che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche
previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all’art. 2087 c.c., è il “garante”
dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene addebitato in forza
del principio che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (art.
40 c.p., co., 2).
Altrettanto consolidato è il principio che la delega non può essere illimitata quanto all’oggetto delle attività
trasferibili.
In vero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il
datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della
sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali,
rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza
(v., tra le altre, Sez. 4, 6 febbraio 2007, Proc. gen. App. Messina ed altro in proc. Chirafisi ed altro).
24
Scheda di giurisprudenza n. 3 È da ritenere, quindi, senz’altro fermo l’obbligo per il datore di lavoro di intervenire allorchè apprezzi che il
rischio connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa si riconnette a scelte di carattere generale di politica
aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa
realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza.
Tali principi hanno trovato conferma nel D.Lgs. n. 81 del 2008 che prevede, infatti, gli obblighi del datore di
lavoro non delegatali, per l’importanza e, all’evidenza, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di
fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro (v. art. 17).
Trattasi: a) dell’attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del
documento previsto dal cit. D.Lgs., art. 28, contenente non solo l’analisi valutativa dei rischi, ma anche
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; nonché b) della designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
La sentenza impugnata è in linea con i principi sopra tratteggiati, tenuto conto che il profilo di colpa
contestato all’imputato e ritenuto dai giudici di merito era stato ravvisato, in sostanza, nella mancata analisi
del rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il
programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali,
tutti aspetti che riguardano le complessive scelte aziendali inerenti alla sicurezza delle lavorazioni e che,
quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro.
Nella specie, in definitiva, correttamente è stata ravvisata la posizione di garanzia del prevenuto,
apprezzandone sia il ruolo di vertice che la diretta competenza nel settore della sicurezza, oltre che i limiti
entro cui il medesimo poteva avvalersi della delega a terzi.
Per gli altri profili di censura, contenuti nel terzo motivo, afferenti la contestazione dei profili di colpa ritenuti in
capo al V., con riferimento ai rilevatori di fumo ed all’impianto di estinzione, valgono i principi affermati in
relazione al primo e secondo motivo, con i quali è stato contestato il giudizio di responsabilità del ricorrente.
Anche il quarto motivo è infondato, giacchè le censure proposte vorrebbero che in questa sede si
procedesse ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato
del potere discrezionale loro concesso dall’ordinamento ai fini della determinazione della pena.
Il ricorrente non considera che, ai fini della determinazione della pena, il potere discrezionale del giudice di
merito, correlato all’apprezzamento degli elementi indicati nell’art. 133 c.p., è incensurabile se supportato da
coerente e congrua motivazione.
Quanto detto vale, a fortiori, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le
argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi,
favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è
sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego delle
attenuanti e della determinazione della pena, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in
carenza di stretta contestazione (cfr., ex pluribus, Sez. 4, 19 giugno 2006, Del Frate).
A ciò dovendosi aggiungere, con specifico riguardo al contenuto dell’obbligo di motivazione, che questo si
attenua sia nel caso in cui il giudice ritenga di applicare la pena in misura prossima o vicina al minimo edittale
(come nella specie in cui è stato effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla
contestata aggravante), tanto più se si consideri che l’applicazione del minimo edittale non è correlata ad un
diritto assoluto dell’imputato (in tal senso, cfr. la sentenza sopra citata).
[...Omissis...]
25
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 4
Causalità omissiva
TRACCIA
Tizio veniva ricoverato presso il reparto di pneumologia dell’ospedale del luogo di residenza in stato di
ubriachezza e per presunta crisi asmatica. Vista la sua condizione psicofisica, il paziente era stato posto su
un letto, dal quale, tuttavia, cadeva a terra una prima volta; a seguito di ciò il personale infermieristico lo
collocava nuovamente a letto, assumendo l’accortezza di predisporre, da un solo lato del medesimo, una
sponda metallica di contenimento. Non essendo disponibile in reparto un’altra sponda metallica, le due
infermiere Caia e Sempronia accostavano l’altro lato del letto al muro, ponendo dei cuscini tra questo ed il
corpo del paziente.
Dopo qualche minuto questi si era nuovamente mosso in modo da spostare il letto ed era caduto ancora a
terra battendo sul pavimento. A seguito delle lesioni riportate negli impatti al suolo Tizio decedeva.
I familiari di Tizio, perplessi per il trattamento ricevuto dal loro congiunto, decidevano di sporgere querela nei
confronti del personale infermieristico per il delitto di omicidio colposo.
Il P.M. competente ratione loci, investito il consulente tecnico della questione relativa alla causa della morte,
accertava che l’effettiva efficienza causale della prima o della seconda caduta non era sicura, atteso che non
era certo che non fosse stata la prima caduta a cagionare la morte. Per contro, rilevava ancora il consulente,
l’evento era stato inevitabile, posto che non poteva affermarsi che l’apposizione delle sponde su entrambi i
lati sarebbe valsa ad impedire la seconda caduta.
Caia e Sempronia, temendo che fosse iniziato un procedimento penale a loro carico, si rivolsero ad un legale
per ottenere conforto sulla loro posizione.
Il candidato, assunte le vesti del legale di entrambe le infermiere, premessi brevi cenni sull’accertamento
della causalità omissiva, rediga motivato parere.
1. La questione.
Il nesso di causalità omissiva è sempre stato terreno di scontro fra diversi orientamenti a causa
dei problemi interpretativi, e dunque a valle applicativi, che nascono dalla peculiarità della struttura
del reato di cui è elemento costitutivo.
In tal senso, sia la dottrina che la giurisprudenza da tempo si sono interrogate, da un lato, sulla natura
della causalità omissiva e, dall’altro, sui relativi criteri di accertamento e dunque sul grado di
certezza che, nell’accertamento del reato, deve essere raggiunto perché possa dirsi che l’azione
doverosa omessa, qualora posta in essere, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento dannoso.
È necessario in via preliminare, richiamare le linee essenziali del reato omissivo e ciò soprattutto in
ragione del fatto che la problematica dell’accertamento della causalità si pone solo in relazione al
reato omissivo improprio.
Il reato omissivo si divide, infatti, in due categorie: da un parte, il reato omissivo proprio, che
trova la sua fonte in espresse disposizioni di legge e che consiste nel mancato compimento
di un’azione di cui la legge penale impone la realizzazione, e, dall’altra, il reato omissivo
improprio, che trova invece la sua fonte nell’art. 40, co. 2, c.p. (“Non impedire un evento, che si
ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) e che svolge una funzione di
duplicazione delle fattispecie di delitto contemplate nella parte speciale del codice penale: la
26
Scheda di giurisprudenza n. 4 citata norma (che, al pari dell’art. 56 c.p., ha la funzione di estendere l’ambito della punibilità,
qualora applicato in combinato disposto con altre norme) pone quella cd. clausola di equivalenza
che, una volta innestata su una disposizione di parte speciale, crea una fattispecie incriminatrice di
carattere autonomo.
Tanto brevemente premesso, risulta implicito il perché il problema della causalità si ponga solo
nell’ambito dei reati omissivi impropri: se è vero che nei reati omissivi propri, perché possano dirsi
integrati gli estremi del reato, è sufficiente l’accertamento della mera omissione (ad es., art. 593
c.p.). allora solo nei primi sarà necessario provare il nesso di causalità che avvince la condotta alla
verificazione dell’evento; non è un caso, del resto, che l’ambito nel quale si siano scontrati gli
orientamenti in tema sia quello della responsabilità medico sanitaria.
In giurisprudenza, sia per quel che concerne la natura della causalità omissiva sia per quel che
riguarda invece i criteri di accertamento, si sono susseguite nel tempo diverse tesi che hanno poi
portato, per un verso, ad affermare l’identità fra la causalità attiva e quella omissiva e, per altro
verso, alla necessaria applicazione anche nel secondo caso del criterio della cd. probabilità
logico processuale, al fine di stabilire se causa dell’evento dannoso possa dirsi effettivamente
l’azione omessa.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali sulla natura della causalità
omissiva.
In relazione alla natura della causalità omissiva, gli orientamenti in campo erano due.
2.1. Il primo orientamento: La tesi della causalità ipotetica.
A mente di un primo orientamento (Cass. pen., Sez IV, 12 maggio 1983, n. 4320; Cass. pen., Sez.
IV, n. 15565/1990), la natura della causalità omissiva sarebbe ipotetica o in senso
normativo, distinguendosi per tale ragione da quella commissiva, al contrario reale.
1° Argomento: netta distinzione della causalità omissiva da quella commissiva. La
causalità omissiva non avrebbe potuto trovare un esatto corrispettivo in quella commissiva: nella
prima, mancando a priori un comportamento concreto (si tratta pur sempre di reato integrato
appunto da un’omissione), non potrebbe trovare spazio un nesso causale fondato invece su
categorie reali, quale quelle della causalità commissiva. La causalità omissiva dovrebbe dunque
essere connotata quale causalità ipotetica poiché al suo accertamento potrebbe giungersi
solo tramite un giudizio ipotetico prognostico.
2° Argomento: ricorso al criterio del cd. aumento del rischio. In ragione del fatto che
qualificare, e correlativamente accertare, la causalità omissiva alla stregua di un giudizio ipotetico
avrebbe potuto esporre la tesi in esame a rischi di incertezza, i fautori dell’orientamento in parola
correggevano il tiro ricorrendo al criterio dell’aumento del rischio: la condotta penalmente
rilevante sarebbe stata integrata qualora, in base ad un accertamento condotto ex ante,
avesse implicato un aumento delle probabilità di verificazione dell’evento dannoso.
Ciò, tuttavia, esponeva la tesi al rischio che il nesso causale sarebbe stato ravvisabile
anche in presenza di una minima probabilità della non verificazione dell’evento dannoso
qualora il comportamento doveroso fosse stato attuato.
27
Parte generale 2.2. Il secondo orientamento: La tesi dell’identità fra la causalità
attiva e quella omissiva.
Secondo un altro orientamento (Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 27781; Cass. pen., Sez.
IV, 25 settembre 2001, n. 1585; Cass. pen., Sez. IV, 6 aprile 2001, n. 14006; Cass. pen., Sez. IV,
28 settembre 2000, n. 9780), la causalità omissiva avrebbe costituito una categoria reale al
pari di quella commissiva.
1° Argomento: reale valore condizionante della causalità omissiva. L’affermazione di
tale valore alla causalità omissiva non potrebbe che comportare la sua identità strutturale con la
causalità commissiva, avendo entrambe un peso concreto tale da poter determinare la
verificazione dell’evento dannoso.
2° Argomento: maggiore certezza dell’accertamento. Posta l’identità fra la causalità
commissiva e quella omissiva, conseguenza naturale sarebbe stata la sovrapponibilità delle
regole di accertamento dell’una rispetto all’altra, sovrapponibilità che comporterebbe una
certezza maggiore nel grado di accertamento della sussistenza del nesso causale.
Quest’ultimo, infatti, così come avviene per la verifica del causalità commissiva, dovrebbe essere
affermato o negato in ragione di criteri più rigorosi, quali:
• il ricorso a leggi scientifiche di copertura dotate di un coefficiente di
probabilità statica prossima al 100 %, grazie al quale affermare che
effettivamente, qualora fosse stata posta in essere l’azione comandata, l’evento
dannoso non si sarebbe verificato;
• la probabilità vicina alla certezza in ragione della quale affermare che l’evento
non si sarebbe verificato in presenza del comportamento doveroso omesso;
• il ripudio del criterio dell’aumento del rischio.
3. Gli orientamenti giurisprudenziali sui criteri di accertamento della
causalità omissiva.
Correlativamente, anche per quel che concerne i criteri di accertamento della causalità
omissiva si sono alternati in giurisprudenza, così come in dottrina, diversi orientamenti, prima di
giungere all’applicazione, anche in tema di omissione, della tesi della probabilità logico
processuale.
3.1. Il primo orientamento: Tesi della volatizzazione del rischio.
A mente di tale orientamento (Cass. pen., Sez. IV, 7 novembre 1988, n. 298) la sussistenza del
nesso causale era ricavabile dalla violazione di una regola cautelare (in tal senso,
l’accertamento del nesso causale veniva sostanzialmente spostato al piano dell’accertamento del
profilo colposo della condotta).
1° Argomento: semplicità e certezza nell’accertamento. Spostando il piano
dell’accertamento della sussistenza del nesso causale omissivo dalla verifica compiuta
grazie ad un giudizio ipotetico ad una verifica compiuta in base all’oggettivo riscontro della
violazione di una regola cautelare, l’affermazione o meno dell’esistenza del medesimo si
28
Scheda di giurisprudenza n. 4 sarebbe rivelata, com’è ovvio, più semplice e certa. Alla tesi era possibile tuttavia facilmente
obiettare che, per quanto si sforzasse di rendere più semplice ed oggettivo l’accertamento della
sussistenza del nesso causale, finiva d’altra parte con il togliere peso alla verifica di quel che
avrebbe potuto verificarsi qualora l’azione doverosa fosse stata posta in essere, risultando così in
contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale.
3.2. Il secondo orientamento: Tesi delle serie ed apprezzabili
probabilità di successo.
In ragione delle critiche mosse al precedente orientamento (Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 1990, n.
185106; Cass. pen., Sez. IV, 7 dicembre 1999, n. 215659; Cass. pen, Sez. IV, 12 luglio 1991, n.
188921; Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 1990, n. 184561), la tesi in esame cercava di coniugare
l’accertamento della causalità omissiva con il principio di responsabilità della responsabilità
penale.
1° Argomento: le serie ed apprezzabili probabilità di successo. In base a tale criterio, la
responsabilità penale avrebbe dovuto essere affermata, così come correlativamente il nesso
causale, qualora fosse stato dimostrato che l’azione doverosa, posta in essere tempestiva e
correttamente, avrebbe evitato non già con certezza ma solo con serie ed apprezzabili
probabilità di successo la verificazione dell’evento dannoso La tesi in parola non era esente
da critiche: ad essa infatti veniva imputata una scarsa compatibilità con il principio di legalità
liddove l’accertamento del nesso causale finiva sostanzialmente con l’essere affidato alla
discrezionalità dell’interprete.
3.3. Il terzo orientamento: Tesi della probabilità vicino alla certezza.
Prendendo atto delle critiche mosse nei confronti dei citati orientamenti, la giurisprudenza (Cass.
pen., 28 settembre 2000, n. 1688; Cass. pen., 29 settembre 2000, n. 2139; Cass. pen., 28
novembre 2000, n. 2123) elaborava la tesi della probabilità vicina alla certezza.
1° Argomento: maggiore aderenza ai principi fondamentali del diritto penale. In
osservanza dei principi di personalità della responsabilità penale, di legalità e di tassatività,
la sussistenza del nesso di causalità omissiva sarebbe stata rinvenibile allorché la condotta
omissiva fosse condizione necessaria dell’evento, evenienza integrata quando emerga che la
condotta attiva doverosa omessa avrebbe evitato l’evento con probabilità vicino alla certezza,
vicino a cento. A tale orientamento è stato obiettato che, per quanto si sforzi di essere il più
rigoroso e certo possibile, tuttavia proprio la certezza invocata al fine di radicare il nesso
causale potrebbe essere di difficile accertamento, lasciando, in ipotesi, condotte colpevoli
impunite.
4. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Piena identità fra la
causalità attiva e la causalità omissiva e applicazione della probabilità
logico processuale.
Entrambe le problematiche, natura della causalità omissiva e relativi criteri di accertamento,
29
Parte generale sembrano aver trovato una soluzione, seguita ormai dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. pen.,
Sez. IV, 17 febbraio 2015, n. 10972; Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2014, n. 15495; Cass. pen.,
Sez. IV, 3 ottobre 2007, n. 36162; Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2007, n. 4177; Cass. pen.,
Sez. IV, 29 luglio 2005, n. 28564) all’indomani della sentenza Franzese (Cass. pen., Sez. Un.,
11 settembre 2002, n. 30328), che, avendo preso le distanze sia dalla tesi delle serie ed
apprezzabili probabilità di successo (che, a sua volta, aveva destituito di fondamento quella
basata sulla volatilizzazione del rischio) sia dalla tesi della probabilità vicina alla certezza, ha
finito, per un verso, con l’accostare la causalità omissiva a quella commissiva e, per altro
verso, con l’affermare la centralità della nozione della certezza processuale, avendo cura di
distinguere in quest’ambito fra la probabilità statistica e la probabilità logica. La prima,
estrapolata grazie al ricorso alla legge di copertura scientifica, attiene all’individuazione della
frequenza da cui è caratterizzata una determinata successione di eventi; la seconda si riferisce
invece alla necessità, appurata la probabile sussistenza del nesso causale in base alla
richiamata legge di copertura, tale probabilità abbia un suo riscontro concreto in relazione alle
circostanze dedotte in giudizio. In tal senso, la Suprema Corte è giunta ad affermare che il nesso
causale può dirsi sussistente qualora il comportamento omissivo del soggetto agente sia stato
“condizione necessaria dell’evento lesivo, con un altro o elevato grado di credibilità razionale o
probabilità logica”.
Nella stessa ottica, la giurisprudenza successiva, nel confermare tale arresto, ha avuto modo di
affermare che “Nei reati omissivi impropri, quindi, la causalità, proprio per essere giustificata in
base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti
nella realtà ed empiricamente verificabili, costituisce una causalità costruita su ipotesi e non già
su certezze. Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata, come quella
commissiva su di un giudizio contro fattuale (“contro i fatti”: se l’intervento omesso fosse stato
adottato, si sarebbe evitato il prodursi dell’evento?) alla quale si fa ricorso per ricostruire una
sequenza che, però, a differenza della causalità commissiva, non potrà mai avere una verifica
fenomenica. Secondo la sentenza di cui sopra “nel reato colposo omissivo improprio il rapporto
di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente
di probabilità statistica, ma deve essere verificato sulla base di un giudizio di alta probabilità
logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione
che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con
elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in
epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”. Pertanto, in tema di causalità
nei reati omissivi impropri, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all’esito del
ragionamento probatorio, che abbia escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva dell’imputato è stata condizione
necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”
(Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 27781).
30
Scheda di giurisprudenza n. 4 Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che Caia e Sempronia non possano incorrere in responsabilità per il delitto di
omicidio colposo. Premesso che ad entrambe si dovrebbe muovere rimprovero naturalmente solo per quel
che concerne la seconda caduta di Tizio, come emerge dalle risultanze delle indagini compiute dal
consulente tecnico, non è ravvisabile l’effettiva sussistenza del nesso causale fra la sua morte e tale caduta;
per altro, lo stesso è a dirsi per quel che concerne la prima caduta, non essendo il consulente certo che
entrambi gli accadimenti possano essere causa dell’evento morte. Anzi, l’ausiliario del P.M. giunge addirittura
a ritenere tale evento come inevitabile anche qualora fossero state poste in essere tutte le accortezze
opportune (come l’apposizione di una seconda sponda metallica).
Alla stregua dei canoni della probabilità statistica e della probabilità logica, non potrebbe essere rinvenuta
dunque quella certezza processuale necessaria per affermare la sussistenza del nesso causale e, a valle,
della responsabilità a titolo di omicidio colposo delle assistite.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328
Estratto
[...Omissis...]
1. - Il problema centrale del processo, sollevato sia dal ricorrente che dalla Sezione remittente, ha per
oggetto l’esistenza del rapporto causale fra la condotta (prevalentemente omissiva) addebitata all’imputato e
l’evento morte del paziente e, di conseguenza, la correttezza logico-giuridica della soluzione ad esso data dai
giudici di merito.
È stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite la controversa questione se “in tema di reato colposo
omissivo improprio, la sussistenza del nesso di causalità fra condotta omissiva ed evento, con particolare
riguardo alla materia della responsabilità professionale del medico-chirurgo, debba essere ricondotta
all’accertamento che con il comportamento dovuto ed omesso l’evento sarebbe stato impedito con elevato
grado di probabilità “vicino alla certezza”, e cioè in una percentuale di casi “quasi prossima a cento”, ovvero
siano sufficienti, a tal fine, soltanto “serie ed apprezzabili probabilità di successo” della condotta che avrebbe
potuto impedire l’evento”.
Sul tema si sono delineati due indirizzi interpretativi all’interno della Quarta Sezione della Corte di
Cassazione: al primo orientamento, tradizionale e maggioritario (ex plurimis, Sez. IV, 7.1.1983, Melis, rv.
158947; 2.4.1987, Ziliotto, rv. 176402; 7.3.1989, Prinzivalli, rv. 181334; 23.1.1990, Pasolini, rv. 184561;
13.6.1990, D’Erme, rv. 185106; 18.10.1990, Oria, rv. 185858; 12.7.1991, Silvestri, rv. 188921; 23.3.1993, De
Donato, rv. 195169; 30.4.1993, De Giovanni, rv. 195482; 11.11.1994, Presta, rv. 201554), che ritiene
sufficienti “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento, anche se limitate
e con ridotti coefficienti di probabilità, talora indicati in misura addirittura inferiore al 50%, si contrappone
l’altro, più recente, per il quale é richiesta la prova che il comportamento alternativo dell’agente avrebbe
impedito l’evento lesivo con un elevato grado di probabilità “prossimo alla certezza”, e cioè in una
percentuale di casi “quasi prossima a cento” (Sez. IV, 28.9.2000, Baltrocchi, rv. 218777; 29.9.2000, Musto;
25.9.2001, Covili, rv. 220953; 25.9.2001, Sgarbi, rv. 220982; 28.11.2000, Di Cintio, rv. 218727). Ritiene il
Collegio che, per pervenire ad una soluzione equilibrata del quesito, sia necessario procedere, in via
prioritaria, ad una ricognizione dello statuto della causalità penalmente rilevante, con particolare riguardo alla
categoria dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore dell’attività medico-chirurgica.
31
Parte generale 2. - Nell’ambito della scienza giuridica penalistica può dirsi assolutamente dominante l’interpretazione che,
nella lettura degli artt. 40 e 41 del codice penale sul rapporto di causalità e sul concorso di cause, fa leva
sulla “teoria condizionalistica” o della “equivalenza delle cause” (temperata, ma in realtà ribadita mediante il
riferimento, speculare e in negativo, alla “causalità umana” quanto alle serie causali sopravvenute, autonome
e indipendenti, da sole sufficienti a determinare l’evento: art. 41 comma 2). È dunque causa penalmente
rilevante (ma il principio stabilito dal codice penale si applica anche nel distinto settore della responsabilità
civile, a differenza di quanto avviene per il diritto anglosassone e nordamericano) la condotta umana, attiva o
omissiva, che si pone come condizione “necessaria” - conditio sine qua non - nella catena degli antecedenti
che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si
sarebbe verificato.
La verifica della causalità postula il ricorso al “giudizio controfattuale”, articolato sul condizionale congiuntivo
“se ... allora ...” (nella forma di un periodo ipotetico dell’irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è
contrario ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale “doppia formula”, nel senso
che: a) la condotta umana “è” condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dei
fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana “non è” condizione
necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo procedimento, l’evento si sarebbe
egualmente verificato.
Ma, ferma restando la struttura ipotetica della spiegazione causale, secondo il paradigma condizionalistico e
lo strumento logico dell’astrazione contro il fatto, sia in dottrina che nelle più lucide e argomentate sentenze
della giurisprudenza di legittimità, pronunciate in riferimento a fattispecie di notevole complessità per la
pluralità e l’incertezza delle ipotesi esplicative dell’evento lesivo (Sez. IV, 24.6.1986, Ponte, rv. 174511-512;
Sez. IV, 6.12.1990, Bonetti, rv. 191788; Sez. IV, 31.10.1991, Rezza, rv. 191810; Sez. IV, 27.5.1993, Rech,
rv. 196425; Sez. IV, 26.1.1998, P.G. in proc. Viviani, rv. 211847), si è osservato che, in tanto può affermarsi
che, operata l’eliminazione mentale dell’antecedente costituito dalla condotta umana, il risultato non si
sarebbe o si sarebbe comunque prodotto, in quanto si sappia, “già da prima”, che da una determinata
condotta scaturisca, o non, un determinato evento.
E la spiegazione causale dell’evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità ed irripetibilità, può essere
dettata dall’esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo
ricorso (non alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabili certezze o da arbitrarie intuizioni individuali,
bensì) al modello generalizzante della sussunzione del singolo evento, opportunamente ri-descritto nelle sue
modalità tipiche e ripetibili, sotto “leggi scientifiche” esplicative dei fenomeni. Di talché, un antecedente può
essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una
successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità
scientifica - “legge di copertura” -, frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico,
conducano ad eventi “del tipo” di quello verificatosi in concreto.
Il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito, a sua volta, sia da leggi “universali” (invero assai rare),
che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi
“statistiche” che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un
altro evento in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, con la conseguenza che
quest’ultime (ampiamente diffuse nei settori delle scienze naturali, quali la biologia, la medicina e la chimica)
sono tanto più dotate di “alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”, quanto più trovano
applicazione in un numero sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma mediante il ricorso a metodi
di prova razionali ed empiricamente controllabili.
Si avverte infine che, per accertare l’esistenza della condizione necessaria secondo il modello della
sussunzione sotto leggi scientifiche, il giudice, dopo avere ri-descritto il singolo evento nelle modalità tipiche
e ripetibili dell’accadimento lesivo, deve necessariamente ricorrere ad una serie di “assunzioni tacite” e
presupporre come presenti determinate “condizioni iniziali”, non conosciute o soltanto congetturate, sulla
base delle quali, “ceteris paribus”, mantiene validità l’impiego della legge stessa.
32
Scheda di giurisprudenza n. 4 3. - La definizione di causa penalmente rilevante ha trovato coerenti conferme anche nelle più recenti
acquisizioni giurisprudenziali (Sez. fer., 1.9.1998, Casaccio, rv. 211526; Sez. IV, 28.9.2000, Baltrocchi, cit.;
29.9.2000, Musto, cit.; 25.9.2001, Covili, cit.; 25.9.2001, Sgarbi, cit.; 20.11.2001, Turco; 28.11.2000, Di
Cintio, cit.; 8.1.2002, Trunfio; 23.1.2002, Orlando), le quali, nel recepire l’enunciata struttura logica della
spiegazione causale, ne hanno efficacemente valorizzato la natura di elemento costitutivo della fattispecie di
reato e la funzione di criterio di imputazione dell’evento lesivo. Dello schema condizionalistico integrato dal
criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche sono state sottolineate, da un lato, la portata tipizzante, in
ossequio alle garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti di responsabilità penale e di
personalità della stessa (Cost., artt. 25, comma 2 e 27, comma 1), e dall’altro, nell’ambito delle fattispecie
causalmente orientate, la funzione selettiva delle condotte rilevanti e per ciò delimitativa dell’area dell’illecito
penale.
In questo senso, nonostante i limiti epistemologici dello statuto della causalità nel rapporto fra eventi svelati
dalla fisica contemporanea e le critiche di avversa dottrina, la persistente fedeltà della prevalente scienza
giuridica penalistica al classico paradigma condizionalistico (v. lo Schema Pagliaro del 1992 di delega per un
nuovo codice penale, sub art. 10, ma soprattutto l’articolata elaborazione del Progetto Grosso del 2001 di
riforma della parte generale del codice penale, sub artt. 13 e 14) non solo appare coerente con l’assetto
normativo dell’ordinamento positivo, ma rappresenta altresì un momento irrinunciabile di garanzia per
l’individuazione della responsabilità nelle fattispecie orientate verso la produzione di un evento lesivo.
Il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale,
altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di
esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi
causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici. E non è privo di significato che dalla quasi generalità
dei sistemi giuridici penali europei (“conditio sine qua non”) e dei paesi anglosassoni (“causa but for”) siano
condivise le ragioni di determinatezza e legalità delle fattispecie di reato che il modello condizionalistico della
spiegazione dell’evento garantisce, in considerazione della funzione ascrittiva dell’imputazione causale.
4. - Nel prendere atto che nel caso in esame si verte in una fattispecie di causalità (prevalentemente)
omissiva attinente all’attività medico-chirurgica, è da porre in evidenza innanzi tutto l’essenza normativa del
concetto di “omissione”, che postula una relazione con un modello alternativo di comportamento attivo,
specifico e imposto dall’ordinamento.
Il “reato omissivo improprio” o “commissivo mediante omissione”, che è realizzato da chi viola gli speciali
doveri collegati alla posizione di garanzia non impedendo il verificarsi dell’evento, presenta una spiccata
autonomia dogmatica, scaturendo esso dall’innesto della clausola generale di equivalenza causale stabilita
dall’art. 40, comma 2, cod. pen. sulle disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato
commissivo orientate verso la produzione di un evento lesivo, suscettive così di essere convertite in
corrispondenti ipotesi omissive: autonomia che, per l’effetto estensivo dell’area della punibilità, pone indubbi
problemi di legalità e determinatezza della fattispecie criminosa.
Ma la presenza nei reati omissivi impropri, accanto all’equivalente normativo della causalità, di un ulteriore,
forte, nucleo normativo, relativo sia alla posizione di garanzia che agli specifici doveri di diligenza, la cui
inosservanza fonda la colpa dell’agente, tende ad agevolare una prevaricazione di questi elementi rispetto
all’ordinaria sequenza che deve muovere dalla spiegazione del nesso eziologico.
Di talché, con particolare riferimento ai settori delle attività medico-chirurgiche, delle malattie professionali,
delle alterazioni ambientali e del danno da prodotto, dall’erosione del paradigma causale nell’omissione,
asseritamente motivata con l’incertezza costitutiva e con i profili altamente ipotetici della condizionalità, a
fronte della pluralità e inconoscibilità dei fattori interagenti, trae alimento la teoria della “imputazione oggettiva
dell’evento”. Questa é caratterizzata dal riferimento alla sufficiente efficacia esplicativa del fenomeno offerta
dalla mera “possibilità” o anche da inadeguati coefficienti di probabilità salvifica del comportamento
doveroso, espressa in termini di “aumento - o mancata diminuzione - del rischio” di lesione del bene protetto
o di diminuzione delle chances di salvezza del medesimo bene (vita, incolumità fisica, salute, ambiente), di
33
Parte generale cui si esalta lo spessore primario e rilevante. Pure in assenza, cioè, dell’accertamento rigoroso che, qualora
si fosse tenuta da parte dell’agente la condotta doverosa e diligente (ad esempio, in materia di responsabilità
medica: diagnosi corretta, terapia adeguata e intervento tempestivo), il singolo evento di danno non si
sarebbe verificato o si sarebbe comunque verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore
intensità lesiva. Orbene, la più recente e citata giurisprudenza di legittimità ha reagito a questa riduttiva
lettura della causalità omissiva ed ha segnato una netta evoluzione interpretativa - che le Sezioni Unite
condividono -, soprattutto nel settore dell’attività medico-chirurgica (Sez. fer., Casaccio; Sez. IV, Baltrocchi,
Musto, Di Cintio, Turco, Trunfio, Orlando), delle malattie professionali (Sez. IV, Covili) e degli infortuni sul
lavoro (Sez. IV, Sgarbi), convenendo che anche per i reati omissivi impropri resta valido il descritto
paradigma unitario di imputazione dell’evento. Pur dandosi atto della peculiarità concettuale dell’omissione (è
tuttora controversa la natura reale o meramente normativa dell’efficienza condizionante di un fattore statico
negli sviluppi della catena causale), si osserva che lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre
quello del “condizionale controfattuale”, la cui formula dovrà rispondere al quesito se, mentalmente eliminato
il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo
dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic
et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo “coperto” dal sapere
scientifico del tempo.
Considerato che anche la spiegazione della causalità attiva ricorre a controfattuali ipotetici, il citato indirizzo
interpretativo ha dunque ridimensionato la tesi per la quale la verifica giudiziale della condizionalità
necessaria dell’omissione pretenderebbe un grado di “certezza” meno rigoroso rispetto ai comuni canoni
richiesti per la condotta propria dei reati commissivi, osservando anzi che l’affievolimento della nozione di
causa penalmente rilevante finisce per accentuare nei reati omissivi impropri, pur positivamente costruiti in
riferimento a ipotesi-base di reati di danno, il disvalore della condotta, rispetto alla quale l’evento degrada a
mera condizione obiettiva di punibilità e il reato di danno a reato di pericolo. Con grave violazione dei principi
di legalità, tassatività e tipicità della fattispecie criminosa e della garanzia di responsabilità personale (Cost.,
art. 25, comma 2 e 27, comma 1), per essere attribuito all’agente come fatto proprio un evento “forse”, non
“certamente”, cagionato dal suo comportamento.
5. - Superato quell’orientamento che si sostanzia in pratica nella “volatilizzazione” del nesso eziologico, il
contrasto giurisprudenziale segnalato dalla Sezione remittente verte, a ben vedere, sui criteri di
determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale, domandandosi, con
particolare riferimento ai delitti omissivi impropri nell’esercizio dell’attività medico-churgica, quale sia il grado
di probabilità richiesto quanto all’efficacia impeditiva e salvifica del comportamento alternativo, omesso ma
supposto come realizzato, rispetto al singolo evento lesivo.
Non é messo dunque in crisi lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità, bensì la sua concreta
verificabilità processuale: ciò in quanto i confini della “elevata o alta credibilità razionale” del condizionamento
necessario, postulata dal modello di sussunzione sotto leggi scientifiche, non sono affatto definiti dalla
medesima legge di copertura.
Dalle prassi giurisprudenziali nel settore indicato emerge che il giudice impiega largamente, spesso
tacitamente, generalizzazioni del senso comune, massime d’esperienza, enunciati di leggi biologiche,
chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento
storico. Di talché, secondo un primo indirizzo interpretativo, le accentuate difficoltà probatorie, il valore
meramente probabilistico della spiegazione e il paventato deficit di efficacia esplicativa del classico
paradigma, quando si tratti di verificare profili omissivi e strettamente ipotetici del decorso causale,
legittimerebbero un affievolimento dell’obbligo del giudice di pervenire ad un accertamento rigoroso della
causalità. In considerazione del valore primario del bene giuridico protetto in materia di trattamenti terapeutici
e chirurgici, dovrebbe pertanto riconoscersi appagante valenza persuasiva a “serie ed apprezzabili
probabilità di successo” (anche se “limitate” e con ridotti coefficienti, talora indicati in misura addirittura
inferiore al 50%) dell’ipotetico comportamento doveroso, omesso ma supposto mentalmente come realizzato,
34
Scheda di giurisprudenza n. 4 sull’assunto che “quando è in gioco la vita umana anche poche probabilità di sopravvivenza rendono
necessario l’intervento del medico”.
Le Sezioni Unite non condividono questa soluzione, pure rappresentativa del tradizionale, ormai ventennale
e prevalente orientamento della Sezione Quarta (cfr. ex plurimis, almeno a partire da Sez. IV, 7.1.1983,
Melis, le citate sentenze Ziliotto, Prinzivalli, Pasolini, D’Erme, Oria, Silvestri, De Donato, De Giovanni, Presta)
poiché, com’è stato sottolineato dall’opposto, più recente e menzionato indirizzo giurisprudenziale (Sez. fer.,
Casaccio; Sez. IV, Baltrocchi, Musto, Di Cintio, Covili, Sgarbi, Turco, Trunfio, Orlando), con la tralaticia
formula delle “serie ed apprezzabili probabilità di successo” dell’ipotetico intervento salvifico del medico si
finisce per esprimere coefficienti di “probabilità” indeterminati, mutevoli, manipolabili dall’interprete, talora
attestati su standard davvero esigui: così sovrapponendosi aspetti deontologici e di colpa professionale per
violazione del principio di precauzione a scelte politico-legislative dettate in funzione degli scopi della
repressione penale ed al problema, strutturalmente distinto, dell’accertamento degli elementi costitutivi della
fattispecie criminosa tipica.
Né va sottaciuto che dall’esame della giurisprudenza di settore emerge che in non pochi casi, sebbene
qualificati in termini di causalità omissiva per mancato impedimento dell’evento, non si è tuttavia in presenza
di effettive, radicali, omissioni da parte del medico. Infatti, talora si verte in tema di condotte commissive
colpose, connotate da gravi errori di diagnosi e terapia, produttive di per sé dell’evento lesivo, che è per ciò
sicuramente attribuibile al soggetto come fatto proprio; altre volte trattasi di condotte eterogenee e
interagenti, in parte attive e in parte omissive per la mancata attivazione di condizioni negative o impeditive.
Ipotesi queste per le quali, nella ricostruzione del fatto lesivo e nell’indagine controfattuale sull’evitabilità
dell’evento, la giurisprudenza spesso confonde la componente omissiva dell’inosservanza delle regole
cautelari, attinente ai profili di “colpa” del garante, rispetto all’ambito - invero prioritario - della spiegazione e
dell’imputazione causale.
6. - È stato acutamente osservato in dottrina che il processo tende con le sue regole ad esercitare un
potenziale dominio sulle categorie del diritto sostantivo e che la laboriosità del procedimento di ricostruzione
probatoria della tipicità dell’elemento oggettivo del reato coinvolge la tenuta sostanziale dell’istituto, oggetto
della prova, scardinandone le caratteristiche dogmatiche e insidiando la tipicità della fattispecie criminosa.
Ma pretese difficoltà di prova, ad avviso delle Sezioni Unite, non possono mai legittimare un’attenuazione del
rigore nell’accertamento del nesso di condizionamento necessario e, con essa, una nozione “debole” della
causalità che, collocandosi ancora sul terreno della teoria, ripudiata dal vigente sistema penale,
dell’”aumento del rischio”, finirebbe per comportare un’abnorme espansione della responsabilità per omesso
impedimento dell’evento, in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di
responsabilità per fatto proprio.
Deve tuttavia riconoscersi che la definizione del concetto di causa penalmente rilevante si rivela
significativamente debitrice nei confronti del momento di accertamento processuale, il quale resta decisivo
per la decodificazione, nei termini effettuali, dei decorsi causali rispetto al singolo evento, soprattutto in
presenza dei complessi fenomeni di “causazione multipla” legati al moderno sviluppo delle attività.
Il processo penale, passaggio cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale del fatto di reato, appare
invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente
inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e
dalla formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo
dell’”abduzione”), rispetto ai quali i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per
intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell’argomento “deduttivo”, da ulteriori elementi
conoscitivi estranei alle premesse stesse.
D’altra parte, lo stesso modello condizionalistico orientato secondo leggi scientifiche sottintende il distacco da
una spiegazione di tipo puramente deduttivo, che implicherebbe un’impossibile conoscenza di tutti gli
antecedenti sinergicamente inseriti nella catena causale e di tutte le leggi pertinenti da parte del giudice, il
quale ricorre invece, nella premessa minore del ragionamento, ad una serie di “assunzioni tacite”,
35
Parte generale presupponendo come presenti determinate “condizioni iniziali” e “di contorno”, spazialmente contigue e
temporalmente continue, non conosciute o soltanto congetturate, sulla base delle quali, “ceteris paribus”,
mantiene validità l’impiego della legge stessa. E, poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie
attraverso le quali la causa produce il suo effetto, né procedere ad una spiegazione fondata su una serie
continua di eventi, l’ipotesi ricostruttiva formulata in partenza sul nesso di condizionamento tra condotta
umana e singolo evento potrà essere riconosciuta fondata soltanto con una quantità di precisazioni e purché
sia ragionevolmente da escludere l’intervento di un diverso ed alternativo decorso causale. Di talché, ove si
ripudiasse la natura preminentemente induttiva dell’accertamento in giudizio e si pretendesse comunque una
spiegazione causale di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica “certezza
assoluta”, si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori
nevralgici per la tutela di beni primari. Tutto ciò significa che il giudice, pur dovendo accertare ex post,
inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell’intera evidenza probatoria disponibile, che
la condotta dell’agente “è” (non “può essere”) condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato
nell’operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, conducenti
conclusivamente, all’esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di
responsabilità caratterizzato da “alto grado di credibilità razionale” o “conferma” dell’ipotesi formulata sullo
specifico fatto da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di “elevata probabilità
logica” o “probabilità prossima alla - confinante con la - certezza”.
7. - Orbene, il modello nomologico può assolvere nel processo penale allo scopo esplicativo della causalità
omissiva tanto meglio quanto più è alto il grado di probabilità di cui l’explanans è portatore, ma non è
sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche
universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico “prossimo ad 1”, cioè alla
“certezza”, quanto all’efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento.
Soprattutto in contesti, come quello della medicina biologica e clinica, cui non appartengono per definizione
parametri di correlazione dotati di tale valore per la complessa rete degli antecedenti già in fieri, sui quali
s’innesta la condotta omissiva del medico, per la dubbia decifrabilità di tutti gli anelli della catena eziopatogenetica dei fenomeni morbosi e, di conseguenza, per le obiettive difficoltà della diagnosi differenziale,
che costruisce il nodo nevralgico della criteriologia medico-legale in tema di rapporto di causalità.
È indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge
statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche),
impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella
fattispecie concreta. Ma nulla esclude che anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto
secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel
caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento
giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi
interpretativi dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare nel settore in esame), pur configurando
un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi,
pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel caso
concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi la “attendibilità” in riferimento al singolo evento e
all’evidenza disponibile.
8. - In definitiva, con il termine “alta o elevata credibilità razionale” dell’accertamento giudiziale, non s’intende
fare riferimento al parametro nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera
relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente come tale alla struttura interna del rapporto di
causalità, bensì ai profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all’evidenza disponibile e
alle circostanze del caso concreto: non essendo consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente
- dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del
rapporto di causalità. La moderna dottrina che ha approfondito la teoria della prova dei fatti giuridici ha infatti
precisato che, mentre la “probabilità statistica” attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza
36
Scheda di giurisprudenza n. 4 relativa nella successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell’indagine causale), la
“probabilità logica”, seguendo l’incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di
conferma dell’ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla
base dell’intera evidenza disponibile, dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e
della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale (in tal senso, cfr. anche Cass., Sez. IV,
5.10.1999, Hariolf, rv. 216219; 30.3.2000, Camposano, rv. 219426; 15.11.2001, Puddu; 23.1.2002, Orlando,
cit.). Si osserva in proposito che, se nelle scienze naturali la spiegazione statistica presenta spesso un
carattere quantitativo, per le scienze sociali come il diritto - ove il relatum è costituito da un comportamento
umano - appare, per contro, inadeguato esprimere il grado di corroborazione dell’explanandum e il risultato
della stima probabilistica mediante cristallizzati coefficienti numerici, piuttosto che enunciare gli stessi in
termini qualitativi.
Partendo dunque dallo specifico punto di vista che interessa il giurista, le Sezioni Unite, nel condividere le
argomentate riflessioni del P.G. requirente, ritengono, con particolare riguardo ai decorsi causali ipotetici,
complessi o alternativi, che rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza giudiziale stabilire se la
postulata connessione nomologica, che forma la base per il libero convincimento del giudice, ma non
esaurisce di per se stessa la verifica esplicativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba
considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere quel risultato di “certezza processuale” che, all’esito del
ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa
omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato, ma
(nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva.
D’altra parte, poiché la condizione “necessaria” si configura come requisito oggettivo della fattispecie
criminosa, non possono non valere per essa gli identici criteri di accertamento e di rigore dimostrativo che il
giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato.
Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di
prova indiziaria dall’art. 192 comma 2 c.p.p. (il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola
stabilita per la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima disposizione, nonché in
quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall’art. 546, comma 1 lett. e c.p.p.),
deve condurre, perché sia valorizzata la funzione ascrittiva dell’imputazione causale, alla conclusione
caratterizzata da un “alto grado di credibilità razionale”, quindi alla “certezza processuale”, che, esclusa
l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei
dati ontologici, è stata condizione “necessaria” dell’evento, attribuibile per ciò all’agente come fatto proprio.
Ex adverso, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole
dubbio, fondato su specifici elementi che in base all’evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in
ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della singola
condotta omissiva all’interno della rete di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell’ipotesi
prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio stabilito dall’art. 530 comma 2 c.p.p., secondo il canone di
garanzia “in dubio pro reo”. E non, viceversa, la disarticolazione del concetto di causa penalmente rilevante
che, per tale via, finirebbe per regredire ad una contraddittoria nozione di “necessità” graduabile in
coefficienti numerici.
9. - In ordine al problema dell’accertamento del rapporto di causalità, con particolare riguardo alla categoria
dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore dell’attività medico-chirurgica, devono essere pertanto
enunciati, ai sensi dell’art. 173.3 n. att. c.p.p., i seguenti principi di diritto:
a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base
di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che,
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non
si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore
intensità lesiva.
b) Non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la
37
Parte generale conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne
la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che,
all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti
giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione
necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”.
c) L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso
causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della
condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo,
comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
Va infine ribadito che alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato il compito di
controllare
retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la c.d. giustificazione esterna - della
decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze
formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il
contesto giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il
giudizio di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da provare.
[...Omissis...]
38
Scheda di giurisprudenza n. 5 Scheda di giurisprudenza n. 5
Offensività e reati di falso
TRACCIA
Tizio, raggiunto da ordine di esecuzione di una condanna complessiva a due anni e sei mesi di reclusione e
contestuale decreto di sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., si rivolge ad un avvocato per
ottenere assistenza per formulare istanza di affidamento in prova ai servizi sociali.
A tal fine ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza l’ammissione al gratuito patrocinio, attestando a tal fine di
non avere alcun reddito e di non essere proprietario di alcun bene immobile.
Il Tribunale, contestualmente all’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 76 e ss. del TU sulle
spese di giustizia, ordinava indagini sul reddito di Tizio all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Proprio all’esito di tali indagini, si verificò che era titolare di un immobile (un piccolo appartamento oggetto di
un lascito ereditario) e di autovettura.
Denunciata alla Procura della Repubblica competente ratione loci, veniva iscritto il suo nome nel registro
degli indagati per il delitto aggravato di cui all’art. 95 del T.U. anzidetto. Proprio per tale notizia di reato a
Tizio veniva notificato l’avviso ex art. 415-bis c.p.p.
Tizio, preoccupato per le conseguenze penali della falsità, si rivolgeva ad un legale per avere delucidazioni,
rappresentando come, per vero, neppure considerando gli elementi patrimoniali accertati sarebbe risultato
superato il limite reddituale di 10.776,33 euro normativamente previsto. Il reddito di Tizio, per come accertato
dall’Agenzia delle Entrate per l’anno in questione, risulta di appena 7 mila euro circa.
Il candidato, premessi cenni sul principio di offensività con particolare riferimento ai delitti di falso, rediga
motivato parere
1. La questione.
In ragione del principio di offensività (nullun crimen sine iniuria), corollario del più generale
principio del neminem laedere (MANTOVANI), la sanzione penale è subordinata all’offesa di un
bene giuridico, sia nella forma della lesione, intesa quale nocumento effettivo, sia nella forma
dell’esposizione a pericolo, intesa quale nocumento potenziale. Il principio de quo rinviene la sua
ratio nell’esigenza di evitare che il legislatore possa incriminare ed il giudice condannare
atteggiamenti interiori, semplici opinioni o mere condotte di vita (in quest’ottica il principio di
offensività presuppone ed integra il principio di materialità) ed è desumibile sia da norme di
rango costituzionale (artt. 13, 21, 25, co. 2 e 27) sia da norme di rango primario. In particolare,
è l’art. 49 c.p. a fornire rilievo codicistico al principio in parola, escludendo la punibilità quando
per “l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento
dannoso o pericoloso”: disciplina, in altri termini, il c.d. reato impossibile.
Tralasciando la diatriba sorta in dottrina in ordine all’interpretazione della suddetta norma (la
dottrina era infatti divisa tra la tesi del doppione in negativo del tentativo, la teoria della concezione
realistica del reato ed un orientamento intermedio) e prendendo atto che il dibattito si è ormai
orientato in favore della tesi della concezione realistica del reato, pur se temperata al fine di
garantire il rispetto del principio di legalità, questa esige che, ai fini della consumazione del delitto,
si verifichi l’offesa al bene protetto. A ciò consegue che, per quel che concerne il reato
impossibile prima citato, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (ex plurimis, Cass. pen.,
39
Parte generale Sez. I, 6 marzo 2007, n. 22722; Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2014, n. 35669) pretende che si
accerti l’inidoneità dell’azione attraverso un giudizio ex ante ed in concreto, volto a verificare
l’incapacità assoluta, intrinseca ed originaria dell’azione di cagionare l’evento offensivo. Quanto
alle ipotesi d’inesistenza dell’oggetto, è da lungo tempo prevalente la tesi secondo cui
l’inesistenza dell’oggetto idonea ad escludere la punibilità dell’agente è quella in rerum natura,
assoluta e originaria, irrilevante essendo il dato della mancanza semplicemente temporanea o
accidentale dello stesso.
2. Gli orientamenti in tema di reati di falso.
I reati di falso, banco di applicazione del reato impossibile, hanno posto il problema di
verificare la rilevanza penale della condotta, appunto, falsificatoria che sia inidonea a
ingannare il destinatario dell’atto. La condotta in tal senso inidonea viene individuata in relazione
alle falsità c.d. tollerabili, nell’ambito delle quali bisogna distinguere tra falso grossolano,
innocuo ed inutile.
2.1. Il falso grossolano.
Si ha falso grossolano qualora la falsità risulta immediatamente riconoscibile da non poter
far cadere in errore alcuna persona, così che sia impossibile e non soltanto improbabile l’offesa
alla pubblica fede; così, risulta non punibile solo il falso grossolano “facilmente riconoscibile ictu
oculi, anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda una certa
attenzione per il riconoscimento della falsificazione” (Cass. pen., Sez. V, 18 ottobre 2013, n. 634).
In particolare, tale falso si distingue dal falso innocuo, di cui infra, “sussistendo la prima di tali
ipotesi quando la contraffazione sia talmente maldestra ed evidente da impedire che
chicchessia possa essere tratto in inganno mentre ricorre la seconda ipotesi quando la
contraffazione, pur non immediatamente percepibile come tale, si caratterizzi per la sua
irrilevanza ai fini della funzionalità dell’atto” (Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 51166).
2.2. Il falso innocuo.
Si ha falso innocuo quando la contraffazione o l’alterazione risulti inoffensiva per la sua
concreta inidoneità ad aggredire l’interesse tutelato; a differenza del falso grossolano, che non
lede il bene protetto perché inidoneo a trarre in inganno, il falso innocuo, sebbene astrattamente
idoneo ad ingannare, non lo è in concreto, in virtù di un accertamento concreto dei possibili
effetti del falso su una determinata situazione giuridica. La giurisprudenza ha di recente affermato
che “in tema di falsità in atti, ricorre il c.d. falso innocuo nei casi in cui l’infedele attestazione
(nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini
del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo
l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto” (Cass. pen., Sez.
V, 17 ottobre 2013, n. 2809).
40
Scheda di giurisprudenza n. 5 2.3. Il falso inutile.
Il falso inutile configura un’ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell’oggetto, la falsità
investendo un atto o una parte di esso privi di valenza probatoria (Cass. pen., Sez. V, 5 luglio
1990, n. 11498).
3. La giurisprudenza di legittimità in relazione ad un caso particolare: Il
falso c.d. tollerabile e le condizioni per accedere al gratuito patrocinio a
spese dello Sato.
La Corte di Cassazione recentemente ha composto il dibattito in ordine alla configurabilità del
reato di cui all’art. 95, d.P.R. n. 115/2002, che prevede un’ipotesi speciale del delitto di falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico previsto dall’art. 483 c.p. e che punisce la
condotta di chi affermi dati falsi ovvero ometta dati veri nella dichiarazione sostituiva di
certificazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nelle altre comunicazioni
per il mantenimento del beneficio medesimo. In particolare, il quesito che ha alimentato il
contrasto giurisprudenziale concerneva lo stabilire se le dichiarazioni mendaci integrassero o meno
il reato de quo solo quando si sostanzino nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore, o pari, a
quello fissato quale soglia di ammissibilità al gratuito patrocinio, oppure se la rilevanza penale delle
stesse sia del tutto indipendente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di ammissibilità e,
pertanto, le dichiarazioni mendaci sono punibili in quanto tali, anche qualora il reddito accertato non
superi la soglia di riferimento.
3.1. Il primo orientamento:
dichiarazione mendace.
Esclusione
della
punibilità
della
Per un primo orientamento (Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2007, n. 15139), proprio in
applicazione delle categorie del falso innocuo e del falso inutile, la Corte di legittimità aveva
ritenuto di dover escludere la punibilità di dichiarazioni false ogni volta in cui queste non
avessero in concreto inciso sull’esistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito
patrocinio a spese dello Stato.
1° Argomento: valorizzazione del principio di offensività. In ossequio a tale principio,
una volta acclarato che i redditi non dichiarati non avrebbero comunque superato la soglia prevista
dalla legge, la Suprema Corte aveva escluso la punibilità del soggetto agente in relazione
all’inoffensività della condotta posta in essere dal medesimo.
3.2. Il secondo orientamento: Punibilità della dichiarazione mendace.
Un secondo orientamento, per altro predominante in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. V, 9 ottobre
2007, n. 42060; Cass. pen., Sez. Un., 27 novembre 2008, n. 6591; Cass. pen., Sez. fer., 13
settembre 2011 n. 34399), riteneva invece che il reato di cui all’art. 95, d.P.R. 115/2002, sarebbe
stato integrato a prescindere dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per
l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
41
Parte generale 1° Argomento: valorizzazione della struttura del reato. Il delitto de quo, in effetti, è reato
di mera condotta, che non subordina la rilevanza dell’offesa della pubblica fede al fine
patrimoniale dell’atto falso; per tale ragione, “la falsità non può ritenersi innocua secondo il
parametro dell’evento, men che inutile secondo il parametro del dolo. (…) La punibilità del reato di
mera condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà verso le
istituzioni” (Cass. pen., Sez. Un., 27 novembre 2008, n. 6591).
3.1. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Punibilità della
dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 95, d.P.R. n. 115/2002.
La Corte di legittimità (Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2012, n. 25409), in un recente intervento, ha
nuovamente sposato la tesi della punibilità del reato in parola, facendo propri gli argomenti posti
alla base e ribandendo che “l’inganno potenziale della falsa attestazione di dati necessari per
determinare al momento dell’istanza le condizioni di reddito sussiste quand’anche le
alterazioni od omissioni di fatto veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di
reddito, previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio”.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene fondata l’accusa di delitto aggravato di cui all’art. 95, d.P.R. n. 115/2002, nei
confronti di Tizio; per vero, pur non superando di fatto il limite reddituale previsto per l’ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato (limite individuato dalla normativa richiamata in 10.776,
33 euro, attestandosi, invece, il reddito annuale di Tizio sulla somma di appena 7000 euro), cionondimeno,
alla luce della più recente giurisprudenza, deve ritenersi interato il reato per il solo fatto di aver posto in
essere una falsità in atti, venendo meno al dovere di lealtà verso le istituzioni.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. IV, 3 maggio 2012, n. 25409
Estratto
[...Omissis...]
Il Tribunale di Cagliari revocava di ufficio, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il provvedimento con il quale
C. R. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato: secondo gli accertamenti svolti dall’ufficio
finanziario, i redditi del nucleo familiare della C. relativi al 2007 sarebbero stati pari a Euro 11.929,00 e quindi
superiori al limite per il beneficio.
Ricorre per cassazione la C. osservando che: a) nell’istanza di ammissione era stato precisato che il reddito
era pari a Euro 0,0 perchè la C. era stata licenziata con lettera del 18 maggio 2007 allegata all’istanza
stessa; b) il licenziamento era avvenuto dopo la presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi e prima
della presentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, e quindi il giudice non avrebbe dovuto
tener conto del reddito dichiarato nell’anno precedente in quanto non più corrispondente alla realtà.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
42
Scheda di giurisprudenza n. 5 Il principio di diritto evocato dalla ricorrente - secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, sono
rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato - non risulta pertinente nella
concreta fattispecie. Detto principio, infatti, presuppone pur sempre una (precedente) fedele dichiarazione
reddituale, corrispondente, cioè, alla effettiva condizione dell’istante. Nel caso in esame, invece, per come
accertato dall’Agenzia delle Entrate, la C. aveva reso una dichiarazione rivelatasi oggettivamente non
corrispondente alla effettiva sua situazione reddituale. Giova ricordare la decisione n. 6591/09 (cc
27/11/2008) delle Sezioni Unite - nell’occasione chiamate a pronunciarsi in ordine agli elementi costitutivi del
reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 - con la quale è stato precisato che la falsità delle indicazioni
contenute nell’autocertificazione deve ritenersi connessa “all’ammissibilità dell’istanza non a quella del
beneficio (art. 96, comma 1), perchè solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel
merito, allo stato”. Dunque, non assume importanza, in presenza di una dichiarazione rivelatasi non
corrispondente alla reale situazione reddituale, nemmeno l’effettivo ammontare del reddito; in tal senso si
sono ancora esplicitamente espresse le Sezioni Unite con la richiamata decisione, laddove hanno avuto
modo di precisare, in motivazione, testualmente quanto segue:
“L’inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell’istanza le
condizioni di reddito, sussiste quand’anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il
superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio”.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. Un., 27 novembre 2008, n. 6591
Estratto
[...Omissis...]
1 - La questione controversa è “se il reato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 sia integrato da falsità
od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l’attestazione di reddito necessarie per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non dovesse
superare la soglia minima prevista dalla legge”.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, incorporando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’art. 74 e
ss., del Testo Unico, ripete nell’art. 95 la norma incriminatrice della L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 5. Questa
legge, a sua volta, aveva ripetuto la disposizione del D.P.R. 30 luglio 1990, n. 217, art. 5, comma 7, ma non
anche quella del comma 2 cit. art., che specificava le allegazioni all’istanza di gratuito patrocinio.
Il contrasto, come dimostra l’analisi, è sorto in effetti per questa ragione, e s’incentra bensì sul falso nella
dichiarazione sostitutiva contenuta nell’istanza di ammissione al beneficio, ma involge la ratio complessiva
della norma incriminatrice.
1.1- Cass. Sez. 5^ Bevilacqua, sopra citata, ha anzitutto affermato che la norma del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 95, immutata dal ‘90, è speciale rispetto a quella di cui all’art. 483 c.p. e che l’art. 95 rinvia all’art. 79,
comma 1, lett. b), c) e d), che incorpora nella fattispecie criminosa solo alcune condotte di alterazione del
vero.
Queste condotte si riassumono nella falsa attestazione di avere un reddito complessivo inferiore a quello
fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità, ovvero nella negazione o nascondimento di mutamenti
significativi per esso intervenuti, ai fini della valutazione dell’eventuale superamento della stessa soglia.
Pertanto non rileva qualsiasi infedele attestazione, ma solo quelle che abbiano, quale conseguenza,
l’inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione sostitutiva (lett. c). E tra esse non rientrano
quelle che occultino redditi il cui ammontare non implichi superamento del limite, che esclude il diritto
43
Parte generale all’ammissione.
Nello stesso solco si calano Cass. Sez. 5^ Salvaggio, 11.5.06 n. 21194, rv. 234207; Sez. 5^ Abrunzo,
20.12.07 n. 4467/08, rv. 238880; Sez. 5^ Gallo, n. 12019 del 19.2.08, rv. 239126; Sez. 5^ Martorana, n.
15139 del 22.1.07, rv. 236143 e da ultimo Sez. 5^ Caprarotta, n. 38759/08. Le sentenze, accentuando la
finalità dell’attestazione, affermano il falso inidoneo all’inganno, se il reddito è comunque inferiore alla soglia
di ammissibilità al beneficio. Sez. 5^, 11.12.07 n. 5532/08, Goman, rv. 239099 richiama invece la categoria
del falso inutile o innocuo.
1.2 - Cass. Sez. 3^, Contino, n. 28340 del 20.6.2006 (rv. 236267) ha affermato invece che, in caso di falsa
attestazione, il reato si ravvisa anche se il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito
l’ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio per più ragioni.
Anzitutto, conformandosi a Sez. 1^, Mollica, n. 14403 del 25.1.01, rv. 218932, che tanto aveva affermato
prima dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2001 con riferimento alle dichiarazioni relative alle variazioni
del reddito, ha rilevato che la disciplina in materia esclude ogni discrezionalità da parte del soggetto da
ammettere al beneficio.
Ha quindi rammentato che il falso, che non concerne solo la dichiarazione sostitutiva, ha ragione propria di
punibilità nell’oggetto giuridico “pubblica fede”.
Nella specie l’art. 95 prevede elemento psicologico del reato il dolo generico e “l’ottenimento o il
mantenimento” del beneficio solo circostanza aggravante. Di più, in caso di condanna per il delitto aggravato,
dispone revoca ex tunc del beneficio già concesso. La revoca del beneficio è parallelamente prevista dall’art.
112 per l’omissione di comunicazioni in termini di eventuali variazioni dei limiti di reddito, per quanto non tali
da implicare il superamento delle condizioni per il mantenimento.
L’insieme impedisce di ritenere irrilevante che il reddito accertato non superi il tetto previsto dalla legge, sia
per l’ammissione che per il mantenimento del beneficio.
All’indirizzo hanno dato seguito Sez. 5^, 6.3.07 n. 13828, Palamara (rv. 236532) e Sez. 5^, 24.1.08 n. 13309,
Marino, rv. 239387, che ha rimarcato in particolare le prescrizioni dell’art. 96 D.P.R. cit., circa i fondati motivi
per cui il magistrato respinge l’istanza di ammissione al beneficio, e dell’art. 98, secondo il quale dispone la
verifica di esattezza dell’ammontare del reddito attestato, dopo l’ammissione al beneficio.
1.3 - In posizione in effetti intermedia si pone Cass., P.G. in proc. Scumaci, Sez. 4^, 10.10 2007 n. 41306, rv.
237732, che formula un’eccezione al secondo indirizzo, affermando che la dichiarazione sostitutiva di cui
all’art. 79, richiamata nell’art. 95, concerne solo i redditi.
Spiega che la L. n. 134 del 2001, art. 5, incorporato nel D.P.R. n. 115 del 2002 ha abrogato la previsione
della L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 2. Pertanto la dichiarazione delle condizioni di reddito non concerne
più i diritti reali su immobili e mobili registrati, ed il reato non sussiste se in proposito è falsa (conf. Sez. 5,
Polito ed a., n. 26031/08).
2 - La soluzione in effetti implica anzitutto verifica dell’evoluzione normativa.
La L. n. 134 del 2001, le cui disposizioni sono state incorporate nel T.U. sulle spese di giustizia, ha bensì
soppresso l’obbligo di cui al L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 2, di specifiche allegazioni all’istanza di
ammissione al beneficio.
Ma il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3 prevede in via surrogatoria che il consiglio forense
competente a provvedere in via anticipata, e quindi il giudice possano chiedere all’istante, a pena di
inammissibilità dell’istanza, di produrre documentazione.
Di più l’art. 96 prevede che, ammessa l’istanza, prima di decidere sull’ammissione al beneficio, il magistrato
può chiedere verifiche tempestive dei dati offertigli alla G. di Finanza, non la verifica dell’esattezza del reddito
attestato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria. Questo compito è
affidato all’ufficio finanziario solo dopo che il giudice ha ammesso l’istante al beneficio e cioè deciso
l’accoglimento (art. 98). All’evidenza allegazioni e verifiche provvisorie sono condizionate dai tempi (si pensi
all’istanza d’imputato detenuto).
Perciò, dal 2001, la legge inversamente accentua l’onere di attestazione dell’istante a fine di prova delle sue
44
Scheda di giurisprudenza n. 5 condizioni di reddito, qualificando sostitutiva la dichiarazione incorporata nell’istanza, con il richiamo al
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1 lett. c, nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), cui
rinvia l’art. 95. E, nel contempo, gli lascia la possibilità, senza obbligo, di avvalersi di moduli predisposti.
All’uopo l’art. 79, comma 1, lett. “c” prevede che la dichiarazione attesti la “sussistenza delle condizioni di
reddito previste per l’ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini,
determinato secondo le modalità dell’art. 76”. E l’art. 76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF. I singoli
dati reddituali sono dunque oggetto indiscriminato di attestazione, secondo il modello tipico recepito. La
ragione di specifica determinazione e collega inoltre al rinvio dell’art. 95 anche all’art. 79, comma 1, lett. b.
La lettera “b” prescrive l’indicazione delle generalità proprie e dei componenti della famiglia anagrafica e
relativi codici fiscali. E si connette all’art. 92, che eleva il limite di reddito per l’ammissione, in quantità fissa
per ognuno dei conviventi che non abbia reddito proprio, il che significa per contro che va sempre indicato il
reddito dei conviventi. La lettera “d” afferma l’impegno a comunicare variazioni rilevanti dei limiti di reddito
nell’anno precedente, la qualcosa presume appunto l’indicazione di ogni fonte, anche potenziale, di reddito. Il
corollario è che i diritti reali su immobili devono essere dichiarati, non solo se fonti attuali (ad es.
usufrutto), ma anche solo potenziali di reddito (ad es. nuda proprietà), perciò suscettibili di variazioni da
comunicare per impegno assunto nell’istanza, come di seguito si precisa.
2.1 - Questa analisi sommaria del procedimento dimostra che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la
falsità della “dichiarazione sostitutiva” al modello dell’art. 483 c.p., la cala in effetti in una previsione
complessa, già per il suo tenore ed il correlato contenuto dell’istanza a pena di inammissibilità (v. l’esordio
dell’art. 79).
Difatti la dichiarazione non ha per sè ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al
beneficio, bensì i dati da cui l’istante la induce C determina”) quale risultato, suscettibile di valutazione
discrezionale seppur vincolata dell’organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si
modella.
E, posto che la dichiarazione sostitutiva è incriminabile per la falsità (commissiva od omissiva, v. oltre) dei
dati che servono alla determinazione, s’intende il vincolo di incriminazione al principio di S.U. P.G. in proc.
Proietti ed a., n. 1827/95 - rv. 200117, per cui la falsità si configura nella “parte descrittiva” dell’atto, salvo
espressa eccettuazione dei fatti da attestare.
La singolarità della dichiarazione sostitutiva nel caso è inoltre dimostrata dal rilievo che la legge che
autorizza il privato attestazione tipica a pena di falso (S.U. Lucarotti, n. 6/99 e Gabrielli 28/00), di solito
prevede che la riversi in atto pubblico a pubblico ufficiale, che si limiti ad attestare nell’atto di averla ricevuta.
E, in ragione del fine dell’atto, la stessa legge pone al privato onere di allegarlo ad istanza diretta a diverso
organo, che adotta provvedimento sulla premessa del fatto attestato.
Il D.P.R. n. 115 del 2002 unifica la doppia azione, perchè l’interessato al beneficio rende la dichiarazione con
valenza attestativa nell’istanza rivolta al magistrato che la contiene a pena di inammissibilità (art. 96). E fa
conto che il magistrato, dovendo subito decidere, possa solo chiedere documentazione o verifica degl’indici
fornitigli, non altro.
In questa luce la norma penale sottolinea la necessità della compiuta ed affidabile informazione del
destinatario che, a fronte della complessità del tenore dell’istanza cui è speculare la valutazione da svolgere,
ha urgenzati decidere.
La necessità di dettaglio del tenore dichiarativo dell’istanza è significato in maniera risolutiva dal D.P.R. n.
112 del 2002, art. 96, comma 2, che prescrive: “il magistrato... respinge l’istanza se vi sono fondati motivi di
ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni degli artt. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle
condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”. Il che, si è visto, connette
tra l’altro le previsioni dell’art. 79, comma 1, lett. b e c, in duplice senso all’art. 92.
La conclusione evidente è che la dichiarazione deve contenere senza eccezione i dati eventualmente già
riversati nella diversa dichiarazione a fini IRPEF relativa ai redditi dell’anno precedente, in tal caso da
allegare, salvo la possibilità di prendere in considerazione l’istanza di ammissione al beneficio, di chi non
45
Parte generale l’abbia presentata.
2.2 - Passando ora alla struttura del reato, risulta assorbente il rilievo che la locuzione “falsità od omissioni”
non distingue il falso dalle altre condotte cui segue evento di pericolo, ed oltre di danno. Il falso è reato
commissivo proprio, seppure consiste in omessa attestazione di fatto vero, sicchè la ratio di incriminazione,
già per lettera, non può essere confinata nell’ipotesi che ha dato luogo al contrasto.
L’incriminazione del reato di pura condotta, commissivo od omissivo che sia, ha funzione di sbarramento
dell’evento di danno ulteriore.
La funzione si è visto è accentuata dal collegamento del dovere di attestazione nell’istanza alla dichiarazione
IRPEF dell’anno precedente, che può non essere stata rilasciata, e quindi dalla possibilità di respingere la
stessa istanza allo stato per le attività, le condizioni di vita personali e familiari, ed il tenore di vita di chi
chiede l’ammissione al beneficio.
Sicchè l’incriminazione si correla da un lato al generale “principio antielusivo” che, affermato da questa Corte
(v. da ultimo, Cass. Civ. n. 10257/08 e n. 25374/08), s’incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’art.
53 Cost., e perciò dell’art. 3. E si correla, dall’altro, all’art. 24, comma 3 ulteriore corollario dell’art. 3 del Patto
fondamentale, in osservanza del quale l’art. 98 c.p.p. prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a
spese dello Stato.
Dal che è evidente che la punibilità del reato di pura condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto
ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni.
È dunque apodittico il rilievo di sproporzione della gravità della pena prevista dall’art. 95 D.P.R. cit. per
un’ipotesi speciale del reato di cui all’art. 483 c.p., in quanto analoga a quella prevista per la truffa aggravata.
E non è in particolare giustificata l’implicazione d’innocuità o inutilità della falsità, correlata ad una soglia di
ammissione al beneficio, che non risulta prevista dalla norma incriminatrice.
In genere l’innocuità del falso in un atto pubblico non va per sè ritenuta con riferimento all’uso che s’intende
fare del documento, che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare
estremi di reato diverso (come rileva la sentenza Contino, rifacendosi a Cass., Sez. 5, n. 11681/97, rv.
209266).
In ispecie la lettera dell’art. 95 non condiziona la rilevanza dell’offesa della pubblica fede al fine patrimoniale
dell’atto falso (cfr. Cass., S.U. Giordano ed a., n. 25887/03). Non opera, difatti, specifica addizione di
qualifica all’evento di pericolo, o all’intenzione di risultato dell’agente (dolo specifico), sicchè la falsità non può
ritenersi innocua secondo parametro dell’evento, men che inutile secondo parametro del dolo.
È questa la ragione di previsione dell’evento di danno come mera aggravante.
Nè la condizione di punibilità può desumersi dal richiamo dell’art. 95 all’art. 79, comma 1, lett. c, la cui
disposizione, si è visto, si combina con altre norme per rinvio espresso (artt. 76 e 92) o per rinvio implicito (v.
anzitutto la distinzione di ammissibilità dell’istanza, che contiene tra l’altro la dichiarazione, dall’ammissione
al beneficio od al rigetto dell’istanza in sè formalmente ammissibile, nell’art. 96).
È dunque esclusa qualsiasi esenzione categorica di legge (innocuità), fuori del parallelo con quanto è dovuto
nella dichiarazione IRPEF. La questione d’inidoneità è circoscritta nei limiti dell’art. 49 c.p., perciò diversa in
quanto sempre e solo di fatto. In concreto è possibile ritenere inidonea all’offesa taluna omessa, e per sè
falsa attestazione, quale quella di un diritto reale su mobile registrato. Ma va tenuto da conto che tale diritto
deve essere dichiarato, già perchè la titolarità del bene incide sulla valutazione del giudice, secondo il
parametro del tenore di vita, ed a maggior ragione se all’esercizio del diritto si connette uri attività economica,
altro metro decisivo per l’ammissione al beneficio (art. 96, comma 1).
Insomma se il reato concerne la parte determinativa della dichiarazione, che si connette al tenore della
dichiarazione IRPEF, giusto il principio premesso di S.U. P.G. in proc. Proietti, la valutazione d’inidoneità
all’inganno non può essere implicata dal rilievo che la determinazione non è stata fatta propria dal
magistrato, che abbia respinto l’istanza. L’inidoneità del falso o dell’omissione va apprezzata con riferimento
a quanto il magistrato potesse intendere, prima di decidere nel merito. E, a maggior ragione, l’inidoneità non
può desumersi dalla prova certa di sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione a beneficio, che si
46
Scheda di giurisprudenza n. 5 consegue dopo che il magistrato l’abbia disposta, per la verifica compiuta deferita all’ufficio finanziario (art.
98).
2.3 - Concludendo, la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (art. 95, art. 79, lett. c) è connessa
all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio (art. 96, comma 1), perchè solo l’istanza ammissibile
genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L’inganno potenziale, della falsa attestazione
di dati necessari per determinare al momento dell’istanza le condizioni di reddito, sussiste quand’anche le
alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto
dalla legge per l’ammissione al beneficio.
Pertanto, la questione riceve risposta affermativa, nel senso che il reato di pericolo si ravvisa se non
rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi
dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo
parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per
l’ammissione al beneficio.
Ogni altra questione è di fatto e, si è visto, pone in discussione cosa il magistrato potesse intendere allo stato
a stregua delle comunicazioni dovute, e per contro la volontà del privato di trarlo in inganno, in reato punibile
a titolo di dolo generico.
[...Omissis...]
47
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 6
Diffamazione e diritto alla libera espressione del pensiero
TRACCIA
Tizio, noto esponente politico dello schieramento di centro-sinistra, in occasione di un’intervista rilasciata ad
un rinomato quotidiano nazionale, riferisce al suo avversario, Caio, l’epiteto di ‘ex picchiatore fascista’.
Il medesimo giorno, a distanza di poche ore dalla conclusione dell’intervista giornalistica, Tizio inseriva
all’interno di un forum, appositamente dedicato al dibattito politico on line, un messaggio con cui
sostanzialmente riproduceva il contenuto di quanto già dichiarato al giornalista del noto quotidiano nazionale.
In codesto spazio virtuale, infatti, Tizio ribadiva che Caio era stato, durante la sua giovane militanza in partito
politico di destra, un “ex picchiatore fascista”.
L’attribuzione di tale appellativo traeva origine da quanto dichiarato dallo stesso Caio, durante un’intervista
rilasciata nel contesto di un programma di informazione politica del servizio pubblico radio televisivo; in quella
sede, infatti, lo stesso Caio, alludendo al suo passato politico, ammise apertamente di aver partecipato più
volte a violenti scontri di piazza caratterizzati dall’uso della forza fisica nell’ambito di una contrapposizione
frontale tra i giovani dell’estrema destra e giovani dell’estrema sinistra.
Va, tuttavia, posta in risalto la circostanza che Caio, nell’occasione, ebbe modo immediatamente di precisare
che, nell’ambito di quegli scontri violenti, egli ne uscì sempre soccombente, giammai vincitore, a motivo della
sua scarsa attitudine fisica alla lotta.
Quindi, Caio, apprendendo dalle pagine del noto quotidiano nazionale il fatto che Tizio gli avesse
espressamente attribuito l’appellativo di “ex picchiatore fascista”, nutrendo il pieno convincimento di essere
stato vittima di una condotta lesiva della propria reputazione, si rivolgeva ad un legale di fiducia,
conferendogli mandato affinché lo stesso sporgesse denuncia, e quindi chiedesse la giusta punizione di
Tizio.
Tizio, preoccupato dalle eventuali conseguenze penali della propria condotta si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di fiducia di Tizio, rediga motivato parere.
1. La questione.
Il dibattitto sul rapporto fra il reato di diffamazione e la libera espressione del pensiero nasce
in ragione del fatto che l’art. 51 c.p., nell’affermare “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un
dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude
la punibilità”, non indica quali siano i criteri per risolvere gli eventuali conflitti che possono
venire a crearsi fra le norme attributive di diritti.
È possibile infatti che valori costituzionalmente tutelati, quali nel caso di specie la reputazione
personale, la riservatezza, l’onore e la dignità personale (art. 2 Cost.) e la libera
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), vengano a scontarsi ed essendo entrambi posti sul
medesimo gradino non è possibile ricorrere ai criteri elaborati da giurisprudenza e dottrina per
stabilire quale sia l’interesse preponderante (criteri quali quello di specialità, quello cronologico ed
infine quello gerarchico): è necessario in tale evenienza operare un bilanciamento di interessi
da risolvere nel caso concreto che si pone dinanzi all’interprete.
A voler dare brevemente contezza della scriminante di cui all’art. 51 c.p., deve essere
evidenziato come la stessa rinvenga la sua ratio nel principio di non contradizione all’interno
48
Scheda di giurisprudenza n. 6 dell’ordinamento, principio per il quale non avrebbe senso consentire l’esercizio di un diritto e in
un secondo momento punire l’autore per gli atti posti in essere in attuazione del medesimo diritto;
la norma è espressione altresì della prevalenza accordata dall’ordinamento all’interesse di chi
agisce nell’esercizio di un diritto. L’operatività della scriminante in parola soffre tuttavia di
limiti sia interni (ricavabili dalla stessa norma attributiva del potere; limite interno comune a tutti i
diritti è rappresentato dagli artt. 392 e 393 c.p.) che esterni (ricavabili dal complesso delle norme
nel cui ambito la norma attributiva del diritto è inserita). Il suo effetto, una volta accertatane
l’operatività, è quello di rendere lecito il comportamento per l’intero ordinamento.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, in relazione alla libera espressione del pensiero, la giurisprudenza ha cercato
di enucleare dei presupposti in presenza dei quali tale diritto possa dirsi prevalente, e dunque
il relativo comportamento scriminato ex art. 51 c.p., sugli altri valori costituzionalmente tutelati; in
particolare, i presupposti in parola sono stati individuati nei requisiti di verità, pertinenza e
continenza, che si atteggiano tuttavia in maniera differente a seconda che il caso concreto
involga l’esercizio del diritto di cronaca, del diritto di critica o infine del diritto di satira.
2.1. Il diritto di cronaca.
Per quanto concerne il diritto di cronaca, inteso quale diffusione di fatti e avvenimenti di interesse
pubblico, non hanno posto nel tempo particolari problemi l’interpretazione dei requisiti della
pertinenza e della continenza. Nel primo caso, infatti, è pacifico che per pertinenza debba
intendersi la sussistenza di un interesse sociale alla diffusione della notizia; allo stesso modo,
per opinione costante, il principio di continenza deve essere inteso quale correttezza
nell’esposizione della notizia al fine di evitare aggressioni futili alla reputazione altrui (Cass.
civ., Sez. V, 17 novembre 2005, n. 7658).
Lo stesso non può dirsi in relazione al requisito della verità: due le tesi in campo sulla sua
interpretazione.
1° Orientamento: interpretazione rigorosa del concetto di verità. La giurisprudenza
maggioritaria (Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1435; Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2014,
n. 10337; Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2012, n. 6902; Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2007, n.
42067; Cass. pen., Sez. V, 22 aprile 2004, n. 23035; Cass. pen., Sez. V 22 giugni 2001, n. 31957)
ritiene che tale presupposto debba essere inteso in modo assoluto: è necessaria sempre la
previa verifica della notizia prima della sua pubblicazione o diffusione, non potendo avere
alcun rilievo la sua mera verosimiglianza. Da ciò deriva che, in assenza del requisito della verità, il
soggetto ben potrà rispondere del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
È stato affermato in tal senso che, in relazione ad un caso di cronaca giudiziaria “sussiste
l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora il titolo dell’articolo attribuisca alla persona
offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta avente riscontro negli atti
giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione e corrispondente al contenuto dell’articolo” (Cass. civ.,
Sez. III, 8 maggio 2012, n. 6902).
In un recente arresto giurisprudenziale, la tesi in esame ha trovato ulteriore conforme
49
Parte generale liddove la Corte di Cassazione si è soffermata ancora una volta sui caratteri che devono
sorreggere il diritto di cronaca perché possa essere scriminato. In particolare, gli Ermellini
hanno ribadito che “la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per
legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa,
purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo
veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente
ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano
accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi
obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma civile
dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. civ., Sez. III,
13 maggio 2014, n. 10337).
2° Orientamento: interpretazione temperata del concetto di verità. A mente di un
indirizzo minoritario (Cass. pen., Sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435), il requisito in parola non
andrebbe inteso in modo del tutto assoluto, potendo essere sufficiente l’accertamento della
notizia compiuto sulla base di fonti attendibili o autorevoli, da cui è possibile desumere con
una certa probabilità la veridicità della notizia. Per altro, la sussistenza del requisito della verità
andrebbe valutato al momento della diffusione della medesima, risultando irrilevanti eventuali
cambiamenti successivi.
2.2. Il diritto di critica.
Il diritto di critica per sua natura si atteggia naturalmente in modo diverso rispetto al diritto di
cronaca. Posso infatti che la critica attiene alla libera manifestazione di un’opinione soggettiva,
come tale non potrebbe essere posta sulla piano di rigore richiesto per la cronaca. E tuttavia
anche in relazione alla cronaca sono sorti in giurisprudenza due orientamenti per quel che
concerne il requisito della verità.
1° Orientamento: inoperatività del requisito della verità. La giurisprudenza
maggioritaria (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 10337; Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2012,
n. 6902; Cass. pen., Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 2300; Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 2005, n.
6149) è ormai assestata nel senso di ritenere che proprio perché la critica consiste
nell’esposizione di mere opinioni e apprezzamenti su determinati eventi, il giudizio ad essa
sottesa non potrebbe essere rigorosamente obiettivo ed imparziale. Si legge infatti che
“l’esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in
particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui
si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare
l’interesse dell’opinione pubblica avuto riguardo all’epoca dei fatti - c.d. tangentopoli - valutando
l’articolo nel complesso e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realtà fattuale, sì da
escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad
attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata” (Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2012,
n. 6902).
50
Scheda di giurisprudenza n. 6 2° Orientamento: applicazione del requisito della verità. Secondo una parte minoritaria
della giurisprudenza, invece, anche in tale ambito dovrebbe trovare necessariamente
applicazione il principio della verità.
Accanto al requisito in parola, così come per il diritto di cronaca, anche nel caso della critica
devono altresì sussistere il principio della pertinenza e della continenza. Come ha avuto modo
di affermare la Corte di Cassazione, “tali parametri debbono valere per il diritto di critica non meno
che per quello di cronaca. Ciò perché anche il diritto di critica, ancorché per sua natura
contrassegnato non dalla divulgazione di un fatto obiettivo, ma dalla libera manifestazione di
un’opinione soggettiva, deve pur sempre esercitarsi non soltanto in presenza di un
apprezzabile interesse pubblico all’interpretazione critica della notizia commentata, ma anche
nel rispetto della continenza verbale; la quale deve a sua volta essere sempre valutata, secondo
parametri complessivi e non formali, nel bilanciamento della libera manifestazione del pensiero,
costituzionalmente garantita, con il diritto individuale alla reputazione ed all’onore” (Cass. civ., sez.
III, 27 gennaio 2015, n. 1434; Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 10337).
La pertinenza anche in tal caso non ha creato particolari problemi, dovendosi intendere per essa,
dunque, pur sempre la sussistenza di un interesse sociale alla diffusione della notizia; il
principio di continenza, invece, ha creato maggiore interesse nella giurisprudenza che, ha
precisato, deve essere analizzato alla luce, da un lato, del carattere offensivo delle espressioni
utilizzate, e dunque dell’eventuale progressiva perdita della portata lesiva nel linguaggio comune
e, dall’altro lato, della levatura sociale del personaggio oggetto della critica (Cass. pen., Sez.
V, 28 gennaio 2008, n. 4129; Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2006, n. 10509).
2.3. Il diritto di satira.
La satira, infine, consiste in una critica, spesso corrosiva ed impietosa, fondata su una
rappresentazione che, essendo tesa a provocare ilarità, enfatizza e deforma la realtà. Una
delle tipiche espressioni della satira è quella caricaturale, consistente nella accentuata e
consapevole alterazione dei tratti somatici e comportamentali di una persona, volta a suscitare
ilarità o derisione nel pubblico.
I requisiti della verità, della pertinenza e della continenza, che anche la satira deve rispettare, si
modellano invero su di essa sulla base delle sue peculiarità. In tal senso, mentre il requisito della
verità ha di fatto un’applicazione al più residuale (e non potrebbe essere altrimenti, consistendo
la satira in un’esagerazione delle caratteristiche fisiche/morali/comportamentali di un soggetto per
metterne in evidenza i lati negativi), devono trovare invece concreta attuazione i principi di
pertinenza e di continenza: la prima intesa pur sempre quale sussistenza di un interesse sociale
alla diffusione della notizia e la seconda quale esposizione della notizia in modo sereno, pacato ed
obiettivo (Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 2006, n. 9246). In particolare, si è affermato, la portata
del principio della continenza varia in ragione della levatura sociale del personaggio che ne
è oggetto: ad una maggiore levatura sociale corrisponde una valutazione meno rigorosa del
principio in parola.
Di recente, la Cassazione, tornando nuovamente sull’argomento, ha precisato che “la peculiarità
della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della
verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca. A differenza di questa che, avendo la finalità
51
Parte generale di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i
connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole. La satira, in sostanza, è riproduzione ironica e non
cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni
soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità. Incompatibile con il
parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle
espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito” (Cass. civ., Sez. III, 10
marzo 2014, n. 5499; posizione ribadita di recente da Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2015, n. 5851).
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che Tizio non possa incorrere in responsabilità per il delitto di diffamazione ex
art. 595 c.p.
Pur vero che per ben due volte ha fatto ricorso ad epiteti forse da considerarsi ai limiti del principio di
continenza, non può esser taciuta che la circostanza che lo stesso Caio, nell’ambito di un’intervista dallo
stesso rilasciata, aveva ammesso d’aver partecipato più volte a violenti scontri di piazza. Vero che è tale
affermazione non coincide certo con l’espressione “ex picchiatore fascista”, utilizzata invece da Tizio, ma è
altresì vero che ad oggi il termine, pur esprimendo indubbiamente una connotazione negativa, è divenuto
d’uso comune, perdendo quella carica prettamente lesiva di cui era impregnato fino a pochi anni fa. Invero,
una parte della giurisprudenza, prendendo atto dell’offesa all’onore che comunque reca l’epiteto “fascista”, ha
optato per la sussistenza del reato di ingiuria, ex art. 594 c., in luogo del delitto di diffamazione.
La fattispecie in esame, tuttavia, non sarebbe sussumibile né nell’ambito dell’una né nell’ambito dell’altra:
rientrerebbe infatti nell’alveo della critica, in particolare quella politica. L’epiteto cui ha fatto ricorso Tizio non
riguarda, a ben vedere, la vita privata di Caio e, ricorrendo ad essa nell’ambito, appunto, della critica politica,
può essere legittimamente compiuta la valutazione dei comportamenti, con giudizi fortemente critici, degli
avversari politici.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2014, n. 10337
Estratto
[...Omissis...]
p.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, la Arnoldo Mondadori Editore lamenta violazione o falsa applicazione
di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la corte
di appello aveva ritenuto sussistenti - con riguardo ad entrambi gli articoli considerati - tutti gli elementi del
reato di cui all’art. 595 c.p., senza affermare al contempo la sussistenza nella specie della scriminante di cui
all’art. 51 c.p., in ragione del legittimo esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all’art.
21 Cost.: inteso sia come diritto di cronaca, sia come diritto di critica.
Con riguardo al primo articolo, la corte di appello aveva escluso l’esimente in questione assumendo la non
veridicità della notizia (frequentazione da parte del M., in (OMISSIS), di un albergo equivoco gestito da
camorristi), nonostante che l’oggettiva rispondenza di quest’ultima risultasse sia da quanto emerso in seno
alla Prima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura che, anche per tale ragione,
aveva espresso parere negativo di minoranza (menzionato nell’articolo) in ordine alla nomina del M. a
52
Scheda di giurisprudenza n. 6 magistrato di cassazione; sia da quanto ammesso da quest’ultimo in ordine al fatto di aver conosciuto di vista
il proprietario dell’hotel, ed alla possibilità di x aver preso, presso quell’albergo, qualche caffè. A nulla
rilevando, trattandosi di aspetto secondario rispetto alla notizia di fondo (data dalla frequentazione
dell’albergo), che l’articolo non riportasse l’intera dichiarazione dell’interessato, secondo cui tale evenienza
poteva essersi verificata casualmente; appunto per prendere “qualche caffè”, ed “in compagnia di qualche
carabiniere”.
Con riguardo al secondo articolo, la decisione della corte d’appello di non riconoscere l’esimente citata urtava
con la circostanza che l’elemento diffamatorio individuato nell’aver menzionato trascorsi giudiziari del M.
senza dare al contempo conto della loro avvenuta archiviazione, doveva invece essere escluso dal fatto che
l’articolista aveva menzionato quest’ultimo evento con un’espressione esplicita ed inequivocabile: “ma anche
quella tempesta passò”.
Inoltre, doveva considerarsi che - come più volte affermato dalla corte di legittimità - il criterio della verità
oggettiva (comunque nella specie rispettato) poteva valere per l’esercizio del diritto di cronaca, non anche
per quello di critica, per sua natura connaturato alla manifestazione soggettiva di un’opinione.
p.2.2 La censura è infondata sotto entrambi i profili dei quali si compone.
Per quanto concerne il primo articolo (“Siamo entrati nell’hotel della camorra”) la corte di appello ha escluso
l’esimente di cui all’articolo 51 cp, atteso che esso: - non dava conto del fatto che la notizia (frequentazione
dell’albergo equivoco) era di “terza mano” perchè non proveniente direttamente dall’avvocato Ba., in esso
menzionato, bensì da altre notizie di stampa, sicchè la legittimità della propalazione dell’informazione doveva
ritenersi (sent. pag. 4) “comunque discutibile, a fronte della necessità di verificare l’attendibilità della fonte e,
altresì, di evitare di fungere da cassa di risonanza”; - poneva una serie di domande retoriche, tendenziose e
screditanti su fatti non veri e, come tali, estranei al diritto di cronaca (si domandava nell’articolo se il M. fosse
“socio onorario” dell’hotel legato alla camorra; se ne avesse “la tessera VIP”; oppure, come un magistrato
definito “il D. P. di (OMISSIS)”, e “novello eroe partenopeo di Mani Pulite” potesse vendersi “se l’ha fatto, per
qualche ora d’amore”; - non aveva riportato quanto il M. aveva dichiarato al PM di Salerno in ordine alla
frequentazione dell’albergo secondo cui “forse, qualche caffè poteva averlo preso in compagnia di qualche
carabiniere”, dal che si doveva evincere che ammettere “di aver preso forse qualche caffè era a tutta
evidenza cosa ben diversa dall’avere ammesso di frequentare l’albergo”.
Per quanto attiene al secondo articolo (“ M. non più M.”), la corte di appello (sent. pag. 5) ne ha fornito una
valutazione unitaria con il primo, in quanto riportato in un “box”, e ad esso riferito. In tale articolo la corte ha
ravvisato contenuto diffamatorio non scriminato, in ragione del fatto che esso: - non rispondeva a verità nella
parte in cui ometteva “la doverosa notizia dell’archiviazione” di due vicende giudiziarie alle quali il M. era
stato sottoposto; nè tale informazione si poteva univocamente desumere dall’aver scritto semplicemente “ma
anche quella tempesta passò”; - attribuiva al M. l’aver fatto, “marcire” per anni l’inchiesta sul dopo-terremoto,
senza che tale notizia fosse stata provata come vera, posto che “il mero riferimento alla sua provenienza da
magistrati non identificati non appare certo sufficiente ad imprimerle nè il carattere della verità, nè della
verosimiglianza”.
p.2.3 Per quanto concerne la doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la corte di appello ha
correttamente applicato la normativa di riferimento (artt. 595 e 51 c.p.; art. 21 Cost.), come costantemente
interpretata in sede di legittimità; segnatamente in punto verità e continenza della pubblicazione.
Così quanto, in particolare, alle valutazioni di merito rese in ordine: - al mancato raggiungimento della prova
di verità; nella specie tentata, da un lato, attraverso l’attribuzione di significato senz’altro ammissivo ad
un’affermazione del M. che, al contrario, non implicava ammissione di frequentazione dell’albergo con le
modalità e per gli scopi indicati nell’articolo; e, dall’altro, attraverso il richiamo ad un inciso inadeguato ed
equivoco nel dare doverosa contezza del fatto che le indagini giudiziarie a carico del M. erano state
archiviate; - alla considerazione necessariamente unitaria e complessiva delle modalità di esposizione della
notizia, nella specie concretantesi nell’individuazione di un messaggio informativo comune ai due articoli, dei
quali il secondo costituiva appendice/integrazione del primo nell’ambito di un unico contesto denigratorio;
53
Parte generale contesto caratterizzato dalla formulazione di interrogativi retorici di per sè chiaramente tendenziosi e
diffamatori.
Va qui ribadito che “la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo
esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purchè frutto di un
serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano
dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne
completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive,
sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore
false rappresentazioni della realtà; b) l’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la
forma civile dell’esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. n. 14822 del
04/09/2012, ed altre).
Tali parametri - correttamente applicati nella sentenza in esame al fine di escludere nel caso concreto le
invocate esimenti - debbono valere per il diritto di critica non meno che per quello di cronaca (Cass. 15443
del 20/06/2013).
Ciò perchè anche il diritto di critica, ancorchè per sua natura contrassegnato non dalla divulgazione di un
fatto obiettivo, ma dalla libera manifestazione di un’opinione soggettiva, deve pur sempre esercitarsi non
soltanto in presenza di un apprezzabile interesse pubblico all’interpretazione critica della notizia commentata,
ma anche nel rispetto della continenza verbale; la quale deve a sua volta essere sempre valutata, secondo
parametri complessivi e non formali, nel bilanciamento della libera manifestazione del pensiero,
costituzionalmente garantita, con il diritto individuale alla reputazione ed all’onore.
[...Omissis...]
Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2014, n. 5499
Estratto
[...Omissis...]
questione che pone il ricorso è se l’utilizzo delle espressioni “Cialtracons”, “contro la diarrea prendete
Codacons”, “Codacons e diarrea...” e “Crollacons” riferite all’associazione ricorrente nei tre articoli apparsi
sulla edizione abruzzese de (OMISSIS) il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) siano diffamatori, oppure
costituiscano legittimo esercizio del diritto di satira, così come ritenuto dalla Corte di merito.
È noto che la satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; come tale rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 21 Cost., che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.
Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella
sua dimensione relazionale, ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia
ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.
Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e
spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso.
La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro
della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca.
A differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del
riscontro storico, la satira assume i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole.
La satira, in sostanza, è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che
necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di
veridicità.
Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della
funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito.
Sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira
54
Scheda di giurisprudenza n. 6 è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione.
Peraltro, l’utilizzo di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui deve essere
strumentalmente collegato alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso
di mira e non deve risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del
soggetto interessato (così Cass. ord. 17.9.2013 n. 21235; Cass. 8.2.2012 n. 1753; Cass. 28.11.2008 n.
28411).
In questo ambito concettuale è stato, ulteriormente, affermato sia dalla giurisprudenza penale sia da quella
civile di legittimità - che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il
rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art.
51 c.p., per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti,
la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine
pubblica (tra le varie Cass. 8.2.2012 n. 1753; Cass. 28.11.2008 n. 28411).
Inoltre, in tema di diffamazione, l’evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il
contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perchè il contesto, in cui
la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non
diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (tra le varie Cass.
13.1.2009 n. 482).
Ora, la Corte di merito, in sentenza, dopo avere riportato le frasi “incriminate”, ha concluso che “Si è, quindi,
in presenza di cronache giornalistiche locali - su cui si sono inserite le battute ironiche del redattore del
quotidiano (OMISSIS) - nelle quali lo spirito che anima gli articoli, dal testo e dal contesto, appare scevro da
denigrazione, disprezzo e ludibrio, sollecitando, piuttosto, il sorriso del lettore”.
Queste conclusioni non sono condivisibili.
Le espressioni quali “Cialtracons” e “Codacons e diarrea...” definite “battute ironiche” rendono, invece
ragione di un errore di sussunzione della fattispecie esaminata nel quadro normativo di riferimento sopra
delineato e di una carenza motivazionale in ordine alla loro portata diffamatoria. Sotto quest’ultimo profilo, in
particolare, la Corte di merito non ha dato conto in motivazione - come censurato con il terzo motivo - della
condotta processuale adottata dalla Editrice Romana spa nel riferire l’erronea denominazione
dell’associazione ad un mero errore tipografico.
Non senza, da ultimo sottolineare che nessun dubbio sussiste in ordine alla configurabilità della lesione alla
reputazione nei confronti di un ente collettivo; lesione che deriva dalla diminuzione della considerazione da
parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l’ente interagisca; ancora più
delicata posizione quando si tratti di un’associazione di consumatori (v. anche Cass. 25.7.2013 n. 18082;
Cass. 4.6.2007 n. 12929).
[...Omissis...]
Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2012, n. 6902
Estratto
[...Omissis...]
Con sentenza del 30 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello proposto da F.P.M. sulle
seguenti considerazioni: 1) gli articolisti avevano riferito un fatto storico: l’arresto del P. nel dicembre 1993
per tentata concussione precisando che l’evento era stato determinato da atti investigativi, e quindi appresi
indirettamente, e usando ripetutamente il condizionale; quindi non erano stati violati i canoni della continenza
formale e sostanziale poiché ricorreva l’utilità sociale della notizia in relazione alla notorietà ed importanza
dell’opera pubblica - ospedale di (OMISSIS), a cui si riferiva la vicenda - la verità dei fatti narrati al momento
degli articoli, la compostezza della forma usata; 2) il titolo dell’articolo sul Mattino: “voleva cento milioni per
l’ok ai lavori:
55
Parte generale in carcere dirigente della regione”, mirante ad attirare l’attenzione dei cittadini, non era denigratorio perché il
contenuto dell’articolo -”Cento milioni per rilasciare il parere favorevole alla realizzazione dell’opera, altrimenti
la ristrutturazione dell’ospedale non sarebbe andata avanti. In carcere per tentata concussione è finito
l’architetto ..”, era corrispondente ai fatti appresi ed il frasario era composto; 3) altrettanto non configurava
diffamazione l’articolo della Repubblica ove sotto il titolo: “La relazione è negativa, ma per cento milioni..”, era
riportata la frase: “il vento di mani pulite non scoraggia i tangentomani più accaniti: ieri i CC hanno arrestato
per concussione l’ingegner P.. Secondo l’accusa egli, addetto al settore tecnico, avrebbe chiesto una
bustarella; cento milioni all’ingegnere M., responsabile dell’impresa che ha realizzato l’ospedale di
(OMISSIS).. il funzionario avrebbe profittato del suo ruolo per ricattare M... P. avrebbe alzato il tiro...”; perché
la notizia era veridica e l’uso continuo del condizionale ed il commento sulla resistenza dei tangentisti anche
all’attacco del pool di mani pulite rientrava nei limiti del diritto di cronaca e di commento. Ricorre P.F.M. cui
resistono le s.p.a. il Mattino ed il Gruppo Editoriale l’Espresso.
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost. e artt.
595 e 51 c.p. e della L. n. 47 del 1948 nonché contraddittoria ovvero carente e/o insufficiente motivazione”
della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell’esercizio del
diritto di cronaca in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa affermando erroneamente che la
portata diffamatoria del titolo va vagliata alla luce dell’intero articolo, mentre questo può avere una
connotazione diffamatoria in sè. Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale sussiste l’esimente dell’esercizio
del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell’articolo attribuisca alla persona offesa - nei
cui confronti penda un procedimento penale - una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell’oggetto
dell’imputazione e corrispondente al contenuto dell’articolo.
2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost., artt. 595 e 51
c.p. e della L. n. 47 del 1948 nonché omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui il
giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di critica in relazione al reato
di diffamazione a mezzo stampa” per non avere la Corte di merito attribuito valenza diffamatoria
all’espressione ingiuriosa:
“tangentomane accanito”, esorbitante dai limiti della continenza formale e sostanziale ingenerando la
convinzione nel lettore dell’abitualità nel richiedere tangenti.
Il motivo è infondato.
Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui l’esercizio del diritto di critica
assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie,
abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le
disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l’interesse dell’opinione pubblica avuto riguardo
all’epoca dei fatti - c.d.
tangentopoli - valutando l’articolo nel complesso e considerando che il contenuto trovava riscontro nella
realtà fattuale, sì da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata
esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata.
3.- Il ricorso va dunque respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
[...Omissis...]
56
Scheda di giurisprudenza n. 7 Scheda di giurisprudenza n. 7
Scriminanti e attività medica
TRACCIA
Tizio, avendo subito un improvviso decremento della propria capacità visiva, si rivolgeva al dott. Caio,
primario di oculistica e oftalmologia nel locale nosocomio e molto noto per le sue riconosciute capacità.
Dopo averlo visitato, il medico riscontrava uno stigmatismo miopico composto obiettivamente molto elevato.
Suggeriva al paziente, quindi, l’opportunità di effettuare un intervento correttivo, definito routinario, al quale
Tizio veniva effettivamente sottoposto qualche giorno dopo. In particolare, il sanitario, pur senza informare
compiutamente il paziente sulle possibili scelte terapeutiche, preannunciava la necessità di un intervento di
cheratomileusi con laser ad eccimeri (cd.lasik), tecnica che egli dichiarava di conoscere bene per averla più
volte sperimentata.
Il dott. Caio, invece, aveva sottoposto Tizio ad un intervento di fotoablazione corneale di superficie
(denominato sinteticamente PRK) in luogo di quello preannunziato di tipo lasik, ancorché a tale tipo di
intervento il paziente aveva dichiarato che non si sarebbe mai sottoposto; veniva, inoltre, accertato che la
struttura sanitaria presso la quale operava il dott. Caio non era attrezzata per l’esecuzione di interventi in
lasik, ma solo per quelli di tipo PRK.
Dall’intervento così effettuato era derivato per Tizio un complessivo peggioramento della vista ad entrambi gli
occhi operati. Conseguentemente, ritenendo scorretto l’operato del medico, Tizio querelava Caio per il delitto
di lesioni volontarie gravi (art. 583, co. 1, n. 1 c.p.).
Il medico, preoccupato per le conseguenze penali della propria condotta, si rivolgeva ad un legale di fiducia.
Il candidato, dopo aver ricostruito il ruolo del consenso del paziente ai fini della liceità del trattamento medico,
rediga motivato parere.
1. La questione.
Il tema delle conseguenze penali derivanti dal trattamento medico arbitrario, integrato qualora
l’attività medico chirurgica sia prestata in assenza di consenso o in presenza di consenso
invalido o di consenso prestato per altro tipo di intervento o, infine, di dissenso esplicito, è
questione da tempo posta all’attenzione della giurisprudenza.
Il consenso, in particolare, quale espressione della libertà di autodeterminazione del singolo,
rinviene la sua tutela nell’art. 32 Cost., a norma del quale è ben possibile anche rifiutare un
trattamento medico, sempre che quest’ultimo, nei casi tassativamente individuati dalla legge, non
sia connotato da obbligatorietà.
Si tratta, in sostanza, di un atto di volontà che è conseguenza diretta del riconoscimento
diretta della libertà personale di cui all’art. 13 Cost. ed il cui fondamento è rinvenibile, oltre che
nel citato art. 32 Cost., altresì nell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, a
norma del quale “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria
persona”.
In virtù di ciò, il consenso, perché sia valido e dunque frutto di una consapevole espressione della
volontà del singolo, deve essere connotato da determinate caratteristiche; in tal senso, il
consenso in tanto è valido in quanto sia personale (dovendo essere espresso direttamente dal
paziente, capace di intendere e di volere), esplicito, specifico (deve avere ad oggetto il singolo
57
Parte generale intervento o ognuna fra le ipotesi di trattamento prospettate), informato (deve vertere su una
specifica e particolareggiata informazione sulla natura dell’intervento e sulle sue possibili
conseguenze negative), immune da vizi (deve essersi formato liberamente), reale ed effettivo
(dunque mai presunto), attuale (deve persistere al momento dell’inizio dell’intervento) ed infine
sempre revocabile.
Tanto premesso, la giurisprudenza, al fine di individuare le conseguenze penali imputabili al
medico che ponga in essere un trattamento arbitrario, ha ritenuto opportuno dover
distinguere l’ipotesi di esito fausto dell’intervento da quella di esisto infausto del medesimo,
avendo cura infine di precisare le peculiarità dell’ipotesi in cui il trattamento medico sia posto
in essere in presenza di esplicito dissenso.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di esito fausto.
In relazione all’esito fausto del trattamento medico arbitrario, prima di giungere all’affermazione
della sua liceità, due erano le tesi che si contendevano il campo: l’una volta ad affermare la
rilevanza penale della condotta del medico e l’altra volta invece a ritenere insussistente una
responsabilità di tal fatta.
2.1. Il primo orientamento: Rilevanza penale della condotta del
medico.
A mente di una tesi ormai minoritaria in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. V, 13 maggio 1992, n.
5639; Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572), la condotta del medico ha rilevanza penale.
Argomento: centralità del consenso. Al di fuori delle attività mediche urgenti o
necessarie, rientranti in quanto tali nello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., la condotta del
medico diversa da quella consentita e non autorizzata sarebbe stata sempre penalmente
rilevante, potendo configurarsi, per una prima tesi, il reato di lesioni personali, dolose (ex art.
582 c.p.) o colpose (ex art. 589 c.p.), e per altra tesi, a seconda dei casi, i delitti di cui agli artt.
605, 610 o 613 c.p.
2.2. Il secondo orientamento: Irrilevanza penale della condotta del
medico.
Secondo la tesi ormai maggioritaria in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2009,
n. 2437; Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 2002, n. 26446), la condotta del sanitario seppur arbitraria,
in presenza di esito fausto, deve essere ritenuta lecita, qualora questi abbia agito secondo le
regole dell’arte medica, fatte salve eventuali responsabilità disciplinari e civili.
1° Argomento: inconfigurabilità del delitti di lesioni personali. L’art. 582 c.p. non
potrebbe essere integrato poiché difetterebbe il fatto tipico del reato, essendo il comportamento
del medico teso ad un miglioramento e non ad un peggioramento della salute del paziente.
2° Argomento: inconfigurabilità dei delitti ex artt. 605, 610 e 613 c.p. Non potrebbero
essere integrati del pari neanche gli estremi di cui all’art. 610 c.p., difettando l’elemento della
violenza, richiesto dalla norma, nell’attività medica.
58
Scheda di giurisprudenza n. 7 3. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di esito infausto.
Anche in tema di esito infausto dell’intervento sanitario arbitrario, sono state avanzate nel
tempo due tesi circa il titolo di reato alla stregua del quale imputare l’evento danno al medico.
3.1. Il primo orientamento: Integrazione degli estremi delle lesioni
volontarie e, in ipotesi, di omicidio preterintenzionale.
Si tratta della prima teoria sviluppata in tema (Cass. pen., Sez., V, 21 aprile 1992, n. 5639), fondata
su un estremo rigore. In particolare, la giurisprudenza riteneva che fosse integrata la
responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie qualora queste ultime si fossero
verificate nel corso di un intervento non sorretto da valido consenso. La conseguenza
naturale di tale impostazione era la configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale
qualora dalle lesioni fosse poi derivata la morte, causalmente connessa alle prime.
Tale responsabilità era fondata sulla ricostruzione del reato di cui all’art. 584 c.p. in termini di
dolo misto a responsabilità oggettiva, in ragione del quale, appunto, l’evento morte pur non
voluto era addebitato al medico poiché collegato causalmente al processo patologico innestato
dall’intervento ed a prescindere da una sua prevedibilità o evitabilità secondo le leges artis.
Argomento: valorizzazione del consenso. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere
inquadrato necessariamente quale presupposto imprescindibile di liceità del trattamento, di
modo che la sua assenza o la sua invalidità avrebbe integrato per ciò solo il reato di lesioni
personali, ex art. 582 c.p.
3.2. Il secondo orientamento: Esclusione della configurabilità dei reati
di lesioni volontarie e di omicidio preterintenzionale.
La giurisprudenza successiva, e ad oggi prevalente (ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV, 9 marzo
2001, n. 28132), all’orientamento testé richiamato ha scardinato il ragionamento che vedeva, a
prescindere da qualsiasi circostanza di sorta, la sussistenza della responsabilità del medico per
lesioni volontarie e, a valle, per omicidio volontario. Si ritiene infatti che debba essere esclusa
una simile imputazione anche qualora manchino oggettive ragioni di urgenza ed il medico
abbia agito travalicando i limiti del previo consenso del paziente, ritenendo erroneamente
l’intervento eseguito necessario. Cionondimeno, escluse tali imputazioni, potrebbe comunque
residuare una responsabilità a titolo colposo.
Argomento: mancanza dell’elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie.
Perché sia integrato il delitto di cui all’art. 582 c.p., è necessario che il medico abbia agito
essendo conscio che il suo intervento avrebbe prodotto una non necessaria menomazione
dell’integrità psico-fisica del paziente. Evenienza che nella specie, in linea teorica, manca, non
essendo l’attività medica finalizzata a ciò. Ed invero, anche a voler ammettere che il delitto di
lesioni dolose, e di conseguenza quello di omicidio preterintenzionale, non richieda
necessariamente la presenza di una “volontà malvagia” nei confronti del paziente, è tuttavia
necessario che il medico si rappresenti e voglia, quale conseguenza della sua condotta, la lesione
dell’integrità psico-fisica del paziente, dato, anche questo, mancante.
59
Parte generale 4. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di trattamento sanitario in
presenza di esplicito dissenso.
In presenza di dissenso esplicito al trattamento sanitario, la giurisprudenza (ex multis, Cass.
pen., Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132) ha ritenuto opportuno distinguere tre diverse ipotesi in cui
può venire in rilievo tale dissenso.
1° Ipotesi: trattamento obbligatorio per legge. In tal caso, l’intervento è scriminato ai
sensi dell’art. 51 c.p., quale esercizio di attività autorizzata, sempre che lo stesso sia stato
praticato nel rispetto dei limiti prescritti e delle leges artis: la volontà del singolo infatti viene
reputata irrilevante o recessiva rispetto alla preventiva valutazione del legislatore (sia
costituzionale, ex art. 32, sia ordinario) sulla necessarietà del trattamento in questione.
2° Ipotesi: trattamento necessario. La giurisprudenza è oscillante in merito; nel tempo
sono state elaborate tre tesi, conseguenze del diverso peso attribuito, per un verso, alla libertà
di autodeterminazione e, per altro verso, alla salvaguardia della salute e della vita del singolo.
• Per un primo orientamento, risalente nel tempo e ormai minoritario (Pret.
Pescara, decr. 8 novembre 1974; Pret. Modica, ord. 13 agosto 1990),
sussisterebbe in capo al medico un obbligo di intervento a tutela della salute
del paziente, nonostante il rifiuto di cure dallo stesso espresso: da un lato, sul
sanitario graverebbe una vera e propria posizione di garanzia della sua tutela e,
dall’altro, non troverebbe asilo nell’ordinamento il diritto “a lasciarsi morire”.
• A mente di secondo orientamento, attualmente maggioritario (Cass. pen., 27
marzo 2001, n. 731; Cass. pen., 9 marzo 2001, n. 585), assume valore assoluto e
preminente il rifiuto di cure e ciò in base alla lettera dell’art. 32, co. 2, Cost., che
a tale rifiuto attribuisce rilevanza. Da ciò deriva che, qualora il medico, in
ossequio al consenso manifestato, non ponga in essere alcun trattamento, in
relazione al reato omissivo che in astratto verrebbe ad essere integrato (omissione
del trattamento e conseguente mancato impedimento dell’evento letale), per
alcuni potrebbe usufruire della scriminante dell’adempimento del dovere, ex
art. 51 c.p., mentre per altri, a monte, il rifiuto di cure impedirebbe la nascita
di una posizione di garanzia in capo al sanitario (e dunque la stessa
configurabilità in astratto di un reato omissivo). Qualora invece il medico effettui
l’intervento in spregio alla volontà contraria del paziente, questo resterebbe
illecito: a prescindere dall’esito e dalla perfetta osservanza delle leges artis,
sarebbero integrati gli estremi del delitto di violenza privata, ex art. 610 c.p.
• Un terzo orientamento intermedio (Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572)
ritiene infine doversi affermare sia la liceità penale dell’astensione del medico,
conseguenza del dissenso espresso dal paziente, sia la liceità della condotta del
medesimo che, pur intervenendo contro la volontà del singolo, sia giustificato da
ragioni di necessità ed urgenza terapeutica (qualora, cioè, il paziente versi in
una situazione di pericolo grave ed attuale per la sua vita o per la sua salute non
altrimenti evitabile): si applicherebbe in tale ipotesi la scriminante dello stato di
necessità, ex l’art. 54 c.p.
60
Scheda di giurisprudenza n. 7 3° Ipotesi: trattamento né obbligatorio né necessario. L’esplicito dissenso, in tal caso, fa
sì che l’intervento debba essere definito quale indebita violazione della libertà di
autodeterminazione del paziente, integrando il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che il dott. Caio possa incorrere nella responsabilità penale per il delitto di
lesioni personali, di cui all’art. 583, co. 1, n. 1, c.p. Invero, applicando i principi prevalenti in materia, risulta
evidente come la condotta del medico non possa dirsi in alcun modo scriminata: oltre a non tenere in
considerazione l’esplicito dissenso del paziente rispetto al trattamento sanitario in concreto poi eseguito, si
tratta di una condotta non conforme né ai limiti prescritti dalle norme né alle leges artis (derivava a Tizio un
peggioramento della vista-definendo la vicenda con esito infausto-e, per altro, la struttura sanitaria si rivelava
non attrezzata per l’intervento).
A ben vedere, lo stesso consenso prestato da Tizio, in relazione ad un intervento poi in concreto non
eseguito, si rilevava invalido e non ritualmente informato (il dott. Caio aveva infatti omesso di informare
compiutamente Tizio in ordine alle possibili scelte terapeutiche). Proprio per tali motivi, sarebbero travalicati
anche i confini di un reato colposo: il medico avrebbe accettato il rischio della possibilità di procurare danno
al paziente (il suo agere sarebbe dunque sorretto da dolo eventuale) ed andando così a ledere il bene
giuridico, l’incolumità individuale, tutelato dal delitto di lesioni personali.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2009, n. 2437
Estratto
[...Omissis...]
8. - Esclusa, quindi, la possibilità di ritenere integrato, nel caso di specie, il delitto di violenza privata, occorre
esaminare quella che è stata ritenuta per lungo tempo l’alternativa “naturalisticamente” privilegiata: vale a
dire il reato di lesioni di cui all’art. 582 c.p.
E ciò non solo per completare la risposta al quesito in ordine al quale queste Sezioni Unite sono state
chiamate a pronunciarsi; ma anche perché la tematica è stata direttamente trattata nel procedimento a quo,
in quanto il delitto originariamente contestato all’imputato era stato proprio il reato di lesioni personali
volontarie aggravato.
Ebbene, una significativa parte della giurisprudenza e della dottrina, è concorde nel mettere in luce un dato
assolutamente incontestabile: vale a dire la sostanziale incompatibilità concettuale che è possibile cogliere
tra lo svolgimento della attività sanitaria, in genere, e medico-chirurgica in specie, e l’elemento soggettivo che
deve sussistere perché possa ritenersi integrato il delitto di lesioni volontarie.
Una condotta “istituzionalmente” rivolta a curare e, dunque, a rimuovere un male non può essere messa sullo
stesso piano di una condotta destinata a cagionare quel “male”.
Ciò non esclude, però, che l’atto chirurgico integri - ove isolato dal contesto del trattamento medicoterapeutico - la tipicità del fatto lesivo, rispetto al quale l’antigiuridicità non può che ricondursi alla disamina
del corretto piano relazionale tra medico e paziente: in una parola, al consenso informato, che compone la
“istituzionalità” della condotta “strumentale” del chirurgo, costretto a “ledere” per “curare”.
61
Parte generale Il versante problematico si sposta, dunque, dalla antigiuridicità, derivante dal mancato consenso al diverso
tipo di intervento chirurgico in origine assentito, alla “tipicità” delle lesioni dell’intervento in sé e delle
conseguenze che da tale intervento sono scaturite: giacché, se l’atto operatorio ha in definitiva prodotto non
un danno, ma un beneficio per la salute, è proprio la tipicità del fatto, sub specie di conformità al modello
delineato dall’art. 582 c.p., a venire seriamente in discussione.
La questione, pertanto, finisce per coinvolgere direttamente la disamina della nozione stessa di “malattia”, ai
sensi dell’art. 582 c.p., giacché anche a questo riguardo le interpretazioni offerte da giurisprudenza e dottrina
si sono non poco evolute nel corso del tempo.
Per lungo tempo, infatti, specie in giurisprudenza, il concetto di malattia ha fortemente risentito di quanto era
stato al riguardo precisato nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, giacché in essa si era
puntualizzato che era stato fatto uso della “espressione, correttamente scientifica, di malattia, anziché quella
di danno nel corpo o perturbazione della mente, l’art. 372 del codice Zanardelli, puniva, infatti, a titolo di
lesione personale, la condotta di chi, “senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella
salute o una perturbazione nella mente”, giacché una malattia è indistintamente qualsiasi alterazione
anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche
generali”.
Simile approccio definitorio è stato, infatti, pedissequamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità,
rimasta, sino ad epoca recente, consolidata nell’affermare che, in tema di lesioni personali volontarie,
costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve
entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in
atto il suddetto processo di alterazione, malgrado il ritorno della persona offesa al lavoro (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 1984, n. 5258, De Chirico; Sez. 5^, 14 novembre 1979, n. 2650, Miscia; Sez. 1^,
30 novembre 1976, n. 7254, Saturno; Sez. 1^, 11 ottobre 1976, n. 2904, Carchedi).
Sul punto, però, non può non convenirsi con quanti ritengono che il concetto di “malattia”, più che evocare
l’impiego di un elemento descrittivo della fattispecie, rinvia ad un parametro normativo extragiuridico, di
matrice chiaramente tecnico-scientifica, tale da far si che il fenomeno morboso, altrimenti apprezzabile da
chiunque in termini soggettivi e del tutto indistinti, presenti, invece, i connotati definitori e di determinatezza
propri del settore della esperienza - quella medica, appunto - da cui quel concetto proviene.
Poiché, dunque, la scienza medica può dirsi da tempo concorde - al punto da essere stata ormai recepita a
livello di communis opinio - nell’intendere la “malattia” come un processo patologico evolutivo
necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell’assetto funzionale
dell’organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il
profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di “malattia”, correttamente intesa.
Pertanto, la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sè, un presupposto indefettibile della
malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una
modificazione di tipo anatomico, così come, all’inverso, una modificazione di quest’ultimo tipo che non
determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell’organismo si presenta, secondo tale condivisibile
impostazione, insuscettibile di integrare la nozione di “malattia”, quale evento naturalistico del reato di cui
all’art. 582 c.p.
Per altro verso, non è senza significato la circostanza che nel codice, la lesione non sia definita in sé - quale
semplice “rottura” della unità organica - ma in relazione all’”evento” che essa deve determinare: e cioè,
appunto, una “malattia” del corpo o della mente.
La circostanza, quindi, che la malattia può riguardare tanto l’aspetto fisico che quello psichico dell’individuo, e
poiché tali due aspetti sono stati fra loro alternativamente considerati dal legislatore (attraverso l’uso della
disgiuntiva “o”), se ne può desumere che, unitario dovendo essere il concetto di malattia e considerato che
non può evocarsi una alterazione “anatomica” della mente, l’unica alterazione che è possibile immaginare,
come comune ai due accennati aspetti, è proprio - e soltanto - quella funzionale.
D’altra parte, il concetto stesso di “durata” della malattia - sulla cui base è parametrata la procedibilità e la
62
Scheda di giurisprudenza n. 7 gravità del reato - non può che confermare una propensione al recepimento normativo della nozione
“funzionalistica” della malattia, del tutto in linea con i tradizionali approdi definitori cui è pervenuta, anche se
con varietà di accenti, la medicina legale.
A tale impostazione mostra, d’altra parte, di aderire anche un significativo filone di giurisprudenza di questa
Corte, attento a ricondurre il concetto di “malattia” nell’ambito di un paradigma di offensività strutturalmente
coeso con la nozione scientifica del concetto stesso, secondo la dichiarata intentio legis fatta palese dal
Guardasigilli, nella richiamata Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, ma poi “tradita” nel
contenuto definitorio trasfuso in quel documento e supinamente recepito dalla giurisprudenza prevalente.
Una prima, sensibile innovazione interpretativa rispetto alla tesi tradizionale è stata, infatti, offerta dalla
sentenza Sez. 4^, 14 novembre 1996, n. 10643, P.C. in proc. Francolini, ove si è affermato che il concetto
clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità,
cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a
breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove
condizioni di vita oppure la morte.
Deriva da ciò - ha concluso la pronuncia - che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il
reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della
funzionalità.
In linea con simili affermazioni si collocano anche Sez. 5^, 15 ottobre 1998, n. 714, Rocca, Sez. 4^, 28 ottobre
2004, n. 3448, Perna, e la più recente sentenza Cass., Sez. 4^, 19 marzo 2008, n. 17505, Pagnani, la quale,
all’esito di un percorso ricostruttivo delle diverse opinioni misuratesi sul tema, ha anch’essa conclusivamente
ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante
non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle
alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una
compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.
Accedendo, dunque, ad una impostazione per così dire “funzionalistica” del concetto di malattia, se ne
devono trarre i necessari riverberi anche per ciò che attiene all’elemento soggettivo del delitto di cui all’art.
582 c.p., giacché, se si ritiene che non possa integrare il reato la lesione che coincida, come evento
causalmente derivato, in una mera alterazione anatomica senza alcuna apprezzabile menomazione
funzionale dell’organismo, se ne deve dedurre che l’elemento psicologico non potrà non proiettarsi a “coprire”
anche la conseguenza “funzionale” che dalla condotta illecita è derivata.
Per la verità, la giurisprudenza di questa Corte si è mostrata propensa a ritenere che per la sussistenza del
dolo nel delitto di lesioni personali non è necessario che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di
conseguenze lesive, essendo sufficiente l’intenzione di infliggere all’altrui persona una violenza fisica;
basta quindi - secondo tale impostazione - il dolo generico, che deve reputarsi sussistere - sia pure nella
forma eventuale - anche in ipotesi di azione commessa ioci causa allorché l’agente abbia previsto come
probabile (e quindi ne abbia accettata la verificazione concreta) l’evento lesivo (cfr., ex multis, Cass, Sez. 1^,
7 giugno 1996, n. 6773, P.M. in proc. Poma; Sez. 6^, 13 ottobre 1989, n. 3103, Lavera; Sez. 5^, 25
novembre 1986, n. 3038/87, Zito; Sez. 5^, 12 aprile 1983, n. 4419, Negovetich).
Discende, poi, da tale orientamento la tesi della identità del dolo delle lesioni volontarie rispetto a quello delle
percosse (Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 1983, n. 9448, Ferrario; Sez. 5^, 3 febbraio 1984, n. 1564, Dal Pozzo).
Anche a voler prescindere dalla dubbia condivisibilità teorica di siffatta ricostruzione dell’elemento soggettivo
del reato di lesioni volontarie, resta il fatto che essa oblitera un dato normativo di ineludibile risalto, quale è
quello rappresentato dal fatto che l’evento naturalistico del delitto di cui all’art. 582 c.p. si compone di un
frammento “definitorio” - la lesione - che si specifica in un altro evento che dal primo deriva: appunto, la
malattia, a sua volta da intendersi nel senso che si è dianzi delineato.
Se, dunque, si cagiona sul derma dell’individuo una soluzione di continuo che può integrare la nozione di
“lesione”, ciò è ancora inconferente, sul versante del trattamento medico-chirurgico, agli effetti della
integrazione del precetto, se ad essa non consegua una alterazione funzionale dell’organismo.
63
Parte generale Pensare che questa “conseguenza” sia estranea alla sfera dell’elemento psicologico, equivale ad estrapolare
dall’evento del reato un solo elemento definitorio, frantumandone, arbitrariamente, l’unitarietà che ad esso ha
ritenuto di imprimere il legislatore.
Sotto questo profilo, dunque, una diversa interpretazione non solo appare inaccettabile da un punto di vista
di disamina “strutturale” della fattispecie - giacché la malattia finirebbe per atteggiarsi alla stregua di una
“eccentrica” condizione obiettiva di punibilità - ma anche in grave frizione con il principio di colpevolezza,
sancito dall’art. 27 Cost., comma 1, per il quale - secondo la costante interpretazione ad esso data dalla
Corte costituzionale (v. da ultimo, la sentenza n. 322 del 2007 e le altre ivi richiamate) - è postulato un
coefficiente di partecipazione psichica del soggetto al fatto, rappresentato quantomeno dalla colpa, in
relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica, fra i quali non può non essere annoverata
proprio la “malattia”.
9. - Alla stregua dei riferiti rilievi è dunque possibile trarre alcune conclusioni.
Una prima considerazione, che appare per molti aspetti dirimente agli specifici fini che qui interessano,
riguarda le peculiarità che caratterizzano, rispetto alla attività sanitaria in genere, l’intervento medicochirurgico realizzato per fini terapeutici.
In quest’ultimo frangente, infatti, la condotta del medico è non soltanto teleologicamente orientata al
raggiungimento di uno specifico obiettivo “prossimo”, quale può essere, in ipotesi, la riuscita, sul piano
tecnico-scientifico, dell’atto operatorio in sè e per sè considerato, quanto - e soprattutto - per realizzare un
beneficio per la salute del paziente.
È quest’ultimo, infatti, il vero bene da preservare; ed è proprio il relativo risalto costituzionale a fornire
copertura costituzionale alla legittimazione dell’atto medico.
L’atto operatorio in sè, dunque, rappresenta solo una “porzione” della condotta terapeutica, giacché essa,
anche se ha preso avvio con quell’atto, potrà misurarsi, nelle sue conseguenze, soltanto in ragione degli esiti
“conclusivi” che dall’intervento chirurgico sono scaturiti sul piano della salute complessiva del paziente che a
quell’atto si è - di regola volontariamente - sottoposto.
Ecco già, dunque, un primo approdo.
Le “conseguenze” dell’intervento chirurgico ed i correlativi profili di responsabilità, nei vari settori
dell’ordinamento, non potranno coincidere con l’atto operatorio in sè e con le “lesioni” che esso
“naturalisticamente” comporta, ma con gli esiti che quell’intervento ha determinato sul piano della valutazione
complessiva della salute.
Il chirurgo, in altri termini, non potrà rispondere del delitto di lesioni, per il sol fatto di essere “chirurgicamente”
intervenuto sul corpo del paziente, salvo ipotesi teoriche di un intervento “coatto”; sebbene, proprio perché la
sua condotta è rivolta a fini terapeutici, è sugli esiti dell’obiettivo terapeutico che andrà misurata la
correttezza dell’agere, in rapporto, anche, alle regole dell’arte.
È, quindi, in questo contesto che andrà verificato l’esito, fausto o infausto, dell’intervento e quindi
parametrato ad esso il concetto di “malattia” di cui si è detto.
È ben vero, a questo riguardo, che la dottrina ha puntualmente evidenziato le difficoltà che - a cagione della
pluralità di considerazioni, di ordine clinico e di altro genere, che tale giudizio comporta - possono
compromettere una valutazione certa e obiettiva in ordine ai risultati scaturiti, per la salute del paziente,
dall’intervento medico-chirurgico.
Ma si tratta di rilievi che, pur se non trascurabili, pertengono ad aspetti di merito che vanno affrontati e risolti
nella competente sede.
Pertanto, ove l’intervento chirurgico sia stato eseguito lege artis, e cioè come indicato in sede scientifica per
contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto, dall’atto cosi eseguito non potrà dirsi
derivata una malattia, giacché l’atto, pur se “anatomicamente” lesivo, non soltanto non ha provocato - nel
quadro generale della “salute” del paziente - una diminuzione funzionale, ma è valso a risolvere la patologia
da cui lo stesso era affetto.
Dunque, e per concludere sul punto, non potrà ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 582 c.p., proprio per
64
Scheda di giurisprudenza n. 7 difetto del relativo “evento”.
In tale ipotesi, che è quella che ricorre nella specie, l’eventuale mancato consenso del paziente al diverso
tipo di intervento praticato dal chirurgo, rispetto a quello originariamente assentito, potrà rilevare su altri piani,
ma non su quello penale.
Proprio sul versante della “opinabilità” della valutazione dei risultati conseguiti dall’intervento chirurgico
effettuato per fini terapeutici, una parte significativa della dottrina ha fatto leva per desumere come il difetto
del consenso informato allo specifico atto operatorio eseguito possa, in fin dei conti, far ritenere che il
concetto stesso di “salute” e di esito più o meno fausto del trattamento chirurgico dovrebbe necessariamente
postulare anche l’apprezzamento e la scelta consapevole dello stesso paziente:
il quale ben può avere, della propria salute, una opinio affatto diversa da quella del medico e che, come tale,
deve essere - trattandosi di diritto inviolabile della persona - adeguatamente cautelata e rispettata.
Il rilievo coglie senz’altro nel segno, ma soltanto in una (auspicabile) prospettiva de iure condendo.
Sul piano del fatto tipico descritto dall’art. 582 c.p., infatti, il concetto di malattia - e di tutela della salute - non
può che ricevere una lettura “obiettiva”, quale è quella che deriva dai dettami della scienza medica, che
necessariamente prescinde dai diversi parametri di apprezzamento della eventuale parte offesa.
È evidente, comunque, che per esito fausto dovrà intendersi soltanto quel giudizio positivo sul miglioramento
apprezzabile delle condizioni di salute del paziente, ragguagliato non soltanto alle regole proprie della
scienza medica, ma anche alle alternative possibili, nelle quali devono necessariamente confluire le
manifestazioni di volontà positivamente o indirettamente espresse dal paziente: ad evitare - quindi - che
possa essere soltanto la “monologante” scelta del medico ad orientare e tracciare gli obiettivi terapeutici da
perseguire, negligendo ciò che il paziente abbia potuto indicare al riguardo.
Ove, invece, l’esito dell’intervento non sia stato fausto, nei sensi dianzi delineati, la condotta del sanitario,
avendo cagionato una “malattia”, realizzerà un fatto conforme al tipo: e rispetto ad essa potrà dunque
operarsi lo scrutinio penale, nella ipotesi in cui, difettando il consenso informato, l’atto medico sia fuoriuscito
dalla innanzi evidenziata “copertura costituzionale”.
Ciò non toglie, peraltro, che, nell’ambito della imputazione del fatto a titolo soggettivo - trattandosi pur
sempre di condotta volta a fini terapeutici - accanto a quella logica incoerenza di siffatto atteggiamento
psicologico con il dolo delle lesioni di cui all’art. 582 c.p., già posta in luce dalla prevalente dottrina e dai più
recenti approdi giurisprudenziali di questa Corte potranno assumere un particolare risalto le figure di colpa
impropria, nelle ipotesi in cui - a seconda dei casi e delle varianti che può assumere il “vizio” del consenso
informato - si possa configurare un errore sulla esistenza di una scriminante, addebitarle ad un
atteggiamento colposo, ovvero allorché i limiti della scriminante vengano superati, sempre a causa di un
atteggiamento rimproverabile a titolo di colpa (art. 55 c.p. e art. 59 c.p., comma 4).
10. - Può quindi concludersi nel senso che, ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico
diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel
rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso
è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali
alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale
condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582 c.p., che sotto
quello del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p.
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 28132
Estratto
[...Omissis...]
65
Parte generale A fondamento del ricorso viene richiamato un precedente di questa Corte (sez. V, sentenza 13 maggio 1992
n. 5639, Massimo) che, in un caso per alcuni aspetti analogo, ritenne di ravvisare l’esistenza dell’omicidio
preterintenzionale. Anche in quel caso il chirurgo, nell’eseguire il programmato intervento di asportazione
trans anale di un adenoma rettale benigno, aveva, in mancanza di consenso (la paziente aveva consentito
esclusivamente ad un intervento per via endoscopica) e in assenza di ragioni di urgenza, proceduto ad un
intervento chirurgico demolitivo di amputazione totale addominoperineale del retto cagionando poi la morte
della paziente a causa di complicazioni sopravvenute.
Sottolineò la Corte, in quell’occasione, che per il reato di lesioni volontarie (cui l’atto deve essere diretto
perché possa, in caso di morte quale evento sopravvenuto non voluto, configurarsi il delitto di omicidio
preterintenzionale) è richiesto il dolo generico e che l’esecuzione di un intervento chirurgico non consentito,
in assenza di ragioni di urgenza che lo giustifichino, non fa venir meno l’indicato elemento psicologico
essendo irrilevante la circostanza che il soggetto abbia agito per il perseguimento di uno scopo lecito o
illecito o per un motivo lecito o illecito. Quanto all’elemento materiale esso sarebbe, secondo quel
precedente, insito nel trattamento chirurgico anche se la condotta, nella quasi totalità dei casi, è
normalmente scriminata ai sensi degli artt. 50 e 51 cod. pen.
La decisione citata richiamava in proposito, condividendolo, l’orientamento della Corte di merito che aveva
definito la condotta del chirurgo, nel caso esaminato, “un atto solo formalmente terapeutico e
sostanzialmente illecito”.
Sono note le divergenze sulla ricostruzione teorica del reato preterintenzionale ed in particolare quelle che
riguardano la struttura del reato nell’aspetto soggettivo. Pacifico essendo che l’evento voluto debba essere
addebitato a titolo di dolo è invece controverso se quello non voluto sia addebitabile a titolo di responsabilità
oggettiva, sulla base del semplice rapporto di causalità materiale, ovvero se sia necessaria la colpa.
Divergenze che si sono ulteriormente acuite a seguito della sentenza 24 marzo 1988 n. 364,
sull’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale (art. 5 cod. pen.) nel caso di ignoranza incolpevole, per
l’inevitabile rafforzamento conseguitone del principio di colpevolezza.
Ancora: sulla natura della colpa (generica o specifica), su quali elementi debba cadere, se possa configurarsi
nella sola violazione dei precetti base, se possa sostituirsi il criterio della colpa con quello della prevedibilità
dell’evento più grave le divergenze di opinione sono altrettanto significative. Nel caso in esame non appare
però necessario affrontare questi problemi in quanto, per le ragioni esposte in precedenza, la colpa
dell’imputato, nella causazione dell’evento più grave, è stata ormai incontestabilmente accertata. Del resto,
nel caso della responsabilità professionale medica, ha minor rilievo il problema, già accennato, se l’evento
non voluto sia addebitato a titolo di colpa o di responsabilità oggettiva posto che generalmente il problema
della ricostruzione del fatto si pone in relazione alle conseguenze dannose non volute cagionate da colpa.
Il problema posto oggi all’attenzione della Corte appare di non facile soluzione perché se è vero che la
connotazione finalistica della condotta (la finalità terapeutica) è irrilevante - non essendo richiesto il dolo
specifico per i reati di lesioni volontarie e percosse - è altrettanto vero che la formulazione dell’art. 584 cod.
pen. (“atti diretti a”) fa propendere per la tesi, non da tutti condivisa (anche perché, secondo alcuni
orientamenti, la caratteristica prevista dalla legge, riprendendo la formulazione dalla legge usata per il
tentativo, riguarderebbe solo la condotta e non l’elemento soggettivo), che l’elemento soggettivo richiesto per
l’omicidio preterintenzionale, quanto all’evento voluto, sia costituito dal dolo diretto o intenzionale con
esclusione quindi del dolo eventuale. Il che non esclude che la locuzione riferita possa riferirsi anche (ma non
esclusivamente) alla condotta.
È vero che l’intenzionalità del dolo è elemento estraneo alla descrizione del delitto preterintenzionale data
dall’art. 43 cod. pen. ma è stato più volte sottolineato come la struttura del delitto previsto dall’art. 584 cod.
pen. (così come quella dell’unica altra ipotesi di delitto preterintenzionale prevista dal nostro ordinamento:
l’aborto previsto dall’art. 18, comma 2 l. 194-1978) non coincida con lo schema normativo previsto dall’art.
43. D’altro canto, se così interpretata (nel senso che per l’omicidio preterintenzionale il dolo debba essere
diretto o intenzionale), non sembra irragionevole la scelta del legislatore di addebitare le conseguenze non
66
Scheda di giurisprudenza n. 7 volute solo quando l’agente abbia almeno direttamente voluto l’evento attribuito a titolo di dolo. Nel caso
invece di dolo indiretto o eventuale verrà meno, come è stato sottolineato in dottrina, il reato
preterintenzionale ma non quello doloso di lesioni o percosse (sulla necessità che, nell’omicidio
preterintenzionale, il dolo sia intenzionale si vedano, nella giurisprudenza di legittimità, le non recenti Cass.,
sez. V, 20 ottobre 1988, Lupiddi; sez. I, 20 gennaio 1986, Barletta).
E allora: quando è possibile affermare che, pur essendo animato da intento terapeutico, il medico ha
coscientemente e volontariamente posto in essere una condotta intenzionalmente diretta a ledere o
percuotere? Numerosi commentatori della sentenza Massimo hanno infatti evidenziato la differenza tra chi si
pone, fin dall’inizio e consapevolmente, in contrasto con il precetto penale e il medico per il quale non è
agevole individuare una analoga volontà. D’altro canto affermare che l’intento terapeutico esclude questa
volontà significa reintrodurre il non richiesto dolo specifico; per converso affermare l’intenzionalità della
condotta, ogni volta che non vi sia il consenso del paziente, significa, in realtà, confondere il problema della
natura del dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame con l’esistenza della scriminante costituita dal
consenso dell’avente diritto.
A parere di questo collegio il problema - fermi restando i presupposti della non necessità del dolo specifico e
delle non discusse caratteristiche dell’elemento materiale del reato (ricavabile dal concetto di malattia fatto
proprio dall’art. 582 cod. pen.) - va invece riportato all’accertamento dei presupposti per ritenere l’esistenza
del dolo intenzionale. L’agente deve anticipatamente (sia pure nel corso dell’intervento chirurgico)
rappresentarsi l’esito (voluto) della sua condotta e non agire “a costo” di provocare quell’evento.
Non va infatti dimenticato che, nella fattispecie dell’omicidio preterintenzionale, l’agente pone in essere una
condotta che sa, e vuole, diretta a provocare un’alterazione dell’integrità fisica della persona offesa; egli si
pone consapevolmente in una situazione di illiceità ponendo coscientemente in pericolo l’incolumità fisica o
la salute del paziente.
Non è necessario, come da taluni è stato osservato, che l’agente sia animato da una “malvagia volontà” nei
confronti della persona offesa ma è comunque necessario che egli si rappresenti, come conseguenza della
sua condotta voluta, la lesione dell’integrità fisica del paziente. E non. va sottaciuta la differenza - proprio per
l’incidenza che ne può derivare sulla natura intenzionale dell’elemento psicologico richiesto - tra i casi nei
quali l’intervento sia deciso nel corso dell’intervento per sopraggiunte e imprevedibili (ovvero prevedibili ma
non previste) circostanze e il caso in cui l’intervento sia stato programmato con quelle caratteristiche fin
dall’inizio.
La soluzione indicata, tesa alla valorizzazione dell’elemento soggettivo richiesto nella forma del dolo
intenzionale, viene incontro anche all’esigenza, sottolineata da alcuni commentatori, che non venga
obliterata, nella ricostruzione in esame, la necessità che venga osservato il principio di offensività, anche
nell’individuazione dell’elemento soggettivo del reato, proprio richiedendosi la necessità che l’agente debba
raffigurarsi anticipatamente le conseguenze dannose della sua condotta.
Non compete al giudice di legittimità individuare i casi in cui sia presente l’elemento soggettivo del reato nella
forma diretta o intenzionale di cui si è detto trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Ma ben può farai astratto riferimento, a titolo di esempio, ai casi in cui la menomazione del corpo o della
mente venga provocata, intenzionalmente, per scopi scientifici, di ricerca o per scopi esclusivamente estetici
(in questi casi non viene surrettiziamente reintrodotto un dolo specifico: lo scopo è estraneo al reato ma vale
a qualificare l’elemento soggettivo come intenzionale), ai casi di interventi demolitivi coscientemente inutili, ai
casi in cui il medico proceda ad un’amputazione per curare una patologia che sa poter essere affrontata
agevolmente con diversi mezzi terapeutici o a quelli in cui produca un’inutile e consapevole mutilazione
all’integrità fisica del paziente. In definitiva si tratta di casi nei quali, già nella rappresentazione dell’agente, il
normale rapporto tra costi (certi) dell’intervento e benefici (eventuali) di esso è ampiamente e
preventivamente conosciuto e rappresentato dall’agente come assolutamente squilibrato verso i primi.
Insomma si avrà l’elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie in tutti i casi in cui il chirurgo, o il
medico, pur animato da intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una
67
Parte generale non necessaria menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente. E poiché l’omicidio
preterintenzionale si configura anche se la condotta è diretta a commettere il delitto di percosse non può
escludersi, in astratto, anche se appare difficile immaginare il concreto verificarsi di queste ipotesi, che
l’evento morte non voluto sia conseguente ad una condotta diretta non a provocare una malattia nel corpo o
nella mente ma ad una condotta qualificabile come percossa (il che rende inutile, tra l’altro, affrontare il
problema, dibattuto soprattutto in dottrina, sulla nozione di malattia con particolare riferimento alla necessità
che, all’alterazione anatomica, si accompagni anche una riduzione apprezzabile della funzionalità).
Così ricondotto l’elemento soggettivo del reato entro i suoi limiti naturali va detto che il discorso sul consenso
del paziente trova un suo ridimensionamento dovendo ricondursi la sua efficacia a quella delle scriminanti
che, secondo l’opinione maggiormente condivisa, escludono l’antigiuridicità della condotta.
Sul consenso del paziente la Corte condivide la preoccupazione, espressa dal P. G. nella memoria
presentata in udienza, per una eccessiva enfatizzazione di tale elemento le cui finalità sono in realtà diverse
rispetto a quella di legittimare interventi lesivi dell’integrità del paziente e la cui rilevanza non ha un ambito di
applicazione generalizzato ove si tenga conto dei limiti posti dalla legge (art. 5 cod. civ.: ma anche in questo
caso vi sono opinioni che ne escludono l’applicabilità al campo penale) agli atti di disposizione del proprio
corpo - che potrebbero fare rientrare nell’ambito del delitto di lesioni volontarie menomazioni consentite in
violazione dell’indicata norma civilistica - e delle ipotesi, pure previste dalla legge, di trattamenti sanitari
obbligatori nonché dei casi di trattamenti nei confronti di persone non consenzienti (per es. colui che ha
tentato il suicidio o che effettua lo “sciopero della fame” o “della sete”) o non in grado di esprimere il
consenso.
Può quindi affermarsi che il consenso del paziente per un verso precluda la possibilità di configurare il delitto
di lesioni volontarie, ma solo nel caso di consenso validamente espresso nei limiti dell’art. 5 cod. civ., per
l’efficacia scriminante attribuita dall’art. 50 cod. pen. al consenso della persona che può validamente disporre
del diritto; per altro verso che, in presenza di ragioni di urgenza terapeutica, o nelle ipotesi previste dalla
legge, il consenso non sia necessario.
Diversamente influisce il dissenso del paziente la cui volontà, nel senso della sua libera autodeterminazione,
ha trovato un rafforzamento a livello costituzionale (art. 32): a fronte di una manifestazione di volontà
esplicitamente contraria all’intervento terapeutico il pericolo grave ed attuale per la vita o per la salute del
paziente configura lo stato di necessità di cui si parlerà oltre e, per rimanere al tema in esame, vale
certamente ad escludere il dolo diretto di lesioni in quanto ciò che si rappresenta il medico, nell’intervenire
malgrado il dissenso del paziente, è la salvaguardia della sua vita e della sua salute poste in pericolo.
Al di fuori di queste situazioni di pericolo l’esplicito dissenso del paziente rende l’atto, asseritamente
terapeutico, un’indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente ma anche della
sua integrità con conseguente applicazione delle ordinarie regole penali.
Analoghe considerazioni devono farsi in relazione alle altre cause di giustificazione astrattamente ipotizzabili.
Ci si riferisce, in particolare, alle situazioni di urgenza terapeutica che concretizzano lo stato di necessità o
l’adempimento di un dovere (secondo altre opinioni sarebbero ipotizzabili anche l’esercizio di un diritto e
anche cause di giustificazione non codificate) qualora siano in gioco non solo la vita del paziente ma anche
la sua integrità fisica. In questi casi mai potrà affermarsi che il medico abbia intenzionalmente provocato la
lesione della salute del paziente; non perché esista la (irrilevante, per quanto si è detto) finalità terapeutica
ma perché, nelle ipotesi in esame, la condotta è intenzionalmente diretta a tutelare la salute del paziente e
non a provocare una menomazione della sua integrità fisica o psichica.
Ciò consente, analogamente, di escludere l’intenzionalità della condotta nei casi, non infrequenti, nei quali il
medico, nel corso dell’intervento chirurgico, rilevi la presenza di una situazione che, pur non essendo
connotata da aspetti di urgenza terapeutica, potendo essere affrontata in tempi diversi, venga invece
affrontata immediatamente senza il consenso del paziente; per es. per evitargli un altro intervento e altri
successivi disagi o anche soltanto per prevenire pericoli futuri.
Per completare il discorso sulle cause di giustificazione occorre ancora precisare che è naturalmente
68
Scheda di giurisprudenza n. 7 applicabile, ai casi in esame, la disciplina prevista dall’art. 59 u.c. cod. pen. nella parte relativa all’erronea
supposizione di una causa di giustificazione. È quindi necessario, nelle situazioni ipotizzabili, che il chirurgo
non si sia erroneamente rappresentato la situazione patologica in modo tale da ritenere che essa richiedesse
l’intervento non consentito, ovvio essendo, anche in questo caso, il venir meno dell’intenzionalità della
condotta. E ferma restando la sua responsabilità per il reato colposo quando si accerti l’esistenza di questo
elemento soggettivo del reato.
Secondo un orientamento, affermatosi soprattutto in dottrina, nelle condizioni descritte perché possa
ravvisarsi l’omicidio preterintenzionale, l’elemento soggettivo del reato consisterebbe non nella
rappresentazione di una menomazione qualificabile come malattia del corpo o della mente, nel senso fatto
proprio dall’art. 582 cod. pen. (sia o meno richiesta, perché possa configurarsi la malattia, anche l’alterazione
funzionale: il problema, già accennato, non è rilevante nel nostro caso), ma nella sola rappresentazione di
compiere un atto contro la volontà del paziente (oltre che non necessitato e non urgente). Il bene giuridico
protetto di cui si lamenta la lesione sarebbe dunque non l’integrità fisica del paziente ma la sua libertà di
autodeterminazione per cui il reato astrattamente configurabile sarebbe quello previsto dall’art. 610 cod. pen.
(violenza privata) e l’eventuale evento lesivo o mortale che ne fosse derivato diverrebbe punibile secondo la
previsione dell’art. 586 cod. pen.
Questa costruzione, a parere della Corte, trova un ostacolo difficilmente superabile nella previsione della
necessità che la condotta dell’agente consista in violenza o minaccia. Quest’ultima sembra proprio da
escludere, mentre la violenza potrebbe forse ipotizzarsi nei soli casi di dissenso espresso del paziente al
trattamento chirurgico.
[...Omissis...]
69
Parte generale SCHEDA DI GIURISPRUDENZA N. 8
Vizio di mente e disturbi della personalità
TRACCIA
Tizio, commerciante d’arte moderna, è solito acquistare le opere per conto dei suoi facoltosi clienti nella
galleria milanese di Sempronio.
Nel corso del rapporto commerciale tra i due, Tizio vende numerosi quadri esposti della galleria di Sempronio
senza corrispondergli il prezzo ricevuto dagli acquirenti finali.
Per tale motivo tra i due inizia un diverbio, nel corso del quale Sempronio chiede a Tizio la somma di
trecentomila euro che quest’ultimo giudica spropositata. Il gallerista, pur di ottenere quanto pensa gli sia
dovuto, minaccia Tizio di riferire tutto alla polizia.
Di fronte a tale minaccia, Tizio aggredisce fisicamente Sempronio; nel corso dell’alterco, a causa di una
spinta, Sempronio sbatte il capo contro lo spigolo di un mobile e cade a terra sanguinante. L’aggressore
infierisce, quindi, su di lui colpendolo in testa con dei bastoni fino a provocarne la morte.
Cerca, quindi, di far sparire il cadavere dal luogo dell’omicidio, senza riuscirvi.
Immediatamente fermato dalle forze dell’ordine giunte sul posto qualche minuto dopo, Tizio viene indagato
per omicidio volontario aggravato. L’indagato racconta l’accaduto al Pubblico ministero competente ratione
loci molto confusamente.
Già nel corso delle prime indagini, dalla cartella clinica dell’indagato, emerge come lo stesso sia affetto da un
gravissimo disturbo della personalità di tipo narcisistico e borderline, a tratti paranoide, per il quale era al
momento del fatto in cura da una psichiatra.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sull’imputabilità e, in particolare, sul
vizio di mente, rediga motivato parere
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito involge la qualificazione dei c.d. disturbi della personalità e
dunque la possibilità che i medesimi possano essere compresi nella nozione di vizio di mente,
escludendo così l’imputabilità del soggetto agente.
Prima di entrare nel vivo della discussione, è opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 88 c.p. non
è imputabile chi “nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente
da escludere la capacità di intendere e di volere”: il legislatore ha così accolto un indirizzo biopsicologico, in ragione del quale non è sufficiente accertare una malattia mentale, occorrendo
altresì che la malattia stessa abbia azzerato la capacità di intendere e di volere del soggetto.
Atteso che la capacità di intendere viene individuata nell’idoneità dell’autore ad orientarsi nel
mondo esterno, nella piena realizzazione del significato delle proprie condotte e delle loro
ripercussioni, e che la capacità di volere va invece identificata nell’attitudine ad
autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che sono alla base dei comportamenti posti in
essere dall’agente, la giurisprudenza si è spesso interrogata sui fattori in grado di menomare o
azzerare entrambe le componenti e dunque, traducendosi in un vizio di mente, tali da escludere
l’imputabilità (che, si ricorda, ai sensi dell’art. 85 c.p., può essere ravvisata solo nel soggetto
capace di intendere e di volere).
L’infermità, che dà origine appunto al vizio di mente rilevante (sia nella sua accezione parziale, ex
70
Scheda di giurisprudenza n. 8 art. 88 c.p., che in quella totale, ex art. 89 c.p.), può essere di qualsiasi genere, ordine e tipo,
per cui non solo di natura psichica, ma altresì di natura fisica, anche a carattere transitorio. In
particolare, il concetto de quo include oltre alla malattia mentale psichiatrica, anche le diverse
forme di deficienza psichica; per contro, in esso non possono trovare accoglimento i
perturbamenti, la pazzia morale o l’immoralità nonché gli stati emotivi e passionali, questi
ultimi esclusi invero per espressa disposizione di legge, ex art. 90 c.p.
Quel che ha occupato per lungo tempo la giurisprudenza, come anticipato, involge la
ricomprensione all’interno del concetto di infermità, tale da provocare il vizio di mente, dei c.d.
disturbi della personalità, individuati in quei comportamenti aberranti o eccentrici, in disturbi
caratterizzati da alta emotività o da un elevato grado di ansietà e definibili come psicopatie o
nevrosi, a volte privi anche di una definizione clinica. La difficoltà risiede proprio in ciò: pur
trattandosi di comportamenti a volte privi, come detto, di una definizione clinica precisa,
cionondimeno non permettono al soggetto di agire in modo pieno e consapevole.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
In tema, gli orientamenti rappresentati in giurisprudenza, prima dell’arresto delle Sezioni Unite,
erano due.
2.1. Il primo orientamento: Irrilevanza dei disturbi della personalità.
Secondo un primo, restrittivo, orientamento (Cass. pen, Sez., V, 27 giugno 2000; Cass. pen.,
Sez. I, 25 marzo 2004, n.16940) nel concetto di infermità rientrerebbero solo le malattie
mentali stricto sensu intese, ossia gravi psicosi acute e croniche accertate clinicamente nonché
insufficienze cerebrali originarie o sopravvenute di carattere organico o anatomico.
1° Argomento: carenza di determinazione del disturbo. La mancanza di una
definizione clinica precisa dei disturbi della personalità non permetterebbe la loro
inclusione nel concetto di infermità, attese le rilevanti conseguenze in punto di esclusione
dell’imputabilità. A ben vedere, del resto, i disturbi de quibus non sono caratterizzati da specifici
sintomi o sindromi, ma “solo” dalla presenza esasperata e rigida di alcune caratteristiche di
personalità.
2.2. Il secondo orientamento: Rilevanza dei disturbi della personalità.
Secondo un altro orientamento (Cass. pen., Sez. I, 9 aprile 2003, n.19532), invece, i disturbi
della personalità ben possono essere considerati rilevanti ai fini della nozione di infermità e
dunque tali da escludere l’imputabilità del soggetto agente.
1° Argomento: concetto di infermità. Il concetto de quo, cui il legislatore fa riferimento, è
invero più ampio di quello di malattia, ragion per cui vi possono essere soggetti incapaci di
intendere e volere, seppur non malati in senso stretto.
71
Parte generale 3. La soluzione delle Sezioni Unite: Rilevanza dei disturbi della
personalità solo in presenza di determinate condizioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163;
confermate, di recente, da Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 2014, n. 52951) hanno accolto il secondo
degli orientamenti esposti, precisandone tuttavia la portata: la Corte in tal senso ha infatti affermato
che, per rientrare, nel “ristretto novero delle malattie mentali (..) i disturbi della personalità
devono essere di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla
capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che
sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto
di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale” (conclusione ribadita di recente
da Cass. pen., Sez. I, 12 settembre 2014, n. 37573).
1° Argomento: concetto di infermità. La Cassazione recepisce un significato ampio del
termine infermità, rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., in ragione del fatto che quando il
legislatore ha ritenuto di dover fare riferimento al solo concetto di alterazione anatomica o
funzionale, l’ha fatto espressamente, utilizzando il diverso termine di malattia (ciò, ad es., è
tangibile nell’art. 582 c.p., riferito appunto alla “malattia nel corpo e nella mente”). Viceversa,
continua la Corte, “non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile
nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in
concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore
del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo”.
Proseguendo sulla scorta di tale ragionamento, gli ermellini hanno cura di precisare che “ i
confini di rilevanza ed applicabilità dell’istituto della imputabilità dipendono, in effetti, anche in
qualche misura dal concetto di pena che si intenda privilegiare: nell’ottica retributiva di questa,
se la pena deve servire a compensare la colpa per il male commesso, non può non rilevarsi che
essa si giustifica solo nei confronti di soggetti che hanno scelto di delinquere in piena libertà”; allo
stesso modo, la “funzione preventiva potrà rivolgersi solo a soggetti che siano effettivamente in
grado di cogliere l’appello contenuto nella norma, e fra questi non sembra che possano
annoverarsi anche i soggetti non imputabili, in quanto tali ritenuti non suscettibili di motivazione
mediante minacce sanzionatorie” .
2° Argomento: valutazione della tipologia del disturbo. Secondo la Corte, i disturbi
della personalità possono costituire causa idonea ad escludere o menomare, in via autonoma
e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, ai fini degli artt. 88 e 89
c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente
incidere sulla stessa; invece, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre anomalie
caratteriali o gli stati emotivi e passionali, che non rivestano i suddetti connotati di incisività
sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente.
3° Argomento: necessità di contemperare le esigenze del diritto penale con la scienza
psichiatrica moderna. Il diritto penale non può prescindere dagli arresti in materia cui è
giunta la scienza psichiatrica, nel cui campo da tempo è stata abbandonata la rigida
contrapposizione tra malattia mentale e non malattia, accogliendo la tesi per la quale
effettivamente vi sono numerosi disturbi della psiche non classificabili come malattie in senso
stretto, ma non per questo si può escludere aprioristicamente che possano incidere sulla capacità
72
Scheda di giurisprudenza n. 8 di intendere e di volere dell’individuo. Gli studi della moderna psichiatria hanno, infatti,
individuato accanto ai disturbi clinici in cui si risolvono le vere e proprie malattie mentali,
anche altri disturbi mentali tra cui i disturbi della personalità, che pur non integrando vere e
proprie malattie mentali, pur tuttavia possono influire, inficiandola sulla capacità di
intendere e volere.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso che ci occupa, l’accusa di omicidio volontario aggravato a carico di Tizio, per aver ucciso
Sempronio a seguito di un diverbio sorto per ragioni puramente economiche, si palesa pienamente fondata.
Invero, il soggetto indagato, pur affetto da un gravissimo disturbo della personalità di tipo narcisistico e
borderline, a tratti paranoide, non potrebbe né essere considerato non imputabile né beneficiare delle relative
attenuanti: in ossequio alle conclusioni della giurisprudenza di legittimità, risalenti ed ormai assestatesi nel
tempo, perché i disturbi della personalità possano rilevare a tal proposito, è necessario che siano di
consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere,
escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica
condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo
mentale.
Orbene, tali condizioni non sono presenti nel caso di specie: non solo infatti il movente prettamente
economico dell’omicidio, ma anche la lucidità di Tizio nel provocare la morte di Sempronio e di occultarne il
cadavere, pur senza successo, esprimono anzi la piena capacità di intendere e di volere dell’indagato al
momento della verificazione del fatto delittuoso.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163
Estratto
[...Omissis...]
10.0 In prima approssimazione, deve innanzitutto osservarsi che, in effetti - come pure non si è mancato di
evidenziare in dottrina - gli artt. 88 e 89 c.p. fanno riferimento non già ad una “infermità mentale”, ma ad ma
“infermità” che induca il soggetto “in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere” o da
farla “scemare grandemente” (gli artt. 218 e 222 c.p., in tema di presupposti per l’applicabilità della misura di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico o in una casa di cura o di custodia, parlano invece
espressamente di “infermità psichica”): se ne è giustamente inferito che “non è l’infermità in se stessa
(neppure, a rigore, la più grave) a rilevare, bensì un ‘tale stato di mente’, da essa determinato, ‘da escludere
la capacità di intendere o di volere’, o da farla ritenere “grandemente scemata” ulteriore corollario di tale
rilievo è l’annotazione che tali norme non circoscrivono il rilievo alle sole infermità psichiche, ma estendono la
loro previsione anche alle infermità fisiche, che a quello stato di mente possano indurre.
10.1 Sempre per quanto concerne il dato testuale di tali norme, deve, poi, convenirsi con quanto rilevato in
dottrina ed in più decisioni di questa Suprema Corte (per tutte, esaustivamente, Cass., Sez. I, n. 4103/1986),
ed evidenziato nell’odierna udienza anche dal P.G. requirente, che, cioè, il concetto di “infermità” non è del
tutto sovrapponibile a quello di “malattia”, risultando, rispetto a questo, più ampio. Deve, invero, innanzitutto
73
Parte generale rilevarsi la circostanza - evidenziata anche dalla difesa del ricorrente nell’odierna discussione orale - che, a
fronte di tale specifica indicazione di “infermità”, il legislatore usi altrove espressamente il diverso termine di
“malattia nel corpo o nella mente” (artt. 582, 583 c.p.). Ma, in ogni caso, brevemente approfondendo il tema,
mette conto di rilevare che in alcuno delle più autorevoli versioni dizionaristiche della lingua italiana, la
malattia è definita come “lo stato di sofferenza dell’organismo in toto o di sue parti, prodotto da una causa
che lo danneggia, e il complesso dei fenomeni reattivi che ne derivano” ed “elemento essenziale del concetto
di malattia è la sua transitorietà, il suo andamento evolutivo verso un esito, che può essere, a seconda dei
casi, la guarigione, la morte o l’adattamento a nuove condizioni di vita....”, avvertendosi anche che “dal
concetto di malattia sono esclusi i cosiddetti stati patologici, ossia quelle stazionarie condizioni di anormalità
morfologica, o funzionale, ereditaria, congenita o acquisita, in cui non vi sono tessuti od organi in condizione
di sofferenza e che sono compatibili con uno stato generale di buona salute: anomalie e deformità varie,
postumi di malattie (come cicatrici e anchilosi), daltonismo, balbuzie, ecc..”; e solo figurativamente il termine
sta anche ad indicare l’eccitazione, esaltazione, esasperazione di un sentimento o di una passione; stato di
forte tensione o turbamento emotivo; situazione di squilibrio determinato da una fantasia troppo accesa o
anche da leggerezza, da stoltezza; attaccamento morboso; idea fissa, mania; tormento, angoscia, sofferenza
interiore...”. La giurisprudenza di legittimità formatasi in riferimento all’art. 582 c.p. ha ritenuto che “il concetto
clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a
cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a
breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove
condizioni di vita oppure la morte” (Cass., Sez. V, n. 714/1999; id., Sez. IV. n. 10643/1996); che esso
comporti “alterazioni organiche o funzionali sia pure di modesta entità (Cass., Sez. I, n. 7388/1985),
“qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata” (Cass., Sez. V, n.
5258/1984), ed in tale concetto è stata inclusa anche la “alterazione psicopatica” che sia in rapporto diretto di
causalità con la condotta dell’agente (Cass., Sez. V, n. 5087/1987). E questa Suprema Corte, affrontando il
tema del significato del termine “dal punto di vista etimologico” in specifico riferimento alla tematica che
occupa, ha rilevato che quello di “malattia” “indica un concetto dinamico, un modo di essere che in un certo
momento ha avuto inizio” (Cass., Sez. I, n. 4103/1986, cit.).
Il termine “infermità”, invece, dal latino infirmitas, a sua volta derivato da infirmus (in privativo e firmus, fermo,
saldo, forte), è dai dizionari della lingua italiana assunto come “termine generico per indicare qualsiasi
malattia che colpisca l’organismo (o, più precisamente, lo stato, la condizione di chi ne è affetto), soprattutto
se permanente o di lunga durata e tale da immobilizzare l’individuo, o da renderlo totalmente o parzialmente
inabile alle sue normali attività ...”; esso indica la “condizione di chi è ammalato, invalido. In particolare:
qualsiasi tipo di malattia o di affezione morbosa, per lo più grave e di carattere permanente, che colpisce una
persona, o, per estensione, il corpo, un suo membro, una sua parte.... Difetto fisico, menomazione...
Insufficienza, deficienza; inadeguatezza...”. E la predetta sentenza di questa Suprema Corte ulteriormente
rileva che tale termine “esprime un concetto statico, un modo di essere senza, alcun riferimento al tempo di
durata ... sicché, in sostanza, “la nozione medico - legale di ‘malattia di mente’ viene identificata nell’ambito
della più vasta categoria delle ‘infermità’...”, riconoscendosi “un valore generico al termine ‘infermità’ e un
valore specifico al termine ‘malattia’...”.
Anche a voler seguire l’opinione di una autorevole voce della dottrina, secondo cui quella della differenza tra
malattia ed infermità, nel contesto della tematica che qui rileva, sarebbe, oggi, “una questione meramente
nominale, questione solo di parole, di cui non esiste più alcun concetto” rimane, nondimeno, che nella
prospettazione codicistica, il termine di infermità deve ritenersi, in effetti, assunto secondo una accezione più
ampia di quello di malattia, e già tanto appare mettere in crisi contrastandolo funditus, il criterio della totale
sovrapponibilità dei due termini e con esso, fra l’altro ed innanzi tutto, quello della esclusiva riconducibilità
della “infermità” alle sole manifestazioni morbose aventi basi anatomiche e substrato organico, o, come altra
volta è stato più restrittivamente detto, come “malattia fisica del sistema nervoso centrale”.
10.2 Vero è, d’altra parte, che gli articoli 88 e 89 non possono non esser letti che in stretto rapporto,
74
Scheda di giurisprudenza n. 8 sistematico e derivativo, con il generale disposto dell’art. 85 c.p., sicché, anche in riferimento alle rigide
classificazioni nosografiche della psichiatrica ottocentesca di stampo organicistico - positivistico, pertinente è
il rilievo di autorevole dottrina, secondo cui, proprio a conferma della maggiore ampiezza del termine di
“infermità” rispetto a quello di “malattia”, “non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente
catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in
concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso,
sia di recepire il significato del trattamento punitivo”, che lasci integra o meno la capacità di “poter agire
altrimenti” posto che - come di sopra si è già accennato - solo nei confronti di soggetti dotati di tali capacità
può concretamente parlarsi di colpevolezza. E si è da altra autorevole voce della dottrina anche osservato
che “certo, una formulazione normativa che, seppure a livello esemplificativo, intervenga a sottolineare più
incisivamente il potenziale rilievo di disturbi psichici che, anche al di fuori di malattie psichiatriche..., valgano
egualmente ad indiziare l’imputabilità..., è in sede di riforma auspicabile. Essa non è però essenziale, poiché
anche l’attuale art. 88, interpretato nel sistema delineato dall’art. 85 (soprattutto) e dalle altre disposizioni in
tema di capacità di intendere e di volere, consente di pervenire alle medesime conclusioni”.
Tanto comporta anche la irrimediabile crisi del criterio della ritenuta necessaria sussumibilità dell’anomalia
psichica nel novero delle rigide e predeterminate categorie nosografiche. D’altronde, a tale sostanzialistica
esigenza mostrano, talora implicitamente, di fare riferimento tutte quelle decisioni di questa Suprema Corte,
le quali hanno ritenuto che sia essenziale non tanto la rigida classificabilità del disturbo psichico in una
specifica categoria nosografica, quanto, invece, la sua attitudine ad incidere, effettivamente e nel caso
concreto, nella misura e nei termini voluti dalla norma, sulla capacità di intendere e di volere del soggetto
agente (Cass., Sez. I, n. 33230/2004; id., Sez. I, n. 24255/2004; id., Sez. I, n. 19532/2003; id., Sez. I, n.
558/1992; id., Sez. I, n. 858/2001; id., Sez. I, n. 13029/1989; id., Sez. I, n. 4861/1988; id., Sez. I, n.
4492/1987; id.; Sez. I, n. 4103/1986; id., Sez. I, n. 7327/1982).
Ed avverte al riguardo autorevole dottrina che, in prospettiva riformistica, oggi “del tutto risibile sarebbe una
scelta del legislatore a favore del metodo nosografico di stampo tradizionale, in particolare di tipo rigido,
giacché la nuova maturata realtà psichiatrico - forense “mostra quello che appare l’irreversibile superamento
di una possibile soluzione normativa in tal senso della questione imputabilità. Scelte di tal genere
porterebbero allo scollamento fra il dato empirico e quello legislativo e a una eccessiva rigidità della disciplina
normativa in punto di imputabilità, a scapito delle istanze garantistiche dettate dal principio di colpevolezza e
da quello di risocializzazione” e dovendo, semmai, il legislatore orientarsi “a livello normativo a soluzioni
tipiche del programma cd. di scopo”, occorrendo al riguardo “potenziare quello che si è definito il terzo piano
del giudizio di imputabilità, cioè quello sanzionatorio, relativo all’opportunità di punire e alla scelta del tipo di
sanzione in ragione della sensibilità che il singolo agente manifesta nei confronti della stessa”.
11.0 Il più moderno e diffuso Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM - IV, messo a punto
dall’American Psychiatric Association nel 1994 - in gran parte sovrapponibile all’altra classificazione dettata
dall’ICD - 10, adottata nel 1992 da gran parte degli Stati membri della Organizzazione Mondiale della Sanità , utilizzato da quasi tutti gli esperti psichiatri, enuclea - con una nomenclatura nosografica che richiama
sindromi e non malattie - i principali disturbi mentali in diciassette classi diagnostiche, e tra queste include
l’autonoma categoria nosografica dei disturbi della personalità, che comprende, suddivisi in tre gruppi, il
disturbo paranoide di personalità, quello schizoide, quello schizotipico, quello antisociale, quello borderline,
quello istrionico, quello narcisistico, quello evitante, quello dipendente, quello ossessivo - compulsivo, e
rimanda anche ad una categoria residua, quella del “disturbo di personalità non altrimenti specificato” nella
quale andrebbero ricondotte “le alterazioni di funzionamento della personalità che non soddisfano i criteri per
alcuno specifico Disturbo della Personalità”.
Tali disturbi della personalità rientrano nella più ampia categoria delle psicopatie, ben distinta, com’è noto, da
quella delle psicosi, queste ultime considerate, anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex
ceteris, Cass., Sez. VI, n. 24614/2003; id., Sez. I n. 659/1997), vere e proprio malattie mentali, comportanti
una perdita dei confini dell’Io; il disturbo della personalità, invece, si caratterizza come “modello costante di
75
Parte generale esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente dalle aspettative di cultura dell’individuo”,
e “i tratti di personalità vengono diagnosticati come Disturbo della Personalità solo quando sono inflessibili,
non adattivi, persistenti, e causano una compromissione sociale significativa o sofferenza soggettiva”.
D’altronde, pure si annota in dottrina che nel 1997, nel nostro Paese, i disturbi della personalità hanno inciso
notevolmente sul numero delle ammissioni ai servizi psichiatrici degli istituti di cura: su un totale di 52.443
ammissioni per “neurosi e turbe psichiche non psicotiche”, ben 10.862 sono stati per disturbi della
personalità; ed anche tali dati empirici, pure indicativi di un generalizzato apprezzamento medico diagnostico di siffatte patologie, non possono non assumere notevole rilievo al riguardo.
In dottrina sono state espresse riserve su tale catalogazione, rilevandosi il suo “eccessivo nominalismo” e
come essa consegua alla premessa che “non esiste una definizione soddisfacente che specifichi i precisi
confini del concetto di disturbo mentale”, e ponendosi “l’altra difficoltà, di ordine semantico, relativa all’uso di
questa, o quella terminologia per definire la stessa sindrome che spesso appare tra ‘come se’ fosse entità
clinica a sé stante...”.
Si è anche rilevato che - come già anticipato - nel DSM “il concetto di ‘disturbo’ si colloca al di fuori di una
ottica eziopatogenetica”, cioè “non si parte dall’idea che a ogni disturbo corrisponde una entità fondata su
una specifica eziopatologia” ma si parla di disturbo solo in senso sindromico”.
Ora, queste ed altre osservazioni critiche meritano indubbia attenzione, sia per la soggettiva autorevolezza
della fonte che le esprime, sia per la oggettiva loro rilevanza.
E però, anche la dottrina psichiatrico - forense appare concordare, ormai, sulla circostanza, che, essendo
questo il sistema diagnostico più diffuso, ad esso occorra fare riferimento per la riconducibilità classificatoria
del disturbo; e, per altro verso, nessun dubbio - come pure si riconosce in dottrina - dovrebbe oggi
permanere sulla circostanza che anche ai disturbi della personalità possa essere riconosciuta la natura di
“infermità”, e quindi una loro potenziale attitudine ad incidere sulla capacità di intendere e di volere del
soggetto agente, alla stregua delle ultime e generalmente condivise acquisizioni del sapere psichiatrico,
anche sussunte nella ricognizione nosografica contenuta nel citato DSM. Vero è, poi, che tale catalogazione
si fonda su basi sindromiche e non eziologiche, ma (così proponendosi un modello classificatorio di natura
sostanzialmente pragmatica, verso il quale, per vero, appare condivisibilmente orientata la attuale scienza
psichiatrica), per un verso (come ancora si annota in dottrina), è presente nella psichiatria forense “un
consenso quasi unanime circa la improponibilità oggi di una spiegazione monoeziologica della malattia
mentale” o, per altro verso, è ricorrente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come si è visto,
l’affermazione che rilevino al riguardo anche “disturbi clinicamente non definibili che tuttavia abbiano inciso
significativamente sul funzionamento dei meccanismi intellettivi o volitivi del soggetto”. La non definibilità
clinica del disturbo può anche derivare dalla (o comportare la) non accertabilità eziologia dello stesso, in un
campo poi, quello della mente umana, ancora avvolto da cospicuo connotazioni di “dubbio e mistero” e da
incoglibile esoterismo patogenetico. E nel campo medico pure si parla di “malattie funzionali: termine usato
per indicare le malattie in cui non vi sono segni dimostrabili di alterazioni di organi particolari, sebbene le
prestazioni di essi siano ridotte”.
E quanto all’”eccessivo nominalismo” ed ai limiti “di ordine semantico” della espressione, deve ritenersi che
(non solo de iure condito, ma, verosimilmente, anche de iure condendo, in riferimento a progetti di riforma di
cui più oltre si dirà) il problema non sembra essere quello del riferimento meramente nominalistico ad una
formula piuttosto che ad un’altra, che, da sole, difficilmente possono avere assoluta ed oggettiva capacità
descrittiva e chiarificatrice, definitivamente risolutoria; qualificata dottrina medico - legale pure afferma, al
riguardo, che “appare un semplice esercizio dialettico disquisire su infermità ed anomalia e sulle etichette
diagnostico - nosografiche perché al legislatore ed al giudice non interessa “quello che c’è a monte” ma se la
capacità di intendere o di volere era (o non era) annullata o grandemente scemata al momento del fatto” (può
osservarsi che, in verità, al giudice deve interessare anche “quello che c’è a monte” esso costituendo snodo
rilevante per la espressione ed il controllo del giudizio sulle capacità intellettive e cognitive dell’agente; ma,
indubitabilmente, ciò che definitivamente rileva è solo l’accertamento di queste ultime, ai fini dell’imputabilità).
76
Scheda di giurisprudenza n. 8 Si tratta, invece, di stabilire in concreto, e non in astratto, la rilevanza di alcune tipologie di disturbi mentali,
sicché, quanto a quella del “disturbo di personalità” che qui interessa, si tratta di accertare e stabilire come
esso si manifesti in concreto, nel soggetto, nel caso singolo: od ove l’accertamento svolto sia indicativo di
una situazione di infermità mentale che escluda la rimproverabilità della condotta al soggetto agente, cioè la
sua colpevolezza - secondo quanto si è sopra detto -, non può non trovare applicazione il disposto della
norma in questione, in riferimento al generale principio indicato dall’art. 85 c.p..
E per il resto, quanto al rapporto od al contenuto dei due piani del giudizio (quello biologico e quello
normativo), il secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico,
dovendosi anche ritenere superato l’orientamento inteso a sostenere la “estrema normativizzazione del
giudizio sulla imputabilità”, che sostanzialmente finisce col negare la base empirica del giudizio medesimo,
pervenendo “alla creazione di un concetto artificiale” sicché, postulandosi, nella simbiosi di un piano empirico
e di uno normativo, una necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza, a quest’ultima il giudice non
può in ogni caso rinunciare - pena la impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio - e, pur in
presenza di una varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche
che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolto, più
condivise, finendo col costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi
protocolli scientifici: e tanto va considerato senza coinvolgere, d’altra parte e più in generale, ulteriori
riflessioni, di portata filosofica oltre che scientifica, circa il giudizio di relatività che oggi viene assegnato,
anche dalla comunità scientifica, alle scienze in genere, anche a quelle una volta considerate assolutamente
“esatte”, del tutto pacifiche e condivise (nel tramonto “dell’ideale classico della scienza come sistema
compiuto di verità necessario o per evidenza o per dimostrazione” come è stato autorevolmente scritto),
vieppiù tanto rilevando nel campo del sapere medico.
Non sembra, difatti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, e pur nella varietà dei paradigmi al
riguardo proposti e dea relativa indotta problematica difficoltà, che possa pervenirsi ad un conclusivo giudizio
di rinvio a fatti “non razionalmente accertabili” a fattispecie non “corrispondenti a realtà”, ma non consentire in
alcun modo una interpretazione od una applicazione razionali da parte del giudice”, situazione che, ove
sussistente, sarebbe senz’altro indiziata di evidente contrasto col principio di tassatività (Corte Cost., n.
96/1981; id,. n. 114/1998), per altro verso inducente ad un conseguente giudizio di impossibilità oggi, e
verosimilmente domani, di dare attuazione al disposto dell’art. 85 c.p. e, prima ancora, di mantenere tale
norma, laddove, per vero - come è detto nella relazione della Commissione al Progetto c.d. Grosso del 2000
-, “il mantenimento della distinzione fra soggetti imputabili e non imputabili appare irrinunciabile per un diritto
penale garantistico”, e la dottrina rimarca che “il concetto di imputabilità... è del tutto fondamentale e del resto
ben saldo nella cultura, nella costruzione e negli sviluppi del diritto penale moderno”.
11.1 Deve, dunque, ritenersi che anche ai disturbi della personalità può essere attribuita una attitudine,
scientificamente condivisa, a proporsi come causa idonea ad escludere o grandemente scemare (in
presenza di determinate condizioni, di cui più oltre si dirà), in via autonoma e specifica, la capacità di
intendere e di volere del soggetto agente. D’altra parte, anche quell’indirizzo che fa leva sul “valore di
malattia” appare evocare un concetto psicopatologico forense, idoneo ad individuare situazioni che,
indipendentemente dalla loro qualifica clinica, “assumono significato di malattia”, meglio “significato di
infermità”, per quanto si è sopra chiarito, e quindi idonee ad incidere sulla predetta capacità di intendere e di
volere: e pure si avverte che, in ogni caso, “se un tempo si affermava che non tutte le malattie in senso
clinico avessero ‘valore di malattia’ in senso forense, oggi si pone soprattutto l’accento sul fatto che,
viceversa, vi possono essere situazioni clinicamente non rilevanti o classificate che in ambito forense
assumono ‘valore di malattia’ in quanto possono inquinare le facoltà cognitive e di scelta”.
12.0 Del resto, anche le più recenti legislazioni di altri Paesi (l’art. 122.1 del codice penale francese,
modificato nel 1993; l’art. 20 del codice penale tedesco, modificato nel 1975; l’art. 37 del codice penale
olandese; l’art. 20 del codice penale spagnolo, modificato nel 1995; l’art. 104 del codice penale portoghese,
modificato nel 1995; l’art. 16 del codice penale sloveno del 1995; una nuova legge in materia psichiatrica
77
Parte generale introdotta in Svezia nel 1992) appaiono discostarsi da un rigido modello definitorio, in favore di clausole
“aperte” che, in uno con i criteri normativi, psicologici e biologici, siano idonee alla espressione di un giudizio
sulla capacità di intendere e di volere, rispettoso delle esigenze garantistiche e preventive indotte dal caso
concreto.
Tali formule “aperte” (“disturbo psichico o neuro psichico”, “turbe mentali patologiche, per un profondo
disturbo della coscienza, per deficienza mentale od altra grave anomalia mentale” “condizioni
psicopatologiche di carenza dello sviluppo o disturbo morboso delle capacità mentali”, “qualsiasi anomalia o
alterazione psichica”, “anomalia psichica”, infermità mentale permanente o temporanea, disturbi psichici
temporanei, sviluppo psichico imperfetto o altra anomalia psichica permanente e grave”, “disturbo psichico”)
appaiono idonee ad attribuire rilevanza anche ai disturbi della personalità, ai fini della imputabilità del
soggetto agente.
E ciò che accomuna queste disposizioni normative appare essere non solo l’adozione di formule “aperte”,
elastiche, ma anche l’aver ancorato la valutazione del disturbo alla sua incidenza sulla capacità di
valutazione del fatto di reato e quindi della capacità di comportarsi secondo tale valutazione, con la
prospettazione, quindi, di un nesso eziologico fra infermità e reato, assunto a requisito della non imputabilità.
Può soggiungersi che nelle conclusioni del VII Colloquio Criminologico del Consiglio d’Europa (Strasburgo,
25 - 27 novembre 1985), si osservava, tra l’altro, che “le legislazioni penali esistenti negli Stati membri del
Consiglio d’Europa presentano una notevole varietà circa lo terminologie ed i concetti fondamentali
concernenti la nozione di responsabilità dell’autore di un reato e dei fattori che possono escludere o
attenuare la stessa”, e che “la tendenza prevalente è di porre agli esperti un quesito che comprenda, nello
stesso tempo, l’aspetto psicopatologico (malattia mentale) e l’aspetto giuridico - normativo (responsabilità o
concetti similari)...”.
13.0 Le incertezze interpretative e conseguentemente applicative collegate alla esatta individuazione del
concetto di malattia mentale, o di infermità mentale, sia sul versante psichiatrico che su quello giuridico, sono
state da tempo oggetto di riflessioni e di proposto nell’ambito di progetti di riforma del codice penale.
Così, nello schema di disegno di legge - delega del 1992 (c.d. Progetto Pagliaro), era prevista (art. 34) la
esclusione della imputabilità per il soggetto che, al momento della condotta, “era, per infermità di mente o per
altra anomalia..., in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere... Nei casi suddetti,
se la capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, diminuire la pena”.
Nello schema del disegno di legge n. 2038/S del 1995 (c.d. Progetto Ritz) si prevedeva (art. 83) che “non è
imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità o per gravissima anomalia
psichica, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere”; e sugli stessi presupposti
era disciplinato il vizio parziale di merito (art. 84).
Nel progetto preliminare di riforma del codice pende (c.d. Progetto Grosso), nel testo del 12 settembre 2000,
si prevedeva (art. 96) che “non è imputabile chi, per infermità o per altra grave anomalia...., nel momento in
cui ha commesso il fatto, era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere l’illiceità
del fatto o di agire in conformità a tale valutazione”.
Nel testo del 26 maggio 2001, più esplicitamente per il tema che qui interessa, si prevedeva (art. 94) che
“non è imputabile chi, per infermità o altro grave disturbo della personalità..., nel momento in cui ha
commesso il fatto era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere il significato del
fatto o di agire in conformità a tale valutazione”. E nel disciplinare la “finalità del trattamento e diminuzione di
pena” (art. 100), si richiamava ancora la “infermità o altro grave disturbo della personalità”.
Quanto al primo di tali testi del c.d. Progetto Grosso, si legge nella relativa Relazione che “potrebbe anche
ritenersi sufficiente la formula del codice vigente, incentrata sul concetto di infermità, alla luce dell’evoluzione
giurisprudenziale cui essa ha dato luogo”; ma che, nondimeno, si ritiene “preferibile un chiarimento
legislativo, mediante l’introduzione, accanto alla infermità, della formula della grave anomalia psichica” che
“renderebbe più sicura la strada per una possibile rilevanza, quali cause di esclusione dell’imputabilità, di
situazioni problematiche, come le nevrosi e le psicopatie, o stati momentanei di profondo disturbo emotivo,
78
Scheda di giurisprudenza n. 8 che fossero tali da togliere base ad un ragionevole rimprovero di colpevolezza”. Ed alle obiezioni circa il
rischio di un possibile indebolimento della tenuta generalpreventiva del sistema penale, si rispondeva
rilevando che “nessuna patente di irresponsabilità si vuole dare automaticamente a realtà in cui sia mancato
un controllo esigibile di impulsi emotivi: le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell’imputabilità sono
situazioni riconoscibilmente abnormi”.
L’espressione “grave anomalia” è stata, poi, sostituita con quella “altro grave disturbo della personalità anche
a seguito dello scetticismo mostrato dalla scienza psichiatrica, che ha rivendicato la utilizzazione della più
scientifica definizione del termine “disturbo mentale” e delle riserve avanzata dalla dottrina penalistica, che
ha rilevato come il generico contenuto del termine “anomalia” (che “ripropone l’inesistente parametro della
normalità”) si affianchi a quello altrettanto generico di “infermità”, con il rischio di aprire varchi eccessivi a
disturbi minori, senza che il richiamo alla “gravità” possa fungere da serio elemento frenante. Ed ha rilevato
la Commissione che “la scelta legislativa più ragionevole” è da individuare in quella di “assicurare le
condizioni di adeguamento del sistema giuridico al sapere scientifico, evitando prese di posizione troppo
rigide e adottando formule atto a recepire la possibile rilevanza dei diversi paradigmi cui dal dibattito
scientifico sia riconosciuta serietà e consistenza”.
Pur evidenziandosi in dottrina una certa ambiguità anche di tale formula sostitutiva, rimane che anche i
progetti di riforma del codice sostanziale, sul punto, appaiono improntati ad un orientamento “aperto” nella
individuazione della malattia (rectius: infermità) penalmente rilevante e sembrano orientare verso tendenze
sostanzialmente conformi a quelle codificate in altri Paesi, abbandonando definitivamente - anche per
espresso dictum lessicale - un rigido modello definitorio ed optando per la utilizzazione di formule “elastiche”.
V’è da aggiungere che nel Progetto del codice penale del 2004 (c.d. Progetto Nordio), che allo stato è
possibile conoscere solo nel suo testo provvisorio e non ufficiale, si prevede (art. 48) che “nessuno può
essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se nel momento della condotta costitutiva non
aveva, per infermità, la capacità di intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato condizionato dalla
incapacità. Agli effetti della legge penale la capacità di intendere e di volere è intesa come possibilità di
comprendere il significato del fatto e di agire in conformità a tale valutazione”.
Sembra, quindi, che rimanga sostanzialmente immutato l’attuale riferimento lessicale al termine “infermità”; e
si legge nel commento di accompagnamento che “si ritiene irrinunciabile il riferimento all’infermità, pur
tenendosi presenti i diversi orientamenti teorici, sulla base delle classiche acquisizioni scientifiche della
psichiatria, della criminologia e della medicina legale, onde evitare gli sbandamenti applicativi - con apertura
a tutti i più originali e diversificati fenomeni in chiave meramente psicologica od emozionale - quanto mai da
impedire in questo delicato campo, quali connessi a formule generiche ed onnicomprensive del tipo disturbo
psichico, disturbo della personalità, psicopatia (fenomeni, secondo prassi censurabili, valutati anche da non
specialisti psichiatrici o medico - legali sulla base di parametri socio - culturali, tipo l’abusata figura del
soggetto c.d. border line”).
14.0 Anche per tali vie (gli esempi provenienti dalle legislazioni straniere, indicativi di un modello “aperto” di
disciplina normativa, e, quanto meno, la gran parte dei progetti riformatori) appare confermarsi l’orientamento
del riconoscimento di possibile rilevanza penale ai disturbi della personalità; ed in tal senso appaiono
orientati, ancorché con grande cautela, anche cospicua parte della dottrina, della scienza psichiatrica che dà
maggiore valore ai contenuti psicologici della infermità mentale, quel filone della giurisprudenza di legittimità
del quale si è sopra già detto.
Tale conclusivo divisamento, del resto, si appalesa, al postutto, pienamente in consonanza col disposto
dell’art. 85 c.p. - di cui, anzi, si pone come ineludibile germinazione - e, più in generale ed ancor prima, con la
impostazione sistematica dell’istituto, secondo il suo orientamento costituzionale cui sopra si è accennato: ai
fini di tale codificato generale principio, difatti, non può non rilevare una situazione psichica che, inserita nel
novero delle “infermità”, determini, ai fini della imputabilità, una incolpevole non riconducibilità di determinate
condotte al soggetto agente, quale persona dotata “di intelletto e volontà”, libera di agire e di volere, cognita
del valore della propria azione, che ne consenta la sua soggettiva ascrizione, senza che su tale sostanziale
79
Parte generale condizione possa fare aggio la mancanza (o la difficoltà) della sua riconducibilità ad un preciso, rigido e
predeterminato, inquadramento clinico, una volta che rimanga accertata la effettiva compromissione della
capacità di intendere o di volere.
15.0 Lo stesso letterale disposto degli artt. 88 e 89 c.p. indica che non è sufficiente, ai fini della imputabilità,
l’accertamento della infermità (per quanto grave essa possa essere, nel suo inquadramento nosografico),
ma, nel contesto di un indirizzo “biopsicologico” che si ritiene accolto dal legislatore, è necessario accertare,
in concreto, se ed in quale misura essa abbia inciso, effettivamente, sulla capacità di intendere e di volere,
compromettendola del tutto o grandemente scemandola.
Per quanto riguarda, quindi, per quel che più specificamente qui interessa, i disturbi della personalità, essi che innanzitutto si caratterizzano, secondo il predetto manuale diagnostico, per essere “inflessibili e
maladattativi” - possono acquisire rilevanza solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da
concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere. Vuole, cioè, dirsi che i disturbi della
personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand’anche non inquadrabili nelle figure tipiche
della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle “malattie” mentali, possono costituire anch’esse
“infermità”, anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di
pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve, perciò, trattarsi di un disturbo
idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile
ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il
dovuto controllo dei propri atti, e conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di
autonomamente, liberamente, autodeterminarsi: ed a tale accertamento il giudice deve procedere
avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, l’indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro
elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali.
Tali requisiti ha più volte evocato la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha esaminato la incidenza,
in subiecta materia, per lo più delle psicopatie, nel cui novero sono ascrivibili, come s’è detto, i disturbi della
personalità. Si è, così, fatto riferimento, nei diversi e variegati contesti motivazionali apprezzati, ai casi in cui
“... “le c.d. personalità psicopatiche..., per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno
squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere” (Cass., Sez. I, n. 33130/2004, in una
fattispecie in cui è stata esclusa la rilevanza di un disturbo della personalità di tipo borderline, “analiticamente
puntualmente motivato”; id., Sez. VI, n. 7845/1997, ancora in tema di un disturbo della personalità
borderline); al “carattere di cogente imperatività” (Cass., Sez. 27708/2004, in riferimento a “disturbo delirante
cronico”); alla infermità “che incida in modo rilevante sui processi intellettivi e volitivi”, rendendo il soggetto
incapace “di rendersi conto del valore delle proprie azioni e di determinarsi in modo coerente con le
rappresentazioni apprese” (Cass., Sez. I, n. 24255/2004, a proposito di “particolari tratti della personalità e di
un prospettato, ma escluso, “disturbo borderline di personalità”); alla manifestazione del disturbo, con elevato
grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi”
(Cass., Sez. I, n. 19532/2003, a proposito di “nevrosi e psicopatie” id. Sez. I, n. 3536/1997, ancora a
proposito di “nevrosi e psicopatie” e sussistenza o meno di una “degenerazione della sfera intellettiva e
cognitiva dell’agente”); alla sussistenza di “una persistente coscienza ed organizzazione del pensiero”, o di
un avvenuta rottura del rapporto con la realtà” (Cass., Sez. I, n. 15419/2002, a proposito di “disturbi della
personalità di tipo borderline” con “componenti narcisistiche” ritenute, nella specie, non “sufficienti a
configurare una situazione di impossibilità di scegliere”); ad “uno squilibrio mentale a causa della intensità
delle deviazioni caratteriali” (Cass., Sez. I, n. 13029/1989, indotto da “una gravità della psicopatia tale da
determinare un vero e proprio stato patologico”; ad una “rivoluzione psicologica interna per cui l’individuo è
diventato estraneo a se stesso”, ad “una effettiva compromissione della coscienza, attestata da uno stato
confusionale acuto”, (Cass., Sez. I, n. 4492/1987). Anche l’indirizzo giurisprudenziale che, più specificamente
ed esplicitamente, fa riferimento al “valore malattia”, appare prospettare non già una sovrapposizione
nosografica dei due termini “malattia” ed “infermità”, ma piuttosto una coincidenza di risultati valutativi quanto
ai finali esiti della sussistenza o meno di una compromissione della capacità intellettiva e volitiva: il tema
80
Scheda di giurisprudenza n. 8 risulta in particolare più diffusamente affrontato nella citata sentenza n. 4103/1986, della I sezione penale, la
quale - puntualizzata la differenza tra “malattia” ed “infermità” - rileva che con tale ultimo concetto “si intende
esprimere il ‘grado di diversità’ fra le direttive abituali di una personalità ed i modi di reazione suoi propri, da
un lato, ed il suo comportamento abnorme dall’altro, in modo da poter chiarire come, partendo dall’essere
‘infermo’ dell’individuo, siano state in concreto limitate o addirittura annullate le possibilità di un minimo
adattamento individuale alla convivenza sociale”.
15.1 Ne consegue, per converso, che non possono avere rilievo, ai fini della imputabilità, altre “anomalie
caratteriali”, disarmonie della personalità”, “alterazioni di tipo caratteriale”, “deviazioni del carattere e del
sentimento” quelle legato “alla indole” del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di
determinazione e di inibizione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non attingano,
quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella
misura voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è detto. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. III, n. 22834/2003;
id., Sez. VI, n. 7845/1997). Né, di norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali, per
la espressa disposizione normativa di cui all’art. 90 c.p. (sul quale, peraltro, puro si appuntano critiche
dottrinarie, ritenendosi, fra l’altro, tale disposizione “priva di una fondata base empirica e motivata piuttosto
da mere considerazioni di prevenzione generale e per questo in contrasto con il principio di colpevolezza”),
salvo che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più ampio quadro
di “infermità”, avente le connotazioni sopra indicate (Cass., Sez. I, n. 967/1998; id., Sez. I, n. 3170/1995; id.,
Sez. I, n. 12429/1994; id., Sez. I, n. 4954/1993; id., Sez. I, n. 1347/1991; id., Sez. V, n. 8660/1990; id., Sez. I,
n. 9084/1987; id., Sez. VI, n. 2285/1985); concordi su tanto anche autorevoli voci della dottrina, che fanno
riferimento a “casi di estrema compromissione dell’Io”.
16.0 È, infine, necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che
consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo.
Invero, la dottrina ha da tempo posto in rilievo come le più recenti acquisizioni della psichiatria riconoscano
spazi sempre più ampi di responsabilità al malato mentale, riconoscendosi che, pur a fronte di patologie
psichiche, egli conservi, in alcuni casi, una “quota di responsabilità”, ed a tali acquisizioni appare ispirarsi
anche la L. n. 180/1978, nel far proprio quell’orientamento psichiatrico secondo cui la risocializzazione
dell’infermo mentale possa avvalersi anche della sua responsabilizzazione in tal senso.
L’esame e l’accertamento di tale nesso eziologico si appalesa, poi, necessario al fine di delibare non solo la
sussistenza del disturbo mentale, ma le stesse reali componenti connotanti il fatto di reato, sotto il profilo
psico - soggettivo del suo autore, attraverso un approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed
individualizzato, in specifico riferimento, quindi, alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione
della persona cui quello specifico fatto di reato medesimo si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, al
giudice - cui solo spetta il definitivo giudizio al riguardo - di compiutamente accertare se quel rimprovero
possa esser mosso per quello specifico fatto, se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua
motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo “settoriale”, che in tal
guisa assurge ad elemento condizionante della condotta: il tutto in un’ottica, concreta e personalizzata, di
rispetto della esigenza generalpreventiva, da un lato, di quella individualgarantista, dall’altro.
Né può ritenersi che a tanto osti il dettato della norma: facendo essa riferimento solo “al momento in cui lo ha
commesso”, si intende, con ciò, postulare la necessaria attualità della capacità di intendere e di volere a quel
momento, ma non si esclude affatto che quella capacità debba essere, appunto a quel momento, valutata,
nella sua incidenza psico - soggettiva in riferimento al fatto medesimo, in relazione alle connotazioni
motivanti ed eziologiche dello stesso.
Ed a tali principi si sono spesso richiamate, già da tempo, molte sentenze di questa Suprema Corte (Cass.,
Sez. I, n. 4103/1986; id., Sez. I, n. 4122/1986; id., Sez. I, n. 14122/1986; id., Sez. I, n. 4492/1987; id., Sez. I,
n. 13029/1989; id., Sez. I, n. 12366/1990; id., Sez. I, n. 3536/1997; id., Sez. I, n. 19532/2003).
17.0 Possono a tal punto raccogliersi le fila del discorso giustificativo sin qui svolto e trarsi la conclusione che
deve essere affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 173.3 disp. att. c.p.p.: ai fini del
81
Parte generale riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi
della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare
grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.
18.0 Alla stregua di tanto, sussistente si appalesa l’error iudicis nel quale è incorsa la sentenza impugnata; la
quale è erroneamente pervenuta alla esclusione del vizio parziale di mente evocando il criterio della
“alterazione patologica clinicamente accertabile” e della “alterazione anatomico - funzionale della sfera
psichica”, ritenendo che in ogni caso i “disturbi della personalità... non integrano quella infermità di mente
presa in considerazione dall’art. 89 c.p.”.
Gli ulteriori profili di doglianza come già anticipato, sono stati prospettati dal ricorrente - la cui difesa tanto ha
espressamente ribadito anche nell’odierna udienza - come intimamente, e propedeuticamente, connessi al
primo motivo di censura; sicché essi ne rimangono, allo stato, assorbiti.
[...Omissis...]
82
Scheda di giurisprudenza n. 9 Scheda di giurisprudenza n. 9
Dolo eventuale e colpa cosciente
TRACCIA
La società Alfa s.p.a. svolge l’attività di produzione di acciaio nel suo stabilimento , scoppia un incendio
notturno: in particolare, le scintille dovute allo sfregamento di un nastro industriale innescavano un piccolo
focolaio d’incendio, che diventava in breve tempo enorme in ragione dei numerosi materiali giacenti sul
pavimento (carta oleata, olio di laminazione, olio idraulico ecc.) che a loro volta prendevano fuoco,
alimentando le fiamme.
Qualche minuto dopo l’innesco, accortisi dello svilupparsi delle fiamme, i lavoratori presenti nello stabilimento
accorrevano sul posto, muniti di estintori portatili, per cercare di domare l’incendio, venendo sopraffatti dal
calore e da una improvvisa fiammata che investiva tre di loro, provocandone la morte.
Della morte dei sette dipendenti venivano chiamati a rispondere l’amministratore unico della Alfa S.p.a. Tizio
e il direttore dello stabilimento Caio a titolo di omicidio volontario con dolo eventuale: in particolare, il
Pubblico ministero riteneva che i due indagati, in ragione dell’alto rischio di incendio insto nella lavorazione
operata e dei precedenti incendi sviluppatisi nello stabilimento, abbiano previsto la possibilità che si
scatenasse un vasto incendio con esiti mortali, accettando il rischio pur di non rivedere il sistema antincendio
(dotandolo di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento e curando meglio la formazione del
personale in tema di prevenzione degli incendi), ristrutturazione ritenuta costosa e antieconomica.
Tizio e Caio, molto preoccupati all’idea di sopportare le conseguenze sanzionatorie dell’imputazione dolosa,
si rivolgono ad un legale per sapere se tale qualificazione risulti corretta alla luce del diritto vigente.
Il candidato, premessi cenni sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, rediga motivato parere.
1. La questione.
Il dibattito inerente al discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente rinviene la sua ragion
d’essere nel fatto che presentano degli elementi in comune: posto che entrambe le figure
rientrano naturalmente nell’ambito dell’elemento soggettivo del reato, il soggetto agisce, in tutti e
due i casi, prevedendo come probabile o possibile il verificarsi di un evento non
direttamente preso di mira. La condotta dunque, diretta a realizzare altri scopi, determina
anche il verificarsi di un evento non è direttamente preso di mira, ma previsto quale
conseguenza accessoria della condotta principale. Giova premettere le nozioni degli elementi
soggettivi de quibus.
Il dolo eventuale, situato, in relazione alla componente volontaristica del dolo, dopo quello
intenzionale e quello diretto, costituisce la forma più lieve di dolo e ricorre qualora l’evento
ulteriore, non perseguito direttamente dall’agente, sia dallo stesso accettato come
conseguenza eventuale, possibile o probabile della sua condotta: il soggetto, in altri termini,
accetta il rischio della verificazione dell’evento.
La colpa cosciente rappresenta invece la forma più grave della colpa e ricorre qualora
l’agente ipotizzi la possibilità che si verifichi l’evento dannoso, ma agisce sorretto dalla
convinzione che non verificherà. In particolare, a mente della dottrina tradizionale (ANTOLISEI) la
colpa cosciente ricorrerebbe quando il soggetto prevede, sì, l’evento antigiuridico ma non ne vuole
l’accadimento, poiché sorretto dalla “fiducia” che non si verifichi; per altra parte di dottrina, ancora,
83
Parte generale (BETTIOL) la colpa cosciente sarebbe caratterizzata dalla “speranza” che l’evento previsto non si
verifichi; e per altri (DELITALA), infine, sarebbe invece necessaria la “convinzione” dell’agente che
l’evento, malgrado la previsione, non si verificherà.
Ciò posto, come anticipato, la distinzione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente (o con
previsione dell’evento) è da sempre una delle principali tematiche foriera di contrasti sia in
dottrina che in giurisprudenza, che costantemente dibattono per elaborare un criterio di
differenziazione, in virtù dell’evidenziato labile confine esistente tra i due elementi soggettivi.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla distinzione fra dolo
eventuale e colpa cosciente.
In relazione alla distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente sono emerse nel tempo quattro
differenti impostazioni frutto di elaborazione sia da parte della dottrina che da parte della
giurisprudenza.
2.1. Il primo orientamento: Le teorie soggettive intellettualistiche.
Secondo una prima teoria (Cass., Sez. I, 12 gennaio 1989, n. 4912; Cass., Sez. I, 28 gennaio
1991, n. 5527Cass., Sez. I, 3 giugno 1993, n. 7382; Cass., Sez. I, 24 febbraio 1994, n. 4583;
Cass., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832; Cass., Sez. V, 25 marzo 2009, n. 13083), posto che
elementi psichici che compongono la struttura del dolo sono la volizione e la
rappresentazione, la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente dovrebbe essere
rinvenuta nell’ambito di quest’ultima. Il criterio che viene utilizzato dalla tesi in commento muove
dal grado di probabilità del verificarsi dell’evento e dunque dal grado di serietà o
concretezza del pericolo che l’agente ricollega alla propria condotta si ricollegano al grado
di probabilità del verificarsi dell’evento (Cass., Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083).
1° Argomento: valorizzazione dell’elemento della rappresentazione. In particolare “il
dolo eventuale è rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e
accettazione del rischio (quindi, volizione) di esso; la colpa cosciente è invece
rappresentazione della (astratta, o meglio, semplice) possibilità della realizzazione del fatto,
ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, nonvolizione)” [Cass., Sez. IV, 10 ottobre 1996, n. 11024].
Tale tesi risulterebbe però smentita dalla lettera dell’art. 43 c.p. che, a ben vedere, definisce il
dolo come intenzione dell’evento, pretendendo così l’accertamento dell’adesione psichica
dell’agente rispetto al fatto tipico concreto.
2.2. Il secondo orientamento: Le teorie soggettive volontaristiche.
Secondo un altro orientamento, che valorizza le critiche mosse alla tesi precedentemente
evidenziata (patrocinato di recente da Cass., Sez. II, 23 ottobre 2013, n. 7027), l’attenzione
andrebbe invece spostato sul profilo volitivo.
1° Argomento: valorizzazione dell’elemento della volizione. La giurisprudenza ha così
affermato che “dolo eventuale e colpa cosciente sono accomunati dall’accettazione del rischio,
84
Scheda di giurisprudenza n. 9 che opera sotto il profilo cognitivo, mentre si differenziano l’uno dall’altra in quanto, dal punto
di vista volitivo, la condotta dell’agente si orienta positivamente al verificarsi dell’evento che è
accettato come ineludibile, dolo eventuale, oppure negativamente laddove l’evento è da
espungere dal progetto di condotta, colpa cosciente” (Cass., Sez. II, 23 ottobre 2013, n. 7027). In
quest’ottica, compito del giudice è quello di verificare quale sarebbe stato il comportamento del
soggetto agente qualora fosse stata certa la realizzazione dell’evento non voluto, reputando così
sussistente il dolo eventuale ove si accerti che egli avrebbe egualmente agito.
2.3. Il terzo orientamento: Le teorie miste.
Il terzo orientamento, quello oggi maggiormente accreditato (Cass., sez. IV, 24 giugno 2009, n.
28231; Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222; Cass., sez. I, 11 luglio 2011, n. 30472; Cass.,
Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411; Cass., Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588; Cass., Sez. I, 5 aprile
2013, n. 20465; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343), rinviene la distinzione fra dolo
eventuale e colpa cosciente applicando il criterio dell’accettazione del rischio. Così “sussiste
il dolo eventuale e non la colpa cosciente qualora l’agente si sia rappresentato il concreto rischio
del verificarsi dell’evento e lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire
anche a costo di cagionarlo. In sostanza, se il soggetto agente non desiste dalla condotta
criminosa bensì persiste nella stessa accettando il rischio che l’evento si verifichi, l’inerzia del
soggetto rispetto alla concreta possibilità di desistere è già sufficiente ad integrare il dolo
eventuale” (Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411).
1° Argomento: l’accettazione del rischio. In applicazione di tale criterio, ricorre:
• dolo eventuale qualora l’agente, pur essendosi rappresentato le possibili ulteriori
conseguenze delittuose della sua condotta, continua ad agire anche a costo di
provocarle,, accettandone dunque il rischio e trasferendo così nel raggio della
volontà ci che era solo oggetto di previsione;
• colpa cosciente qualora l’agente, pur rappresentandosi l’astratta possibilità del
verificarsi dell’evento, respinge il rischio della sua verificazione, confidando nella
propria capacità abilità di controllare l’azione.
Per quanto in concreto la giurisprudenza maggioritaria faccia ricorso al criterio dell’accettazione del
rischio, cionondimeno non mancano rilevi critici mossi nei suoi confronti, nati dai dubbi applicativi
cui può condurre; in tale senso, la Corte ha più volte evidenziato che, a ben vedere, una volta
provata la situazione di rischio, il criterio risulta invero inidoneo a stabilire se effettivamente l’agente
lo ha accettato o meno, venendo così affidato del tutto alla sensibilità del giudice di merito
l’accertamento della carica di disvalore più o meno elevato della condotta. Non può essere
dimenticato infatti che in un recente arresto delle Sezioni Unite, la Cassazione ha precisato
ulteriormente il discrimen fra gli elementi psichici de quibus, asserendo che “l’elemento distintivo fra
dolo eventuale e colpa cosciente va individuato nell’adesione all’evento: nel dolo eventuale l’evento
deve costituire una prospettiva sufficientemente concreta, mediante un alto giudizio di probabilità.
Va dunque chiaramente rappresentato, anche in via alternativa, mentre la mera accettazione del
rischio rientra nella sfera più propriamente colposa dell’agire” (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n.
38343). In considerazione del principio di colpevolezza, la linea di confine tra dolo eventuale e
colpa cosciente dovrebbe essere individuata valorizzando la diversa natura dei rimproveri
85
Parte generale giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie. Per tale
ragione:
• nella colpa, essendo presente il c.d. malgoverno di un rischio, e dunque la mancata
adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che
caratterizzano l’illecito, il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale
anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza,
disinteresse o altro motivo censurabile. Manca la direzione della volontà verso
l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente);
• nel dolo si è in presenza, invece, di un’organizzazione della condotta che coinvolge la
verificazione del fatto di reato sia sul piano rappresentativo che su quello volitivo;
nel dolo eventuale, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e
quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta,
significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciononostante, si determina ad
agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione
che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella
fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le
caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al
fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.
2.4. Il quarto orientamento: Le teorie oggettivistiche.
Un ultimo e minoritario orientamento (G.u.p. Tribunale Grosseto, 20 luglio 2013), patrocinato per lo
più dalla dottrina, prende come punto di partenza l’idea che già la natura oggettiva del rischio
assunto sarebbe tale da poter determinare la fattispecie dolosa o colposa senza dover
necessariamente indagare sull’atteggiamento interiore.
1° Argomento: la distinzione fra rischio “schermato” e rischio “non schermato”. Nel
primo caso, intendendosi per esso il rischio controllabile oggettivamente in virtù di
determinati fattori, vi sarebbe colpa cosciente; nel secondo caso invece, facendo con esso
riferimento ai casi in cui l’agente non è in grado di controllare il decorso causale da lui
avviato, vi sarebbe dolo eventuale, essendo il tutto rimesso al puro caso.
È facile tuttavia obiettare all’orientamento de quo che, eliminando del tutto l’indagine sull’elemento
soggettivo, risulta quanto mai carente in concreto nell’individuazione del confine fra dolo eventuale
e colpa cosciente.
3. La soluzione della
dell’accettazione del rischio.
giurisprudenza
maggioritaria:
Il
criterio
La giurisprudenza maggioritaria (Cass. pen., Sez. II, 30 settembre 2014, n. 43348; Cass., Sez.
VI 24 gennaio 2014, n. 7389; Cass., Sez. II 16 maggio 2014, n. 29371 Cass., Sez. I, 5 aprile
2013, n. 20465; Cass., Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588; Cass., sez. I, 11 luglio 2011, n. 30472;
Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411; Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222; Cass., sez. IV,
24 giugno 2009, n. 28231; Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 13544; Cass., Sez. Un., 14 febbraio
1996, n. 3571), ribadita per altro anche recentemente, sposa ormai da tempo la terza tesi,
86
Scheda di giurisprudenza n. 9 facendo dunque ricorso, al fine di distinguere dolo eventuale e colpa cosciente, al criterio
dell’accettazione del rischio.
1° Argomento: valorizzazione del criterio dell’accettazione del rischio. Per
giurisprudenza ormai costante, si tratta invero dell’unico criterio in concreto efficace per
tracciare la linea di confine fra dolo eventuale e colpa cosciente. Così “il dolo eventuale è
caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma
si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio;
quando invece l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può ritenere
che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo
abbia voluto, sicché in tale ipotesi l’elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e
non in quella di dolo eventuale (…). Si versa nella c.d. colpa cosciente, qualora l’agente, nel
porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la
possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si
verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità
personale o per intervento di altri fattori” (Cass., Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588).
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso che ci occupa, la sorte di Tizio, amministratore unico della Alfa S.p.a., e di Caio, direttore dello
stabilimento, si palesa abbastanza controversa. In effetti, in virtù dell’applicazione del criterio
dell’accettazione del rischio, nei due soggetti senza alcun dubbio dovrebbe essere confermata l’imputazione
di omicidio volontario sorretto dal dolo eventuale; e del resto, come emerge dagli atti, entrambi, pur avendo
previsto la possibilità che si sviluppasse un incendio all’interno dello stabilimento, data la natura dell’attività
ivi svolta nonché dei materiali ivi presenti, avevano accettato il rischio che si verificasse una simile
eventualità pur di non rivedere il sistema antincendio.
A tale conclusione, tuttavia, oggi osterebbe il recente intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 24
aprile 2014, n. 38343) che, invece, hanno posto nuovamente l’accento, al fine distinguere dolo eventuale e
colpa cosciente, sull’aspetto volitivo dei due elementi soggettivi, liddove nella colpa non sarebbe
naturalmente presente la volontà dell’evento, componente, questa, essenziale viceversa del dolo. Applicando
dunque tali coordinate, l’imputazione di Tizio e Caio dovrebbe essere necessariamente rivista e commutata
in omicidio colposo, sorretta appunto da colpa cosciente.
Tanto precisato, si ritiene, ad ogni modo, di dover propendere per l’applicazione del criterio dell’accettazione
del rischio, maggioritario in giurisprudenza, soprattutto in ragione di quanto emerge dagli atti di causa (gli
imputati erano infatti ben consapevoli dei rischi congeniti alla natura dell’attività svolta dall’impresa): per tale
motivo l’imputazione di omicidio doloso non potrebbe che trovare conferma dinanzi al giudice di primo grado.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. I, 5 aprile 2013, n. 20465
Estratto
[...Omissis...]
87
Parte generale La sentenza di appello va annullata. Invero essa, nell’intento di dare una risposta giudiziaria ritenuta la più
adeguata a condotte del tipo di quella oggetto del presente processo, ha di fatto forzato il confine giuridico
tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa, tra volontà dell’evento (volontà dell’azione a costo di causare
l’evento e quindi volontà - anche - del detto evento) e colpa cosciente (volontà dell’azione nella convinzione
che l’evento - sia pur prevedibile - non si verificherà). Il dolo vuole l’evento (quel determinato evento) e così
lo vuole il dolo eventuale, che pone in essere l’azione anche a costo di provocare l’evento (quel determinato
evento). La colpa, sia pur cosciente, no: provoca l’evento, sia pur il più grave e per la più riprovevole delle
condotte, ma lo provoca per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline. È esattamente il caso in esame. M.A. non si è messo alla guida di una
vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno (tanto meno una specifica persona), ma solo per
raggiungere la sua meta (l’ospedale di (OMISSIS), dove avrebbe avuto l’occasione di aprire una pratica
funeraria) e ciò nonostante fosse consapevole delle proprie precarie condizioni psico-fisiche, dell’ora notturna
e delle avverse condizioni metereologhe; nonostante - soprattutto (circostanza quasi dimenticata dalla difesa
ricorrente, anche se nell’imputazione è menzionata solo nella contestazione della recidiva, poi esclusa in
primo grado) - fosse anche consapevole di avere la patente sospesa e per ragioni strettamente collegate a
quelle stesse condizioni psico - fisiche nelle quali si era posto alla guida quella notte. Certamente la più grave
delle azioni colpose, ma non di meno un’azione colposa e non dolosa, non potendosi affermare che egli - ove
si fosse concretamente rappresentato l’investimento e la morte di un’altra persona (paradossalmente anche
di sè stesso) - avrebbe deciso di mettersi alla guida anche a costo di ciò. In realtà allo stato della legislazione
il reato è già previsto ed è precisamente (come non ha mancato di rilevare la difesa ricorrente) quello dell’art.
589 c.p., che nel sanzionare l’omicidio colposo prevede espressamente l’aggravante del fatto commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (comma 2) e, nel perimetro della detta
aggravante, quella ulteriore (comma 3, n. 2) che riguarda il soggetto che è sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope. E il reato, così aggravato, non è di poco conto, prevedendo una sanzione da tre a
dieci anni di reclusione. Una diversa regolamentazione della materia è de iure condendo.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto alla ricostruzione del fatto. Premesso che a detta
ricostruzione ha motivatamente provveduto il giudice di appello, per cui le censure difensive in proposito si
appalesano come di inammissibile merito (sostenendosi che l’invasione dell’opposta corsia di marcia, lungo
la quale sopraggiungeva a prudente velocità l’incolpevole C., fu dovuta a uno sfortunato tentativo di sorpasso
- di fatto solo ipotizzato - e non, secondo quanto stabilito in sentenza, alla perdita di controllo dell’automezzo
per le condizioni psico-fisiche del suo conducente, accertate in atti su base scientifica), le dette
considerazioni sull’atteggiamento psichico dei soggetto involgono tutte le ipotesi e quindi anche la più grave.
La stessa sentenza Lucidi evocata dal giudice di secondo grado (Cass., sez. 4^, n. 11222/10, rv. 249492)
afferma chiaramente che il dolo eventuale consiste nell’accettazione del rischio di verificazione dell’evento
(non direttamente voluto seppure rappresentato) e non solamente nella situazione di pericolo posta in
essere, con la conseguenza che esso si traduce in una condotta tenuta anche a costo di determinare
quell’evento: ed in quel caso, contrariamente a quello in esame (dove la colpa individuata in concreto è
quella di essersi messo alla guida nonostante le alterate condizioni psico-fisiche), si poteva affermare che il
conducente dell’auto in vestitrice (di un ciclomotore che, all’incrocio da entrambi impegnato, transitava col
verde) aveva percepito il rischio ed il quesito che si poneva ai giudici era se, ciononostante, egli lo avesse
accettato, decidendo ugualmente di passare col rosso. Qui questo margine di accertata consapevolezza è
negato (l’imputato afferma di nulla ricordare dell’incidente) e il discrimine resta solo ipotetico. E comunque
anche nella sentenza Lucidi la S.C. si pronunziò per la colpa cosciente. Altrettanto nella sentenza Braidic
(sez. 1^, n. 30472/11, rv. 251484), la cui massima afferma, con speciale efficacia, che “il dolo eventuale
presuppone che l’agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento
non direttamente voluto ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell’evento, accettandone
quindi il prospettato verificarsi; diversamente, la colpa con previsione o cosciente sussiste quando l’agente,
pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della
88
Scheda di giurisprudenza n. 9 propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi”.
Così pure nelle sentenze Montalbano (sez. 4^, n. 28231/09, rv.
244693: “Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella
rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto con accettazione del rischio - e quindi
volizione - di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto,
accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà - e quindi non volizione”) e Bodac
(sez. 4^, n. 13083/10, rv. 242979: “Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione
dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talchè, in mancanza dell’autonoma
prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler
affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta
rimproverabile”).
Sotto il principale profilo della qualificazione del fatto la sentenza va pertanto annullata. Va altresì annullata
sotto l’ulteriore profilo dell’attenuante del risarcimento del danno. Se, infatti, circa il diniego delle attenuanti
generiche (anche del quale il ricorrente si duole) la sentenza di appello ha congruamente motivato
(sottolineando l’atteggiamento di ripetuta incoscienza del soggetto in merito alle condotte di guida, che
evidenzia un’elevata pericolosità del suo operare, ed il suo perseverare nell’uso della droga e,
contemporaneamente, nel condurre un veicolo nel disprezzo totale delle regole), non così per l’attenuante
specifica dell’art. 62 c.p., n. 6: per essa la sentenza impugnata ha seguito un indirizzo risalente (l’esempio più
recente è Cass., sez. 6^, n. 46329/05, rv. 232837, Caputo), superato da una giurisprudenza (cui questa
Corte aderisce e intende dar seguito) che privilegia l’atto di previdenza (anche se obbligatorio) posto in
essere dal soggetto che assicura il proprio mezzo o che comunque (come nel caso) adopera un mezzo che
sa essere assicurato. Di tale indirizzo era già esempio Cass., 4^, n. 46557/04, rv. 230195, Albrizzi (“In tema
di attenuante del risarcimento del danno, alla luce della interpretazione adeguatrice dell’art. 62 c.p., n. 6,
fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, deve ritenersi che detta attenuante - da
riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile
come essenzialmente oggettiva - sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da
un istituto o una impresa di assicurazione”) e lo è oggi Cass., 4^, n. 13870/09, rv. 243202, Cappelletti: “Ai fini
della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento, ancorchè eseguito dalla società
assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato tutte le volte in cui questi ne abbia
conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio” (fattispecie relativa ad omicidio colposo da incidente
stradale).
Anche al detto principio (al pari di quello affermato in ordine alla qualificazione del reato) si uniformerà il
giudice del rinvio, con conseguente diminuzione di pena (su quella individuata per il reato come sopra
qualificato) nella misura che riterrà opportuna.
In tali termini la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ad altra sezione
della Corte di Appello di Milano, cui viene altresì rimessa la pronuncia sulle spese sostenute in questo grado
di legittimità dalla parte civile costituita (solo all’esito del giudizio di rinvio potendosi compiutamente valutare
la reciproca soccombenza delle parti: Cass., sez. IV, sent. n. 4497 del 15/10/99, dep. 13/4/00, rv. 216462,
Barbisan).
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588
Estratto
[...Omissis...]
Nella giurisprudenza di questa Corte si è messo anche in evidenza che il dolo eventuale è caratterizzato dal
89
Parte generale fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta anche la semplice
possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio; quando invece l’ulteriore accadimento si presenta
all’agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio
dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo abbia voluto, sicchè in tale ipotesi l’elemento psicologico si
configura nella forma del dolo diretto e non in quella di dolo eventuale (V. sentenza già citata delle Sezioni
Unite e Sez. 1 sent. n. 13544 del 20.11.1998, Rv. 212058). Il Tribunale del riesame ha escluso, con
motivazione immune da pecche logico giuridiche, che l’atteggiamento psicologico dell’imputato possa essere
inquadrato nella colpa cosciente.
Si versa nella c.d. colpa cosciente, qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la
rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo nè accettando il
rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per
abilità personale o per intervento di altri fattori. Correttamente si è osservato che nel caso di specie non si
rinviene nel comportamento dell’imputato alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, contava di
poter evitare l’evento, perchè ha invece continuato a marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti
senza porre in essere - e questo è il dato più significativo - alcuna manovra che, per quanto spericolata,
possa far pensare alla sua intenzione di evitare l’urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità.
L’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali l’unica misura idonea a
contenere la pericolosità dell’indagato sia la custodia cautelare in carcere, facendo riferimento alla
complessiva condotta posta in essere dall’indagato, al disprezzo mostrato per la vita altrui, ai trascorsi
giudiziari e alla inaffidabilità della sua persona.
La difesa ha sostenuto, nella discussione davanti a questa Corte, che non risulta chiaro il fine per il quale
l’indagato ha agito nel modo che gli è stato addebitato;
il rilievo ha un suo fondamento e in proposito è auspicabile che dal prosieguo dell’istruttoria possano
emergere ulteriori elementi che diano una compiuta spiegazione alle ragioni intime del suo agire; ma la
attuale mancata conoscenza di queste ragioni - in presenza dei dati sopra indicati - non può essere valutata
come un elemento che riduca la possibilità che B.I. possa porre in essere ulteriori analoghe condotte
criminose.
[...Omissis...]
Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411
Estratto
[...Omissis...]
1. L’esatta ricostruzione degli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente presuppone la
definizione dei rapporti tra l’elemento della rappresentazione e quello della volontà nel quadro della struttura
del dolo, che rappresenta il criterio ordinario d’imputazione soggettiva.
La volontà esprime la tensione dell’individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero
desiderio - dimensione questa che attiene alla sfera della motivazione - quanto piuttosto di concreta
attivazione in vista del raggiungimento di un determinato scopo. Qualsiasi condotta umana, eccezion fatta
per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato e solo il riferimento ad esso consente di
individuare la volontà dell’agente, che deve investire direttamente o indirettamente (nei termini che saranno
precisati al paragrafo successivo) anche l’intero fatto di reato colto nella sua unità di significato, nel
dinamismo tra i suoi elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell’offesa. In adesione ad una
recente elaborazione teorica è possibile affermare che, poichè il comportamento doloso orienta
finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell’ambito della
volontà l’intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della
90
Scheda di giurisprudenza n. 9 condotta incide sulla sfera della volizione e la svela.
L’elemento rappresentativo attiene, a sua volta, al complessivo quadro di conoscenza degli elementi
essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata.
Esso costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il
fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole,
idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza. La volontà presuppone, perciò, la consapevolezza di ciò
che si vuole. Il dolo è, quindi, rappresentazione e volontà del fatto tipico. La rappresentazione, che ha ad
oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume - come osservato con efficace sintesi da un’autorevole
dottrina - natura psichica di conoscenza, quando concerne gli elementi preesistenti e concomitanti al
comportamento, di coscienza, quando è riferita alla condotta, di previsione, quando riguarda elementi futuri,
qual è essenzialmente l’evento del reato.
Nell’agire doloso, il soggetto agente orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione
del fatto di reato che costituisce un disvalore per l’ordinamento giuridico, modella la propria condotta in modo
da imprimerle l’idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perchè il
soggetto ha deciso di agire in modo tale da determinarlo.
La rappresentazione e la volizione debbono avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
tipica - condotta, evento e nesso di causalità materiale -, e non il solo evento causalmente dipendente dalla
condotta, come è confermato dalla disciplina dell’errore sul fatto costituente reato contenuta nell’art. 47 c.p.,
comma 1, secondo cui siffatto errore, facendo venir meno il dolo sotto il profilo della indispensabile
consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità
dell’agente.
Nei reati a forma vincolata oggetto del dolo deve essere la condotta specificamente descritta nella norma
incrini matrice, mentre nei reati a forma libera, quali sono i reati di cui ai capi a), b), l’imputazione a titolo di
dolo del fatto nel suo insieme postula che la volontà sia effettiva sino all’ultimo atto.
2. La giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella
rappresentazione e nell’accettazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità, intesa in termini di
elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria. Il soggetto
pone in essere un’azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica
non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel
determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicchè lo stesso non può
non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva (Sez. Un. 12 ottobre 1993, n. 748; Sez. Un. 15
dicembre 1992, Cutruzzolà, in Cass. pen., 1993, 1095; Sez. Un. 12 ottobre 1993, n. 748; Sez. Un. 14
febbraio 1996, n. 3571; Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 6358; Sez. 1, 11 febbraio 1998, n. 8052; Sez. 1, 20
novembre 1998, n. 13544; Sez. 5, 17 gennaio 2005, n. 6168; Sez. 6, 26 ottobre 2006, n. 1367; Sez. 1, 24
maggio 2007, n. 27620; Sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 12954).
Si versa, invece, nella forma di colpa definita “cosciente”, aggravata dall’avere agito nonostante la previsione
dell’evento (art. 61 c.p., n. 3), qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la
rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo nè accettando il
rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per
abilità personale o per intervento di altri fattori.
Dall’interpretazione letterale dell’art. 61 c.p., comma 1, n. 3, che fa esplicito riferimento alla realizzazione di
un’azione pur in presenza di un fattore ostativo della stessa, si evince che la previsione deve sussistere al
momento della condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come
quella implicita nella rimozione del dubbio. Quest’ultimo non esclude l’esistenza del dolo, ma non è
sufficiente ad integrarlo.
Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire, pur senza avere
conseguito la sicurezza soggettiva che l’evento previsto non si verificherà. Il semplice accantonamento del
dubbio, quale stratagemma mentale cui l’agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad
91
Parte generale agire, non esclude di per sè l’accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la
rimozione stessa abbia un’obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la
convinzione che l’evento non si sarebbe verificato.
In tale articolato contesto, come sottolineano i più recenti approdi interpretativi dottrinali e giurisprudenziali,
poichè la rappresentazione dell’intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo
eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione.
Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata “accettata” psicologicamente
dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto,
nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto
l’agente.
Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l’agente
subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L’autore del reato, che si prospetta
chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento
dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione
comparata tra tutti gli interessi in gioco - il suo e quelli altrui - e attribuisce prevalenza ad uno di essi.
L’obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l’evento
collaterale, che viene dall’agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo
perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell’evento lesivo,
ma è indispensabile l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo
(eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato (Sez. 6, 26 ottobre 2006, n. 1367;
Sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 12954; Sez. 5, 17 settembre 2008, n. 44712).
3. La delicata linea di confine tra il “dolo eventuale” e la “colpa cosciente” o “con previsione” e l’esigenza di
non svuotare di significato la dimensione psicologica dell’imputazione soggettiva, connessa alla specificità
del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell’accertamento e di
effettuare con approccio critico un’acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue
probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai
dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione
finalistica. Si tratta di un’indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi
psicologici attraverso un procedimento di verifica dell’id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze
esteriori che normalmente costituiscono l’espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici.
4. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora illustrati.
Innanzitutto, pur muovendo dalla dichiarata adesione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità
sui criteri distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente, ha incentrato l’iter dell’argomentazione pressochè
esclusivamente sull’elemento rappresentativo, trascurando un’adeguata analisi ricostruttiva del profilo della
volizione (cfr precedente par. 3), così come maturata nello specifico contesto fattuale sottoposto al suo
esame.
In secondo luogo ha ricostruito l’elemento di natura intellettiva della previsione/rappresentazione correlato al
fatto oggetto del giudizio sulla base di valutazioni astratte e presuntive, prescindendo dall’esame di tutti gli
elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento e nesso di causalità materiale -, quali emergenti
dallo specifico caso concreto.
È, in tal senso, mancata una compiuta e globale ricostruzione dell’intera vicenda, idonea a fondare un
epilogo decisionale diverso rispetto a quello della sentenza di primo grado. Il giudice d’appello, infatti, dopo
avere sommariamente descritto l’episodio, ha proceduto alla “scomposizione” del fatto, enucleandone
soltanto alcuni aspetti (superamento indenne di precedenti incroci regolati da impianto semaforico che
proiettava luce rossa; capacità di guida;
tempi e modi di avvistamento dell’autovettura “Citroen”; condizioni del traffico; caratteristiche dell’incrocio tra
viale (OMISSIS)) e, rispetto a ciascuno di essi, ha desunto la configurabilità della colpa aggravata dalla
previsione dell’evento sulla base di mere congetture, omettendo una compiuta analisi di tutti i dati conoscitivi
92
Scheda di giurisprudenza n. 9 acquisiti.
In particolare, con riferimento alla genesi dell’episodio, la sentenza impugnata si è limitata a osservare che la
Polizia, dopo l’iniziale avvistamento, aveva deciso di desistere dall’inseguimento per evitare incidenti, ma non
ha specificato dopo quanto tempo rispetto all’avvistamento iniziale ciò avvenne, se l’imputato - che non era
sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti - fu in grado di percepire tale mutato comportamento delle
forze dell’ordine e se, in conseguenza di esso, ebbe a decelerare e ad atteggiare diversamente la condotta di
guida, se fu in grado di valutare le conseguenze di un eventuale rallentamento in relazione alla diverse
dimensioni dei mezzi e alla loro differente velocità, limitandosi a considerare, in via meramente ipotetica, che
l’eventualità di un incidente non poteva non apparire a I. la meno favorevole, perchè avrebbe determinato
certamente il suo arresto (f. 6 sentenza impugnata). La evidente carenza motivazionale su tutti questi profili
incide sulla compiuta analisi dell’elemento volitivo.
Analogamente ne impediscono l’esatta ricostruzione l’omesso apprezzamento delle modalità e della durata
dell’inseguimento, del lasso di tempo intercorso tra l’inizio dello stesso e la sua trasformazione in mero
controllo a distanza del furgone rubato, delle complessive modalità della fuga, della sua protrazione pur dopo
che la Polizia aveva adottato una differente tipologia di vigilanza, dell’estensione chilometrica del percorso
effettuato.
Si sostiene, inoltre, apoditticamente che l’imputato, procedendo in maniera spericolata ad oltre centro
chilometri all’ora in centro abitato e in presenza di traffico veicolare ancora intenso a causa del periodo estivo
e dell’ubicazione dei luoghi, era ragionevolmente convinto di potere dominare la situazione, ossia di essere in
grado di superare anche l’incrocio tra via (OMISSIS), grazie alla sua abilità di guida e alle condizioni di
traffico più limitate in ora notturna (f. 5 sentenza impugnata).
Tale affermazione, fondata su mere presunzioni, mal si concilia, peraltro, con l’apprezzamento riservato dagli
stessi giudici alla precedente condotta di guida, la cui mancata produzione di pregressi eventi lesivi è stata
alternativamente ricondotta - ancora una volta in via meramente ipotetica - all’assenza di ostacoli o alla
capacità di porre in essere le manovre più appropriate (f. 6 sentenza impugnata).
La Corte d’appello ha, poi, desunto la capacità di guida - pur in assenza di una valida patente - dalle
dichiarazioni rese dall’imputato e non riscontrate in alcun modo circa il relativo conseguimento, in epoca
imprecisata, nel paese d’origine e dalla circostanza che lo stesso non si sarebbe altrimenti posto alla guida di
un pesante mezzo di illecita provenienza nè sarebbe stato in grado di sostenere “un inseguimento protrattosi
per alcuni chilometri a velocità elevatissima” (cfr. f. 7 sentenza impugnata). Tale conclusione si pone in
aperto contrasto con la stessa ricostruzione del fatto operata dalla sentenza, evidenziante, sulla base delle
testimonianze acquisite, che i poliziotti avevano desistito dall’inseguimento per evitare incidenti (cfr. f. 6 della
sentenza impugnata). Essa confligge, inoltre, con la rilevata assenza di tracce di frenata, con la mancata
adozione di manovre di deviazione della traiettoria (cfr. f. 6 sentenza impugnata), o, comunque, di manovre
di emergenza, astrattamente possibili, tenuto conto delle caratteristiche dell’incrocio in cui si verificò il fatto e
dell’ampiezza della relativa visuale (f. 7 sentenza impugnata).
Il carattere non univoco dell’omessa presenza di tracce di frenata sul luogo dell’incidente è stato sostenuto
dai giudici di merito sulla base di un immotivato richiamo ad un’alternativa astrattamente prospettata dal
consulente tecnico (cfr. f. 6 sentenza d’appello), le cui considerazioni sul punto (non conosciute nè
conoscibili dal giudice di legittimità che non ha accesso diretto agli atti) non sono state illustrate nè sono state
oggetto di verifica critica alla luce dell’epoca di fabbricazione del furgone e delle caratteristiche del sistema di
arresto e di frenata.
Il generico riferimento alle pregiudizievoli conseguenze per l’imputato in caso di sinistro è stato effettuato,
omettendo di considerare il dato - valorizzato invece dalla sentenza di primo grado - costituito dai diversi
esiti, in caso di incidente, per colui che viaggiava a bordo di un furgone del peso pari a circa due tonnellate e
per chi, invece, si trovasse a bordo di un’auto.
La conclusione circa l’omessa volizione e accettazione del rischio di verificazione dell’evento lesivo nella
convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale, desunta dalla capacità di
93
Parte generale guida e dall’asserita capacità di trovare “uno spazio in cui inserirsi”, pur in presenza di un “traffico non
scarso”, mal si concilia con le indicazioni in ordine alle caratteristiche del luogo del sinistro (“un
incrocio...molto ampio”, secondo quanto risulta a f. 7 della sentenza impugnata), al punto d’impatto (la
fiancata posteriore destra dell’auto “Citroen” condotta da Te.Ni. - cfr. f. 1 sentenza impugnata) e alla mancata
adozione di qualsiasi tipo di manovra di emergenza (cfr. f. 6 della sentenza impugnata), idonea a scongiurare
la collisione.
5. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si
articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di
precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente
proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da
dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere
secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e
unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che “nella valutazione complessiva ciascun indizio
(notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta
superato, (...) l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può
assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova
logica del fatto (...) che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica)
quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero
convincimento del giudice” (Sez. Un, 4 febbraio 1992, n. 6682).
Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite
che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si
esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica
che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa,
tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. Un. 12
luglio 2005, n. 33748).
6. Nel caso in esame la Corte di merito, oltre a leggere in maniera parziale le risultanze processuali illustrate
nella sentenza di primo grado, ha valutato la posizione dell’imputato analizzando soltanto alcuni degli
elementi probatori e non si è preoccupato di calarli all’interno dell’intero contesto che avrebbe potuto
indubbiamente contribuire a chiarire la loro effettiva portata dimostrativa e la loro reale congruenza rispetto al
tema d’indagine.
Al fine di stabilire se nel caso in esame ricossero gli estremi del dolo eventuale o della colpa aggravata dalla
previsione dell’evento, il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare i seguenti elementi, ponendoli in
correlazione logica fra loro: le modalità e la durata dell’inseguimento; il lasso di tempo intercorso tra l’inizio
dello stesso e la sua trasformazione in mero controllo a distanza del furgone rubato; le complessive modalità
della fuga e la sua protrazione pur dopo che la Polizia aveva adottato una differente tipologia di vigilanza; le
caratteristiche tecniche del mezzo rubato in rapporto a quanto in esso contenuto; la conseguente energia
cinetica in relazione alla velocità serbata; le caratteristiche degli incroci impegnati con luce semaforica rossa
prima del raggiungimento di quello tra via (OMISSIS) e le relative possibilità di avvistamento di altri veicoli; la
conformazione dei luoghi in cui avvenne l’impatto con la “Citroen” condotta da Te.Ni.; l’assenza di tracce di
frenata o di elementi obiettivamente indicativi di tentativi di deviazione in rapporto al punto d’impatto con il
mezzo su cui viaggiavano i tre giovani e alle caratteristiche dell’incrocio tra viale (OMISSIS); il
comportamento serbato dall’imputato dopo la violenta collisione.
7. Palese è, infine, il vizio metodologico dell’iter argomentativo della sentenza impugnata che ha assunto il
ragionevole dubbio come punto di partenza, anzichè come approdo finale del ragionamento una volta assolto
all’onere informativo. Compito del giudice di merito, infatti, è, in primo luogo, quello di esaminare tutte le
informazioni probatorie acquisite e, quindi, di vagliare la loro valenza, non potendosi, al contrario, prendere le
mosse dal ragionevole dubbio per mettere in ordine logico le congetture.
Il processo penale, passaggio cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale del fatto-reato, è sorretto da
94
Scheda di giurisprudenza n. 9 ragionamenti probatori di tipo prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico
copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione della più probabile ipotesi
ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo dell’abduzione), rispetto ai quali i dati informativi e
giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza
dell’argomento del “deduttivo”, da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse. Il giudice è
impegnato nell’operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, conducenti
conclusivamente, all’esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di
responsabilità caratterizzato da “alto grado di credibilità razionale” o “conferma” dell’ipotesi formulata sullo
specifico fatto da provare: giudizio enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di “elevata probabilità
logica” (cfr. Sez. Un. 10 luglio 2002, n. 30328).
[...Omissis...]
95
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 10
La colpa professionale
TRACCIA
Tizio viene ricoverato d’urgenza in ospedale e sottoposto ad intervento di angioplastica coronarica perché
colpito da infarto acuto del miocardio, con grave insufficienza respiratoria. Dopo cinque giorni viene trasferito
dal reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato al suo arrivo, in quello di cardiologia.
Stabilizzatosi il quadro clinico, a distanza di nove giorni dal ricovero, Caio, medico cardiologo addetto alle
cure e alle terapie post-operatorie, decide di dimettere Tizio, attenendosi alle linee guida (o protocolli medici)
che prescrivono la dimissione allorché sia raggiunta la stabilizzazione delle condizioni cliniche del paziente.
Dall’anamnesi in precedenza effettuata era emerso, tuttavia, che Tizio era soggetto a rischio coronarie
trattandosi di fumatore, iperteso da anni, con rifiuto di terapia, affetto da ipertrigliceridemia ed obesità.
Nella stessa notte delle dimissioni e a poche ore dal suo rientro a casa, Tizio viene colto da insufficienza
respiratoria e trasportato d’urgenza in ospedale dove giunge in arresto cardiocircolatorio. L’autopsia
consente di accertare che Tizio è morto a causa di uno scompenso cardiaco.
Il dott. Caio, preoccupato delle conseguenze penali della propria condotta, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio rediga motivato parere.
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito involge la perimetrazione del concetto di colpa speciale o
professionale – la relativa fonte dell’obbligo da individuarsi nelle regole di condotta scritte, e
dunque in leggi, extrapenali o penali con specifica funzione cautelare, in regolamenti, in
discipline o infine in ordini, categoria che si contrappone alla c.d. colpa comune o generica –
la relativa fonte dell’obbligo da individuarsi nelle regole di condotta non scritte, quali le regole
sociali di diligenza, di prudenza e di perizia (MANTOVANI). In particolare, il fulcro della
discussione riguarda l’attività professionale svolta dal medico, un’attività utile sul piano
sociale, e per tale motivo consentita dall’ordinamento giuridico ma cionondimeno pericolosa.
Posto che la valutazione della condotta del medico, alla luce di un importante decisum della
Consulta (C. Cost., 28 novembre 1973, n. 166), prescinde del tutto dalle coordinate rilevanti in
ambito civile (nella specie, agli artt. 1176 e 2236 c.c.), dovendo essere esclusivamente
effettuata alla luce dei criteri propri del diritto penale, anche per quel che attiene alla colpa
generica, ci si è chiesti, in relazione alla colpa specifica, da ascrivere, nel caso, al medico
specialista (e per la quale le leges artis da prendere in considerazione non sono solo quelle di
carattere generale che ogni medico deve conoscere ed applicare, ma anche quelle speciali fissate
dalla migliore scienza ed esperienza del settore in cui il medico agisce, non essendo logico
richiedere allo specialista una perizia minore, in proporzione, rispetto a quella che si richiede al
medico generico), quale sia il rilievo da ascrivere alle c.d. linee guida ospedaliere, ossia a
quelle raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione
sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare i medici a decidere le
modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche (DE MATTEIS), considerate
una fonte di regole cautelari, attesa la loro ratio di tutela della salute del paziente (Cass. pen, Sez.
96
Scheda di giurisprudenza n. 10 IV, 14 novembre 2007, n. 10795).
Ci si è chiesti, in sostanza, se possa essere formulato un giudizio di responsabilità colposa
in capo al medico pur attenutosi in modo conforme a tali indicazioni.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
In giurisprudenza, prima dell’introduzione del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto
Balduzzi), convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, era pacifica l’irrilevanza del rispetto delle
linee guida ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità per colpa, orientamento modificato in
ragione di quanto disposto dal decreto citato.
C’è da precisare sulla legittimità costituzionale del decreto de quo, si è espressa
recentemente la Consulta (C. Cost., 6 dicembre 2012, n. 295), cui era stata rimessa la
questione dal Tribunale di Milano per presunta violazione degli artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33 e 111
Cost. ed in specie per contrasto con il principio di determinatezza (la locuzione “non risponde
penalmente per colpa lieve” risulta suscettibile di interpretazioni antitetiche) e con il principio di
uguaglianza-ragionevolezza, introducendo una scriminante per i medici a scapito di quei soggetti
che, pur venendo in contatto con i medesimi beni tutelati, siano sprovvisti di tale qualifica (nelle
specie, invero, la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile non avendo il
giudice a quo fornito adeguata motivazione sulla rilevanza).
2.1. Il primo orientamento: Possibile formulazione del giudizio di
responsabilità per colpa anche in capo al medico che si è attenuto al
rispetto delle linee guida.
Per una prima tesi (Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2010, n. 8254; Cass. pen., Sez. VI, 11 luglio
2012, n. 35922), ben sarebbe possibile formulare nei confronti del medico specialista un giudizio di
responsabilità per colpa anche qualora si sia attenuto al rispetto delle linee guida.
1° Argomento: parametri di valutazione della colpa del medico. Pur essendo vero che il
rispetto delle linee guida, quali leges artis, rappresenta un parametro utilizzabile dal giudice
nella valutazione dell’operato del medico, la Suprema Corte ha precisato che ciò di per sé non
esaurisce il profilo di doverosa diligenza e prudenza richiesta al medico, che ha l’obbligo
giuridico di adattare il proprio comportamento alle peculiarità del caso concreto e ove lo impongano
le circostanze concrete, non solo può, ma deve disapplicarle.
2° Argomento: inidoneità delle linee guida ad esaurire le regole di condotta sanitaria.
Unico fine del medico è, infatti, la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di
cui al tempo dispone la scienza medica e, nel perseguimento di tale scopo, non deve farsi
condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive
che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative
responsabilità. Il rispetto delle linee guida non può essere quindi univocamente assunto
quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico e
nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più
appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente.
Pertanto, non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo
97
Parte generale all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida,
comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui
al tempo la scienza medica dispone.
2.2. Il secondo orientamento: Esclusione del giudizio di responsabilità
per colpa lieve in capo al medico che si sia attenuto alle linee guida.
Per un secondo orientamento, nato sostanzialmente in ragione dell’adozione del decreto
Balduzzi (Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11493), ritiene, invece, che la responsabilità
per colpa specifica del medico possa essere esclusa ma solo nei casi di colpa lieve.
1° Argomento: tenore testuale dell’art. 3, d.l. n. 158/2012. Secondo la norma,
“l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice
civile”.
2° Argomento: distinzione fra colpa lieve e colpa grave. L’innovazione della
disposizione de qua è dunque consistita nell’introdurre per la prima volta nel diritto penale la
distinzione tra colpa lieve e colpa grave in relazione ai criteri di imputazione soggettiva del
reato. Tanto premesso, e ferma restando in ogni caso la responsabilità ex art. 2043 c.c., la
norma connette la punibilità del fatto al grado di colpa riscontrabile nella condotta del
sanitario. Così, il medico, che nello svolgimento della propria attività abbia rispettato le linee guida,
potrà rispondere dei reati colposi eventualmente commessi solo per colpa grave, mentre non sarà
punibile se ha agito con colpa lieve: se il professionista non valuta correttamente il quadro clinico e
non si discosta dalle linee guida, la sua responsabilità andrà esclusa se nell’erronea valutazione
sia ravvisabile una colpa lieve (PIRAS).
In sostanza, la colpa grave sarà configurabile nell’ipotesi in cui il medico non si sia
discostato dalle linee guida e la necessità di discostarsi da esse fosse macroscopica ed
immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell’imputato (GATTA).
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Esclusione del
giudizio di responsabilità per colpa lieve in capo al medico che si sia
attenuto al rispetto delle linee guida, ma solo in relazione ai comportamenti
imperiti.
La Suprema Corte (Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2014, n. 36347; Cass. civ., Sez. VI, 17 aprile
2014, n. 8940; Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2013, n. 46753; Cass. pen., Sez. IV, 18 giugno
2013, n. 39165; Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4030; Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio
2013, n. 16237), nell’affermare che, in virtù del decreto Balduzzi, le linee guida ospedaliere
entrano a pieno titolo fra i criteri che il giudice deve utilizzare per sindacare l’attività
professionale svolta da un sanitario, ha ritenuto doveroso tuttavia precisare che, pur vero che la
responsabilità per colpa del medico è esclusa in presenza del rispetto delle linee guida e
naturalmente, come prevede la norma, solo nei casi di colpa lieve, quest’ultima deve essere
riferita esclusivamente ai comportamenti imperiti, e non anche a quelli causati da negligenza o
98
Scheda di giurisprudenza n. 10 imprudenza.
1° Argomento: differenza ontologica. La valutazione della colpa medica debba essere
compiuta con speciale cautela nei soli casi in cui si richiedano interventi particolarmente delicati e
complessi e che coinvolgano l’aspetto più squisitamente scientifico dell’arte medica. patrimonio e
non anche di una causa illecita.
2° Argomento: perimetrazione dell’ambito di applicazione delle linee guida ai fini di
cui all’art. 3 d.l. n. 158/2012. Precisa ulteriormente la Corte che, perché le linee guida siano tali
da poter esonerare da responsabilità per colpa lieve il medico che ad esse si attenga, è
necessario che siano rispettose a loro volta di determinati parametri individuati dalla
comunità scientifica; qualora infatti si tratti di linee guida che non rispondano ai requisiti minimi
per essere definite tali, indichino standards diagnostico terapeutici non conformi alle regole dettate
dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente o che risultino, infine, ispirate a
esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese,
ponendosi per evidenti ragioni in contrasto con le esigenze di cura del paziente, non saranno
rilevanti ai fini del citato art. 3.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso che ci occupa, il medico Caio, in seguito alla morte di Tizio, paziente ricoverato d’urgenza,
sottoposto ad intervento e poi dal sanitario dimesso in applicazione di linee guida ispirate a logiche
prettamente economiche, non potrà beneficiare della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 3, d.l. n.
158/2012; invero, come la giurisprudenza ultima ha affermato, seppur vero che le linee guida rientrano ormai
fra i criteri che il giudice deve utilizzare ai fini della valutazione della condotta del medico, è altresì vero che le
medesime linee guida non saranno rilevanti ai fini del citato art. 3, qualora lo scopo ad esse sotteso sia
rispondente eminentemente a logiche economiche, in palese contrasto con la scopo primario dell’attività
medica, la cura del paziente.
Nella specie, Caio, nell’attuazione delle linee guida che prescrivono la dimissione allorché sia raggiunta la
stabilizzazione delle condizioni cliniche del paziente, aveva ritenuto di poter dimettere Tizio, non
considerando il quadro anamnico del medesimo, da cui emergeva evidente che si trattasse di soggetto a
rischio.
Alla luce di ciò, dunque, si ritiene che, in seguito alla morte di Tizio, Caio potrà andare incontro ad
un’imputazione di responsabilità per omicidio colposo.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237
Estratto
[...Omissis...]
9. Tale prima indagine sull’attendibilità delle linee guida non esaurisce l’itinerario che conduce
all’individuazione dell’approccio terapeutico appropriato. Sono infatti in questione la natura, la struttura e lo
scopo delle direttive. Si entra qui in un ambito che riguarda la conformazione delle linee guida e che tocca da
99
Parte generale vicino la comprensione del significato della novella di cui ci si occupa.
Una prima lettura della norma induce a cogliervi una contraddizione:
un terapeuta che rispetta le linee guida e che è al contempo in colpa. La contraddizione è in realtà solo
apparente. Per risolverla occorre considerare che, come si è sopra esposto, le linee guida, a differenza dei
protocolli e delle cheek list, non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma
propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto
applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico.
Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze
che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si
trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale
situazione, disciplinando l’evenienza di un terapeuta rispettoso delle “istruzioni per l’uso” e tuttavia in colpa.
10. Tale ricostruzione del ruolo non meccanicistico delle linee guida si rinviene nella giurisprudenza di questa
Suprema Corte. Da essa, nel complesso, emerge che l’osservanza o l’inosservanza delle guida terapeutica
indizia soltanto la presenza o l’assenza di colpa, ma non implica l’automatica esclusione o affermazione
dell’imputazione soggettiva. Le linee guida, in effetti, sono utilizzate frequentemente, con esiti tuttavia
variabili sulla sorte del processo.
Il tema è stato recentemente colto riassuntivamente (Cass. 4, 11 luglio 2012, n. 35922, Ingrassia), anche
attraverso la lettura della giurisprudenza più recente. Si è considerato che le linee guida hanno un rilievo
probatorio indubbio ma non esaustivo. Esse non possono fornire, infatti, indicazioni di valore assoluto: non si
può pregiudizialmente escludere la scelta consapevole del medico che ritenga, attese le particolarità del caso
clinico, di dover coltivare una soluzione atipica. D’altra parte, le raccomandazioni possono essere
controverse oppure non più rispondenti ai progressi nelle more verificatisi nella cura della patologia. È
evidente che i suggerimenti codificati contengono indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è
altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze
peculiari che caratterizzano ciascun concreto caso clinico. In ogni caso, i documenti devono essere in linea
con il sapere scientifico accreditato e non possono essere improntati all’esclusivo soddisfacimento di
esigenze di economia gestionale, trascurando le reali esigenze di cura.
11. La considerazione delle caratteristiche delle linee guida aiuta a comprendere la portata della nuova
normativa ed risolverne l’apparente contraddittorietà.
Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi
cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue
linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio
all’adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello
specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo
quando l’errore sia non lieve.
Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una
determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi
radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d’azione ordinaria. Una tale eventualità può essere
agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di
tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche
radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova
normativa.
Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con
riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l’adeguamento delle direttive allo
specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una
diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d’insieme, sarà censurabile, in ambito
penale, solo quando l’acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve.
Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell’ars
100
Scheda di giurisprudenza n. 10 medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e
magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la
valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla
difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato,
attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l’errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi
rimarchevole.
In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica
per l’esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze
punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi
commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Tale disciplina,
naturalmente, trova il suo terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia.
12. La protezione offerta non è però illimitata. Si vuoi dire che, alla stregua della logica della norma, la regola
d’imputazione soggettiva della sola colpa non lieve non interviene in tutte le situazioni In cui, nel corso del
trattamento, vi sia stata, in qualche frangente, l’attuazione di una direttiva corroborata. Al contrario, occorre
individuare la causa dell’evento, il rischio che in esso si è concretizzato. Si richiede altresì di comprendere se
la gestione di quello specifico rischio sia governata da linee guida qualificate, se il professionista si sia ad
esse attenuto, se infine, nonostante tale complessivo ossequio ai suggerimenti accreditati, vi sia stato alcun
errore e, nell’affermativa, se esso sia rimarchevole o meno. Naturalmente, si tratterà pure di valutare se una
condotta terapeutica appropriata avrebbe avuto qualche qualificata probabilità di evitare l’evento, ma in ciò
non vi è nulla di nuovo rispetto agli ordinari criteri di accertamento della colpa.
In conclusione, il paradigma di accertamento e valutazione della colpa che si è sinteticamente tratteggiato
seguendo la ratio della riforma non è sempre pertinente: l’indagine sulla correttezza della condotta medica
potrà esulare dall’ambito segnato da accreditate direttive scientifiche. Ciò potrà senz’altro accadere quando
tali direttive manchino o quando la questione di cui si discute nel processo concerna comunque un aspetto
del trattamento che esuli dal tema dell’aderenza alle ridette linee guida.
13. Resta, infine, da esaminare il tema più nuovo ed oscuro introdotto dalla nuova disciplina, quello della
distinzione tra colpa lieve e colpa grave.
È intanto da escludere senz’altro che si sia configurata un’esimente. Infatti, non si è in presenza di una
giustificazione che trovi la sua base in istanze germinate in altre parti dell’ordinamento giuridico. Nè può
pensarsi ad una scusante, cioè ad una causa di esclusione della colpevolezza.
Il legislatore ha evidentemente utilizzato lo strumento costituito dal modellamento della colpa che, come si è
visto, si rinviene nella tradizione penalistica italiana proprio in tema di responsabilità medica; e che si
riscontra pure in molti ordinamenti stranieri. Si è quindi scelto di distinguere colpa lieve e colpa grave.
La nuova normativa non ha definito le due figure, nè ha tratteggiato la linea di confine tra esse; e d’altra parte
non vi sono elementi per ritenere che si sia voluto far riferimento a categorie estranee alla tradizione
penalistica nazionale, quale si esprime nella già evocata giurisprudenza.
L’assenza di una definizione legale complica senza dubbio le cose.
L’esperienza giuridica insegna che, quando una categoria giuridica si scompone in distinte configurazioni,
l’interprete si trova solitamente ad affrontare complesse questioni che riguardano il tratteggio dell’area di
ciascuna figura e la collocazione nell’uno o nell’altro contenitore concettuale di comportamenti che si trovano
in una sfumata zona grigia sita ai margini del metaforico segno di confine. Tale compito si annunzia
particolarmente arduo in un ambito come quello di cui ora ci si occupa. Intanto, si è al cospetto del lato
soggettivo del reato, quello che per sua natura maggiormente sfugge all’umana comprensione, che assai
spesso non mostra clamorosi segni di sè e chiede al giudice l’immane compito di scorgere e ponderare
segni, indizi impalpabili dai quali inferire l’atteggiamento interiore. La difficoltà diviene massima nell’ambito
della colpa, figura soggettiva d’impronta marcatamente normativa, priva di contenuto psicologico: qui, in fin
dei conti, tutto si risolve nella valutazione che il giudicante esprime. Dunque, il peso dell’apprezzamento
tecnicamente “discrezionale” è massimo.
101
Parte generale Naturalmente, il giudizio sulla gravità della colpa non è per nulla estraneo all’esperienza giuridica penalistica.
Esso è imposto dall’art. 133 cod. pen.che prevede che la misura della pena debba essere commisurata
anche al grado della colpa, ma non fornisce alcuna indicazione sui criteri che debbono presiedere a tale
delicata valutazione. La graduabilità della colpa si desume altresì dall’art. 43 c.p.eart. 61 c.p., n. 3 che
configurano la colpa cosciente come un grado particolare e non come una figura autonoma di colpa. La
materia è scarsamente approfondita sia in dottrina che in giurisprudenza, soprattutto a causa dell’opinione
diffusa che il giudizio sulla colpa e sulla graduazione della pena sfugga ad una analisi razionale fondata su
basi logiche e sia alimentato prevalentemente da valutazioni su base intuitiva, che riguardano elementi
emotivi, la personalità dell’agente e l’atteggiamento nei confronti degli interessi in gioco. Ciò nonostante nella
riflessione dottrinale si rinvengono utili e sostanzialmente concordi indicazioni.
Si osserva che, poichè la colpa costituisce la violazione di un dovere obiettivo di diligenza, un primo
parametro attinente al profilo oggettivo della diligenza riguarda la misura della divergenza tra la condotta
effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva
attenere.
Occorrerà cioè considerare di quanto ci si è discostati da tale regola. Così, ad esempio, occorrerà analizzare
di quanto si è superato il limite di velocità consentito; o in che misura si è disattesa una regola generica di
prudenza. Occorrerà altresì considerare quanto fosse prevedibile in concreto la realizzazione dell’evento,
quanto fosse in concreto evitabile la sua realizzazione.
Vi è poi nel grado della colpa un profilo soggettivo che riguarda l’agente in concreto. Si tratta cioè di
determinare la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell’agente. Quanto più
adeguato il soggetto all’osservanza della regola e quanto maggiore e fondato l’affidamento dei terzi, tanto
maggiore il grado della colpa. Il quantum di esigibilità dell’osservanza delle regole cautelari costituisce fattore
importante per la graduazione della colpa. Ad esempio, per restare al nostro campo, l’inosservanza di un
norma terapeutica ha un maggiore disvalore per un insigne specialista che per comune medico generico.
Per contro il rimprovero sarà meno forte quando l’agente si sia trovato in una situazione di particolare
difficoltà per ragioni quali, ad esempio, un leggero malessere, uno shock emotivo o un’improvvisa
stanchezza.
Altro elemento di rilievo sul piano soggettivo è quello della motivazione della condotta. Come si è già
accennato, un trattamento terapeutico sbrigativo e non appropriato è meno grave se compiuto per una
ragione d’urgenza. Infine, un profilo soggettivo è costituito dalla consapevolezza o meno di tenere una
condotta pericolosa e, quindi, dalla previsione dell’evento. Si tratta della colpa cosciente, che rappresenta la
forma più prossima al dolo.
Peraltro, non sempre ed anzi di rado la valutazione della colpa è fondata su un unico indicatore. Ben spesso
coesistono fattori differenti e di segno contrario. In tale caso si ritiene che il giudice debba procedere alla
ponderazione comparativa di tali fattori, secondo un criterio di equivalenza o prevalenza non dissimile da
quello che viene compiuto in tema di concorso di circostanze. L’analisi comparativa diviene ancora più
complessa quando si presenti il concorso di colpa di più agenti o della stessa vittima.
Nella giurisprudenza non si rinvengono indicazioni analitiche circa i fattori di graduazione della colpa, ma solo
riferimenti impliciti o appena accennati alla distanza tra la condotta tenuta e quella pretesa, alla misura della
prevedibilità dell’evento.
14. La valutazione di cui si parla, normalmente altamente “discrezionale”, assume ora, nell’ambito della
responsabilità medica, un peso diverso, estremo. Essa segna l’essere o il non essere del reato. Dunque, non
si tratta più di graduare, ma di tentare di definire con qualche precisione il cruciale confine che determina
l’estensione dell’illecito. Si tratta di sfuggire, per quanto possibile, alla tentazione di ricorrere a sinonimi, ad
artifici retorici, ad itinerari argomentativi circolari, tautologici; ed occorre provare ad aggiungere, per quanto
possibile, qualcosa di definito, oggettivo e pertinente a ciò che l’idea di gravità del rimprovero intuitivamente
implica.
Il panorama normativo non fornisce aiuto concreto. In diverse norme compare l’evocazione della colpa grave,
102
Scheda di giurisprudenza n. 10 senza che segua alcuna definizione che possa ritenersi anche solo limitatamente pertinente al contesto. Per
contro, qualche indicazione può essere fornita propria dalla già evocata giurisprudenza di questa Corte
suprema.
Come si è visto, per un lungo periodo si è ritenuto che la responsabilità colposa del sanitario potesse
configurarsi solo in caso di macroscopica violazione delle regole più elementari dell’ars medica: la plateale
ignoranza o l’altrettanto estrema assenza di perizia nell’esecuzione dell’atto medico. Naturalmente, in casi di
tale genere non vi può essere dubbio sulla gravità della colpa.
Tuttavia tale definizione appare riduttiva. Essa si confronta con la marcata violazione delle regole basilari e
traccia la figura di un terapeuta radicalmente inadeguato rispetto al suo ruolo. Tuttavia, occorre considerare
che lo stato attuale della medicina appare assi più complesso e sofisticato: la valutazione sull’adeguatezza
dell’approccio terapeutico non può essere realisticamente rapportata a poche, essenziali regole di base. Al
contrario, si assiste al proliferare di complesse strategie diagnostiche e terapeutiche, governate da
“istruzioni” articolate, spesso tipiche di ambiti specialistici o superspecialistici. In tali contesti sarebbe riduttivo
discutere di gravità della colpa con riguardo alle sole regole basilari. Al contrario, l’entità della violazione delle
prescrizioni va rapportata proprio agli standard di perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pratiche
mediche o, In mancanza, da corroborate informazioni scientifiche di base. Quanto maggiore sarà il distacco
dal modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa; e si potrà ragionevolmente parlare di colpa
grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato definito
dalle standardizzate regole d’azione. Attraverso tale raffronto la ponderazione demandata al giudice
acquisisce una misura di maggiore determinatezza o, forse, solo di minore vaghezza.
Infatti non può essere taciuto che, per quanto ci si voglia sforzare di congegnare la valutazione rendendola
parametrata a dati oggettivi, a regole definite, e quindi non solo intuitiva, resta comunque un ineliminabile
spazio valutativo, discrezionale, col quale occorre fare i conti.
L’indicato criterio generale non appare incompatibile con la nuova normativa. La novella, infatti, come si è
visto, si riferisce ad un terapeuta che si sia mantenuto entro l’area astrattamente, genericamente segnata
dalle accreditate istruzioni scientifiche ed applicative e tuttavia, nel corso del trattamento, abbia in qualche
guisa errato nell’adeguare le prescrizioni alle specificità del caso trattato. Qui, verosimilmente, per misurare il
grado della colpa sarà scarsamente concludente il raffronto con le regole standardizzate, con le linee guida,
che si assumono rispettate nella loro complessiva, generica configurazione. Si può ragionevolmente
affermare che, in tale situazione, la colpa assumerà connotati di grave entità solo quando l’erronea
conformazione dell’approccio terapeutico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle
peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni del paziente.
Discorso non dissimile può esser fatto nel caso in cui il terapeuta si attenga allo standard generalmente
appropriato per un’affezione, trascurando i concomitanti fattori di rischio o le contingenze che giustifichino la
necessità di discostarsi radicalmente dalla routine. In tale situazione potrà parlarsi di colpa grave solo
quando i riconoscibili fattori che suggerivano l’abbandono delle prassi accreditate assumano rimarchevole,
chiaro rilievo e non lascino residuare un dubbio plausibile sulla necessità di un intervento difforme e
personalizzato rispetto alla peculiare condizione del paziente.
È chiaro che la ponderazione sulla gravità della colpa, nelle situazioni descritte sopra in coerenza con la
conformazione della nuova disciplina legale, tende ad allontanarsi dal piano delle regole oggettive e
standardizzate per concentrarsi su differenti criteri di valutazione. Si tratta di compiere un apprezzamento
basato sulle conoscenze scientifiche ed al contempo marcatamente focalizzato sulle particolarità del caso
concreto.
Gli strumenti concettuali per muoversi su tale terreno sono quelli della tradizione. Invero non si potrà
mancare di individuare le caratteristiche dell’atto medico, la sua complessità; e di definire la figura di
professionista, l’agente modello cioè, adeguatamente qualificato per gestire lo specifico rischio terapeutico; e
di comprendere se l’agente concreto si sia altamente discostato dallo standard di qualità dell’agire
terapeutico che il professionista archetipico esprime regolarmente. Si tratta del classico modello dell’homo
103
Parte generale eiusdem professionis et condicionis, di un professionista, cioè, che opera al livello di qualificazione
dell’agente concreto e che esprime un modo di operare appropriato, tipico. In breve, ci si sposta sul terreno
della colpa propriamente generica e si utilizza lo strumento di analisi dell’agente modello, accreditato sia in
dottrina che nella prassi. A tale riguardo occorre chiarire che questa Corte suprema non ha alcuna ragione
per prender parte alla disputa teorica tra quanti preferiscono accreditare un modello di valutazione della
condotta basato sulle regole e procedure scientifiche qualificate, nel segno delle oggettività e della
determinatezza e quanti, invece, preferiscono concepire un giudizio basato sul raffronto con la figura
archetipica e quindi inteso a valorizzazione le componenti più soggettive della colpa. L’enorme compito che
grava sul giudice lo induce senza riserve o incertezze ad un approccio eclettico: si usano gli strumenti di
analisi appropriati alla concreta situazione probatoria del processo.
A tali generali indicazioni di metodo si devono aggiungere altre più specifiche e forse anche più decisive. Per
articolare un giudizio sulla colpa ispirato al canone del rimprovero personale si dovrà porre speciale
attenzione alle peculiarità del caso concreto; ci si dovrà dedicare a considerare i tratti della specifica vicenda,
in linea con le istanze che si sono espresse nella recente giurisprudenza di legittimità e che sono state prima
sintetizzate.
Allora, non si potrà mancare di valutare la complessità, l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di
cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data. Neppure si potrà
trascurare la situazione nella quale il terapeuta si trovi ad operare: l’urgenza e l’assenza di presidi adeguati,
come si è esposto, rendono difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli standard. E quanto più la
vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la
propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del terapeuta che, pur uniformandosi ad una
accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e determini la negativa
evoluzione della patologia.
15. Occorre infine chiarire quale influenza abbia la nuova normativa sul caso in esame. Si pone un problema
di diritto intertemporale che trova piana regolamentazione alla luce della disciplina legale. Non pare dubbio,
infatti, che la riforma abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli
esercenti le professioni sanitarie ed, in particolare, per quel che qui interessa, di quella di cui all’art. 589 cod.
pen..
Come si è visto, la restrizione della portata dell’incriminazione ha avuto luogo attraverso due passaggi:
l’individuazione di un’area fattuale costituita da condotte aderenti ad accreditate linee guida;
e l’attribuzione di rilevanza penale, in tale ambito, alle sole condotte connotate da colpa grave, poste in
essere nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche. Insomma, nell’indicata sfera fattuale, la regola
d’imputazione soggettiva è ora quella della (sola) colpa grave; mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante
Tale struttura della riforma da corpo ad un tipico caso di abolitio criminis parziale. Si è infatti in presenza di
norma incriminatrice speciale che sopravviene e che restringe l’area applicativa della norma anteriormente
vigente. Si avvicendano nel tempo norme in rapporto di genere a specie: due incriminazioni di cui quella
successiva restringe l’area del penalmente rilevante individuata da quella anteriore, ritagliando
implicitamente due sottofattispecie, quella che conserva rilievo penale e quella che, Invece, diviene
penalmente irrilevante. Tale ultima sottofattispecie è propriamente oggetto di abrogazione. La valutazione
non muta se, per controprova, si guardano le cose sul piano dei valori: il legislatore ha ritenuto di non
considerare soggettivamente rimproverabili e quindi penalmente rilevanti comportamenti che, per le ragioni
ormai più volte ripetute, presentano tenue disvalore.
Il parziale effetto abrogativo, naturalmente, chiama in causa la disciplina dell’art. 2 c.p., comma 2, e quindi
l’efficacia retroattiva dell’innovazione. Tale ordine di idee trova conforto nella giurisprudenza delle Sezioni
unite di questa Suprema Corte: si è infatti condivisibilmente affermato che il fenomeno dell’abrogazione
parziale ricorre allorchè tra due norme incriminatrici che si avvicendano nel tempo esiste una relazione di
genere a specie (Sez un., 27 settembre 2007, Magera, Rv. 238197; Sez. Un. 26 marzo 2003, Giordano, Rv.
224607).
104
Scheda di giurisprudenza n. 10 Invero, quando ad una norma generale subentra una norma speciale “ci si trova in presenza di un’abolizione
parziale, perchè l’area della punibilità riferibile alla prima viene ad essere circoscritta, rimanendone espunti
tutti quei fatti che, pur rientrando nella norma generale venuta meno, sono privi degli elementi specializzanti.
Si tratta di fatti che per la legge posteriore non costituiscono reato e quindi restano assoggettati alla regola
dell’art. 2 c.p., comma 2, anche se tra la disposizione sostituita e quella sostitutiva può ravvisarsi una
parziale continuità” (Sez. Un. 26 marzo 2003, Giordano, cit.).
16. Ne discende che nel caso in esame la vicenda illecita dovrà essere nuovamente esaminata dalla Corte
d’appello. Infatti, come emerge esplicitamente dalla sentenza impugnata, il giudizio in ordine alla colpa si è
incentrato proprio sul tema delle linee guida e delle prassi terapeutiche, nonchè sulla loro osservanza da
parte del C.. Si è discusso se esistessero direttive scientificamente accreditate in materia, pertinenti alle
modalità di esecuzione dell’intervento ed in particolare alla profondità dell’Inserimento dello strumento
chirurgico. Si è pure dibattuto se le prescrizioni in questione fossero rigide ovvero elastiche, tanto che la
questione ha formato oggetto di specifico motivo di ricorso, incentrato sui ritenuto travisamento delle
indicazioni espresse al riguardo in un documento scientifico.
Ne consegue che il giudice di merito dovrà stabilire se il fatto si collochi nella sottofattispecie abrogata o in
quella ancora vigente.
L’indagine si muoverà con le cadenze imposte dalla riforma. Posto che l’innovazione esclude la rilevanza
penale delle condotte connotate da colpa lieve che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o
da pratiche mediche scientificamente accreditate, il caso dovrà essere riesaminato per determinare se
esistano direttive di tale genere afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione. Nell’affermativa, si
dovrà accertare se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali raccomandazioni. In tale
eventualità dovrà essere pure chiarito se nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.
Ne discenderà l’esistenza o meno dell’elemento soggettivo del reato alla stregua della normativa
sopravvenuta.
[...Omissis...]
105
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 11
L’elemento psicologico nella preterintenzione
TRACCIA
Tizia viene trovata morta nel sotterraneo di uno stabile disabitato, frequentato abitualmente da
tossicodipendenti.
Vicino al cadavere vi erano una siringa usata, con tracce di eroina al suo interno, e la
borsetta con alcuni effetti personali della donna.
Secondo il medico legale, il decesso, doveva essere fatto risalire a circa quarantotto ore prima ed era stato
determinato da “scompenso cardio-respiratorio per azione di sostanze d’abuso cocaina e oppioidi”. Inoltre, il
CT accertava che le punture presenti sul braccio destro difficilmente potevano essere state realizzate dalla
stessa vittima che era destrimane e rilevavano come Tizia non fosse solita iniettarsi eroina.
Le indagini svolte dalla Polizia, sotto la direzione del PM competente ratione loci conducevano ad accertare
che insieme alla donna fosse presente, al momento dell’iniezione di eroina, Caio suo compagno, assuntore
abituale di cocaina e piccolo spacciatore della medesima sostanza.
Lo stesso Caio, interrogato dal PM in presenza del suo difensore, ammetteva di avere effettuato l’iniezione
letale a Caia, dopo averle comprato la droga, eroina e cocaina, ricevendo quaranta Euro, e aver preparato il
mix di stupefacente.
A quel punto l’indagato aveva abbandonato la ragazza al suo destino.
Il PM iscriveva, quindi, Caio per il reato di omicidio preterintenzionale e omissione di soccorso.
Caio, preoccupato per le conseguenze delle proprie condotte, si rivolgeva ad un legale per avere
delucidazioni.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi cenni sull’elemento soggettivo della
preterintenzione, rediga motivato parere.
1. La questione.
L’art. 43 c.p., rubricato “Elemento psicologico del reato”, inserisce, tra il dolo e la colpa, la
preterintenzione, ritenendo sussistente il reato “preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando
dall’azione o dall’omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello
voluto dall’agente”. Invero, nulla è detto più di tale definizione e lo stesso legislatore classifica
come reati preterintenzionali sono due illeciti: l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale, di cui
all’art. 584 c.p., e l’ipotesi dell’aborto preterintenzionale, di cui all’art. 18, co. 2, l. 22 maggio
1978, n. 194. La dottrina (MANTOVANI) ha sottolineato che, per quel che concerne la sua struttura,
“nel delitto preterintenzionale, vi è la volontà di un evento minore – ad es., percosse o lesioni, che
ne rappresenta la base dolosa, e non volontà di un evento più grave, neppure a titolo di dolo
eventuale – ad es., morte, che è pur sempre conseguenza della condotta dell’agente”.
La scarsità di precisazioni ulteriori circa la portata e la natura della preterintenzione ha da subito
alimentato il dibattito concernente il criterio di imputazione all’agente del risultato più grave non
voluto; in particolare, la dottrina e la giurisprudenza si sono chieste se la preterintenzione
rappresenti un tertium genus oppure sia una forma di colpevolezza in qualche modo
assimilabile agli altri due elementi psicologici previsti dall’art. 43 c.p., il dolo e la colpa.
106
Scheda di giurisprudenza n. 11 2. Gli orientamenti dottrinali.
La portata e la natura della preterintenzione sono state oggetto nel tempo di diverse teorie,
avvicendatesi l’una all’altra ed elaborate soprattutto in dottrina.
2.1. Il primo orientamento: La tesi che nega autonomia alla
preterintenzione.
Per un primo e risalente orientamento, la preterintenzione non avrebbe avuto alcuna
autonomia: in considerazione del fatto che l’evento più grave non è del tutto non voluto, dovrebbe
essere assimilata al dolo, con l’unica differenza che l’azione voluta determina un risultato al di là
del volere.
2.2. Il secondo orientamento: La tesi del dolo misto a responsabilità
oggettiva.
Una seconda teoria (sostenuta in dottrina da Antolisei, Fiandaca-Musco ed in giurisprudenza da
Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114; Cass. pen., Sez. V, 2 ottobre 1996, n. 9197)
riteneva invece che l’elemento soggettivo in parola fosse integrato da un’ipotesi di dolo
misto a responsabilità oggettiva, in applicazione del principio qui versari in re illicita.
1° Argomento: ragioni di ordine formale. Non potendo essere ricompresa la
preterintenzione nell’ambito del dolo, attesa l’ontologica ed evidente diversità, per la stessa
ragione non sarebbe neanche possibile imputare il reato più grave non voluto a titolo di
colpa. E del resto, in ragione dell’art. 42 c.p., la colpa può essere accertata solo dove un’espressa
previsione di legge lo preveda e, a ben vedere, né l’art. 43 c.p. né l’art. 584 c.p. né l’art. 18, co. 2,
l. n. 194/1978 richiedono tale accertamento, con ciò implicitamente facendo dunque riferimento
al solo nesso di derivazione causale ai fini dell’imputabilità dell’evento più grave non voluto
in capo al soggetto agente.
2° Argomento: ragioni di ordine logico e sistematico. L’attribuzione dell’evento non
voluto a titolo di colpa, invero, si connoterebbe di illogicità; premesso che, perché siano integrati gli
estremi della colpa, è necessaria la violazione di una regola cautelare, l’ordinamento ponendo a
carico del soggetto agente l’obbligo della sua osservanza, l’illogicità sarebbe ravvisabile liddove,
volendo scorgere la colpa nella preterintenzione, il legislatore prima vieti e punisca certi
comportamenti e poi detti un regola di prudenza e di diligenza nel caso della loro
esecuzione.
Tale orientamento è stato tuttavia travolto dall’arresto della Corte Costituzionale, con la
nota sentenza n. 363/1988, con la quale la Consulta, ribandendo una volta per tutte la necessità
del principio di responsabilità per fatto proprio colpevole, di cui all’art. 27 Cost., ha reciso la
possibilità di imputazione a titolo di responsabilità oggettiva in relazione agli elementi significativi
della fattispecie, fra i quali naturalmente rientra anche l’evento più grave non voluto.
107
Parte generale 2.3. Il terzo orientamento: La tesi del dolo misto a colpa presunta.
La tesi del dolo misto a colpa presunta (BETTIOL) riteneva invece che l’atteggiamento colposo
fosse ricavabile dal fatto stesso della commissione del delitto doloso di base: la colpa sarebbe
così desumibile meccanicamente dall’inosservanza di una qualsiasi legge, a prescindere dal
suo contenuto cautelare.
1° Argomento: tenore testuale dell’art. 43 c.p. Il rinvio operato dall’art. 43, co. 1, c.p., a
leggi, regolamenti, ordini e discipline sarebbe talmente ampio da comprendere anche le leggi
penali, motivo per cui anche la violazione della norma incriminatrice integrerebbe gli estremi
dell’imperizia e dell’imprudenza necessari per integrare l’elemento psicologico minore.
Le critiche mosse nei confronti di tale tesi sono state invero le medesime rivolte contro la
teoria del dolo misto a responsabilità oggettiva: a ben vedere, infatti, una simile accezione di colpa
finirebbe con il risultare speculate ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
2.4. Il quarto orientamento: La tesi del dolo misto a colpa.
In ragione delle critiche mosse ai precedenti orientamenti, una quarta tesi (in dottrina, MANTOVANI
e in giurisprudenza Cass. pen., Sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055; Cass. pen., Sez. I, 26 aprile
2006, n. 19611) riteneva di poter inquadrare la preterintenzione in termini di dolo misto a
colpa: il primo al reato meno grave e la seconda all’evento più grave in concreto realizzatosi, e, ai
fini dell’imputazione, si deve verificare, di volta in volta, la concreta prevedibilità ed evitabilità
dell’evento maggiore
1° Argomento: coerenza con i principi fissati dalla Consulta. In applicazione del
decisum della Corte Costituzionale (sent. n. 364/1988) deve necessariamente postularsi la
colpa dell’agente almeno in relazione agli elementi più significativi della fattispecie, fra i quali
il complessivo ultimo risultato vietato se non si vuole incorrere nel divieto ex art. 27, co. 1 e 3, Cost.
della responsabilità oggettiva c.d. pura o propria.
Tuttavia, occorre precisare che si tratta di una particolare responsabilità colposa, posto che
la stessa si incardina in una precedente attività penalmente illecita. Pertanto l’evento più grave
realizzato dovrebbe essere addebitato in ragione della prevedibilità dell’evento: nelle ipotesi che
si fondano su una pregressa attività illecita, l’elemento caratterizzante sarebbe semplicemente
nella circostanza che il risultato ulteriore sia prevedibile da parte dell’autore del fatto.
2.5. Il quinto
soggettivo.
orientamento:
La
tesi
dell’unicità
dell’elemento
Un’ultima teoria, di recente elaborata in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2006, n.
13673), ritiene di poter qualificare la preterintenzione in termini di unicità dell’elemento
soggettivo che andrebbe individuato nel dolo del delitto meno grave, che finirebbe con
l’assorbire anche l’offesa più grave arrecata.
108
Scheda di giurisprudenza n. 11 3. La soluzione della giurisprudenza recente: L’unicità dell’elemento
soggettivo nel delitto preterintenzionale.
La giurisprudenza di legittimità recentemente (Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 2012, n. 31466;
Cass. pen., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 27161) ha fatto ricorso all’ultima tesi esaminata, e dunque
all’opzione dell’unicità dell’elemento soggettivo. In particolare, la questione al vaglio della
Suprema Corte involgeva un’ipotesi di omicidio preterintenzionale: il collegio ha ritenuto che l’art.
584 c.p. conterrebbe un proprio titolo esclusivo di responsabilità consistente nell’unicità
dell’elemento soggettivo del dolo richiesto per il reato base.
1° Argomento: tenore testuale dell’art. 43. La norma “assorbe la prevedibilità di un
evento più grave nell’intenzione di risultato, per il quale i parametri di negligenza, imprudenza o
imperizia men che di inosservanza sono assolutamente irrilevanti”.
2° Argomento: ragioni di ordine logico. “La ragione evidente è che chi agisce con dolo di
delitto di percosse o lesioni per definizione può prevedere l’evento più grave del risultato voluto,
indipendentemente dei parametri che servono a qualificare la colpa. Il rischio del verificarsi della
morte è implicito nell’offesa dell’incolumità personale”.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso che ci occupa, a ben vedere il titolo di imputazione nei confronti di Caio, ossia la responsabilità per
l’omicidio preterintenzionale di Tizia nonché per omissione di soccorso, potrebbe essere modificato all’esito
del processo; invero da quanto emerge dall’esame degli elementi forniti dalla traccia, e considerando i recenti
approdi giurisprudenziali, si dovrebbe parlare non di omicidio preterintenzionale, ma di omicidio volontario.
Dalla condotta di Caio, che aveva fatto scendere la ragazza nel sotterraneo di uno stabile disabitato, così da
renderla non visibile a chi vi accedeva, somministrandole non una dose di droga ma un mix letale,
abbandonandola mentre le sue condizioni stavano diventando irreversibili, sono desumibili infatti elementi
che confermerebbero la rappresentazione omicida di Caio e la sua previsione della morte di Tizia come
conseguenza altamente probabile del suo agire; tali dati escluderebbero la configurabilità dell’omicidio
preterintenzionale, che invece presupporrebbe, al contrario, la mancata rappresentazione da parte di Caio
della morte della ragazza come conseguenza della sua azione lesiva.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 2006, n. 13673
Estratto
[...Omissis...]
1.1 - Il delitto di cui all’art. 584 c.p. ha un titolo proprio ed esclusivo di responsabilità.
L’art. 42 c.p., fondando la regola di responsabilità nel dolo, prevede quali eccezioni il delitto
preterintenzionale e colposo. E infine afferma che la legge determina i casi in cui l’evento è posto altrimenti a
carico dell’agente come conseguenza della sua condotta.
Va perciò escluso che l’omicidio preterintenzionale sia punibile a titolo di dolo e responsabilità obiettiva
109
Parte generale insieme. Si era ritenuto che lo fosse per dolo misto a colpa (cfr. Cass., Sez. 5^ n. 10994/1981, rv. 151265;
9294/83 - 161038; 4836/85 - 169259; 2634/93 - 194325). Ma questa Corte (Sez. 5^, n. 13114/02, P.G. in
proc. Izzo, rv. 222054), giusta lettera della norma incriminatrice, afferma che l’elemento psicologico
dell’omicidio preterintenzionale è costituito unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare
lesioni.
Per intendere la ratio normativa, va innanzitutto osservato che l’art. 43 c.p., costruisce l’elemento psicologico
quale causalità morale, in parallelo a quella materiale (art. 40 c.p.), fondandola sul rapporto tra intenzione,
costituita da volontà e previsione del risultato della condotta, ed evento conseguente alla stessa condotta.
Definendo il delitto doloso secondo l’intenzione, l’articolo pone la regola di responsabilità nella
corrispondenza dell’evento, da cui dipende l’esistenza del reato, all’intenzione di risultato. La corrispondenza
permane nel delitto preterintenzionale, nel quale è superata solo dalla maggior gravità dell’evento.
La corrispondenza è invece esclusa nel delitto colposo nel quale l’evento, seppure preveduto, è in contrasto
con il risultato intenzionale. Ed è per questa ragione che l’art. 43 c.p., detta quali parametri di causalità
morale (“quando l’evento ... si verifica a causa di ...”) la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia o l’inosservanza
di norme da parte dell’agente.
Ciascun parametro si rapporta alla categoria logica di prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del
reato, come conseguenza della condotta, e serve a dimostrare superabile dall’agente l’inconsapevolezza
dell’esigenza di diverso comportamento. Tanto basta. Perciò, se nel delitto colposo si agisce nonostante la
previsione dell’evento, l’art. 61 c.p., n. 3 prevede un’aggravante: la possibilità cognitiva è superata dalla
consapevolezza.
La tassativa limitazione dell’aggravante al delitto colposo conferma che la previsione dell’evento da cui
dipende l’esistenza del reato è componente necessaria e non circostanziale nel delitto preterintenzionale,
come in quello doloso. Il sistema dunque significa che quanto al delitto preterintenzionale, la disposizione
dell’art. 43 assorbe la prevedibilita di evento più grave nell’intenzione di risultato, per il quale parametri di
negligenza, imprudenza o imperizia, men che d’inosservanza di norme sono assolutamente irrilevanti.
È per esempio incontroverso che l’essere l’agente privo di conoscenze mediche, tali da consentirgli di
prevedere l’evoluzione nell’evento morte del risultato lesivo intenzionale, non pone questione di imperizia,
pur a fronte di complessa ricostruzione medico - legale del nesso causale. La ragione evidente è che chi
agisce con dolo di delitto di percosse o lesioni per definizione può prevedere l’evento più grave del risultato
voluto, indipendentemente dai parametri che servono a qualificare la colpa. Il rischio del verificarsi della
morte è implicito nell’offesa dell’incolumità personale, tant’è che se l’agente prevede l’evento morte, il delitto
è secondo l’intenzione, e va qualificato omicidio volontario.
Difatti, come si è premesso, la piena corrispondenza dell’intenzione, intesa previsione e volontà di risultato,
all’evento conseguito alla condotta, integra dolo generico del delitto di cui all’art. 575 c.p.. E, secondo diritto
vivente, è irrilevante che alla previsione dell’evento si associ l’opzione di risultato meno grave perchè,
agendo, si vuole anche quello più grave, secondo causalità naturale della propria condotta (dolo eventuale o
indiretto). Tanto, paradossalmente, riconosce proprio la giurisprudenza del doppio elemento psicologico.
L’errore ermeneutico è dunque dovuto al travisamento della categoria (idea) di prevedibilità, per la colpa
(concetto), che è una specie del genere elemento psicologico. Ma se la prevedibilità va codificata in un
carattere (negligenza, imprudenza, etc.) necessario del delitto colposo, perchè l’evento si verifica contro
l’intenzione, questa necessità non esiste nel delitto preterintenzionale, a fronte dell’intenzione del risultato
della condotta.
1.2 - A riprova strutturale, l’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale è unico, perchè ad esso
corrisponde un solo evento, da cui dipende l’esistenza del reato.
Tanto trova conferma, oltre che nella lettera della norma incriminatrice in rapporto al dettato dell’art. 15 c.p.,
nelle norme sul concorso di reati. Si ritorni alla lettera delle norma.
Secondo l’art. 584 c.p., la condotta consiste in atti diretti a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 581 o
582 c.p., mentre l’evento cagionato, da cui dipende l’esistenza del delitto, è la morte. Per diritto vivente
110
Scheda di giurisprudenza n. 11 (giurisprudenza costante da Cass. 13.10.64, Viti in CPMA 65,488 e v. Sez. 5^, 4793/88, CED rv. 178180) la
lettera significa sufficiente il tentativo di percosse, men che di lesione, per la punibilità a titolo di omicidio
preterintenzionale (se per es. ad un atto aggressivo, che non attinga il corpo dell’offeso, segua un infarto).
Orbene, se l’agente ha voluto un evento minore omogeneo, quale conseguenza della condotta ai sensi
dell’art. 581 o 582 c.p., la progressività del delitto di cui all’art. 584 c.p., implica, giusta la regola dell’art. 15
c.p., assorbimento del delitto sussidiario di cui all’art. 581 o 582 c.p..
Proprio il riferimento all’art. 586 c.p., la cui disposizione parallela è tratta a conforto dalla teoria del “doppio
elemento psicologico”, lo conferma. L’art. 586 c.p., disciplina un delitto “contro l’intenzione”, perchè l’evento
mortale, o anche solo lesivo si badi (e v. oltre, dove si osserva perchè non è previsto anche il delitto di
lesione preterintenzionale), è conseguenza non voluta di un delitto doloso non sussidiario.
La disposizione si fonda dunque, al contrario di quella di cui all’art. 584 c.p., sulla disomogeneità dell’evento
lesivo o mortale, rispetto al risultato prefigurato e voluto dall’agente, tant’è che rinvia all’art. 83 c.p., che
disciplina l’aberrazione e a sua volta stabilisce bensì che l’agente risponda a titolo di colpa del delitto
qualificato dall’evento diverso, quando il fatto è preveduto come delitto colposo, ma conferma il concorso di
reati, se l’agente ha cagionato anche l’evento voluto. L’art. 586 c.p., dunque, non si rifà alla regola dell’art. 15
c.p., ma a quella del concorso di reati, perchè i due eventi eterogenei, ovvero rapportabili a norme che
disciplinano diversa materia, implicano ciascuno un proprio elemento psicologico.
Viceversa l’art. 584 c.p., non richiede un ulteriore elemento psicologico oltre il dolo di delitto sussidiario,
perchè l’evento da cui dipende l’esistenza del reato progressivo è unico.
1.3 - Per concludere sul perchè la prevedibilità non assurge a carattere distinto dell’omicidio
preterintenzionale, è necessario verificare il rapporto con la realtà fenomenica.
Orbene, si è visto, l’esperienza dimostra che il rischio di evento omogeneo più grave è insito nel danno o
pericolo che si arreca alla persona fisica. E nel sistema l’interesse primario, che accomuna i beni essenziali
della persona, è complessivamente tutelato in ragione dell’idea (categoria) di inevitabilità dell’evento più
grave, conseguente al processo naturale attivato con la condotta umana. Si tratta della stessa idea per cui la
legge afferma in via generale che la causalità umana non è esclusa da cause concorrenti precedenti,
simultanee o sopravvenute, indipendenti dall’azione (art. 41 c.p.).
Su questa premessa si rifletta innanzitutto sul perchè la legge non prevede il delitto di lesione
preterintenzionale: il delitto di percosse e quello di lesione concernono oltre che lo stesso interesse, lo stesso
bene incolumità. Perciò se, percuotendo una persona, dalla condotta scaturisce un processo morboso (per
es. da trauma), il delitto va qualificato ai sensi dell’art. 582 c.p., e, in ipotesi di maggior gravità,
progressivamente aggravato ai sensi dell’art. 583 c.p.. La ratio di questa disciplina è incontestata sul piano
obiettivo e psicologico.
Ma la vita, che si rapporta bensì allo stesso interesse, costituisce quel bene diverso ed omogeneo, sulla cui
tutela s’incentra tutto il sistema penale. E, fermo che se si usa violenza fisica alla persona per cagionare
sofferenza o malattia, non si è per definizione in grado di potere escludere che cause indipendenti dalla
condotta, seppure ignote al momento di agire, possano concorrere a cagionare la morte, è evidente perchè il
sistema, per sorreggere la disciplina dell’unica ipotesi di delitto preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p.,
disciplina una specie autonoma di responsabilità morale nell’art. 43 c.p..
È questa la ragione per cui, in caso di omicidio preterintenzionale, il giudice non deve verificare se l’evento
morte fosse prevedibile secondo un parametro legale, dettato per la colpa, ma solo se l’agente ha agito con il
dolo di cui all’art. 581 o 582 c.p..
La prevedibilità dell’evento più grave è assorbita nell’intenzione di risultato del delitto contro la persona fisica,
mentre la speculazione teorica del doppio elemento psicologico, pone la disciplina normativa fuori della
realtà.
1.4 - È pertanto singolare che la motivazione della sentenza impugnata concluda che la previsione
dell’evento non è necessaria, altrimenti nella specie sarebbe stata contestata l’aggravante di cui all’art. 61
c.p., n. 3 esclusa in concreto. In tal modo travisa che l’aggravante si applica solo ai delitti colposi, e non può
111
Parte generale essere applicata all’omicidio preterintenzionale, ed autorizza l’argomentazione infondata del ricorso.
All’evidenza era sufficiente la risposta già resa che la H. aveva di certo voluto offendere l’incolumità
personale della E., per dimostrare corretta l’inferenza della sua responsabilità a titolo di omicidio
preterintenzionale per la morte cagionata.
2 - Il ricorso è infine giunto a contestare l’illegittimità dell’art. 584 c.p., in rapporto all’art. 27 Cost.. La verifica
dell’equivoco dialettico, in cui è già incorso in passato questo Giudice di diritto, a cui altrimenti si rifà
altrimenti il ricorso, dimostra la manifesta infondatezza della questione.
Questa Corte aveva difatti già ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale,
proprio con l’affermazione che la giurisprudenza configura la preterintenzione come dolo misto a colpa
(Cass. Sez. 5^, n. 2634/93, rv. 194325, cit).
Sennonchè la difesa non ha osservato che, motivandola, tradisce l’equivoco spiegando che l’evento non si
rapporta a responsabilità oggettiva, ma ad una prevedibilità di minimo profilo. In tal modo ammette
implicitamente che non si è in presenza dei parametri posti dall’art. 43 c.p., circa il delitto colposo, che
concernono l’intenzione diretta ad altro risultato della condotta, perciò contro l’evento. Ma non trae
l’implicazione realistica che la prevedibilità dell’evento più grave è in caso di delitto preterintenzionale
categoria irrilevante per la struttura dell’elemento psicologico, assorbita nel dolo di percosse o lesioni.
Orbene, l’art. 27 Cost., non trascura affatto che il disvalore del reato è segnato oltre che dal nesso di
causalità tra condotta ed evento (art. 40 c.p.), dal rapporto dell’elemento psicologico con lo stesso evento
(art. 43 c.p.).
È quanto si evince dall’ordinanza 152/84 e dalla sentenza 364/88 del Giudice di legittimità (menzionate da
Cass. 13114/02, cit.). In questi provvedimenti si afferma che l’art. 27 Cost., comma 1, propugnando il
principio di responsabilità personale, esclude quella per fatto di terzi (e perciò stesso già riconosce come
centrale del sistema penale il rapporto causale dell’evento con la condotta dell’agente) e non contiene
tassativo divieto di responsabilità oggettiva (art. 42 c.p., comma u.), perchè il precetto va combinato quello di
cui al comma con il 3 (che si occupa dell’emenda del reo).
Per quanto interessa la responsabilità morale ai sensi dell’art. 584 c.p., quest’ultima non rileva come
concessiva perchè, conclude il Giudice di legittimità, è l’insieme degli elementi costitutivi di ciascun reato a
significarne la ragione di incriminazione ed il metro di punibilità. Spetta dunque a questa Corte, per il suo
compito nomofilattico, volto alla realizzazione del diritto vivente, spiegare la ragione di incriminazione, e
affermare che nel caso non entra minimamente in giuoco la responsabilità obiettiva, men che la colpa, bensì
solo il dolo di evento minore, che assorbe la prevedibilità dell’evento omogeneo più grave.
La ratio dell’art. 584 c.p., risulta insomma conforme al dettato costituzionale, in quanto si fonda sul rapporto
dell’elemento psicologico di un delitto preveduto e voluto contro l’incolumità, con l’evento morte come
conseguenza perciò stesso prevedibile della condotta.
3 - Passando alle questioni di premessa di fatto della sentenza impugnata, il 1^ motivo è infondato, al di là
della lettera della motivazione, che pure afferma: “la frattura è derivata non dalla caduta, ma dal violento
calcio inflitto alla vittima già per terra”. Questa frase a prima vista collega gratuitamente il trauma pelvico
fratturativo, che immobilizzava l’arto inferiore sinistro della E., da cui è scaturita la morte, al calcio da lei
ricevuto in terra a destra nell’inguine, come pure riferito (pg. 2).
L’asserto denuncia un travisamento, che è bensì evidente, ma irrilevante.
La frase difatti va letta nel contesto ricostruttivo, che riassume nella frase precedente a quella censurata,
quanto esposto in dettaglio dalla sentenza di 1^ grado, con il rilievo che se la donna (di età avanzata) “è
caduta a seguito del parapiglia, tale parapiglia è stato cagionato dall’imputata”. Ed è incontestato dal ricorso
che la H. l’aveva repentinamente percossa, afferrata per i capelli e strattonata, ed ha continuato nella sua
azione violenta con calci, tra cui quello all’inguine, quando è caduta in terra nel parapiglia, seguito al tentativo
delle altre donne presenti di fermarla nella sua azione violenta.
Ne segue per quanto interessa che la caduta, men che rapportabile a fatto di terzi, non è ritenuta estranea
alla condotta dell’imputata dai Giudici di entrambi i gradi di merito, bensì dovuta proprio all’azione incriminata.
112
Scheda di giurisprudenza n. 11 Essi non hanno perciò rilevato alcun elemento di segno contrario idoneo ad escludere il nesso causale, posto
che l’anziana persona offesa, prima di essere aggredita con violenza da lei e di cadere durante il “parapiglia”
sorto per fermarla, ovvero consecutivo all’azione, era seduta e sicura sulla panchina. Pertanto il
ragionamento complessivo si sottrae alla censura di manifesta illogicità (contraddittorietà o mancanza di
motivazione che si voglia).
Resta l’ultima questione, secondo la quale la Corte di merito individuando, quale causa dell’evento, un tipico
atto diretto a ledere (art. 582 c.p.) e non invece, come correttamente avrebbe dovuto fare, un insieme di atti
diretti ad indurre un altro soggetto a desistere da una condotta già oppressiva dell’offesa (art. 610 c.p.), ha
ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 584 c.p., in luogo della fattispecie prevista e punita dall’art. 586 c.p..
L’argomento è non consentito per l’implicazione di valutazione alternativa che prospetta in questa sede.
Secondo la ricostruzione di fatto delle sentenze, l’intento offensivo dell’incolumità sino a livello di lesione è
dimostrato dall’insieme della condotta violenta contro la persona, attestato a partire dallo schiaffo e
dell’afferrare la donna per i capelli a finire proprio con quel calcio peraltro non unico, quale che fosse il
movente della condotta.
Ed è anche manifestamente infondato. Se i Giudici di merito avessero ritenuto che l’agente aveva anche lo
scopo rilevante di costringere l’offesa ad un non fare, si sarebbero trovati in presenza di concorso di reati,
non alla necessità di qualificare diversamente lo stesso fatto, insopprimibili gli estremi di delitto di lesione in
rapporto al più grave evento cagionato. Il richiamo all’art. 586 c.p., posto a suffragio dal ricorso, perciò
implica altro travisamento degli estremi di reato, stavolta non avallato da alcuna giurisprudenza.
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 27161
Estratto
[...Omissis...]
Il primo motivo fa leva su una discutibile e non conferente interpretazione del quesito peritale, secondo cui
dal giudice del rinvio sarebbe stato negato al perito d’ufficio non solo l’accesso alla consulenza tecnica
disposta dal Pm nella fase delle indagini preliminari (depositata solo dopo la richiesta di giudizio allo stato
degli atti da parte dell’imputato) ma anche al verbale autoptico, dal quale sarebbe risultata l’assenza di
ecchimosi sul viso della vittima, l’origine non traumatica dell’epistassi dal naso e l’origine non recente della
riscontrata avulsione di un dente. In realtà tale preclusione non risulta e il perito d’ufficio è comunque giunto a
conclusioni attendibili sulla base della documentazione in suo possesso. Ma il rilievo, oltre che fondato su
una soggettiva interpretazione della difesa, neppure è conferente, laddove mira essenzialmente a contestare
la violenza del colpo, che (senza arrivare a negarlo) è reiteratamente definito “buffetto” (cioè un colpetto
leggero dato con la mano). Dalla premessa di fatto le deduzioni teoriche, secondo cui l’evento non sarebbe
giuridicamente attribuibile all’Imputato (per l’assenza del coefficiente di prevedibilità) bensì allo stato di
alterazione alcolica della vittima, di cui l’imputato stesso non poteva essere consapevole. Ebbene, a parte la
notazione di fatto per la quale i due, prima di decidere di affrontarsi a pugni, si erano ubriacati insieme
(donde la comune consapevolezza di ciò), sotto il profilo giuridico la difesa trascura la pacifica giurisprudenza
di legittimità in tema di omicidio preterintenzionale. Particolarmente recente, si veda ad esempio Cass., sez.
5, sent. n. 791 del 18/10/12, dep. 8/1/13, rv. 254386: “L’elemento soggettivo del delitto di omicidio
preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva nè dal dolo misto a colpa, ma
unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p. assorbe la
prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità
dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, essendo assolutamente
probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa”. Ancora
113
Parte generale (Cass., 5, sent. n. 3SS82 del 27/6/12, rv. 253536): “L’elemento soggettivo del delitto di omicidio
preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse
o provocare lesioni, a condizione che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta
dell’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello
effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio”. Ma anche
5, n. 40389 del 17/5/12, rv. 253357: “L’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale è costituito
unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 cp assorbe la
prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato”. A proposito, infine, della pretesa lievità della
spinta (o buffetto) si veda Cass., 5, sent. n. 16285 del 16/3/10, rv. 247267: “Ai fini della sussistenza
dell’ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale è sufficiente che l’agente abbia posto in essere
atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e
l’evento morte, mentre proprio l’azione violenta (che può essere costituita anche da una spinta) estrinsecandosi in una energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della
persona - ove consapevole e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per
cui quando da essa derivi la morte, da luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale (art. 584
c.p.)”. È appena il caso di osservare come nulla rilevi nella fattispecie il piano di parità in cui si potessero
trovare i due contendenti.
Infondato anche il secondo motivo (sostenuto su analoghi argomenti), circa il preteso concorso doloso della
vittima nella determinazione dell’evento. Anche in proposito la giurisprudenza di legittimità è netta
nell’affermare che la circostanza attenuante comune (ex art. 62 c.p., n. 5) del concorso del fatto doloso della
persona offesa non è applicabile ai reati di rissa e a quelli connessi, “non essendo invero concepibile
(omissis) che le vittime abbiano voluto, su di sè, lo stesso evento (morte o lesioni) voluto in loro danno dagli
antagonisti” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 49966 del 5/11/09, rv. 245955). Affinchè si configuri l’attenuante in
parola, il fatto voluto dalla parte offesa deve essere cioè lo stesso, effettivamente verificatosi, voluto dal
soggetto agente.
[...Omissis...]
114
Scheda di giurisprudenza n. 12 Scheda di giurisprudenza n. 12
La responsabilità dello spacciatore per morte dell’assuntore
TRACCIA
Tre amici, Tizio, Caio e Sempronio, decidono di consumare insieme eroina, come spesso avviene all’interno
del loro gruppo.
Per tale ragione, raccolti i soldi, Tizio si reca a farne acquisto da uno spacciatore, già suo rifornitore da tempo
e del quale si fida. Il gruppo, quindi, consuma lo stupefacente nel corso di un festino a base di alcoolici.
Subito dopo l’assunzione, Caio accusa un grave malore e, dopo essere stato soccorso e portato in ospedale,
muore in ragione dell’interazione tra l’eroina, l’alcool e i farmaci che Caio assumeva in quel momento per
motivi di salute.
La polizia, grazie anche alla collaborazione di Tizio e Sempronio, riusciva ad identificare lo spacciatore in
Mevio. Quest’ultimo viene rinviato a giudizio con l’imputazione dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del
1990, 83 e 586 cod. pen..
Mevio, quindi, si rivolge ad un legale per ottenere chiarimenti circa la propria responsabilità penale per la
morte di Caio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevio, rediga motivato parere.
1. La questione.
La questione si inquadra nell’ambito della responsabilità per morte o lesioni non volute di cui
all’art. 586 c.p.: in relazione alla natura e al criterio di imputazione della relativa responsabilità
sono ravvisabili in giurisprudenza ed in dottrina diversi orientamenti.
Va premesso che l’art. 586 c.p. prevede che quando da un fatto previsto dalla legge come
delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta del colpevole, la morte o la lesione di
una persona, si applicano le disposizioni contemplate dall’art. 83 c.p., ma le pene previste
per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. sono aumentate. Si tratta di una norma di chiusura e
di rafforzamento del sistema di tutela dei bene giuridici della vita e dell’incolumità fisica, che
trova applicazione nei casi appunti in cui la morte o le lesioni siano conseguenza non voluta di un
qualsivoglia delitto doloso, anche solo tentato. Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che
tale norma sia un’applicazione speciale dell’art. 83 c.p., rispetto al quale prevede una disciplina
più severa in virtù dell’importanza del bene protetto. In particolare, l’art. 83 c.p. prevede che, fuori
dai casi del precedente art. 82 c.p., qualora, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o
per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a titolo
di colpa dell’evento non voluto, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. In
entrambe le fattispecie, dunque, vi è identità di struttura: ad un’azione dolosa segue infatti la
produzione di un evento non voluto. Tuttavia, a differenza dell’art. 83 c.p., l’art. 586 c.p. non
richiede che la responsabilità per il secondo evento sia subordinata all’indagine sull’errore dei
mezzi di esecuzione o sull’altra causa. Ulteriori cause di distinzione delle fattispecie sono poi
rinvenibili nella natura dell’offesa non voluta nonché nella previsione di una circostanza aggravante
da parte dell’art. 586 c.p.
115
Parte generale 2. Gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità dello
spacciatore per morte dell’assuntore.
La questione dei criteri di imputazione soggettiva del reato non voluto è stata oggetto di un
lungo dibattito sorto a proposito della responsabilità dello spacciatore per morte del
tossicodipendente a seguito di assunzione della sostanza stupefacente acquistata.
Nel tempo si sono avvicendate quattro tesi.
2.1. Il primo orientamento: L’accertamento del nesso di causalità.
A mente di un consistente orientamento, ormai risalente nel tempo (Cass. pen., 17 aprile 1939;
Cass. pen., 10 aprile 1945; Cass. pen., Sez. I, 14 aprile 1982, n. 156067; Cass. pen., Sez. I, 25
marzo 1985, n. 169934; Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 1988, n. 179343; Cass. pen., Sez. II, 14
febbraio 1990, n. 184598; Cass. pen., Sez. I, 28 maggio 1993, n. 194773; Cass. pen., Sez. II, 15
febbraio 1996, n. 205374; Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2006, n. 234187.), sarebbe sufficiente,
per affermare la responsabilità del venditore, il solo accertamento del nesso di causalità non
interrotto da eventi eccezionali e, in presenza di plurime cessioni di sostanza stupefacente,
successive l’una all’altra, le cessioni intermedie non inciderebbero al punto di interrompere il
nesso di causalità.
1° Argomento: centralità dell’accertamento del nesso eziologico. Ciò che rileverebbe
sarebbe solo l’indagine sulla condotta esecutiva dell’agente al fine di verificare che il nesso di
causalità non sia stato interrotto da fattori eccezionali non ascrivibili a quest’ultimo poiché al di
fuori della sua sfera di controllo.
2° Argomento: natura della responsabilità ex art. 586 c.p. La norma, al pari dell’art. 83,
co. 2, c.p. (aberratio delicti plurilesiva), disciplinerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in
forza della quale il soggetto agente deve rispondere del delitto e delle sue conseguenze ulteriori
anche non volute, purché ad esso connesse.
2.2. Il secondo orientamento: La responsabilità per colpa specifica.
Secondo un altro orientamento (Cass. pen., Sez. V, 9 novembre 1988, n. 183396; Cass. pen., Sez.
VI, 27 ottobre 1992, n. 193239; Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 1994, n. 197848), l’art. 586 c.p.
disciplinerebbe invece una fattispecie di responsabilità per colpa specifica, fondata
sull’inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso.
1° Argomento: l’art. 586 c.p. ha natura di norma di chiusura e di rafforzamento del
sistema di tutela della vita e dell’incolumità fisica. In ragione di tale natura, l’articolo trova
applicazione qualora la morte sia la conseguenza di un delitto doloso, qualunque ne sia la natura e
dunque anche quando il fatto tipico di per sé non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto,
sempre che, naturalmente, fra il comportamento illecito del soggetto agente e l’evento dannoso
non voluto siano legati dal nesso di causalità.
2° Argomento: valorizzazione dell’art. 43 c.p. L’evento lesivo non voluto sarebbe
addebitato al soggetto agente a titolo di colpa per violazione di legge in quanto l’art. 43 c.p.
annovera fra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi anche l’inosservanza della legge:
116
Scheda di giurisprudenza n. 12 la colpa, in altre parole, secondo tale impostazione, non sarebbe limitata alla sola violazione
delle norme cautelari, ma comprenderebbe anche la violazione delle stesse norme penali.
2.3. Il terzo orientamento: La responsabilità per colpa, da accertare
sulla base della c.d. prevedibilità in astratto.
Un terzo orientamento (Cass. pen., Sez. VI, 6 dicembre 1988, n. 180420; Cass. pen., Sez. V, 9
novembre 1988, n. 183396; Cass. pen., Sez. VI, 14 novembre 1988, n. 179839; Cass. pen., Sez.
VI, 24 gennaio 1989, n. 180747; Cass. pen., Sez. VI, 27 ottobre 1992, n. 193239; Cass. pen., Sez.
VI, 11 marzo 1994, n. 197848), ai fini dell’addebitabilità della responsabilità de qua al soggetto
agente, richiede non solo l’accertamento del nesso causale, ma anche la prevedibilità
dell’eventi, riferendosi con ciò alla prevedibilità in astratto.
1° Argomento: valorizzazione del criterio della prevedibilità in re ipsa. In virtù di tale
criterio, non verrebbe condotta in concreto alcuna indagine circa il decorso causale e l’evento
finale: si parla in tal senso di prevedibilità desunta dalla notorietà, dall’ordinarietà o dalla
frequenza del pericolo connesso ad un certo tipo di condotta o, ancora, di prevedibilità
secondo l’id quod plerumque accidit, desunta dal pericolo insito nel delitto doloso di base. Nella
specie, la prevedibilità dell’evento verrebbe automaticamente dedotta dalla destinazione della
droga ceduta, dall’assunzione e dalla constatazione che, secondo appunto la comune esperienza,
può provocare la morte dell’assuntore.
2.4. Il quarto orientamento: La responsabilità per colpa in concreto.
Un’ultima tesi, elaborata relativamente di recente in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. I, 19 ottobre
1998, n. 11055; Cass. pen., Sez. I, 14 novembre 2002, n. 2595; Cass. pen., Sez. Vi, 7 febbraio
2006, n. 14302; Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2007, n. 12129; Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre
2012. N. 41462), ritiene invece che “in tema di responsabilità penale per morte o lesioni
costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere
sussistente la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale (purché
non interrotto ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p., da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la
precedente condotta e l’evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la
sussistenza di un coefficiente di prevedibilità della morte o delle lesioni, sì da potersene
dedurre una forma di responsabilità per colpa” (Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2006, n. 14302).
1° Argomento: superamento delle forme di responsabilità oggettiva. Devono essere
ricordati gli interventi della Corte Costituzionale, che nel tempo hanno premuto affinché al
principio di colpevolezza fosse dato il giusto peso. La Suprema Corte, già con la nota sentenza
n. 364/1988, costituzionale, sulla base di una approfondita esegesi dell’art. 27 Cost. (imperniata
sul collegamento tra il principio di personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa
della pena), aveva identificato la responsabilità personale, richiesta da tale norma, con la
responsabilità per fatto proprio colpevole. Ed ancora, con la successiva sentenza n. 1085/1988,
il collegio precisava altresì che “perché l’art. 27, co. 1, Cost., sia pienamente rispettato e la
responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli
elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente
117
Parte generale collegati all’agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e
ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili”. In tale pronuncia, per altro,
la Corte ha affermato che il principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu
contrasta con l’art. 27, co. 1, Cost., essendo necessario, quale essenziale requisito subiettivo
d’imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell’azione od omissione, almeno la colpa in
termini di collegamento subiettivo tra l’autore del fatto ed il dato significativo addebitato.
3. La soluzione delle Sezioni Unite: l’accoglimento della tesi della
responsabilità della colpa in concreto.
L’ultimo orientamento esaminato è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez.
Un., 22 maggio 2009, n. 22676), che hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di
morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza
stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di
causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale
(diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità
dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale”.
1° Argomento: valorizzazione del principio di colpevolezza. La Corte ritiene di non
doversi e non potersi discostare dall’insegnamento della Suprema Corte (prima citati): l’art. 27
Cost. impone, ai fini dell’incriminabilità, non solo il collegamento fra soggetto agente e fatto, ma
anche la rimproverabilità dello stesso soggettivo collegamento. Come ha precisato la Corte
Costituzionale (sent. n. 364/1988), “il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve
necessariamente includere almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più
significativi della fattispecie”; diversamente opinando, infatti “non avrebbe senso la rieducazione
(di cui all’art. 27 Cost.) di chi, non essendo in colpa (rispetto al fatto) non ha certo bisogno di
essere rieducato”.
2° Argomento: ripudio della natura della responsabilità ex art. 586 c.p. in termini di
responsabilità oggettiva. Tale norma non potrebbe dunque essere configurata in termini di
responsabilità oggettiva, pena il contrasto evidente con i canoni costituzionali. Proprio tale
motivazione impone di disattendere del tutto i primi tre orientamenti elaborati nell’ambito
dell’interpretazione pretoria, poiché finiscono, tutti, col prefigurare appunto un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, mascherata di volta in volta, dalla colpa in astratto, dalla colpa specifica,
giungendo finanche al solo accertamento del nesso di causalità.
3° Argomento: responsabilità per colpa in concreto. Simile configurazione è l’unica in
virtù della quale l’art. 586 c.p. possa dirsi conforme al dettato costituzionale, ancorando
dunque la responsabilità per l’evento ulteriore non voluto alla violazione di regole cautelari
di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e mai in astratto,
del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità
personale, intrinseca alla consumazione del delitto doloso di base. Nell’ipotesi dunque di morte
o lesioni conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità per gli eventi
ulteriori a carico di chi le abbia illecitamente cedute sarà configurabile in presenza
dell’accertamento del nesso di causalità fra la morte o le lesioni e la cessione nonché del
118
Scheda di giurisprudenza n. 12 collegamento soggettivo fra il soggetto agente e l’evento non voluto, rimproverabile al primo
appunto a titolo di colpa in concreto, accertata ex ante ed in base al comportamento ideale
del c.d. agente modello, inteso quale persona ragionevole, fornita di esperienza, al pari
dell’agente reale, nel campo della cessione e dell’assunzione di sostanza stupefacenti nonché
consapevole dei rischi alle medesime connesse.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che Mevio possa esser rispondere della morte di Caio, ex artt. 586 e 83 c.p. Pur
vero infatti che nulla avrebbe potuto sapere circa le condizioni in cui versava Caio (assunzione di farmaci),
senza alcun avvertimento in merito da parte di Tizio, è altrettanto vero che, atteso il suo rapporto di
conoscenza e di “fiducia” con quest’ultimo, ben avrebbe potuto sapere che, contestualmente all’assunzione
dell’eroina, i giovani avrebbero affiancato ad essa anche l’assunzione di alcolici, di cui sono note le
conseguenze negative sulla salute in ragione dell’interazione fra eroina e alcool. Proprio per tale motivo,
ferma restando l’imputazione per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui
all’art. 73 D.P.R. 309/90, a Mevio potrà essere addebitata anche la morte di Caio a titolo di responsabilità per
colpa in concreto.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 22 maggio 2009, n. 22676
Estratto
[...Omissis...]
12. Non sussistono poi ostacoli di ordine testuale o logico che impediscano questa interpretazione, la quale
anzi è anche più rispettosa della originaria intenzione del legislatore storico e del dato testuale del richiamo
alla colpa contenuto nell’art. 83 cod. pen.. In particolare, questa conclusione non è impedita da una presunta
impossibilità di muovere un rimprovero di colpa per un evento non voluto nei confronti di un soggetto che ha
volontariamente intrapreso un’attività illecita.
È stato invero sostenuto da una parte della dottrina che sarebbe impossibile configurare una combinazione di
dolo (rispetto al delitto base) e di colpa (rispetto alla conseguenza non voluta). E ciò soprattutto per
l’argomento che il legislatore sarebbe contraddittorio ed irragionevole se, da una parte, vietasse di tenere
una determinata condotta volontaria (attraverso la previsione del delitto doloso) e, da un’altra parte,
attraverso l’imputazione per colpa dell’evento ulteriore non voluto, obbligasse ad eseguire tale condotta con
le cautele necessarie ad evitare la produzione di ulteriori risultati non voluti. Tesi questa che sembra essere
stata ripresa anche da qualche decisione di questa Corte che, in riferimento all’omicidio preterintenzionale,
ha sostenuto che “sarebbe assurdo pretendere cautela (quanto alle conseguenze) da parte di chi,
comunque, mette in atto un’aggressione fisica nei confronti di un terzo” (Sez. 5, 13.2.2002, n. 13114, Izzo).
Queste obiezioni non appaiono però decisive. A fronte della presunta contraddizione, si è invero evidenziato
che l’esclusione della possibilità di configurare una colpa in chi versa in re illicita comporterebbe una
violazione del principio di uguaglianza, ponendo sullo stesso piano chi cagioni l’evento ulteriore non voluto in
circostanze che rendevano agevole la previsione del suo verificarsi e chi lo cagioni in circostanze
eccezionali, tali da non renderlo prevedibile. Al contrario, ammettendo la possibilità di un rimprovero per
119
Parte generale colpa in chi realizza un evento non voluto mediante la commissione di un reato doloso, si avrà anche la
possibilità di trattare in modo diverso situazioni diverse, quali quella in cui l’evento ulteriore era agevolmente
prevedibile e quella in cui era assolutamente imprevedibile e quindi nessun rimprovero può muoversi al
soggetto. Ed è stato altresì osservato che sarebbe ancora maggiore la contraddizione del legislatore
ipotizzando che lo stesso, da un lato, con norma costituzionale (art. 27 Cost.) accoglie il principio di
colpevolezza e con norma ordinaria (art. 59 c.p., comma 2) prevede l’imputazione almeno per colpa delle
circostanze, e poi, da un altro lato, con altre norme ordinarie nega il principio di colpevolezza e non richiede
la colpa in ordine agli ulteriori eventi non voluti.
Nè la configurabilità di una colpa in attività illecita può essere negata sulla base delle argomentazioni che
portano ad escludere una colpa per inosservanza di leggi penali, ossia perchè non avrebbe senso imporre a
chi sta compiendo un illecito doloso di eseguirlo con cautela. Ed infatti, il ritenere che non sia accettabile la
tesi secondo cui ogni norma penale, nel momento in cui punisce una condotta, porrebbe anche una regola
preventiva sulla pericolosità della condotta stessa, non significa affatto negare la possibilità che, in occasione
della esecuzione dolosa di un reato, l’agente possa essere anche destinatario di regole cautelari per la
prevenzione di ulteriori eventi, purchè, ovviamente, non si pretenda di ricavare tali regole cautelari, in modo
automatico e scontato, proprio dalla stessa disposizione penale incriminatrice della fattispecie dolosa.
Si deve quindi ammettere la possibilità di concepire e praticare una colpa in attività illecite, la quale non solo
è riconosciuta esplicitamente in numerosi ordinamenti positivi (che imputano per colpa l’evento non voluto,
aggravante o qualificante, derivante dalla commissione di un delitto doloso), ma è anche ammessa da tempo
dalla gran parte della dottrina italiana, che ha evidenziato come le norme cautelari di condotta valgano tanto
per chi agisce legittimamente quanto per chi opera illegittimamente.
D’altra parte, la citata sentenza n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale, oltre a dichiarare l’illegittimità
delle forme di responsabilità oggettiva, ha esplicitamente riferito il requisito della colpa anche ad attività
illecite, mentre la possibilità di una colpa ravvisabile anche nell’ambito di una attività illecita è stata recepita
pure dal legislatore, il quale, con la riforma del regime di imputazione delle circostanze aggravanti di cui
all’art. 59 c.p., comma 2, (introdotta con la L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 1) ha reso possibile una
combinazione di dolo (rispetto al reato semplice) e di colpa (rispetto alla circostanza aggravante). Il nuovo
testo dell’art. 59 c.p., comma 2, richiede, infatti, che le circostanze aggravanti siano “ignorate per colpa o
ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”: si tratta quindi di una colpa che si innesta su un fatto già
di per sè costituente reato.
Il legislatore ha così espressamente riconosciuto la possibilità di ambientare il rimprovero per colpa in un
ambito di illiceità dolosa.
Del resto, in riferimento alla disposizione dell’art. 59 c.p., comma 2, la giurisprudenza ha affermato che,
attesa l’ampia formulazione di tale disposizione, “non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l’imputazione
a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la
circostanza in questione” (Sez. 6, 6.12.1994, n. 2164, Imerti, m. 200902; Sez. 1, 27.10.1997, Carelli, m.
208936).
13. Va dunque confermato che mentre, da un lato, una interpretazione adeguatrice che rispetti il principio
costituzionale di colpevolezza esige che nella fattispecie dell’art. 586 cod. pen. la morte o le lesioni non
volute devono essere imputate per colpa, da un altro lato, non esistono insuperabili ostacoli, normativi o
logici, contro questa interpretazione.
Occorre però stabilire se si tratta della stessa colpa presente nelle normali fattispecie colpose ovvero di una
colpa che subisca delle modificazioni nella sua struttura e nel suo contenuto in conseguenza del fatto che
l’agente, attraverso il delitto base doloso, si è collocato in un’area di illiceità penale.
Ora, se si ritiene che in quest’ultima ipotesi la colpa possa avere una fisionomia ed un contenuto particolari,
si corre il rischio che si possa poi giungere di fatto ad un impoverimento e ad uno svuotamento del contenuto
della colpa, con risultati pratici sostanzialmente identici a quelli della responsabilità oggettiva, o della colpa
presunta per violazione di legge penale, o della colpa da prevedibilità in astratto dell’evento non voluto, ossia
120
Scheda di giurisprudenza n. 12 ad applicazioni pratiche solo formalmente rispettose del principio di colpevolezza, ma sostanzialmente non
conformi allo stesso. Rischio questo non meramente ipotetico, come risulta da alcune decisioni che, pur
affermando formalmente la necessità, attesa la “indefettibilità del principio di colpevolezza”, della
“sussistenza di un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell’evento non investito dal dolo del
reato di base”, tuttavia poi di fatto non hanno svolto alcuna indagine sulla effettiva presenza degli elementi
costitutivi di una imputazione realmente colposa, in relazione alle circostanze oggettive e soggettive della
concreta situazione (cfr. Sez. 1, 14.11.2002, n. 2595, Solazzo).
D’altra parte, non sembrano sussistere valide e decisive ragioni per le quali, allorchè si manifesti nell’ambito
di una diversa condotta illecita, la colpa debba subire delle modificazioni nella sua struttura o nel suo
contenuto.
Ora, secondo l’opinione più diffusa, la colpa “normale” consiste nella realizzazione di un fatto non voluto,
rimproverabile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza (di prudenza, di imperizia), che
discende da una valutazione positiva di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell’evento.
Tale valutazione, sempre secondo la tesi più diffusa, deve essere compiuta con un giudizio di prognosi
postuma, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da
svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello, ossia di un agente ideato
mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo
sociale dell’agente reale. Occorre, infatti, da un lato, evitare di soggettivizzare la colpa fino a renderla
inattuabile; da un altro lato, mantenere alla qualificazione di negligenza, imprudenza, imperizia quel minimo
di aderenza alla situazione concreta, che permetta di considerarla criterio di imputazione soggettiva; e da un
altro lato ancora, differenziare il punto di vista, dal quale valutare prevedibilità ed evitabilità, a seconda della
situazione concreta in cui, di volta in volta, viene e trovarsi il singolo agente. Una volta ideato mentalmente
l’omologo agente modello, deve valutarsi, sulla base di tutte le circostanze di fatto della concreta situazione
in cui si trovava l’agente reale - tenendo peraltro conto anche di tutte le particolari conoscenze della realtà di
fatto e le particolari capacità o abilità eventualmente possedute dall’agente concreto in misura superiore al
normale - la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, per individuare la condotta che l’agente modello avrebbe
tenuto a seguito di tale valutazione. In caso di divergenza, potrà affermarsi che la condotta dell’agente
concreto è colposa.
14. La circostanza che l’agente reale versi in un ambito di illiceità, dunque, non influenza la fisionomia della
colpa ed il procedimento di individuazione dell’omologo agente modello.
Ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico “delinquente modello”, bensì alla
condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all’evento non voluto, da un individuo
medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l’agente reale.
Anche in ambito illecito, pertanto, occorre pur sempre che il fatto costitutivo del reato colposo sia una
conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell’inosservanza di una regola cautelare.
In particolare, è opportuno ribadire che, ai fini della imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un
reato-base doloso, la colpa non può essere presunta in forza della sola violazione della legge incriminatrice
del reato doloso. Per quanto riguarda più specificamente l’ipotesi di morte o lesioni personali conseguenti alla
cessione illecita di sostanze stupefacenti, la regola cautelare, la cui inosservanza può costituire base della
colpa, non può individuarsi nella stessa norma penale che incrimina la cessione dello stupefacente. La
legislazione in materia di sostanze stupefacenti, invero, non svolge in via diretta un ruolo di prevenzione delle
offese alla integrità fisica dei cittadini, ma, come già rilevato, ha come scopo diretto ed immediato delle sue
norme incriminatrici la repressione del mercato illegale della droga e soltanto come scopo ulteriore, collocato
sullo sfondo, la tutela della salute pubblica, accanto alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Del
resto, a conferma che l’attuale legislazione in materia non ha una destinazione diretta ed immediata alla
tutela dell’integrità fisica dei cittadini, sta la scelta del legislatore a favore della non punibilità del consumo
personale di stupefacenti.
È stato inoltre esattamente osservato che lo scopo ulteriore ed indiretto di tutelare la vita dei possibili
121
Parte generale consumatori riguarda solo un rischio ed un pericolo generali e generici per l’incolumità e la salute della
massa dei consumatori, pericolo che è già incluso nel disvalore complessivo, severamente sanzionato dalle
disposizioni sulla produzione e sullo spaccio degli stupefacenti. In altri termini, anche riconoscendo che lo
scopo “ultimo” della sfera di protezione delle norme che vietano lo spaccio di sostanze stupefacenti sia la
tutela della vita dei possibili consumatori, il disvalore di questo rischio generico si esaurisce nell’imputazione
per il reato presupposto. Il pericolo “iniziale” per l’incolumità insito nel commercio di sostanze stupefacenti,
che è di tipo “generico”, è già ampiamente previsto e punito per una efficace difesa prodromica della vita,
dalle norme speciali sugli stupefacenti. Tale disvalore e tale rischio non possono quindi essere replicati in un
altro reato per il tramite di una applicazione dell’art. 586 cod. pen. del tutto sganciata dalla sussistenza di un
profilo soggettivo di colpa e fondata esclusivamente su una responsabilità oggettiva o su una colpa presunta
per violazione della legge penale, perchè in tal modo si verrebbe a sanzionare nuovamente un fatto già
incluso per il suo carico di disvalore nella condanna per lo spaccio di droga. In altre parole, con le
incriminazioni sul divieto dello spaccio viene sanzionata la creazione di un rischio generico per la salute della
potenziale platea dei consumatori della sostanza, e non anche il rischio specifico del singolo assuntore, il
quale viene invece sanzionato con le incriminazioni per morte o lesioni (dolose o colpose) sempre però che
sussista una connessione diretta di rischio tra spaccio e morte del tossicodipendente e sempre che questo
rischio specifico sia in concreto rimproverabile allo spacciatore perchè da lui prevedibile ed evitabile. E
questa relazione non può - a meno di non ricadere appunto in una ipotesi di responsabilità oggettiva - essere
automaticamente ed immancabilmente riconosciuta in tutti i casi ipotizzando fittiziamente che l’art. 586 cod.
pen. attribuisca alle norme incriminatrici sullo spaccio di stupefacenti anche il valore di specifiche regole di
cautela dirette a prevenire la morte o le lesioni del singolo assuntore.
15.1. Anche nel caso di morte o lesioni conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti, dunque, la
responsabilità per questi ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere
ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l’evento
morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l’evento non voluto
sia comunque soggettivamente collegabile all’agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in
concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi. Occorrerà quindi che
l’agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli stupefacenti) che incrimina
il delitto base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. Occorrerà poi una
valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento, compiuta ex ante, sulla base del
comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tendendo peraltro conto di tutte le
circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Si dovrà pertanto verificare se dal punto di vista di un
agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l’evento morte come conseguenza
dell’assunzione, da parte di uno specifico soggetto, di una determinata dose di droga. È poi evidente che per
agente modello non si deve intendere uno “spacciatore modello”, ma una persona ragionevole, fornita, al pari
dell’agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e
consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede.
Deve peraltro farsi una ulteriore precisazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 322 del 2007, ha
ribadito che il principio di colpevolezza postula un coefficiente di partecipazione psichica del soggetto al fatto,
ed implica quindi che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della
fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente ed a questi rimproverabili, siano cioè investiti dal dolo o
dalla colpa.
La Corte ha confermato che il principio di colpevolezza non può essere “sacrificato” dal legislatore ordinario
in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorchè essi pure di rango costituzionale. Ma ha
anche chiarito che, nell’ambito delle diverse forme di colpevolezza, il legislatore ben può “graduare” “il
coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli
interessi che debbono essere preservati: pretendendo dall’agente un particolare “impegno” nell’evitare la
lesione dei valori esposti a rischio da determinate attività”. Ed ha poi specificato che la soglia minima di
122
Scheda di giurisprudenza n. 12 compatibilità con l’art. 27 Cost., comma 1, è rappresentata “dall’attribuzione di valenza scusante all’ignoranza
(o all’errore) che presenti caratteri di inevitabilità: giacchè deve poter essere mosso all’agente almeno il
rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o
difettosa conoscenza del dato rilevante”.
Ciò significa che, qualora si tratti della tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, il legislatore non solo
può prevedere che sia sufficiente la sola colpa, invece del dolo, ma può anche richiedere un grado di
attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti. Nell’ipotesi in esame ricorre
una di queste situazioni, sia per la rilevanza costituzionale dei beni (vita ed incolumità fisica) tutelati, sia
perchè la natura astrattamente e genericamente pericolosa dell’attività è legislativamente segnalata dal
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81, il quale prevede la possibilità che l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
possa cagionare la morte o lesioni personali dell’assuntore e che in tal caso possano essere configuratoli i
reati di cui agli artt. 586, 589 o 590 c.p. per chi abbia determinato o agevolato tale uso, disponendo altresì
una notevole riduzione delle pene previste dalle norme sugli stupefacenti se il colpevole presti assistenza alla
persona offesa ed informi tempestivamente l’autorità sanitaria o di polizia. Ciò significa che il legislatore ha
voluto che l’agente sia tenuto a prendere in considerazione tutte le eventuali circostanze del caso concreto
ed a desistere dall’azione (ossia dalla cessione dello stupefacente) sia quando taluna di queste circostanze
evidenzi un concreto pericolo per l’incolumità dell’assuntore, e sia anche quando rimanga in concreto un
dubbio in ordine alla effettiva pericolosità della stessa.
Lo spacciatore pertanto potrà ritenersi esente da colpa quando una attenta e prudente valutazione di tutte le
circostanze del caso concreto non faccia prevedere l’evento morte o lesioni. La colpa potrà invece essere
ravvisabile quando la morte sia prevedibile, ed anche quando non sia prevista perchè una circostanza
pericolosa sia stata ignorata per colpa o sia stata erroneamente valutata sempre per colpa.
In sintesi, la colpa non potrà essere ravvisata nella prevedibilità in astratto dell’evento morte, desunta dalla
presunta frequenza, o dalla notorietà, o dalla ordinarietà di tale evento in seguito alla assunzione di sostanza
stupefacente, o in un pericolo che sarebbe presuntivamente insito in qualsiasi cessione della sostanza,
ovvero nella natura di talune sostanze più pericolose di altre. La colpa andrà accertata sempre e soltanto in
concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che
dimostravano il concreto pericolo di un evento letale a seguito dell’assunzione di una determinata dose di
droga da parte dello specifico soggetto. All’agente è peraltro richiesto un particolare livello di attenzione e di
prudenza, sicchè lo stesso potrà essere ritenuto in colpa qualora non si sia astenuto dal cedere lo
stupefacente dinanzi ad una circostanza dal significato equivoco o comunque quando abbia ignorato una
circostanza pericolosa o sia caduto in errore sul suo significato e l’ignoranza o l’errore siano determinati da
colpa, e siano quindi a lui rimproverabili perchè non inevitabili.
15.2. In via generale dovrà dunque escludersi la responsabilità del cedente per la morte del cessionario in
tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non
noti o non rappresentabili dal cedente, come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di cessione di una
sostanza “normale” per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea assunzione di alcol che
abbia accentuato gli effetti della droga (a meno che lo spacciatore sapesse che la vittima era dedita all’uso di
alcol o intendesse farne uso in quella occasione);
o nel caso di consumo dello stupefacente congiunto all’uso di psicofarmaci, o di consumo da parte di
soggetto apparentemente giovane e in buono stato di salute, ma in realtà con gravi difetti fisici, o in precario
stato di salute, o con grave vizio cardiaco; o anche nel caso in cui l’agente abbia ceduto un normale
quantitativo di droga ad un soggetto presentatosi come consumatore diretto senza che fosse prevedibile
l’ulteriore cessione ad un terzo con un ridotto grado di tolleranza (e quindi altamente a rischio di overdose) e
ciò quand’anche fosse prevedibile l’ulteriore cessione ad altri.
Così, ad esempio, la colpa è stata esattamente esclusa (o avrebbe dovuto essere esclusa) perchè il rischio
non era prevedibile in concreto nel caso di cessione di un rilevante quantitativo di eroina alla vittima, la quale,
accortasi della presenza della polizia, aveva repentinamente ingoiato la bustina di plastica, che però si era
123
Parte generale aperta nello stomaco (Trib. Palermo, 4.2.2005, C.R.); o di cessione di una dose non eccessiva in cui la morte
era stata causata da assunzione di alcol che aveva accentuato gli effetti della droga, senza che il cedente
potesse prevedere l’evento morte per effetto congiunto di droga ed alcol (contro Sez. 4, 28.6.1991, n. 11965,
Greco, m. 188768, che ritenne sufficiente il solo nesso causale); o di ulteriore cessione da parte
dell’acquirente ad un terzo, poi deceduto per il suo ridotto grado di tolleranza agli stupefacenti, conseguente
ad un precedente tentativo di disassuefazione, senza che lo spacciatore potesse prevedere l’ulteriore
cessione e comunque la cessione ad un soggetto altamente a rischio (contro Trib. Rimini, 3.11.1987,
Zaouali, sulla base di un giudizio di prevedibilità in astratto); o di assunzione di una normale dose di
stupefacente che abbia provocato la morte ad uno solo dei due cessionari, abituale assuntore di droga, per
un meccanismo allergico o idiosincrasico, ignoto allo spacciatore e di cui non vi erano manifestazioni esteriori
(Trib. Roma, 12.2.1985, Trombetti).
Potrà, invece, nei singoli casi concreti, ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a
conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito
all’alcol o al consumo di psicofarmaci o aveva, al di là dell’apparenza, gravi difetti fisici ovvero anche quando
la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi
inescusabili, come ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia ceduto la sostanza ad un acquirente che
denotava un alito vinoso, o che presentava caratteristiche esteriori di fragilità fisica o di consumatore di
medicinali, o abbia ceduto la droga all’interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di
sostanze alcoliche (essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di droga e alcol), ovvero
l’abbia ceduta a soggetti minorenni di cui poteva essere conoscibile la minore resistenza a quella
determinata sostanza. Analogamente, la colpa in concreto potrebbe essere configurabile quando lo
spacciatore abbia ceduto eroina ad un soggetto di cui conosceva i precedenti tentativi di disintossicazione e
quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; o quando abbia ceduto sostanza micidiale come
l’eroina a persona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evidenziava la precedente
assunzione di tranquillanti. E così, ad esempio, correttamente è stata ravvisata la colpa nel fatto che il
tossicodipendente era in evidente stato di ebbrezza ed in condizione di sofferenza e precarietà fisica per
ingestione di medicinali (Sez. 6, 9.12.1989, n. 5348, Virdis, m. 184003 e 184004); o nel caso in cui il rischio
di morte per overdose era prevedibile in concreto a causa delle visibili menomate condizioni della parte
offesa, alla ricerca spasmodica di una droga pesante (Sez. 5, 7.2.2006, n. 14302, Giancaterino, m. 234584);
o nel caso in cui il cedente era a conoscenza che il cessionario nei mesi precedenti aveva ridotto il consumo
di stupefacente, esponendosi così al rischio di morte per overdose (Trib. Velletri, 11.3.1986, Mattiazzo); o in
cui il soggetto aveva iniettato eroina ad una giovane pur sapendo che non era dedita all’uso di tale droga e
che era particolarmente affaticata per un lungo viaggio (Trib. Firenze, 6.11.1978, Poulopoulos); o di cessione
di droga pesante (eroina) a persona di giovanissima età e di assai esile costituzione fisica, che aveva
assunto tranquillanti (Trib. Busto Arsizio, 26.3.1985, Irritano).
La colpa potrà poi essere rinvenuta in particolari circostanze attinenti alla quantità, natura e qualità della
sostanza ceduta, come ad esempio nel caso in cui lo spacciatore predisponga dosi a composizione diversa
da quelle usuali o miscelate con sostanze diverse, con consapevolezza della probabilità di particolari
maggiori rischi per la vita del consumatore.
Va peraltro anche tenuto presente che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 prevede un cospicuo aumento di
pena, da un terzo alla metà, quando le sostanze stupefacenti siano consegnate o destinate a minori, o siano
adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva, o se la cessione sia
effettuata all’interno o in prossimità di scuole, comunità giovanili, strutture per la cura e la riabilitazione dei
tossicodipendenti; un aumento dalla metà a due terzi se la cessione riguardi quantità ingenti di sostanze
stupefacenti o psicotrope; e prevede addirittura la pena di trenta anni di reclusione nel caso di cessione di
ingenti quantità delle sostanze stupefacenti più pesanti adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti
accentuata la potenzialità lesiva. Anche questi aggravamenti di pena, peraltro, non sono finalizzati in via
diretta ed immediata alla tutela della integrità fisica pur avendo indubbiamente come scopo ulteriore ed
124
Scheda di giurisprudenza n. 12 indiretto anche il contrasto ad un più elevato rischio generico per la salute della massa dei consumatori.
Anche in questi casi il carico di disvalore derivante di per sè da tale maggior rischio generico è già compreso
nella maggior pena comminata per la violazione delle norme speciali sugli stupefacenti in presenza di dette
circostanze.
Ciò non significa tuttavia che non possa eventualmente essere ravvisata, sempre in relazione alle specifiche
circostanze del caso concreto e non in astratto, anche una ulteriore violazione (oltre a quella della legge
speciale) di una regola cautelare specificamente preventiva dell’evento dannoso morte nel caso concreto,
quando un maggior pericolo concreto ed effettivo per la vita dell’assuntore fosse in concreto prevedibile in
considerazione della quantità e qualità della sostanza spacciata (eventualmente anche adulterata o “tagliata”
in modo pericoloso) o della conoscibile minore resistenza fisica dell’assuntore o del maggior pericolo di
overdose, dovuti alla sua minore età o allo stato di tossicodipendente in riabilitazione.
Nel caso poi in cui siano intervenute plurime, successive cessioni, la necessità che la responsabilità sia
fondata su una colpa da accertarsi in concreto comporta che in tanto la colpa potrà ritenersi esistente in
quanto la morte sia intervenuta per un fattore che era in concreto prevedibile dal cedente. Così, ad esempio,
potrebbe non ravvisarsi la colpa nella ipotesi in cui la morte del terzo assuntore (non conosciuto e non
conoscibile dal cedente) sia stata determinata da fattori non noti o non conoscibili dallo spacciatore, come nel
caso che l’assuntore finale abbia consumato la droga insieme ad alcol, o a psicofarmaci, o sia affetto da vizi
cardiaci o da gravi difetti fisici. In via generale, quindi, nel caso di plurime cessioni non potrà ravvisarsi una
responsabilità dell’originario cedente quando questi non conosceva o non era in grado di conoscere l’identità
dei successivi cessionari e soprattutto la presenza di particolari fattori che abbiano aumentato il rischio di
decesso. Peraltro, anche in caso di plurime successive cessioni potrà ravvisarsi una colpa del cedente
qualora questi particolari fattori relativi ai successivi cessionari non siano stati nel caso concreto conosciuti
dal cedente per errore o ignoranza evitabili, e quindi colpevoli, come ad esempio nel caso che l’agente abbia
ceduto la droga sapendo o potendo sapere che il cedente l’avrebbe a sua volta venduta in una discoteca o in
un simile locale (e che quindi vi era in concreto una elevata probabilità che fosse assunta insieme ad alcol), o
l’avrebbe venduta in una scuola o a minorenni.
Analogamente, anche nel caso di plurime cessioni, potrà ravvisarsi la colpa in capo al cedente indiretto
quando il maggior rischio non dipende dalla identità e dalle caratteristiche personali dell’assuntore ma è
riconducibile alla quantità, natura e qualità dello stupefacente, ed in particolare alle modalità con cui esso sia
stato nel caso concreto eventualmente miscelato con altre sostanze tali da accentuarne in concreto la
potenzialità lesiva (a meno che, in tali specifici casi di maggiore rischio per la vita di qualsiasi potenziale
consumatore, non sia addirittura ravvisabile il dolo eventuale).
16. In conclusione, va dunque affermato il principio che, nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza
dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod.
pen. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e
morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto
rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento
soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma
penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per
il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente
modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso
concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. Venendo al caso in esame, si è già rilevato come la
sentenza impugnata non si sia conformata al suddetto principio di diritto, avendo affermato la responsabilità
dell’imputato per il reato di cui all’art. 586 cod. pen. a puro titolo di responsabilità oggettiva e sulla sola base
del nesso di causalità materiale, pur avendo accertato che la morte del terzo cessionario (non conosciuto
dall’imputato) era stata causata, o quanto meno favorita, dalla contemporanea assunzione di alcol etilico e
pur essendo stato dedotto che la vittima si trovava in un precario stato di salute per l’assunzione di notevoli
quantità di medicinali. La corte d’appello ha osservato che l’effetto letale era prevedibile, ma ha fatto
125
Parte generale riferimento esclusivamente ad una prevedibilità in astratto derivante dalla stessa cessione della sostanza
stupefacente senza esaminare nè indicare se vi fossero nel caso concreto specifiche circostanze, conosciute
o conoscibili dal cedente, che rendevano probabile in concreto, e non solo astrattamente possibile, un
maggior rischio di esito letale. In particolare, non ha accertato se l’imputato sapesse o potesse sapere che il
N. avrebbe a sua volta ceduto parte dello stupefacente a terzi e che uno di costoro era consumatore di
notevoli quantità di medicinali, si trovava in precario stato di salute e avrebbe ingerito alcol etilico
contemporaneamente all’assunzione dello stupefacente. La corte ha anche parlato di colpa dell’agente e di
concreta prevedibilità dell’evento letale per l’assuntore della sostanza stupefacente, ma si tratta di
affermazioni apodittiche e di motivazione di stile, non essendo stata indicata nessuna circostanza di fatto che
dimostrasse una prevedibilità della morte in concreto ed una colpa in concreto dell’agente.La sentenza
impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al reato di cui agli artt. 83 e 586 cod. pen. per totale
mancanza di motivazione sull’esistenza in concreto di una colpa dell’imputato rispetto all’evento morte non
voluto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che si uniformerà al
principio di diritto dianzi affermato.
[...Omissis...]
126
Scheda di giurisprudenza n. 13 Scheda di giurisprudenza n. 13
L’errore sulla legge extrapenale: la distinzione fra errore sul fatto ed errore sul precetto
TRACCIA
Il Tribunale di Alfa, con sentenza in data 21.05.2014 dichiarava Tizio responsabile del delitto di omicidio
colposo per avere cagionato la morte di Caio, impattando con il proprio veicolo contro quello della vittima
mentre viaggiava ad una velocità superiore a quelli previsti dal codice della strada in zone urbane.
In particolare, veniva contestata e ritenuta sussistente, quale profilo di colpa specifica, la violazione degli artt.
141, commi 1, 2, 3, e 142 del Codice della Strada per aver tenuto una velocità superiore ai 50 km/h (in
specie circa 70 km/h) all’interno di un centro abitato. A seguito dell’impatto tra i due veicoli, determinato
esclusivamente dall’eccessiva velocità, Caio era stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando traumi che ne
cagionavano il decesso. Inoltre, qualora l’imputato avesse rispettato il predetto limite di velocità, l’evento non
si sarebbe verificato, tenuto conto del fatto che in tal caso lo spazio di arresto sarebbe stato inferiore alla
distanza che separava i due veicoli, al momento dell’avvio della frenata di emergenza.
La Corte, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, il Tribunale
condannava l’imputato alla pena di Euro 4.560,00 di multa.
Tizio, non soddisfatto dell’assistenza tecnica ricevuta nel giudizio di primo grado, si rivolge ad un diverso
difensore di fiducia, evidenziando che il mancato rispetto del limite di velocità fosse dovuto ad un cartello
stradale recante la scritta “arrivederci ad Alfa”; tale indicazione, non rispondente alla segnaletica approvata
dal Codice della Strada, aveva ingenerato nell’imputato l’idea di trovarsi fuori dal centro abitato (cui si applica
il superiore limite di 90 km/h).
Il candidato, assunte le vesti del nuovo difensore di Tizio, premessi cenni sulla rilevanza dell’errore di diritto,
rediga motivato parere.
1. La questione.
L’art. 47, co. 3, c.p. afferma che “l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la
punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato”: sebbene si tratti di
una formulazione apparentemente chiara e pur definendo, in rubrica, l’art. 47 c.p. l’errore da esso
disciplinato in termini di “errore di fatto”, il comma citato, invero, facendo riferimento alla legge
diversa da quella penale, implica sia l’errore sul fatto tipico sia l’errore sul precetto.
Le conseguenze, com’è noto, dell’una o dell’altra evenienza non sono di poco conto: mentre nel
primo caso, infatti, l’errore, inerendo appunto al fatto tipico, dà luogo ad efficacia scusante
della condotta, non così nel secondo caso, liddove l’errore, caduto sul precetto, non può
essere considerato irrilevante ai sensi dell’art. 5 c.p., in virtù del quale “nessuno può invocare a
propria scusa l’ignoranza della legge penale” (ignorantia legis non excusat).
Quel che ha occupato per lungo tempo la giurisprudenza e la dottrina riguarda la necessità di
tracciare una linea di demarcazione, nell’art. 47, co. 3, c.p., fra i casi in cui la condotta del
soggetto agente sia sorretta effettivamente da errore sul fatto da quelli in cui, invece, tale
condotta sia frutto di errore sul precetto.
Val la pena precisare, preliminarmente, cosa si intende per errore sul fatto ed errore sul precetto.
L’errore sul fatto, di cui all’art. 47, co. 1, c.p., viene ravvisato nelle ipotesi di divergenza fra il
fatto rappresentato e voluto dall’agente e quello descritto dalla fattispecie incriminatrice: in
127
Parte generale altri termini, l’errore de quo consiste in una mancata o falsa rappresentazione della realtà
materiale, incidendo per tale ragione sul processo formativo della volontà. Qualora, infatti,
siano investiti gli elementi costitutivi della fattispecie viene meno il dolo, che invece, per la sua
sussistenza, pretende la corretta rappresentazione da parte del soggetto agente della situazione di
fatto in cui si trova (Cass. pen., Sez. VI, 25 giugno 2010, n. 32329). L’errore dunque, perché
possa scusare la condotta dell’agente, escludendone così la punibilità, deve concernere
elementi essenziali del fatto, la cui mancata conoscenza impedisce che il soggetto si rappresenti
un fatto corrispondente al modello legale. Ciò tuttavia non esclude che, qualora l’errore sia
determinato da colpa e la legge espressamente preveda la condotta realizzata come delitto
colposo, possa residuare una responsabilità del soggetto agente, appunto, a titolo di colpa.
L’errore sul precetto, invece, si traduce nell’ignoranza o nella falsa rappresentazione di una
norma giuridica e, in ragione del principio generale dell’obbligatorietà della legge penale, non
esclude la punibilità, così come precisato dal ricordato art. 5 c.p., salvo i limiti di inevitabilitàscusabilità dell’errore medesimo. Limiti, questi, in particolare, introdotti dalla Corte
Costituzionale, che ha affermato, in tal senso, l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non
esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza invitabile. A seguito del
decisum della Consulta, l’art. 5 c.p. è dunque da interpretare nel senso che “l’ignoranza della
legge penale non scusa tranne che si tratti d’ignoranza inevitabile” (C. Cost., 23 marzo 1988,
n. 364).
Infine, è necessario altresì ricordare che per legge extrapenale, si ritiene debba intendersi sia
norme extragiuridiche (di natura etico morale) sia norme legislative originariamente non
penali.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Tanto premesso, e tornando all’ubi consistam della questione, gli orientamenti avvicendatesi nel
tempo, volti all’individuazione della distinzione, nell’ambito dell’art. 47, co. 3, c.p., fra errore sul
fatto ed errore sul precetto, sono essenzialmente tre, di cui, per vero, solo uno sostenuto
costantemente dalla giurisprudenza.
2.1. Il primo orientamento: Tesi degli effetti psicologici ultimi.
Secondo una prima tesi, sostenuta dalla dottrina (MANTOVANI), al fine di distinguere l’errore sul
precetto e l’errore sul fatto, nell’ambito dell’art. 47, co. 3, c.p., l’accento andrebbe posto
sull’oggetto finale (in tal senso si parla di effetti psicologici ultimi) dell’errore e dunque a
seconda che il medesimo riguardi, appunto, il precetto o il fatto.
1° Argomento: sostanziale equiparazione tra l’errore sul fatto di cui al co. 1, e l’errore
sulla legge extrapenale, di cui al co. 3. Gli errori de quibus, infatti, rientrano entrambi
nell’ambito della previsione di non punibilità poiché fenomeni sostanzialmente equiparati
dalla valutazione del legislatore: l’errore che investe il significato giuridico da attribuire agli
elementi normativi, che ricevono la loro qualificazione appunto della norma extrapenale richiamata,
determina una situazione del tuto equivalente, dal punto di vista effettuale, a quella causata da una
falsa rappresentazione della realtà materiale. Per tale motivo, in entrambi i casi l’errore si riverbera
128
Scheda di giurisprudenza n. 13 sul fatto costituivo di reato, operando dunque quale causa di esclusione dell’elemento soggettivo.
In ragione della tesi degli effetti psicologici ultimi, potrebbe dunque distinguersi tra:
• errore sulla legge extrapenale che comporta un errore sul fatto, in ragione del
quale il soggetto agente ha voluto e si è rappresentato un fatto diverso da quello
legalmente tipizzato: l’errore, in tal caso, ha efficacia scusante;
• errore sulla legge extrapenale che comporta un errore sul precetto, in ragione
del quale il soggetto agente ha voluto e si è rappresentato un fatto del tutto
identico a quello punito dal legislatore, ignorandone il divieto penale: l’errore, in tal
caso, non scusa.
2.2. Il secondo orientamento: Tesi dell’incorporazione.
Secondo la giurisprudenza dominante (Cass. pen., Sez. IV, 18 gennaio 2012, n. 6405; Cass.
pen., Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 43646; Cass. pen., Sez. IV, 7 luglio 2010, n. 37590; Cass. pen.,
Sez. VI, 25 giugno 2010, n. 32329; Cass. pen., Sez. VI, 3 aprile 2003, n. 24605; Cass. pen., Sez.
II, 19 aprile 2002, n. 17205; Cass. pen., Sez. V, 11 gennaio 2000, n. 2174; Cass. pen., Sez. VI, 18
novembre 1998, n. 7817; Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 1998, n. 8053; Cass. pen., Sez. VI, 3 giugno
1994, n. 9767), l’attenzione deve essere posta sulla natura della norma, penale o extrapenale,
oggetto di falsa rappresentazione.
1° Argomento: incorporazione nel precetto penale. In quest’ottica, la giurisprudenza
ritiene infatti che le norme originariamente non penali, per effetto del richiamo esplicito o
implicito operato dalla norma penale incriminatrice, subiscano un processo di penalizzazione,
finendo con l’essere del tutto incorporate alla norma penale che le richiama (definite, per tale
ragione, norme extrapenali integratrici).
In base alla tesi dell’incorporazione, si distingue, così, tra:
• un errore che investe le norme extrapenali integratrici, che, risolvendosi
dunque in un errore sulla legge penale, non scusa;
• un errore che investe norme extrapenali non attratte nell’ambito della norma
incriminatrice, per effetto di rinvio recettizio e non integranti il logico presupposto
dell’applicazione della norma penale, che, invece, ha efficacia scusante. Si tratta,
tuttavia, di casi rarissimi.
2.3. Il terzo orientamento: Tesi secondo cui l’errore su legge
extrapenale è sempre un errore di diritto.
Si tratta di una tesi, invero, sostenuta da una parte minoritaria di dottrina (GROSSO), in ragione
della quale l’art. 47, co. 3, c.p. trova applicazione in tutte le ipotesi di errore su norme in
origine non penali che siano oggetto di richiamo implicito o esplicito della norma
incriminatrice, a prescindere dalla loro penalizzazione. La norma disciplinerebbe così sempre
un errore sul precetto che, però, inerendo ad una realtà normativa differente da quella
penale, viene sottratto per tale ragione al disposto dell’art. 5 c.p. ed attratto nel regime di
scusabilità dell’art. 47, co. 3, c.p.
129
Parte generale 3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Tesi dell’incorporazione.
La Cassazione ha di recente (Cass. pen., Sez. VI, 3 settembre 2012, n. 33590) ribadito ancora una
volta l’adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, sostenendo dunque
la tesi dell’incorporazione, basato sulla distinzione tra norme extrapenali integratrici del precetto
penale e norme extrapenali non integratrici del precetto penale.
1° Argomento: distinzione nell’ambito delle norme extrapenali. La giurisprudenza ha
tradizionalmente distinto tra norme extrapenali integratrici del precetto – che, essendo in esso
incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l’errore su di esse non scusa, ai
sensi dell’art. 5 c.p. – e norme extrapenali non integratrici del precetto – ossia disposizioni
destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate,
neppure implicitamente, dalla norma penale – affermando che l’errore che cade su di esse
esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell’art. 47, co. 3, c.p.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Invero, nel caso di specie, la condotta di Tizio si ritiene correttamente qualificata come omicidio colposo per
aver provocato, nell’ambito di un incidente stradale, la morte di Caio impattando con il proprio veicolo contro
quello della vittima mentre viaggiava ad una velocità superiore a quelli previsti dal codice della strada in zone
urbane. L’errore da lui paventato (l’aver ritenuto, in ragione della presenza di un cartello stradale recante la
scritta “arrivederci ad Alfa”, di non essere più nell’ambito di un centro abitato e di poter dunque superare i
relativi limiti di velocità) non potrebbe essere qualificato in termini di errore di fatto, l’errore sulla
interpretazione della segnaletica, tipizzata per forme e colori, si risolve infatti, in un irrilevante errore di diritto,
sub specie di errore su norma extrapenale che integra la norma penale - nella specie la previsione di cui
all’art. 589 cod. pen. - ai sensi dell’art. 47, comma terzo, cod. pen.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. VI, 3 settembre 2012, n. 33590
Estratto
[...Omissis...]
1. Ricorre per cassazione il difensore di P.F. avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo il
23 -12-11, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 5-5-11, il P. venne
dichiarato colpevole del reato di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 31 per avere omesso di comunicare al Nucleo
di Polizia tributaria le variazioni intervenute nell’entità e nella composizione del suo patrimonio nel decennio
successivo al 14 gennaio 2002, data in cui era divenuta irrevocabile la condanna pronunciata nei suoi
confronti per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., e, in particolare, per avere omesso di comunicare la vendita di
due appartamenti, siti in Palermo, per il valore dichiarato di Euro 50.000 il primo e 22.000 il secondo (vendite
rispettivamente stipulate il 21-4-2005 e il 12 giugno 2005); la vendita di un ulteriore appartamento in
(OMISSIS) per un valore dichiarato di Euro 70.835,00 (vendita del 19-12-2007); e infine la vendita di un terzo
130
Scheda di giurisprudenza n. 13 di un immobile sito in Palermo, per una quota pari a Euro 100.000. Il P., tenuto conto della contestata
recidiva e ritenuta la continuazione tra i diversi episodi contestati, veniva pertanto condannato alla pena di
anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 16000 di multa. Reati commessi in (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 646 del
1982, artt. 30 e 31 e art. 5 c.p., per inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico dei reati ascritti al P..
Il giudice di prime cure aveva assolto il P., non ravvisando l’elemento soggettivo del reato. Viceversa, la
Corte d’appello, su impugnazione del P.G., è pervenuta alla declaratoria di responsabilità valorizzando, del
tutto incongruamente, secondo il ricorrente, elementi come la tempistica degli atti di compravendita e
l’importo elevato delle singole cessioni. Al riguardo, deve infatti osservarsi che le vendite in disamina sono
state realizzate nell’arco di oltre tre anni e che il decreto applicativo della misura di prevenzione personale che non aveva quindi ad oggetto l’ablazione del patrimonio, all’evidenza ritenuto di legittima provenienza venne reso il 25-6-2006 ossia, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l’anno successivo ai primi due
atti di compravendita in contestazione. Del pari inconferente risulta essere il riferimento della Corte d’appello
all’importo delle singole cessioni poichè, come osservato dal Tribunale, ove il P. avesse voluto nascondere
qualcosa, avrebbe potuto agevolmente indicare al notaio una somma inferiore al tetto previsto dalla legge (
Euro 10.329, 14).
Dunque l’indagine, ad avviso del ricorrente non ha consentito di rinvenire alcun elemento sintomatico della
consapevolezza, in capo al P., di violare il precetto in disamina e della volontà di occultare l’incremento
patrimoniale, la cui sussistenza è smentita dalle forme di pubblicità negoziale regolarmente osservate.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 62 bis e 132
c.p. per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt 99 e 132 c.p. per
difetto di motivazione in ordine all’aumento di pena per la recidiva.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La L. n. 646 del 1982, art. 30 impone a chi versi nelle condizioni
soggettive indicate dalla norma l’obbligo di comunicare per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, al
Nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del
patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute
nell’anno precedente, quando riguardino complessivamente elementi di valore non inferiore all’importo
poc’anzi indicato. Si tratta, come si vede, di obblighi di comunicazione funzionali ad un penetrante e capillare
sistema di controlli nei confronti di particolari categorie di soggetti. La ratio della norma è dunque quella di
assicurare ai competenti organi immediata contezza delle variazioni patrimoniali, preordinatamente alle
opportune verifiche. Se così è, nessuna rilevanza sul piano oggettivo, come rilevato dal giudice d’appello, ha
la circostanza che le operazioni in disamina siano state effettuate con atti pubblici perchè questi ultimi,
ancorchè liberamente consumabili da parte di chiunque, non sono destinati a essere portati a conoscenza
della polizia tributaria.
Ma le doglianze del ricorrente investono non l’elemento oggettivo del reato bensì l’elemento psicologico.
Occorre però osservare, al riguardo, che la categoria del dolo viene impropriamente richiamata in ricorso. Il
reato di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 31 è infatti a dolo generico. Quest’ultimo si esaurisce pertanto nella
coscienza e volontà di omettere le comunicazioni previste dalla norma. È dunque irrilevante che l’agente
avesse o non avesse un precipuo intento di occultare alla polizia tributaria le variazioni patrimoniali in
disamina perchè il reato non è a dolo specifico e una tale finalità esula dall’orizzonte psicologico richiesto,
nell’agente, dalla legge per la configurabilità del titolo d’imputazione soggettiva dell’illecito.
Orbene, che il P. avesse coscienza e volontà di non effettuare le comunicazioni in questione è incontroverso.
Ma egli assume di non averle effettuate perchè non era a conoscenza dell’obbligo impostogli dalla norma.
Quest’asserto traspone la problematica al di fuori dell’area del dolo e sul terreno dell’ignoranza del precetto.
Avrebbe potuto ritenersi il difetto di dolo, in capo all’imputato, ove fosse stato dimostrato che egli era a
131
Parte generale conoscenza degli obblighi su di lui incombenti ma non li aveva osservati, ad esempio, per mera negligenza e
quindi per colpa. Si pensi al caso in cui egli avesse incaricato qualcuno di effettuare le comunicazioni, senza
poi preoccuparsi di verificare se gli incombenti in disamina fossero stati o meno espletati dal proprio
incaricato. In tal caso, avrebbe potuto eventualmente ravvisarsi, in capo all’imputato, una negligenza,
penalmente irrilevante, ma non il dolo del reato in disamina. Ma non è questo l’assunto dell’imputato.
L’assunto del P. è che in lui non vi era consapevolezza di violare la norma.
Il ricorrente adduce dunque ignoranza del precetto. Orbene, l’ignoranza del precetto può assumere rilevanza
sotto un duplice profilo: o come ignoranza della legge extrapenale, nell’ottica delineata dall’art. 47 c.p.,
comma 3; o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell’art. 5 c.p., nel testo risultante da
C.Cost. 24 -3-1988 n 364 (Cass. pen 1988, 1133). La prima ipotesi esula dal caso di specie. In ordine all’art.
47 c.p., comma 3, infatti, la giurisprudenza, come noto, distingue, fra norme extrapenali integratrici del
precetto che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l’errore su di esse non
scusa, ai sensi dell’art. 5 c.p.; e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate in
origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla
norma penale. L’errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell’art.
47 c.p., comma 3 (ex plurimis, Cass., Sez 5 20-2-2001, Martini, Cass. pen. 2002, 3872; Cass, Sez. 6, 18-1198, Benanti, Cass. pen. 2000, 2636). Orbene, anche a voler qualificare la L. n. 646 del 1982, art. 30 come
norma extrapenale, appare difficile sostenere che essa non integri il precetto di cui all’art. 31, L. cit. che non
solo la richiama espressamente ma si configura come una norma esclusivamente sanzionatoria della
violazione del precetto di cui all’art. 30. Di talchè anzi la fattispecie incriminatrice risulta dal combinato
disposto delle due norme: l’art. 30, norma precettiva, e l’art. 31, norma sanzionatoria. L’ignoranza del
disposto dell’art 30 si traduce quindi in ignoranza di legge penale, che ricade sotto il disposto dell’art. 5 c.p..
Rimane da verificare se non sia ravvisabile ignoranza inevitabile della legge penale. Prospettazione che
occorre sempre riguardare con cautela, nella vastissima area dei mala quia prohibita.
Orbene, al riguardo, la giurisprudenza, come è noto, sulla scia della citata pronuncia della Corte
costituzionale, ha elaborato tre criteri: il criterio oggettivo; il criterio soggettivo; il criterio misto. Il criterio
oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi
che qualsiasi consociato, in una determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato
nell’ignoranza o nell’errore sulla norma penale . Ciò può dipendere dall’oscurità o dalla contraddittorietà del
testo legislativo; da un generalizzato caos interpretativo; dall’assoluta estraneità del suo contento precettivo
ai valori correnti nella società. Tali ipotesi esulano dal caso in disamina, trattandosi di norma dal contenuto
precettivo sufficientemente chiaro, che non presenta particolari asperità ermeneutiche e che non si discosta
dai valori correnti nella società in misura tale da non trovare nessuna rispondenza nella c.d. “sfera parallela
laica”, alla quale è noto che, nei confronti dei soggetti condannati per reati di mafia, la legge prevede tutta
una serie di controlli e di cautele. In ogni caso, Sez. un 10-6-94, Calzetta (Cass. pen. 1994, 2925) ha stabilito
che l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia
assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “ dovere di informazione”, attraverso
l’espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente. Ciò che
il P., che pur aveva subito una condanna per un reato particolarmente grave, non risulta aver fatto.
Ancor meno può farsi applicazione, nel caso di specie, del cd. parametro soggettivo, basato sulle
caratteristiche personali dell’agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l’elevato deficit
culturale, alla luce ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio-culturali molto distanti
dalla nostra e da poco in Italia; o l’incolpevole carenza di socializzazione (Cass. 9-5-96, Falsino, rv n.
205513; Cass. 4-5-95, Bindi, Cass. pen. 1996, 2959). Situazioni tutte estranee alle condizioni sociali e
culturali del ricorrente.
Per le ragioni appena indicate, non è applicabile nemmeno il parametro c.d. misto, che comprende tutte le
ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore, criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione
tra loro. In quest’ottica, la giurisprudenza ha evidenziato come l’esimente della buona fede possa trovare
132
Scheda di giurisprudenza n. 13 applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e
questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, al quale quindi non possa essere
mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare
gli estremi dell’esimente il semplice comportamento passivo dell’agente, qual’è ravvisabile nel caso di specie,
essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all’ordinamento giuridico, ad esempio,
informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (Cass. Sez. 1 18-12-2003, n.
25912, rv. 228235; Cass. Sez. 5, 25-9-2003 n. 41476, rv 227042). Nulla di tutto ciò risulta aver fatto il
ricorrente onde non può essergli applicata l’esimente in disamina.
4. Le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede
di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato.
5. Non cosi invece per quanto attiene all’aumento di pena per la recidiva, essendosi limitato il giudice
d’appello a un generico richiamo alla “natura delle precedenti condanne”, senza specificare in qual modo
essa abbia influito sulle valutazioni inerenti alla ritenuta rilevanza della recidiva nè quale sia stato l’itinerario
logico-giuridico seguito al riguardo.
Su quest’ultimo punto, pertanto, il ricorso va accolto mentre per il resto, va rigettato.
[...Omissis...]
133
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 14
La distinzione fra circostanze ed elementi costitutivi del reato
TRACCIA
La società Alfa s.p.a. è beneficiaria di un finanziamento pubblico finalizzato alle aree sottoutilizzate del
mezzogiorno, concesso in via provvisoria con decreto del Ministero delle Attività Produttive, per un valore
complessivo pari ad oltre sei milioni di euro, in vista della realizzazione di un impianto industriale volto alla
produzione di birra.
La predetta società ha ottenuto soltanto la prima rata a titolo di anticipazione pari circa due milioni di euro,
accreditata nel marzo del 2011.
La Procura della Repubblica competente ratione loci, infatti, ha condotto approfondite indagini ed accertato
che il finanziamento predetto sia stato ottenuto dalla Alfa s.p.a. con artifizi e raggiri e, in particolare, mediante
la presentazione di fatture gonfiate relative ai costi sostenuti per la costruzione dell’impianto. Tali condotte
venivano poste in essere prima che fosse erogata la prima rata di finanziamento.
In conseguenza degli accertamenti svolti dal PM, la società procedeva a restituire l’intera somma, prima
ancora che le indagini fossero concluse.
Tizio, presidente del consiglio di amministrazione della Alfa s.p.a. e legale rappresentante di quest’ultima, si
rivolgeva ad un legale per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
1. La questione.
La necessità di tracciare una linea di demarcazione fra circostanze aggravanti ed elementi
costitutivi del reato nasce da considerevoli esigenze di rilievo pratico: qualificare un elemento
nell’uno o nell’altro modo non è certo operazione priva di conseguenze. Basti pensare al regime di
imputazione, peculiare nel caso si tratti circostanze (le attenuanti sono imputate anche se non
conosciute dall’agente, mentre le aggravanti anche se non conosciute per colpa o ritenute
inesistenti per errore determinato da colpa) e normale qualora si tratti di elementi costitutivi (il dolo
rimane il normale presupposto psicologico di attribuzione dei reati); per altro, naturalmente, solo le
circostanze sono soggette al giudizio di comparazione.
In ragione del fatto che fra circostanze ed elementi costituivi del reato non esiste una vera e
propria differenza ontologica, potendo il legislatore qualificare un elemento nell’uno o nell’altro
modo indifferentemente, la giurisprudenza ha cercato di individuare dei criteri discretivi fra
l’una e l’altra categoria.
2. I criteri elaborati in giurisprudenza.
Nel tempo, sono stati individuati cinque differenti criteri di distinzione tra circostanze ed elementi
costitutivi del reato.
134
Scheda di giurisprudenza n. 14 2.1. Il primo orientamento: Il criterio testuale.
Una prima tesi, in particolare, fa leva sul nomen iuris cui fa ricorso il legislatore (in tal senso, si
pensi, ad esempio, all’art. 585 c.p., espressamente rubricato in termini di “circostanza aggravanti”).
2.2. Il secondo orientamento: Il criterio topografico.
Un secondo orientamento valorizza invece la collocazione, autonoma o meno, della norma.
2.3. Il terzo orientamento: Il criterio strutturale delle modalità di
descrizione della fattispecie.
A mentre di una terza teoria (Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 26351), per qualificare
l’elemento dubbio, occorre avere riguardo alla tecnica di descrizione del comportamento
incriminato nel precetto primario della norma incriminatrice: se il legislatore ha optato per la
descrizione per relationem, rinviando ad un fatto descritto in altra fattispecie, ci si troverà dinanzi
ad una circostanza; diversamente, se ha privilegiato la descrizione completa, ci si troverà al
cospetto di un autonomo titolo di reato. In particolare, tale criterio è stato seguito della
giurisprudenza in riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p., considerata circostanza aggravante della truffa, di cui all’art.
640 c.p., e non figura autonoma di reato.
2.4. Il quarto orientamento: Il criterio teleologico.
Per un quarto indirizzo (Cass. pen., Sez. Un., 22 settembre 2011, n. 34475; Cass. pen., Sez. Un., 8
gennaio 1998, n. 119; Cass. pen., Sez. Un., 12 settembre 1991, n. 91489; Cass. pen., Sez. Un., 26
novembre 1982, n. 11399), occorrerebbe verificare se muti, o meno, il bene giuridico tutelato
dalla fattispecie base o anche la diversità dell’entità della sua offesa; in particolare, mentre le
circostanze sarebbero caratterizzate dalla loro inidoneità ad incidere sulla sfera giuridica del
bene protetto, gli elementi costituivi del reato altererebbero, invece, il piano dell’offesa. Il
criterio de quo è stato, ad esempio, applicato sulla questione relativa alla natura giuridica del delitto
di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p., ritenuta figura autonoma atteso il
peculiare disvalore riconosciuto dalla norma ala partecipazione simultanea di più persone alla
fattispecie di violenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 3348).
2.5. Il quinto orientamento:
dell’interpretazione storica.
Il
criterio
della
ratio
legis
e
Infine, un ultimo orientamento (Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2006, n. 36606) fa leva sia sulla
ratio legis che sull’interpretazione storica dell’elemento oggetto di dubbio pe comprendere se si
tratti di circostanza o di elemento costituivo del reato. A tale criterio, la giurisprudenza ha fatto
ricorso in relazione alla fattispecie di furto in abitazione, reputandola fattispecie autonoma rispetto a
quella disciplinata dall’art. 624 c.p.).
135
Parte generale 3. Le ultime applicazioni giurisprudenziali: Il criterio strutturale delle
modalità di descrizione della fattispecie.
La Cassazione ha recentemente fatto applicazione del criterio strutturale (Cass. pen., Sez. II, 15
ottobre 2013, n. 44446) e, soffermandosi sul rapporto fra la fattispecie di truffa aggravata, di cui
all’art. 640 bis c.p., e la truffa, di cui all’art. 640 c.p., ribadisce la natura di circostanza della
prima, facendo così proprie le conclusioni cui era già giunta la Cassazione, in un precedente
arresto (Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 25361). La Corte precisa altresì che non esiste
alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o essenziali) e elementi
circostanziali (o accidentali) del reato, atteso che questi elementi si possono distinguere solo in
base alla disciplina positiva che ne stabilisce il legislatore; gli art. 61, 62 e 84 c.p. sono univoci al
riguardo, laddove riconoscono esplicitamente che lo stesso fatto materiale può essere considerato
dalla legge ora come elemento costitutivo ora come circostanza del reato.
In particolare, risulta opportuno precisare che la Cassazione ha optato per la natura di circostanza
aggravante dell’art. 640 bis c.p. in ragione sia del tenore letterale della relativa rubrica, che
definisce “aggravata” la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia la previsione
espressa della sua procedibilità di ufficio, altrimenti superflua ove detta norma avesse contemplato
una fattispecie autonoma, sia, infine, la funzione ancillare assegnata alla fattispecie di cui all’art.
640 bis c.p. rispetto a quella contemplata dall’art. 640 cod. pen. sarebbe resa evidente anche dal
rinvio operato a quest’ultima per quanto attiene agli elementi costitutivi del fatto.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che la società Alfa, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione
e legale rappresentante della medesima, possa andare incontro ad una condanna per il reato di truffa, di cui
all’art. 640 c.p., aggravata dalla previsione di cui all’art. 640 bis c.p.; tale conclusione, del resto sarebbe
ampiamente sorretta dalle risultanze delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica competente
ratione loci, dalle quali emergeva che la società, beneficiaria di un finanziamento pubblico finalizzato alle
aree sottoutilizzate del mezzogiorno, aveva ottenuto il predetto finanziamento con artifizi e raggiri.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 44446
Estratto
[...Omissis...]
3. La data di consumazione del reato deve dunque essere fissata in quella del 1 giugno 2004. Va quindi
applicata la precedente disciplina sulla prescrizione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p. di truffa per erogazioni
pubbliche costituisce una aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p. e non figura autonoma di reato,
con la conseguenza che al fine di determinare il tempo occorrente per il decorso della prescrizione bisogna
tener conto delle attenuanti concesse e del loro bilanciamento con la suddetta aggravante (Sez. Un.,
136
Scheda di giurisprudenza n. 14 26.6.2002, n. 26351, Fedi, m. 221663). Nella specie, il giudice di primo grado ha concesso le attenuanti
generiche ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti. Pertanto, dovendosi appunto applicare, in
considerazione della data di consumazione del reato di truffa, la precedente normativa più favorevole,
bisogna tenere conto, ai fini della prescrizione, della pena prevista dall’art. 640 c.p., comma 1, così come del
resto ha correttamente fatto il giudice di primo grado.
Ne consegue che, non risultando sospensioni, il reato di cui all’art. 640 bis c.p., iscritto al capo 1) si è estinto
per prescrizione il 1 dicembre 2011. Dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel
merito.
4. Da ciò consegue anche che restano assorbiti tutti gli altri motivi che investono il detto reato di cui all’art.
640 bis c.p..
Invero, non potrebbe essere pronunciato un annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente
a questo reato, stante l’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.
5. È anche fondato - conformemente alle richieste del Procuratore generale - il motivo con cui si censura la
statuizione che dispone la confisca dell’intera somma percepita a titolo di finanziamento, sebbene la stessa
sia stata integralmente già restituita all’ente erogante, il quale ha azionato la fideiussione bancaria prestata
dall’imputato.
6. La corte d’appello anche su questo punto si è pedissequamente riportata alla sentenza di primo grado, la
quale a sua volta aveva richiamato giurisprudenza relativa esclusivamente a provvedimenti cautelari di
sequestro preventivo per equivalente finalizzati a garantire una futura confisca del profitto del reato e non a
sentenze con le quali viene effettivamente imposta la confisca per equivalente. Nel medesimo equivoco
sembra caduta la corte d’appello la quale si è limitata a richiamare le massime secondo cui “In tema di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p., le somme di denaro
costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono suscettibili di
sostituzione attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia
personale di pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro” (Sez. 6, 1.7.2009, n. 36095, Fezia,
m. 244870); e “In tema di sequestro preventivo, il prezzo del reato, oggetto della confisca obbligatoria ex art.
322 ter c.p., non è suscettibile di essere sostituito dal tandundem offerto da un terzo o da un coimputato,
posto che il carattere sanzionatorio della suddetta confisca impedisce che l’autore del reato possa in alcun
modo avvantaggiarsi o, comunque beneficiare del “pretium sceleris” approfittando del fatto che altri abbia
offerto una somma equivalente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini del sequestro preventivo
del prezzo del reato di cui all’art. 319 c.p. che il coindagato di corruzione attiva avesse versato su un c/c
vincolato a favore dell’Erario una somma diretta a coprire, per l’ipotesi dell’eventuale confisca, oltre al profitto
del reato anche il suddetto prezzo)” (Sez. 6, 19.3.2009, n. 16725, Fitto, m. 243672); e “Le somme di denaro
oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione
mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, atteso che,
altrimenti, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all’indagato la disponibilità
del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante” (Sez.
3, 19.6.2012, n. 33587, Paulin, m. 253135).
È chiaro l’equivoco della sentenza impugnata che ha applicato massime inconferenti, relative al diverso tema
dei presupposti per concedere la misura cautelare reale del sequestro preventivo, e non alla applicazione
della confisca, senza considerare le fattispecie concrete alle quali le massime si riferivano e nemmeno le
relative motivazioni. Ed invero, la sentenza relativa alla massima da ultimo ricordata (Sez. 3, 19.6.2012, n.
33587, Paulin, m. 253135) ha espressamente affermato (richiamando anche Sez. 2, n. 45054 del 2011, Rv.
251070) come “la confisca sia strumentale a colpire l’accrescimento patrimoniale frutto dell’illecito e non una
parte del patrimonio in quanto tale, dandosi altrimenti vita ad un effetto sanzionatorio illegittimo, in quanto
non previsto dalla legge” e soprattutto evidenziato “che il sequestro per equivalente non possa
ricomprendere le somme che abbiano già formato oggetto di restituzione”, e che proprio sulla base di questo
principio si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 322 ter c.p.
137
Parte generale ed L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, per la parte in cui, nel prevedere la confisca per
equivalente anche per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contrasterebbero, nel caso di
sanatoria della posizione debitoria con l’Amministrazione finanziaria, con gli artt. 23 e 25 Cost. La medesima
sentenza ha anche osservato che “la restituzione all’Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo
principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 10120 del
01/12/2010 Rv. 249752). E tale indirizzo va certamente condiviso in quanto lo scopo del sequestro per
equivalente in funzione della successiva confisca non può che essere quello di colpire l’accrescimento
patrimoniale nei casi in cui non sia possibile apprendere direttamente i beni che rappresentano il profitto del
reato”.
Va quindi anche in questa sede confermato che “la restituzione all’erario del profitto derivante dal reato
elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe
appunto una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che l’espropriazione
definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato” (Sez. 3, 01/12/2010 n.
10120, Provenzale, in motivazione).
Non può dunque condividersi l’assunto della corte d’appello secondo cui, nonostante vi sia stata la totale
restituzione delle somme per conto della società beneficiaria del finanziamento, Elen’ s Beer s.a. e
dell’odierno ricorrente, dovrebbe comunque operare a titolo sanzionatorio la confisca per equivalente dei beni
intestati a R. A.. Se così fosse, infatti, si incorrerebbe in una duplicazione della restituzione, con una
sostanziale sproporzione tra il presunto profitto e prezzo del reato e la somma restituita ed il valore dei beni
confiscati.
Nella specie è pacifico che è comunque avvenuta la restituzione integrale delle somme percepite e che
dunque non residua alcun danno erariale a carico dello Stato per come riconosciuto anche dalla Procura
della Corte dei Conti.
Appare inoltre irrilevante la circostanza che la restituzione sia avvenuta mediante l’escussione della polizza
fideiussoria bancaria, dal momento che, in ogni caso, la polizza fideiussoria è stata comunque prestata
dall’odierno ricorrente e le somme anticipate dalla banca sono state poste a suo carico. Ciò che conta, infatti,
è l’avvenuto pagamento, per conto ed in nome dell’odierno ricorrente, della somma inizialmente erogata dallo
Stato a titolo di anticipazione, pagamento che ha eliminato radicalmente il possibile configurarsi di un danno
erariale a carico dello Stato ed ha fatto venire meno l’eventuale profitto derivante dal reato al medesimo
ricorrente. Questa conclusione è confermata anche dalla necessità di dare alle disposizioni che vengono in
rilievo una interpretazione adeguatrice, che eviti una possibile non conformità con i principi di cui agli artt. 3,
23 e 25 Cost., qualora imponessero la confisca per equivalente anche allorchè il profitto conseguito o il
prezzo del reato siano stati comunque oggetto di restituzione.
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. Un., 15 ottobre 2013, n. 44446
Estratto
[...Omissis...]
4 - La questione posta all’esame delle Sezioni unite si può quindi formulare nel modo seguente:
“se l’art. 640 bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) preveda una figura
autonoma di reato ovvero una circostanza aggravante del reato di truffa”.
Com’è noto, l’art. 640 bis è stato introdotto nel codice penale dall’art. 22 della legge 19.3.1990 n. 55, che
reca come titolo “nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale”.
Su questo tema, l’originario disegno di legge del Governo, presentato alla Camera dei Deputati il 5.11.1988,
138
Scheda di giurisprudenza n. 14 di fronte alla “eccezionalità e gravità del fenomeno mafioso” si proponeva di “procedere a un rapido riesame
e aggiornamento degli strumenti normativi in vigore per ricalibrarne la disciplina in relazione alle mutate
strategie delle organizzazioni criminali”. A tale fine di(*) il disegno di legge non intendeva “ricorrere a
strumenti eccezionali, bensì ad un rafforzamento ed un aggiornamento di quelli ordinari già previsti dalla
vigente normativa antimafia”, attraverso la tecnica novellistica (Atto Camera n, 3325-ter).
L’impostazione governativa fu ampiamente condivisa dal Parlamento, che approvò più penetranti misure di
prevenzione e una disciplina più rigorosa delle misure atte a precludere i rapporti tra soggetti mafiosi e
pubblica amministrazione. Peraltro, l’art. 22, introduttivo della nuova fattispecie penale di cui all’art. 640 bis
c.p., non era previsto nel disegno di legge governativo, ma fu introdotto, attraverso un emendamento del
relatore, durante l’esame del disegno presso la Camera dei Deputati.
In conclusione, all’esito della discussione parlamentare, venne approvata la legge n. 55-1990 e introdotto nel
codice penale l’art. 640 bis, che recita testualmente: “La pena è della reclusione da uno a sei anni e si
procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee.”
È significativo che, nello stesso torno di tempo, con l’art. 3 della legge 26.4.1990 n. 86 (modifiche in tema di
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) fu introdotta nel codice penale una nuova
fattispecie di malversazione a danno dello Stato, secondo la quale è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico (o dalle Comunità europee - secondo un’aggiunta inserita con legge 7.2.1992 n. 181) contributi,
sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento
di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (art. 316 bis c.p.).
È evidente che il legislatore italiano del 1990 e del 1992 ha voluto in tal modo offrire una tutela penale agli
interessi finanziari della Comunità Europea, incriminando sia la fraudolenta captazione sia la indebita
utilizzazione delle sovvenzioni e dei contributi erogati in attuazione della politica comunitaria. E ciò ha fatto
per adempiere agli impegni che gli derivano dai trattati europei (art. 5 e art. 280 del Trattato di Roma, così
come modificato dal Trattato di Amsterdam), e per rispondere alle pressioni dei partners comunitari,
preoccupati dal dilagare delle frodi nella soggetta materia e dal coinvolgimento crescente in questa pratica
della criminalità organizzata.
Giova peraltro rammentare che, prima e dopo il 1990, altre figure sono state introdotte nel sistema penale
nazionale di tutela delle erogazioni comunitarie.
Già nel 1986 venne introdotto il reato di frode in danno del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia
(F.E.O.G.A.), secondo il quale è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, mediante
l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità,
restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del predetto fondo (art. 2 della legge 23.12.1986, di
conversione del decreto legge 701-1986). Nel 1992, due anni dopo l’introduzione dell’art. 640 bis c.p., il
legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia per inserire una espressa clausola di riserva, secondo la
quale la fattispecie di frode comunitaria agraria resta integrata solo “ove il fatto non configuri il più grave reato
previsto dall’art. 640 bis c.p.” (art. 73 legge 142-1992). In tal modo veniva legislativamente recepito il
carattere sussidiario della fattispecie rispetto alla truffa comunitaria codicisiica, già stabilito dalla
giurisprudenza di legittimità: sicché il reato speciale di frode comunitaria agricola resta configurato solo
quando il soggetto attivo si limiti all’esposizione di dati e notizie falsi, e non anche quando, oltre alle false
dichiarazioni, utilizzi artifici e-o raggiri di altra natura, che integrano invece il delitto codicistico di truffa
comunitaria (Cass. Sez. Un. n. 2780 del 24.1.1996, dep. 14.3.1996, P. e altri, rv. 203969).
Infine, il quadro normativo è stato ulteriormente complicato con la legge 29.9.2000 n. 300, che, con l’art. 4,
ripetendo la consueta clausola di riserva, ha introdotto nel codice penale l’art. 316 ter (indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato), che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, “salvo che il fatto
costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis” l’indebita percezione di erogazioni concesse dallo Stato, da altri
139
Parte generale enti pubblici o dalle Comunità europee “mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute”.
5 - La suddetta formulazione dell’art. 640 bis introduce chiaramente un elemento di specializzazione rispetto
alla fattispecie di cui all’art. 640, laddove descrive il fatto - reato richiamando quello di cui all’art. 640 con tutti
i suoi elementi costitutivi (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto
profitto dell’agente o di terzi, danno del soggetto passivo), ma prevedendo un oggetto materiale specifico
della condotta fraudolenta e della disposizione patrimoniale, vale a dire contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o
delle Comunità europee.
Tuttavia, bisogna osservare che l’elemento di specializzazione non offre alcuna chiave ermeneutica per la
soluzione della questione sottoposta alle Sezioni unite. Infatti esso, se sovente connota una fattispecie
circostanziale rispetto al reato semplice col quale intercorre il rapporto di specialità (es. lesioni gravi e
gravissime di cui all’art. 583, rispetto alle lesioni semplici di cui all’art. 582), qualche volta configura
sicuramente una fattispecie autonoma di reato: si pensi all’abrogato delitto di oltraggio, o al superstite delitto
di oltraggio a magistrato in udienza, rispetto alla generale fattispecie dell’ingiuria; o anche alla fattispecie di
cui alla lett. c), secondo periodo, dell’art. 20 legge 47-1985 (interventi edilizi senza concessione in zone
sottoposte a vincolo), costantemente ritenuta autonoma e non circostanziale rispetto alla fattispecie di cui alla
lett. b) dello stesso art. 20 (interventi edilizi senza concessione in zone non vincolate).
Ciò si spiega con la ragione che non esiste alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o
essenziali) e elementi circostanziali (a accidentali) del reato, atteso che questi elementi si possono
distinguere solo in base alla disciplina positiva che ne stabilisce il legislatore. Gli articoli 61, 62 e 84 c.p. sono
univoci al riguardo, laddove riconoscono esplicitamente che lo stesso fatto materiale può essere considerato
dalla legge ora come elemento costitutivo ora come circostanza del reato.
6 - Se quindi il legislatore è libero di assumere un dato fattuale nell’una o nell’altra categoria, per risolvere la
questione bisogna necessariamente accertare quale sia esattamente la voluntas legis. La soluzione non è
però semplice, perché gli indizi positivi a disposizione dell’interprete per risalire a questa volontà sono spesso
incerti ed ambigui, sicché gli approdi giurisprudenziali e dottrinali risultano travagliati e contrastanti.
In tema di truffa relativa ad erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata
in base a varie argomentazioni a ritenerla fattispecie autonoma di reato (Sez. II, n. 3086 del 9.7.1996, P.G. in
proc. L., rv. 206859; Sez. I, n. 6753 del 1.12.1997, confl. comp. in proc. P.; Sez. II, n. 11582 del 15.10.1998,
D. V., rv. 211650; Sez. I, n. 2286 del 19.3.1999, confl. comp. in proc. M., rv. 213349; Sez. I, n. 4240
dell’8.6.1999, confl. comp. in proc. C., rv. 213949; Sez. II, n. 11077 del 20.10.2000, P.M. in proc. B., rv.
217130).
Nettamente minoritaria è invece l’opzione giurisprudenziale che configura la nuova fattispecie come
circostanza aggravante del delitto di truffa (Sez. II, n. 4731 dell’8.3.2000, V., rv. 217105; nonché Sez. I, n.
6843 del 4.12.1997, confl. comp. in proc. L., rv. 209537, che però omette qualsiasi motivazione specifica sul
punto).
Di segno contrario sembra l’orientamento complessivo della dottrina, che si è prevalentemente schierata per
la tesi della figura circostanziale, salvo opzioni minoritarie a favore della figura autonoma di reato.
Inutile sottolineare la rilevanza pratica della questione, anche dopo la modifica intervenuta nella disciplina
codicistica delle circostanze del reato in tema di imputazione soggettiva delle stesse (legge 19-1990).
Caduta con questa legge l’imputazione oggettiva delle circostanze, ricondotta nell’ambito costituzionale del
principio di responsabilità colpevole, la differenza tra elemento costitutivo ed elemento circostanziale del
reato continua a rilevare soprattutto in ordine al giudizio di bilanciamento, che ai sensi dell’art. 69 c.p. può
essere effettuato in ogni caso di concorso tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti (e che è
strutturalmente impensabile in relazione agli elementi costitutivi). La rilevanza della distinzione si è poi acuita
dopo che, col decreto legge n. 99-1974, convertito in legge 7.6.1974 n. 220, si è ammesso al bilanciamento
ogni tipo di circostanza, comprese le circostanze c.d. autonome o indipendenti e quelle inerenti alla persona
140
Scheda di giurisprudenza n. 14 del colpevole, così attribuendo al giudice una potestà discrezionale vastissima, attraverso la quale egli può
neutralizzare imponenti aumenti sanzionatori ove li riconosca connessi a una configurazione circostanziale
anziché a una configurazione autonoma del reato.
Ma la distinzione ha anche rilievo, seppure meno importante, agli effetti del concorso di persone nel reato
(applicandosi gli artt. 116 e 117 ovvero l’art. 118 c.p., a seconda che si adotti una o l’altra opzione), e della
depenalizzazione (art. 32 legge 689-1981: ma in tal caso, la qualifica circostanziale sarebbe meno favorevole
all’imputato, perché impedirebbe nei congrui casi la depenalizzazione del reato base). Un effetto indiretto
della distinzione si verifica in ordine alla prescrizione, come dimostra il caso di specie.
7 - Conviene a questo punto esaminare partitamente i criteri adottati da dottrina e giurisprudenza per
accertare la volontà legislativa in ordine alla qualificazione circostanziale o costitutiva di una fattispecie,
quando - come accade purtroppo nella maggior parte dei casi - essa non sia espressamente manifestata.
Essi sono criteri di natura testuale o topografica, di natura strutturale o di natura teleologica.
7.1 - Fra i primi rientra il nomen iuris adottato dal legislatore, come nel caso di specie, in cui la rubrica dell’art.
640 bis è intitolata “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”. In questo caso il titolo
della rubrica sembra indicare nettamente la volontà di configurare la fattispecie come circostanza
aggravante. Ma - come è noto - la rubrica non è mai stata ritenuta indizio univoco e assoluto della voluntas
legis.
Del resto, seguendo lo stesso criterio del nomen iuris, un indizio simmetricamente contrario dovrebbe
ricavarsi dalla formulazione dell’art. 7 della legge 31.5.1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), come
modificato dal D.L. 152-1992, convertito in legge 12.7.1991 n. 203, il quale prevede un aumento di pena, se il
fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, in ordine ai “delitti previsti” dall’art. 640
bis, oltre che da altre numerose norme. Altro indizio testuale contrario si potrebbe ravvisare nelle succitate
clausole di riserva di cui alle leggi 142-1992 e 300-2000, laddove la fattispecie di cui all’art. 640 bis è ancora
qualificata come “reato”. In queste disposizioni il legislatore sembra qualificare il fatto descritto nell’art. 640
bis come figura autonoma di reato e non come circostanza aggravante.
7.1.1 - Altro indizio dello stesso genere è quello che si potrebbe chiamare topografico, perché valorizza la
collocazione della norma: se la norma è formulata in un articolo separato, denoterebbe una fattispecie
autonoma di reato; se è formulata nello stesso articolo che prevede il reato semplice, denoterebbe una
fattispecie circostanziale.
Secondo questo indizio, dunque, il reato di cui all’art. 640 bis sarebbe autonomo rispetto a quello di truffa
previsto dall’art. 640.
Ma anche questo indizio non è probante, perché vi sono fattispecie formulate in articoli separati che tuttavia
sono da classificarsi come circostanze aggravanti: così le circostanze aggravanti previste negli artt. 292 bis e
293 c.p. rispetto ad alcuni delitti contro la personalità interna dello Stato, se compiuti da militari in congedo o
dal cittadino in territorio estero. Di contro vi sono fattispecie formulate nello stesso articolo che sono
sicuramente reati autonomi: per esempio forme colpose di delitti dolosi; le diverse ipotesi di favoreggiamento
personale di cui al comma primo e al comma terzo dell’art. 378 c.p.; o altri reati c.d. a fattispecie plurime
contemplati in molte leggi speciali.
7.2 - I criteri che si possono chiamare strutturali, perché attengono alla struttura del precetto o della
sanzione, sono invece di maggior peso.
7.2.1 - Così, il modo in cui il legislatore descrive gli elementi costitutivi della fattispecie può essere molto
indicativo della volontà di qualificarli come circostanza o come reato autonomo. Si sostiene che quando la
fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto - reato tipizzato in altra disposizione di legge, ci si
trova in presenza di una circostanza aggravante. Si replica in contrario che vi sono casi in cui un reato
sicuramente autonomo è descritto solo per relationem. Così per il reato di cui all’art. 251, comma 2, c.p., nel
quale l’inadempimento colposo di contratti di fornitura in tempo di guerra è indicato richiamando
l’inadempimento doloso di cui al comma 1 dello stesso articolo (“se l’inadempimento del contratto, totale o
parziale, è dovuto a colpa”). Così anche, prima della recente depenalizzazione della figura colposa, avveniva
141
Parte generale per il delitto di atti osceni di cui all’art. 527 c.p., dove il delitto colposo era individuato nel secondo comma
attraverso il rinvio al “fatto” descritto nel primo comma (“se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da
lire sessantamila a lire seicentomila”). Altro esempio si può ravvisare nei delitti colposi contro la salute
pubblica di cui all’art. 452 c.p., individuati richiamando semplicemente i “fatti” preveduti dagli artt. 438 e 439
c.p..
7.2.2 - Altro criterio strutturale è dato dal modo di determinazione della pena.
In certi casi il legislatore determina la pena richiamando quella prevista in altra norma e applicando sulla
stessa una variazione frazionaria in aumento o in diminuzione. Nonostante la determinazione per relationem
possa far pensare alla configurazione di una circostanza, sono però frequenti i casi in cui è indubbia la
previsione di uno autonomo reato: così per la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.
320 c.p.); per la subornazione (art. 377), la cui pena è stabilita in relazione a quelle previste per la falsa
testimonianza e la falsa perizia o interpretazione; per i già citati delitti colposi contro la salute pubblica di cui
al secondo comma dell’art. 452.
In altri casi invece il legislatore determina la pena modificandone la specie o mutando la cornice edittale
rispetto alla pena di riferimento. Anche in questi casi in genere l’indizio non è univoco, perché, con siffatte
variazioni del trattamento sanzionatorio, talvolta il legislatore ha inteso configurare una figura nuova di reato
e talaltra ha semplicemente previsto una circostanza c.d. autonoma o indipendente.
In linea generale, comunque, l’unico caso in cui il modo di determinazione della pena non lascia adito a dubbi
è quello in cui la variazione in aumento o in diminuzione è lasciata indeterminata dal legislatore: così per
esempio nei già menzionati articoli 292 bis e 293. In tali casi il giudice che debba quantificare la pena deve
necessariamente far ricorso ai criteri generali stabiliti negli artt. 64 e 65 c.p., che delimitano la variazione
quantitativa entro una misura frazionaria (un terzo) e specificano la variazione qualitativa (reclusione fino a
24 anni invece che ergastolo). E poiché tali variazioni sono stabilite con espresso riferimento alle circostanze
del reato (come si evince dalla rubrica delle norme e del capo II in cui sono inserite), ne risulta obiettivamente
una chiara volontà del legislatore di sussumere la fattispecie sotto la categoria del reato circostanziato.
In tal modo resta individuato un indizio univoco della voluntas legis in ordine alla qualificazione circostanziale
o essenziale del fatto. Ma questo indizio non è utilizzabile per la questione rimessa al giudizio di queste
Sezioni unite, atteso che l’art. 640 bis non lascia indeterminata la variazione sanzionatoria e quindi non
richiede l’applicazione dell’art. 64.
7.3 - Resta ora da esaminare il criterio di tipo teleologico, che è in genere quello più seguito dalla
giurisprudenza di legittimità. Secondo questo criterio, quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico
diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un’autonoma figura
di reato e non a una circostanza aggravante.
In particolare questo criterio è stato adottato in numerose decisioni di queste Sezioni unite.
La sentenza G. del 1982, trattando un caso di omessa cessione all’ufficio italiano dei cambi di valuta estera
non superiore a lire cinque milioni, affermava nettamente il principio che ai fini della distinzione tra
circostanze ed elementi costitutivi del reato occorre tener presente il bene giuridico protetto (Sez. Un. n.
11399 del 19.6.1982, dep. 26.11.1982, G., rv. 156405).
La sentenza P. del 1991, nel qualificare come circostanza attenuante l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art.
73 del D.P.R. 9.10.1990 n. 309, secondo cui si applicano pene molto inferiori se i fatti di produzione e traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono di lieve entità per i mezzi, per le modalità o le circostanze
dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, osservava che questi ultimi elementi della
fattispecie non modificano nè l’obiettività giuridica nè la struttura essenziale del reato, ma attribuiscono al
reato stesso solo minore valenza offensiva e grado di pericolosità: sicché sono elementi di carattere
accidentale ed accessorio, esterni alla struttura tipica del reato, che incidono solo sulla gravità del reato e
sulla quantità della pena (Sez. Un. n. 9148 del 31.5.1991, dep. 12.9.1991, P., rv. 187930).
Significativa è anche la sentenza P. del 1994. Le Sezioni unite dovevano affrontare la questione se il
superamento della soglia di lire cento milioni di proventi non dichiarati, prevista nell’art. 1, comma 1, della
142
Scheda di giurisprudenza n. 14 legge 7.8.1982 n. 516, costituisse una circostanza aggravante del reato di omessa dichiarazione fiscale,
ovvero un titolo autonomo di reato. La questione si poneva prima della modifica introdotta dalla legge
15.5.1991 n. 154, che invertendo l’ordine delle proposizioni normative e anteponendo l’ipotesi della omessa
dichiarazione di proventi per oltre cento milioni, trasformava tale ipotesi in reato base, rispetto all’ipotesi
minore - posposta - della omessa dichiarazione di proventi inferiori ai cento milioni. Orbene, la sentenza
osservava che ciò che distingueva le due ipotesi era un mero dato quantitativo, che indicava il maggior
pericolo cui era esposto il bene giuridico protetto, che era comune a entrambe le ipotesi contravvenzionali;
sicché la diversità del dato quantitativo, restava un profilo contingente, che non intaccava l’identità del bene
protetto e la struttura essenziale del reato. Per conseguenza, in base a siffatto criterio, integrato da altri criteri
complementari, la fattispecie doveva qualificarsi come circostanza aggravante e non come titolo autonomo di
reato.
Da ultima, utilizza - assieme ad altri - il criterio dell’oggettività giuridica la sentenza D. del 1997. Essa doveva
valutare se il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 15 kg., previsto e punito
dall’art. 2 della legge 18.1.1994 n. 50, costituisse figura autonoma di reato oppure circostanza aggravante del
delitto di contrabbando previsto dall’art. 282 D.P.R. 21.1.1973 n. 43. Al riguardo osservava anzitutto che
differenti sono gli interessi tutelati dalle due disposizioni e quindi differente è l’oggettività giuridica, giacché il
testo unico del 1973 tutela la potestà tributaria dello Stato e la riscossione delle imposte di confine, mentre la
legge del 1994 protegge il regime di monopolio sui tabacchi. Era questo un primo sintomo della volontà del
legislatore del 1994 di configurare un reato autonomo anziché una circostanza aggravante (Sez. Un. n. 119
del 29.10.1997, dep. 8.1.1998, D., rv. 209126). L’obiezione più seria contro il criterio dell’oggettività giuridica
è quella che denuncia l’inversione logica su cui esso si fonda. Per individuare l’interesse tutelato dalla
fattispecie penale, invero, è necessario prima esaminare la struttura della stessa fattispecie, distinguendo i
suoi elementi essenziali da quelli accidentali; sicché si potrà registrare un mutamento del bene tutelato solo
quando e perché è stato accertato un mutamento degli essentialia delicti.
Le stesse sentenze sopra citate, in realtà, pur adottando formalmente il criterio teleologico, finiscono per
optare per la qualificazione circostanziale o per la qualificazione autonoma della fattispecie non tanto perché
non è cambiata o è cambiata l’oggettività giuridica, quanto piuttosto perché è rimasta o non è rimasta
immutata la struttura essenziale del reato (per una formulazione esplicita in questo senso, v. soprattutto le
sentenze P. e P.).
Solo in questo senso si può dire che la fattispecie circostanziale modifica soltanto il grado di offensività della
condotta, senza sostituire il bene tutelato. Anche se si deve aggiungere che non è sempre vero il contrario,
che cioè la figura autonoma di reato modifica necessariamente l’oggetto giuridico rispetto alla figura
autonoma di riferimento: così per esempio l’infanticidio di cui all’art. 578 c.p. ha lo stesso oggetto giuridico
dell’omicidio di cui all’art. 575 c.p..
8 - Rilevato il carattere insoddisfacente o comunque non risolutivo degli indici sopra esaminati, un’autorevole
dottrina ha sostenuto che nella soggetta materia deve essere adottato come criterio preferenziale il principio
di legalità canonizzato nell’art. 25, comma 2, Cost. e nell’art. 1 c.p..
Quando si controverte intorno alla natura costitutiva o circostanziale di un determinato elemento della
fattispecie, si controverte per ciò stesso circa l’esistenza nell’ordinamento di una particolare figura criminosa.
Ma per il principio di legalità questa figura esiste nell’ordinamento solo se è “espressamente” prevista,
ovverosia se è contemplata in modo certo e incontrovertibile: sicché ogni dubbio ermeneutico deve essere
risolto contro la qualificazione autonoma e a favore della qualificazione circostanziale della fattispecie.
Questa teoria ha carattere dichiaratamente residuale, perché dovrebbe soccorrere solo quando la voluntas
legis rimanga altrimenti inaccessibile all’interprete.
Ma a parte questa considerazione, essa si espone a un’essenziale obiezione di ordine dommatico, perché il
principio di legalità vale per il reato semplice come per il reato circostanziato; sicché, in mancanza di
un’espressa qualificazione legislativa, l’interprete dubbioso non potrebbe optare per una configurazione
circostanziale invece che autonoma senza incidere ugualmente sul principio di legalità penale.
143
Parte generale Nello stesso ordine di idee, qualche autore ha additato come criterio sussidiario di risoluzione della questione
il favor rei, sostenendo che nei casi dubbi l’interprete dovrebbe qualificare la fattispecie come circostanziale,
in quanto essa è più favorevole all’imputato, che in tal modo potrebbe godere dei benefici effetti del giudizio
di bilanciamento tra circostanze.
Ma nell’ordinamento penale, il favor rei è un principio di accertamento del fatto addebitato all’imputato, è cioè
soltanto un principio che regola l’applicazione della legge al caso concreto, non già un canone di
interpretazione della legge stessa.
E ciò senza considerare che in teoria la configurazione circostanziale non sempre è più favorevole
all’imputato. Si pensi a un dubbio ermeneutico tra un reato autonomo meno grave rispetto al reato di
riferimento e una circostanza attenuante: in tal caso la qualificazione come circostanza attenuante espone
l’imputato alla pena più grave prevista per il reato semplice, ove il giudice ritenga l’attenuante equivalente (o
peggio subvalente) rispetto a concorrenti circostanze aggravanti, speciali o comuni.
9 - Dopo aver saggiato in tal modo la validità generale dei criteri adottabili nella soggetta materia, è possibile
affrontare più da vicino il thema decidendum.
Un criterio del tutto specifico utilizzato per risolvere il problema della qualificazione giuridica della fattispecie
de qua, è quello del regime di procedibilità espressamente previsto per la stessa. Ma anche questo criterio è
stato utilizzato ed è utilizzabile con pari plausibilità razionale per conclusioni diametralmente opposte. Come
s’è già visto, l’art. 640 bis richiede che si proceda d’ufficio. Orbene, da una parte si può sostenere che questo
è indizio della configurazione circostanziale, giacché per una fattispecie autonoma di reato la procedibilità
d’ufficio è la regola e quindi non aveva alcun senso richiamarla espressamente. Ma d’altra parte si può
sostenere con altrettanto fondamento logico che, siccome la procedibilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 640,
ultimo comma, è prevista come regola per la truffa aggravata da qualsiasi circostanza, speciale o comune, il
richiamo alla procedibilità officiosa risulterebbe superfluo anche se si accedesse alla tesi del reato
circostanziato.
S’è già visto che anche i criteri generali del nomen iuris e della collocazione topografica della norma non
hanno portata univoca.
Anche il modo di determinazione della pena non ha un valore sintomatico decisivo nel caso della truffa
comunitaria. Come s’è visto, la fattispecie di cui all’art. 640 bis non lascia indeterminata la variazione della
pena, sicché sia necessario fare ricorso all’art. 64 c.p.; ma stabilisce invece la pena con una variazione
qualitativa (reclusione, invece che reclusione e multa) e con una variazione quantitativa (reclusione da uno a
sei anni, invece che reclusione da sei mesi a tre anni) rispetto alla pena prevista per la truffa semplice.
Peraltro questa formulazione può denotare tanto la volontà di configurare la fattispecie come reato a sè,
quanto la volontà di configurare una circostanza aggravante autonoma rispetto alla truffa semplice.
Risulta invece decisivo, ad avviso di questo collegio, il criterio strutturale della descrizione del precetto
penale.
Nel caso dell’art. 640 bis la fattispecie è descritta attraverso il rinvio al fatto - reato previsto nell’art. 640,
seppure con l’integrazione di un oggetto materiale specifico della condotta truffaldina e della disposizione
patrimoniale (le erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici). Una siffatta
struttura della norma incriminatrice indica la volontà di configurare soltanto una circostanza aggravante del
delitto di truffa. L’obiezione summenzionata (paragrafo 7.2.1), secondo cui vi sono casi in cui la descrizione
per relationem è tuttavia compatibile con la configurazione di un autonomo reato, non regge a un’analisi
critica più attenta. A ben vedere, tutti i casi addotti a sostegno dell’obiezione, tra cui l’art. 251, comma 2, l’art.
452 e l’art. 527, comma 2 (prima della recente depenalizzazione), configurano reati colposi, sicché la
descrizione per rinvio alla corrispondente ipotesi dolosa non contrasta con la configurazione di una
fattispecie autonoma di reato solo per la ragione che il modulo descrittivo adoperato, se da una parte
richiama il fatto tipico del reato doloso, dall’altra introduce anche una variazione nell’elemento soggettivo, che
è essenziale nella struttura del reato medesimo, trasformandolo da doloso a colposo.
In altri termini, è propria la struttura della fattispecie penale di cui all’art. 640 bis, definita da un lato attraverso
144
Scheda di giurisprudenza n. 14 il richiamo degli elementi essenziali del delitto di truffa di cui all’art. 640 (artifici o raggiri, induzione in errore
con conseguente disposizione patrimoniale, ingiusto profitto per l’agente o per altri, danno del soggetto
passivo) e dall’altro con l’introduzione di un elemento specifico (erogazioni pubbliche) che è estraneo alla
struttura essenziale della truffa, a denotare la inequivoca volontà legislativa di configurare una circostanza
aggravante e non un diverso titolo di reato. La descrizione della fattispecie, insomma, non immuta gli
elementi essenziali del delitto di truffa, nè quelli materiali nè quelli psicologici, ma introduce soltanto un
oggetto materiale specifico - tradizionalmente qualificato come accidentale e cioè circostanziale - laddove
prevede che la condotta truffaldina dell’agente e la disposizione patrimoniale dell’ente pubblico riguardino
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. Tra reato - base e reato
circostanziato intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel
senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l’aggiunta di
elementi circostanziali.
Per completezza, si deve rilevare come la specialità che caratterizza la fattispecie dell’art. 640 bis rispetto
alla truffa semplice di cui all’art. 640 sia in realtà duplice, giacché riguarda sia l’oggetto materiale della
condotta dell’agente e della disposizione patrimoniale del soggetto passivo (sovvenzioni ed erogazioni) sia la
natura pubblica del soggetto passivo medesimo (Stato, Comunità europea, altri enti pubblici); mentre in
rapporto alla fattispecie di truffa aggravata contro lo Stato o altri enti pubblici, di cui all’art. 640 cpv. n. 1,
quella specialità si riduca solo all’oggetto materiale, posto che i soggetti passivi appartengono nei due casi
alla stessa categoria pubblicistica (gli istituti comunitari sono considerati pacificamente di diritto pubblico: cfr.
per tutte Cass. Sez. Un. P., succitata, rv. 203971).
A questo proposito va quindi rilevato che, una volta qualificata la fattispecie de qua come circostanza
aggravante, la sua applicazione dà luogo a un concorso di circostanze aggravanti, disciplinato dall’art. 68
c.p., con l’assorbimento della circostanza generale dell’art. 640 cpv. n. 1 nella circostanza speciale di cui
all’art. 640 bis (è la circostanza c.d. complessa, che l’art. 68 disciplina facendo espressamente salva
l’applicabilità del principio di specialità di cui all’art. 15 preleggi).
10 - Per le considerazioni sopra svolte, restando immutata la struttura essenziale del reato, non cambia
neppure il bene giuridico tutelato, che è sempre il patrimonio del soggetto passivo. L’unica particolarità è data
dal fatto che nella truffa aggravata di cui all’art. 640 bis, come del resto in quella aggravata di cui all’art. 640
cpv. n. 1, a essere offeso è il patrimonio di un ente pubblico.
Vero è che si possono ipotizzare casi di truffa aggravata contro enti pubblici in cui è difficile ravvisare quella
effettiva deminutio patrimoni tradizionalmente ritenuta essenziale per integrare la truffa. Quando lo Stato o la
Unione europea stanzia in bilancio fondi da destinare a finanziamenti per aiutare - ad esempio - imprese
aventi particolari requisiti, l’illecita captazione del finanziamento, carpita rappresentando fraudolentemente
requisiti inesistenti, può avere l’effetto di sottrarre il finanziamento ad altre imprese in possesso dei requisiti di
legge, ma non quello di provocare uscite di bilancio superiori a quelle stanziate dall’ente erogatore. Per tali
casi tuttavia la dottrina ha opportunamente precisato che la nozione di patrimonio deve essere intesa in
senso dinamico o funzionale, come corretta allocazione delle risorse pubbliche, sicché il danno patrimoniale
subìto(*) dall’ente pubblico si atteggia come sviamento dal vincolo di destinazione delle risorse. Ne deriva
che anche negli esempi indicati la truffa aggravata causa un danno patrimoniale all’ente erogatore.
Del resto, se si volesse sostenere che nella truffa aggravata di cui all’art. 640 bis interviene un mutamento
del bene giuridico tutelato, posto che la tutela penale si sposterebbe dal patrimonio alla funzione pubblica
amministrativa (nonostante la collocazione del reato sotto i delitti contro il patrimonio), per dedurne così che
la fattispecie debba qualificarsi come reato autonomo anziché come circostanza aggravante, si dovrebbe
escludere la qualifica circostanziale anche per la fattispecie di cui all’art. 640 cpv. n. 1. Ma nessuna
pronuncia giurisprudenziale e quasi nessun autore arriva a tale conclusione.
11 - In realtà, la tesi che opta per la qualificazione della fattispecie come autonomo titolo di reato sottende
spesso, in modo più o meno esplicito, la preoccupazione di non indebolire la repressione e la prevenzione di
un fenomeno criminale - spesso organizzato - quale quello della truffa per il conseguimento di erogazione
145
Parte generale pubbliche, specialmente comunitarie, giacché la prevenzione e repressione di un simile fenomeno sarebbe
inevitabilmente pregiudicata dalla frequente propensione dei giudici di considerare prevalenti o equivalenti
pur gracili attenuanti a fronte di circostanze aggravanti anche di maggior peso.
Ma questa pur apprezzabile ragione di politica criminale non può essere perseguita a costo di manipolazione
esegetiche,che finiscono per tradire la oggettiva volontà della legge.
A questo riguardo si può ragionevolmente ritenere che il legislatore nazionale non abbia rigorosamente
adempiuto agli obblighi che gli derivano dall’appartenenza alla Unione europea. Come già accennato, a
norma dell’art. 280 del Trattato di Roma (come modificato dall’art. 209 A del Trattato di Amsterdam), gli Stati
membri devono combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della
Comunità adottando misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace degli Stati
membri (primo comma). Inoltre, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della
Comunità, devono adottare le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro
interessi finanziari (secondo comma).
Atteso che da tale norma derivano per gli Stati membri due principi vincolanti per la disciplina delle frodi
comunitarie, il principio di dissuasione efficace e il principio di assimilazione, si può anche concludere - con
una valutazione non priva di fondamento - che il legislatore italiano ha sicuramente rispettato il principio di
assimilazione (considerata la parità di trattamento delle truffe per erogazioni comunitarie e per erogazioni
statali), ma ha lasciato molto a desiderare verso il principio di dissuasione efficace (considerata la possibilità
di controbilanciare l’aggravamento sanzionatorio).
Ma, ancora una volta, il principio comunitario non può diventare criterio di interpretazione della legge
nazionale, al punto da capovolgerne il chiaro dettato normativo in base a una supposta e opinabile violazione
del principio stesso. Una cosa è la voluntas legis nell’ordinamento nazionale, quale si desume da una
corretta esegesi, altra cosa è la valutazione degli obblighi comunitari. Superfluo aggiungere che manca
qualsiasi presupposto per il ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 del Trattato di Roma (già art.
177), non trattandosi di interpretazione di norme comunitarie.
[...Omissis...]
146
Scheda di giurisprudenza n. 15 Scheda di giurisprudenza n. 15
Tentativo ed elemento soggettivo
TRACCIA
Tre giovani amici, Tizio, Caio e Sempronio, in una noiosa sera d’estate, decidono di dare una svolta alla
propria serata, fino ad allora trascorsa consumando alcolici in un bar della zona.
In stato di alterazione alcolica i tre si recavano, quindi, sul terrapieno che costeggia una grande arteria
autostradale, non senza essersi prima procurati sassi di grandi dimensioni, raccolti lungo il percorso;
posizionatosi al margine della strada, Tizio, lanciava alcuni di questi sassi, del diametro di diversi centimetri,
sulle vetture in corsa.
Alcune delle pietre colpivano l’abitacolo di tre autovetture che, tuttavia, arrestavano la marcia senza che gli
occupanti subissero conseguenze ulteriori. Proprio in quel momento transitava una pattuglia della polizia
stradale che, nonostante l’immediata fuga dei tre ragazzi, riusciva a fermarli e a identificarli.
In particolare, Tizio veniva iscritto sul registro delle notizie di reato per i delitti di danneggiamento e tentato
omicidio, aggravati dai futili motivi.
La relazione degli operanti intervenuti, infatti, sottolineava come in ragione della rilevante dimensione delle
pietre, del posizionamento dell’imputato e dell’insidiosità della condotta, si dovesse ritenere corretta una
qualificazione dolosa della condotta, cui il Pubblico ministero dava successivamente credito.
Tizio, quindi, preoccupato per le conseguenze della propria condotta, si rivolgeva ad un legale di fiducia.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e premessi brevi cenni sull’elemento soggettivo del delitto
tentato, rediga motivato parere.
1. La questione.
Il tema della compatibilità del dolo eventuale con la struttura del tentativo è da tempo
questione sottoposta all’attenzione della giurisprudenza: premesso che il delitto tentato è
necessariamente un delitto doloso (la colpa viene infatti a priori esclusa, essendo
ontologicamente incompatibile con il comune concetto di “tentare”), la discussione è sorta in merito
alla possibilità che l’elemento soggettivo nella fattispecie tentata sia integrato anche dal
dolo eventuale e, dunque, da quella volontà del soggetto agente che non persegue in via
diretta l’evento tipico del reato, ma lo prevede quale conseguenza eventuale, possibile o
probabile della sua condotta.
Il dubbio nasce in ragione della peculiare struttura del delitto tentato: ai sensi dell’art. 56 c.p.,
infatti, la figura è integrata dal compimento univoco di atti diretti alla commissione di un
delitto, elemento di non semplice coniugabilità con la mera eventualità della verificazione
dell’evento, che caratterizza, appunto, il dolo eventuale.
Emblematico è il caso del lancio dei sassi dal cavalcavia: in dottrina era stata avanzata l’ipotesi che
l’azione criminosa potesse essere sorretta dal dolo eventuale, posto su un gradino inferiore sia
rispetto al dolo intenzionale, quale espressione di massima intensità della volontà criminosa (il cui
fine ultimo è direttamente la verificazione dell’evento), sia rispetto al dolo diretto, espressione della
volontà del soggetto agente che, pur non prendendo di mira direttamente l’evento, se ne prefigura
tuttavia la verificazione quale conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta.
La questione, che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito, involge dunque la corretta
147
Parte generale interpretazione dell’inciso “atti diretti a” posto dall’art. 56 c.p. quale requisito indispensabile
perché sia integrato il delitto tentato.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, e prima di giungere alla soluzione ormai pacifica in giurisprudenza, che esclude la
compatibilità del dolo eventuale con il tentativo, è necessario dare atto dei due orientamenti
elaborati in merito.
2.1. Il primo orientamento: Compatibilità del tentativo con il dolo
eventuale.
A mente di un primo, ed ormai risalente nel tempo, orientamento dottrinale e
giurisprudenziale, che trovava conferma in un’autorevole sentenza della Corte di Cassazione,
resa a sezioni unite (Cass. pen., Sez. Un., 18 giugno 1983, n. 7157), il tentativo ben sarebbe
compatibile con tutte le forme di dolo e dunque anche con il dolo eventuale. La decisione
veniva adottata sulla scorta della considerazione per cui, essendo il dolo unico, avrebbe
necessariamente dovuto investire sia il reato consumato sia tutte le sue fasi intermedie, volte pur
sempre alla sua attuazione.
In particolare, il requisito dell’univocità degli atti (“atti diretti a” ex art. 56 c.p.) era
interpretato in modo oggettivo.
1° Argomento: interpretazione omnicomprensiva del dolo del tentativo. La
giurisprudenza aveva posto l’accento sulla natura del dolo del tentativo, che sarebbe pur
sempre ravvisabile nella volontà del compimento del delitto perfetto; in quest’ottica, allora,
tale dolo non può non comprendere anche il dolo eventuale. Del resto, si faceva notare,
nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna norma che distingua fra i due tipi di dolo.
2° Argomento: interpretazione oggettiva della formula “atti diretti a”. L’univocità
degli atti richiesta dall’art. 56 c.p., lungi dall’avere una connotazione soggettivistica, connota
anzi in senso oggettivo la condotta: secondo tale orientamento, già in quest’ultima sono
ravvisabili gli elementi distintivi del delitto perfetto, proprio perché la volontà è tesa all’attuazione
della condotta criminosa e dunque alla verificazione dell’evento di reato, che non si perfeziona
esclusivamente a causa di interventi esterni alla volontà medesima (ad es., per l’intervento della
polizia) o al mutamento di quest’ultima, in un momento, però, successivo all’attuazione di
comportamenti che di per sé costituiscono già tentativo punibile (si fa riferimento alle ipotesi di
desistenza o recesso volontario, ex art. 56, co. 3 e 4, c.p.).
In sostanza, gli atti in concreto posti in essere dal reo rivelerebbero la direzione finalistica
della condotta e, dunque, la volontà criminosa. Il dolo eventuale sarebbe così pienamente
configurabile, sempre che, a monte, risulti configurabile in egual modo nella forma
consumata del reato.
148
Scheda di giurisprudenza n. 15 2.2. Il secondo orientamento: Incompatibilità del tentativo con il dolo
eventuale.
Una seconda tesi, seguita dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. pen., sez. I, 6 dicembre
2012, n. 47257; Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2012, n. 14034; Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2011,
n. 32100; Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 2010, n. 37516; Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2010, n. 25114;
Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 2007, n. 44995; Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2006, n. 5849; Cass.
pen., sez. I, 30 novembre 1994, n. 4710; Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1991, n. 336; Cass. pen.,
sez. I, 18 gennaio 1990, n. 671), è dell’avviso di dover invece escludere la compatibilità del
tentativo con il dolo eventuale: si sottolinea, in quest’ottica, che l’univocità degli atti non può
che essere interpretata quale necessaria connotazione dell’elemento soggettivo del delitto
tentato. Del resto il tentativo, proprio in quanto teso ab origine al compimento del delitto perfetto,
deve essere del pari naturalmente sorretto da una volontà in tal senso inequivocabile.
1° Argomento: ratio dell’art. 56 c.p. Scopo del tentativo è quello di punire una condotta
criminosa volta al compimento di un delitto perfetto, interrottasi per fattori esterni o sopravvenuti
(anticipazione della soglia di punibilità); in ragione di ciò, il tentativo non potrebbe essere
sorretto dal dolo eventuale, poiché ontologicamente implica una volontà diretta all’attuazione
dell’evento di reato e non alla mera eventualità, possibilità o probabilità che lo stesso si verifichi.
In secondo luogo, scopo della fattispecie tentata è quello di prevenire l’esposizione a
pericolo dei beni giuridicamente protetti: anche l’art 56 c.p., del resto, deve essere interpretato alla
luce del principio di offensività (nullum crimen sine inuria): il reato, perché sia punibile, deve
tendere all’offesa di un bene giuridico). Qualora, in ipotesi, fosse punito un delitto tentato a titolo di
dolo eventuale, risulterebbe difficile individuare il reale bene giuridico oggetto della condotta
criminosa, potendosi parlare al più di pericolo di esposizione al pericolo, ipotesi, com’è noto,
naturalmente non punibile. Allargando le maglie dell’elemento soggettivo nel tentativo, e dunque
ammettendone la compatibilità con il dolo eventuale, verrebbe correlativamente ampliata la soglia
di punibilità, giungendo a comprendervi non solo eventi effettivamente presi di mira dall’agente, ma
anche eventi per i quali era stato solo accettato il rischio di verificazione o eventi che avrebbero
potuto verificarsi, ma di cui l’agente non aveva neppure prefigurato la possibilità. Conseguenza,
questa, non compatibile con l’ordinamento, che, anche e soprattutto in tema di delitto tentato, esige
concreto rispetto dei principi di offensività e soggettività.
In tal senso, “se il dolo cosiddetto eventuale o per accettazione del rischio può costituire il
fondamento di una responsabilità dolosa per eventi determinati non intenzionalmente e imputabili
all’agente a titolo di dolo generico, nel caso in cui l’evento rispetto al quale è stato corso il rischio
non si è verificato, discende dalla specifica previsione dell’art. 56 c.p. che gli atti posti in essere
devono avere concretezza tale da risultare inequivocamente diretti all’evento
specificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento”(Cass.
pen., sez. I, 22 ottobre 2010, n. 37516).
Ed ancora, “il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché,
quando l’evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento
a un atteggiamento volitivo diverso dall’intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere
luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo volere dell’autore, ossia della volontà
univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate
149
Parte generale accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi” (Cass.
pen., sez. I, 6 dicembre 2012, n. 47257).
2° Argomento: interpretazione soggettiva dell’univocità degli atti. La formula “atti
diretti a” è chiara nel pretendere che debba essere impressa una direzione univoca alle azioni
poste in essere dal soggetto agente: da ciò è facile desumere che, per quanto l’art. 56 c.p. si
riferisca prima facie esclusivamente alla connotazione del comportamento criminoso,
cionondimeno è innegabile che tale comportamento sia il riflesso di una volontà tesa
all’attuazione del delitto nella sua forma perfetta. Ciò implica necessariamente che l’univocità
degli atti debba essere riferita sia al fatto sia, a maggior ragione, all’elemento psicologico: la
presenza di entrambi gli elementi è quel che giustifica l’anticipazione della soglia di punibilità cui dà
luogo il tentativo
Tale conclusione troverebbe conforto per altro nell’ormai affermata caratterizzazione del
delitto tentato quale figura del tutto autonoma, e dunque differente, rispetto al corrispondente delitto
consumato: di conseguenza, anche l’elemento soggettivo si atteggerebbe in maniera diversa, non
ricomprendendo il dolo eventuale.
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Incompatibilità del
tentativo con il dolo eventuale ed il ricorso al dolo diretto alternativo.
La giurisprudenza maggioritaria, in accoglimento del secondo orientamento, è ormai da tempo
assestata nel senso di ritenere incompatibile il dolo eventuale con la struttura del delitto
tentato.
Esclusa la compatibilità fra tentativo e dolo eventuale, la Corte di Cassazione ha però risolto la
problematica n esame, facendo riferimento al dolo diretto alternativo, quale elemento soggettivo
in grado di integrare la fattispecie tentata anche nei casi di confine, nei quali la dottrina soleva
scorgere, appunto, la configurabilità del dolo eventuale; ciò è avvenuto nel già citato caso del
lancio dei sassi dal cavalcavia.
In tale ipotesi, la Corte, nell’escludere appunto la sussistenza del dolo eventuale, ha precisato che
quest’ultimo sussiste qualora “l’agente, ponendo in essere la condotta diretta ad altri scopi, si
rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta
e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla, mentre il dolo alternativo sussiste
qualora l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente, al momento della realizzazione
dell’elemento oggettivo del reato, che si verifichi l’uno o l’altro degli elementi casualmente
ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché, attesa la sostanziale equivalenza
dell’uno o dell’altro, egli risponde per quello effettivamente realizzato”. Gli ermellini concludono
asserendo che “si sarebbe trattato non già di dolo eventuale bensì di dolo alternativo, non potendo
il lancio dei sassi essere diretto ad un fine diverso da quello di colpire una macchina in transito, né
l’imputato è stato in grado di indicare u diverso fine, con la conseguenza che deve ritenersi anche
in tal caso configurabile il reato di tentato omicidio poiché la particolare manifestazione di volontà
dolosa definita dolo alternativo deve qualificarsi come diretta, attesa la sostanziale equivalenza
dell’uno o dell’altro evento” (Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 5436).
Posta l’incompatibilità del dolo eventuale con il tentativo, quest’ultimo dunque ben può essere
sorretto dal dolo diretto alternativo, che si verifica qualora il soggetto agente si rappresenti e
150
Scheda di giurisprudenza n. 15 voglia indifferentemente uno dei due eventi (ad es., la morte o le lesioni) causalmente collegati alla
condotta e alla volontà dello stesso (Cass. Pen., 2 maggio 2007, n. 16666).
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che Tizio possa incorrere nella responsabilità per i delitti di danneggiamento e
tentato omicidio.
In particolare, quanto a quest’ultima fattispecie, sulla scorta di quanto richiesto dall’art. 56 c.p., la condotta di
Tizio ben può essere considerata diretta e idonea a commettere il delitto di omicidio, in considerazione della
rilevante dimensione delle pietre, del posizionamento dell’imputato lungo il margine della strada a poca
distanza dalle vetture i transito, della direzione del lancio dei sassi verso i veicoli in corsa.
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, inoltre, tale comportamento, anche se non sorretto da dolo
intenzionale, risulta compatibile con il dolo diretto nella forma di dolo alternativo, in quanto Tizio si è mostrato
indifferente dinanzi alla verificazione dei possibili eventi collegati alla sua condotta (danneggiamento delle
auto, lesioni personali o addirittura morte dei passanti). Pertanto, si tratterebbe di quella particolare
manifestazione della volontà dolosa, per l’appunto “alternativa”, che la giurisprudenza maggioritaria ritiene
compatibile con la fattispecie di omicidio tentato.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2005, n. 543
Estratto
[...Omissis...]
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che costituisce tentativo di omicidio il lancio di sassi da un
cavalcavia sulla sottostante autostrada in quanto tale azione, seppure non diretta, in ipotesi, a colpire singoli
autoveicoli, è idonea - per la non facile avvistabilità degli oggetti che cadano all’improvviso dall’alto o che
comunque siano già giunti al suolo sulla carreggiata mentre i conducenti sono intenti ad osservare le
macchine che precedono e seguono e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in
autostrada - a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il
profilo soggettivo, deve intendersi diretta la volontà dell’agente (cfr. Cass. 30.4.2003 n. 19897).
A tali corretti principi si è attenuto il giudice di merito il quale ha ritenuto che il lancio di sassi da un
cavalcavia, oltretutto protetto da uno sbarramento laterale alto un metro ed ottanta centimetri proprio per
impedire quel lancio che aveva provocato poco tempo prima un evento mortale su quella stessa autostrada,
evento che aveva suscitato grande allarme pubblico anche per la tragica emulazione che ne era seguita,
costituisse una specifica condotta per ritenere che l’imputato volesse provocare la morte degli automobilisti
che transitavano sulla sottostante autostrada, alla stregua degli elementi sintomatici solitamente indicati dalla
giurisprudenza per la individuazione del dolo diretto omicidiario, ed in particolare della raccolta di un rilevante
numero di grossi sassi, rinvenuti all’interno della sua macchina, dell’impiego di un sasso del peso di ben tre
chilogrammi, che, lanciato dall’alto sulle auto in corsa, avrebbe certamente sfondato il parabrezza o quanto
meno provocato la fuoriuscita di una vettura dalla sede stradale, dello specifico e ripetuto sforzo fatto
dall’imputato, vista la sua bassa statura, per raggiungere tale risultato, della precedente morte di altra
persona per una azione analoga con quelle stesse modalità, ben nota all’imputato, nonché della accertata
151
Parte generale mancanza di visuale sulla autostrada dal cavalcavia, che non consentiva di verificare visivamente se in quel
momento giungessero o meno delle macchine, anche se a quell’ora l’autostrada era notoriamente trafficata
in modo notevole per cui le autovetture arrivavano in continuazione ed era praticamente impossibile che una
autovettura non finisse colpita dal sasso ovvero vi finisse sopra subito dopo la sua caduta. Né rileva a tal fine
che l’imputato non conoscesse la vittima né le altre persone che in quel momento circolavano sull’autostrada
Milano - Genova, poiché all’imputato non interessava uccidere una specifica persona, essendo per lui
indifferente, vista anche la sua struttura di personalità, ben delineata nella perizia psichiatrica, che morisse
una o altra persona. Si tratta eventualmente di inadeguatezza della causale alla stregua del sentire dell’uomo
comune che però non incide sulla sussistenza o meno della volontà omicida, essendo varie per intensità le
ragioni di ciascun individuo e potendosi uccidere anche per un futile motivo, essendo l’omicidio di per sé un
gesto sempre irrazionale che non può quindi essere giudicato alla stregua di criteri razionali.
Ugualmente non rileva che l’imputato potesse o meno vedere le auto in transito, poiché sapeva benissimo
che sotto il cavalcavia, sulla autostrada Milano - Genova, con direzione verso Milano, transitava a quell’ora
una fila continua di autovetture e proprio per questo aveva scelto quel luogo e quell’ora per il lancio dei sassi,
correndo il rischio di essere visto e riconosciuto (come poi è stato in effetti visto e riconosciuto dalla sua ex
insegnante) ed anzi proprio la circostanza, accertata positivamente, che non potesse vedere dal cavalcavia
le macchine in corsa sulla sottostante autostrada, dimostra la sua totale indifferenza verso la vita delle
persone che transitavano in quel momento dirette verso Milano.
Si è perciò in presenza di dolo diretto, ma la soluzione non sarebbe diversa neppure alla stregua della
ipotesi, formulata dalla difesa dell’imputato, della eventuale indifferenza di quest’ultimo nei confronti
dell’evento che poteva seguire al lancio dei sassi, atteggiamento che la difesa dell’imputato ha ritenuto di
collegare al dolo eventuale ma che invece è stato correttamente qualificato dai giudici di merito come dolo
alternativo.
Si ha invero dolo eventuale allorquando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si
rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e,
ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla, mentre il dolo alternativo sussiste qualora l’agente
si rappresenta e vuole indifferentemente, al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo del reato,
che si verifichi l’uno o l’altro degli elementi casualmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria
(nella specie che muoia una persona o più persone ovvero che una o più vetture finiscano fuori strada),
sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell’uno o dell’altro, egli risponde per quello effettivamente
realizzato (cfr. per tutte cass. 10.4.2003 n. 16976).
Orbene, è di tutta evidenza che, come giustamente ritenuto dai giudici di merito, nel caso in esame si
sarebbe perciò trattato non già di dolo eventuale bensì di dolo alternativo, non potendo il lancio di sassi
essere diretto ad un fine diverso da quello di colpire una macchina in transito, né l’imputato è stato in grado
di indicare un diverso fine, con la conseguenza che deve ritenersi, anche in tal caso, configurabile il reato di
tentato omicidio poiché la particolare manifestazione di volontà dolosa definita “dolo alternativo” deve
qualificarsi come diretta, attesa la sostanziale equivalenza dell’uno o dell’altro evento (v. Cass. 14.1.2000 n.
385).
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 37516
Estratto
[...Omissis...]
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame (mancanza di motivazione in merito all’elemento soggettivo del
reato) è privo di pregio e va rigettato. Esaustiva è stata infatti la motivazione del giudice in relazione alla
152
Scheda di giurisprudenza n. 15 valutazione della qualità del dolo, individuato in quello del dolo alternativo. È pacifico, secondo arresti
consolidati di questa Corte di legittimità, che ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo di
omicidio quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il
soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi
causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (cfr. S.U. n. 748 del 12 ottobre 1993,
Cassata, che richiama S.U. n. 3428 del 6 dicembre 1991, e alla quale si rifanno S.U. n. 3571 del 14 febbraio
1996, Suraci e S.U. n. 3286 del 27 novembre 2008, Chiodi).
Occorre tuttavia chiarire che, come notava già Cass., Sez. 1, 23 ottobre 1989, n. 671, Ditto, rv. 183095, alla
base di tali precedenti giurisprudenziali vi è la piana osservazione che, avendo l’ordinamento ricollegato una
responsabilità penale al compimento di atti finalizzati (“diretti in modo non equivoco”) alla commissione di un
delitto, la specifica ed autonoma figura di reato prevista dall’art. 56 c.p. non può ricomprendere atti rispetto ai
quali un evento delittuoso si prospetta solo come un accadimento possibile o probabile non preso
direttamente in considerazione dall’agente.
Sicchè se il dolo cosiddetto “eventuale” o per “accettazione del rischio” può costituire il fondamento di una
responsabilità dolosa per eventi determinati non intenzionalmente e imputabili all’agente a titolo di dolo
generico, nel caso in cui l’evento rispetto al quale è stato corso il rischio non si è verificato, discende dalla
specifica previsione dell’art. 56 c.p. che gli atti posti in essere devono avere concretezza tale da risultare
inequivocamente diretti all’evento specificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di
riferimento.
L’affermazione giurisprudenziale che tale forma dolosa è compatibile anche con una volontà “alternativa”,
nulla toglie dunque alla necessità che risulti una inequivoca direzione della condotta: non superabile
mediante la sola astratta assunzione a regola della dicotomia “accettazione del risultato” (dolo alternativo) “accettazione del rischio del risultato” (dolo eventuale), assolutamente ambigua se priva di adeguato
supporto fattuale.
Il problema del tentativo è dunque per lo più un problema di prova e di (inequivocità del) fatto. E tanto più lo è
quando, in presenza di una condotta che già costituisce un reato consumato (resistenza, lesioni), alla cui
realizzazione s’è arrestata l’azione, s’intenda dimostrare che l’agente voleva in realtà anche altro (la morte).
Tanto premesso, i giudici del merito, hanno logicamente ritenuto che gli accadimenti e la loro sequenza non
consentivano di affermare che la prefata avesse voluto altro se non uccidere la vittima. Il tipo di arma
utilizzata, la forza impiegata, la sede corporea attinta facevano ben comprendere che l’evento morte non era
stato rappresentato solo come possibile, ma accettato nella sua concreta accadibilità.
[...Omissis...]
153
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 16
L’applicazione del principio di specialità
TRACCIA
Tizio decideva di sottoporsi ad una serie di accertamenti clinici e di esami di laboratorio prescritti dal proprio
medico di famiglia.
Per eseguire gli stessi, si recava presso l’Ospedale della propria città. Ivi giunto, con dichiarazione falsa resa
all’impiegato addetto all’ufficio ticket, dichiarava di percepire redditi non superiori a quelli previsti dalla legge
per l’attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni mediche in regime di esenzione contributiva. Tizio
dichiarava di essere stato licenziato e di essere attualmente disoccupato, autocertificando che il suo nucleo
familiare non superava il reddito previsto per l’esenzione.
Alcuni mesi dopo aver effettuato tali esami, ed aver beneficiato dell’esenzione, Tizio leggeva un articolo di
stampa ove si dava notizia della scoperta da parte della Guardia di Finanza delle false attestazioni rese da
alcuni cittadini per fruire dell’esenzione del ticket e dell’avvio di un procedimento penale contro costoro.
Preoccupato delle conseguenze della propria condotta, si recava da un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili
nel caso di specie.
1. La questione.
Il concorso apparente di norme ricorre quando un’unica condotta è apparentemente
sussumibile sotto più norme penali: in realtà la norma applicabile è solo una. In particolare,
tre sono i presupposti in base ai quali è possibile ravvisare un concorso di tal fatta:
• la pluralità di norme incriminatrici, tra loro non antinomiche;
• l’identità del fatto incriminato;
• la circostanza per cui solo una fattispecie di reato è in concreto applicabile,
avendosi così unicità e non pluralità di reati (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2011, n.
1235).
Si pone così il problema di accertare se, in concreto, ricorra un’ipotesi di concorso apparente
di norme (art. 15 c.p.) o di concorso formale di reati (art. 81, co. 1, c.p.), posti in un rapporto di
alternatività.
Le conseguenze non sono per altro di poco conto: mentre la ricorrenza del concorso formale di
reati rende contemporaneamente applicabili tutte le norme in astratto considerate, in applicazione
del cumulo giuridico, nel caso di concorso apparente di norme, la norma applicabile è, appunto,
solo una, da individuarsi attraverso il principio di specialità ex art. 15 c.p.
Tale norma prevede infatti che “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge
penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o
alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito” (lex specialis derogat
generali); la ratio del principio è da rinvenire nel principio del ne bis in idem sostanziale, che
vieta di addossare la responsabilità di uno stesso fatto al suo autore per più volte.
La specialità, in altre parole, postula che due disposizioni incriminatrici siano in rapporto di
genere a specie l’una rispetto all’altra, ossia che l’una, speciale, rechi in sé tutti gli elementi
154
Scheda di giurisprudenza n. 16 costitutivi dell’altra, generale, con l’aggiunta di uno o più elementi c.d. specializzanti.
Tradizionalmente, il rapporto di specialità tra due disposizioni viene spiegato ricorrendo
all’immagine di due cerchi concentrici di diametro diverso, per cui quello più ampio contiene in sé
quello meno ampio e ha inoltre, un settore residuo, non comune, nel quale vengano raccolti gli
elementi specializzanti aggiuntivi (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 1993, Costarelli).
Il nucleo portante del principio de quo è il concetto di stessa materia, cui l’art. 15 c.p. fa espresso
riferimento. In merito alla sua perimetrazione, la tesi, ormai risalente, che riteneva di identificare
l’identità di materia con l’identità della natura delle norme (necessità che siano tutte norme penali)
e con l’identità di oggettività giuridica (identità del bene giuridico tutelato)[da ultimo sostenuto da
Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 2011, n. 33833], è stata sostituta da quella che ritiene che il concetto
di stessa materia vada letto come fattispecie astratta - ossia come aspetto dell’attività umana
che la legge interviene a disciplinare - e non quale episodio in concreto verificatosi.
La verifica della sussistenza di un rapporto di specialità tra fattispecie deve essere
effettuata in base ad un confronto meramente strutturale che evidenzi “una relazione logicostrutturale tra norme”, riconosciuta la quale, il riferimento anche all’interesse tutelato non ha
immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità
di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del
patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in rapporto di specialità, come l’ingiuria,
offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivi del prestigio
dell’amministrazione della giustizia (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio 2011, n. 1235).
Con riferimento al contenuto del principio di specialità, si distingue tra:
• specialità in concreto, che sussiste quando il fatto, per come verificatosi, sia
riconducibile ad entrambe le norme in astratto considerate, sebbene tra le stesse non
sussista rapporto di genere a specie in astratto;
• specialità in astratto, che sussiste quando il fatto sia riconducibile a due norme che si
pongono in un rapporto strutturale di genere a specie tra le fattispecie;
• specialità unilaterale, che sussiste quando tra due norme che si pongono in rapporto
strutturale di specialità, secondo l’immagine dei cerchi concentrici, soltanto una delle due
presenti rispetto all’altra (generale) elementi specializzanti;
• specialità bilaterale o reciproca, che ricorre quando, ferma restando la presenza di un
nucleo d’illecito comune ad entrambe, ciascuna di esse possieda poi uno o più elementi
specializzanti rispetto all’altra.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di sufficienza del solo
criterio di specialità.
Per lungo tempo la giurisprudenza si è chiesta se la sola applicazione del criterio di
specialità, di cui all’art. 15 c.p., fosse bastevole in ogni caso a poter ravvisare o meno un
concorso apparente di norme; le tesi rappresentate, in particolare, erano due: la teoria
pluralistica e quella monistica.
155
Parte generale 2.1. Il primo orientamento: Tesi pluralistica.
Per lungo tempo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza (App. Roma, Sez. II, 26 gennaio 2010,
n. 759; Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2007, n. 16568; Cass. pen., Sez. II, 4 aprile 2007, n. 1090;
Cass. pen., Sez. I, 24 gennaio 2006, n. 7629; Cass. pen., Sez. VI, 12 settembre 2006, n. 30150)
ha affermato l’insufficienza del solo criterio di specialità, affiancando ad esso altri due
criteri, quello della sussidiarietà e quello dell’assorbimento.
1° Argomento: inidoneità del criterio di specialità. Configurandosi essenzialmente un
criterio astratto, inidoneo a soddisfare ragioni equitative e di giustizia sostanziale che
impongono di valutare l’accadimento concreto nel suo complessivo significato di disvalore penale,
è stato ritenuto necessario elaborare altri criteri, fondati, viceversa, su un apprezzamento di
valore del fatto concreto. Per tale ragione, il criterio di specialità si applica solo ove il
raffronto tra due norme in concorso manifesti un rapporto strutturale di genere a specie,
dovendosi negli altri casi ricorrere al criterio della sussidiarietà e a quello dell’assorbimento.
In applicazione del criterio dell’assorbimento (o della consunzione), qualora una
condotta sia sussumibile in più fattispecie incriminatici, e pur non riscontrandosi un rapporto di
specialità in astratto, sussiste un concorso apparente di norme se, in base ad un criterio di
normalità sociale, il disvalore penale concretizzato da una fattispecie criminosa resti
assorbito in altro reato: la commissione di una fattispecie di illecito comporta, secondo l’id quod
plerumque accidit, la necessaria integrazione della seconda, di conseguenza assorbita nella
prima.
Tra le due norme in concorso apparente si applicherà solo la norma penale
assorbente, coincidente con quella che prevede la pena più grave, gravità che va valutata non
in astratto, ma in relazione alla fattispecie concreta (nei predetti termini sono stati, ad es.,
ricostruiti i rapporti tra reato di incendio, ex art. 423 c.p., e reato di crollo di costruzione o altri
disastri dolosi, ex art. 434, co. 2, c.p.; delitto di truffa, ex art. 640 c.p., e millantato credito, ex art.
364 c.p.; riduzione in schiavitù, ex art. 600 c.p., e maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p.;
sequestro di persona, ex art. 605 c.p., e violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p.).
Il criterio di sussidiarietà postula, invece, che tra le fattispecie astratte esista un
rapporto di complementarità, di modo che la norma sussidiaria trovi applicazione solo
quando quella primaria non lo sia. Il rapporto de quo insiste quando due norme prevedono un
grado diverso di offesa allo stesso bene giuridico, per cui l’offesa maggiore contiene già in sé
quella minore.
Si distingue tra sussidiarietà espressa – ove sia lo stesso legislatore a subordinare, con
apposita clausola di salvaguardia, l’applicazione di una norma alla mancata applicazione dell’altra
– e sussidiarietà tacita – ove il rapporto di vicarietà di una norma rispetto all’altra sia desumibile in
via interpretativa dal raffronto tra le norme in concorso (sono stati ricostruiti, applicando tale
principio, i rapporti tra l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter c.p., e
la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.).
2.2. Il secondo orientamento: Tesi monistica.
La tesi pluralistica è stata di recente superata dalla Cassazione (Cass. pen., Sez. Un., 19 gennaio
156
Scheda di giurisprudenza n. 16 2011, n. 1235) che ha ritenuto il principio di specialità l’unico criterio da poter applicare al fine
di dirimere il dubbio circa la sussistenza o meno del concorso apparente di norme, fatta eccezione
per la sussidiarietà, qualora però sia la stessa norma a prevedere, in deroga all’art. 15 c.p.,
l’applicazione della norma generale.
1° Argomento: assenza di fondamento normativo. L’inciso finale dell’art. 15 c.p.
allude alle clausole di riserva previste dalle norme, che, in deroga al principio di specialità,
prevedono talora l’applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata
sussidiaria.
2° Argomento: contrasto con il principio di determinatezza e tassatività. Il criterio
de quo fa dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una
norma.
3° Argomento: contrasto con il principio di legalità. Tale contrasto, invero, risulterebbe
anche dall’art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona, dai valori della accessibilità della norma
violata nonché dalla prevedibilità della sanzione, che si riferiscono non alla semplice astratta
previsione della legge, ma alla norma vivente quale risulta dall’applicazione e dalla
interpretazione dei giudici.
4° Argomento: mancanza di canoni precisi per comprendere quale sia la norma
applicabile. Prescindendo dall’analisi della struttura delle norme, sarebbe compito quanto mai
gravoso per l’interprete optare per l’applicabilità di una norma anziché di un’altra.
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria in merito ad un caso
peculiare: Rapporti fra il reato di falso ideologico del privato in atto
pubblico, ex art. 483 c.p., e l’indebita percezione di erogazioni assistenziali,
ex art. 316 ter c.p.
Invero, il problema investiva, a monte, il rapporto a monte fra l’art. 640 bis c.p., truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e l’art. 316 ter c.p., indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato, e, a valle, il rapporto fra quest’ultimo e l’art. 483 c.p., falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Atteso che, per quel che concerne la prima problematica, i rapporti tra l’art. 316 ter c.p. e l’art.
640 bis c.p. sono stati ricostruititi in termini di sussidiarietà (sebbene le due fattispecie
presentino tratti di coincidenza con riguardo agli aiuti economici e all’evento del conseguimento
indebito degli stessi, descrivono condotte diverse non automaticamente sovrapponibili,
richiedendo la truffa aggravata la sussistenza degli artifici o dei raggiri tali da indurre la
vittima in errore e da provocare così l’atto dispositivo della sua sfera patrimoniale e
l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato solo la sussistenza del mendacio,
consistente in false o reticenti dichiarazioni o in documenti falsi o attestanti cose non vere; Cass.
pen., Sez. Un., 24 aprile 2007, n. 16568), i rapporti fra l’art. 316 ter c.p. e l’art. 483 c.p.
venivano ricostruiti in termini ora di concorso di reati ora di assorbimento del secondo
nell’ambito del primo.
157
Parte generale 3.1. Il primo orientamento: Concorso di reati.
Un minoritario, e risalente, indirizzo riteneva che tra le norme de quibus dovesse essere
ritenuto sussistente un concorso di reati.
1° Argomento: mancata identità del bene giuridico protetto. Mentre l’art. 316 ter c.p.,
introdotto dall’art. 4, l. 29 settembre 2000, n. 300, al fine di completare la tutela apprestata contro le
frodi allo Stato e alla Comunità Europea, tutela gli interessi finanziari dell’amministrazione, sia
nazionale che sovranazionale e dunque il buon andamento della medesima sotto il profilo della
corretta e giusta allocazione delle risorse finanziarie, l’oggettività giuridica dell’art. 483 c.p. deve
essere rinvenuta nella tutela della fede pubblica, intesa quale interesse a garantire la veridicità dei
fatti dichiarati in un atto pubblico dal privato che abbia il dovere di esporre la verità.
3.2. Il secondo orientamento: Assorbimento dell’art. 483 c.p. nel
delitto di cui all’art. 361 ter c.p.
Un secondo indirizzo, del tutto prevalente (ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, 26 giungo 2009, n.
31909; Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2008, n. 41383; Cass. pen., 31 maggio 2007, n. 28665),
riteneva al contrario che il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
ben potesse essere assorbito da quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato.
1° Argomento: indifferenza della mancata identità del bene giuridico protetto. Quello
su cui deve essere posta l’attenzione, infatti, non è l’identità o meno dell’oggettività giuridica
(criterio, per altro, da tempo abbandonato dalla giurisprudenza) ma la struttura della norme in
esame, poiché solo in ragione di questo concreto dato sarebbe possibile comprendere se si sia in
presenza di un concorso apparente di norme ovvero di un concorso di reati. La Cassazione, nella
specie, optava come anticipato in favore della sussistenza di un concorso apparente di norme.
3.3. La giurisprudenza maggioritaria: Assorbimento dell’art. 483 c.p.
nel delitto di cui all’art. 361 ter c.p.
L’orientamento della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537;
confermata di recente da Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 2014, n. 1574; Cass. pen., Sez. II, 16
aprile 2013, n. 17300) è ormai granitico nel confermare le conclusioni della seconda tesi e
dunque nell’affermare l’assorbimento della fattispecie di cui all’art. 483 c.p. nel delitto di
indebite percezioni a danno dello Stato.
1° Argomento: confronto strutturale fra le norme. Il reato di cui all’art. 316 ter c.p.,
invero, assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p., in quanto l’uso o la presentazione di
dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua
configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483 c.p., ovvero l’uso di un
atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione.
In ragione di tale arresto, la giurisprudenza ha poi ulteriormente precisato che il delitto di
cui all’art. 483 c.p. resta assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. dal momento che
tale delitto ne contiene tuti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso
158
Scheda di giurisprudenza n. 16 e ciò pure quando occorra avere riguardo alla previsione dell’art. 316 ter, co. 2, non venendo
superati i livelli quantitativi dell’indebitamente percepito posti dalla legge come spartiacque fra il
fattoi di mera rilevanza amministrativa e quello di rilevanza penale.
La Cassazione, nel decisum reso a sezioni unite (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n.
7537), ha così ribadito che il reato di cui all’art. 316 ter c.p. assorbe il delitto di falso in tutti i
casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono
elementi essenziali per la sua configurazione; non solo, la Corte ha altresì precisato che
“l’assorbimento del falso ideologico nell’art. 316 ter c.p. si realizza anche quando la somma
indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima
dell’erogazione, integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello
stesso art. 316 ter c.p.”.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso che ci occupa, si ritiene che, qualora le indagini della Giardia di Finanza dovesse condurre alla
scoperta della condotta di Tizio (il quale, si ricorda, per eseguire una serie di accertamenti ed usufruire delle
esenzioni previste in materia, dichiarava di percepire redditi non superiori a quelli previsti dalla legge per
l’attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni mediche in regime di esenzione contributiva), questi
potrebbe verosimilmente essere imputato per il delitto di cui all’art. 316 ter c.p., nell’ambito del quale, come
ribadito più volte dalla giurisprudenza, resta assorbito il reato di falso del privato in atto pubblico (i cui
estremi, a rigore, sono stati integrati dalla condotta di Tizio), di cui all’art. 483 c.p.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537
Estratto
[...Omissis...]
1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 ottobre 2009, ha confermato la sentenza 19.12.2006
del Tribunale monocratico di Patti, che aveva affermato la responsabilità penale di P. G.E. in ordine ai reati di
cui all’art. 483 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 2, in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 76 e 46,
e all’art. 640 c.p., comma 2, in danno della A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina; per avere autocertificato, con
dichiarazione falsa resa all’impiegato addetto all’ufficio ticket dell’ospedale di Patti, di percepire redditi non
superiori a quelli previsti dalla legge per l’attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni mediche in
regime di esenzione contributiva, così procurandosi l’ingiusto profitto costituito dal risparmio sulla quota di
partecipazione alla spesa con correlato danno per l’ente pubblico - in (OMISSIS); e, riconosciute circostanze
generiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto di truffa, unificati i reati nel vincolo della
continuazione ex art. 81 c.p., comma 2, lo aveva condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi
quattro e giorni quindici di reclusione, nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale ne ha chiesto l’annullamento
articolando due doglianze.
In particolare ha prospettato:
159
Parte generale 2.1. che la falsa attestazione in addebito, non essendo contenuta in un atto pubblico, non sarebbe idonea ad
integrare il contestato reato di cui all’art. 483 c.p..
La falsità configurabile sarebbe, invece, quella di falso ideologico in scrittura privata e ciò perchè la
dichiarazione sostitutiva di certificazioni è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà
soltanto se ad essa è allegato un valido documento di identità. Opinando diversamente si resterebbe esposti
al serio pericolo che il dichiarante possa indicare false generalità, spacciandosi per altri;
2.2. che la falsità contestata non sarebbe altresì idonea ad integrare l’elemento degli “artifici e raggiri”,
proprio del reato di truffa, perchè il mero mendacio acquista tale idoneità soltanto a condizione che inerisca
ad un attestato o documento avente carattere fidefacente. Il carattere fidefacente mancherebbe in relazione
ad un’autocertificazione alla quale non è allegato alcun documento di riconoscimento e sarebbe stato
necessario, pertanto, un quid pluris per integrare l’elemento degli artifici e raggiri.
3. Il ricorso è stato assegnato alla Seconda sezione penale, la quale, all’udienza del 21 ottobre 2010 (con
ordinanza depositata il successivo 29 ottobre), ne ha rimesso la trattazione alle Sezioni Unite, rilevando
l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale riferito alla assorbente questione della qualificazione giuridica
della condotta consistente nel rendere una falsa dichiarazione circa le condizioni di reddito indicate in quelle
di legge, allo scopo di fruire dell’esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario.
La Sezione rimettente ha evidenziato, in proposito, che alcune decisioni di questa Corte (Sez. 2: n. 24817 del
25/02/2009, dep. 16/06/2009, Molonia; n. 32849 del 26/06/2007, dep. 13/08/2007, Mannarà) qualificano la
condotta sopra descritta in termini di truffa aggravata in danno di ente pubblico e non già come reato di
indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altri enti pubblici, muovendo da quanto statuito
dalle Sezioni Unite - con la sentenza n. 16568 del 19/04/2007, dep. 27/04/2007, Carchivi - circa i rapporti tra
le fattispecie criminose di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p..
Le Sezioni Unite hanno ricondotto l’ambito di operatività dell’art. 316 ter c.p., a situazioni del tutto marginali,
come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore
della disposizione patrimoniale, e dai principi affermati si evincerebbe che il reato di cui all’art. 316 ter ricorre
quando l’erogazione del contributo non presupponga l’effettivo accertamento, da parte dell’erogatore, dei
presupposti necessari per la concessione del contributo richiesto.
L’oggetto dell’attività dell’autore è costituito dal conseguimento, secondo quanto recita la norma, di
“contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.
Esula, invece, dalla previsione normativa dell’art. 316 ter c.p., il caso in cui non ricorra la percezione di una
pubblica sovvenzione ma la esenzione dalla corresponsione di una somma. Il concetto di contributo o di
finanziamento o di mutuo agevolato non è assimilabile a quello di esenzione da un pagamento, ma va
ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, ossia di aiuto economico concesso sotto forma di
elargizione o prestito agevolato, che si concretizza nell’attribuzione pecuniaria giustificata dall’attuazione di
un interesse pubblico e che si correla, nella commissione del reato di cui all’art. 316 ter, al danno
patrimoniale dell’ente, identificabile esclusivamente con il danno emergente sorto al momento dell’elargizione
del denaro.
La Seconda sezione ha quindi dato atto di un diverso ed opposto orientamento, secondo il quale la condotta
di cui si discute non integra il reato di truffa, bensì quello di indebita percezione di erogazioni in danno dello
Stato o di altri enti pubblici, restando in esso assorbito il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico,
e ciò anche nel caso in cui, dato il livello quantitativo dell’indebita percezione, il fatto integri una mera
violazione amministrativa.
Anche questo secondo orientamento fa richiamo alla già citata sentenza Carchivi delle Sezioni Unite, ma
valorizza quel passo della decisione in cui si afferma che nella nozione di “erogazioni pubbliche” rientrano
pure quelle di natura assistenziale. Trae dunque la conseguenza che nel concetto di erogazione rientra non
solo l’ottenimento di una somma di denaro a titolo di contributo ma altresì l’esenzione dal pagamento di una
somma dovuta a enti pubblici, perchè anche in tal caso il richiedente ottiene un vantaggio, che è posto a
carico della comunità.
160
Scheda di giurisprudenza n. 16 La Sezione rimettente cita, in proposito, alcune decisioni che esplicitamente interpretano il concetto di
erogazione di cui all’art. 316 ter come comprensivo “sia di somme versate dall’ente pubblico, sia di somme
non richieste o richieste in misura minore per servizi resi da detto ente” (Sez. 5, n. 39340 del 9/07/2009, dep.
9/10/2009, Nicchi; Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009, dep. 05/08/2009, Arcidiacono; Sez. 6, n. 28665 del
31/05/2007, dep. 18/07/2007, P.M. in proc. Piga).
4. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna
udienza pubblica.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite è la seguente: “quale sia la
corretta qualificazione giuridica del fatto criminoso consistente nella falsa attestazione del privato di trovarsi
nelle condizioni di reddito per fruire, a termini di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza
il versamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria”.
2. Sul punto si rinviene effettivamente un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
2.1 Alcune decisioni hanno affermato che la condotta dianzi descritta, connotata, com’è, dall’artificiosa
rappresentazione di circostanze di fatto, deve essere qualificata in termini di truffa, ex art. 640 c.p., comma 2.
Si è sostanzialmente di fronte ad una falsificazione della realtà, consistente nella dichiarazione di trovarsi
nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l’esenzione, e questo è un dato di fatto che da corpo
all’elemento degli artifici e dei raggiri richiesto dalla fattispecie criminosa come sopra individuata.
La condotta medesima non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 316 ter c.p., anche perchè
l’elemento dell’esenzione da un pagamento resta estraneo alla nozione di “contributo, finanziamento o mutuo
agevolato”, elementi questi ricompresi tutti nella generica accezione di “sovvenzione” (vedi Sez. 2, n. 32849
del 26/06/2007, dep. 13/08/2007, Mannarà; Sez, 5, n. 38478 del 09/07/2008, dep. 14/10/2008, Nicotera, Sez.
2, n. 24817 del 25/02/2009, dep. 16/06/2009, Molonia).
L’orientamento in esame risulta organicamente delineato, da ultimo, nella sentenza della Sez. 2, n. 32578 del
27/04/2010, dep. 01/09/2010, Di Costanze che - a fronte di una pronunzia di condanna ai sensi dell’art. 483
c.p., e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in un contesto fattuale di mero mendacio riferito alle condizioni di reddito
e finalizzato ad ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario - ha rigettato la tesi difensiva della
riqualificazione ai sensi dell’art. 316 ter, evidenziando che:
- la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., ha carattere residuale rispetto a quella della truffa, con la quale non è
in rapporto di specialità e può con essa concorrere, ove della stessa siano integrati i presupposti (se, ad
esempio, le falsità e le omissioni si risolvano in un’artificiosa rappresentazione della realtà capace di indurre
in errore);
- la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 95 del 2004, ha escluso la sovrapponibilità delle condotte
individuate dall’art. 316 ter c.p., con quelle integranti il reato di truffa;
- le Sezioni Unite penali - con la sentenza n. 16568 del 19/04/2007, dep. 27/04/2007, Carenivi - hanno
precisato che l’ambito di applicazione dell’art. 316 ter si riduce a situazioni del tutto marginali, come quelle
del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della
disposizione patrimoniale, aggiungendo come l’erogazione delle pubbliche sovvenzioni possa non dipendere
da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore nella misura in cui può legarsi,
almeno in vìa provvisoria, all’esistenza della formale dichiarazione del richiedente;
- il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, di cui alla enunciazione della fattispecie
incriminatrice posta dall’art. 316 ter, non è assimilabile a quello di esenzione da un pagamento, ma va
ricompreso nella generica accezione di “sovvenzione”, ossia di aiuto economico concesso sotto forma di
elargizione o prestito agevolato.
2.2 In senso contrario si esprimono altre pronunzie, secondo le quali la condotta di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata in ragione dell’assenza dell’elemento
dell’induzione in errore realizzata attraverso la messa in atto di artifici o raggiri.
161
Parte generale Nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, indicate dall’art. 316 ter c.p., rientrano anche
quelle concernenti l’esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie. Nel concetto di erogazione deve ritenersi
compreso, infatti, non solo l’ottenimento di una somma di denaro a titolo di contributo, ma pure l’esenzione
dal pagamento di una somma dovuta ad enti pubblici, perchè anche in tal caso il richiedente ottiene un
vantaggio che viene posto a carico della comunità (così Cass.: Sez. 5, n. 41383 del 17/09/2008, dep.
06/11/2008, Capalbo; Sez. 6, 21/10/2010, dep. 22/11/2010, Gelsi).
3. Appare utile ricordare che - sempre sulla premessa che nel termine “erogazioni”, che si rinviene nell’art.
316 ter c.p., rientrano non solo le somme versare dall’ente pubblico, ma anche le somme non richieste o
richieste in misura minore per servizi resi dal predetto ente - sono state inquadrate nell’ambito applicativo
dell’art. 316 ter c.p., le condotte del privato che dichiari un reddito familiare inferiore a quello effettivamente
percepito al fine di ottenere:
- un canone agevolato per la locazione di alloggio appartenente all’Amministrazione provinciale (Sez. 5, n.
39340 del 09/07/2009, dep. 09/10/2009, Nicchi);
- un abbonamento mensile, con tariffa agevolata, al servizio municipale di trasporto pubblico (Sez. 5, n.
31909 del 26/06/2009, dep. 05/08/2009, Arcidiacono).
4. Le Sezioni Unite - con la sentenza n. 16568 del 19/04/2007, dep. 27/04/2007, Carchivi - hanno risolto un
duplice contrasto relativo sia alla riconducibilità o meno delle sovvenzioni pubbliche a carattere assistenziale
o previdenziale alle previsioni degli artt. 316 ter e 640 bis c.p., (a seconda il diverso conformarsi delle singole
fattispecie) sia alle differenze tra gli elementi costitutivi di tali delitti.
Nella citata decisione - quanto ai rapporti tra il reato di truffa aggravata e quello di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici - le Sezioni Unite hanno posto anzitutto in rilievo che
l’art. 640 bis c.p., “prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa, che si pone in rapporto di
specialità con la circostanza aggravante di cui all’art. 640 c.p., comma 2, n. 1, (così già Sez. Unite,
26/06/2002, Fedi).
Infatti, se si raffrontano le due norme, risulta immediatamente evidente come sia concentrico l’ambito di
applicazione delle circostanze aggravanti da esse previste. La circostanza prevista dall’art. 640 c.p., comma
2, n. 1, si applica a qualsiasi truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare. La circostanza prevista dall’art. 640 bis c.p., si applica solo quando
la truffa abbia comportato l’indebita erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità Europee”.
Hanno quindi osservato - in congruenza con l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 95 del 2004 - che
l’introduzione nel codice penale dell’art. 316 ter ha risposto all’intento di estendere la punibilità a condotte
“decettive” (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell’ambito operativo della fattispecie di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Con questa premessa hanno condotto il problema a una secca alternativa: o la riduzione dell’ambito di
applicazione dell’art. 316 ter in termini di radicale marginalità o la riduzione sostanziosa dell’ambito di
applicazione della fattispecie di truffa.
Rispetto alla delineata alternativa, che riassumeva il contrasto giurisprudenziale allora esistente, le Sezioni
Unite hanno optato per la soluzione di tenere fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa e di ricondurre
alla fattispecie di cui all’art. 316 ter le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore o un danno per
l’ente erogatore, con la conseguente compressione dell’art. 316 ter a situazioni del tutto marginali, “come
quello del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della
disposizione patrimoniale”.
Una falsa rappresentazione della realtà in capo all’erogatore può dipendere, oltre che dalle modalità del
procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, anche dalle modalità effettive del suo
svolgimento nel singolo caso concreto, sicchè l’accertamento dell’esistenza di una induzione in errore, quale
elemento costitutivo del reato di truffa, ovvero la sua mancanza in favore dell’applicabilità dell’art. 316 ter, è
162
Scheda di giurisprudenza n. 16 questione di fatto riservata al giudice del merito.
5. La Corte Costituzionale - con la citata ordinanza n. 95 del 2004 - ha affermato, come dato inequivoco, il
carattere sussidiario e residuale dell’art. 316 ter rispetto all’art. 640 bis c.p., chiarendo che, alla luce del dato
normativo e della ratio legis, l’art. 316 ter assicura una tutela aggiuntiva e “complementare” rispetto a quella
offerta agli stessi interessi dall’art. 640 bis, coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento - per
difetto - del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Ha quindi rinviato all’ordinario
compito interpretativo del giudice l’accertamento, in concreto, se una determinata condotta formalmente
rispondente alla fattispecie dell’art. 316 ter integri anche la figura descritta dall’art. 640 bis, dovendosi, in tal
caso, fare applicazione solo di quest’ultima.
6. A fronte del quadro interpretativo dianzi delineato, queste Sezioni Unite ritengono che debba essere
affermato il principio secondo il quale:
“L’art. 316 ter c.p., punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che
dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione
non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che
non viene indotto in errore perchè in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale
attestazione del richiedente”.
Rileva in proposito il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte, in relazione al reato di truffa, ha
gradualmente svalutato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del delitto
in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto,
piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l’effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si è
così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa,
l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla
particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso.
Le Sezioni Unite, già con la sentenza 24/01/1996, Panigoni, ebbero ad evidenziare la rilevanza della
questione “se il concetto di artifizi e raggiri sia integrato anche dalla menzogna pura e semplice e cioè dalla
menzogna che, senza particolari modalità ingannatorie aggiuntive, abbia determinato l’errore nel soggetto
passivo”:
questione - avvertivano le Sezioni Unite - senz’altro seria, “potendosi ritenere che la menzogna pura e
semplice integra soltanto la condotta che induce in errore, ma non la condotta posta in essere con artifizi e
raggiri”.
A fronte di tale avvertimento, poi, sempre le Sezioni Unite - con la sentenza n. 16568 del 2007, Carchivi hanno statuito che “vanno ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 316 ter - e non a quella di truffa - le condotte
alle quali non consegua un’induzione in errore per l’ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia
delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità
effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto”.
Questo principio va ribadito ed alla stregua di esso la truffa va ravvisata solo ove l’ente erogante sia stato in
concreto “circuito” nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi.
La sussistenza della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall’altro, deve
formare oggetto (come segnalato dalla Corte Costituzionale) di una disamina da condurre caso per caso, alla
stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto.
Significazioni in tal senso possono trarsi, del resto, dalla stessa collocazione topografica dell’art. 316 ter c.p.,
e dagli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel testo della norma, chiaramente
evidenzianti la volontà del legislatore di perseguire sostanzialmente la percezione sine titulo delle erogazioni
in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l’indebita percezione si è realizzata.
7. Il principio dianzi enunciato va poi specificato nel senso che:
“Integra il delitto di cui all’art. 316 ter c.p., anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura
assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed
ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici
163
Parte generale rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di
una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli
stessi dovuta, perchè anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio
economico che viene posto a carico della comunità”.
La nozione di “contributo” va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una
finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della
norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro.
Appare utile rilevare, in proposito, che l’art. 316 ter è stato inserito nel codice penale dalla L. 29 settembre
2000, n. 300, nel quadro delle misure di adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee redatta a Bruxelles il 26 luglio
1995, e nessun argomento contrario all’inclusione anche delle prestazioni assistenziali nelle previsioni dello
stesso art. 316 ter potrebbe trarsi dalla locuzione “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
dello stesso tipo”, che pure nella normativa comunitaria viene formulata con termini del tutto generici e privi di
uno specifico significato tecnico riferibile soltanto a sovvenzioni in danaro e non anche ad agevolazioni ed
ausili economici di qualsiasi tipo, attribuiti con scopi sociali.
Deve considerarsi, poi, che - mentre la norma peculiare posta dall’art. 316 bis c.p., è rivolta specificamente a
reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali sono stati erogati - l’art. 316 ter,
sanziona la percezione di per sè indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari
destinazioni funzionali, e ciò può ritenersi ulteriore elemento confermativo della possibilità di ricondurre
nell’ambito di quest’ultima fattispecie anche erogazioni a destinazione non vincolata quali quelle assistenziali.
8. Esaminato secondo l’impostazione dianzi delineata, il caso che ci occupa appare caratterizzato dalla
inesistenza di quella “induzione in errore”, che integra elemento costitutivo del reato di truffa.
La vicenda, invero, nei suoi elementi fattuali, non è integrata dall’esistenza di un attestato o di un certificato di
esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in relazione al reddito, rilasciato dall’azienda USL in
seguito alla compilazione di un’autocertificazione del beneficiario, ma l’assistito ha apposto la propria firma in
calce ad un timbro impresso sul retro dell’impegnativa di prescrizione (riferita ad accertamenti specialistici)
recante la dichiarazione “Sono licenziato e disoccupato. Il mio nucleo familiare non supera il reddito previsto
per l’esenzione”. In base a ciò solo la struttura sanitaria ha erogato le prestazioni in regime di esonero.
Nella Regione Siciliana soltanto con la L.R. 31 maggio 2004, n. 9 (attuata con decreto assessoriale n. 3665
del 18.6.2004 ed ulteriormente integrata nel novembre del 2007) è stata introdotta una disciplina delle
esenzioni del ticket sanitario, secondo la quale, per essere esentati dal pagamento, è necessario munirsi del
certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ottenibile presso i CAF o CAAF previa
compilazione, da parte dell’utente, di una dichiarazione sostitutiva unica D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex
artt. 38, 46 e 47, avente validità di 12 mesi dalla data di rilascio.
Tale normativa non era vigente all’epoca dei fatti per i quali si procede (agosto 2002) e - tenendosi
comunque presente che nel concetto di “induzione in errore” non può essere assorbito quello di “falsa
rappresentazione” - la esenzione del ticket venne ammessa quale conseguenza automatica della formale
dichiarazione del richiedente (questo regime è stato successivamente emendato in senso restrittivo proprio a
cagione del rilevante numero di abusi che ad esso si riconnettevano).
Per la relazione di residuante e sussidiarietà rispetto alla ipotesi di truffa (già evidenziata dianzi), dunque,
trova applicazione la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p..
9. Le Sezioni Unite, con la citata sentenza Carchivi, hanno già dato risposta alla ulteriore questione dei
rapporti della fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., con i reati di falso ed in proposito hanno concluso che il
reato di cui all’art. 316 ter assorbe quello di falso previsto dall’art. 483, in quanto l’uso o la presentazione di
dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la
falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di
consumazione.
Le Sezioni semplici si sono conformate a tale orientamento ed hanno ribadito che il concorrente reato di cui
164
Scheda di giurisprudenza n. 16 all’art. 483 c.p., resta assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter, dal momento che tale ultimo delitto ne
contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso, e ciò pure quando occorra
avere riguardo alla previsione dell’art. 316 ter, comma 2, non superandosi i livelli quantitativi
dell’indebitamente percepito posti dalla legge come spartiacque tra il fatto di mera rilevanza amministrativa e
quello di rilevanza penale (vedi Cass.: Sez. 6, n. 28665 del 31/05/2007, dep. 18/07/2007, P.M. in proc. Piga;
Sez. 5, n. 41383 del 17/09/2008, dep. 06/11/2008, Capalbo; Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009, dep.
5/08/2009, Arcidiacono; Sez. 6, 21/10/2010, dep. 22/11/2010, Gelsi).
10. Nel quadro giurisprudenziale come sopra delineato ritiene questo Collegio di dovere ribadire i principi
secondo i quali:
a) “Il reato di cui all’art. 316 ter c.p., assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p., in tutti i casi in cui
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua
configurazione”.
La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si
configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di
falso ideologico.
Nè può attribuirsi rilevo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni
reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione
sistematica della fattispecie incriminatrice.
b) “L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p., si realizza anche quando la
somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione
(Euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso art. 316 ter”.
Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte
sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie,
a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie
complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato.
11. Nella vicenda in esame, in conclusione, i fatti contestati vanno ricompresi nello schema descrittivo
dell’art. 316 ter c.p., ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione
del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro
3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa.
Vanno revocate, quindi, le statuizioni civili e, per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa, gli atti
devono essere trasmessi al Prefetto di Messina.
[...Omissis...]
165
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 17
La natura del reato continuato
TRACCIA
Tizio, anche grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza delle stazioni di servizio, veniva identificato
dalla Polizia come l’autore di numerose sottrazioni fraudolente di carburante realizzate in alcuni distributori
dell’hinterland milanese.
Si accertava, infatti, come Tizio avesse - in sei diverse occasioni -introdotto benzina nel serbatoio per poi
salire in auto e fuggire velocemente dal distributore di benzina senza pagarne il controvalore. Ciascuno di tali
episodi - realizzati nell’arco di circa due mesi, con le medesime modalità e al fine di avere, in un periodo di
crisi economica, la disponibilità del carburante per spostarsi con l’auto - concerne carburante per valori esigui
(circa 30-40 euro ciascuno), per un danno complessivo di 200 euro.
Volendo conoscere le conseguenze giuridiche delle proprie azioni, Tizio si reca da un legale di propria
fiducia.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, specificando se possa essere
ritenuta sussistente l’attenuante del danno di lieve entità.
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito involge la natura giuridica del reato continuato, in particolare
se esso debba essere considerato quale reato unico ovvero se le singole violazioni di legge
conservino a loro autonomia, tranne che per gli effetti espressamente previsti dalla legge,
quesito sorto in giurisprudenza e dottrina in ragione della sua peculiare forma di manifestazione:
l’art. 81 c.p. individua, infatti, la figura del reato continuato nell’ipotesi in cui il reo abbia
commesso più reati con azioni diverse ma nell’esecuzione del medesimo disegno
criminoso. Naturalmente l’adesione all’una o all’altra tesi non è priva di conseguenze, soprattutto
dal punto di pratico: basti considerare in tal senso ciò che ne deriverebbe in tema di applicazione di
circostanze, delle pene accessorie, delle misure di sicurezza nonché delle cause di estinzione del
reato o della pena.
È necessario premettere che il reato de quo rappresenta una particolare forma di concorso
materiale di reati avvinti del c.d. medesimo disegno criminoso, che, affiancato dalla pluralità di
reati e dalla pluralità di azioni od omissioni, costituisce l’elemento portante per la sua
configurabilità.
Di antica tradizione giuridica (MANTOVANI), il reato continuato è ispirato sostanzialmente al
principio del favor rei. Il codice prevede, infatti, come metodo di calcolo per la pena quello del
cumulo giuridico, in base al quale il soggetto agente è punito con la pena prevista per la
violazione più grave aumentata fino al triplo (così come avviene, per altro, nel caso di concorso
formale di reati).
Del resto, come ha avuto modo di ribadire a più riprese la Corte Costituzionale, il cumulo giuridico
costituisce un modello legale di pena previsto proprio per rendere effettivo il principio del favor rei.
La ratio di questo più mite trattamento sanzionatorio risiede nella minore riprovevolezza
complessiva dell’agente, che cede ai motivi a delinquere una sola volta, quando concepisce il
166
Scheda di giurisprudenza n. 17 disegno criminoso.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
In merito alla questione della natura del reato continuato, erano sorti in giurisprudenza due
orientamenti opposti, l’uno teso ad affermare l’unitarietà del reato in parola e l’altro volto
invece a qualificarlo in termini di pluralità di reati.
2.1. Il primo orientamento: Tesi dell’unicità del reato.
Secondo una prima tesi (ex plurimis, Cass. pen., VI, 8 luglio 2005, n. 33951), il reato continuato
costituirebbe una figura unica di reato in quanto sanzionata con un’unica pena.
1° Argomento: tenore testuale. In effetti, l’art. 81 c.p., non precisando nulla in merito alla
natura del reato continuato, ma prevedendo solo l’applicazione della pena prevista per la violazione
più grave, quale unica pena, lascerebbe supporre l’intentio legis di considerare le diverse violazioni
commesse dal soggetto agente quale unico reato.
2.2. Il secondo orientamento: Tesi della pluralità dei reati.
A mente di un secondo orientamento, di gran lunga maggioritario e ribadito di recente (Cass.
pen, Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 14; Cass. pen., Sez. II, 7 aprile 2004, n. 18033; Cass. pen., Sez.
I, 12 aprile 2006, n. 14563; Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 1405), invece, i reati avvinti
dal vincolo della continuazione devono considerarsi come un unico reato o come una
pluralità di reati autonomi e diversi a seconda del carattere più o meno favorevole degli
effetti che ne discendono nei confronti del soggetto agente.
1° Argomento: valorizzazione della ratio dell’istituto. Solo considerando il reato
continuato quale figura unitaria per certi aspetti e come semplice concorso materiale di reati per
altri sarebbe rispettata la ratio di favor cui è ispirato l’istituto de quo.
Per tale ragione, sarebbero così, ad esempio, i reati rileverebbero autonomamente in
relazione al computo del termine di prescrizione, di cui agli artt. 157 e ss. c.p. (dopo la novella
operata dalla legge n. 251/2005, per altro, ogni reato in continuazione ha un proprio termine iniziale
di decorrenza della prescrizione), all’amnistia, sia propria che impropria, e all’indulto nonché
all’applicazione delle misure di sicurezza.
Per contro, l’illecito rileverebbe quale reato unico non solo ai fini della pena principale, ma
anche in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale delle pena
(conclusione, questa, oggi confermata dall’art. 671, co. 3, c.p.p., a mente del quale il giudice
dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menziona della
condanna nel certificato del casellario giudiziario, qualora ciò consegua al riconoscimento del
concorso formale o del vincolo della continuazione, sempre che la pena irrogata rientri nei limiti di
cui all’art. 163 c.p. e ricorrano gli altri presupposti previsti dalla legge) e alla dichiarazione di
abitualità o professionalità del reato.
167
Parte generale 3. La soluzione delle Sezioni Unite: Tesi della pluralità dei reati autonomi
e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne
discendono.
Gli ermellini (Cass. pen., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 3286; posizione ribadita di recente da
Cass. pen., Sez. Un., 13 giugno 2013, n. 25939), nel comporre il contrato sorto in merito
all’applicabilità degli artt. 61, n. 7 (danno patrimoniale di rilevante gravità), e 62, n. 4 (danno
patrimoniale di speciale tenuità) e 6 (riparazione del danno ante giudizio), c.p. al danno
complessivamente inteso, come prodotto dalla fattispecie continuata, oppure al danno
provocato dai singoli illeciti, hanno preso posizione altresì circa la natura del reato
continuato, sposando la tesi maggioritaria e pronunciandosi dunque in favore della qualificazione
del reato de quo in termini di unità i pluralità in funzione degli effetti favorevoli che derivano
in concreto dall’una e dall’altra qualificazione.
1° Argomento: valorizzazione del principio del favor rei. Facendo proprie le
argomentazioni della tesi condivisa, la Suprema Corte ritiene che sono una simile conclusione
possa dirsi rispettosa del principio di favor cui la previsione dell’istituto è ispirata. Pertanto
ha precisato, i reati legati dal medesimo disegno criminoso in tanto possono essere considerati
avvinti dal vincolo della continuazione in quanto o questo sia previsto per legge o, appunto, soddisfi
il principio del favor rei, in mancanza la regola sarà quella di considerare i reati nella loro
autonomia.
2° Argomento: valorizzazione della giurisprudenza pregressa. Tale conclusione
incontra del resto il favore di autorevoli pronunce, adottate sia dalla Corte di Cassazione (ex
multis, Cass. pen., Sez. Un., n. 1508/1998) che dalla Consulta (C. Cost., n. 115/1987; C. Cost., n.
361/1994).
3° Argomento: modifiche della disciplina del reato continuato. Ancora, una simile
conclusione trova conferma anche nell’attuale assetto codicistico. Già la riforma del 1974,
ammettendo anche violazioni di legge fra loro diverse, ha introdotto un reato continuato
eterogeneo, nel quale non conta più l’identità dei reati, che oggi possono essere ontologicamente
diversi, ma l’unificazione della pena in un’ottica di favore.
In questa direzione si è mossa anche la riforma del 2005 che, eliminando dall’art 158 c.p.
il riferimento alla continuazione come termine da cui far decorrere la prescrizione, ha
definitivamente eliminato l’idea che l’unitarietà del reato continuato costituisse la regola. Al
contrario, oggi la regola è costituita dalla sua valutazione come una pluralità di illeciti, da
considerare come un unicum solo in presenza di conseguenze favorevoli. In quest’ottica, per altro,
la Consulta, in una recente sentenza (n. 324/2008), ha avuto modo di precisare che anche la
vecchia formulazione dell’art. 158 c.p. non era da intendere come una disciplina generale in favore
dell’unitarietà del reato, ma andava pur sempre considerata come una norma speciale.
Proprio sulla scorta di tali ragioni, la Corte di Cassazione ha escluso che le aggravanti
menzionate possano essere applicate al danno complessivamente considerato. Gli artt. 61,
n.7, e 62, n. 4 e 6, c.p. andranno riferiti ai singoli reati e all’entità del danno da questi
prodotto.
168
Scheda di giurisprudenza n. 17 Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso che ci occupa, si ritiene nei confronti di Tizio, per il furto di carburante, possa andare, sì, incontro
alla relativa imputazione, ma le molteplici violazioni ben potranno essere considerate avvinte dal medesimo
disegno criminoso (Tizio del resto agiva in esecuzione dello scopo di avere la disponibilità di carburante in un
periodo di crisi economica) ed essere qualificate dunque quale reato continuato, di cui all’art. 81 c.p. Allo
stesso potrà essere riconosciuta tuttavia l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art.
62, n. 4, c.p., da applicarsi in relazione ad ogni singolo reato e al conseguente danno prodotto dallo stesso.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 23 gennaio 2009, n. 3286
Estratto
[...Omissis...]
1. La questione controversa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite inerisce al terzo motivo del ricorso e
consiste nello stabilire “se, nel caso di reato continuato, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61
c.p., n. 7, e delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 4 e 6, debba tenersi conto del danno complessivo ovvero di
quello cagionato da ogni singolo reato”.
Essa si correla all’unica tra le eccezioni poste dal ricorrente che presenta profili di fondatezza ed appare perciò
opportuno premetterne l’esame alle altre doglianze svolte con l’atto di gravame.
2. In relazione a tale questione si rinvengono effettivamente contrasti nella giurisprudenza di legittimità.
2.1 Per quanto attiene all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6:
a) un primo orientamento giurisprudenziale (fino ad oggi prevalente) ritiene che, nell’ipotesi di reato continuato,
detta circostanza attenuante sia applicabile solo quando il risarcimento integrale del danno sia intervenuto in
relazione a tutti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione e non solo per quello più grave o per taluno di essi
(così, tra le molteplici decisioni, Cass.: Sez. 6, 8.5.2003, Kolli; Sez. 2, 24.2.1994, Perfetti; Sez. 2, 31.5.1990,
Bevilacqua; Sez. 6, 17.3.1987, Contarin; Sez. 4, 25.9.1985, Di Salvatore; Sez. 2, 8.2.1985, Procida; Sez. 2,
17.10.1983, Gabba; Sez. 6, 7.10.1983, Romano; Sez. 2, 11.6.1983, Bocchicchio; Sez. 2, 27.11.1982, Camorali;
Sez. 5, 26.5.1982, Apis; Sez. 2, 21.4.1982, Ciofani; Sez. 2, 13.1.1982, Campese; Sez. 5, 7.1.1982, Viale; Sez.
5, 10.11.1980, Tarzaghi; Sez. 6, 18.12.1978, Martino; Sez. 5, 22.7.1977, Celotto);
b) altro orientamento, invece, afferma che, nel reato continuato, la circostanza attenuante della integrale
riparazione del danno deve essere applicata pure se il risarcimento non concerna tutte le violazioni ma soltanto
quella più grave o altro dei singoli illeciti confluiti nel medesimo contesto (così Cass.: Sez. 1, 1.6.1990,
Sassolino; Sez. 2, 9.3.1990, Drago; Sez. 2, 10.3.1984, Messina; Sez. 2, 3.2.1971, Quatela).
2.2 Anche in riferimento all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4:
a) in alcune pronunzie è stato affermato che la valutazione della speciale tenuità del danno, nel caso di reato
continuato, va effettuata non in relazione all’importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al
danno cagionato per ogni singolo fatto reato (così Cass.: Sez. 6, 24.7.2007, Bortolotto; Sez. 3, 2.12.1993,
Lamanna; Sez. 2, 11.4.1989, Pizzo);
b) in altre decisioni si è precisato che, per la concessione dell’attenuante in oggetto, è sufficiente che essa
ricorra in relazione al reato ritenuto più grave (vedi Cass., Sez. 2:
14.1.1992, Cantoni e 25.5.1988, Scida);
c) secondo un diverso orientamento, invece, l’attenuante può essere concessa soltanto ove ricorra in tutti i fatti
unificati nel vincolo della continuazione (così Cass.: Sez. 6, 24.1.1990, Corsi; Sez. 2, 22.6.1989, Ravasio; Sez.
169
Parte generale 2, 6.7.1987, Nani).
2.3 Per ciò che concerne, infine, l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7:
a) un prevalente indirizzo ha affermato il principio secondo il quale, in caso di reato continuato, valendo, in
mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno
dell’aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da
ogni singola violazione, ma a quello complessivo cagionato dalla somma delle violazioni. Non è necessaria,
cioè, la sussistenza della rilevante gravità del danno patrimoniale in relazione ad ogni singolo reato, potendo
ravvisarsi la cennata circostanza in relazione al reato continuato, a tal fine considerato unitariamente (così
Cass.: Sez. 6, 22.9.2005, Garacci; Sez. 2, 27.3.2003, Miragliotta; Sez. 2, 21.10.2000, Vignuzzi; Sez. 6,
14.12.1999, De Vecchis; Sez. 2, 5.7.1989, Baraldi);
b) altre decisioni, invece, si sono espresse nel senso che nell’ipotesi di una pluralità di reati unificati dal vincolo
della continuazione, la determinazione del danno patrimoniale di particolare gravità, ai fini della sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, deve essere fatta con riferimento a ciascuno dei reati concorrenti,
posto che l’unificazione è finzione giuridica solo quoad poenam, mantenendo i singoli reati ogni loro
caratteristica e particolarità immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico (così Cass.: Sez. 1,
23.7.1984, Boscariol; Sez. 6, 27.1.1984, Parmiggiani; Sez. 2, 7.8.1980, Calvani).
3.1 contrasti giurisprudenziali di cui si è dato conto dianzi rientrano in un contesto il cui denominatore comune
consiste nella contrapposizione di una considerazione unitaria del reato continuato a fronte della diversa
prospettiva dell’autonomia giuridica delle singole violazioni che nel reato continuato confluiscono.
E - quanto alla questione pregiudiziale della natura giuridica e della disciplina dell’istituto della continuazione queste Sezioni Unite, già con la sentenza 30.6.1994, n. 14, Ronga (che fissò il principio della scindibilità, nel
corso dell’esecuzione, del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, ai fini della fruizione dei
benefici penitenziari) ebbero ad evidenziare che la unitarietà del reato continuato “deve affermarsi là dove vi sia
una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non
dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della
logica, appunto, del reato continuato”. Non vi è, quindi, una struttura unitaria da assumere come punto di
partenza di rilievo generale. Al contrario, la considerazione unitaria del reato continuato richiede due condizioni:
deve essere espressamente prevista da “apposita disposizione” o, comunque, deve garantire un risultato
favorevole al reo. Ne deriva che al di fuori di queste due ipotesi non vi è alcuna unitarietà di cui tener conto e, di
conseguenza, vige e opera la considerazione della pluralità dei reati nella loro autonomia e distinzione che,
pertanto, costituisce la regola.
Trattasi di orientamento poi ribadito dalla successiva sentenza 26.2.1997, Mammoliti (in tema di computo dei
termini di durata massima della custodia cautelare).
Le Sezioni Unite, del resto, avevano già enunciato il principio della scissione del cumulo con la sentenza
16.11.1989, Fiorentini, in tema di applicazione dell’indulto a reati unificati nel vincolo della continuazione (alcuni
dei quali non compresi nel provvedimento di clemenza) e tale principio hanno ribadito con la sentenza
24.1.1996, Panigoni (relativa ad indulto denegato sulla base “della natura globale della pena”).
Quanto agli effetti della scissione del reato continuato, la citata sentenza Ronga precisò che, “per effetto dello
scioglimento del cumulo, ... ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale,
sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto”.
4. La Corte Costituzionale:
- già con la sentenza n. 115 del 1987 aveva rilevato che, dopo la riforma introdotta dal D.L. 11 aprile 1974, n.
99, art. 8, convertito nella L. 7 giugno 1974, n. 220 (con la quale era stata modificata la formulazione originaria
dell’art. 81 c.p., estendendosi il trattamento sanzionatorio previsto per il reato continuato all’ipotesi di violazione
di disposizioni di legge diverse), essendosi introdotta una nozione eterogenea di reato continuato, non
conservava più importanza il problema dell’unità reale o fittizia dei reati, “visto che nella realtà esistono più reati
ontologicamente distinti che vengono unificati a fini sanzionatori”, e lo stesso Giudice delle leggi aveva
testualmente aggiunto che “ogni qualvolta l’unificazione sia per risolversi a danno dell’imputato, è lecito operare
170
Scheda di giurisprudenza n. 17 la scissione, parziale o totale, a seconda che lo richieda il favor rei”;
- con la sentenza n. 361 del 1994 aveva poi espresso esplicitamente adesione, in caso di reati unificati dal
vincolo della continuazione, allo “insegnamento giurisprudenziale della necessità dello scioglimento del cumulo
in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di
condanna e delle relative pene”;
- con la più recente sentenza n. 324 del 2008 (riferita ai rapporti tra cessazione della continuazione e computo
del termine prescrizionale, in presenza di una pluralità di condotte avvinte dal medesimo disegno criminoso, alla
stregua delle modifiche apportate all’art. 158 c.p. dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 2), infine, ha rilevato
che la previgente formulazione dell’art. 158 c.p. non costituiva espressione di una regola generale di unitarietà
del reato continuato e va riguardata come norma speciale, dovendosi individuare, al contrario, quale disciplina di
carattere generale, quella che considera autonomamente ciascun reato legato dal vincolo della continuazione
(disciplina alla quale la Consulta ha ritenuto che si è appunto allineato il nuovo art. 158 c.p.).
5. Tenuto conto della evoluzione normativa della relativa disciplina, nonchè delle argomentazioni dianzi
compendiate svolte dalle Sezioni Unite e dal Giudice delle leggi, deve ritenersi - a giudizio del Collegio definitivamente superata la concezione dell’unitarietà del reato continuato.
Già la riforma del 1974 all’art. 81 cod. pen. aveva incrinato detta concezione, facendo perdere al reato
continuato quella caratteristica essenziale, data dall’omogeneità delle violazioni, che costituiva l’originaria
condizione per la riconducibilità ad un unico reato delle plurime condotte illecite sorrette dalla identità del
disegno criminoso. La stessa riforma, inoltre, aveva significativamente soppresso l’inciso - prima contenuto
nell’art. 81 c.p., comma 3 - per il quale “le diverse violazioni si considerano come un solo reato”.
Il recente intervento novellistico, attuato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 2, ha eliminato poi la
disposizione, contenuta nella formulazione originaria dell’art. 158 c.p., per la quale nel reato continuato il termine
di prescrizione decorreva dalla cessazione della continuazione, con la conseguenza che ogni reato tra quelli
posti in continuazione criminosa con altri ha ormai un proprio termine di decorrenza iniziale della prescrizione,
da fissarsi secondo le regole di cui allo stesso art. 158 cod. pen.. Anche a tali effetti, dunque, non opera più
l’inscindibilità del reato continuato e viene confermata l’autonomia delle singole violazioni, sicchè in definitiva,
poichè la disposizione di cui all’art. 158 c.p. nel testo abrogato rappresentava l’unica eccezione espressa ai
principi ordinari, si può oggi affermare che la disciplina sostanziale del reato continuato è, in generale, quella
ordinaria sul concorso materiale di reati.
Attualmente ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione quoad poenam. Pure per la
determinazione della competenza, infatti, l’art. 4 del vigente codice di rito (non essendo state più riprodotte le
disposizioni di cui agli artt. 32 e 39 del codice previgente) esclude il reato continuato dagli elementi di
individuazione della stessa e stabilisce testualmente che “per determinare la competenza si ha riguardo alla
pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato” e che “non si tiene conto della
continuazione...”. Il reato continuato, dunque, va considerato anche a tali fini come una pluralità di illeciti.
Infine, a conferma delle esposte considerazioni, va aggiunto che l’art. 533 c.p.p., comma 2, prevede che “se la
condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che
deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione”.
Può allora concludersi - e in tale senso è altresì orientata l’unanime dottrina - che il reato continuato si configura
quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente
previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non
espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che
garantisca un risultato favorevole al reo.
Va affermato, conseguentemente, il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo della continuazione, con
riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati
distinti.
Ne consegue che - rispetto all’aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61 c.p., n.
7) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62 c.p., n. 4) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62 c.p., n. 6) 171
Parte generale l’entità del danno e l’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato
e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione. Ciò incide, ad evidenza:
sulla individuazione del reato più grave; sulla determinazione della pena-base, nel caso in cui la sussistenza
della circostanza riguardi la violazione ritenuta più grave; sulla determinazione del “quantum” dei rispettivi
aumenti di pena, in caso di circostanza inerente ad uno ovvero a più tra gli altri reati posti in continuazione.
5.1 Nella fattispecie in esame la Corte di appello di Torino ha dato atto che l’imputato ha formulato una formale
offerta risarcitoria (tramite lettera raccomandata del proprio legale in data 21.2.2007) alle persone offese del
delitto di rapina (i minori B. F. e L.), rimasta priva di riscontro, ed ha successivamente inviato, mediante vaglia
postale del 15.5.2007, la somma di Euro 250,00 al genitore dei minori suddetti. Ha però denegato il
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, argomentando che tale risarcimento sarebbe da
considerarsi parziale, perchè riguardante soltanto i danni subiti dalle persone offese del delitto di rapina e non
anche quelli conseguenti alle lesioni riportate dai carabinieri operanti, al danneggiamento dell’autovettura di
servizio ed al furto dell’autovettura guidata dallo stesso C..
Erronea deve ritenersi, al riguardo, per le ragioni dianzi esplicitate, l’applicazione del principio di diritto secondo il
quale, nell’ipotesi di reato continuato, la circostanza attenuante in oggetto sarebbe applicabile esclusivamente
allorquando il risarcimento integrale sia intervenuto in relazione a tutti i fatti avvinti dal vincolo della
continuazione e non solo per taluni di essi.
Limitatamente a tale punto va disposto, in conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuova decisione - ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
La stessa Corte territoriale non ha riconosciuto, invece, l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 alla stregua di una
considerazione autonoma dei distinti fatti di reato e, facendo corretto riferimento al valore oggettivo intrinseco
dei beni sottratti (la somma di 30,00 Euro ed i tre telefoni cellulari compendio della rapina; l’autovettura “Fiat
Punto” rubata ed utilizzata per commettere la stessa), razionalmente ha escluso che il danno cagionato alle
rispettive parti offese possa ritenersi “di speciale tenuità”, ossia di rilevanza minima, non essendo sufficiente,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che esso sia soltanto lieve.
Le eccezioni svolte al riguardo nel ricorso si riferiscono esclusivamente al delitto di rapina e risultano articolate
soltanto in fatto, sicchè esse devono considerarsi improponibili nel giudizio di legittimità, a fronte di una
valutazione sorretta da logico e coerente apparato argomentativo.
6. Gli altri motivi di ricorso sono infondati, sicchè in relazione ad essi il gravame deve essere rigettato.
6.1 Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale si è in presenza di dolo
eventuale quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta
possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e, ciò nonostante, agisca accettando il
rischio di cagionarle; quando, invece, l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può
ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo
abbia voluto, sicchè in tale ipotesi l’elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di
dolo eventuale (vedi Cass.: Sez. Unite, 12.4.1996, n. 3571 e, più di recente, Sez. 6, 19.1.2007, n. 1367).
Nella fattispecie in esame correttamente è stato ravvisato dolo diretto dell’imputato in ordine al reato di
danneggiamento dell’autovettura militare che lo aveva inseguito. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai
giudici del merito con puntuale riferimento alle acquisizioni probatorie, invero, il C. si trovava alla guida
dell’autovettura “Fiat Punto” targata (OMISSIS) e, dopo la consumazione della rapina, allorquando detto veicolo
venne intercettato dall’autovettura di servizio dei Carabinieri, quegli, essendosi in un primo momento fermato,
ripartì repentinamente mentre gli operanti si stavano avvicinando per eseguire gli opportuni controlli. Ebbe inizio
così un inseguimento, nel corso del quale il C. speronò volontariamente due volte il veicolo di servizio, facendolo
ruotare di 90 gradi rispetto alla sua direzione, e pose poi in essere una serie di manovre finalizzate a deviare
quello stesso veicolo nell’opposta corsia di marcia.
Quanto poi al reato di lesioni in danno del brigadiere Ci. e dell’appuntato V., deve evidenziarsi che il primo
venne investito in seguito a manovra di retromarcia posta in essere dall’imputato nel tentativo di riprendere la
fuga: manovra nell’effettuazione della quale l’investimento del sottufficiale, pur se non costituiva lo scopo finale
172
Scheda di giurisprudenza n. 17 della condotta, era altamente probabile sicchè non il rischio dell’evento ma l’evento stesso venne accettato e
quindi voluto. L’appuntato, invece, riportò lesioni per effetto degli speronamenti subiti nel corso
dell’inseguimento, lesioni sicuramente possibili quali conseguenze di quella condotta, in relazione alle quali
logicamente è stata ravvisata l’accettazione del rischio.
6.2 Dal disposto della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2 - secondo il quale devono ritenersi “armi”, sia
pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta e da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di
luogo, possano essere utilizzati per l’offesa alla persona - deriva che anche un attrezzo meccanico, quale una
chiave per svitare bulloni, quando sia utilizzato a scopo di minaccia e in un contesto aggressivo, e quindi senza
giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve perciò considerarsi arma, anche ai fini
dell’applicazione della relativa aggravante prevista dall’art. 628 c.p., comma 3 n. 1, (vedi Cass., Sez. 2,
5.4.1991, n. 3760).
Nella specie fu il minorenne F. ad intimare ai fratelli B. la consegna dei cellulari e dei portafogli ed il C. pose in
essere una condotta sicuramente minacciosa, sia incitando il suo complice a “prendere il coltello” sia
impugnando l’attrezzo meccanico e battendolo ritmicamente contro il palmo dell’altra mano.
6.3 Non è ravvisabile alcuna contraddittorietà tra dispositivo e motivazione nella quantificazione della pena e nel
calcolo degli incrementi della pena-base per i reati in continuazione, poichè la sommatoria degli aumenti
specificamente determinati, nella parte motiva, per ciascuno dei reati posti in continuazione (pari ad anni 4, mesi
6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa) conduce esattamente - tenuto conto della successiva riduzione per la
scelta del rito abbreviato - alla pena finale inflitta nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
6.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod. pen., è rimesso al potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
- il medesimo giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato già quando il giudice, nell’esercizio del
potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell’equivalenza, anzichè della prevalenza delle
attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez.
1, 26.1.1994, n. 758);
- anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante - non è
tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una
visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di
valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione
(vedi Cass., Sez. 6, 4.9.1992, n. 9398).
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in
proposito dalla legge, ha confermato il giudizio di equivalenza espresso dal primo giudice attribuendo rilevanza
decisiva alla “estrema gravità oggettiva” delle condotte criminose accertate ed al “comportamento processuale
ispirato alla ostinata negazione delle proprie responsabilità”, deducendone razionalmente significazioni negative
della personalità dell’imputato.
ricorso per Cassazione K.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 3 aprile 2009 con la
quale, essendo il ricorrente in stato di custodia cautelare, è stata confermata la sentenza di primo grado
affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di furto pluri-aggravato continuato in concorso, eseguiti su
veicoli in sosta e in uno scantinato, di porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso e al reato ex L. n. 286 del
1998, art. 6, fatti accertati il (OMISSIS).
Deve invece affermarsi che nel caso in esame il possesso degli strumenti atti allo scasso presenti una
autonoma rilevanza giuridica come espressione del potenziale criminale dei ricorrenti, ancora in grado di
provocare danni contro il patrimonio all’atto dell’intervento delle forze dell’ordine.
[...Omissis...]
173
Parte generale Scheda di giurisprudenza n. 18
L’obbligo di impedire il reato altrui: il concorso mediante omissione
TRACCIA
Tizio è padre di Sempronia, dell’età di quattordici anni.
Dall’età di tredici anni quest’ultima è fidanzata con Caio, di dieci anni più grande di lei.
Tizio, pochi mesi dopo aver saputo della relazione di Sempronia, la incoraggiava a cominciare una
convivenza stabile con Caio, avendo la disponibilità di un appartamento di proprietà in quel momento
inutilizzato e ritenendo la figlia pienamente matura.
Sempronia e Caio accettano di buon grado l’invito di Tizio ed iniziano una convivenza.
Dietro segnalazione dei servizi sociali, la polizia giudiziaria prima e il pubblico ministero competente ratione
loci poi, vengono a conoscenza dei costanti rapporti sessuali intrattenuti da Caio con Sempronia, rapporti che
la stessa Sempronia candidamente ammette senza conoscere la natura illecita di questi.
Venuto a sapere dell’arresto di Caio, Tizio si preoccupa delle conseguenze delle proprie azioni e si rivolge ad
un legale per avere delucidazioni circa eventuali proprie responsabilità penali.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, ricostruiti i presupposti del concorso mediante omissione nel
reato altrui, rediga motivato parere.
1. La questione.
Se dubbi non sussistono circa la configurabilità di un concorso commissivo nel reato omissivo e di
un concorso omissivo nel reato omissivo, lo stesso non può dirsi circa i limiti di ammissibilità di
un concorso omissivo nel reato commissivo altrui, questione da tempo sottoposta
all’attenzione di giurisprudenza e dottrina. A tal proposito, si rende necessaria una premessa.
Il concorso omissivo si configura sulla base della combinazione del disposto degli artt. 110
e 40, co. 2, c.p. e della norma di parte speciale. Perché si ipotizzi in concreto un concorso
omissivo, è necessario verificare, oltre all’integrazione dei requisiti del concorso di persone,
l’esistenza di una posizione di garanzia che ponga a carico di un soggetto l’obbligo giuridico di
impedire il verificarsi di un evento, rappresentato appunto dal reato altrui.
La generale configurabilità della figura concorsuale de qua – concorso omissivo nel reato
commissivo altrui – trova la sua ragion d’essere nell’art. 40, co. 2, c.p.: la c.d. clausola di
equivalenza (“non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo”), in combinato disposto con l’art. 110 c.p., lascia implicitamente intravedere
l’ammissibilità di un concorso di tal fatta.
Va ricordato a tal proposito che nel concetto di evento, richiesto dall’art. 40 c.p., è compreso
anche il reato altrui. Ed ancora, perché l’omissione assuma rilevanza penale è necessario
che costituisca condizione necessaria o quantomeno agevolatrice della realizzazione del
fatto (classico l’esempio del custode che si accorda con i ladri per non azionare il sistema di
allarme) e che sia violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire il reato (dunque, della
già citata posizione di garanzia). La mera connivenza, del resto, non è punibile: consiste in un
comportamento meramente passivo tenuto da un soggetto in capo al quale difetta ogni obbligo
giuridico di intervento impeditivo del reato altrui (Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2012, n. 23788).
174
Scheda di giurisprudenza n. 18 È infatti escluso un generalizzato obbligo di intervento dei consociati teso ad impedire
l’altrui commissione di reati: nessuna responsabilità può essere ascritta in capo al soggetto
inerte, a meno che non si tratti di persone che rivestono determinate posizioni di garanzia
giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p.
In relazione a queste ultime, vale la pena precisare che, premesso il rispetto del principio di
riserva di legge in ambito penale e dunque l’individuazione della fonte dell’obbligo in base al
criterio formale, si distinguono in posizioni di protezione (fondate sul rapporto di vicinanza del
garante al bene giuridico tutelato; possono originare da rapporti familiari, da comunanza di vita o
da una volontaria assunzione di un tale obbligo ed importano l’obbligo del garante di intervenire per
proteggere il bene giuridico tutelato da ogni fonte di pericolo) e posizioni di controllo (fondate
sulla vicinanza del garante rispetto ad una specifica fonte di pericolo, che implica un potere di
governo, disposizione e organizzazione sulla medesima, tale da imporgli di attivarsi per
neutralizzarne la potenzialità lesiva o pericolosa rispetto al bene tutelato).
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
La delimitazione della sfera di operatività del concorso omissivo nel reato commissivo altrui
è, come anticipato, da tempo questione oggetto di giurisprudenza e dottrina: in tema, si sono
contrapposti due orientamenti.
2.1. Il primo orientamento: Tesi ampliativa.
Secondo un primo indirizzo, del tutto maggioritario in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. II, 15
gennaio 2013, n. 18745; ez. III, 30 gennaio 1996, n. 3100,ez. V, 5 aprile 1995, n. 5139,ez. II, 6
dicembre 1991, n. 1506 Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 1984, n. 8870; Cass. pen., Sez. II, 8 maggio
1984, n. 6177), tale forma di concorso sarebbe pienamente configurabile sia con riferimento
ai reati con evento naturalistico, sia con riferimento ai reati di pura condotta.
1° Argomento: combinazione degli artt. 40, co. 2, e 110 c.p. In relazione alla
realizzazione di reati altrui, la combinazione di tali articoli con le norme di parte speciale implica
che l’obbligo giuridico dei garanti sia riferito non solo all’impedimento degli eventi
naturalistici, ma, più in generale, all’impedimento dei reati realizzati dai concorrenti, a
prescindere dalla presenza di un evento naturalistico.
2.2. Il secondo orientamento: Tesi restrittiva.
Un secondo orientamento, portato avanti per lo più in dottrina e prevalente in tale ambito (a
titolo esemplificativo: PATALANO, FIANDACA-MUSCO, RISICATO; contra, PALAZZO), ritiene invece di
dover escludere che il concorso omissivo nel reato commissivo possa essere esteso anche alle
ipotesi di reati di mera condotta.
1° Argomento: interpretazione degli artt. 40, co. 2, e 110 c.p. Prendendo le mosse da
tale disposizione, che disciplina, in via generale, l’illecito penale omissivo improprio, la dottrina
afferma che una forma concorsuale di responsabilità omissiva nel reato commissivo altrui
possa essere ipotizzata solo con riferimento ai reati di evento (e, in tal caso, invero, non
175
Parte generale sarebbe neppure necessario riferirsi alla fattispecie concorsuale di cui all’art. 110 c.p. in quanto la
responsabilità scaturirebbe direttamente dalla combinazione tra l’art. 40 c.p. e la fattispecie astratta
mono soggettiva). L’art. 110 c.p., infatti, non può valere ad estendere le condizioni ed i
presupposti della responsabilità omissiva che, a mente dell’art. 40 c.p., richiede, ai fini della
sua astratta configurabilità, la sussistenza di un evento naturalistico che, con riferimento a
particolare posizione di protezione o di garanzia rivestite, si abbia l’obbligo giuridico di
impedire.
2° Argomento: mancanza di un’espressa previsione. L’estensione dell’ambito di
operatività del concorso omissivo nel reato commissivo altrui, disposta in assenza di una
disposizione che la disciplina espressamente, comporta inevitabilmente un’eccessiva
dilatazione della gamma degli interessi tutelabili con lo strumento della sanzione penale e
rende oltremodo complesso lo stesso processo di selezione degli obblighi di garanzia e dei loro
titolari.
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Configurabilità del
concorso omissivo nel reato commissivo rispetto a tutti i reati.
La Cassazione ha di recente ribadito l’accoglimento dell’opzione ampliativa, affermando di recente
che “il concorso omissivo è configurabile rispetto a tutti i reati: di evento e di mera condotta,
a forma libera e vincolata, e ciò, essenzialmente, in base alla combinazione degli artt. 40
comma 2 e 110 c.p.” (Cass. pen., Sez. I, 23 settembre 2013, n. 43273).
1° Argomento: corretta interpretazione dell’art. 110 c.p. Entrambe le norme contengono
una clausola aperta di estensione della punibilità, tale da innestarsi su qualsiasi norma di parte
speciale ed idonea ad attribuire rilevanza penale a qualunque condotta che, seppur atipica, abbia
agevolato, dal punto di vista causale, la produzione dell’evento lesivo. Anche nell’ambito del
concorso di persone, dunque, l’incriminazione è fondata sulla tecnica di tipizzazione
causale, ma, a differenza di quel che avviene in relazione all’art. 40 c.p., l’art. 110 c.p. è norma
assai più ampia, richiedendo infatti solo che la condotta morale o materiale di ciascun
concorrente abbia rivestito, alla luce di un’indagine ex post ed in concreto, un ruolo di
efficienza causale, anche solo in termini di agevolazione, nella realizzazione di una qualunque
fattispecie di reato. E del resto, non v’è dubbio in merito all’affermazione che anche l’inerzia,
da parte del soggetto su cui grava un obbligo giuridico di agire, sia tale da agevolare la
commissione di un reato.
Proprio per tale ragione, la figura del concorso omissivo nel reato commissivo, di cui agli
artt. 40, co. 2, e 110 c.p., risulta applicabile anche alle ipotesi di reati di mera condotta o ai
reati di evento a forma vincolata.
2° Argomento: tipicità dell’omissione. Qualora la condotta omissiva di partecipazione si
identifichi nel mancato impedimento dell’evento naturalistico di un reato, la tipicità dell’omissione
viene dedotta già a valle dalla sola combinazione dell’art. 40, co. 2, c.p. con la norma di
parte di speciale interessata nel caso concreto; l’art. 110 c.p. si limiterebbe, invero, a dettare la
disciplina da applicare in tema di concorso di persone e ad estendere, come testé visto, la
punibilità.
3° Argomento: presenza di altre norme da cui trarre implicita conferma
176
Scheda di giurisprudenza n. 18 dell’ammissibilità del concorso de quo. Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 116 c.p. e 138
c.p. mil. p. L’art. 116 c.p., nell’ascrivere al concorrente la responsabilità per il reato commesso
nella forma della compartecipazione criminosa, pur diverso da quello programmato, impiega il
termine “evento” non in senso naturalistico, ma in relazione al reato effettivamente realizzato,
prevedendo altresì che quel fatto debba essere conseguenza dell’azione od omissione del
concorrente anomalo. L’art. 138 c.p. mil., dal canto suo, nel disciplinare l’autonoma fattispecie
delittuosa di omesso impedimento dei reati militari, compresi i reati di mera condotta, fa
espressamente salva l’ipotesi contemplata dall’art. 40, co. 2, c.p., in ragione del fatto che, ove
gravi sul militare uno specifico obbligo di impedimento, non si applicherà la residuale fattispecie
disciplinata dal codice penale militare di pace, rispondendo il soggetto direttamente di concorso
mediante omissione nel reato non impedito.
4° Argomento: titolarità del dovere impeditivo. Infine, proprio la titolarità della
posizione di garanzia svolgerebbe un ruolo delimitativo, non consentendo di incriminare
chiunque per omissione in un reato commissivo, ma solo il soggetto agente su cui gravi un
obbligo giuridico di agire; la mera connivenza non potrebbe mai essere oggetto di
incriminazione, pena l’inevitabile e inaccettabile compressione delle libertà individuali.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso che ci occupa, le conseguenze cui andrà incontro Tizio non ricadono, per vero, nell’ambito del
concorso omissivo nel reato commissivo altrui, configurandosi in termini di vero e proprio concorso, di cui
all’art. 110, per aver favorito ed anzi agevolato i rapporti sessuali tra Caio e Sempronia, figlia di Tizio, di
appena tredici anni.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. I, 23 settembre 2013, n. 43273
Estratto
[...Omissis...]
1. Con ordinanza deliberata il 22 aprile 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava il
provvedimento emesso l’11 marzo 2013 dal GIP del medesimo tribunale, che aveva disposto l’applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.C., brigadiere dei Carabinieri in servizio
presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di (OMISSIS), in relazione a due
distinte imputazioni:
- la prima, relativa alla detenzione illegale ed al porto in luogo pubblico, in concorso con M.G., Ca.Gi. e I.M.,
di alcune pistole di marca e calibro non identificati, contestandosi all’indagato, in particolare, un “concorso
commissivo mediante omissione”, in quanto, dopo aver fatto in modo di favorire un incontro tra il M.,
responsabile di un’impresa di trasporti corrente in (OMISSIS), denominata Eurotour con il quale intratteneva
un rapporto confidenziale, Ca. G., “compariello del M. e genero di T. G., esponente di primo piano del clan
camorristico Moccia, e I.M., soggetto che quello stesso giorno aveva avuto con il M. un’accesa controversia
per ragioni di viabilità (nel corso della quale era stato schiaffeggiato dall’antagonista), vi aveva assistito “ben
177
Parte generale sapendo che i tre soggetti erano armati” e ciò non di meno “aveva omesso di provvedere al sequestro delle
armi ed al conseguente arresto nella fragranza dei tre soggetti” in (OMISSIS) il (OMISSIS) (capo 1 della
rubrica provvisoria);
- la seconda, relativa alla soppressione od occultamento di atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, in
(OMISSIS), in epoca immediatamente successiva all’ottobre 2010, e segnatamente del fascicolo n.
(OMISSIS) registro generale notizie anonime della Procura della Repubblica di (OMISSIS), assegnato al
Dott. C. M., contenente, al suo interno, i verbali di assunzione di informazioni di A.F., una dirigente del
Comune di (OMISSIS), la quale, in detta qualità, aveva stipulato con una ditta concorrente della Eurotour un
contratto relativo al servizio pubblico di trasporto scolastico per l’anno 2008, all’esito di gara d’appalto, alla
quale aveva partecipato anche l’impresa del M. (capo 3 della rubrica provvisoria).
1.1. Il Tribunale, con riferimento alle deduzioni difensive svolte nell’istanza di riesame e per quanto ancora
rileva nel presente scrutinio di legittimità, riteneva, infatti, quanto al fatto contestato al capo 1 della rubrica,
che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza era desumibile dal contenuto di plurime intercettazioni telefoniche ed ambientali - relative a colloqui intercorsi tra il coindagato M.G. il C. C. e Ca.Gi., nonchè tra il C.
e la propria madre, di cui nell’ordinanza si riproducono i passaggi più significativi.
Dal contenuto di tali intercettazioni, eseguite nell’ambito di una complessa attività investigativa disposta a
seguito della consumazione, di una serie di fatti di sangue, che coinvolgevano esponenti della criminalità
organizzata, emergeva, in termini ritenuti inequivoci, che il (OMISSIS) tra il M. ed altro indagato, lo I.M., era
insorto un animato litigio, originato da un sinistro stradale che aveva coinvolto, da un lato, l’auto condotta
dalla cognata dello I., e dall’altro, un veicolo della Eurotur, alla cui guida si trovava un autista ucraino, Co.,
che a detta dello I. era ubriaco, che aveva invaso la corsia opposta di guida, andando a collidere
frontalmente con il veicolo antagonista.
Il diverbio, insorto tra il M. e lo I., non coinvolti personalmente nel sinistro ma informati rispettivamente
dall’autista e dalla cognata della intervenuta collisione dei rispettivi veicoli, era degenerato, avendo il M.
infetto due schiaffi a “ Mi. da (OMISSIS)”.
Avendo lo I., dopo aver accompagnato in ospedale la cognata e la nipote che si trovava a bordo dell’auto,
manifestato propositi di vendetta recandosi presso l’autorimessa della Eurotour, con l’intenzione di rivalersi
nei confronti del M., quest’ultimo aveva informato dell’accaduto il brigadiere C. ed il “compariello” Ca.Gi.,
chiedendo l’intervento degli stessi per comporre il dissidio.
Orbene è proprio dal contenuto di tali conversazioni, nonchè dal resoconto di quanto avvenuto fornito dal C.
alla propria madre, per giustificare il suo ritardo nel rincasare il (OMISSIS), che emergeva, in maniera
ritenuta inequivoca, atteso anche il ripetuto ricorrere dei termini “vestuto”, “sistemarmi” e “giubbino”, che
allorquando lo I. ed il M. si affrontarono nei pressi dell’autorimessa alla presenza del C. e del Ca. e risolsero
la disputa che li opponeva anche grazie all’intervento pacificatore svolto dagli stessi, erano entrambi armati di
pistola.
1.1.2 Con riferimento, poi, alla deduzione difensiva secondo cui gli indizi raccolti consentivano di ravvisare
nella condotta del C., a tutto concedere, gli estremi del reato di cui all’art. 361 c.p., (omessa denuncia di
reato da parte del pubblico ufficiale) ma non certamente un concorso dello stesso nei reati di detenzione e
porto illegali delle pistole asseritamente commessi, in particolare, dal M., dal Ca., il Tribunale sviluppava un
articolato percorso motivazionale che può così sintetizzarsi:
l’omissione può assumere rilevanza come condotta concorsuale, quando la stessa, come dimostrato nel
caso in esame dal complesso delle intercettazioni, implichi la violazione di un obbligo di garanzia (art. 40 c.p.,
comma 2), vale a dire di un obbligo di impedire il reato commissivo altrui.
Secondo il Tribunale, in altri termini, il C. ha omesso di adottare il doveroso comportamento positivo
(impedimento del reato) che poteva materialmente attuare e che invece non attuato, concorrendo così al
compimento del reato stesso.
1.2 Quanto, invece, alla seconda imputazione, il falso per soppressione od occultamento accertato in epoca
immediatamente successiva all’(OMISSIS), premesso che tale episodio delittuoso, dettagliatamente
178
Scheda di giurisprudenza n. 18 ricostruito dal Tribunale specie quanto alla sua genesi, riconducibile all’esito di una gara di appalto vinta da
un’impresa di trasporti (la ditta Angelino) in concorrenza di quella gestita dal M., i giudici del riesame
osservavano, in primo luogo, che la sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato risultava incontestata,
quanto alla condotta materiale, sulla base delle dichiarazioni della dirigente della segreteria del Pubblico
ministero che aveva in carico il fascicolo processuale di cui trattasi, la quale aveva riferito che lo stesso, più
volte cercato in quanto risultato pendente non era stato reperito, e dalla relazione del maresciallo D., come il
C. in servizio presso la segreteria del pubblico ministero assegnatario del fascicolo, attestante che il
materiale informatico esistente presso quella segreteria, risultava includere anche due file (denominati
escussione A. ed escussione A. II) inserite in una cartella elettronica connessa al numero identificato
dell’indicato fascicolo mai rinvenuto.
Il Tribunale disattendeva, altresì, la deduzione difensiva volta a negare la natura di atto pubblico ai verbali
dichiarativi pacificamente formati dall’indagato nella sua veste di ufficiale di pubblica sicurezza, a ragione del
rilievo che gli stessi dovevano, in realtà, venire allegati ad una relazione di servizio che il C. non aveva
ancora ultimato, rimarcando che tali verbali erano dotati di una propria distinta ed autonoma efficacia
giuridica.
Quanto poi alla dedotta mancanza di un interesse o movente del C. alla soppressione, il Tribunale, nel
ribadire che dalle intercettazioni emergeva come l’indagato avesse avuto numerose conversazioni con il M.
riguardanti l’appalto del servizio scuola bus del Comune di (OMISSIS) oggetto delle dichiarazioni dell’A.,
evidenziava come, in ogni caso, l’accertamento dello specifico movente era superfluo, in quanto la
volontarietà dell’azione è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo del reato, essendo il fine di procurare
a sè o ad altri un vantaggio una componente essenziale dell’elemento psicologico del reato, solo quando il
documento si identifichi in una scrittura privata.
Riteneva infine il Tribunale astratta e scarsamente credibile l’ipotesi che la soppressione dei verbali fosse da
ascriversi all’opera di terzi, evidenziando, per un verso, che all’ufficio in cui gli atti si erano formati, non
avevano accesso un numero indeterminato di soggetti non meglio qualificati e, per altro verso, che solo il C.
aveva un concreto e diretto interesse alla soppressione dei verbali informativi dell’A., onde soddisfare la
posizione del M., concorrente della ditta Angelino.
1.3 Quanto poi alla contestata scelta della più severa misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale,
valutata la preoccupante gravità dei fatti, “avendo il C. asservito la sua qualificata funzione di carabiniere ai
fini deviati e devianti del crimine”, perveniva alla conclusione che sussistesse un qualificato pericolo di
reiterazione di delitti della stessa specie e che quella applicata fosse la misura più adeguata e proporzionata,
precisando che “il decremento della coercizione personale, previo ricorso a misure di minore afflizione,
produrrebbe il proporzionale abbassamento del livello di tutela del pericolo su argomentato”.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del suo difensore,
deducendone l’illegittimità:
- con il primo motivo dedotto, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento sia alla ritenuta
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza che alla negata sussumibilità del fatto di cui al capo 1
dell’imputazione, nella fattispecie di cui all’art. 361 c.p.;
- con il secondo motivo, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione - carente, illogica e
contraddittoria - in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
2.1 In particolare nel ricorso, sintetizzando argomentazioni ben più articolate, si censura, con il primo motivo,
l’ordinanza impugnata con riferimento:
- al ricorso ad una motivazione per relationem, consistita, essenzialmente, nella riproduzione pedissequa
degli esiti dell’attività di captazione svolta a carico del C. e degli altri coindagati;
- alla non adeguata confutazione della deduzione difensiva relativa alla sussumibilità del fatto ascritto
nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 361 c.p., ed in particolare alla tesi, prospettata da autorevole dottrina,
secondo cui la clausola di equivalenza di cui all’art. 40 c.p., comma 2, deve ritenersi applicabile solo alle
fattispecie a forma libera, causalmente orientate, nel senso che la rilevanza causale dell’omissione sarebbe
179
Parte generale ammissibile solo per un tal genere di reati, sicchè non sarebbe possibile una partecipazione mediante
omissione a reati di mera condotta ovvero a reati di evento a forma vincolata, quali la detenzione illegale di
armi;
- alla non corretta valutazione delle conversazioni intercettate, emergendo dalle stesse soltanto che il C.
venne convocato dal M. presso l’autorimessa della sua impresa per un intervento, a ragione
dell’atteggiamento assunto dallo I., a sua volta in attesa dell’arrivo del M. in detto luogo;
- alla conseguente illogicità dell’assunto secondo cui l’indicato contenuto delle intercettazioni configurerebbe
un grave quadro indiziario a carico del C., relativamente ad un suo concorso nella detenzione di armi,
occorrendo a tal fine che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole
commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente;
- al carattere meramente apparente della motivazione relativamente all’illustrazione delle ragioni per cui
sussisterebbe un grave quadro indiziario a carico del C., in ordine al reato contestato al capo 3 della rubrica,
evidenziandosi al riguardo come risulti generico il riferimento alle conversazioni intercorse tra l’indagato ed il
vigile urbano Diana Gabriele nonchè tra l’indagato ed il M., e l’incongruo apprezzamento della circostanza
che l’indagato non aveva alcun interesse alla soppressione dei verbali relativi alle sommarie informazioni
rese dall’A.; che lo stesso, all’epoca dei fatti, non era l’unico soggetto ad avere accesso ai locali della
Procura ove gli atti asseritamente soppressi erano stati formati e venivano custoditi; che il suo interesse alle
vicende lavorative del M. non poteva assurgere al rango di elemento indiziante a carico dell’indagato.
2.2 Con il secondo motivo, l’ordinanza impugnata viene censurata con riferimento alla ritenuta inevitabilità
dell’adozione della più severa misura cautelare applicata, tenuto conto, per un verso, dell’insussistenza
dell’elemento dell’attualità delle esigenze cautelari, posto che i fatti contestati risultano risalenti nel tempo
(riferendosi le condotte ascritte all’anno (OMISSIS)); che non sussiste alcun pericolo per la genuinità della
prova, essendosi conclusa la fase delle indagini preliminari; che non sussiste alcun concreto pericolo di
reiterazione dei reati, posto che l’indagato non svolge più alcuna attività lavorativa, essendo in aspettativa
per ragioni di salute.
1. L’impugnazione proposta nell’interesse di C.C. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
1.1 Quanto al primo motivo dedotto in ricorso, premesso che le argomentazioni ivi formulate sono dirette a
confutare, in primo luogo, l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, con riferimento
all’ipotizzato suo concorso nei reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi, contestato agli
altri indagati, è opportuno ricordare, preliminarmente, quali siano i limiti del sindacato della Corte di
Cassazione in materia cautelare.
In proposito è stato più volte ribadito che “l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di
accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione
delle misura cautelare e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui
possesso rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 2050/96, imp.
Marseglia, rv. 206104; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).
1.1.1 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato come dalle intercettazioni relative a colloqui avuti
dall’indagato con M. e con il C., e immediatamente dopo i fatti di cui è processo con la propria madre,
emergeva che il C. aveva acquisito piena consapevolezza che le persone convenute il (OMISSIS) presso
l’autorimessa dell’impresa Eurotour, fossero armate e che malgrado ciò l’indagato non aveva assunto alcuna
iniziativa diretta ad interrompere la commissione di illeciti penali, omettendo finanche di denunciare
all’Autorità giudiziaria i responsabili degli stessi.
1.1.2 Le censure mosse dalla difesa all’ordinanza per contestare la sussistenza di un quadro indiziario grave,
180
Scheda di giurisprudenza n. 18 esprimono, quindi, solo un generico dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura
nel merito della vicenda, del contenuto delle intercettazioni, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte
di una plausibile motivazione del provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte dai giudici del riesame quei profili di macroscopica illogicità,
che soli, potrebbero qui avere rilievo.
1.2 Quanto poi alle deduzioni difensive volte a contestare la configurabilità stessa di un concorso
dell’indagato in reati di mera condotta e comunque la sussistenza dell’elemento soggettivo, le stesse, così
come formulate, non possono trovare accoglimento.
1.2.1 Non ignora, invero, questo Collegio che una parte della dottrina sostiene che, essendo applicabile la
clausola di equivalenza di cui all’art. 40 c.p., comma 2, solo alle fattispecie a forma libera, causalmente
orientate, anche la rilevanza concorsuale dell’omissione sarebbe ammissibile solo per il mancato
impedimento di un tal genere di reati, sicchè non sarebbe possibile una partecipazione mediante omissione a
reati di mera condotta ovvero a reati di evento a forma vincolata. Ma trattasi di opinione minoritaria e non
condivisibile.
La dottrina prevalente - senza avere la pretesa di illustrare in questa sede “i tenaci argomenti, teorici e
pratici” addotti - è infatti nel senso di ritenere configurabile il concorso omissivo, rispetto a tutti i reati: di
evento e di mera condotta, a forma libera e vincolata, e ciò, essenzialmente, in base alla combinazione
dell’art. 40 c.p., comma 2, e art. 110 c.p..
L’esistenza dell’obbligo di impedire l’evento, contraddistingue infatti il concorso per omissione dalla mera
connivenza, che si ha quando il soggetto assiste passivamente alla perpetrazione di un reato, che ha la
possibilità materiale ma non l’obbligo giuridico di impedire.
Ciò posto, che l’obbligo di impedire i reati che grava sulle forze di polizia sia idoneo a determinare fattispecie
concorsuali, rappresenta un dato ormai certo, almeno secondo l’insegnamento della dottrina e della
giurisprudenza prevalenti, dal quale il Collegio non intende discostarsi, condividendolo.
Ed invero, come questa Corte regolatrice ha già da tempo precisato (Sez. 2, n. 1506 del 06/12/1991 - dep.
14/02/1992, Viani, Rv. 189762;
ed in senso non difforme Sez. 5, n. 5139 del 05/04/1995 - dep. 05/05/1995, P.M. in proc. Russo ed altri, Rv.
201323), “la condotta omissiva di pubblici ufficiali.... consistente nella mancata opposizione alle azioni
delittuose in atto (rapina impropria e violenza privata....) e nella successiva omessa denuncia di fatti
penalmente perseguibili, è giuridicamente apprezzabile sotto il profilo concausale della produzione degli
eventi, e, come tale, equivale a concorso morale nel cagionarli, stante l’imperatività dell’obbligo giuridico
inadempiuto” (art. 40 c.p., comma 2).
1.2.2 Nè, allo stato, trova conforto in adeguati elementi indiziari, la tesi prospettata dalla difesa del C.
secondo cui nella condotta dell’indagato sarebbero ravvisabili soltanto gli estremi dall’omessa denuncia di
reato di cui all’art. 361 c.p..
Premesso, infatti, che secondo l’ormai consolidata lezione interpretativa di questa Corte, “diverso dalla
omessa denuncia di reato di cui all’art. 361 c.p., è il concorso nel reato per non averlo impedito pur avendone
l’obbligo, previsto dall’art. 40 c.p.” in quanto, “nel primo caso il pubblico ufficiale omette o ritarda di
denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza; nel secondo caso invece egli non omette la semplice
notizia, ma omette il doveroso comportamento positivo (impedimento del reato) che poteva materialmente
attuare e che invece non ha attuato, concorrendo così al compimento del reato stesso” (Sez. 2, n. 6177 del
08/05/1984 - dep. 02/07/1984, Calvaruso, Rv. 165133), è agevole rilevare che nel presente procedimento al
C., in base al contenuto delle intercettazioni, viene contestato non già di aver appreso ex post di un “animato
confronto” tra persone armate svoltosi presso l’autorimessa dell’impresa Eurotour il (OMISSIS) e di non aver
denunciato il fatto, ma di avervi personalmente partecipato, nella piena consapevolezza che i suoi
interlocutori fossero armati, e di aver omesso qualsiasi comportamento, pur doveroso, diretto ad impedire il
protrarsi delle condotte antigiuridiche dei terzi, dovendo escludersi, in particolare, quanto alla struttura del
dolo di concorso, la necessità del “previo concorso”, essendo perseguibili a titolo di concorso, anche i casi di
181
Parte generale “accordo improvviso” che si manifesti durante l’esecuzione del reato (in termini, si veda Sez. 1, n. 8870 del
18/05/1984 - dep. 20/10/1984, Adinolfi, Rv. 166215 e tra le decisioni più recenti, Sez. 2, n. 18745 del
15/01/2013 - dep. 29/04/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260).
1.3 Del tutto generiche si rivelano pure le deduzioni difensive dirette a contestare la sussistenza di gravi
indizi relativamente all’imputazione di falso, avendo i giudici del riesame compiutamente illustrato gli elementi
indiziari, da cui emergeva non solo il fatto materiale dell’avvenuta soppressione o comunque
dell’occultamento di un fascicolo processuale e di alcuni verbali relativi alle sommarie informazioni rese da
una dirigente del comune di (OMISSIS) relativamente ad una gara di appalto del trasporto pubblico
scolastico, a cui aveva partecipato, tra le altre anche l’impresa del M., ma anche le ripetute richieste di
informazioni sull’andamento delle indagini rivolte dal predetto coimputato al C., che in prima persona aveva
sentito la dirigente comunale.
1.4 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione diretto a censurare l’ordinanza
impugnata relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed al giudizio di esclusiva
adeguatezza della misura applicata.
Osserva in proposito il Collegio che il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato la estrema gravità
della condotta posta in essere e le modalità della stessa, avuto riguardo, in particolare ai fatti contestati al
capo 1 della rubrica, evidenziando che tali elementi indicavano una spiccata ed elevata pericolosità sociale e
quindi una propensione alla commissione di altri delitti di talchè doveva ritenersi concreta e grave l’esigenza
di prevenzione speciale, e rilevando come in presenza di una tale situazione, l’unica misura idonea a
salvaguardare la suddetta esigenza possa essere soltanto quella della custodia cautelare in carcere, laddove
le deduzioni difensive, in particolare quelle volte ad escludere la sussistenza di un pericolo “attuale” di
reiterazione di reati della stessa specie attesa la cessazione del rapporto di servizio presso l’Arma dei
Carabinieri, non considerano che intanto la circostanza addotta (l’avvenuto pensionamento del C., dopo una
lunga aspettativa) è sopravvenuta rispetto alla decisione impugnata e che la motivazione addotta dai giudici
del riesame, specie laddove evidenzia la sussistenza “di un contesto relazionale fondativo di cointeressenze illecite” tra l’indagato e personaggi malavitosi, fornisce adeguata e logica spiegazione della
irrilevanza del dato relativo alle sorti del rapporto organico con la pubblica amministrazione, non potendo
escludersi la rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’indagato, pur nella mutata veste di
soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, proprio in considerazione degli evidenziati suoi stretti
legami con ambienti criminogeni, (in termini, sulla relativa incidenza che in tema di misure cautelari può
assumere la dismissione di un ufficio pubblico, si veda ex multis, Sez. 1, n. 15667 del 16/01/2013 - dep.
04/04/2013, Capogrosso e altri, Rv. 255351).
2. Il ricorso, infondato sotto ogni profilo, deve di conseguenza essere rigettato e ciò comporta la condanna
del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.
A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al
Direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
[...Omissis...]
182
Scheda di giurisprudenza n. 19 Scheda di giurisprudenza n. 19
I presupposti soggettivi del concorso anomalo
TRACCIA
Tizio, Caio e Sempronio, amici cresciuti nella periferia milanese, decidono di punire Primo, che vive nel loro
stesso quartiere, per aver provocato la rottura della relazione tra Tizio e la fidanzata storica.
Decidono, allora, di tendere un agguato a Primo, chiedendogli un incontro chiarificatore in un parco della
zona. Quest’ultimo, tuttavia, nutrendo dubbi sulle reali intenzioni di Tizio, porta con sé i fratelli Secondo e
Terzo.
Non appena giunti sul posto, avvedutisi della presenza di ulteriori persone e che l’agguato è fallito, i tre
decidono di non soprassedere al proprio piano ma di aggredire comunque Primo, confidando nelle propria
maggiore forza fisica. Ne nasce una rissa tra i due gruppi di amici.
Durante la rissa, Caio estrae la pistola che possiede in qualità di guardia giurata e spara a Primo, che viene
colpito al torace e muore poco dopo in conseguenza delle ferite subite.
Per tali condotte, Caio viene arrestato e tratto a giudizio per omicidio volontario aggravato e rissa. Secondo e
Terzo vengono imputati per rissa aggravata, mentre Tizio e Sempronio sono rinviati a giudizio per rissa e
concorso cd. anomalo in omicidio volontario.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e Sempronio, premessi cenni sul cd. concorso anomalo,
rediga motivato parere.
1. La questione.
Il concorso anomalo configura un’ipotesi peculiare di concorso di persone ed è disciplinato
dall’art. 116 c.p., a mente del quale “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da
taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione
od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a
chi volle il reato meno grave”. La norma disciplina la punibilità del correo nolente a titolo di
concorso doloso anomalo, qualora taluno dei correi commetta un fatto di reato distinto
rispetto a quello originariamente programmato.
Per vero, all’indomani dell’introduzione della Costituzione, la norma ha posto non pochi
problemi in ordine alla sua compatibilità con il principio di personalità della responsabilità
penale, di cui all’art. 27 Cost.: difettando, infatti, il dolo del reato diverso in capo al correo, il
problema è quello di stabilire a che titolo tale delitto possa essere al medesimo imputato. Invero, il
legislatore ha definito tale questione, optando per una soluzione c.d. oggettivistica (qui
versari in re illicita), secondo cui l’evento va imputato per lo stesso titolo a ciascun concorrente
sulla sola base del contributo causale materiale; proprio tale conclusione, tuttavia, si scontra con i
dettami costituzionali, posto che la norma configurerebbe, in altri termini, una responsabilità
oggettiva, ormai del tutto espunta dall’ordinamento a seguito degli arresti della Corte
Costituzionale in tema (C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364; C. Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085).
Tanto premesso, dunque, la giurisprudenza ha cercato nel tempo di individuare il titolo in base al
quale il delitto commesso, diverso da quello originariamente programmato, possa essere imputato.
Nella ricerca di soluzioni interpretative corrette, la Corte Costituzionale ha sostenuto sin da
subito l’esigenza che, per evitare che la norma de qua fosse interpretata in termini di
183
Parte generale responsabilità oggettiva e come tale incostituzionale, “il reato diverso più grave commesso dal
concorrente” debba potere “rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e
concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto”
(C. Cost., 13 maggio 1965, n. 42). La Corte in particolare, nel respingere una doglianza di
illegittimità dell’art. 116 c.p. per contrasto con l’art. 27 Cost., ne affermava invece la compatibilità,
espungendola dall’ambito della responsabilità oggettiva, in ragione della necessaria “presenza
anche di un coefficiente di colpevolezza”.
Nella ricerca di soluzione interpretative corrette si è sostenuto che, ai fini della responsabilità del
correo, siano necessari, oltre all’adesione dell’agente ad un reato concorsualmente voluto e alla
commissione, da parte dell’altro correo, di un reato diverso e più grave, anche un nesso, materiale
e psicologico, fra l’azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e quello diverso
effettivamente commesso, che deve essere prevedibile, poiché logico sviluppo di quello
concordato, senza che l’agente l’abbia previsto effettivamente o ne abbia accettato il rischio, nel
qual caso tornerebbe ad operare l’ordinario regime della responsabilità a titolo di concorso pieno
(Cass., n. 9770/2014). In alcune pronunce, per vero ad oggi ancora isolate, la giurisprudenza ha
preteso, ai fini della sussistenza del concorso di cui all’art. 116 c.p, la prevedibilità in concreto del
reato diverso, da accertare tenuto conto di tutte le circostanze dell’azione, valutate secondo
l’esperienza dell’uomo medio.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
La pronuncia della Consulta, avendo solo precisato la necessità che tra soggetto agente ed evento
non voluto vi fosse una relazione di prevedibilità logica senza perimetrare il principio enunciato, ha
originato in giurisprudenza due filoni interpretativi, entrambi incentrati sul criterio della
prevedibilità, ma proteso, uno, ad affermarla in astratto e, l’altro, in concreto.
2.1. Il primo orientamento: Prevedibilità in astratto.
La giurisprudenza immediatamente successiva al decisum della Consulta (Cass. pen., 18
maggio 1994, Bilardo; Cass. pen., 7 aprile 1990, Siviero; Cass. pen., 2 ottobre 1989, Loddo; Cass.
9 dicembre 1985, Decembrino; Cass. 9 gennaio 1985, Carbone, 1985; Cass. 20 maggio 1983,
Cannas; nonché, di recente, Cass. pen., Sez. I, 30 dicembre 2011, n. 48726; Cass. pen., Sez. I, 23
settembre 2011, n. 3453) riteneva sufficiente accontentarsi di un nesso di prevedibilità solo
astratta.
1° Argomento: sufficienza della comparazione in astratto tra le norme incriminatrici.
La prevedibilità avrebbe dovuto essere accertata, appunto, in astratto, semplicemente
accostando i due modelli legali di reato, quello voluto e quello verificatosi, non voluto, senza
dover guardare alle concrete modalità di attuazione della condotta. In tal senso, la
giurisprudenza ha affermato la configurazione della fattispecie del concorso anomalo
qualora il reato diverso costituisca il logico sviluppo di quello concordato, sì da restare
escluso solo qualora il diverso e più grave reato commesso dal concorrente consista in un evento
atipico, del tutto eccezionale e imprevedibile.
184
Scheda di giurisprudenza n. 19 2.2. Il secondo orientamento: Prevedibilità in concreto.
Dalle critiche al precedente orientamento nasceva un secondo filone(Cass. pen., Sez. V, 6 agosto
2013, n. 34036; Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2012, n. 18383; Cass. pen., Sez. II, 6 marzo 2009,
n. 10098; Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 621; Cass. pen., Sez. V, 8 luglio 2009, n.
39339), a mente del quale la prevedibilità deve essere valutata in concreto.
1° Argomento: critica alla tesi della prevedibilità in astratto. Tale orientamento non
potrebbe essere condiviso poiché, essendo la valutazione della prevedibilità del tutto slegata dalle
concrete modalità di attuazione della condotta, non permette il superamento della
responsabilità oggettiva: l’interprete non sarebbe dunque in grado di comprendere se, nel
concreto e dunque sulla base degli elementi desumibili dal caso di specie, l’imputato fosse o meno
in grado di prevedere la verosimile verificazione del reato diverso da quello programmato,
commesso infine da correi. La prevedibilità astratta per tali ragioni non è tale da fondare un
rimprovero personale.
2° Argomento: necessità di accertare la prevedibilità in concreto. Solo una simile
interpretazione è tale da sganciare definitivamente l’art. 116 c.p. dal fantasma della responsabilità
oggettiva; subordinando l’applicazione della norma citata ad un accertamento in concreto,
diviene possibile dare il giusto peso alla concreta rappresentabilità, alla personalità
dell’imputato nonché alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l’azione, elementi,
questi, che non possono non rientrare nell’ambito di un giudizio di responsabilità.
Una valutazione della prevedibilità di tal fatta equivale, in altre parole, ad un giudizio di
colpa, motivo per cui, alcuni recenti arresti (ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 3 maggio 2010, n.
16762) subordinano tout court la responsabilità del concorrente anomalo alla colpa.
In particolare, il giudice di legittimità afferma così che “la responsabilità del compartecipe
per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro
concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha
previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre
configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non avendo
in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo
logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze
del caso concreto, della dovuta diligenza” (Cass. pen., Sez. V, 6 agosto 2013, n. 34036).
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Prevedibilità in
concreto.
La Suprema Corte, in un recente arresto (Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 9770;
confermato, poco dopo, da Cass. pen., Sez. II, 14 novembre 2014, n. 49486), ha preso posizione
in ordine alla questione, ribadendo la necessità che la valutazione della prevedibilità sia
effettuata in concreto ed affermando in tal senso che “si ha la responsabilità a titolo di
concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p., qualora sussista la volontà di partecipare con altri
alla realizzazione di un determinato evento criminoso ed allorché l’evento diverso e più
grave, pur costituendo il logico sviluppo del reato meno grave da lui voluto, secondo
l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, non sia stato da lui effettivamente previsto,
185
Parte generale al punto che, in ordine ad esso, non sia stato accettato il relativo rischio, posto che l’accettazione di
tale ultimo rischio avrebbe comportato il concorso pieno, di cui all’art. 110 c.p.; è altresì noto che la
prevedibilità dell’evento più grave deve essere valutata in concreto, tenendo conto della personalità
dell’imputato e delle concrete circostanze di fatto nelle quali si è svolta l’azione”.
La Cassazione sposa dunque la seconda opzione ermeneutica, facendo proprie le relative
motivazioni ed i capisaldi cui la giurisprudenza pregressa, per quanto recente, era già giunta.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che ben possa configurarsi a carico di Tizio e Sempronio l’imputazione di
concorso anomalo per omicidio volontario. Per vero, pur riguardando la questione direttamente solo Tizio, sia
costui che Sempronio erano a conoscenza della probabilità che Caio, in ragione del suo impiego di guardia
giurata e dati i propositi vendicativi dell’appuntamento con Primo, potesse portare con sé la pistola
d’ordinanza e, nel caso, farne uso. In ossequio, undici ai recenti arresti giurisprudenziali, l’imputazione
formulata a carico di Tizio e Sempronio non potrebbe che essere confermata.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 9770
Estratto
[...Omissis...]
1. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da V.J. J.L..
2. Con esso il ricorrente sostiene che nel suo comportamento non era ravvisabile la volontà di uccidere la
vittima.
Va al contrario rilevato che appare incensurabile nella presente sede, siccome immune da vizi logici e da
contraddizioni, la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere la sussistenza nel comportamento
tenuto dal ricorrente dell’elemento psicologico del dolo omicidiario.
Esso è stato correttamente qualificato dalla sentenza impugnata come dolo diretto, nella sua manifestazione
nota come dolo alternativo, che si ha quando, come nel caso in esame, l’agente prevede e vuole, con scelta
sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo
comportamento cosciente e volontario e cioè, nella specie, la morte ovvero il grave ferimento della vittima; e
la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il dolo diretto, nella sua qualificazione di dolo
alternativo, è compatibile con l’omicidio tentato (cfr., in termini, Cass. 1^ 20.10.97 n. 9949; Cass. 1^ 25.5.07
n. 27620).
3.1 giudici di merito hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario nel comportamento tenuto dal
ricorrente nei confronti della vittima, correttamente avendo valorizzato le concrete modalità della condotta
tenuta, avendo egli usato come strumento di offesa un coltello, strumento in sè idoneo a cagionare la morte;
avendo egli colpito la vittima con un solo preciso colpo in una zona del corpo ricca di organi vitali (addome
con lesione epatica, shock emorragico ed emitorace) ed avendo infine indugiato con il coltello ampliandone
in tal modo gli effetti lesivi; il che rafforzava il giudizio che si fosse trattato di azione voluta con forte
determinazione.
La motivazione addotta dai giudici di merito per ritenere la sussistenza, nel comportamento del ricorrente, del
186
Scheda di giurisprudenza n. 19 dolo omicidiario sotto la forma del dolo alternativo nei confronti di A.O. è pertanto pienamente condivisibile,
siccome immune da illogicità e contraddizioni (cfr., in termini, Cass. 2^ 23.5.07 n. 23419).
4. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso proposto dal V. nella parte in cui lamenta la mancata
concessione in suo favore dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, (avere risarcito il danno patrimoniale
arrecato alla vittima).
La giurisprudenza di legittimità è invero orientata nel senso di ritenere che il giudice ben può negare
l’attenuante della riparazione del danno, anche in presenza di una dichiarazione liberatoria della persona
offesa, purchè vengano esposte in modo specifico dal giudice le ragioni per le quali ritenga detta riparazione
inadeguata ed il risarcimento operato dall’imputato comunque insufficiente (cfr. Cass. Sez. 5 n. 26388 del
20/3/2013, Benzoni, Rv. 256322).
Sul punto la sentenza impugnata ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali non poteva ritenersi
esaustivo il risarcimento ricevuto dalla parte offesa nella misura di Euro 4.000,00 da parte di entrambi gli
imputati, siccome insufficiente per un completo ed adeguato ristoro del danno morale e delle sofferenze
arrecate alla vittima, essendo stata la stessa in pericolo di vita, avendo essa subito un difficile intervento
chirurgico ed avendo infine riportato una vistosissima cicatrice all’addome.
5. È invece fondato il secondo motivo di ricorso proposto dal V., nella parte in cui lamenta la mancata
concessione in suo favore dell’attenuante della provocazione, di cui all’art. 62 c.p., n. 2.
Sotto tale profilo esso è identico al secondo motivo di ricorso proposto dall’altro ricorrente R.M.A.F., si che
appare opportuna la loro trattazione unitaria.
È noto che, ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione, occorrono:
a) - uno stato d’ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso particolarmente
intenso ed irrefrenabile, tale da determinare la perdita dei poteri di autocontrollo e da ingenerare un forte
turbamento, caratterizzato da violenti impulsi aggressivi;
b) - un fatto ingiusto altrui, che può consistere non solo in un comportamento antigiuridico in senso stretto,
ma anche nell’inosservanza di norme sociali o di costume che regolano l’ordinaria convivenza civile;
c) - un rapporto di causalità psicologica fra l’offesa e la reazione, che può anche prescindere dalla
sussistenza di una proporzionalità fra la prima e la seconda (cfr. Cass. 5^ 13.2.04 n. 12558; Cass. 11.2.08 n.
9775).
Ora, nella specie i giudici di merito hanno escluso che l’azione delittuosa di entrambi i ricorrenti sia stata
determinata da un comportamento ingiusto tenuto dalla parte offesa, in quanto, pur avendo quest’ultima poco
prima dell’evento omicidiario sferrato un pugno sul viso di un altro loro congiunto, la vittima sarebbe stata a
sua volta in precedenza ferita al viso con una coltellata da persona appartenente al gruppo familiare dei due
imputati. Si sarebbe stato quindi in presenza di provocazioni reciproche, tali da escludere la sussistenza
dell’attenuante in esame.
Si osserva al contrario che, dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, è dato evincere che gli
atti ostili nei confronti della vittima sono stati posti in essere da un familiare dei due ricorrenti in un momento
di gran lunga anteriore a quello in cui la vittima ha a sua volta sferrato un pugno ad uno dei familiari dei due
ricorrenti, si da non potersi mettere in relazione diretta ed immediata con tale ultimo episodio, con la
conseguenza che non può negarsi, nella specie, avere la vittima compiuto, nell’immediatezza dei fatti, un
grave atto ostile nei confronti dei due ricorrenti, idoneo a determinare un loro stato d’ira valutabile ai fini della
concessione dell’attenuante in esame.
6. È infine infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente R.M.A.F. lamenta che i giudici di
merito lo abbiano ritenuto partecipe del reato di tentato omicidio di A.O., pur se con le modalità attenuate di
cui all’art. 116 c.p..
7. È noto che la giurisprudenza di legittimità ravvisa la responsabilità a titolo di concorso anomalo di cui
all’art. 116 c.p., ritenuto nella specie dai giudici di merito a carico del ricorrente, allorchè sussiste la volontà di
partecipare con altri a realizzare un determinato evento criminoso ed allorchè l’evento diverso e più grave,
pur costituendo il logico sviluppo del reato meno grave da lui voluto, secondo l’ordinario svolgersi e
187
Parte generale concatenarsi dei fatti umani, non sia stato da lui effettivamente previsto, si che, in ordine ad esso, non sia
stato accettato il relativo rischio, posto che l’accettazione di tale ultimo rischio avrebbe comportato il
concorso pieno, di cui all’art. 110 c.p.; è altresì noto che la prevedibilità dell’evento più grave deve essere
valutata in concreto, tenendo conto della personalità dell’imputato e delle concrete circostanze di fatto nelle
quali si è svolta l’azione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 39339 dell’8.7.09, Rv. 245152).
8. Fatte tali premesse, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione conforme ai canoni della logica e
priva di contraddizioni, ha correttamente ritenuto a carico del R. la sussistenza del concorso anomalo, di cui
all’art. 116 c.p., nel tentato omicidio di A.O., avendo rilevato come il medesimo avesse pur sempre fornito la
propria adesione all’evento criminoso di cui è causa, pur materialmente posto in essere dal coimputato V..
La Corte territoriale ha invero rilevato come il R., pur non avendo concertato la condotta con il V., ha pur
sempre bloccato con le braccia la vittima mentre era intenta a fuggire, consentendo al coimputato ed
esecutore materiale V. di raggiungere la vittima ed aveva continuato a trattenere la stessa pur essendo stato
in grado di percepire che il coimputato gli si stava avventando contro armato di un coltello, senza avere in
alcun modo impedito tale ultimo evento, ma anzi avendo agevolato l’esecutore materiale, avendo continuato
a tenere bloccata la vittima; ed il comportamento tenuto dal ricorrente, peraltro chiaramente desunto dalle
riprese di una telecamera ubicata in loco, correttamente è stato valutato dalla Corte territoriale nel senso che
egli, pur non avendo voluto contribuire alla tentata uccisione della vittima, aveva pur sempre avuto la
possibilità di prospettarsi il grave evento che si stava per verificare; invero, nella specie, la tentata uccisione
dell’A. non poteva essere ritenuta dal ricorrente un evento atipico ed imprevedibile, essendo stato egli
consapevole che il coimputato V. stesse, nella contingenza, per avventarsi sulla vittima armato di un
micidiale coltello.
9. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza, limitatamente alla mancata
concessione dell’attenuante della provocazione, con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Genova in diversa
composizione affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’appello proposto sul punto da
entrambi i ricorrenti, tenendo presenti le considerazioni sopra svolte.
10. Il ricorso di entrambi i ricorrenti va invece respinto nel resto.
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. V, 6 agosto 2013, n. 34036
Estratto
[...Omissis...]
1. Il primo motivo di ricorso delle parti civili, concernente il mancato riconoscimento, agli effetti civili, del
delitto di rissa, è infondato.
La Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, ha escluso la sussistenza
degli elementi costitutivi del reato contestato, che si realizza in presenza di una violenta contesa fra tre o più
persone tutte animate dall’intento di recare offesa agli avversari (Sez. 5, n. 2517 del 13/01/1984, Tovaglieri,
Rv. 163222).
A tale conclusione è giunta, sottolineando che nessuno dei testi escussi aveva descritto l’accaduto in modo
che potesse configurarsi siffatta contesa, dal momento che il C. e lo S., quali che fossero le loro intenzioni,
improvvisamente aggrediti, si erano dati alla fuga, senza aver posto in essere alcuna reazione.
Le critiche dei ricorrenti non colgono nel segno. Escluso che la precedente sentenza di questa Corte
pregiudichi in alcun modo la soluzione della questione demandata al rinnovato esame del giudice del rinvio,
va rilevato: a) che la censura concernente il carattere meramente congetturale dell’affermazione relativa alla
pretesa mancanza di un’aggressione reciproca, non può essere fondata sulle conclusioni raggiunte dalle
precedenti sentenze di merito, giacchè l’annullamento disposto dalla I sezione comportava la necessità per i
188
Scheda di giurisprudenza n. 19 ricorrenti di valorizzare piuttosto e in modo specifico le risultanze istruttorie acquisite, a proposito delle quali
va, invece, segnalato, sul punto oggetto di discussione, un assoluto silenzio; b) che lo stesso deve dirsi a
proposito della ritenuta arbitrarietà dell’affermazione secondo cui nessuno dei testi escussi aveva descritto
l’accaduto in modo tale da poter configurare una rissa, giacchè non vengono indicati gli atti istruttori dai quali
emergerebbe la denunciata arbitrarietà della conclusione della sentenza impugnata; c) che, una volta preso
atto della fuga dello S. e del C., l’uso della pistola da parte del M. esprime solo l’esito del confronto tra questi
e il D. B., non essendo più dato ravvisare, con riguardo al concreto episodio accertato dal giudice di merito,
la presenza di gruppi contrapposti (Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fiorillo, Rv. 253107).
2. Del pari infondati sono il ricorso del P.M. e il secondo motivo del ricorso delle parti civili, con riferimento
all’altro reato contestato allo S. e al C.. Poichè le critiche sono sostanzialmente articolate attorno alla
violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio e della disciplina in tema
di concorso anomalo, violazione colta anche, sotto il profilo motivazionale, nella base obiettiva
dell’accertamento dei fatti considerati, occorre rilevare quanto segue. È certamente condivisibile
l’interpretazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, secondo cui la Corte di cassazione risolve una questione di
diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicchè il giudice di rinvio, pur
conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al
punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o
esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata
valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012 - dep. 15/02/2013, Scavetto, Rv.
254830).
Così come, peraltro, va ribadito che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello
concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod.
pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave,
mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in
concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile
dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta
diligenza (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011 - dep. 01/02/2012, Camko, Rv. 251849). E, peraltro, la necessaria
individuazione di quest’ultimo coefficiente di imputazione soggettiva dell’evento, imposta da una lettura
coerente con l’art. 27 Cost. (v. già Corte cost. 13 - 31/05/1965, n. 42), comporta la verifica della sussistenza
di un nesso non solo causale ma anche psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato
meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione
in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la
prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto,
valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l’azione (Sez. 5, n.
39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152).
Proprio in tale cornice interpretativa di riferimento si è mossa la sentenza impugnata, la quale, valutando le
circostanze del caso concreto, è giunta alla conclusione, non manifestamente illogica, che lo S. e il C.
confidavano nel fatto che il M. non avrebbe utilizzato la pistola, come aveva loro garantito e che, in ultima
analisi, non era possibile pervenire, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla conclusione della presenza del
necessario elemento di rappresentazione psichica dell’evento, sia pure nei termini sopra ricordati.
La Corte territoriale, a tal proposito, ha in sintesi considerato: a) che agli occhi dei due imputati la detenzione
dell’arma era giustificata dalla successiva attività lavorativa del M.; b) che il contesto di amicizia e di
conoscenza risalente tra i giovani rappresentava sufficiente motivo per tranquillizzare i due imputati, in ordine
al fatto che il M. avrebbe usato l’arma a scopo meramente difensivo o intimidatorio.
Quest’ultima espressione, peraltro, proprio nel contesto della discussione ricostruita dalla Corte d’assise
d’appello, non indica un progetto di positiva prospettazione di un male ingiusto, ma si inserisce sempre,
come mera eventualità, nel contesto difensivo ragionevolmente immaginato da persone che desideravano
frequentare pacificamente un luogo. Ed, infatti, al di là dell’espressione di sintesi adoperata a pag. 11 della
189
Parte generale sentenza, il contenuto della discussione, riportato a pag. 9 della medesima decisione, vede il M. affermare
che avrebbe, in caso di necessità, usato l’arma per esplodere colpi in aria e solo a scopo difensivo.
Del resto, che siffatto affidamento fosse ragionevole nel caso concreto si desume, a posteriori, anche dal
fatto che il M., vedendo il D.B. venirgli incontro imperterrito, esplose effettivamente alcuni colpi in aria (pag.
10 della sentenza impugnata), salvo poi inopinatamente perdere il controllo e indirizzare l’arma verso la
vittima.
La Corte territoriale, sempre in questa prospettiva, ha preso in considerazione la presenza di una mazza,
condotta forse dal C. sul luogo dell’appuntamento, ma ha valorizzato, con un’argomentazione priva di
qualunque illogicità, il fatto che fosse nascosta, per sottolineare il mero intento di proteggere la propria
incolumità e giammai di mettere a repentaglio quella altrui.
In tal modo colto il percorso motivazionale della sentenza impugnata, si deve concludere anche per
l’insussistenza della prospettata violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3 dal momento che le considerazioni
svolte affrontano nella sostanza il tema dell’astratto pericolo della degenerazione, ma lo escludono in
concreto - e in concreto, come s’è visto, va operata la prognosi postuma imposta dall’art. 116 cod. pen., alla
luce delle rassicuranti affermazioni del M. e della ragionevolezza dell’affidamento in esse riposto dai due
imputati.
Talchè, anche sotto tale profilo, viene a mancare il necessario elemento dell’inosservanza delle regole di
prudenza che giustifica la responsabilità per il reato diverso.
D’altra parte, il fatto che i due imputati avrebbero potuto astenersi dal recarsi all’appuntamento, sapendo che
il M. aveva con sè un’arma, non incide sulla soluzione della questione che si esamina, in quanto non
esclude, di per sè, comunque, la ragionevole certezza dei primi che la pistola non sarebbe stata usata.
3. Alla decisione di rigetto consegue la condanna di ciascuna delle parti civili al pagamento delle spese
processuali.
[...Omissis...]
190
PARTE SPECIALE
Parte speciale Scheda di giurisprudenza n. 20
Rapporti fra gli artt. 270 e 270 bis c.p. - Aggravante della finalità di terrorismo
TRACCIA
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio furono riconosciuti colpevoli, in primo grado, con sentenza della Corte di
assise di Milano del 13.6.2009, del delitto di cui all’art. 306 c.p., commi 1, 2, 3, in relazione all’art. 270 bis c.p.
(associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, denominata Partito Comunista
Politico Militare, PCPM, mediante costituzione di banda armata) (capo A), con l’aggravante della finalità
terroristica di cui all’art. 1 l. 15/1980, nonché di una serie di ulteriori reati.
La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna per il capo A, nella forma aggravata
dall’aggravante sopra indicata. Nelle motivazioni della sentenza, tuttavia, non è stato chiarito con quali
modalità le azioni progettate o solo ideate (il ferimento di OMISSIS, l’attentato ad OMISSIS, il
danneggiamento dello sportello OMISSIS, o dei Magazzini OMISSIS, o della sede del giornale OMISSIS)
avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione. Si sarebbe trattato di azioni violente con riconoscibili finalità
eversive, di azioni dirette contro l’ordine costituzionale, ma non è rimasto accertato se la violenza
programmata sarebbe stata “qualificata” da modalità terroristiche oppure no.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, proponga ricorso per cassazione.
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito, risolta da un intervento chiarificatore della Corte di legittimità, di
cui a breve si darà contezza, involge due aspetti differenti ma legati fra di loro: la Cassazione si è
occupata, infatti, da un lato, di tracciare la linea di discrimen che corre fra la fattispecie di cui
all’art. 270 c.p., “Associazioni sovversive”, e quella di cui all’art. 270 bis c.p., “Associazioni con
finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”, e, dall’altro, di
verificare l’applicabilità dell’aggravante della finalità di “eversione dell’ordine democratico”,
prevista dall’art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertita dalla l. 6 febbraio 1980, alle ipotesi
delittuose citate.
Invero, soprattutto per quel che concerne la prima questione, la turbolenta evoluzione legislativa
dell’ultimo decennio subita dalle norme ne ha modificato considerevolmente sia la struttura
che la portata. Val la pena brevemente premettere alla disamina della tematica de qua gli
interventi succedutesi nel tempo.
L’art. 270 bis c.p. subisce una prima modifica nel 2001, l. n. 374, in virtù della quale alla finalità
eversiva viene affiancata quella, alternativa, terroristica, ampliando così la portata della
norma anche alle ipotesi di associazioni sorrette da uno scopo terroristico nei confronti di
uno stato estero; la finalità eversiva era infatti integrata solo qualora fosse rivolta nei confronti
dell’ordinamento costituzionale italiano.
Nel 2005, la l. n. 15 ha introdotto l’art. 270 sexies c.p., con il quale vengono definite
espressamente le condotte con finalità di terrorismo: in maniera inequivoca, la disposizione
stabilisce che devono intendersi connotate dalla finalità di terrorismo le condotte che per la loro
natura o contesto possono arrecare grave danno a un Paese o ad un’Organizzazione
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici,
192
Scheda di giurisprudenza n. 20 o l’Organizzazione internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto; che
possono destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche
e sociali di un Paese o di un’Organizzazione internazionale; che siano definite terroristiche o
commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti
per l’Italia.
Con la l. n. 85/2006, infine, il legislatore è intervenuto sull’art. 270 c.p., introducendo, da un lato, il
requisito della idoneità dell’organizzazione a raggiungere il proprio obiettivo sovversivo e,
dall’altro, modernizzando le finalità dell’associazione sovversiva: a tal fine, le finalità di
“sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato” e di “sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato” hanno preso il posto delle
previgenti finalità di “stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre” e di
“sopprimere violentemente una classe sociale”.
2. I rapporti fra gli artt. 270 e 270 bis c.p.
Come emerge dal brevissimo quadro normativo tracciato, il distinguo fra le ipotesi di cui agli artt.
270 e 270 bis c.p. si rivela non facile.
La tesi maggioritaria in giurisprudenza (ex multis, Cass. pen., Sez. I, 3 febbraio 1983; Sez. I, 4
novembre 1987), antecedente alla novella del 2001, riteneva che l’art. 270 bis c.p. avesse un
ambito di applicazione più ampio rispetto al delitto di cui all’art. 270 c.p., in ragione della
limitazione di quest’ultimo ai fatti commessi sul territorio nazionale. Per altro, pur essendo
annoverato fra gli elementi costitutivi di entrambe le norme incriminatrici il requisito dell’uso dei
mezzi violenti, cionondimeno la fattispecie di cui all’art. 270 bis c.p. veniva delineata in termini di
specificità rispetto all’art. 270 c.p.: la diversità fra i due delitti veniva infatti ravvisata nell’oggettività
giuridica. Mentre la prima norma infatti mira ad impedire la soppressione degli ordinamento politici
e giuridici della società, la seconda disposizione è volta invece ad impedire “solo” l’eversione
dell’ordine democratico, qualificandosi dunque in termini di maggiore genericità. Per tale ragione,
veniva altresì esclusa a configurabilità di un concorso fra i due delitti.
Tale conclusione veniva ribadita anche a valle della modifica del 2001: un concorso non
sarebbe stato comunque ravvisabile fra le norme in esame attese le finalità distruttive della
condotta propria di entrambi i delitti, evenienza che lascia intravedere, invece, un rapporto di
progressione, in ragione del quale la fattispecie più grave, ossia l’associazione con finalità di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.),
impedisce la configurabilità dell’associazione sovversiva (art. 270 c.p.), assorbendola (Cass.
pen., Sez. II, 20 aprile 2004, n. 18339).
La modifica del 2006 ha reso tali arresti ancora più evidenti in ragione della nuova
formulazione dell’art. 270 c.p., che ha reso la finalità eversiva contemplata all’artt. 270 bis c.p.
ancora più specifica rispetto a quella della prima norma, atteso che non è possibile attuare le
finalità cui l’associazione sovversiva di cui all’art. 270 bis c.p. è tesa senza coinvolgere
anche l’ordine democratico.
2.1. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: il discrimen fra
gli art. 270 e 270 bis c.p. deve essere individuato nella natura della
193
Parte speciale violenza utilizzata per perseguire il fine
La Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2012, n. 12252) ha preso posizione in tema,
affermando che deve essere riconosciuta perfetta identità fra il fine di “sovvertire violentemente gli
ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero [di] sopprimere violentemente
l’ordinamento politico e giuridico dello Stato”, previsto dall’art. 270, e il fine di “destabilizzare o
distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese”,
previsto dalla norma definitoria di cui all’art. 270 sexies come caratterizzante il concetto di
terrorismo. Per tale ragione, la Corte ritiene che, escluso che la differenza fra le fattispecie
delittuose di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p. risieda nel fine perseguito, il discrimen vada
individuato nella natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per cui l’associazione
è costituita: “la fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis c.p. è speciale rispetto a
quella di associazione sovversiva di cui all’art. 270 c.p. in quanto la natura della violenza che il
sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica”.
1° Argomento: nozione di terrorismo. Attesa la qualificazione di comune violenza
richiamata dall’art. 270 c.p. e di violenza terroristica richiamata dall’art. 270 bis c.p., la Corte
precisa che il terrorismo, pur venendo configurato in termini di finalità sia dall’art. 270 bis c.p. che
dall’art. 280 c.p. o come scopo dall’art. 289 bis c.p., “funge da strumento di pressione, da metodo di
lotta, da modus operandi particolarmente efferato” caratterizzato dall’”uso indiscriminato e
polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli ‘effetti collaterali’ della violenza diretta [...]
ma anche perché ess[o] può essere rivolt[o] in incertam personam, proprio per generare panico,
terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni
a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato”.
Non va dimenticato che, a tal proposito, tale indirizzo è stato confermato anche dalla
giurisprudenza successiva (Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2013, n. 46340) che, ribadita la distinzione
delle fattispecie de quibus in ragione del tipo di violenza esercitato, ha ulteriormente affermato che
“per quanto attiene alla distinzione tra art. 270 c.p. (associazioni sovversive) e 270 bis c.p.
(associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico),
il discrimine non sta nell’oggetto della tutela - nel primo caso gli ordinamenti politici e giuridici,
come veicolati dai canali della rappresentanza, nel secondo caso l’ordine democratico più
sistemicamente inteso -, sta, invece, nella diversa struttura delle norme, in primis. Infatti, mentre il
reato di associazioni sovversive ex art. 270 c.p. punisce la costituzione di organizzazioni dirette ed
idonee alla sovversione degli ordinamenti politici e sociali, nel caso della più recente fattispecie,
l’art. 270 bis c.p., opera una più accentuata regressione della punibilità del vincolo associativo fino
allo stato della presunzione del pericolo per l’ordinamento democratico - tipica struttura del reato a
pericolo presunto”.
3. L’aggravante della finalità di terrorismo.
La seconda questione affrontata dalla Corte involge la configurabilità dell’aggravante della
finalità di eversione dell’ordine democratico, prevista dall’art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito dalla l. 6 febbraio 1980, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p.
194
Scheda di giurisprudenza n. 20 3.1. Il primo e minoritario orientamento: Configurabilità
dell’aggravante della finalità di eversione dell’ordine democratico anche
in relazione agli artt. 270 e 270 bis c.p.
Per un primo orientamento (Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2006, n. 2310), l’aggravante de qua
è configurabile anche in relazione alle norme in esame.
1° Argomento: interpretazione dei termini “eversione” e sovversione”. Invero, il
concetto di eversione non abbraccia un solo evento, ma diverse fattispecie; le parole
“sovversione” ed “eversione” possono prima facie essere considerate equivalenti pur non
essendolo. Va infatti considerato che “etimologicamente (…) sovversione significa rivolgimento,
sconvolgimento mentre la parola eversione significa deviazione, spinta al di fuori”.
3.2. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Inconfigurabilità
dell’aggravante della finalità di eversione dell’ordine democratico anche
in relazione agli artt. 270 e 270 bis c.p.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2012, n.
12252), negli ultimi anni, si è invece assestata nel ritenere l’aggravante in parola
incompatibile con i delitti ex artt. 270 e 270 bis c.p.
1° Argomento: analisi degli elementi costitutivi degli artt. 270 e 270 bis c.p.. Tale
incompatibilità è imposta sol se si pensa che, attesa l’appartenenza della violenza terroristica
alla struttura dell’art. 270 bis c.p., il medesimo elemento non può essere considerato anche
come circostanza aggravante dello stesso.
Lo stesso è a dirsi in relazione all’associazione sovversiva, perché se la violenza di cui
all’art. 270 c.p. avesse connotazioni terroristiche, dovrebbe trovare applicazione, in ragione di
quanto prima affermato, l’art. 270 bis c.p., rispetto al quale, come detto, l’aggravante non
configurabile.
In definitiva, l’aggravante de qua è inapplicabile sia al delitto di cui all’art. 270 bis c.p.,
poiché ne è elemento costitutivo, sia al delitto di cui all’art. 270 c.p., integrando proprio quel quid
pluris che costituisce la nota di specialità che distingue i due delitti associativi.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene di poter consigliare a tizio la favorevole proposizione di ricorso per Cassazione.
In ossequio9 alla giurisprudenza di legittimità recente, infatti, l’aggravante della finalità di terrorismo è
inconfigurabile in presenza dell’integrazione del delitto di cui all’art. 270 c.p., parimenti contestato
all’imputato.
Al ricorso per Cassazione, dunque, potrebbe quasi scuramente conseguire la cassazione della sentenza ed il
rinvio al giudice per definire la pena in termini maggiormente rispettosi del dettato normativo.
195
Parte speciale LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2012, n. 12252
Estratto
[...Omissis...]
Naturalmente, si deve fare riferimento all’assetto normativo dell’epoca: l’art. 270 c.p. reprimeva le condotte di
quelle strutture associatile costituite per stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull’altra,
ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, ovvero ancora a sovvertire, sempre violentemente, gli
ordinamenti economici e sociali, giuridici, politici dello Stato, o meglio, come si esprimeva la lettera della
legge “ogni ordinamento”. La specificità della norma, dunque, discendeva dalla specificità dell’obiettivo che si
proponevano gli agenti, atteso che l’art. 270 bis, viceversa, puniva chi, costituendosi in associazione, mirava
alla eversione -genericamente, appunto- dell’ordine democratico. Le distinzioni intraviste dalle due ricordate
sentenze, già di per sè (a giudizio di questo Collegio) non del tutto soddisfacenti (non appare del tutto chiara,
nel caso di specie, la contrapposizione genericità/specificità, atteso che anche l,a formula dell’art. 270
appare, a ben vedere, onnicomprensiva, nè si riesce a ipotizzare come si possa sopprimere un ordinamento
politico senza avere, per lo meno, in progetto un’alternativa, fosse pure quella anarchica), devono comunque
ritenersi “superate” alla luce delle modifiche legislative intervenute, che hanno completamente ridisegnato
entrambi gli articoli: il D.L. n. 374 del 2001, conv. in L. n. 438 del 2001: “Disposizioni urgenti per contrastare il
terrorismo internazionale”, la L. n. 85 del 2006: “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”,
ma -principalmente- ad opera del D.L. n. 144 del 2005, conv. in L. n. 15 del 2005, che, introducendo l’art. 270
sexies c.p., ha definito le “condotte con finalità di terrorismo”.
In realtà la “finalità di terrorismo” aveva già fatto la sua comparsa nell’art. 280 c.p. (“Attentato con finalità
terroristiche o di eversione”, aggiunto dal D.L. n. 625 del 1979 conv. in L. n. 15 del 1980, con il connesso art.
280 bis: “Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, come sostituito dalla L. n. 85 del 2006), così
come era stato introdotto nell’ordinamento lo “scopo di terrorismo”, con l’art. 289 bis c.p. (ad opera del D.L. n.
59 del 1978, conv. in L. n. 191 del 1978); al proposito, la giurisprudenza - certamente risalente e in contrasto,
per altro, con autorevole dottrina- ribadiva la distinzione tra la finalità di terrorismo e quella di eversione
dell’ordinamento costituzionale, che qualificano il sequestro di persona (art. 289 bis), divenendone elemento
costitutivo, e devono muovere l’azione del soggetto, della quale il terrorismo o l’eversione costituiscono il
particolare obbiettivo (ASN 198703130-RV 175352). La successiva definizione codicistica (anno 2005),
tuttavia (art. 270 sexies, appunto), che recepisce, sul punto, le indicazioni emerse in sede sovrannazionale
(Convenzione di New York 8.12.1999, ratificata con L. n. 7 del 2003, Decisione-quadro del Consiglio
d’Europa n. 164 del 22.6.2002, cfr. ASN 200535427-ftV 232280), è inequivoca, stabilendo che devono
intendersi connotate dalla finalità di terrorismo quelle condotte:
1) che “per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a una Organizzazione
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici, o
un’Organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto”;
2) che possono “destabilizzare, o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e
sociali di un Paese o di un’Organizzazione internazionale;
3) che siano “definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di
diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.
Dunque, la condotta terroristica ha rilevanza penale in sè;
tuttavia, quando è tenuta allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra indicati al n. 2
(destabilizzazione/distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e/o socio-economici di uno Stato), fa
“corpo unico” con tale finalità. Ma tale opera di destabilizzazione/distruzione, ovviamente, altro non è che la
sovversione o eversione violenta di cui all’art. 270 c.p. (il sottile “distinguo” etimologico che opera la Corte
196
Scheda di giurisprudenza n. 20 territoriale di secondo grado non pare, francamente, incidente). Invero, tale articolo descrive la condotta
come diretta ad attentare agli ordinamenti economici o sociali del nostro Stato, ovvero a sopprimere il suo
ordinamento politico e giuridico.
Orbene, posto che il mutamento di tali assetti non è -in sè- vietato, a tanto ostando il dettato dell’art. 49 Cost.,
ciò che fa “scivolare” la sovversione nel campo del penalmente rilevante è la violenza (“sovvertire
violentamente” per l’art. 270 c.p., “compimento di atti di violenza” per l’art. 270 bis c.p.), vale a dire, per usare
ancora le parole del Costituente, l’utilizzo di un metodo non democratico, connotandosi come violenza
generica, nel primo caso (art. 270), violenza terroristica, nel secondo (art. 270 bis).
A parere di questo Collegio, invero, quella sopra riportata è l’unica interpretazione che possa giustificare il
permanere nell’ordinamento dell’art. 270 c.p., dopo l’introduzione dell’art. 270 bis e il loro “rimaneggiamento”
ulteriore.
L’art. 270 bis c.p., infatti, come è noto e come anticipato, trova applicazione, tanto nella sfera internazionale
(tutelando gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali, cfr. comma secondo), quanto nella sfera interna
(è collocato nel libro 2, titolo 1, “delitti contro la personalità dello Stato”) ed in tale sfera sembra, ad una prima
lettura, sovrapporsi al più antico art. 270, entrambi delitti contro la personalità internazionale dello Stato.
Invero, sempre rimanendo nella “sfera interna”, a parte l’ampliamento dell’elenco dei soggetti punibili (viene
prevista la figura del finanziatore, che non è presente tra i soggetti di cui all’art. 270), si rileva che la
fattispecie introdotta posteriormente anticipa la soglia della punibilità e si connota, a sua volta, come delitto di
pericolo presunto, volendo reprimere la condotta di chi costituisca, organizzi ecc. associazioni che si
“propongano” il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione, mentre l’art. 270 c.p.
richiede, per la punibilità, che dette associazioni siano non solo “dirette”, ma anche “idonee” a sovvertire violentemente - l’ordinamento. Si tratta, in ultima analisi, per quel che riguarda la ipotesi criminosa ex art. 270
c.p., dello schema di cui all’art. 56 c.p. (inequivocità e idoneità degli atti); laddove la “nuova” norma
incriminatrice (art. 270 bis c.p.) punisce, come si è appena anticipato, il “proposito” (ASN 200624994- RV
234345), sempre che, si intende, esso non sia stato in mente retentun (altrimenti ci si avvicinerebbe
pericolosamente alla figura del “tipo d’autore”), ma abbia già dato luogo a una struttura associativa, costituita
proprio allo scopo di attuare detto proposito, con atti di violenza “qualificata” (ASN 200003486-RV 216253).
Ma, appunto la maggiore ampiezza della previsione ex art. 270 bis potrebbe determinare, anche per questo
verso, la “scomparsa” della fattispecie ex art. 270 c.p., “scomparsa”, tuttavia, che il Legislatore non ha
decretato, con la conseguenza che compete all’interprete individuare il confine tra le due disposizioni
normative. Come si diceva, tale discrimen non può che essere individuato nella natura della violenza
utilizzata: generica o terroristica. Il terrorismo, invero, anche se qualificato come “finalità” (artt. 270 bis e 280)
o come “scopo” (art. 289 bis) nel codice penale, non costituisce, in genere, un obiettivo in sè, ma,
ovviamente, funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente
efferato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l’avversario o
riferibili allo stesso, per imporre a quest’ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe
accettato.
Per tale ragione, non si concorda con quella giurisprudenza (ad es.
ASN 198711382-RV 17694) che, rispettando alla lettera il dato testuale, ritiene concettualmente distinti e
fattualmente sempre distinguibili la “finalità” di terrorismo e quella di eversione.
A ben vedere, infatti, solo la seconda - lo si ribadisce - rappresenta un obiettivo, mentre il primo costituisce
un mezzo, o più correttamente, una strategia, che si caratterizza per l’uso indiscriminato e polidirezionale
della violenza, non solo perchè accetta gli “effetti collaterali” della violenza diretta (ASN 200831389-RV
2411745), ma anche perchè essa può essere rivolta in incertam personam, proprio per generare panico,
terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o
tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato.
La repressione del terrorismo, in campo internazionale, risponde a una finalità di tutela dello status quo nei
rapporti tra Stati e tra questi e Organizzazioni internazionali (ovviamente il giudice italiano non può e non
197
Parte speciale deve esprimersi sul sistema politico - istituzionale di uno Stato estero cfr. ASN 200336776-RV 226049);
nella sfera interna, viceversa, rappresenta una “difesa avanzata” dell’ordine democratico (da intendersi come
ordine costituzionale, in base all’interpretazione autentica fornita dalla L. n. 304 del 1982, art. 11).
Al proposito, la giurisprudenza (ASN 200839504- RV 241859) ha chiarito che non qualsiasi azione politica
violenta può farsi rientrare nel concetto di eversione, previsto dal codice penale, ma solo quella che miri al
sovvertimento dei principi fondamentali, che formano il nucleo intangibile dell’assetto ordinamentale.
La maggiore dannosità, il più intenso allarme sociale, il più grave pericolo che rappresenta la violenza
terroristica per gli assetti istituzionali giustificano una più severa repressione della stessa, rispetto alla
generica violenza eversiva (ex art. 270 c.p.).
Il nucleo del problema, dunque, non si identifica con la contrapposizione tra concretezza e attualità della
condotta pericolosa, da un lato, e mera progettualità o potenzialità della stessa, dall’altro, come si adombra
nella censura sub 24). Si è già detto, infatti, che trattasi di reati di pericolo presunto, richiedendosi, in un
caso, la inequivocità e la idoneità dei mezzi predisposti dalla associazione sovversiva (art. 270 c.p.),
nell’altro, la serietà del proposito eversivo da perseguirsi con atti di terrorismo, in vista dei quali la societas
contro fegem è stata costituita.
La differenza, si ripete, consiste, per questo Collegio, nella natura della violenza che si intende esercitare
(terroristica o “comune”).
E, da questo punto di vista, sono le censure sub 25) e 26) -relative alla corretta interpretazione del dettato
dell’art. 270 sexies - quelle che “aprono la strada” all’accoglimento della censura sub 24) e, in parte qua, di
quella sub 53).
Ne deriva, per altro, la inaccoglibilità della censura sub 31).
Per tutto quanto sopra scritto, è evidente che il programma del PCPM era attuale, anche se non attuato, o
per meglio dire, in parte aveva cominciato ad esserlo, posto che il tentativo di scassinamento del bancomat
in (OMISSIS), i prodromici furti di autovetture e targhe, la predisposizione di “inchieste”, il procacciamento e il
collaudo delle armi stanno chiaramente a provare che lo stadio della mera progettualità o, addirittura, della
semplice ideazione, era stato di gran lunga superato.
Tutto ciò premesso, sarebbe stato necessario accertare se la associazione di cui al capo A), che certamente
aveva l’intenzione e la capacità di esercitare la violenza, anche con uso di armi, aveva anche intenzione e
possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel senso dell’art. 270 sexies c.p.) per conseguire il suo programma
di eversione dell’ordine costituzionale, vale a dire, doveva essere chiarito se, nei suoi programmi e nei suoi
effettivi progetti, rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l’intenzione di
esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti
istituzionali nel nostro Paese.
Non è stato sufficientemente chiarito che cosa si dovesse intendere per “propaganda armata”, che figura
nelle linee programmatiche del PCPM: se essa dovesse essere rivolta esclusivamente verso obiettivi “di
elezione”, in modo da ottenere un effetto paradigmatico, innestando magari meccanismi di emulazione,
oppure se si volesse, a tutti i costi, raggiungere determinati risultati di destabilizzazione, accettando anche il
rischio di vittime collaterali, o se, addirittura, si volesse colpire indiscriminatamente la popolazione, per
suscitare terrore, panico e insicurezza.
A pag. 151 della sentenza si legge che era intenzione degli associati “educare le masse” alla lotta armata
contro lo Stato borghese, ottenendo, come risultato finale, la “insurrezione armata dei proletari”. Tutto dò
premesso, però, continua la sentenza, gli imputati esprimevano ferme critiche sulla “deriva militarista”, che
aveva caratterizzato la storia delle BR. Essi attendevano il maturarsi della crisi del sistema capitalistico, crisi
da sfruttare in una prospettiva eversiva, che doveva essere conseguita attraverso una “guerra popolare
prolungata”.
Orbene, non è stato chiarito con quali modalità le azioni progettate o solo ideate (il ferimento di S., l’attentato
ad I., il danneggiamento dello “Sportello Biagi”, o dei “Magazzini Alcom”, o della sede del giornale
“(OMISSIS)”) avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione. Si sarebbe trattato, senza dubbio, di azioni
198
Scheda di giurisprudenza n. 20 violente con riconoscibili finalità eversive, di azioni dirette contro l’ordine costituzionale, ma, per quel che si è
detto, non è rimasto accertato se la violenza programmata sarebbe stata “qualificata” da modalità
terroristiche, oppure no.
Nè soccorre la coesistenza, all’interno del medesimo capo A) del delitto di banda armata ex art. 306 c.p.,
posto che esso si pone (può porsi) pacificamente in concorso, tanto con il delitto di cui all’ari 270, quanto con
quello di cui all’art. 270 bis c.p. (ASN 198711382-RV 176945). Invero, l’uso della violenza, che si esprima
attraverso la progettazione/realizzazione di reati contro la personalità dello Stato e che sia accompagnata
dalla concreta disponibilità di armi, integra entrambe le fattispecie criminose (art. 306, da un lato, art. 270 o
art. 270 bis, dall’altro), che si pongono in rapporto, non di genere a specie, ma di mezzo a fine (ASN
200737119-RV 237768).
Quanto alla struttura della banda armata, è stato chiarito (ASN 199203744- RV 189716) che tale reato si
qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o
internazionale dello Stato, nonchè per la organizzazione in banda e la disponibilità di armi; non è però
richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato,
essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli
associati. In tal senso, la censura sub 53) ( Ga.) è da rigettare, nella parte in cui assume la insussistenza del
delitto ex art. 306 c.p. e “propone” che siano rimaste integrate le minori ipotesi ex artt. 304 e 305 c.p..
Parimenti da rigettare è la censura sub 27). Si è già detto del rapporto strumentale tra la fattispecie ex art.
306 c.p. e quelle ex artt. 270 e 270 bis c.p. (come, d’altra parte, si deduce chiaramente dallo stesso dettato
dell’art. 306). Non può dunque ragionevolmente sostenersi che la societas contro legem, sia il mero
presupposto cronologico della banda armata, atteso che detta banda è costituita allo scopo di ottenere, con
l’uso delle armi, gli scopi per i quali sono costituite le strutture ex artt. 270 e 270 bis c.p.. In ordine alla
esistenza di una gerarchia interna, si è già detto.
E allora, tornando al problema della distinzione tra associazione sovversiva e associazione con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, deve concludersi che non è stato compiutamente (e
correttamente) sciolto il nodo della esatta qualificazione giuridica del delitto del capo A), atteso che, ferma
restando la imputazione di banda armata, si deve chiarire se la stessa sia strumentale rispetto al delitto di cui
all’art. 270 c.p. o di quello ex art. 270 bis c.p..
Sul punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendosi estendere l’annullamento, per la
comunanza delle posizioni, anche a T. e Sc..
Da tutto quanto premesso, discende, a mò di corollario, la manifesta infondatezza della censura sub 28).
Poichè i delitti associativi sussistono indipendentemente dalla esecuzione dei delitti-fine, non ha alcun senso
soffermarsi sulla natura -preparatoria, esecutiva o consumativa- di detti delitti.
La reciproca autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello di cognizione (da ultimo, ASN
201120160-RV 250278) comporta che gli stessi possano essere instaurati anche parallelamente e che
parallelamente possano avere sviluppo.
Va da sè che, in presenza di meri atti preparatori, troverà applicazione la sola misura di prevenzione, ma, se
detti atti siano riducibili a una struttura organizzata, resteranno integrati i reati associativi configurabili nel
caso di specie.
Per quel che riguarda la c.d. aggravante di terrorismo (L. n. 15 del 1980, art. 1) e la sua compatibilità con i
delitti contestati, si possono prendere le mosse dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, la quale ebbe
ad affermare (ASN 199803241-RV 210681), che, non essendo il terrorismo elemento costitutivo della
fattispecie ex art. 270 bis c.p., l’aggravante in questione ben poteva essere contestata in relazione alla
predetta figura criminosa.
E tuttavia, proprio tale considerazione, rende evidente che, una volta modificato l’art. 270 bis c.p. (ad opera,
come si è visto della L. n. 438 del 2001), una volta, vale a dire, che la violenza terroristica è entrata a far
parte della struttura del reato -anche se l’azione è diretta, non contro uno Stato estero o un’Organizzazione
internazionale, ma contro lo Stato italiano- il medesimo elemento non può essere considerato come
199
Parte speciale circostanza aggravante dello stesso.
Nè vale dire che, se la ipotesi correttamente contestabile fosse quella di cui all’art. 270 c.p. (e non art. 270
bis c.p.), allora la predetta aggravante potrebbe trovare luogo.
Sulla base di tutto quanto premesso, invero, è di tutta evidenza che, se la violenza di cui all’art. 270 avesse
connotazioni terroristiche, dovrebbe immediatamente trovare applicazione proprio l’art. 270 bis.
È allora evidente che l’aggravante de qua è inapplicabile tanto alla figura incriminatrice ex art. 270 bis c.p.,
perchè ne è elemento costitutivo, quanto al delitto ex art. 270 c.p., integrando quel quid pluris che costituisce
la nota di specialità che distingue i due delitti.
Nei sensi e nei limiti sopra indicati, dunque, le censure sub 29) e 30) sono fondate.
La predetta aggravante, tuttavia, può trovare pacificamente applicazione in riferimento agli eventuali delittifine che si pongano in relazione con il delitto associativo.
Ne consegue l’annullamento con rinvio, anche su tale punto, competendo al giudice ad quem accertare se la
predetta aggravante sia da ritenere sussistente con riferimento ai reati diversi da quelli contestati sub A) e B).
Le censure relative alla costituzione di PC di I.P. - sub 8), 23), 50)- sono fondate. Quelle sub 9) e 51) restano
assorbite.
Contrariamente a quanto ritenuto nel 2009 da questa stessa Sezione (ASN 200900075-RV 242355), questo
Collegio ritiene che i delitti ex artt. 270 e 270 bis c.p. non abbiano natura plurioffensiva.
Tale natura non è compatibile con i delitti contro la personalità dello Stato e, ancor più, in particolare, con i
delitti contro la personalità internazionale dello Stato, atteso che tali delitti sono diretti contro gli interessi
attinenti alla vita dello Stato nella sua essenza unitaria, tranne le ipotesi in cui la condotta dell’agente si
appunti direttamente su di una persona fisica (es. art. 280 c.p.), ovvero consista nella provocazione di un
danno materiale diffuso, in grado di attingere una o più persone fisiche (es. artt. 280 bis e 285 c.p.).
A ben vedere, oltretutto, gli stessi reati associativi non ammettono quali PP.OO. soggetti fisici, tanto che, ad
es., in relazione al delitto ex art. 416 bis c.p., si è giunti a riconoscere la possibilità di costituirsi PC ad enti e
associazioni esponenziali di interessi pubblici o diffusi (il comune, le associazioni antiracket ecc. es. ASN
199510371-RV 202736, A5N 199208381-RV 191448), non certo al singolo, vittima, eventualmente, di uno o
più reati-fine e, con riferimento ad essi, certamente legittimato alla costituzione di PC. Il fatto è che va distinta
la vittima del reato dalla persona danneggiata dal reato.
Sia la risalente giurisprudenza di questa Corte (ASN 198808425-RV 178967) ebbe modo di chiarire che,
nella categoria delle persone che subiscono pregiudizio dalla commissione di un reato, occorre distinguere la
figura del danneggiato da quella del soggetto passivo.
Il primo si identifica in colui che subisce dal reato un danno patrimonialmente valutabile, mentre il soggetto
passivo si identifica nel titolare del bene-interesse tutelato dalle norme penali, che viene offeso o posto in
pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta dell’agente.
Conseguentemente, il soggetto legittimato all’azione civile non è solo il soggetto passivo del reato, ma anche
il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del
soggetto attivo del reato (ASN 201004816- RV 246280; ASN 200804060-RV 239189; ASN 2G057259-RV
231210).
Insomma: legittimato all’azione civile è sempre il danneggiato, il quale ben può identificarsi (e in genere così
accade) con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma anche con chiunque abbia riportato un danno
eziologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato (ASN 200005613-RV
216115).
Ovviamente, mentre, per la vittima del reato, la dimostrazione del danno patito è facilmente desumibile dalla
stessa titolarità del bene o dell’interesse tutelato dalla norma e violato dall’agente, detta dimostrazione deve
essere data, in maniera stringente dal danneggiato che non sia anche persona offesa.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata omette di chiarire quale danno abbia riportato il prof. I. e quale sia
il rapporto causale tra l’eventuale danno e la condotta degli imputati, atteso che i propositi delittuosi esplicitati
nei suoi confronti - nelle conversazioni intercettate - non furono portati ad esecuzione, nè risulta (o almeno
200
Scheda di giurisprudenza n. 20 non è detto) che lo stesso li abbia percepiti, ricavandone, inevitabilmente, turbamento e preoccupazione.
Detti propositi, per altro, evidentemente, furono noti agli inquirenti. E allora sarebbe stato necessario chiarire
se essi ne resero edotto l’I. e adottarono le conseguenti misure o, se, anche senza comunicare con la
potenziale vittima, si decise di rafforzare le misure di sicurezza in suo favore, con conseguente, probabile,
limitazione (o ulteriore limitazione, nel caso che il predetto fosse stato già sottoposto a tali misure) della sua
libertà di movimento e/o della sua privacy.
Su tali questioni dovrà pronunziarsi il giudice del rinvio.
A tal punto, la censura sub 18), ridimensionata nella sua portata, può essere affrontata.
Essa appare comunque generica, in quanto il ricorrente non chiarisce quale rilevanza e quale incidenza la
deposizione I., svoltasi, per quel che si legge nel ricorso, parzialmente (controesame) in assenza degli
imputati, abbia avuto nelle ricostruzione dei fatti per i quali è processo.
Se essa, come allo stato è ipotizzarle, dato il silenzio sul punto del ricorrente, ha avuto ad oggetto
unicamente gli eventuali disagi e le limitazioni che il prof. I. ha dovuto sopportare in conseguenza delle
misure di sicurezza assunte a sua tutela, ciò si riverbera -unicamente- sull’accertamento dell’off e del
quantum del diritto al risarcimento, vale a dire di una delle problematiche in relazione alle quali è disposto
l’annullamento con rinvio.
Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame, con riferimento: 1) alla
imputazione del capo B) (per Sc.) e del capo A) (per tutti gli altri imputati) per l’esigenza di nuovo esame in
ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei limiti sopra specificati, 2) atta aggravante di cui alla L.
n. 15 del 1980, art. 1, con riferimento ai reati per i quali è stata contestata ( B., D., Ga., G., L., Sc., S., T., 3)
alla ammissione della PC e alle conseguenti statuizioni. Le censure relative al trattamento sanzionatolo, in
esse incluse quelle attinenti al diniego di riconoscimento della continuazione con precedenti condanne (sub
32, 33, 40) restano, ovviamente, assorbite, cosi come assorbita è la censura sub 13), che replica il contenuto
di altre censure, cui già si è fornita risposta.
L’entità del danno da risarcire alla Presidenza del Consiglio dei ministri potrà essere rideterminata all’esito
del nuovo giudizio di merito.
Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.
Il giudice del rinvio è da individuarsi in altra sezione della Corte di assise di appello di Milano.
[...Omissis...]
201
Parte speciale Scheda di giurisprudenza n. 21
L’”oggettivizzazione” del dolo specifico nell’associazione con finalità terroristiche
TRACCIA
Tizio è indagato in ordine ai seguenti delitti: a) danneggiamento di alcun autovetture, aggravato
dall’esposizione alla pubblica fede e dalla finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (artt.
110, 635, comma 2, n. 3, in relazione all’art. 625 c.p., n. 7 e D.L. n. 625 del 1979, art. 1), per avere, in
concorso con altre persone sconosciute, appiccato il fuoco a tre veicoli di proprietà di OMISSIS; b) delitto di
associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.) per avere, unitamente a soggetti non identificati,
partecipato ad un sodalizio anarco-insurrezionalista e progettato e consumato atti di violenza.
In ordine al delitto in questione la Procura della Repubblica di OMISSIS formulava richiesta di applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere, respinta dal giudice per le indagini preliminari. A seguito
dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, il Tribunale di OMISSIS, costituito ex art. 310 c.p.,
accoglieva l’appello. Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto di poter inferire l’esistenza di un’associazione
con finalità di terrorismo dagli scritti collegabili all’imputato, teorizzanti la “necessità di compiere attività
delittuose finalizzate a mettere in pratica l’ideologia anarchica”, dai contatti intercorsi tra il ricorrente e un
soggetto in libertà, uniti da una comune ideologia di violenza, e dal verificarsi di numerosi episodi di
danneggiamento nella zona, omettendo qualsiasi approfondimento in ordine all’effettività del dato strutturale
e organizzativo proprio dell’associazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere.
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito investe la compatibilità della figura del dolo specifico, previsto
quale elemento costituivo delle fattispecie delittuose imperniate sulla costituzione di
un’associazione con finalità terroristica, con il principio di offensività.
Per vero, il problema trae origine già in astratto dal discusso rapporto intercorrente fra il
principio di offensività e il dolo specifico: atteso che il principio di offensività esprime la
necessità che il reato si sostanzi nell’offesa ad un bene giuridico protetto (nullum crimen
sine iniuria) e che, d’altra parte, il dolo specifico sussiste in quelle peculiari ipotesi di legge
in cui la norma prevede espressamente che, oltre alla coscienza e alla volontà del fatto
materiale, il soggetto agisca anche per un fine particolare, previsto appunto quale elemento
costitutivo della fattispecie legale (si tratta, dunque, di un elemento posto oltre il fatto materiale
tipico, per la cui integrazione è necessaria la consumazione del fatto di reato), la giurisprudenza si
è domandata se il ricorso alla figura del dolo specifico non integri una violazione del principio de
quo, a causa del rischio che il disvalore penalmente sanzionato si esaurisca in un mero
atteggiamento interiore.
Quanto sinora detto si complica in relazione al delitto di associazione con finalità terroristiche,
di cui all’art. 270 bis c.p.: la norma, infatti, essendo costruita in termini di anticipazione della
soglia di punibilità, incrimina l’associazione con finalità terroristiche per il solo fatto della
sua costituzione, a prescindere dunque dagli eventuali reati fine posti in essere in esecuzione del
relativo programma criminoso. Struttura, questa, che rinviene la sua ratio giustificatrice nel
particolare bene giuridico protetto dalla disposizione, individuato oggi, a seguito delle novelle
202
Scheda di giurisprudenza n. 21 intervenute nel corso dell’ultimo decennio, la sicurezza pubblica mondiale, ossia la sicurezza
della comunità internazionale dagli attacchi terroristici pianificati da organizzazione terroristiche
sovranazionale o da loro cellule, operanti sul territorio italiano (Cass. pen., Sez. I, 21 giugno 2005,
n. 35427). La pervasività dell’oggettività giuridica così ricostruita è tale dunque da consentire,
come avviene, ad es., anche nel caso degli artt. 416 e 416 bis c.p., la deroga a quanto disposto
dall’art. 115 c.p., a norma del quale, invece, il semplice accordo non è punibile qualora ad esso
non consegua la commissione del reato.
Tanto premesso, la struttura della norma de qua, se non pone particolari problemi per quel che
riguarda l’anticipazione della soglia di punibilità ivi contenuta (che potrebbe, sì, far discutere in
ordine alla sua compatibilità con il principio di offensività, ma che risulta giustificata, come visto,
dall’importanza del bene giuridico protetto), ha sollevato invece dubbi in relazione alla
previsione, fra i suoi elementi costitutivi, del dolo specifico.
La giurisprudenza, a tal proposito, si è infatti chiesta se la connotazione finalistica dell’art.
270 bis c.p. non si risolva nell’incriminazione di fatto di un mero scopo a prescindere dalle
possibili offese al giuridico protetto.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
In tema, erano due gli orientamenti, l’uno sostenuto in dottrina e l’altro in giurisprudenza.
2.1. Il primo orientamento: Configurabilità dell’art. 270 bis c.p. in
termini di dolo generico.
Per una prima tesi, sostenuta in dottrina (MARINUCCI-DOLCINI), l’unica soluzione possibile, per
salvare l’art. 270 bis c.p. dall’evidente contrasto con il principio di offensività, sarebbe quella di
qualificare, a prescindere dalla lettera della norma, l’elemento soggettivo che deve sorreggere la
costituzione dell’associazione in termini di dolo generico.
1° Argomento: principio di offensività. La dottrina pone in rilievo che, qualora la norma
de qua fosse sorretta da dolo specifico, inevitabile sarebbe il contrasto con il principio di
offensività: si finirebbe infatti con il reprimere mere intenzioni, senza attendere l’effettiva
produzione dell’offesa nei confronti del bene giuridico protetto, lasciando così intravedere un diritto
penale a base soggettivistica, che, al contrario, non trova asilo nell’ordinamento italiano.
2.2. Il secondo orientamento: “Oggettivizzazione” del dolo specifico.
La giurisprudenza di legittimità è invece già da tempo assestata su conclusioni
diametralmente opposte (ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 1° marzo 1996; Cass. pen., Sez. I, 15
giugno 2006, n. 30824), concludendo per la compatibilità dell’art. 270 bis c.p., e soprattutto del
dolo specifico da cui è inequivocabilmente sorretto, con il principio di offensività.
1° Argomento: tenore testuale. Dalla lettera della norma è inequivocabile che il delitto
punito sia sorretto da dolo specifico, motivo per cui sarebbe impossibile che il medesimo venisse
integrato alla luce del solo dolo generico, come la tesi precedente sosteneva.
2° Argomento: “oggettivizzazione” del dolo specifico. La giurisprudenza, in particolare,
203
Parte speciale ritiene che la finalità tipica del dolo specifico debba riflettersi nella materialità del fatto, di cui
si pretenderebbe l’idoneità a realizzarla. Ciò in altri termini significa che la finalità che la legge
considera come oggetto di dolo specifico dovrebbe, a livello oggettivo, riflettersi in atti
concretamente idonei a raggiungere la finalità medesima: il delitto sorretto da dolo specifico,
dunque, verrebbe ad atteggiarsi alla stregua di un tentativo, per cui l’agente andrebbe esente da
sanzione qualora, pur essendo animato dal fine previsto dalla norma, abbia tuttavia posto in essere
atti inidonei al raggiungimento del fine medesimo.
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: L’”oggettivizzazione
de” del dolo specifico.
La giurisprudenza oggi maggioritaria della Corte di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 10 luglio
2007, n. 34989) è assestata sulle conclusioni appena ricordate, ribadendo la tesi
dell’”oggettivizzazione” del dolo specifico nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato
e dunque anche in relazione all’art. 270 bis c.p.
1° Argomento: valorizzazione del dato strutturale e organizzativo insito
nell’associazione. La Corte ha a tal proposito affermato che “pur essendo incontroverso che la
sola costituzione dell’associazione integra il reato previsto dall’art. 270 bis c.p., e che, ai fini della
sussistenza del reato, non è necessario il compimento degli atti criminosi costituenti espressione
del programma criminoso e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che
la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno
possibile l’attuazione del progetto criminoso e da giustificare, quindi, la valutazione legale
di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura alla realizzazione della serie
indeterminata di reati per il cui compimento l’associazione stessa è stata costituita”.
Qualora infatti venisse sminuito il dato strutturale ed organizzativo dell’associazione,
l’anticipazione della repressione penale finirebbe per sanzionare la semplice adesione ad
un’ideologia, collidendo, così, con il principio di offensività.
2° Argomento: qualificazione del dolo specifico come figura ibrida. Il dolo specifico,
dunque, non dovrebbe più essere considerato come un istituto afferente esclusivamente al piano
della colpevolezza, ma piuttosto come una figura ibrida suscettibile di determinare importanti
ricadute anche sull’elemento oggettivo della fattispecie.
Tale orientamento è stato per altro da un recente arresto della Corte di Cassazione che a tal
proposito ha affermato che “il reato di cui all’art. 270 bis c.p. è un reato di pericolo, per la cui
configurabilità occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che
presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso
e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. Peraltro, vertendosi appunto in ipotesi di reato di
pericolo, non è necessario che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia
realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all’esecuzione del programma
stesso, per esempio partendo per i territori di guerra” (Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2012, n.
46308).
204
Scheda di giurisprudenza n. 21 Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene di poter consigliare a Tizio la favorevole proposizione di ricorso per Cassazione;
invero, la sentenza di grado è facilmente criticabile, in punto di diritto, liddove a ben vedere né stato omesso
qualsiasi approfondimento in ordine all’effettività del dato strutturale e organizzativo proprio dell’associazione
ex art. 270 bis c.p., delitto per il quale Tizio è stato condannato.
In ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, infatti, per la configurazione del delitto di cui all’art. 270 bis c.p.
è necessaria l’esistenza, e dunque la sua prova, di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti
un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminoso, prova che nella
specie manca.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34989
Estratto
[...Omissis...]
1. S.F.J.A. è indagato in ordine ai seguenti delitti:
a)danneggiamento di alcun autovetture, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e dalla finalità di
terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (artt. 110, 635, comma 2, n. 3, in relazione all’art. 625 c.p.,
n. 7 e D.L. n. 625 del 1979, art. 1), per avere, in concorso con altre persone sconosciute, appiccato il fuoco a
tre veicoli di proprietà di Trenitalia; b) associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.) per avere,
unitamente a soggetti non identificati, partecipato ad un sodalizio inarco - insurrezionalista e progettato e
consumato atti di violenza.
In ordine ai predetti delitti la Procura della Repubblica di Trento formulava richiesta di applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere, respinta dal giudice per le indagini preliminari.
A seguito dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, il 7 giugno 2006, il Tribunale di Trento, costituito
ex art. 310 c.p., accoglieva l’appello limitatamente al delitto di danneggiamento e, per l’effetto, applicava solo
per tale reato la custodia cautelare in carcere.
Avverso la citata ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia la difesa dell’indagato che il pubblico
ministero.
La Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza del 23 novembre 2006, in accoglimento del ricorso
del Procuratore della Repubblica, annullava l’ordinanza del Tribunale di Trento, cui disponeva la trasmissione
degli atti per nuova deliberazione, nella parte in cui aveva ritenuto insussistente un quadro di gravità
indiziaria con riguardo al delitto previsto dall’art. 270 bis c.p., sottolineando l’intrinseca contraddittorietà del
provvedimento oggetto di gravame che, dopo avere valorizzato un complesso di elementi di fatto implicanti
una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, aveva poi ritenuto che le condotte contestate dovessero
essere semplicemente inquadrate nel contesto di un “ambiente variegato e aggregato sulla base di
un’identità ideologico - politica”. In proposito la Corte osservava testualmente che quando un “ambiente... si
esprime con condotte che necessariamente presuppongono l’esistenza e l’operatività di una struttura- sia
pure sommariamente organizzata - non si può più parlare di azioni isolate ispirate da una comune ideologia”
ed inoltre che, attesa la natura di reato di pericolo presunto del delitto ex art. 270 bis c.p., ai fini della
configurabilità della responsabilità del partecipe è sufficiente “l’effettiva pratica della violenza come metodo di
lotta politica e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche” (cfr. f. 2 della sentenza della Quinta
Sezione penale di questa Corte).
205
Parte speciale 2. 11 16 gennaio 2007 il Tribunale di Trento, pronunziandosi in sede di annullamento con rinvio dalla
Cassazione, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, applicava nei confronti di S.F.A. la misura
cautelare della custodia in carcere anche in relazione al delitto di cui all’art. 270 bis c.p., ritenendo integrati i
gravi indi di colpevolezza sulla base di quattro annotazioni della Digos, depositate dal Procuratore della
Repubblica in epoca successiva alla prima pronunzia, degli scritti inviati dal carcere con i quali l’indagato
teorizzava la necessità di danneggiamenti, attentati a banche, prigioni, caserme, ripetitori come “atti di
libertà” e si proclamava persona insuscettibile di ravvedimento, avendo trasgredito le leggi non per caso ma
per scelta.
3. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia,
l’indagato il quale lamenta erronea applicazione dell’art. 270 bis c.p., carenza e contraddittorietà della
motivazione sotto i seguenti profili:
a) l’operatività dell’associazione è stata desunta sulla base dell’invio dal carcere di una lettera diretta a M.F.
e, tramite questa, ad altra persona in assenza di qualsiasi spiegazione circa la rilevanza giuridica della mera
diffusione di corrispondenza quale espressione di un più vasto disegno criminoso volto a commettere atti di
violenza e della sola ricezione di alcuni scritti quale atto di collaborazione all’interno di un presunto sodalizio;
b) non è stato evidenziato il nesso tra l’esistenza di un’organizzazione criminale e il comunicato del 30
giugno 2006, avente ad oggetto l’arresto del ricorrente e di B.D. (detto (OMISSIS)), avvenuti nei giorni
precedenti; c) la diffusione, a Torini, di un volantino contenente frasi identiche a quelle diffuse in Trentino è
stata valutata come manifestazione ideologica di solidarietà; d) non è stata fornita una prova compiuta della
struttura dell’organizzazione in assenza di specifiche condotte costituenti espressione del programma
perseguito dall’associazione Il 25 luglio 2007 perveniva a questa Corte un’articolata memoria del pubblico
ministero, contenente un’ampia illustrazione dei fatti ascritti a S. e del complesso degli elementi investigativi
acquisiti.
1. La giurisprudenza di legittimità riconduce il delitto associativo previsto dall’art. 270 bis c.p., nell’ambito dei
delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall’anticipazione della soglia di
punibilità nel momento stesso della costituzione di un’organizzazione di persone e di mezzi, volta a realizzare
un programma di violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto
attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all’inizio di esecuzione delle programmate
condotte violente (Cass. Sez. 2, 25 maggio 2006, n. 24994, Bouhrama; Cass. Sez. 1, 21 giugno 2005, n.
35427, Drissi; Cass. Sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 19646, Bouyahia ed altri).
Pur essendo incontroverso che la sola costituzione dell’associazione integra il reato previsto dall’art. 270 bis
c.p., e che, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario il compimento degli atti criminosi costituenti
espressione del programma criminoso e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio
che la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile
l’attuazione del progetto criminoso e da giustificare, quindi, la valutazione legale di pericolosità, correlata alla
idoneità della struttura alla realizzazione della serie indeterminata di reati per il cui compimento
l’associazione stessa è stata costituita (Cass. Sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 19646, Bouyahia ed altri).
Sminuendo il dato strutturale e organizzativo insito nel delitto associativo, l’anticipazione della repressione
penale finirebbe per sanzionare la semplice adesione ad un’astratta ideologia che, pur aberrante per
l’esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata dalla possibilità
di attuazione del programma; in tal modo si finirebbe per reprimere idee, piuttosto che fatti, potendo tutt’al più
configurarsi, nell’ipotesi di accordo non concretizzatosi in un’organizzazione adeguata al piano terroristico, il
reato di cui all’art. 304 c.p., che, attraverso l’art. 302 c.p., richiama anche l’art. 270 bis c.p., (cfr. Cass. Sez. 1,
27 febbraio 2002, Marra, rv. 221834).
L’elemento oggettivo del delitto, classificabile tra quelli plurioffensivi, è contraddistinto da una pluralità di
condotte che designano l’inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati
all’interno dell’associazione. In proposito deve essere sottolineato che la norma incriminatrice, oltre, alle
posizioni di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa, prende in esame anche la condotta di
206
Scheda di giurisprudenza n. 21 finanziamento, tipizzando lo specifico ruolo di chi fornisce le risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione del
programma criminoso.
La condotta di partecipazione ad associazioni terroristiche può essere compiutamente delineata richiamando
i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte che, in tema di associazione per delinquere di stampo
mafioso, hanno chiarito che “si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente
nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende
parte alla) stessa:
locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso
dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a
svolgere perchè l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate
della medesima” (Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673).
In coerenza con questa linea interpretativa la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la prova della
partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all’adesione
psicologica o ideologica al programma criminale, e che la dichiarazione di responsabilità presuppone la
dimostrazione dell’effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente
sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma
oppure nell’assunzione di un ruolo concreto nell’organigramma criminale (Cass. Sez. 1, 15 giugno 2006, n.
30824, Tartag).
Con riferimento all’elemento soggettivo è da evidenziare che l’art. 270 bis c.p., richiede il dolo specifico, in
quanto la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere rivolte al perseguimento della
peculiare finalità di terrorismo che connota l’attività dell’intera associazione.
2. Così ricostruita la fattispecie incriminatrice, il Collegio ritiene che l’iter argomentativo seguito nel
provvedimento impugnato sia carente rispetto ai principi di diritto e al tema di indagine fissato nella sentenza
di annullamento pronunziata il 23 novembre 2006 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, in quanto,
dopo avere richiamato tre scritti (manifesto affisso nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2006 a Rovereto, diffuso
anche via internet; volantino del 30 giugno 2006 a firma “(OMISSIS) e (OMISSIS) dal carcere di Rovereto”,
inviato, tramite posta elettronica, da M.F. a K.L., con un messaggio di accompagnamento del seguente
tenore “ti mando in allegato il testo dei geni”; volantino del 19 luglio 2006 recante la sigla “dal carcere di
Vicenza due canaglie punk-HC (OMISSIS) e (OMISSIS)”), teorizzanti la necessità di danneggiamenti,
attentati a banche, carceri, caserme, ripetitori, quali azioni finalizzate a mettere in pratica l’ideologia
anarchica, omette qualsiasi approfondimento in ordine all’effettività del dato strutturale e organizzativo
proprio dell’associazione disciplinata dall’art. 270 bis c.p.. Il provvedimento impugnato si limita, infatti, ad
inferire dagli scritti e dai contatti in precedenza sintetizzati, intercorsi tra il ricorrente e un soggetto in libertà,
uniti da una comune ideologia di violenza, e dal verificarsi di numerosi episodi di danneggiamento, a partire
dal 2002, nella zona di (OMISSIS), prevalentemente ad opera di autori ignoti, l’esistenza di una “realtà
organizzativa pur sempre rudimentale” e di un “gruppo minimamente organizzato, finalizzato alla diffusione e
alla realizzazione del programma anarchico - insurrezionalista”.
Va, pertanto, rimarcata l’assenza di adeguate argomentazioni atte a sostenere il convincimento del Tribunale
che ha apoditticamente affermato l’esistenza di un’associazione inquadrarle nello schema previsto dall’art.
270 bis c.p., senza approfondire la questione relativa alla sussistenza dei profili strutturali e organizzativi del
sodalizio avente finalità terroristiche, alla loro idoneità per il conseguimento degli scopi normativamente
fissati, al ruolo svolto da S. all’interno dell’organizzazione.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, deve essere, pertanto, pronunciato l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Trento che, nel valutare il
compendio investigativo, applicherà i principi di diritto sopra enunciati.
[...Omissis...]
207
Parte speciale Scheda di giurisprudenza n. 22
Corruzione in atti giudiziari susseguente
TRACCIA
Tizio è parte attrice in una causa civile avente ad oggetto un risarcimento danni di svariate centinaia di
migliaia di euro. Il giudizio civile in questione è affidato al giudice Sempronio, amico di Tizio. Sempronio, per
avvantaggiare Tizio nella controversia civile in cui è giudice, adotta un atto contrario ai propri doveri d’ufficio,
con cui fa vincere la causa a Tizio.
Tizio, allora, incarica la propria segretaria di recarsi presso la casa di Sempronio per far avere allo stesso un
orologio di lusso come ricompensa per l’adozione dell’atto che lo ha favorito. Sempronio accetta il regalo.
Dopo pochi giorni, tuttavia, la segretaria di Tizio, decide di denunciare il fatto.
Tizio si reca quindi da un legale per conoscere la propria posizione processuale.
1. La questione.
Il dibattito sorto in seno a giurisprudenza e dottrina involge la configurabilità del delitto di
corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente, nella quale dunque il versamento
della retribuzione avviene a valle di un atto già compiuto.
Giova premettere all’analisi della questione una breve introduzione circa il reato de quo.
Introdotta dall’art. 319 ter c.p., per mano della l. n. 86/1990, la fattispecie in esame prevede
un’ipotesi peculiare di corruzione; per vero, v’è da notare che tale ipotesi era già prevista
dal Codice penale, ma solo come circostanza aggravante dell’art. 319 (“Corruzione per atto
contrario ai doveri di ufficio”), disciplinata al secondo comma. L’aver dato autonomia all’ipotesi
in parola ha comportato il sorgere di un primo dibattito, il cui terreno era conteso da chi, da un
lato, riteneva che la corruzione in atti giudiziari avesse mantenuto la propria natura di
circostanza (e ciò in ragione del mancato richiamo dell’art. 319 ter c.p. da parte degli artt. 322,
322 bis e dell’originario 321, mancato richiamo giustificabile solo, appunto, in considerazione
della natura di mera aggravante della previsione de qua) e da chi, dall’altro lato, riteneva
invece che, a valle della novella, fosse da considerare quale vero e proprio reato (tramite la
previsione espressa dell’art. 319 ter c.p., il legislatore avrebbe infatti attribuito all’ipotesi
criminosa valore di vero e proprio titolo di reato autonomo e tale interpretazione sarebbe del
resto conforme sia alla considerazione che nel capoverso dell’articolo citato sono previste altre
specifiche ipotesi con indicazione di autonome pene sia alla ratio della novella del 1990, appunto
di innovazione e inasprimento del sistema previgente). Le conseguenze non sono di poco
conto, essendo sottratta al giudizio di bilanciamento nel secondo caso.
La Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 1995, n. 3442; Cass. pen., Sez. I, 23 gennaio
2003, n. 6274) accoglieva la seconda delle ricostruzioni esposte, ritenendo che la natura del
delitto di cui all’art. 319 ter c.p. sia quella di reato autonomo e non una circostanza
aggravante ad effetto speciale ai delitti di corruzione previsti dagli artt. 18 e 319 c.p. In
particolare, la norma non distingue tra corruzione propria e impropria, racchiudendo tutti gli
episodi corruttivi relativi alla funzione giudiziaria, siano essi destinati al compimento di un atto di
ufficio ovvero contrario ai propri doveri o, infine, all’omissione o alla ritardata adozione.
208
Scheda di giurisprudenza n. 22 Tanto premesso, come anticipato, la giurisprudenza si era interrogata altresì circa la
configurabilità della corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente, in cui la dazione
segue l’atto già compiuto.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
In relazione alla questione citata, due erano gli orientamenti formatisi, per altro entrambi all’interno
della medesima Sezione della Corte di Cassazione, la Sesta.
2.1. Il primo orientamento: Inconfigurabilità del delitto di correzione in
atti giudiziari susseguente.
Per un primo e minoritario orientamento (Cass. pen., Sez VI, 4 maggio 2006, n. 33435), la
configurabilità della corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente andrebbe senza
dubbio esclusa.
1° Argomento: tenore testuale. La Corte assegna rilievo centrale all’inciso “per
favorire o danneggiare una parte” per sottolineare che, in ragione del fatto che la condotta
incriminata assume rilievo nell’attesa di un atto funzionale ancora da compiersi, la
remunerazione di atti pregressi invero rimane al fuori dell’area della tipicità. La
corruzione in atti giudiziari si qualifica per la tensione finalistica verso un risultato non
essendo quindi compatibile con la proiezione verso il passato, con una situazione di
interesse già soddisfatto, su cui è invece modulato lo schema della corruzione susseguente.
Diversamente opinando, sarebbe per altro difficile provare che l’influsso illecito del
giudice sul processo sarebbe stato dal medesimo attuato in vista di una retribuzione
postuma e naturalmente indebita.
2° Argomento: ragioni sistematiche. In quest’ottica deve essere considerato che
nella fattispecie di corruzione in atti giudiziari sono equiparate le condotte di corruzione
propria ed impropria (intendendosi per esse, rispettivamente, il compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio ed il compimento di un atto invece conforme ai doveri di ufficio)
antecedente, in quanto entrambe condizionano il processo e sono espressione del medesimo
disvalore penale; qualora rientrasse nell’art. 319 ter c.p. anche la forma susseguente, che
invero non influenza l’andamento del processo in quanto trattasi di attività già compiuta, si
giungerebbe al risultato quanto mai irragionevole di assoggettare al medesimo
trattamento sanzionatorio tipologie di corruzione in realtà differenti.
3° Argomento: ragioni storiche. Prima della novella del 1990, la corruzione in atti
giudiziari era, come visto, una fattispecie aggravata della corruzione propria antecedente,
richiedendo infatti un diretto rapporto causale tra il fatto di correzione ed il favore o il danno
per una parte del processo; il legislatore, dunque, con la riforma ha voluto mantenere
l’estraneità della corruzione susseguente all’area della corruzione in atti giudiziari,
ferma la ravvisabilità della corruzione ordinaria per atto d’ufficio o per atto contrati dai doveri di
ufficio.
209
Parte speciale 2.2. Il secondo orientamento: Configurabilità del delitto di corruzione
in atti giudiziari susseguente.
A mente di altra tesi, sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio
2004, n. 23024; Cass. pen., Sez. VI, 28 febbraio 205, n. 13919; Cass. pen., Sez. VI, 18 settembre
2009 n. 36323), invece, la corruzione in atti giudiziari susseguente avrebbe dovuto trovare
piena cittadinanza nell’ambito delle previsioni codicistiche.
1° Argomento: tenore testuale. Affermare l’inconfigurabilità della corruzione in atti
giudiziari nella forma susseguente sarebbe pari ad un’interpretazione abrogatrice dell’art. 319
ter c.p., in cui il legislatore richiama senza alcuna distinzione il testo integrale sia dell’art. 318
che dell’art. 319 c.p., richiamo che impone l’adattamento della struttura della norma in parola ad
entrambi gli schemi, e dunque sia antecedente che susseguente. E del resto di entrambi è
comune il presupposto per cui l’autore del fatto viene meno ai suoi doveri di imparzialità e
terzietà.
2° Argomento: struttura del dolo specifico. Nella fattispecie di corruzione
antecedente in atti giudiziari, il dolo specifico si articola nella doppia finalità, l’una consistenza
nell’adozione di un atto, conforme o contrario ai propri doveri di ufficio, e l’altra, consistente nella
violazione, per mezzo del compimento del medesimo atto, del dovere di imparzialità della funzione
giudiziaria. Nella forma invece susseguente, l’elemento soggettivo si compone del dolo
generico della corruzione generica e del dolo specifico proprio della corruzione in atti
giudiziari, che si atteggia, in tal caso, ad elemento antecedente alla condotta tipica. In sostanza,
nella corruzione in atti giudiziari susseguente, il dolo specifico si incentra nel compimento
dell’atto, in sé condotta non punibile, rispetto al quale la successiva dazione di danaro o
accettazione della promessa assume valenza esclusivamente causale, in presenza di un
precedente comportamento volto a favorire o danneggiare una parte processuale.
3° Argomento: la c.d. causalità invertita. La fattispecie di corruzione in atti giudiziari
susseguente è connotata dalla c.d. causalità invertita rispetto alla corruzione in atti giudiziari
antecedente: in tal senso, l’atto costituisce il presupposto strutturale indispensabile alla
condotta, che assume rilievo causale solo in ragione del suo contributo causale.
4° Argomento: ragioni di ordine logico. “Se il provvedimento giudiziale è stato già
emesso, non si veda come si possa supporre che il soggetto privato successivamente dia o
prometta danaro o altra utilità proprio allo scopo di conseguire un obiettivo, che, al momento della
dazione o della promessa, è già stato conseguito: in questo momento, la condotta corruttiva del
privato, lungi dall’essere finalizzata ad uno scopo futuro, si atteggia a corrispettivo di un
interesse già soddisfatto e consistente, nella specie, nel favore o nel danno concreto
arrecato all’altra parte” (Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2004, n. 23024).
3. La soluzione delle Sezioni Unite: Configurabilità del delitto di
corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente.
La Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208), chiamata a dirimere il
contrasto, si è pronunciata in favore della seconda tesi, sposando le ragioni che ne
costituiscono il fondamento e dunque concludendo per l’ammissibilità della forma
210
Scheda di giurisprudenza n. 22 susseguente anche in relazione alla corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319 ter c.p. Alle
argomentazioni sostenute dalla tesi accolta, le Sezioni Unite affiancano le proprie, volte a
scardinare altri punti della tesi che escludeva la configurabilità del reato de quo.
1° Argomento: violazione del principio di legalità. Escludendo la configurabilità della
corruzione susseguente in atti giudiziari, si violerebbe il principio di legalità poiché si
limiterebbe, in modo del tutto arbitrario, solo al tipo della corruzione antecedente il rinvio
operato nel primo comma dell’art. 319 ter c.p. in favore dei fatti di corruzione di cui agli artt. 318
e 319 c.p.
2° Argomento: valorizzazione della finalità perseguita. Il fine di arrecare vantaggio o
danno nei confronti di una parte processuale deve essere riferito al pubblico ufficiale, poiché è
costui che, adottando un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio, può incidere sulla
dinamica processuale; è tale atto, o comportamento, dunque, che deve essere contrassegnato
da una finalità non imparziale, essendo la peculiare direzione della volontà del pubblico ufficiale
connotato soggettivo della sua condotta materiale.
Ciò che conta, in sostanza, è la finalità perseguita al momento del compimento
dell’atto da parte del pubblico ufficiale: qualora sia diretta, per uno motivo qualsiasi (rapporti di
amicizia, prospettive di vantaggi economici, etc.), a favorire o a danneggiare un parte in un
processo, è del tutto indifferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o
susseguente al compimento dell’atto; del pari, è irrilevante stabilire se l’atto sia o meno, in
concreto, contrario o conforme ai doveri di ufficio.
3° Argomento: rapporto di specialità fra la corruzione comune di cui agli artt. 318 e
319 c.p. e la corruzione in atti giudiziari. Quest’ultima, in quanto species delle prime due, non
potrebbe non essere composta di tutti gli elementi che caratterizzano le medesime,
aggiungendo ad essi l’elemento specializzante di essere commessa per favorire o per
danneggiare una parte nell’ambito di un processo.
4° Argomento: critica dell’argomento storico. La l. n. 86/1990 ha introdotto
un’autonoma figura di delitto per la corruzione in atti giudiziari, nell’ambito del generale
inasprimento della sanzioni per i delitti di corruzione, con lo scopo di sottrarre la pregressa
aggravante al giudizio di bilanciamento cui soggiacciono le circostanze, conferendole il rango
appunto di autonomo titolo di reato; la ratio di tale introduzione, per altro, vinee rinvenuta anche
nell’esigenza del rafforzamento del dovere di imparzialità che incombe su tutti i pubblici
dipendenti, ai sensi dell’art. 97, co 1, Cost., e che assume peculiare connotazione proprio per
coloro che prendono parte alla funzione giurisdizionale, occupando un ruolo per certi versi decisivo.
Se tali dunque sono le ragioni, non avrebbe senso escludere la forma susseguente.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che Tizio possa del delitto di corruzione, di cui all’art. 319 ter c.p. invero, va
premesso che il reto di corruzione è reato plurisoggettivo, o reato a concorso necessario, rispondendone sia
il corruttore che il corrotto. Si distingue, infatti, la corruzione attiva da quella passiva, a seconda che la si
guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto. Per altro, anche dal punto di vista strutturale il
comportamento dei soggetti è sostanzialmente identico. Il pubblico ufficiale riceve la dazione o la promessa e
211
Parte speciale dà in cambio l’atto d’ufficio o contrario ai doveri di ufficio; il privato, da parte sua, riceve l’atto di ufficio o l’atto
contrario ai doveri di ufficio e dà in cambio denaro o altra utilità. Il pubblico funzionario che si fa corrompere
ed il privato che lo corrompe non commettono reati diversi dunque ma risultano essere compartecipi del
medesimo reato, quest’ultimo configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti.
In ragione della giurisprudenza ultima, che oggi ammette la configurabilità del delitto di corruzione in atti
giudiziari nella forma susseguente, sia Tizio che Sempronio potranno essere imputati del delitto di cui all’art.
319 ter c.p.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208
Estratto
[...Omissis...]
1. Per un’evidente esigenza sistematica deve essere affrontata, in via prioritaria, la questione controversa
sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite, consistente nello stabilire: “se il delitto di corruzione in atti
giudiziali sia configurabile nella forma della corruzione susseguente”.
Tale questione, infatti, si connette alla possibilità di configurare la stessa sussistenza del reato e si pone,
pertanto, come preliminare e dirimente rispetto a tutte le altre confutazioni svolte nel ricorso.
2. Quanto alla compatibilità delle forme susseguenti con la struttura della fattispecie di corruzione in atti
giudiziali, descritta nell’art. 319 ter c.p., si rinvengono effettivamente due contrastanti impostazioni nelle
decisioni della sesta Sezione penale di questa Corte Suprema.
2.1 Premesso che è “susseguente” la corruzione allorquando la retribuzione concerna un atto già compiuto in
precedenza, va rilevato che - secondo un primo orientamento (che si rinviene in Cass., Sez. 6, 4 maggio
2006, n. 33435, Battistella e altri) - non è ipotizzabile la corruzione in atti giudiziali nella forma susseguente,
benchè il generico rinvio operato dalla disposizione incriminatrice ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. possa
far pensare che il legislatore non abbia inteso porre alcuna distinzione o limitazione.
Il dato normativo che gioca un ruolo decisivo nella ricostruzione interpretativa di detta sentenza è racchiuso
nell’inciso “per favorire o danneggiare una parte...”: siccome la condotta incriminata, costituita dal ricevere
denaro o accettarne la promessa, assume rilievo nell’attesa di un atto funzionale ancora da compiersi, e per
il cui compimento il pubblico ufficiale assume un impegno, la mera remunerazione di atti pregressi resta fuori
dell’area di tipicità.
La corruzione in atti giudiziari si qualifica per la tensione finalistica verso un risultato e non è quindi
compatibile con la proiezione verso il passato, con una situazione di interesse già soddisfatto, su cui è invece
modulato lo schema della corruzione susseguente.
Un diverso ragionamento, che punti alla valorizzazione dell’indistinto richiamo contenuto nell’art. 319 ter c.p.
ai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p., per poi inferire la piena compatibilità della forma susseguente, si
risolverebbe in una forzatura interpretativa in malam partem con l’attribuzione di una valenza anche causale,
oltre che finale, all’espressione “per favorire o danneggiare”, come se ad essa fosse affiancata anche quella
“per aver favorito o danneggiato”. Se si procedesse su questa strada, peraltro, sarebbe evidente il contrasto
con il principio di tassatività.
Questa conclusione è poi confermata da considerazioni di tipo sistematico. Nella fattispecie di corruzione in
atti giudiziari sono equiparate le condotte di corruzione propria e impropria antecedente, perchè entrambe
condizionano il processo e sono espressione di un medesimo disvalore. Se si ritenesse compresa anche la
corruzione susseguente, che a differenza di quella antecedente non influenza l’andamento dell’attività
giudiziaria perchè già compiuta, si avrebbe l’irragionevole risultato di assoggettare ad uno stesso trattamento
212
Scheda di giurisprudenza n. 22 sanzionatorio tipologie di corruzione oggettivamente diverse. Si avrebbe così la conseguenza di escludere,
stante il generico rinvio che l’art. 321 c.p. fa all’art. 319 ter c.p., la non punibilità del corruttore in caso di
corruzione impropria susseguente in atti giudiziari, a dispetto di quanto per lui è previsto in ogni altro caso di
corruzione impropria susseguente.
L’appiattimento di diversi contenuti offensivi e lo stravolgimento della gerarchia di valori a essi sottesi
integrerebbero i presupposti per più che fondati dubbi di costituzionalità.
Nello stesso senso si pongono considerazioni di natura storica.
Prima della novella codicistica del 1990, che ha introdotto la corruzione in atti giudiziari come fattispecie
autonoma di reato, la corruzione in atti giudiziari era fattispecie aggravata della corruzione propria
antecedente, tanto da richiedere un diretto rapporto causale tra il fatto di corruzione e il favore o il danno per
una parte del processo, come risultava dall’inciso: “la pena è aumentata se dal fatto deriva...il favore o il
danno...” del vecchio testo dell’art. 319 c.p., comma 2, n. 2. Sembra allora coerente ritenere che il legislatore
della novella abbia mantenuto l’estraneità della corruzione susseguente all’area della corruzione in atti
giudiziari, fermo restando che essa è comunque soggetta alle previsioni sanzionatrici della corruzione
ordinaria per atto d’ufficio o per atto contrario ai doveri d’ufficio.
Nessuna sentenza successiva ha aderito espressamente alla soluzione qui delineata.
2.2 Un orientamento nettamente difforme si rinviene, invece, in altre decisioni della sesta Sezione penale, tra
le quali vanno già ricordate le sentenze 4 febbraio 2004, n. 23024, Drassich e 28 febbraio 2005, n. 13919,
Baccarini.
In particolare poi - con la sentenza 3 luglio 2007, n. 25418, Giombini e altro - è stato evidenziato che
l’affermazione dell’incompatibilità della forma susseguente si risolve in un’interpretazione abrogatrice del
precetto dell’art. 319 ter c.p., ove viene richiamato, senza distinzione alcuna, l’integrale contenuto degli artt.
318 e 319 c.p..
Il richiamo all’intero contenuto di questi due ultimi articoli impone l’adattamento della struttura della
corruzione in atti giudiziari ad ambedue i modelli, della corruzione antecedente e di quella susseguente. Tali
due modelli di corruzione in atti giudiziari hanno in comune il presupposto che l’autore del fatto
(necessariamente un pubblico ufficiale, perchè l’art. 319 ter c.p., non è richiamato dall’art. 320 c.p.) viene
meno ai doveri di imparzialità e terzietà, e questo presupposto si realizza anche nella forma susseguente, in
quanto il peculiare elemento soggettivo del “favorire o danneggiare una parte”, che qualifica testualmente la
disposizione incriminatrice, finalizza la tipicità dei fatti.
La finalità, in buona sostanza, si riferisce al fatto ed il dato di rilievo nell’integrazione del fatto - reato è che la
promessa o la ricezione siano avvenute per un atto di giurisdizione o per un comportamento strumentale
all’atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare una parte. È l’atto giudiziario
che deve essere contrassegnato da una finalità non imparziale, sicchè l’elemento del dolo specifico, presente
nell’ipotesi di corruzione antecedente, viene meno nel caso di corruzione susseguente per essere l’atto già
stato compiuto.
Nella fattispecie di corruzione antecedente in atti giudiziari il dolo specifico si articola nella doppia finalità,
l’una - propria della corruzione generica - consistente nell’adozione di un atto, conforme o contrario ai doveri
d’ufficio, l’altra - specifica della corruzione in atti giudiziari - consistente nella violazione, per mezzo del
compimento dell’atto, del dovere rafforzato di imparzialità che connota la funzione giudiziaria; nella
corruzione in atti giudiziari susseguente, invece, l’elemento soggettivo si compone del dolo generico della
corruzione generica e del dolo specifico proprio della corruzione in atti giudiziari che però si atteggia ad
elemento antecedente alla condotta tipica. Il dolo specifico, nella corruzione in atti giudiziari susseguente, si
incentra nel compimento dell’atto, che di per sè non è condotta punibile, rispetto al quale la successiva
condotta di ricezione del denaro o di accettazione della promessa assume valenza esclusivamente causale,
in presenza di un precedente comportamento orientato specificamente a favorire o danneggiare una parte
processuale.
Da detto elemento soggettivo scompare l’ulteriore finalizzazione specifica costituita dallo scopo tipico della
213
Parte speciale corruzione antecedente.
Si ha così che - mentre nella fattispecie di corruzione antecedente l’atto, contrario o conforme ai doveri
d’ufficio, costituisce l’oggetto finalistico della condotta, il cui compimento non è necessario per la
consumazione del reato - nella fattispecie di corruzione susseguente il dolo, generico, deve investire, oltre
che la condotta, anche l’atto, contrario o conforme ai doveri d’ufficio, e l’elemento soggettivo che dell’atto è
profilo indispensabile, il favorire o danneggiare una parte processuale.
Nella fattispecie di corruzione in atti giudiziari susseguente si ha, dunque, una causalità invertita rispetto alla
fattispecie di corruzione in atti giudiziari antecedente, nel senso che l’atto (conforme o contrario ai doveri
d’ufficio) costituisce il presupposto strutturale indispensabile della condotta, che assume rilievo penale solo in
forza del contributo causale dell’atto stesso.
Alla tesi della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente ha prestato
adesione sempre la Sezione sesta, con la sentenza 18 settembre 2009, n. 36323, Drassich, secondo cui
l’ampiezza della disposizione incriminatrice, che racchiude tutte le ipotesi di corruzione (propria e impropria,
antecedente e susseguente), assoggettandole alla medesima pena, trova ragione nella tutela della funzione
giudiziaria, costituzionalmente prevista per il riconoscimento dei diritti fondamentali e il rispetto del principio di
legalità. La sentenza in oggetto ha tratto quindi la conclusione che il delitto di corruzione in atti giudiziari ben
può essere posto in essere con la ricezione di un’utilità dopo il compimento di un atto, pur conforme ai doveri
d’ufficio, che, funzionale a un procedimento giudiziario, sia strumento dì un favore o di un danno nei confronti
di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo.
In termini particolarmente sintetici si è mossa nella stessa direzione la successiva sentenza della Sez. 6, 9
luglio 2007, n. 35118, Fezia, che ha risposto al rilievo difensivo circa l’impossibilità di riconoscere la
responsabilità del corruttore per il delitto di corruzione in atti giudiziari susseguente per compimento di atto
conforme ai doveri d’ufficio, richiamando la giurisprudenza secondo cui anche la corruzione in atti giudiziari
impropria può integrare il delitto di cui all’art. 319 ter c.p., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo
della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso
che futuro.
2.3 In dottrina l’indirizzo nettamente prevalente è nel senso della inconfigurabilità della forma della corruzione
susseguente laddove si versi nella peculiare fattispecie della corruzione in atti giudiziari.
Le argomentazioni alla base di tale indirizzo muovono essenzialmente dalla presenza, nel testo dell’art. 319
ter c.p., della espressa previsione, afferente al dolo specifico che caratterizzerebbe il reato, che i fatti siano
commessi “per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”, senza che
nulla possa autorizzare, pena la violazione del principio di tassati vita, ad includervi anche le condotte
collegate all’”avere favorito o danneggiato” la stessa parte. Ciò, evidentemente, considerando che nelle
ipotesi di corruzione susseguente il dolo non potrebbe che essere generico attesa l’incompatibilità di un
comportamento proteso ad ottenere un evento successivo con la già avvenuta realizzazione dell’atto
contrario ai doveri di ufficio.
Sotto un diverso profilo (che, accettato però nella sua integralità, non potrebbe non coinvolgere la stessa
fattispecie di corruzione susseguente “ordinaria”), si è sottolineato come sembrerebbe abbastanza difficile
configurare la fattispecie di corruzione in atti giudiziari con riferimento alla cosiddetta corruzione successiva,
“essendo difficile provare che l’illecito influsso ormai determinatosi sul processuale sarebbe stato architettato
dal giudicabile in vista di una retribuzione indebita” postuma.
Si è altresì affermato, sul piano logico, che “se il provvedimento giudiziale è già stato emesso, non si vede
come si possa supporre che il soggetto privato “successivamente” dia o prometta denaro o altra utilità proprio
allo scopo di conseguire un obiettivo (emissione del provvedimento in questione) che, al momento della
dazione o della promessa, è già stato conseguito: in questo momento la condotta corruttiva del privato, lungi
dall’essere finalizzata a uno scopo futuro, si atteggia a corrispettivo di un interesse già soddisfatto e
consistente, nella specie, nel favore o nel danno concreto arrecato all’altra parte”.
A fronte della specifica previsione riguardante la connotazione del dolo, dunque, assumerebbe carattere
214
Scheda di giurisprudenza n. 22 recessivo il richiamo (apparentemente solo integrale, ma in realtà da interpretare, in senso logico,
selettivamente) ai fatti indicati nell’artt. 318 e 319 c.p. (ivi compresa, dunque, la fattispecie della corruzione
susseguente contemplata appunto dall’art. 319 c.p.); ciò tanto più in quanto, a dispetto della configurazione
della norma nel senso di una meccanica trasposizione, sul piano del processo, dei fatti corruttivi
ordinariamente ricollegabili alla generica attività della pubblica amministrazione, apparentemente suggerita,
appunto, dal richiamo indifferenziato agli artt. 318 e 319 c.p., il peculiare e significativo disvalore proprio della
fattispecie in oggetto (nata, anche storicamente, per tutelare nel massimo grado la imparzialità e correttezza
della funzione giudiziaria) dovrebbe condurre ad attribuire alla norma una originale e autonoma fisionomia.
Non vi sarebbe, del resto, ragione alcuna di estendere l’applicazione di una disciplina, la cui maggiore gravità
sarebbe realmente giustificata soltanto nelle ipotesi di corruzione propria antecedente proprio per la assoluta
mercificazione della funzione giurisdizionale e la grave violazione al principio di imparzialità, “anche a quelle
ipotesi di reato la cui carica offensiva trova sufficiente risposta punitiva nelle sanzioni previste per le ipotesi
comuni di corruzione”. Esclusa in tale caso la configurabilità della corruzione in atti giudiziali, il fatto corruttivo
commesso a mò di ricompensa per un atto giudiziario contrario ai doveri di ufficio in precedenza posto in
essere non potrebbe comunque non rientrare nella corruzione “ordinaria” susseguente, di cui all’art. 319 c.p.,
attesa la generale ed onnicomprensiva struttura di tale reato.
Su una linea divergente si colloca, invece, una minoranza dottrinale, che ritiene astrattamente configurabile il
reato di corruzione susseguente in atti giudiziali sul presupposto che l’atto contrario ai doveri di ufficio, in
quanto idoneo a determinare un mutamento in meglio o in peggio della posizione di una delle parti nel
processo, attraverso il successivo accordo, può venir fatto proprio da entrambi i soggetti in quell’effetto di
danno o vantaggio che esso può produrre; l’intervenuto accordo dimostrerebbe così, sia pure a posteriori,
che il corruttore ha inteso l’atto come compiuto ovvero omesso a suo favore, tanto da retribuirlo, e che nel
medesimo senso lo ha inteso il corrotto, ricevendo l’utilità con quella direzione psicologica.
Nel senso della inclusione, nella figura di reato dell’art. 319 ter c.p., anche della corruzione susseguente,
potrebbero infine annoverarsi anche quelle impostazioni che, pur con riferimento alla diversa questione della
ammissibilità della corruzione impropria in atti giudiziali, individuano sostanzialmente, a fondamento della
figura autonoma introdotta dal legislatore nel 1990, la volontà di “voler evitare qualsiasi forma di mercimonio
allorchè l’atto della pubblica amministrazione dovesse riguardare la speciale funzione giudiziaria”, di talchè
l’oggetto della tutela si risolverebbe, in definitiva, nella “incontaminatezza da qualsiasi forma di incidenza
dettata da finalità di lucro”.
Se, infatti, l’essenza della norma stesse nel divieto, per chi eserciti funzioni giudiziarie, di ricevere comunque
denaro od altra utilità ad esse collegata, a poco rileverebbe, in definitiva, anche la collocazione cronologica
della utilitas rispetto all’atto compiuto o da compiere, indubbiamente recessiva a fronte di una superiore
esigenza di preservazione assoluta del bene della correttezza dell’operato giudiziario.
3. Queste Sezioni Unite aderiscono all’orientamento prevalente, espresso nelle sentenze nn. 25418/2007 e
36323/2009, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
3.1 Nel senso della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziali anche nella forma della corruzione
susseguente è inequivoca - anzitutto - la formulazione letterale dell’art. 319 ter c.p., che riconnette la
sanzione in esso prevista ai “fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.”.
L’art. 12 disp. gen., comma 1, (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) dispone che il primo canone interpretativo della
norma giuridica è quello letterale, dovendosi prevalentemente attribuire alla legge il senso “fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
Il successivo accenno alla “intenzione del legislatore” consente il ricorso alla c.d. “interpretazione logica” nel
caso in cui il senso letterale della norma non dovesse risultare di univoca e chiara interpretazione. In tal
caso, per la individuazione della mens legis, può farsi ricorso ai lavori preparatori, fermo comunque il
fondamentale principio ermeneutico secondo il quale, una volta entrata in vigore, la norma giuridica ha una
propria vita, autonoma rispetto alle intenzioni di chi la pose in essere.
Le Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema (già con la sentenza 5.7.1982, n. 4000) hanno affermato il
215
Parte speciale primato dell’interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, il cui impiego ha carattere sussidiario a
causa della loro funzione ausiliaria e secondaria, riflettendo l’ordine con cui i diversi criteri interpretativi sono
enunciati dall’art. 12 preleggi, secondo una gerarchia di valori non alterabile.
L’indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta, pertanto, in via
primaria, sul significato lessicale della stessa, che, se chiaro ed univoco, non consente l’utilizzazione di altre
vie di ricerca.
Ciò comporta che, quando l’interpretazione letterale di una norma sia sufficiente ad individuarne il relativo
significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere ai criteri ermeneutici sussidiali,
poichè il ricorso a tali canoni secondari non può portare al risultato di modificare la volontà della norma come
inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti dubbia
o ambigua l’intento del legislatore assume un ruolo paritetico in seno al procedimento interpretativo, sì che
funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare. La stessa mens
legis, inoltre, può assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso,
eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il
sistema normativo (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass. civ. 6 aprile 2001, n. 5128).
L’applicazione del canone ermeneutico letterale alla formulazione dell’art. 319 ter c.p., elimina la possibilità di
una interpretazione riduttiva, poichè la norma in oggetto risulta formulata con un rinvio puro e semplice alle
disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p., e tali disposizioni contemplano tutti i tipi di corruzione: propria,
impropria, antecedente e susseguente.
Escludendo la corruzione susseguente dal paradigma dell’art. 319 ter c.p., si violerebbe il principio di legalità,
dato che si verrebbe arbitrariamente a ritagliare solo sul tipo della corruzione antecedente il rinvio operato nel
comma 1 di detta norma a tutti i fatti di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p..
3.2 I “fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.p.” - testualmente richiamati dall’art. 319 ter c.p. - si identificano
con le condotte poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fanno esclusivamente riferimento le due
disposizioni anzidette (mentre la punibilità di colui che da o promette il denaro o altra utilità è sancita dal
successivo art. 321 c.p., al pari di quanto avviene per la corruzione in atti giudiziali) e tali condotte vanno
individuate nel compimento dell’atto (conforme o contrario ai doveri) dell’ufficio, più che nella ricezione o
nell’accettazione della promessa di denaro o di altra utilità.
L’art. 319 ter c.p. collega, però, a tutti i fatti indicati nei precedenti artt. 318 e 319 c.p. la finalità di ‘favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”.
Secondo la sentenza n. 33435/2006 (Battistella), da tale previsione discenderebbe logicamente che l’atto del
pubblico ufficiale debba essere realizzato solo sulla base di un previo accordo con il corruttore o di una
previa ricezione di denaro o altra utilità (corruzione antecedente). Infatti, se la corruzione fosse susseguente,
non potrebbe dirsi che la retribuzione o la promessa fatta al pubblico ufficiale avvenga “per favorire o
danneggiare una parte”, dato che l’atto è stato già compiuto. Per ammettere la forma della corruzione
susseguente nell’art. 319 ter c.p., tale espressione normativa dovrebbe ritenersi implicitamente affiancata da
quella “per avere favorito o danneggiato una parte”, ma ciò contrasterebbe con il principio di tassati vita delle
fattispecie penali.
Osserva al riguardo il Collegio - tenuto anche conto della formulazione dell’art. 319 ter c.p., comma 2, ove
viene prevista un’aggravante ad effetto speciale nel caso in cui “dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno
...” - che il fine di arrecare vantaggio o danno nei confronti di una parte processuale va riferito al pubblico
ufficiale, poichè è questi che, compiendo un atto del proprio ufficio, può incidere sull’esito del processo: è
l’atto o il comportamento processuale che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non
imparziale (non la condotta di accettazione della promessa o di ricezione del denaro o di altra utilità) e
l’anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale del pubblico
ufficiale.
Ciò che conta è la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto del pubblico ufficiale: se essa (per
qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica;
216
Scheda di giurisprudenza n. 22 prospettive di vantaggi economici o di benefici pubblici o privati;
sollecitazioni della parte interessata o di altri) è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è
indifferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell’atto, come pure è
irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio.
La finalità sì riferisce al fatto ed il valore del profilo soggettivo diviene così preponderante ai fini della
ipotizzabilità del fatto di corruzione giudiziaria da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio
e atto di ufficio, rimanendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere di
imparzialità e terzietà (non solo soggettiva ma anche oggettiva) costituzionalmente presidiato, così da
alterare la dialettica processuale.
L’elemento soggettivo peculiare (come rilevato nella sentenza Giombini) “finalizza la stessa tipicità dei fatti
previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità del contegno”.
Trattasi di un comportamento psicologicamente orientato, riconducibile a quelli che, come viene rilevato in
dottrina, “per la loro stessa natura o per i modi di estrinsecazione nella realtà, parlano, per così dire, il
linguaggio del dolo”.
È opportuno altresì evidenziare il rapporto di specialità che sussiste tra la corruzione “comune” di cui agli artt.
318 e 319 c.p. e la corruzione in atti giudiziali, con la conseguenza che la species di cui all’art. 319 ter c.p.
non può non contenere tutti gli elementi del genus (quindi quelli integranti la corruzione propria ed impropria,
antecedente e susseguente), ai quali si aggiunge l’elemento specializzante di essere commessa per favorire
o danneggiare una parte.
3.3 Quanto all’atteggiarsi del dolo, poi, sono senz’altro da condividersi le argomentazioni svolte nella
medesima sentenza Giombini (di cui si è detto diffusamente dianzi).
È vero che, nel caso della corruzione antecedente, la condotta del pubblico ufficiale, rivolta a favorire o
danneggiare una parte, trova la sua ragione in un accordo corruttivo già intervenuto, laddove invece, nella
corruzione susseguente, la condotta medesima non costituisce la controprestazione rispetto ad una
promessa o ad una dazione di denaro o di altra utilità: l’attività giudiziaria, però - in entrambi i casi - resta
comunque influenzata dall’atto o dal comportamento contrario ai doveri d’ufficio, mediante il quale si realizza
il fine perseguito dal pubblico ufficiale.
In tutte le forme di corruzione antecedente (e quindi anche nella corruzione antecedente in atti giudiziali)
l’atto o il comportamento del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta del corrotto
penalmente rilevante già in itinere. Nelle ipotesi di corruzione susseguente, invece, l’atto del pubblico ufficiale
si inserisce nel contesto di una condotta che non ha ancora assunto rilevanza penale con riferimento al
delitto di corruzione e che tale rilevanza assume se, successivamente all’atto o al comportamento, il pubblico
ufficiale accetta denaro o altra utilità (ovvero la loro promessa) per averlo realizzato. Pure in questo caso,
comunque, si è in presenza di una strumentalizzazione della pubblica funzione, sotto l’aspetto particolare,
quanto alla corruzione in atti giudiziali, di uno sviamento della giurisdizione (anche solo tentato), non essendo
necessario, infatti, per il perfezionamento del reato, che la finalità avuta di mira sia conseguita.
Le considerazioni anzidette si attagliano agevolmente ai casi di corruzione susseguente propria; mentre
perplessità vengono manifestate in dottrina per la corruzione susseguente impropria, evidenziandosi che un
atto conforme ai doveri di ufficio, in mancanza di un accordo preventivo, difficilmente può essere considerato
volto a favorire o danneggiare una parte nel momento in cui è stato posto in essere per il solo fatto che
successivamente il pubblico ufficiale riceva per esso denaro o altra utilità.
La circostanza che oggettivamente sussistano difficoltà probatorie, però, non può essere confusa con la
ontologica strutturale impossibilità di realizzare un tale tipo di corruzione.
3.4 Nè argomentazioni decisive, a favore della tesi contraria alla configurabilità della corruzione in atti
giudiziali susseguente, possono farsi derivare dalla prospettazione che la disposizione di cui all’art. 319 ter
c.p. si pone in continuità normativa con l’art. 319 c.p., comma 2, che - nella formulazione anteriore alla sua
sostituzione ad opera della L. 26 aprile 1990, n. 86, art. 7 - prevedeva un aumento della pena per la
corruzione propria antecedente “se dal fatto deriva ... il favore o il danno di una parte in un processo ...”.
217
Parte speciale La L. n. 86 del 1990, infatti, ha introdotto un’autonoma figura delittuosa per la corruzione in atti giudiziali, in
un contesto ispirato alla ratio generale dell’inasprimento delle sanzioni per i fatti di corruzione, con lo scopo
pratico di sottrarre la preesistente aggravante al giudizio di bilanciamento e di anticipare la soglia della tutela
(e, quindi, della punibilità) nella più ampia finalizzazione di rafforzamento del dovere di imparzialità, il quale
incombe su tutti i pubblici dipendenti, ex art. 97 Cost., comma 1, ma assume peculiari connotazioni per
coloro che partecipano, con un ruolo potenzialmente decisivo, all’attuazione della giurisdizione.
Se lo scopo della innovazione legislativa è stato, dunque, quello di apprestare una più incisiva tutela alla
funzione giurisdizionale, per la preminente rilevanza che essa ha nell’organizzazione statuale, non è dato
comprendere per quale ragione ciò dovrebbe valere solo per la corruzione antecedente, mentre quella
susseguente resterebbe residualmente relegata nell’ambito della sfera di operatività degli artt. 318 e 319 c.p.
e sarebbe conseguentemente parificata ad una corruzione “comune”, il che palesemente integrerebbe un
contrasto sistematico con la stessa L. n. 86 del 1990, che ha inteso differenziare la corruzione in atti
giudiziari dalla corruzione “comune”.
Nella medesima prospettiva va letta la rilevanza penale - desumibile dall’art. 321 c.p. con il suo integrale
rinvio all’art. 319 ter c.p. - della condotta dell’extraneus in tutti i casi di corruzione in atti giudiziari, rispetto
all’irrilevanza della condotta dell’extraneus nel caso di corruzione “comune” impropria susseguente.
Appare del resto assolutamente irrazionale ed asistematico ritenere che la disciplina penalistica della
“corruzione in atti giudiziari” non sarebbe rinvenibile integralmente nell’art. 319 ter c.p. (che reca tale testuale
rubrica) ma sarebbe contenuta in ben tre norme: la corruzione antecedente, propria e impropria, nell’art. 319
ter c.p.;
quella impropria susseguente nell’art. 318 c.p., comma 2; quella propria susseguente nell’art. 319 c.p..
[...Omissis...]
218
Scheda di giurisprudenza n. 23 Scheda di giurisprudenza n. 23
La finalità dell’apposizione di sigilli
TRACCIA
Nell’ambito dell’esercizio di ritrovo Alfa, veniva effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande
senza le autorizzazioni prescritte dalla legge; per tale ragione, in particolare, la macchinetta del caffè ed una
scaffalatura di esposizione bevande venivano sottoposti a sigilli da parte dell’Autorità amministrativa. Delle
cose veniva nominata custode Mevia, che tuttavia violava i predetti sigilli, usufruendo dei servizi forniti dalle
cose su cui gli stessi insistevano. Per tale ragione, Mevia, cui veniva contestato il delitto di cui all’art. 349
c.p., si rivolgeva ad un legale per ottenere delucidazione in ordine alla sua posizione e alle conseguenze
della sua condotta.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevia, rediga motivato parere circa la configurabilità o meno del
reato contestato..
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito investe l’integrazione del delitto di violazione di sigilli, di cui
all’art. 349 c.p. (inserito nell’ambito dei reati commessi dai privati contro la Pubblica
Amministrazione), anche nel caso in cui la finalità per la quale i medesimi vengano apposti
non sia quella di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa, scopo che la norma
espressamente si prefigge, ma quella invece di impedirne l’uso illegittimo. In tal caso, invero, il
riferimento sarebbe dunque al profilo funzionale della cosa oggetto di apposizione di sigilli
e non alla sua materialità, aspetto invece cristallizzato nell’art. 349 c.p.
La giurisprudenza si è così interrogata circa la possibilità che anche la seconda menzionata
finalità, sebbene non prevista espressamente dalla norma de qua, possa integrare il delitto di
violazione di sigilli.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
In tema, prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, la giurisprudenza aveva
elaborato due differenti orientamenti.
2.1. Il primo orientamento: Configurabilità del delitto anche in
presenza della finalità volta ad impedire l’illegittimo uso della cosa.
Secondo un primo orientamento, maggioritario (Cass. pen., Sez. VI, 11 dicembre 1969, n. 2401;
Cass. pen., Sez. VI, 22 febbraio 1984, n. 4943; Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 1985, n. 2109;
Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 1986, n. 1066; Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 1988, n. 926; Cass.
pen., Sez. VI, 28 aprile 1993, n. 7961; Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2001, n. 36210; Cass. pen.,
Sez. III, 28 gennaio 2003, n. 10267; Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2003, n. 26004; Cass. pen.,
Sez. III, 28 settembre 2004, n. 42900; Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2007, n. 6417; Cass. pen.,
Sez. III, 5 luglio 2007, n. 34151; Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 2008, n. 19722), il delitto di
219
Parte speciale violazione di sigilli ben sarebbe integrabile anche in presenza dell’apposizione di sigilli volta
ad impedire che la cosa venga utilizzata in modo illegittimo.
1° Argomento: oggettività giuridica. L’oggetto giuridico del delitto de quo deve essere
invero individuato nella tutela dell’intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione
o di manomissione, dovendo essere così ricondotta alla finalità di assicurarne la
conservazione anche l’interdizione dell’uso della medesima disposta dall’autorità, senza che
rilevino le finalità o le ragioni del provvedimento limitativo.
2° Argomento: interpretazione ampliativa. A mente di tale tesi, la lettera della norma non
pone alcun parametro insuperabile circa la sua interpretazione: in particolare, “conservare una
cosa letteralmente significa mantenerla nello stato in cui attualmente si trova e quindi,
poiché anche il non uso è uno stato, tra i significati che tale espressione è suscettibile di
esprimere vi è anche quello di sottrarre la cosa all’esercizio di ogni facoltà altrui compresa
quella di farne uso” (già Cass. pen., Sez. VI, 11 dicembre 1969, n. 2401).
2.2. Il secondo orientamento: Inconfigurabilità del delitto anche in presenza della finalità
volta ad impedire l’illegittimo uso della cosa.
Un secondo orientamento giurisprudenziale, del tutto minoritario (Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio
1982, n. 7934; Cass. pen., Sez. VI, 24 novembre 1987, n. 5248; Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre
1999, n. 13710; Cass. pen., Sez. II, 12 dicembre 2003 n. 3416/04), ritiene invece inconfigurabile
il reato di violazione di sigilli in presenza di uno scopo diverso da quello codificato dalla
norma, e dunque da quello di assicurare la conservazione o l’identità della cosa.
1° Argomento: principio di tassatività. Le finalità codificate dall’art. 349 c.p. sono infatti
tassative, non potendo dunque né essere ampliare né comprendere scopi differenti, quale
quello, in esame, volto ad evitare un uso illegittimo della cosa.
2° Argomento: tenore testuale. In ragione di un’interpretazione strettamente letterale
della norma de qua, il legislatore avrebbe senza alcun dubbio inteso dare rilevanza penale
alla sola violazione dei sigilli apposti per evitare manomissioni dirette a alterare l’oggettiva
consistenza della cosa.
3. La soluzione delle Sezioni Unite: Configurabilità del delitto anche in
presenza della finalità volta ad impedire l’illegittimo uso della cosa.
La questione, portata innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. Un.,
10 febbraio 2010, n. 5385), è stata dalle stesse composta, aderendo alla prima delle tesi testé
esposte.
1° Argomento: ratio legis. A ben vedere, ad una simile conclusione conducono quei
criteri propri dell’interpretazione logica cui, ex art. 12 disp. prel., il giudice deve fare ricorso per
stabilire quale sia la reale intenzione del legislatore, con il solo limite rappresentato dalla lettera
della norma nella sua massima capacità di espansione. In particolare, la voluntas legis non deve
essere considerata in senso soggettivo, bensì oggettivo (ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 13
maggio 2008, n. 36845), motivo per cui non è importante stabilire quale fosse lo scopo perseguito
dal legislatore al momento dell’introduzione della norma, quanto piuttosto individuare quale sia la
funzione cui la medesima è preposta.
220
Scheda di giurisprudenza n. 23 2° Argomento: ragioni storiche. L’art. 349 c.p. riproduce, senza rilevanti differenze, l’art.
201 del previgente Codice penale, del 1889, disposizione a sua volta ripresa dai codici
preunitari, in particolare quello sardo del 1859 e quello toscano: è dunque una norma frutto di
un’elaborazione estremamente lontana nel tempo. Per tale ragione, più che al tenore letterale
della medesima, è necessario valutare e tenere in considerazione le esigenze di tutela cui è
ispirata, ossia assicurare il funzionamento della Pubblica Amministrazione, lato sensu intesa,
“garantendo il rispetto dovuto a quelle custodie materiali - meramente simboliche, in quanto
costituiscono non tanto un mezzo di impedimento fisico all’attività interdetta, quanto piuttosto un
segno di avvertimento delle conseguenze giuridiche di tale attività - mediante le quali si manifesta
la volontà dello Stato diretta a preservare determinate cose da ogni atto di disposizione o di
manomissione da parte di persone non autorizzate”.
3° Argomento: profilo sistematico. La protezione delle cose sottoposte a vincolo è
demandata anche ad altre nome incriminatrici, nella specie gli artt. 334, “Sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall’autorità
amministrativa”, 351, “Sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di corpi
di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico
ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio”, e 388, co. 3,
“Sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o il deterioramento di cose, di proprietà
dell’agente, sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo” c.p.
Rispetto a tali norme, tutte di portata generale, in quanto prescindono dalla finalità per cui
il vincolo è stato posto, l’art. 349 c.p. rappresenta una forma di tutela prodromica: non è diretta
infatti immediatamente sulla materialità dei beni custoditi ma incentrata sulla repressione dei
comportamenti che incidono sui segni esteriori della custodia.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene di poter affermare che nei confronti di Mevia ben possa essere confermata dal
giudice l’imputazione per il delitto di violazione dei sigilli di cui all’art. 349 c.p.; invero, per giurisprudenza
ormai costante, fra le finalità dell’apposizione dei sigilli rientrano sia quelle volte ad assicurare la
conservazione e l’identità della cosa sia quelle volte ad evitare che della stessa possa esser fatto un uso
illegittimo. Uso illegittimo che, nel caso in esame, risulterebbe dall’utilizzo delle cose sottoposte a sigilli (e
dunque dall’utilizzo della macchinetta del caffè e della scaffalatura di esposizione di bevande senza le
necessarie autorizzazioni previste dalla legge).
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 10 febbraio 2010, n. 5385
Estratto
[...Omissis...]
1. Il contrasto per cui il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è molto netto, avendo dato luogo a decisioni
221
Parte speciale opposte in situazioni quasi identiche, e si è radicalizzato senza che le due diverse tesi siano state fatte
oggetto di particolari approfondimenti, stante l’essenzialità dell’apparato argomentativo delle varie pronunce.
L’area in cui vi è stata difformità rispetto all’orientamento nettamente maggioritario è però piuttosto limitata,
riguardando in tutto solo quattro casi di violazione di sigilli apposti per impedire la prosecuzione di attività
commerciali o artigianali esercitate in assenza delle necessarie autorizzazioni.
Per la stessa finalità, quella di impedire il protrarsi di attività svolte senza il rispetto della normativa che le
disciplina, i sigilli violati risultano essere stati apposti in casi del tutto analoghi in cui è stata adottata la
soluzione contraria.
Nessun contrasto rispetto all’orientamento prevalente si è invece mai verificato nelle fattispecie, le più
numerose tra quelle che hanno dato luogo a pronunce di questa Corte, in cui i sigilli violati risultano essere
stati apposti per impedire la prosecuzione di costruzioni abusive o altre attività in campo edilizio.
2. L’orientamento minoritario si è attestato su una interpretazione strettamente letterale della norma
incriminatrice e ha quindi senz’altro ritenuto, senza indagare quelle che potrebbero essere state le ragioni di
una simile scelta, che il legislatore abbia voluto attribuire rilevanza penale alla sola violazione dei sigilli
apposti per evitare manomissioni dirette ad alterare l’oggettiva consistenza della cosa.
L’orientamento prevalente ha ritenuto invece, sin dalla pronuncia più risalente nel tempo (Sez. 6^ 11/12/69 n.
2401), che la lettera dell’art. 349 c.p., se non ci si ferma alla più comune accezione delle espressioni usate,
non delinea affatto in modo insuperabile un perimetro così limitato.
Ciò sul rilievo che “conservare una cosa” letteralmente significa mantenerla nello stato in cui attualmente si
trova e quindi, poichè anche il non uso è uno stato, tra i significati che tale espressione è suscettibile di
esprimere vi è anche quello di sottrarre la cosa “all’esercizio di ogni facoltà altrui compresa quella di farne
uso”.
Ritenuto quindi che vi fosse spazio agevolmente percorribile per una interpretazione estensiva della norma
incriminatrice di cui si tratta, che non contrasta con il principio di stretta legalità vigente in materia penale non
risolvendosi in applicazione analogica in malam partem, l’orientamento prevalente è approdato alla
conclusione che il fine di conservazione della cosa, che deve connotare l’apposizione del sigillo perchè la
sua violazione abbia rilevanza, comprende anche il fine di impedirne l’uso, non solo quello di preservarne la
materialità.
3. Le Sezioni Unite ritengono di aderire alla soluzione data alla dall’orientamento prevalente, sul rilievo che
ad essa conducono i criteri propri della interpretazione logica cui, ai sensi dell’art. 12 delle Disposizioni sulla
legge in generale, il giudice deve lare ricorso, con il solo limite rappresentato dalla lettera della norma nella
sua massima capacità di espansione, per stabilire quale sia la reale intenzione del legislatore.
Intenzione che, secondo un canone ermeneutico ormai generalmente recepito e costantemente adottato
dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 3^ 13/5/08 n. 36845 con riferimento al reato di cui
all’art. 674 c.p.) va considerata non in senso soggettivo ma in senso oggettivo, come voluntas legis, sicchè
non è importante tanto stabilire (soprattutto se, come nel caso di specie, l’origine della norma è lontana nel
tempo) quale fosse lo scopo perseguito da chi l’ha redatta, quanto piuttosto individuare quale è la funzione
cui essa risponde nel contesto del sistema in cui è attualmente inserita; e ciò al di là delle parole usate che,
nella loro accezione più comune, possono non essere, per le più svariate ragioni, le più idonee a
compiutamente rivelare la ratio della disposizione.
4. Posta questa premessa, va anzitutto rilevato, sotto il profilo storico, che il testo dell’art. 349 del vigente
codice penale, collocato nel capo riguardante i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione,
riproduce, senza rilevanti variazioni ai fini che qui interessano, quello del precedente art. 201 c.p. del 1889, e
che quest’ultima disposizione era stata mutuata dai codici preunitari (il codice sardo del 1859, che ha imitato
la comune casistica del codice francese del 1810, e il codice toscano).
Si tratta dunque di una norma elaborata secondo tecniche e con riferimento a realtà molto lontane nel tempo,
sicchè più che all’aspetto descrittivo è all’esigenza da cui è ispirata che occorre avere riguardo.
Tale esigenza è stata sempre individuata dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte
222
Scheda di giurisprudenza n. 23 (cfr., tra le molte, Sez. 6^ 10/12/85 n. 2109, Manone, rv. 172.144; Sez. 6^ 15/4/88 n. 926, Tranchino, rv.
180.266; Sez. 3^ 28/9/04 n. 42900, Giuliani, rv. 230.307) nell’interesse di assicurare il normale
funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato garantendo il rispetto dovuto a quelle custodie
materiali - meramente simboliche, in quanto costituiscono non tanto un mezzo di impedimento fisico
all’attività interdetta, quanto piuttosto un segno di avvertimento delle conseguenze giuridiche di tale attività mediante le quali si manifesta la volontà dello Stato diretta a preservare determinate cose da ogni atto di
disposizione o di manomissione da parte di persone non autorizzate.
E poichè questo interesse dello Stato si presenta in moltissimi campi - e all’apposizione di sigilli sono
legittimate a fare ricorso, per manifestare erga omnes la presenza di un siffatto vincolo giuridico su
determinati beni, sia l’autorità giudiziaria e quella di polizia, nei procedimenti penali e in quelli civili, sia, come
è avvenuto nel caso di specie, l’autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 5
recante norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 - l’ambito di possibile applicazione dell’art.
349 c.p. risulta molto ampio.
5. Proseguendo nell’indagine diretta a verificare - al di là del dato letterale su cui si fonda l’orientamento
giurisprudenziale restrittivo - se esista qualche pregnante ragione per ritenere che la voluntas legis sia di
escludere dalla tutela penale dei sigilli i casi, molto numerosi, in cui la loro apposizione è precipuamente
finalizzata a impedire l’uso della cosa assicurata con questo mezzo piuttosto che a preservarne l’integrità, è
utile ancora ricordare, sotto il profilo sistematico, che la protezione delle cose sottoposte a vincolo è
demandata anche ad altre norme incriminatrici come l’art. 334 c.p. (che punisce la sottrazione o il
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall’autorità
amministrativa), l’art. 351 c.p. (che punisce la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o
deterioramento di corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un
pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio) e l’art. 388 c.p.,
comma 3 (che punisce la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o il deterioramento di cose, di
proprietà dell’agente, sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo).
Rispetto a queste norme - che sono tutte di portata generale, prescindendo dalla specifica finalità per cui il
vincolo sulla cosa è stato posto - quella sulla violazione dei sigilli chiaramente rappresenta, come è stato
rilevato in dottrina, una forma di tutela “prodromica”, in quanto non diretta immediatamente sulla materialità
dei beni custoditi ma incentrata sulla repressione dei comportamenti che incidono sui segni esteriori della
custodia.
6. Il profilo funzionale che emerge da quanto sinora evidenziato è dunque decisivo, insieme a quello
sistematico, per la risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite.
Ed invero, poichè il sigillo si configura come un mezzo di portata generale destinato a rafforzare la protezione
delle cose che l’autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il
perseguimento dei suoi compiti istituzionali, appare del tutto coerente ritenere che la effettiva voluntas legis
sia di attribuire la stessa ampiezza anche alla tutela penale che a tale strumento si è inteso riconoscere.
È significativo, infatti, che in dottrina sia pervenuto a questa stessa conclusione - sul rilievo che le finalità
indicate dall’art. 349 c.p. non sono di per sè escluse dalla eventuale compresenza di fini ed obiettivi ulteriori
rispetto alla conservazione o alla identità della cosa, che si vogliono strumentalmente garantire - anche chi
ritiene che le espressioni usate nella norma facciano riferimento alla cosa nella sua materialità.
Come è stato rilevato nella sentenza 12/1/07 n. 6417 della Sezione 3^, contrasterebbe d’altra parte in modo
evidente con la ratio della incriminazione che venissero sottratte alla tutela penale apprestata dall’art. 349
c.p. molte e importanti ipotesi di sequestro cautelare disposto dall’autorità giudiziaria; conseguenza questa
cui si perverrebbe alla stregua dell’orientamento, formatosi sui ricordati casi di sequestro amministrativo, che
privilegia una interpretazione strettamente letterale della norma.
Ciò in particolare accadrebbe per il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.) - in relazione al quale
l’applicabilità dell’art. 349 c.p. è stata invece specificamente ritenuta (cfr. Sez. 3^ 24/1/06 n. 6446, Ornano e
altri, rv. 233.312) - che è preordinato proprio ad impedire la disponibilità della cosa pertinente al reato, per
223
Parte speciale evitare che dall’uso di essa possa derivare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze o
l’agevolazione della commissione di altri reati.
7. Va quindi affermato il principio di diritto che il reato di cui all’art. 349 c.p. è configurabile anche quando la
condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti per impedire l’uso illegittimo della cosa.
Pertanto il ricorso dell’imputata va rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste
dall’art. 616 c.p.p..
[...Omissis...]
224
Scheda di giurisprudenza n. 24 Scheda di giurisprudenza n. 24
Esercizio abusivo della professione di esperto contabile
TRACCIA
Con sentenza emessa il 10 novembre 2009 in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano condannava
Tizio alla pena di legge, dichiarandolo colpevole, limitatamente ai fatti commessi dopo il 7 maggio 2001 (con
contestuale declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione riguardo a quelli anteriori), dei reati,
ritenuti avvinti dalla continuazione, di cui agli artt. 640, 61, comma primo, n. 11, cod. pen. (capo a), 482 , 476
cod. pen. (capo b) e 348 cod. pen. (capo c), perché, con artifizi e raggiri consistiti nello spacciarsi per dottore
commercialista e nel formare e presentare falsi certificati attestanti il versamento degli importi dovuti (oltre a
un falso relativo alla presentazione di una domanda di accertamento di invalidità civile), e nell’ottenere
conseguentemente da Mevio, Sempronio e Seiana, così indotti in errore, l’incarico, abusivamente svolto, di
tenere la contabilità e provvedere alle dichiarazioni e ai pagamenti relativi ai vari tributi dovuti (e ai contributi
previdenziali per l’attività autonoma), e la consegna di somme da versare a tali titoli, tratteneva per sé tali
somme, così realizzando un ingiusto profitto, con relativo danno per le parti lese.
Su appello dell’imputato, con sentenza del 10 gennaio 2011, la Corte di appello di Milano confermava la
pronuncia del Tribunale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, valuti l’opportunità di proporre ricorso per cassazione in
particolare in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 348 c.p.
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito si incentra sull’art. 348 c.p., che punisce chi “abusivamente
esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” e che
rinviene la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse generale a che determinate
professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano
esercitate solo da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in
possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. La norma de qua, per la sua
concreta operatività, opera un rinvio in favore di altre fonti (in particolare, discipline relative agli
ordinamenti professionali nonché discipline comunque rilevanti allo scopo), che, in via di
integrazione necessaria, precisino quali sono le professioni soggette alla speciale abilitazione
statale e quando il loro esercizio debba considerarsi, appunto, abusivo. Proprio per tale motivo, la
disposizione viene qualificata quale norma in bianco (Cass. pen., Sez. V, 17 ottobre 2001, n.
41142; Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2009, n. 47028); contra, una parte di dottrina, supportata
anche da una pronuncia della Consulta (C. Cost., 27 aprile 1993, n. 119; nonché Cass. pen., Sez.
VI, 27 marzo 2003, n. 22528), che ritiene non sussistano gli estremi di una norma penale in bianco,
l’art. 348 c.p., delineando in modo esauriente l’illecito in tutte le sue componenti essenziali.
Ad ogni modo, ciò che la norma considera in concreto abusivo è la mancanza dell’iscrizione
dell’albo di riferimento del professionista: l’iscrizione, infatti, il cui presupposto è il
conseguimento di pregressi titoli è configurata infatti quale condizione per l’esercizio della
professione.
In particolare, in relazione a tale aspetto, ci si è chiesti se le condotte di tenuta della contabilità
aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, qualora
225
Parte speciale svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito da chi non sia iscritto al relativo albo
professionale, integrino il reato di esercizio abusivo della professione di ragioniere, perito
commerciale o dottore commercialista; posto che l’esercizio abusivo punito dalla norma deve
avere naturalmente una rilevanza esterna (Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2002, n. 12177;
Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2000, n. 12980), si tratta di comprendere quali siano in concreto
gli atti che sostanzino l’esercizio della professione, se solo quelli attribuiti in via esclusiva a
una determinata professione oppure tutti gli atti, per così dire, caratteristici della medesima, e
dunque sia gli atti attribuiti in via esclusiva sia gli atti c.d. liberi, potendo essere compiuti da
chiunque, anche a titolo occasionale e gratuito.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla distinzione fra dolo
eventuale e colpa cosciente.
In merito, le tesi formatesi erano due.
2.1. Il primo orientamento: Tesi restrittiva.
A mente dell’orientamento tradizionale (Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2003, n. 17921; Cass.
pen., Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 22258; Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 30590; Cass. pen.,
Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 17702; Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2007, n. 342000), gli atti rilevanti
ai fini dell’incriminazione di cui all’art. 348 c.p. sarebbero solo quelli attribuiti in via esclusiva ad
una determinata professione; altrimenti opinando, si determinerebbe una indebita
compressione dei diritti di libertà e di iniziativa economica spettanti a ciascun individuo.
1° Argomento: configurazione del reato de quo in termini di reato istantaneo. Si ritiene
dunque che per integrarlo sia sufficiente anche un unico atto, appunto riservato, pur se
compiuto in modo occasionale e a titolo gratuito; qualora fossero stati posti in essere una
molteplicità di atti, questi sarebbero risultati avvinti dal vincolo della continuazione.
2° Argomento: criterio sostanzialistico. L’orientamento si preoccupa altresì di precisare il
modo in cui individuare tali atti riservati nel caso in cui dalle discipline non fossero
ricavabili criteri di sorta per procedere a tale perimetrazione. In applicazione del criterio
sostanzialistico, è necessario classificare gli atti compiuti in ragione dell’intrinseca
specificità e delicatezza di determinate attività, tale cioè da rendere incompatibile il loro
espletamento da parte di soggetti non muniti della relativa abilitazione.
2.2. Il secondo orientamento: Tesi estensiva.
Un secondo orientamento (Cass. pen., Sez. VI, 5 luglio 2006, n. 26829; Cass. pen., Sez. VI, 8
ottobre 2002, n. 49) ritiene che, invece, debbano assumere rilevanza tutti gli atti comunque
caratteristici di una determinata professione: nell’ambito di tali atti, devono essere inclusi sia
quelli attribuiti in via esclusiva (di cui alla teoria precedentemente esposta) sia quelli c.d. liberi,
ossia quegli atti che chiunque può compiere a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento
(strumentale alla professione) resta invece “riservato” qualora avvenga in modo continuativo,
organizzato e remunerato.
226
Scheda di giurisprudenza n. 24 1° Argomento: ratio della norma. Infatti, in entrambe le ipotesi di atti ricorre l’esercizio
della professione rilevante ai fini dell’integrazione del reato e dunque del pari ricorre in
entrambe le ipotesi la necessità di tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate
esigenze, a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o indegni di esercitarla.
3. La soluzione delle Sezioni Unite: L’adesione alla tesi estensiva.
La Cassazione (Cass. pen., Sez. Un., 23 marzo 2012, n. 11545; di recente, in termini, Cass. pen.,
Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 6467) ha aderito alla seconda tesi esposta, ritenendo necessaria
un’interpretazione estensiva dell’art. 348 c.p. e degli atti che devono essere ritenuti rilevanti ai
fini dell’integrazione dell’abusivo esercizio della professione, punito dalla norma. La Suprema
Corte così qualifica come penalmente rilevanti, qualora compiuti in modo abusivo, sia gli atti
attribuiti in via esclusiva sia gli atti liberi, quegli atti, cioè, che chiunque può compiere a titolo
occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentale alla professione) resta invece
“riservato” qualora avvenga in modo continuativo, organizzato e remunerato.
1° Argomento: tutela della ratio della norma de qua. Le Sezioni Unite fanno proprie le
considerazioni svolte in tema, ribandendo che sia negli atti esclusivi che in quelli caratteristici
si riscontra la medesima ratio di tutela.
2° Argomento: carattere di abitualità insito nel concetto di esercizio professionale. “Il
concetto di esercizio professionale contiene già in sè un tendenziale tratto di abitualità, e, se è vero
che da esso è giusto prescindere a fronte di atti che l’ordinamento riservi come tali, nell’interesse
generale, a una speciale abilitazione, ne è naturale, ragionevole ed ermeneuticamente rilevante il
recupero in presenza dell’indebita invasione di uno spazio operativo considerato dall’ordinamento
come specificamente qualificante una determinata professione, allorchè la stessa sia attuata con
modalità idonee a tradire l’affidamento dei terzi, per la tutela dei cui interessi l’esercizio di quella
professione è stato sottoposto a particolari cautele”.
3° Argomento: carattere unitario della tutela apprestata dal Codice del 1930. Le
conclusioni testé evidenziate trovano conforto nell’impianto codicistico che ha predisposto, in
relazione al sistema delle professioni soggette ad abilitazione, un sistema di tutela tale da
inglobare l’ampliamento e l’evoluzione, sia a livello normativo che pragmatico, che ne sono
seguiti nel tempo, la cui fondatezza ha trovato a sua volta conforto nell’art. 33, co. 5, Cost.
4° Argomento: d.P.R. n. 328/2001. Le conclusioni della Corte rinvengono altresì conforto
nell’art. 1, co. 1, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, chiaro nell’affermare che “le norme contenute nel
presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività
attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.
La Corte giunge così ad affermare che “concreta esercizio abusivo di una professione,
punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere
occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una
determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti
singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica
di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali,
per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di
chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da
227
Parte speciale soggetto regolarmente abilitato”.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che di dover sconsigliare a Tizio la proposizione di ricorso per Cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello che lo condannava, in quanto colpevole, fra gli altri, di esercizio
abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p. Invero, in ragione degli ultimi arresti giurisprudenziali, la
condotta di Tizio che con artifizi e raggiri consistiti nello spacciarsi per dottore commercialista e nel formare e
presentare falsi certificati attestanti il versamento degli importi dovuti, ottenendo così l’incarico, abusivamente
svolto, di tenere la contabilità e provvedere alle dichiarazioni e ai pagamenti relativi ai vari tributi dovuti, a ben
vedere sostanzia proprio quegli atti che integrano l’esercizio abusivo della professione, punito dall’art. 348
c.p.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 23 marzo 2012, n. 11545
Estratto
[...Omissis...]
5. Posizione assunta dalla sentenza impugnata.
La sentenza impugnata; nel confermare la condanna del C. anche per il reato di cui all’art. 348 c.p., ha fatto
puntuale applicazione dell’indirizzo “estensivo” sopra esposto, rilevando che nel caso sottoposto al suo
esame gli atti compiuti dal prevenuto, pur non essendo, come tali, riservati in via esclusiva alla professione di
ragioniere e perito commerciale, rientravano comunque fra quelli “relativamente liberi”, riconducibili alle
competenze indicate in via generale nella prima parte del cit. D.P.R. n. 1068 del 1953, art. 1, ed, essendo
stati compiuti in modo continuativo, sistematico e retribuito, integravano senz’altro il reato predetto.
6. Interpretazione delle norme sugli ordinamenti delle professioni contabili. Prima di affrontare il tema della
soluzione del contrasto innescato dalla sentenza Notaristefano, è opportuno soffermarsi un pò più
ampiamente sulla disciplina relativa alle professioni contabili vigente all’epoca dei fatti.
Si è già sopra illustrata parte del contenuto del D.P.R. n. 1068 del 1953, art. 1. Tale norma, in effetti,
proseguiva (comma secondo) introducendo l’obbligo per l’autorità giudiziaria e per le pubbliche
amministrazioni di affidare normalmente gli incarichi relativi alle predette attività ai ragionieri e periti
commerciali iscritti nell’albo “salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei
dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per
legge, ai propri dipendenti”.
In ogni caso, infine, la elencazione di cui al primo comma non era considerata ostativa all’esercizio “di ogni
altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, nè quanto può formare oggetto dell’attività
professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti” (comma terzo).
Quanto ai dottori commercialisti, il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, emanato parimenti in forza della ricordata
L. 28 dicembre 1952, n. 3060, recava nel suo art. 1, uno svolgimento sostanzialmente analogo a quello del
D.P.R. n. 1068, art. 1, riconoscendo (comma 1) in via preliminare ai dottori commercialisti “competenza
tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria”, e stabilendo poi,
nell’indicare gli atti rientranti nell’esercizio dell’attività protetta, che “in particolare” formavano oggetto della
228
Scheda di giurisprudenza n. 24 professione le seguenti attività: a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione ed ogni
altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d’ogni altro documento contabile delle
imprese; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società
commerciali.
La norma, poi, proseguiva (comma 2) introducendo l’obbligo per l’autorità giudiziaria e per le pubbliche
amministrazioni di affidare normalmente gli incarichi relativi alle predette attività di cui sopra a persone iscritte
nell’albo dei dottori commercialisti “salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei
ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l’Amministrazione pubblica conferisce per
legge ai propri dipendenti”. A differenza di quanto stabilito per l’esercizio della professione di ragionieri e
periti commerciali iscritti nell’albo, la norma (comma 3) prevedeva però la possibilità che l’incarico potesse
essere affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, purchè nel provvedimento di nomina si
giustificassero “i particolari motivi di scelta”.
Infine, con disposizione di tenore analogo a quella contenuta nell’omologa previsione del D.P.R. n. 1067 del
1953, art. 1, si stabiliva che la predetta elencazione non era da considerarsi ostativa all’esercizio “di ogni
altra attività professionale dei dottori commercialisti, nè quanto può formare oggetto dell’attività professionale
di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti” (comma 4).
Da notare poi che la Legge Delega n. 3060 del 1952, art. 1, stabiliva che il Governo si dovesse uniformare a
una serie di principi e criteri direttivi, tra cui rileva, per quanto qui di interesse (come meglio si vedrà più
innanzi), il primo:
“a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via
esclusiva”.
Questo essendo il tenore delle norme, una prima osservazione da fare è che le stesse contengono, accanto
a una previsione di competenze definite in modo del tutto generico (prima parte dell’art. 1), un’elencazione
specifica di attività ritenute formanti oggetto “in particolare” delle professioni. Ora, tale elencazione,
contrariamente a quanto affermato dalla sentenza Notaristefano e dalla prevalente giurisprudenza (vedi Sez.
6, n. 6157 del 28/02/1985, Giannaccini, Rv.
169824; Sez. 6, n. 2685 del 18/11/1993, dep. 1994, Salustri, Rv.
198235; Sez. 6, n. 904 del 21/10/1999, dep. 2000, Zambon, Rv. 215432;
Sez. 6, n. 13124 del 14/02/2001, Meloni, Rv. 218306), non ne comporta per sè l’attribuzione in via esclusiva.
L’elencazione è preceduta, invero, dalla semplice locuzione: “In particolare formano oggetto della
professione le seguenti attività”. Nell’ultimo comma degli artt. 1, poi (come già sopra ricordato), è
espressamente puntualizzato che “L’elencazione di cui ai presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni
altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, nè quanto può formare oggetto dell’attività
professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti”.
Se quanto sopra si legge doverosamente alla luce della Legge Delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo
la quale (come già ricordato) “la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare
attribuzioni di attività in via esclusiva”, non può che concludersi nel senso indicato da Corte cost. n. 418 del
1996, per la quale nelle norme delegate in esame “non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di
competenze”, e la succitata “espressione a norma di leggi e regolamenti, di cui all’ultimo comma di entrambe
le disposizioni (...) dei D.P.R. n. 1067 del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, deve doverosamente essere
intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche (...)
con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività
intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi”.
7. Soluzione del contrasto.
Il contrasto innescato dalla sentenza Notaristefano può e deve essere risolto, ad avviso del Collegio,
attraverso una interpretazione estensiva della norma dell’art. 348 c.p., che superi i limiti dell’orientamento
tradizionale, recuperando le ragioni sostanziali della detta sentenza, in un’ottica che tenga nel giusto conto la
229
Parte speciale ratio della norma incriminatrice e il contesto normativo in cui è destinata a operare, ma sia nel contempo
rispettosa del principio di tassativita.
Secondo l’orientamento sostenuto dalla Notaristefano, in sostanza, gli atti caratteristici “relativamente liberi”
di una determinata professione, non attribuiti ad essa in via esclusiva, qualificano comunque la medesima e
non possono, quindi, essere svolti, da chi non vi sia abilitato, in un modo che ne costituisca di fatto esercizio,
e cioè in forma stabile, organizzata e retribuita. In tal modo la tutela penale è estesa, dal singolo atto di per
sè riservato, allo svolgimento “sistematico” (riservato solo in quanto tale) di atti qualificanti (anche se
singolarmente non riservati). Il tratto comune alle due condotte si rinviene evidentemente nell’essere
entrambe espressione tipica e oggettiva dell’esercizio professionale.
Tale assunto è inaccettabile nella concreta applicazione che la sentenza ne fa: come riferito cioè a categorie
di attività definite in senso estremamente lato e generico. Esso, infatti, come si è sopra ricordato, è stato
applicato in relazione alla generale previsione, contenuta nella prima parte del D.P.R. 27 ottobre 1953, n.
1068, art. 1, relativa al riconoscimento di “competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica
commerciale, di economia aziendale nonchè in materia di amministrazione e di tributi”.
Il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, discendente da quello di legalità e riferibile, come
questo, non solo alle previsioni direttamente contenute nelle norme penali ma anche a quelle delle fonti
extrapenali che ne costituiscano sostanziale integrazione, impedisce di dare qualsiasi rilievo, ai fini della
norma di cui all’art. 348 c.p., a disposizioni di carattere così indeterminato, come quella sopra indicata (e
discorso analogo vale, ovviamente, per la consimile disposizione, contenuta nella prima parte del D.P.R 27
ottobre 1953, n. 1067, art. 1, secondo cui “Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle
materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria”).
L’interpretazione estensiva proposta nella Notaristefano è invece da condividere in riferimento a quelle
attività che, pur quando non siano attribuite in via esclusiva, siano però qualificate nelle singole discipline,
con previsione, beninteso, puntuale e non generica (in rispetto, quindi, del principio di tassativita), come di
specifica o particolare competenza di una data professione (tale è, ad es., proprio il caso delle surriportate
elencazioni di cui alla seconda parte del D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 1, e D.P.R. n. 1068 del 1953, art. 1). È
innegabile, infatti, che quando tali attività siano svolte in modo continuativo e creando tutte le apparenze
(organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, le
stesse costituiscano espressione tipica della relativa professione e ne realizzino quindi i presupposti
dell’abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale.
Il concetto di esercizio professionale contiene già in sè un tendenziale tratto di abitualità, e, se è vero che da
esso è giusto prescindere a fronte di atti che l’ordinamento riservi come tali, nell’interesse generale, a una
speciale abilitazione, ne è naturale, ragionevole ed ermeneuticamente rilevante il recupero in presenza
dell’indebita invasione di uno spazio operativo considerato dall’ordinamento come specificamente
qualificante una determinata professione, allorchè la stessa sia attuata con modalità idonee a tradire
l’affidamento dei terzi, per la tutela dei cui interessi l’esercizio di quella professione è stato sottoposto a
particolari cautele.
I precedenti rilievi che spingono a ricondurre le situazioni testè descritte nell’ambito applicativo dell’art. 343
c.p., ricevono un conforto essenziale dal carattere unitario del presidio che il codice penale del 1930
(innovando in ciò rispetto alla legislazione precedente) ha oggettivamente assicurato al complessivo sistema
delle professioni soggette ad abilitazione, con una proiezione normativa idonea a inglobarne l’ampliamento e
l’evoluzione che ne sono seguiti nel tempo, in un contesto corroborato, fra l’altro, dall’importante
riconoscimento costituzionale di cui all’art. 33 Cost., comma 5.
Esistono, come si è già ricordato, ordinamenti professionali “protetti” in cui si rinvengono indicazioni di attività
ritenute di competenza “specifica”, ma per le quali manca una espressa attribuzione di esclusiva. Tali
indicazioni, nei casi in cui l’attribuzione esclusiva non sia desumibile formalmente aliunde o attraverso il
ricordato criterio sostanzialistico, resterebbero, secondo l’orientamento tradizionale, e in maniera
irragionevolmente contrastante con la stessa previsione della professione “protetta”, delle vuote
230
Scheda di giurisprudenza n. 24 nomenclature. Diventa, così, decisivo per l’interprete lo stato reale della legislazione, che, ad onta di
sollecitazioni “aperturiste” provenienti da più parti, contempla tuttora un sistema di professioni organizzato in
Ordini/Collegi e rispettivi Albi ad appartenenza necessaria, non circoscritto alle sole attività destinate alla
tutela di essenziali valori costituzionali (come, in particolare, la salute e il diritto alla difesa in giudizio) e non
inscindibilmente connesso alla riserva di specifiche attribuzioni esclusive. Di tale assetto si ha significativa
conferma nel D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 1, comma 2, (recante Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti), laddove si dice che “Le Norme contenute nel
presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite
o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.
Gli esposti rilievi logico-sistematici, unitamente allo stesso tenore letterale dell’art. 348 c.p., impongono,
dunque, l’adesione all’interpretazione estensiva in discorso. La quale enuclea, in sostanza, accanto alla
“riserva” professionale collegata alla attribuzione in esclusiva dell’atto singolo, una riserva collegata allo
svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza
specifica: conclusione questa che si rivela, in definitiva - come già precisato -, l’unica coerente con un
sistema indistinto di Albi in cui non è indispensabile l’esistenza di riserva esclusiva di specifiche attività ma
che sono nel contempo ad appartenenza necessaria.
È importante, per evitare equivoci applicativi, ribadire con chiarezza che la condotta “abituale” ritenuta
punibile in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio
professionale, perchè solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per se stessi, si viola appunto
il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento
dell’affidamento dei terzi. Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità,
organizzazione o remunerazione, sia perchè il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è
munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque
acquisita, si è fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 348 c.p.. Tale vantazione va compiuta peraltro, in
conformità all’interesse protetto dal reato, su un piano generale e oggettivo, e non nella dimensione dello
specifico rapporto interpersonale, con quanto ne consegue ai fini della (persistente) irrilevanza scriminante
del consenso del singolo destinatario della prestazione abusiva.
Tirando le fila del discorso, si può affermate il seguente principio di diritto: “Concreta esercizio abusivo di una
professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere
occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione,
ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano
univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorchè lo stesso
compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale)
organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività
professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
8. Soluzione del caso e norme speciali sopravvenute.
Applicando le conclusioni in diritto che precedono alla fattispecie di causa, si deve osservare che le attività
ascritte al C. non erano incluse nelle positive elencazioni di quelle considerate di particolare competenza
della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale a sensi del D.P.R. n. 1067
del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, vigenti all’epoca. Esse, quindi - escluso, per le ragioni sopra esposte, di
poter valorizzare al riguardo le previsioni introduttive di carattere generale contenute negli stessi decreti restano del tutto fuori del campo di applicabilità dell’art. 348 c.p., quand’anche connotate dai caratteri di
continuatività, onerosità e organizzazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in relazione all’imputazione di cui
all’art. 348 c.p., perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ne consegue l’eliminazione della
relativa pena di un mese e dieci giorni di reclusione.
Per completezza, può aggiungersi che il successivo D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, emanato in attuazione
231
Parte speciale della delega conferita al Governo con la L. 24 febbraio 2005, n. 34, art. 2, ha sostituito i D.P.R. n. 1067 del
1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, istituendo l’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie (riproducente quella già relativa ai
commercialisti secondo il D.P.R. n. 1067 del 1953), ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta
competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta
competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili) dell’Albo, fra le quali sono state incluse le
seguenti: “a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione
contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle
società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarle e cura degli ulteriori
adempimenti tributari”.
Pur non recando più la legge delega n. 39 del 2005, la previsione, già presente nella legge delega 28
dicembre 1952, n. 3060, secondo la quale (criterio direttivo sub a) “la determinazione del campo delle attività
professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva”, e pur essendosi, nel D.Lgs. n. 139
del 2005, riformulata la clausola di salvezza per i soggetti non iscritti all’Albo oggetto dei decreto in un modo
che sembra riferirsi solo ai professionisti iscritti in altri Albi (“Sono fatte salve le prerogative attualmente
attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi”), non si ravvisano ragioni formali (in relazione alle
espressioni usate) o sostanziali (in relazione alla natura della professione di esperto contabile) per ritenere
che l’inserimento nell’elenco comune agli iscritti alle due Sezioni e nell’elenco separato relativo agli iscritti alla
Sezione B comporti ora l’attribuzione in via esclusiva delle relative attività.
Conferma decisiva di tale conclusione discende dalla constatazione che l’unico accenno, presente nella
nuova legge delega, ricollegabile in qualche modo a una possibile logica di competenza esclusiva (non
monopolistica), la sussistenza e i limiti della cui effettiva realizzazione restano ovviamente da verificare,
riguarda gli iscritti alla sezione A e si rinviene in particolare nella lett. d) dell’art. 3, laddove si prevede che “ È
consentita l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati
specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di
concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi.
Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed
elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione”.
La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di
elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari,
nell’elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente però ora
senz’altro di ritenere, alla stregua delle conclusioni sopra assunte, che lo svolgimento di esse, se effettuato
da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso
provenienti, le apparenze dell’attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è
punibile a norma dell’art. 348 c.p..
Il principio di diritto che da quanto sopra si può enucleare è il seguente: “Le condotte di tenuta della
contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non
integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito
commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dal D.P.R. nn. 1067 del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953,
anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e
retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta
conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in
questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs. n. 139 del
2005”.
9. Raffronto con la giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza civile. Le conclusioni adottate non
appaiono incompatibili con quanto affermato dalla citata Corte cost. n. 418 del 1996. Nell’occasione la
Consulta venne investita dal giudice a quo, nel corso di una controversia civile relativa al pagamento di
compensi per attività di consulenza aziendale espletata da una S.r.l., della questione di legittimità
232
Scheda di giurisprudenza n. 24 costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 1, commi 1 ed ultimo, (Ordinamento della professione
di dottore commercialista) e D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 1, commi 1 ed ultimo, (Ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale), “nella parte in cui riservano concretamente in via esclusiva a
quei professionisti l’esercizio professionale nelle materie della economia e della consulenza aziendale”:
questione sollevata in particolare in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione alla presunta
“violazione del criterio direttivo della Legge Delega 28 dicembre 1952, n. 3060, sulla revisione degli
ordinamenti professionali di dottore commercialista e di ragioniere, che all’articolo unico, lett. a), dispone che
la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via
esclusiva”. Gli ultimi commi degli artt. 1 dei D.P.R. n. 1067 del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, dettati in
applicazione del criterio direttivo della legge delega sul divieto di attribuzione esclusiva delle materie indicate
agli iscritti negli albi dei commercialisti, ben lungi dall’aver tale effetto, avevano di contro, secondo il giudice
rimettente, concretamente impedito l’esercizio di tale attività di consulenza a chi non fosse iscritto negli albi,
dal momento che, secondo il loro tenore testuale, solo i professionisti iscritti in altri albi potevano esercitare
nelle stesse materie, purchè loro attribuite da leggi e regolamenti. Poichè nessuna legge prescriveva alcun
“albo dei consulenti aziendali”, ne conseguiva che l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale in
materia “economica” ai commercialisti e ai ragionieri assorbiva anche quella di consulenza aziendale,
determinando l’esercizio esclusivo in favore di questi ultimi.
Nel risolvere la questione con pronuncia interpretativa di rigetto, la Consulta, come si è sopra visto, escluse
che nelle norme delegate fossero rinvenibili attribuzioni in via esclusiva di competenze, e interpretò la
clausola di cui all’ultimo comma degli artt. 1 dei D.P.R. n. 1067 del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, secondo
la quale l’elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica “quanto può
formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti” nel senso che
l’espressione “a norma di leggi e regolamenti”, doveva essere intesa “non con esclusivo riferimento a
professioni regolamentate mediante iscrizione ad albo, ma anche, per quel che qui più rileva, con riferimento
agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma
non collegati a iscrizione in albi”.
Com’è evidente dall’oggetto della pronuncia e dal suo tenore formale e sostanziale, il discorso in essa svolto,
anche per quanto concerne le importanti enunciazioni di carattere generale (“Al di fuori delle attività
comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica
abilitazione (...), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di
assistenza o consulenza (...), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di
servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”), si è interamente e
costantemente mantenuto sul piano dei problemi inerenti alle attribuzioni esclusive di specifiche attività, da
escludere in assenza di univoche indicazioni in contrario (ed escluse in concreto in riferimento ai DD.PP.RR.
presi in considerazione). È rimasta quindi (e non poteva che rimanere) fuori dal suo ambito la questione della
possibile rilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 348 c.p., dello svolgimento di specifiche attività attribuite a
una professione soggetta ad abilitazione non in via esclusiva ma sotto il profilo della particolare competenza
tecnica, attuato (da un non abilitato) in forma sistematica e con le oggettive apparenze del possesso del
relativo titolo, e da ritenere, (solo) per e in tali modalità, “riservato” alla professione stessa.
Incompatibili con le conclusioni assunte nella presente decisione non appaiono neppure gli esiti di recenti
arresti della giurisprudenza civile di questa Corte, che, in dichiarata adesione alla anzidetta pronuncia del
Giudice delle leggi (e a modifica della posizione assunta in precedenza da Sez. 2 civ., n. 21495 del
12/10/2007, Rv.
600035), hanno riconosciuto il diritto di consulenti del lavoro al compenso per le attività di consulenza e
valutazione in materia aziendale, ritenute non riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai
ragionieri e ai periti commerciali (Sez. 2 civ., n. 15530 del 11/06/2008, Rv. 603748), e per le attività di tenuta
delle scritture contabili dell’impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione
di conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini dell’ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la
233
Parte speciale Camera di Commercio, ritenute non rientranti in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di
specifica abilitazione (Sez. 2 civ., n. 14085 del 11/06/2010, Rv. 613443). Le attività indicate, infatti, da un
lato, non erano incluse all’epoca nelle elencazioni specifiche delle attività qualificate come di particolare
competenza delle professioni commerciali, e, dall’altro (e al di là di ogni altra possibile considerazione), erano
comunque svolte nell’esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l’indotta apparenza
di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale.
[...Omissis...]
234
Scheda di giurisprudenza n. 25 Scheda di giurisprudenza n. 25
Favoreggiamento e diritto di difesa
TRACCIA
Tizio, difensore di Sempronio, si reca negli uffici della Procura della Repubblica di OMISSIS per richiedere il
rilascio di un certificato a Mevio, addetto presso uno degli uffici in questione.
Sennonché, mentre Mevio è intento a compilare il certificato richiestogli, Tizio, leggendo sullo schermo del
computer utilizzato dallo stesso Mevio, viene a conoscenza che il proprio assistito Sempronio sta per essere
raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Tizio decide allora di informare di quanto appreso Sempronio, il quale a sua volta si rende latitante.
Dopo poco tempo, Tizio viene raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini per il reato di
favoreggiamento personale.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere in merito alla posizione dello stesso.
1. La questione.
In relazione ai rapporti intercorrenti fra il diritto di difesa e il delitto di favoreggiamento, di cui
all’art. 378 c.p., una questione peculiare che ha attirato l’attenzione della giurisprudenza involge la
configurazione della condotta dell’avvocato difensore che riveli notizie o dichiarazioni
apprese in ragione della sua attività al soggetto da lui difeso, imputato o anche solo indagato.
Invero, non sorgono dubbi qualora le notizie rivelate siano state apprese in modo illegittimo,
configurandosi in tal caso a carico del difensore il delitto di favoreggiamento: il reato, a ben
vedere, è integrato nelle predette ipotesi poiché la condotta del difensore si traduce inevitabilmente
nella prestazione di un consapevole aiuto al soggetto difeso, la cui conseguenza non potrebbe che
sostanziarsi in un ostacolo alle indagini o allo svolgimento del processo. In quest’ottica, la Corte di
Cassazione ha precisato che, in relazione all’ipotetica invocabilità dell’art. 51 c.p., l’esercizio di un
diritto scrimina esclusivamente nei limiti in cui esso è riconosciuto, essendo dunque
necessario che l’attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà
inerenti al diritto in questione. Naturalmente, ciò non è riscontrabile nella condotta del difensore
che, essendo venuto a conoscenza in maniera illegittima di notizie o informazioni sull’assistito,
gliele abbia poi riferite, avvantaggiandolo o comunque ostacolando il normale iter della giustizia: la
difesa, infatti, pur essendo certamente un diritto inviolabile, non ha nulla a che fare con attività
sleali o delittuose (Cass. pen., Sez. Un., 28 settembre 2006, n. 32009; indirizzo ribadito di recente
da Cass. pen., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327).
Tanto premesso, lo stesso non può dirsi qualora notizie ed informazioni relative all’assistito
siano apprese dal difensore in maniera, invece, legittima e siano poi al primo rivelate.
2. Gli orientamenti.
Circa la configurabilità del delitto di favoreggiamento a carico del difensore che abbia appreso, in
maniera legittima, notizie o informazioni riguardanti il proprio assistito, riferendole a quest’ultimo, si
erano formate due correnti di pensiero.
235
Parte speciale 2.1. Il primo
favoreggiamento.
orientamento:
Inconfigurabilità
del
delitto
di
Per una prima tesi, sostenuta dalla dottrina maggioritaria (PULITANÒ, TAGLIARINI), il delitto de
quo non sarebbe configurabile a carico del difensore che, anche per pura casualità, ma pur
sempre in modo legittimo, sia entrato in possesso di informazioni riguardanti il proprio assistito e le
abbia a lui rivelate.
1° Argomento: valorizzazione del diritto di difesa. A ben vedere, una simile condotta
del difensore, lungi dall’integrare il delitto di cui all’art. 378 c.p., non può che essere sussunta
nell’ambito del diritto di difesa, trovando così giustificazione ex art. 51 c.p.. In effetti, “la
disponibilità delle informazioni lecitamente acquisite sarebbe espressione naturale del rapporti di
fiducia che deve intercorrere fra difensore e cliente. (…) Il diritto di difesa deve per tanto ritenersi
comprensivo della libertà di comunicazioni anche oggettivamente favoreggiatrici, che abbiano ad
oggetto atti processuali e che il difensore non si sia procacciato commettendo un illecito”.
2.2. Il secondo
favoreggiamento.
orientamento:
Configurabilità
del
delitto
di
Per un diverso orientamento, sostenuto pur sempre in dottrina (DINACCI), il delitto di
favoreggiamento sarebbe invece pienamente configurabile in capo al difensore.
1° Argomento: valorizzazione di notizie, atti e informazioni divulgate al soggetto
difeso. In presenza di atti, informazioni o notizie dal valore particolarmente pregnante o comunque
tale da agevolare la posizione dell’indagato/imputato o ostacolare le indagini ovvero la
prosecuzione del processo, il rilievo della loro assunzione in maniera lecita o meno non ha
importanza, poiché, pur essendo tale, fuoriesce dagli schemi della difesa tipica.
3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Inconfigurabilità del
delitto di favoreggiamento.
La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nell’accogliere la prima opzione interpretativa,
concludendo così per l’irrilevanza penale della condotta del difensore che, in maniera lecita,
apprenda notizie e informazioni concernenti il proprio assistito e a lui le riveli. In tal senso, in
un recente arresto, la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “non integra il delitto di
favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia
dell’emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendo
così la sua latitanza, atteso che non esorbita dalla funzione del difensore partecipare al proprio
assistito quanto possa aiutarlo a mantenere la propria libertà personale” (Cass. pen., Sez. VI, 18
maggio 2010, n. 20813).
1° Argomento: valorizzazione della modalità di acquisizione delle informazioni.
Nell’affermare l’inconfigurabilità del delitto di favoreggiamento a carico del difensore, la Corte
ritiene opportuno ricordare la tesi maggioritaria in giurisprudenza, secondo la quale solo nel caso in
cui le notizie siano state apprese illegittimamente viene integrato il delitto ex art. 378 c.p., non
potendo dirsi la stessa cosa in caso contrario.
236
Scheda di giurisprudenza n. 25 2° Argomento: valorizzazione del diritto di difesa. Nella specie, la comunicazione
all’assistito dell’emissione nei suoi confronti di una misura cautelare, per quanto possa avere
effettivamente contribuito alla sua latitanza, rientra appieno nel diritto di difesa, costituzionalmente
garantito, atteso che ha contribuito al mantenimento della sua libertà personale.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che nei confronti di Tizio un’accusa di favoreggiamento personale non possa
trovare accoglimento. Invero, a mente della giurisprudenza maggioritaria, qualora le notizie siano apprese in
maniera legittima, come nel caso di specie (si ricorda che Tizio aveva appreso dell’ordinanza cautelare nei
confronti del suo assistito per mero caso), mancano gli elementi integrativi del il reato de quo.
LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 35327
Estratto
[...Omissis...]
1. I ricorsi degli imputati A.F., A.S. e G.F., con riferimento all’utilizzazione che i giudici del merito hanno fatto
delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, denunciano la violazione delle disposizioni poste
dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e, segnatamente, l’utilizzazione erronea da parte del giudice d’appello del
principio della cosiddetta “frazionabilità delle dichiarazioni”.
1.1. In proposito, il Collegio sottolinea la necessità di procedere previamente alla rigorosa verifica
dell’attendibilità dei dichiaranti e delle relative dichiarazioni, secondo la metodologia più volte indicata da
questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. n. 1653 del 22.2.93; Marino; Sez. 2^ n. 15756 del 3.4.03,
Papalia e n. 2350 del 26/01/05, Contrada; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri).
Il giudice deve, in primo luogo, affrontare il problema dell’attendibilità del dichiarante, in relazione, tra l’altro,
alla sua personalità, alle sue condizioni socio - economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con l’accusato,
alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto all’accusa. In secondo luogo, deve valutare la credibilità delle
dichiarazioni rese, verificandone l’intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli
altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e
costanza. Infine, egli deve esaminare l’esistenza di riscontri esterni, ai fini della necessaria conferma di
attendibilità.
L’esame deve essere compiuto seguendo l’indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una
valutazione unitaria della chiamata in correità o un reità e degli altri elementi di prova che ne confermano
l’attendibilità (come prescrive l’art. 192 c.p.p., comma 3), se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che
si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.
1.2. Per quanto concerne l’autonomia e la spontaneità di plurime dichiarazioni accusatorie, in caso di dubbio
e tanto più di specifica censura degli appellanti - come nella vicenda processuale qui esaminata - è
necessario verificare non soltanto se la convergenza di più dichiarazioni non sia l’esito di collusione o
concerto calunnioso, ma anche se tale consonanza non sia il frutto di condizionamenti o reciproche
influenze, pur senza alcuna preconcetta malafede. Occorrendo, infatti, la certezza che i coimputati abbiano
detto la verità, è indispensabile che il giudizio di attendibilità intrinseca sia particolarmente severo e
237
Parte speciale scrupoloso, in modo da allontanare ogni ragionevole dubbio di reciproche influenze e di progressivo
allineamento dei dettagli originariamente divergenti di ciascuna di esse (cfr. Cass. sez. 1^, n. 13279/90,
Barbato; sez. 5^ 9001/2000, Madonia; sez. 6^, n. 6422/2004, Goddi).
1.3. Per la valutazione complessiva richiesta dall’art. 192 c.p.p., comma 3, ai fini del giudizio di
responsabilità, le chiamate accusatorie e i riscontri esterni devono essere individualizzanti, ossia devono
riguardare direttamente l’imputato in relazione allo specifico fatto storico a lui contestato: se oggetto della
prova è lo specifico fatto e la sua attribuibilità al singolo imputato (art. 187 c.p.p.), oggetto della chiamata e
dei riscontri d’attendibilità (art. 192 c.p.p., comma 3) deve essere lo stesso specifico fatto, con riferimento
all’imputato cui è ascritto.
1.4. Giova anche precisare che affinchè le più chiamate in reità o correità, provenienti da soggetti diversi,
possono valere come riscontro reciproco (sempre che esse risultino spontanee e tra loro indipendenti), è
necessario che, per ogni singola chiamata, il giudice proceda alla verifica sopra indicata, in ordine alla
credibilità del chiamante e all’attendibilità della dichiarazione.
Il fatto che di una chiamata il giudice si avvalga soltanto come riscontro esterno d’altra chiamata non esenta
dall’obbligo di verificare - e motivare - credibilità del chiamante e attendibilità delle dichiarazioni rese.
1.5. Va, infine, riaffermato un principio essenziale, più volte sottolineato da questa Corte, nell’ipotesi di
molteplici dichiarazioni accusatorie non coincidenti su particolari di dettaglio o su elementi essenziali della
ricostruzione di fatto: in presenza di significative divergenze di dichiarazioni rese da due chiamanti in correità
o reità, aventi ad oggetto particolari non marginali, bensì il ruolo e il contributo causale asseritamente fornito
dall’imputato alla commissione del delitto, ai fini della dichiarazione di colpevolezza non è consentito
utilizzare la parte coincidente delle due dichiarazioni, per argomentare che l’indagato sarebbe comunque
coinvolto come concorrente nel delitto, senza fornire una logica spiegazione delle ragioni delle versioni in
contrasto e senza esplicitare i motivi che convincono il giudice dell’attendibilità dei due dichiaranti e delle
dichiarazioni rese nella parte che risulta coincidente, (cfr. Cass. sez. 6^, n. 22/1996, Gentile; Sez. 6, n. 6221
del 20/04/2005, Aglieri).
Il principio di frazionabilità, invero, non è un passepartout utile per assembleare le parti coincidenti di
dichiarazioni differenti.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la validità del principio della c.d.
“frazionabilità” delle dichiarazioni, secondo cui l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se
esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l’attendibilità del dichiarante con
riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno.
È stato, tuttavia, reiteratamente precisato che affinchè ciò sia ammissibile è necessario, in primo luogo, che
non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti,
intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (cfr. Cass. sez. 1^, n. 468/2001, Orofino) e, in
secondo luogo, che la falsità o l’inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente
macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa
credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente si prospetta dalla parti, e ancor più quando
oggettivamente si constata, un’ipotesi siffatta, l’obbligo motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non
potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l’inattendibilità parziale delle
dichiarazioni, non incide sull’attendibilità del dichiarante (Cass. Sez. 6^, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri).
1.6. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto che “fonte probatoria fondamentale” per l’affermazione
di responsabilità degli imputati è costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia C., Ma., Bu. e Bo..
A tale proposito gli appellanti avevano formulato specifici motivi d’appello. La Corte territoriale ha risposto
con considerazioni generiche, richiamandosi a quanto avevano espresso i giudici di primo grado e utilizzando
(soprattutto con riferimento alle dichiarazioni di C. e di Ma., che hanno costituito la più importante base
probatoria) il principio di frazionabilità per “assemblare” illogicamente le parti coincidenti di dichiarazioni
differenti. Essa ha sostanzialmente eluso le critiche più puntuali rivolte alla valutazione sull’attendibilità
personale e sulla credibilità delle loro dichiarazioni.
238
Scheda di giurisprudenza n. 25 Così, per esempio, è accaduto con riferimento alle critiche degli appellanti sulla scarsa credibilità del C.,
appartenente al gruppo Grandearacri, avversario degli A., nella parte in cui descrive di incontri con A.F.,
riferisce di avere partecipato a riunioni della cosca Arena o di avere ricevuto dallo stesso A.F. la
comunicazione dell’intenzione di eliminare Gr.Er..
Alla censura di inverosimiglianza che un capoclan riveli ad un esponente del gruppo contrapposto
l’intenzione di uccidere un avversario di spessore, la Corte territoriale si è limitata a prendere atto che la
spiegazioni offerta dal C. (“non avendo egli partecipato agli agguati ai danni di D.R. e Ar.Fr. - ed essendo
nota tale circostanza agli A. - non aveva nulla da temere) “appare logica e coerente con le dinamiche
delinquenziali di tipo mafioso”.
Osserva il Collegio che siffatta apodittica affermazione non fornisce alcuna spiegazione, tanto più che la
massima di esperienza implicita in siffatta affermazione “agli esponenti del gruppo nemico che non hanno
partecipato ad uno specifico gruppo di fuoco (ai danni di D.R. e Ar.Fr.) si può ben confidare l’intenzione
omicida di uccidere uno dei loro capi; gli stessi, inoltre, possono persino partecipare a riunioni riservate del
sodalizio criminale contro cui combattono” contrasta con elementari criteri di logica comune e con quanto
risulta dall’esperienza giudiziaria delle dinamiche dei gruppi mafiosi in contrapposizione, fondate sulla
segretezza delle intenzioni omicide e delle programmate aggressioni, che potrebbero essere compromessi e
neutralizzati da ogni rivelazione a membri del gruppo avversario. Tanto più quando l’elemento della
segretezza è stato ritenuto, dai giudici di primo grado e di appello, uno dei connotati del gruppo mafioso in
esame, al punto che i sodali utilizzavano un “sistema chiuso” di comunicazione telefonica.
1.7. Assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti dei tre
imputati di partecipazione ad associazione mafiosa, con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà procedere a
nuovo giudizio sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.
2. Il ricorso di M.D., condannato per il delitto di favoreggiamento personale, va accolto limitatamente
all’aggravante di cui all’art. 378 c.p., comma 2.
Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto provata la circostanza che il M., appresa in maniera illecita la
notizia dal carabiniere B., suo amico, informò Mo. e L., consentendo loro di sottrarsi alla cattura.
Il ricorrente ha riproposto le censure formulate in appello contro la sentenza di primo grado, con particolare
riferimento all’elemento cronologico del fatto contestato (al fine di stabilire se le ricerche del Mo. da parte dei
Carabinieri avessero effettivamente avuto già inizio) e all’effettiva idoneità ed efficacia della condotta
dell’imputato “a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità”.
Si tratta di motivi di impugnazione non consentiti ex art. 606 c.p.p., in quanto involgono accertamenti e
valutazioni di fatto estranei alla competenza della Corte di legittimità, il cui sindacato è circoscritto al controllo
della motivazione nei termini stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.
Osserva il Collegio che sotto quest’ultimo profilo - e salvo quanto si dirà sulla ritenuta aggravante - la
sentenza è indenne dai denunciati vizi di motivazione, avendo assolto con puntualità agli obblighi stabiliti
dall’art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e rigettato con esauriente e logica
motivazione tutti i motivi prospettati con l’atto d’appello.
I giudici del merito hanno illustrato minutamente le risultanze dell’istruttoria dibattimentale (testimonianza del
capitano dei Carabinieri, dichiarazioni del correo B., esame dell’imputato M., contenuto delle conversazioni
intercettate e analisi incrociata del traffico telefonico delle intercettazioni, avvenute nei giorni (OMISSIS),
quest’ultime tra le 4 e le 5 del mattino, ora in cui l’ordinanza di custodia carceraria avrebbe dovuto esser
eseguita), e sono giunti, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla conclusione che l’imputato - dopo avere
appreso illecitamente dal suo amico carabiniere B., incaricato di procedere nei confronti del Mo., la notizia
dell’imminente esecuzione di una misura cautelare - si affrettò a comunicarla allo stesso Mo., suo parente.
Tutti gli elementi addotti a difesa dell’imputato (a cominciare dall’asserita modalità fortuita ed occasionale di
apprendimento della notizia) sono stati analizzati in maniera approfondita e rigettati perchè contrastanti con
univoci elementi probatori.
Irrilevante risulta, perciò, l’assunto del ricorrente di aver avvisato il Mo. nell’esercizio del suo mandato di
239
Parte speciale difensore (circostanza peraltro motivatamente esclusa in fatto dai giudici del merito), al fine di invocare
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta
del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia dell’emissione nei confronti del proprio assistito di
una misura cautelare, lo informi (Cass. Sez. 6^, n. 20813 del 18/05/2010, Valentino, Rv. 247349).
Nel caso in esame, i giudice del merito, con motivazione completa, logica e coerente, hanno escluso che
l’acquisizione della notizia fosse avvenuta in maniera occasionale e fortuita, avendo invece trovato causa nel
legame di amicizia e di favori reciproci che intercorrevano tra l’avvocato M. e il carabiniere B..
2.1. Immotivata risulta invece la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 378 c.p., comma 2. La
Corte territoriale si limita a rilevare - con riferimento al trattamento sanzionatorio - che “il reato commesso si
presenta di particolare ed estrema gravità avendo l’imputato posto in essere la condotta a lui ascritta con
estrema disinvoltura e nella piena consapevolezza della sua illiceità e con la piena conoscenza, data la
provenienza dal medesimo contesto territoriale, della gravità delle condotte attribuite ai soggetti favoriti”.
Orbene, considerato che, a norma dell’art. 59 c.p., comma 2, “le circostanze che aggravano la pena sono
valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per
errore determinato da colpa”, la ritenuta sussistenza dell’aggravante richiede una specifica motivazione sulla
conoscenza da parte dell’imputato del reato presupposto, tanto più che nel caso in esame il M., pur
ammettendo di aver rivelato al Mo.
dell’imminente arresto, ha negato di conoscere la ragione del provvedimento.
2.2. La sentenza va, perciò, annullata anche nei confronti del M., ma solo limitatamente all’aggravante di cui
all’art. 378 c.p., comma 2, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Catanzaro.
[...Omissis...]
240
Scheda di giurisprudenza n. 26 Scheda di giurisprudenza n. 26
Reato associativo e reati fine: configurabilità del vincolo della continuazione
TRACCIA
Tizio, Caio e Sempronio venivano riconosciuti colpevoli, in primo grado, dei delitti di associazione per
delinquere, ex art. 416 c.p., di omicidio, ex art. 575 c.p., nonché infine di occultamento di cadavere, ex art.
412 c.p.; in particolare, vittima dell’omicidio era Mevio, nipote di uno dei associati, Sempronio, che si era reso
colpevole di non aver rispettato le regole consortili.
Il candidato, premessi cenni sulla possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione fra il reato
associativo ed i singoli reati scopo ed assunte le vesti del legale di Tizio, valuti la possibilità di proporre
appello avverso la sentenza di condanna di primo grado.
1. La questione.
Il rapporto fra reato associativo, di cui all’art. 416 c.p., e singoli reati scopo è oggetto di un
vivace dibattito in giurisprudenza, che da tempo si interroga circa la configurabilità fra i
medesimi del vincolo della continuazione, ex art. 81, co. 2, c.p.
A tal proposito, atteso che gli elementi costitutivi del reato continuato sono ravvisabili nella
pluralità di azioni o omissioni, nell’integrazione di più violazioni di legge ed infine nel
medesimo disegno criminoso, va ricordato che non può essere escluso a priori che un reato
continuato sia posto in essere da una pluralità di soggetti senza che fra gli stessi sussista un
vincolo di tipo associativo, avendo gli autori agito, sì, in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, ma cionondimeno in assenza di una precostituita struttura organizzativa, ancorché
rudimentale e minima.
Allo stesso modo, deve essere ammessa l’ipotesi inversa, ben potendo una struttura associativa
nascere e vivere senza che tra i delitti commessi dagli associati possa scorgersi il legame
psicologico tipico della continuazione, evenienza che si verifica qualora i reati siano posti in essere
sulla base di un generico programma delinquenziale, senza un originario disegno criminoso
sufficientemente preciso.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, in giurisprudenza erano rappresentati due orientamenti in tema, l’uno
sfavorevole alla configurabilità del vincolo della continuazione e l’altro, invece, propenso alla sua
integrazione.
2.1. Il primo orientamento: Inconfigurabilità del vincolo della
continuazione.
Un primo ed ormai risalente orientamento (Cass. pen., 24 maggio 1989; Cass. pen., Sez. V, 15
novembre 2000, n. 598) escludeva tassativamente la configurabilità del vincolo della
continuazione fra reati scopo e reato associativo.
241
Parte speciale 1° Argomento: incompatibilità strutturale. Il reato continuato si caratterizza per la
presenza di un programma criminoso involgente la commissione dei singoli reati, già
previsto a monte dall’agente nei suoi tratti essenziali, anche se non nei minimi dettagli: peculiarità,
questa, ritenuta incompatibile con il generico accordo programmatico per la commissione di
una serie indeterminata di retai, tipico, invece, dell’associazione per delinquere.
Da qui discenderebbe ovvia l’incompatibilità logico strutturale tra la continuazione,
quale unificazione giuridica di reati avvinti dal vincolo dell’identità del disegno criminoso, ed il
nesso che lega il reato associativo ai reati fine, oggetto del programma elaborato dalla societas
sceleris, in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 416 c.p.
2° Argomento: determinatezza del medesimo disegno criminoso. La necessità che,
nell’ambito del delitto di associazione per delinquere, i delitti programmati siano sia
qualitativamente che quantitativamente indefiniti determina un’insanabile contrapposizione fra
determinatezza del disegno criminoso e indeterminatezza del programma associativo. In
quest’ottica, la giurisprudenza affermava infatti che “il programma associativo di un’associazione
per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso, la cui unicità costituisce il presupposto
essenziale per la configurabilità per la continuazione fra più reati, atteso che quest’ultima richiede
la rappresentazione, fin dall’inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee
essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l’autore abbia già previsto e deliberato in
origine, per linee generali, l’iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali lo stesso si
snoda; ne consegue che la partecipazione ad un’associazione per delinquere non può costituire di
per sé sola la prova dell’unicità di un disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento
degli scopi dell’associazione”.
2.2. Il secondo orientamento: Configurabilità del vincolo della
continuazione.
Un secondo orientamento (Cass. pen., Sez. Vi, 2 aprile 1997; Cass. pen., Sez. VI, 31 maggio
2002, 21509; Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 2007, n. 24750) ritiene invece, oggi, pienamente
configurabile il vincolo della continuazione fra reato associativo e reati scopo.
1° Argomento: critica della tesi dell’incompatibilità strutturale. Invero, nulla si oppone
a priori al fatto che sin dall’inizio nel programma criminoso dell’associazione si
concepiscano uno o più reati fine nelle loro linee essenziali, così che tra questi reati e tra
quello associativo si possa ravvisare un’identità di disegno criminoso. Si tratterebbe, più che alto, di
una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice, da effettuarsi caso per caso.
2° Argomento: compatibilità del disegno criminoso di cui all’art. 81 c.p. con un
programma criminoso specifico. Si osserva infatti che, se in linea generale è vero che la
continuazione costituisce una situazione ben diversa dalla mera inclinazione a reiterare violazioni
della specie o di specie diverse, normalmente collegate ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità, cionondimeno è possibile
comunque che si configuri il vincolo della continuazione tra la fattispecie associativa ed i
singoli reati scopo, qualora risulti che l’autore abbia già previsto, in origine, al momento
della sua adesione al sodalizio, l’iter criminoso da percorrere ed i singoli delitti attraverso i
quali il medesimo è destinato a snodarsi.
242
Scheda di giurisprudenza n. 26 3. La soluzione della giurisprudenza maggioritaria: Configurabilità del
vincolo della continuazione fra reato associativo e reati scopo.
La giurisprudenza di legittimità, ormai maggioritaria (ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 16
novembre 2006, n. 39726), è concorde nell’ammettere l’integrazione del vincolo della
continuazione fra il delitto di associazione per delinquere ed i singoli reati scopo; in
quest’ottica, si afferma infatti che “mentre un’associazione per delinquere è contraddistinta da
un accordo programmatico per la commissione di delitti, per aversi reato continuato non è
sufficiente un generico piano di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le azioni od
omissioni siano comprese, fin dal primo momento e nei loro elementi essenziali e
individualizzanti, nell’originario disegno criminoso. Pertanto, affinché possa ritenersi
sussistente il vincolo della continuazione tra un reato associativo e i reati-fine programmati
ed effettivamente realizzati, non basta una generica compatibilità strutturale tra detti reati, né una
contiguità temporale che ne caratterizzi la commissione, ma occorre la sussistenza di uno
stesso momento genetico-ideativo che accomuni il reato associativo a quelli eseguiti per la
sua realizzazione, cosicché possa affermarsi che, sin dall’inizio, nel programma criminoso
dell’associazione si erano concepiti nelle loro linee essenziali detti reati-fine, in modo tale da potere
ravvisare un’identità di disegno criminoso”.
1° Argomento: compatibilità fra il disegno criminoso ed un programma criminoso
specifico. La Corte fa proprie le conclusioni della tesi maggioritaria ed afferma la piena
compatibilità del disegno criminoso, richiesto dall’art. 81, co. 2, c.p. ai fini dell’integrazione del
reato continuato, con uno specifico programma criminoso dell’associazione per delinquere.
Tanto premesso in astratto, tuttavia, grava sul giudice, caso per caso, la valutazione in
concreto tesa alla verifica che quest’ultimo possieda i requisiti di specificità e determinatezza che
la giurisprudenza solitamente richiede quali caratteri indefettibili del disegno criminoso, tali da
legare i singoli episodi ex art. 81 c.p., ai fini del beneficio del trattamento sanzionatorio di minor
rigore previsto dalla norma.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene di dover sconsigliare a Tizio la proposizione dell’appello avverso la sentenza di
condanna di primo grado: invero, il giudice di prime cure non ha ritenuto a ragione di doversi applicare il
vincolo della continuazione fra il reato associativo ed i reati scopo, nella specie, si ricordi omicidio di Mevio
ed occultamento di cadavere. Se è vero infatti che la giurisprudenza maggioritaria ritiene oggi possibile che il
reato associativo e i reati fine possano essere avvinti dal vincolo della continuazione, cionondimeno questo
deve sussistere fra reati pur sempre, quanto meno nella loro forma generica o solo ipotetica, già ideati:
evenienza, questa, che non è possibile riscontrare sol se si pensi al fatto che vittima di omicidio è il nipote di
uno degli associati, associato egli stesso.
243
Parte speciale LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 39726
Estratto
[...Omissis...]
I. Con ordinanza del 21 marzo 2006, la corte di assise di appello di Salerno rigettava la richiesta di
applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva avanzata da T.N. in relazione ai fatti
giudicati con due sentenze definitive della corte di assise di appello di Potenza (la prima, del 28 giugno 2001,
relativa all’occultamento del cadavere di B.G., e la seconda, del 16 aprile 2003, relativa a una fattispecie
associativa e a numerosi reati satelliti), sul rilievo che non era configurabile il vincolo della continuazione tra
l’associazione criminale facente capo a Z.P. e l’omicidio del B.G., giacché, a parte la coincidenza temporale
tra i due fatti (l’associazione era operante fin dal 1993 e l’occultamento era stato compiuto nel luglio 1996), il
movente dell’omicidio era consistito nell’esigenza di punire il B., nipote dello Z., reo di aver contravvenuto alle
regole della consorteria, sicché il delitto, lungi dall’essere stato previsto ed accettato nel momento della
costituzione del sodalizio, era maturato in virtù di eventi successivi ad esso.
Ricorre per cassazione il T. a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione di
legge e del vizio di motivazione, che tra i due fatti giudicati dalla corte di assise di appetto di Potenza
emergeva per tabulas la medesimezza del disegno criminoso, sia perché era stata contestata per il delitto di
occultamento di cadavere l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sia perché i profili temporali dei
due fatti coincidevano. La difesa del T. indugiava su una lunga analisi della dottrina e della giurisprudenza
circa le peculiarità dell’associazionismo di tipo mafioso per concludere che tra i due reati (quello associativo e
quello di occultamento di cadavere) poteva ben ravvisarsi il vincolo della continuazione.
II. Il ricorso non è fondato.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare in più occasioni (v, tra le tante, Cass., Sez. I, 28
febbraio 2006, Sipala; Id., Sez. I, 20 ottobre 2003, Laezza; Id., Sez. I, 12 gennaio 2001, Cucchiara; Id., Sez.
VI, 2 aprile 1997, Giampà; Id., Sez. VI, 26 settembre 1997, Conoscenti, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n.
1312, p. 2358), con riferimento ai reati associativi e ai reati-fine programmati ed effettivamente commessi,
occorre tener presente che un’associazione per delinquere è contraddistinta da un accordo programmatico
per la commissione di delitti, laddove, per aversi reato continuato, non è sufficiente un generico piano di
attività delinquenziale, ma occorre che tutte fé azioni ed omissioni siano comprese, fin dal primo momento e
nei loro elementi essenziali ed individualizzanti, nell’originario disegno criminoso. Come dire che deve
sussistere uno stesso momento genetico-ideativo che accomuna il delitto associativo a quelli eseguiti per la
sua realizzazione.
Ne deriva che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e uno o più supposti
reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale o di contiguità temporale. Nulla, in rerum
natura, si oppone alla circostanza per cui, sin dall’inizio, nel programma criminoso dell’associazione, si
concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, così che tra questi reati e il reato
associativo si possa ravvisare un’identità di disegno criminoso. Si tratta però di una quaestio facti fa cui
soluzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito.
Nella vicenda de qua, come fa correttamente osservare la corte di merito, il rapporto istituitane tra il sodalizio
criminoso di stampo mafioso facente capo allo Z. e l’omicidio del B., nipote dello Z., non era tanto quello
dell’attuazione di un programma delinquenziale concordato fin dall’inizio, quanto quello della improvvisa ed
imprevista rottura del vincolo associativo da parte del B., che non poteva certo essere stata preventivata al
momento dell’adesione da parte del T. al sodalizio di appartenenza. Il B. era stato punito perché, come
adepto afta consorteria mafiosa di cui era a capo lo zio, aveva sottratto armi, droga e denaro da un bidone di
proprietà del gruppo e soprattutto aveva contribuito atta cattura detto Z. nel giugno 1995. Il suo omicidio era
244
Scheda di giurisprudenza n. 26 stato deciso nelle settimane successive ed eseguito il 17 luglio 1995, sicché, lungi dall’essere stato previsto
ed accettato nel momento della costituzione del sodalizio, era maturato in virtù di eventi successivi. Va da sé,
insomma - è questo il succo del pensiero della corte di merito che questa Corte Suprema ritiene pienamente
condivisibile - che per quanto generico e indeterminato possa essere il programma delinquenziale che
costituisce l’oggetto “sociale” del sodalizio, esso non può ricomprendere anche l’uccisione e l’occultamento
del cadavere di un parente del capo, sia pure reo di essere venuto meno alle regole del sodalizio.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
[...Omissis...]
Cass. pen., Sez. I, 22 giugno 2007, n. 24750
Estratto
[...Omissis...]
M.C. ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il giudice dell’esecuzione ha
ritenuto la continuazione fra reati, separatamente giudicati, di associazione dedita al narcotraffico e satelliti,
commessi dal (OMISSIS), da un lato, ed una ulteriore violazione della normativa sugli stupefacenti
commessa il 2.2.2002; ha invece escluso l’estensione del vincolo di cui all’art. 81 c.p. ad altre violazioni
commesse il (OMISSIS) e il (OMISSIS).
Con il gravame viene censurata tale esclusione, siccome illogica, contraddittoria e carente di motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va preliminarmente ribadita l’ormai consolidata giurisprudenza secondo cui la continuazione presuppone
l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo
nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare
violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un bisogno persistente nel tempo, ad una scelta di vita o
ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità, qual
è quello che generalmente connota le associazioni per delinquere. Pertanto, la continuazione fra il reato
associativo e quelli che vengono posti in essere in attuazione delle finalità perseguite dall’organizzazione
criminale è ravvisabile solo quando risulti che l’autore abbia già previsto in origine, al momento della sua
adesione al sodalizio, l’iter criminoso da percorrere ed i singoli delitti attraverso i quali si snoda; ne consegue
che la partecipazione ad un’associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell’identità
di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell’associazione. (cfr., per tutte,
Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).
La prova di una congiunta previsione - ritenuta dal legislatore meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un
singolo impulso, anzichè di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l’inesplorabile interiorità
psichica del soggetto deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza,
del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito
esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto
intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori,
deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici
congetture o presunzioni.
Tanto premesso, è irrilevante la pretesa del ricorrente di retrodatare il momento della sua adesione al
sodalizio dedito al narcotraffico al fine di comprendere nell’arco temporale della partecipazione associativa
anche il primo reato di spaccio dell’(OMISSIS); operazione comunque non consentita al giudice
dell’esecuzione che, se può rilevare un legame - non emerso ma non escluso - tra fatti irrevocabilmente
245
Parte speciale accertati, è per il resto, in ragione delle sue funzioni, vincolato al giudicato e privo del potere di modificarlo
attribuendo al condannato una condotta non giudizialmente accertata. Altrettanto va detto a proposito del
reato commesso nel 2004, posto che il giudicato sul reato associativo - contestato senza indicazione del
momento finale della permanenza - non può estendersi oltre la data della sentenza di primo grado
(30.7.2003).
Al di là di tale preliminare rilievo, del tutto logica è l’esclusione dalla continuazione del primo reato
((OMISSIS)), consistente in un’attività di spaccio individuale di lieve entità senza alcun elemento che lo
colleghi al contesto associativo ed alla capillare organizzazione che lo caratterizza. Quanto al fatto del 2004,
la distanza temporale e la diversità di concorrenti sono del pari ragionevolmente ritenuti elementi non
indicativi di collegamento progettuale con i reati fine dell’associazione; e ciò tanto più ove si consideri che,
come rappresentato in ricorso, il M. “è stato ristretto “in vinculis” dal 18.7 al 12.8.2002 nonchè dal 17.9.2002
al 7.8.2003”, lunga detenzione che, interrompendo il contatto con gli associati, se non esclude in assoluto la
persistenza di un preesistente progetto criminale, la rende assai improbabile e depone per una nuova
progettazione di illeciti in diverso contesto e con differenti soci. Nè rileva in contrario l’assunto che uno
(soltanto) dei correi sarebbe comune a entrambe le serie criminose (affermazione che, comunque,
presuppone un’indagine di fatto estranea al giudizio di legittimità circa un’erronea attribuzione di generalità).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinata in
Euro 500,00.
[...Omissis...]
246
Scheda di giurisprudenza n. 27 Scheda di giurisprudenza n. 27
L’associazione per delinquere e la circostanza aggravante della transnazionalità
TRACCIA
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di OMISSIS pronunciava sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per una serie di reati oggetto di contestazione nei confronti di Tizio e Caio.
In particolare, ai due soggetti, unitamente ad altri imputati, veniva contestato il reato di cui all’art. 416 c.p.,
commi 1, 2, 3 e 5, con l’aggravante prevista dall’art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, per essersi associati
tra loro e con alter persone specificamente indicate (per le quali si procedeva separatamente) allo scopo di
commettere un numero indeterminato di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed altri
illeciti diretti ad evadere l’imposizione fiscale, diretta ed indiretta, per ragguardevoli importi.
Secondo quanto accertato, attraverso un articolato sistema fraudolento – mediante costituzione di società
fittizie, in apparenza riconducibili allo stesso gruppo; simulate relazioni negoziali tra le stesse e le società
capogruppo; trasferimento di interi rami di azienda e di ingenti risorse finanziarie nonché intestazione fittizia
di beni societari – era stato realizzato il progressivo svuotamento del patrimonio di diverse società. La
strategia del gruppo prevedeva anche la costituzione di fittizie società con sede all’estero, mercè il contributo
collaborativo di persone lì operanti e di compiacenti prestanome.
In seno al sodalizio, che faceva capo ad uno studio di professionisti di OMISSIS, gli imputati avevano
assunto un ruolo di rilievo come organizzatori del complesso meccanismo di frode.
Erano stati realizzati numerosi reati-fine: delitti di bancarotta fraudolenta impropria, con riferimento alle
società specificamente indicate; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ed altri reati tributari;
appropriazione indebita e riciclaggio, in gran parte aggravati ai sensi dell’art. 4 della L. n. 146/2006 in virtù
del collegamento funzionale con nuclei operanti all’estero e lo svolgimento di attività illecite anche al di fuori
del territorio nazionale.
Assunte le vesti del legale di Tizio e Caio, il candidato, premessi cenni sulla disciplina dell’associazione per
delinquere, rediga motivato parere sulla vicenda in esame, illustrando le principali problematiche ad essa
sottese, avuto riguardo anche alla particolare problematica della compatibilità tra il reato associativo e
l’aggravante della c.d. transnazionalità ed esprimendo, in conclusione, una motivata valutazione circa la
possibilità di proporre ricorso per cassazione.
1. La questione.
La questione oggetto di dibattito involge la circostanza aggravante ad effetto speciale della c.d.
«transnazionalità» di cui all’art. 4 della l. 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) ed in particolare la
sua compatibilità con il reato di associazione per delinquere ovvero solo con i singoli reati
fine.
Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 3, l. cit., è reato transnazionale il reato punito con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo
criminale organizzato, nonché il reato sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia
commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso
sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
247
Parte speciale Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Da ciò è agevole dedurre che la transnazionalità, considerata in sé, non sia un’autonoma
fattispecie di reato, bensì una peculiare modalità di espressione riferibile a qualsiasi delitto, a
condizione che lo stesso assuma una proiezione transfrontaliera.
L’art. 4 l. cit. oggetto di discussione, in particolare, prevede una circostanza speciale, in quanto
applicabile solo a determinati reati ritenuti gravi, puniti con una pena non inferiore nel massimo a
quattro anni, e ad effetto speciale, ex art. 63, co. 3, c.p., poiché prevede un aumento di pena da
un terzo alla metà.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
In tema, gli indirizzi emersi in seno alla giurisprudenza di legittimità erano due.
2.1. Il primo orientamento: Incompatibilità dell’aggravante con l’art.
416 c.p.
A mente di un primo indirizzo, sostenuto per altro da un’unica pronuncia (Cass. Pen., Sez. V, 21
gennaio 2011, n. 1937) la circostanza aggravante della transnazionalità non è compatibile
con il reato associativo.
1° Argomento: incompatibilità concettuale ed ontologica dell’aggravante. Questa
presupporrebbe, infatti, l’esistenza del gruppo criminale organizzato, potendo per tale ragione
accedere ai soli reati fine attuati del medesimo; del resto, “l’associazione criminosa è la
qualificazione giuridica del ‘gruppo criminale organizzato’, speculare allo stesso, e non una
proiezione esterna, un ‘quid pluris’, cui il gruppo abbia dato il suo contributo”.
2° Argomento: ragioni sistematiche e di giustizia sociale. L’aggravante della
transnazionalità sarebbe incompatibile rispetto al reato associativo in ragione dell’evidente
irrazionalità di un aggravamento di pena che non aderisca a un fatto esterno, dotato di autonomo
disvalore penalistico, ma che si riferisca invece ai medesimi elementi di fatto che già integrano il
reato base.
2.2. Il secondo orientamento: Compatibilità dell’aggravante con l’art.
416 c.p.
La conclusione prevalente fra i giudici di legittimità (Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2013, n.
16540; Cass. pen., sez. III, 26 giungo 2012, n. 27413; Cass. pen., sez. I, 06 giugno 2012, n.
31019; Cass. pen., Sez. V, 10 novembre 2011, n. 1843), invece, preme per la compatibilità
dell’aggravante de qua con il delitto di associazione per delinquere, qualora il gruppo
criminale organizzato ponga in essere attività illecite realizzate in più di uno Stato.
1° Argomento: struttura del delitto di associazione per delinquere. Invero, non solo il
delitto di cui all’art. 416 c.p. prevede una pena edittale superiore nel massimo a quattro anni
di reclusione, dovendo poi essere altresì preso in considerazione che tale reato necessita, per
definizione, del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Da ciò, allora, non
potrebbe non derivare la conclusione per cui l’operatività in più Stati dell’associazione per
248
Scheda di giurisprudenza n. 27 delinquere è sufficiente a determinare l’automatica applicabilità dell’aggravante in parola al
reato associativo, essendo appunto detta transnazionalità l’unico elemento variabile, non
coessenziale a entrambe le definizioni legislative.
3. La soluzione delle Sezioni Unite: Compatibilità dell’aggravante con il
delitto di associazione per delinquere.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. Un., 23 aprile 2013, n. 18374)
hanno ribadito, ancora una volta, la compatibilità dell’aggravante della transnazionalità con il
delitto di associazione per delinquere, allineandosi, così, alla giurisprudenza prevalente (per non
dire quasi del tutto univoca) in tema, a condizione che il gruppo criminale organizzato
transnazionale non coincida con l’associazione stessa
1° Argomento: concetto di transnazionalità. Il concetto de quo, a ben vedere, non è
elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie delittuosa, configurando, invece, una peculiare
modalità di espressione riferibile a qualsiasi delitto, sempre che lo stesso, sia per ragioni
oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di
uno Stato, assuma una proiezione transfrontaliera.
In quest’ottica, la Corte sottolinea che l’art. 3 qualifica il reato come transnazionale in
virtù di tre criteri:
• la gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena;
• il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
• in forma alternativa: la commissione del reato in più di uno Stato; la commissione
in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua pianificazione, direzione o
controllo in un altro Stato; la commissione in uno Stato, ma implicazione in esso di
un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
la commissione in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.
Del resto, proprio in virtù della qualificazione di transnazionalità il fatto delittuoso cui
inerisce deve considerarsi più grave: è connotato, infatti, da un coefficiente di maggiore
pericolosità connesso alla fenomenologia della criminalità organizzata transnazionale. L’art. 4,
infatti, introduce una speciale aggravante per il reato “grave” che sia commesso con il “contributo”
di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato: proprio il
generico riferimento a qualunque reato, purché ad esso si accompagni la previsione sanzionatoria
contemplata dalla norma, propende per la conclusione in base alla quale l’apporto causale di un
gruppo siffatto possa spiegarsi nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche
di quella associativa, e non dei soli reati fine, di cui la prima costituisce il mezzo per la relativa
consumazione.
2° Argomento: critica della tesi dell’incompatibilità. Il sostegno alla prima tesi
comporterebbe l’immedesimazione del gruppo criminale organizzato, il cui apporto è
presupposto dell’aggravante, con la contestata associazione, non essendo così più ipotizzabile
l’esistenza di un gruppo criminale che contribuisca all’esistenza di sé stesso. Tuttavia, la
formulazione normativa dell’aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, è chiara
nell’affermare la necessità che, ai fini della sua integrazione, presupposto indefettibile sia
proprio la mancanza di immedesimazione, richiedendo che associazione per delinquere e
249
Parte speciale gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse.
3° Argomento: combinato disposto degli artt. 3 e 4, l. 16 marzo 2006, n. 146. In ragione
dell’interpretazione congiunta di tali norme, la Corte afferma la compatibilità dell’aggravante de
qua con il delitto di associazione per delinquere; non solo. I giudici sottolineano che non è
necessario che il reato venga commesso anche all’estero, ben potendo restare circoscritto in
ambito nazionale, né che l’associazione per delinquere operi anche in Paesi esteri né infine
che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in Paesi diversi, posto che quel
che occorre, ai fini dell’operatività dell’aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di
aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello
internazionale.
Il contributo, naturalmente, pur realizzato in forma associativa, deve comunque
rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria ad integrare la
fattispecie base di reato: non potrebbe essere altrimenti, del resto, sol se si pensi che proprio tale
contributo integra il quid pluris richiesto dalla norma ai fini dell’applicazione dell’aggravamento di
pena.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene che di dover sconsigliare a Tizio e Caio la proposizione di ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, nel confermare quanto stabilito dal giudice di
primo grado, condannava entrambi per il reato di cui all’art. 416 c.p., co. 1, 2, 3 e 5, con l’aggravante prevista
dall’art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, per essersi associati tra loro e con altre persone, allo scopo di
commettere un numero indeterminato di reati.
Invero, alla luce della giurisprudenza maggioritaria, tale condotta correttamente è stata sussunta nell’ambito
del delitto di associazione per delinquere; non solo. In virtù dei recenti arresti in materia, si ritiene anche
pienamente applicabile l’aggravante di cui all’art. 4, l. 146/2006, ritenuta pienamente compatibile con il delitto
contestato agli imputati.
LA SENTENZA DECISIVA
Cass. pen., Sez. Un., 23 aprile 2013, n. 18374
Estratto
[...Omissis...]
1. Il ricorso proposto nell’interesse dell’A. - affidato al mero rilievo della mancanza di motivazione in ordine
all’insussistenza delle condizioni che, a mente dell’art. 129 c.p.p., avrebbero comportato il proscioglimento
nel merito - è manifestamente infondato.
Ed invero, è ius receptum, alla stregua di consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, che, ai fini
dell’adempimento dell’obbligo della motivazione nella speciale sentenza di patteggiamento - con particolare
riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. - deve reputarsi sufficiente la mera enunciazione, da
parte del giudice, della compiuta delibazione in merito. Tanto più quando dagli atti di causa non risulti - come
nella fattispecie in esame - che le parti abbiano dedotto o fatto specifica questione in ordine alla ricorrenza di
250
Scheda di giurisprudenza n. 27 una delle previste cause di non punibilità, sì da rendere poi necessaria una specifica motivazione sul punto.
Nel caso di specie, il ridotto onere motivazionale è stato pienamente assolto. Infatti, il giudicante ha,
compiutamente, indicato le ragioni ostative ad un più favorevole proscioglimento nel merito, con particolare
riferimento alle “chiare risultanze dell’indagine svolta dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza,
compendiate nell’informativa finale n. 39737 dell’11.3. 2011, che consentivano di disvelare l’esistenza di
un’articolata e complessa organizzazione di carattere transnazionale (...) nella quale hanno fatto parte (...) gli
odierni imputati (...) in qualità di organizzatori e che si proponeva, quale oggetto sociale, la commissione di
una pluralità di reati di bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed altri
reati tributari, appropriazione indebita riciclaggio”, soggiungendo più oltre: “rilevato che gli operanti
accertavano l’esistenza di una complessa organizzazione, promossa e costituita dai citati commercialisti (...)
e nel corso degli anni articolatasi mediante collaborazione con strutture professionali autonome ed esterne,
facenti capo al V. ed all’A., che forniva soluzioni fraudolente alla propria clientela - fra cui si annoveravano
vari e consistenti gruppi imprenditoriali - consistite in operazioni di sottrazione fraudolenta al pagamento
dell’imposta mediante distrazione di beni, di autofinanziamento attraverso operazioni di leasing e di
riciclaggio, reimpiego di beni e denaro, operazioni realizzate con l’ausilio ed il contributo degli attuali imputati
che hanno sfruttato la loro professionalità di commercialisti”.
D’altronde, la doglianza è espressa in termini assolutamente generici, limitandosi ad una mera enunciazione,
che omette anche di indicare quali elementi concreti, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero potuto
giustificare una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi della menzionata norma processuale.
Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria consegue, a mente dell’art. 616 c.p.p., l’onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura indicata in dispositivo.
2. La questione di diritto, investita dal ricorso del V., che deve essere esaminata dalle Sezioni Unite, è la
seguente: “se la circostanza aggravante ad effetto speciale della c.d.
transnazionalità, prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, sia compatibile con il reato di associazione
per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine”.
3. In limine, va riconosciuta la piena ammissibilità della censura espressa sul punto dal ricorrente V.,
ancorchè lo stesso imputato abbia patteggiato la pena, peraltro sul presupposto della sussistenza
dell’anzidetta circostanza.
Si tratta, infatti, di doglianza afferente alla definizione della fattispecie incriminatrice, in forma semplice od
aggravata.
Orbene, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, in tema di patteggiamento, il
ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come
prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia
sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. b), (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825).
4. Il tema anzidetto ha costituito oggetto di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte
regolatrice, nei termini già segnalati dall’Ufficio del Massimario con relazione n. 15 del 18 aprile 2011.
Ed invero un primo orientamento è espresso - in tema di associazione per delinquere dedita al narcotraffico,
prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, - da Sez. 5, n. 1937 del 15/12/2010, dep. 21/01/2011,
Dalti, Rv. 249099, secondo cui la speciale aggravante è concettualmente ed ontologicamente incompatibile
con l’ipotesi associativa, sul riflesso che la detta circostanza presuppone l’esistenza del gruppo criminale
organizzato e può accedere, pertanto, ai soli reati costituenti la diretta manifestazione dell’attività del gruppo
(c.d. reati-fine dell’associazione) ovvero di quelli ai quali il gruppo abbia prestato un contributo causale.
Il secondo orientamento - nel senso dell’applicabilità della circostanza aggravante anche al reato associativo
- è, invece, sostenuto da un maggior numero di pronunce emesse da diverse Sezioni:
in particolare, la Terza Sezione con sentenze n. 27413 del 26/6/2012, Amendolagine, Rv. 253146; n. 11969
del 24/2/2011, Rossetti, Rv.
251
Parte speciale 249760; n. 35465 del 14/07/2010, Ferruzzi, Rv. 248481; n. 10976 del 14/01/2010, Zhu, Rv. 246336; la Prima
Sezione, con sentenza n. 31019 del 06/06/2012, Minnella, Rv. 253280; e, da ultimo, la stessa Quinta
Sezione, con pronuncia n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253481, emessa, peraltro, in riferimento alla
stessa vicenda sostanziale oggetto del presente giudizio, seppur nei confronti di altro imputato.
5. All’esame della questione di diritto giova premettere un breve richiamo al contesto normativo di riferimento.
La L. n. 146 del 2006, art. 4, recante l’intestazione: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, così dispone:
“1. Per i reati previsti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella
commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività
criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. - 2. Si applica altresì il D.L. 13 maggio
1991, n. 152, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni”.
Si tratta, in tutta evidenza, di circostanza “speciale” - in quanto applicabile solo a determinati reati, ritenuti
gravi siccome puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione - e, ad un tempo, “ad
effetti speciali”, in ragione dell’entità dell’aumento di pena previsto, superiore ad un terzo, ai sensi dell’art. 63
c.p., comma 3.
All’operatività dell’aggravante è stato esteso il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti diverse
da quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p., previsto, per reati connessi ad attività mafiose, dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ad eloquente
sottolineatura della particolare pericolosità attribuita dal legislatore a fatti-reato alla cui realizzazione abbia
dato un contributo causale un gruppo criminale organizzato “impegnato in attività criminali in più di uno
Stato”.
5.1. La lettura della norma in parola non può andare disgiunta - nell’ineludibile esigenza di una prospettiva
sistematica - dall’esame di quella immediatamente precedente, che, recando la definizione di “reato
transnazionale”, è con essa intimamente connessa, nell’assumere un ruolo di indubbia centralità nella
complessiva impalcatura della disciplina in questione.
L’art. 3 dispone: “Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonchè: - a) sia commesso in più di uno Stato; - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una
parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo intervenga in un altro Stato; - c)
ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in
attività criminali in più di uno Stato; - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un
altro Stato”.
5.2. Com’è fatto palese dalla riferita intestazione, la legge n. 146 del 2006 autorizza la ratifica della
Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre
2000, correntemente intesa “Convenzione di Palermo” o TOC Convention (da Transnational Organized
Crime Convention). I Protocolli aggiunti alla Convenzione, cui si fa espresso richiamo per farne parte
integrante, riguardano, rispettivamente, il traffico di immigrati clandestini (smuggling), la tratta degli esseri
umani (trafficking), con specifico riferimento allo sfruttamento di donne e bambini (exploitation), ed il traffico
di armi da fuoco e relative munizioni.
5.3. Scopo della Convenzione - efficacemente scolpito dall’art. 1 - è quello di promuovere la cooperazione
degli Stati - parte per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.
A fronte del dilagare di forme di criminalità organizzata travalicanti le frontiere nazionali, la comunità
internazionale ha preso coscienza della pericolosità di siffatta fenomenologia e della necessità che, ai fini di
una più efficace azione di contrasto, vengano adottate risposte capaci di rapportarsi alle nuove metodologie
delle organizzazioni criminali. In questa prospettiva di condivisione si è cercato di rendere, quanto più
possibile, omogeneo il piano di azione degli Stati - membri, mediante l’obbligo convenzionale di incriminare
252
Scheda di giurisprudenza n. 27 determinate tipologie di attività illecite riconducibili a gruppi criminali internazionali (ed anche la mera
partecipazione ad essi, ai sensi dell’art. 5) e la previsione di forme di cooperazione giudiziaria e di polizia per
rendere più efficaci gli strumenti investigativi, in un quadro concertato di specifiche procedure di assistenza
giudiziaria, estradizione, trasferimento dei giudizi, sequestro e confisca dei proventi di reato e quant’altro.
D’altronde, già da tempo, in ambito internazionale, si era avuta chiara percezione della pericolosità di
aggregazioni attive in ambito transfrontaliero: eloquente segno, in tal senso, è costituito dall’elaborazione
pattizia della nozione “organizzazione criminale” recepita dall’art. 1 dell’Azione comune 98/733/GAI, relativa
alla punibilità della partecipazione a consorterie criminali negli Stati membri dell’Unione Europea, adottata il
21 dicembre 1998 dal Consiglio dell’U.E..
Anzi, proprio sulla relativa formulazione (“Ai fini della presente azione comune, per organizzazione criminale
si intende l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato
allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza
privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in
sè ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l’operato delle
pubbliche autorità”) sembra disegnata la nozione di gruppo organizzato criminale ora in esame.
5.4. L’esigenza della previsione di un obbligo d’incriminazione delle fenomenologie delinquenziali in forma
organizzata va apprezzata sul rilievo che alla tradizione giuridica e culturale di alcuni Stati aderenti era
estranea l’elaborazione dell’associazionismo criminale, capace di sostanziare autonome configurazioni di
reato. Il nostro ordinamento, invece, sin dal lontano 1930, incriminava espressioni di delinquenza
plurisoggettiva, dalla forma più elementare del concorso di persone, ai sensi dell’art. 110 c.p., a quella più
complessa dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., Successivamente, sono state, via via,
tipizzate peculiari fenomenologie di aggregazione, come, tra le altre, l’associazione per delinquere finalizzata
al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater;
l’associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 416 bis c.p.;
l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all’art. 74 T.U. stup.; sino alla violenza sessuale di
gruppo prevista dall’art. 609 octies c.p., e alle forme di discriminazione razziale di cui alla L. 13 ottobre 1975,
n. 654, art. 3, che utilizza, alternativamente, le nozioni di organizzazione, associazione, movimento o gruppo.
6. Tornando, ora, alla legge di ratifica, il combinato disposto del L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, consente,
intanto, di affermare che, per conformazione morfologica e strutturale, la transnazionalità non è elemento
costitutivo di un’autonoma fattispecie delittuosa, destinata ad incrementare il già cospicuo novero di illeciti
dell’universo penale. Si tratta, invece, di una peculiare modalità di espressione, o predicato, riferibile a
qualsivoglia delitto (con esclusione, quindi, delle contravvenzioni), a condizione che lo stesso, sia per ragioni
oggettive sia per la sua riferibilità alla sfera di azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Stato,
assuma una proiezione transfrontaliera.
Il “reato transnazionale” è, dunque, nozione definitoria che si ricava dall’insieme degli elementi costitutivi di
un comune delitto e di quelli specifici, positivamente previsti.
6.1. In particolare, il citato art. 3 ancora la qualificazione della transnazionalità al concorso di tre distinti
parametri.
Il primo è connesso alla gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena (non inferiore
nel massimo a quattro anni di reclusione), dunque sulla base di un coefficiente di gravità non flessibile, bensì
predeterminato, peraltro in conformità della nozione di reato grave recepita dalla stessa Convenzione, che,
nel “glossario” offerto dall’art. 2, qualifica “reato grave” proprio la condotta sanzionabile “con una pena
privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata”.
Il secondo criterio prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Il lemma “coinvolto” che
figura nel testo normativo è sicuramente inusuale nel lessico penalistico, evocando espressioni di vago
tenore colloquiale o di conio prettamente giornalistico.
Si tratta, in realtà, della mera trasposizione letterale del termine che figura nel testo della Convenzione
(dall’inglese involving), ove assume una significazione volutamente generica, capace di compendiare, proprio
253
Parte speciale per ampiezza di formulazione, diversi modelli ordinamentali di incriminazione del fenomeno lato sensu
associativo, l’association de malfaiteurs, propria dei sistemi di civil law, l’associazione per delinquere di
stampo mafioso, tipicamente italiana, e la conspiracy, tradizionale strumento di contrasto giudiziario alla
criminalità organizzata nei sistemi penali di common law, in cui è, notoriamente, meno netta la distinzione tra
concorso di persone e fattispecie associative.
Nondimeno, trattandosi di approccio solo definitorio, può ritenersi che il termine alluda, genericamente, a
qualsivoglia forma di riferibilità del fatto-reato all’operatività di un gruppo criminale organizzato (quale esso
sia e tout court indicato, ossia indipendentemente dal suo impegno in attività criminali commesse in più di
uno Stato, come invece richiesto, più oltre, dalla previsione sub c); in breve, deve trattarsi di espressioni di
criminalità in forma organizzata, sicchè è agevole il rilievo che la dimensione organizzativa è componente
coessenziale della complessa fenomenologia criminale in questione.
Soggettiva “riferibilità”, secondo l’interpretazione offerta dalle prime riflessioni dottrinarie sul tema, può essere
intesa in termini di interrelazione biunivoca, ossia come contributo alla commissione del reato offerto da uno
o più adepti del gruppo criminale organizzato, in adempimento del programma criminale dello stesso
sodalizio, ovvero come vantaggio che al gruppo oggetti va mente derivi, comunque, dall’attività delittuosa da
altri posta in essere.
Il terzo parametro si sostanza, invece, di uno degli elementi che la norma prevede, stavolta, in forma
alternativa: commissione del reato in più di uno Stato (a), commissione in uno Stato, ma con parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato (b); commissione in
uno Stato, ma implicazione in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di
uno Stato (c); commissione in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (d).
6.2. La formalizzazione del connotato di transnazionalità, ancorchè priva di specifico contenuto precettivo e
sanzionatorio, non assolve, però, ad esigenza meramente definitoria o descrittiva, ma è, invece, foriera di
rilevanti effetti sul piano della disciplina sostanziale e processuale. Già questo lascia, chiaramente, intendere
che la connotazione in parola non è fine a se stessa, in quanto implica che, proprio per le dette ricadute, il
fatto delittuoso cui inerisce debba considerarsi, eo ipso, più grave rispetto alla forma ordinaria, in ragione del
coefficiente di maggiore pericolosità che l’ordinamento interno, in ottemperanza dei menzionati obblighi
convenzionali, era chiamato ad attribuire alla peculiare fenomenologia della criminalità organizzata
transnazionale.
Si intende fare riferimento, tra gli altri effetti, alla previsione della responsabilità amministrativa degli enti di
cui alla L. n. 146 del 2006, art. 10, che, proprio nel caso di commissione di uno dei reati previsti dall’art. 3,
sancisce l’applicabilità di particolari sanzioni amministrative in misura determinata; alla confisca obbligatoria
anche per equivalente prevista dall’art. 11 della stessa normativa proprio per i reati di cui al detto art. 3;
all’estensione dei poteri di indagine del pubblico ministero “nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del
codice di procedura penale”, allo scopo di assicurare la confisca, nella massima estensione possibile, dei
proventi dell’attività illecita, ai sensi dell’art. 12;
all’attribuzione al Procuratore distrettuale antimafia delle stesse competenze conferite al procuratore della
Repubblica ed al questore in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, come previsto - sempre
per i reati di cui al menzionato art. 3 - dal successivo art. 13; alla possibilità del trasferimento di processi
penali (già prevista dall’art. 21 della Convenzione), che deve aver luogo esclusivamente nella forme e nei
limiti degli accordi internazionali.
Dunque, tutta una serie di effetti “a cascata” che, come si è detto, valgono a conferire al reato transnazionale
uno specifico rilievo rispetto ad identica forma delittuosa priva di siffatta caratterizzazione.
7. Limitandosi ad introdurre una norma meramente definitoria, l’art. 3, non prevede, quindi, sanzione alcuna.
Invece, il successivo art. 4, introduce una speciale aggravante per il reato “grave” che sia commesso con il
“contributo” di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.
7.1. Dal raffronto delle due disposizioni balza evidente come la previsione della particolare aggravante sia
stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della
254
Scheda di giurisprudenza n. 27 transnazionalità, ossia quello di cui alla lettera c). La circostanza è, dunque, “ritagliata” dalla definizione
anzidetta con operazione selettiva, che per una sola delle ipotesi di transnazionalità - cioè la “implicazione” di
un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato - ha previsto
l’aggravamento di pena.
7.2. Potrebbe discutersi circa l’individuazione della ratio di una simile scelta, ma ciò che conta è che essa
non appare improntata ad irragionevolezza, ponendosi, anzi, in sintonia con le precipue finalità della
Convenzione, come sopra indicate, tenuto peraltro conto della disposizione di cui all’art. 34, comma 3,
secondo cui “ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dada presente
Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale”.
7.3. La previsione dell’aggravante resta, ovviamente, inglobata nella più ampia nozione di transnazionalità, in
termini plasticamente rappresentabili con la configurazione geometrica dei centri concentrici.
È agevole, allora, inferire che non è il reato transnazionale in sè soggetto ad aggravamento di pena, mentre
la sussistenza della speciale aggravante della L. n. 146 del 2006, art. 4, è, invece, già di per sè, sintomo
univoco di transnazionalità, di talchè il reato comune aggravato è sempre - e necessariamente - reato
transnazionale, ai fini della stessa legge di ratifica.
7.4. All’atto dell’estrapolazione dal novero dei parametri di transnazionalità di una sola delle ipotesi previste
dall’art. 3, si è, poi, avuta la singolare trasposizione semantica dal lemma “implicato”, contenuto nella lett. c)
(“in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato” - termine sostanzialmente coincidente con quello
“coinvolto”) - nel sintagma, contenuto nell’art. 4, “dato il suo contributo” (“Per i reati (...) nella commissione dei
quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato”).
Dall’atecnica ed aspecifica formula: “implicazione” si è, dunque, passati ad una locuzione ben più consona al
patrimonio lessicale penalistico. “Dare il contributo”, infatti, è null’altro che prestare un apporto causalmente
rilevante, in chiave di causalità materiale, nel senso che la commissione di un qualsiasi reato in ambito
nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, deve essere stata
determinata, od anche solo agevolata, in tutto od in parte, dall’apporto deterministico - quale esso sia - di un
gruppo criminale organizzato transnazionale.
7.5. L’inequivoca formulazione della norma, nello specifico richiamo al contributo causale di un gruppo
criminale organizzato, non consente la diversa opzione ermeneutica dell’applicabilità dell’aggravamento ad
ogni ipotesi di transnazionalità, nel concorso delle condizioni previste dalla L. n. 146 del 2006, art. 3, ogni
qual volta, cioè, il reato sia comunque riconducibile alla sfera di operatività di un gruppo organizzato
transnazionale.
Se è vero, infatti, che uno degli indici della transnazionalità c.d. soggettiva è il “coinvolgimento” di un gruppo
criminale organizzato transnazionale, è pur vero che, per l’intervento selettivo del legislatore, ai fini
dell’aggravamento di pena è necessario un più elevato coefficiente di coinvolgimento, ossia la prestazione di
un contributo causale alla commissione del reato, giacchè - per quanto si è detto - solo siffatta situazione, per
discrezionale scelta del legislatore, è ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale.
7.6. Il generico riferimento normativo a qualsiasi reato, purchè ad esso si accompagni la previsione
sanzionatoria di cui si è detto, porta allora a ritenere che l’apporto causale di un gruppo siffatto possa
spiegarsi nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di quella associativa. Alla
stregua dei dati normativi e delle linee ispiratrici della Convenzione non è dato, infatti, ravvisare ragione
alcuna perchè la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo,
che costituisce il mezzo per la relativa consumazione.
Non esiste, dunque, alcun motivo - nè d’ordine testuale nè d’ordine logico-sistematico - per ritenere
l’incompatibilità della speciale aggravante con quest’ultimo reato.
Resta da dire che nessuna diretta rilevanza, ai fini della soluzione della quaestio iuris in esame, può
assumere il riferimento alla L. n. 146 del 2006, art. 10, che prevede, tra i reati transnazionali che comportano
responsabilità amministrativa degli enti, proprio i reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.. Ed infatti,
la norma anzidetta può, semmai, costituire conferma del fatto che anche il reato associativo possa assumere
255
Parte speciale connotato di transnazionalità, ma nulla dice sull’applicabilità al detto reato dell’aggravante di cui all’art. 4.
7.7. Il rilievo argomentativo sul quale si fonda il percorso motivazionale della sola sentenza che si è espressa
in favore dell’incompatibilità, ossia la citata Sez. 5 Dalti, risente in tutta evidenza di un equivoco di fondo,
ossia del convincimento che l’associazione per delinquere si identifichi nel gruppo criminale organizzato
ovvero si sovrapponga ad esso (“La circostanza presuppone l’esistenza del gruppo criminale organizzato e
può accedere pertanto ai reati costituenti la diretta manifestazione dell’attività del gruppo, c.d. reati-fine
dell’associazione, ovvero di quelli ai quali il gruppo abbia prestato un contributo causale. Il reato associativo,
per contro, non è qualificato da tale elemento circostanziale ove si consideri che l’associazione criminosa è la
qualificazione giuridica del gruppo criminale organizzato, speculare allo stesso, e non una proiezione
esterna, un quid pluris, cui il gruppo abbia dato il suo contributo”). In tale logica, se il gruppo criminale
organizzato, il cui apporto è presupposto dell’aggravante, non fosse altro che la contestata associazione per
delinquere, non sarebbe ovviamente ipotizzabile l’esistenza di un gruppo criminale che contribuisca
all’esistenza di se stesso; donde, la ritenuta riferibilità del contributo ai soli reati fine.
Invece, la formulazione normativa dell’aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia
chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di
immedesimazione, richiedendo - piuttosto - che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato
si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. La locuzione “dare contributo” postula, infatti,
“alterità” o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà
plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell’apporto causale.
D’altronde, le espressioni: “associazione per delinquere” e “gruppo organizzato”, al di là dell’improprio uso
promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corrente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o
concettualmente sovrapponibili.
Ed invero, quanto alla nozione “gruppo criminale organizzato” - che il legislatore non ha ritenuto definire - non
può che farsi riferimento alla definizione offerta dalla stessa Convenzione, che, del resto, proprio in forza
della legge di ratifica ed esecuzione n. 146 del 2006, è stata recepita, nella sua interezza, nel nostro
ordinamento giuridico.
Orbene, a mente dell’art. 2, punto a) della detta TOC Convention, “gruppo criminale organizzato” è “un
gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di
concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di
ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.
Il punto e) dello stesso art. 2, reca, poi, la definizione di “gruppo strutturato”, da intendere come gruppo “che
non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve
necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una
struttura articolata”.
Si tratta, allora, di nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di
concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p., e di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p..
“Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del
21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è - con pari certezza - un minus rispetto alla associazione per
delinquere. Per la sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di
organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la
costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro
vantaggio materiale; invece, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 c.p., anche alla luce di
ricorrente lettura di questa Corte, occorrono un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima
od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di
una serie indeterminata di reati (tra le altre, Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. il 31/01/2012, Papa, Rv.
251562). Il contesto strutturale - organizzato deve essere, insomma, funzionale alla realizzazione di un
numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche il
teleologismo finanziario o comunque materiale dell’azione della consorteria, derivando - di fatto - l’eventuale
256
Scheda di giurisprudenza n. 27 profitto dall’apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia funzionalmente preordinato.
È ovvio poi che, ove il gruppo organizzato assuma siffatti connotati, diventi esso stesso associazione per
delinquere e, in tal caso, vi sarà sicura sovrapposizione od immedesimazione delle due entità.
Nell’ipotesi di cui all’art. 4, invece, siffatta immedesimazione non deve assolutamente sussistere, giacchè per quanto si è detto - la previsione del contributo causale implica diversità soggettiva, ossia l’esistenza di
due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attività
criminali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, cioè alla
costituzione od all’agevolazione, in qualsiasi forma, dell’associazione formatasi ed operante in ambito
nazionale.
Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l’ipotesi in cui il gruppo
organizzato sia esso stesso associazione per delinquere. D’altronde, in uno al dato ontologico
dell’immedesimazione, all’applicabilità dell’aggravante osterebbe, sul piano formale, il chiaro disposto
normativo dell’art. 61 cod. pen., secondo cui le circostanze, positivamente previste, aggravano il reato
“quando non ne sono elementi costitutivi”.
Deve pure essere espunta l’ipotesi che l’associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati od
anche l’ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all’estero oppure gli effetti sostanziali
dell’attività della stessa consorteria si producano oltre confine.
In questi casi, infatti, il reato associativo assume, di per sè, connotato di transnazionalità, ai sensi della L. n.
146 del 2006, art. 3, ma la sua commissione non è il risultato dell’apporto contributivo di un gruppo
organizzato “esterno”, nei termini della sola evidenza fattuale, che, per quanto si è detto, il legislatore - nella
sua discrezionale valutazione - ha ritenuto di tale gravità da comportare aggravamento di pena.
7.8. Dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 3 e 4 della legge di ratifica emerge, quindi,
chiaramente, che, ai fini della configurazione della speciale aggravante in esame, non è affatto necessario
che il reato in questione venga commesso anche all’estero, ben potendo restare circoscritto in ambito
nazionale, come, correttamente, ritenuto da Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri (in senso contrario,
Sez. 3, n. 35465 del 14/07/2010, Ferruzzi, Rv. 248481, che reputa, invece, necessario che la stessa struttura
associativa sia impegnata in attività realizzate in più di uno Stato); nè che l’associazione per delinquere operi
anche in paesi esteri (Sez. 1, n. 31019 del 06/06/2012, Minnella, Rv. 253280). Non è neppure necessario
che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in paesi diversi (Sez. 3, n. 27413 del 26/06/2012,
Amendolagine, Rv 253146; Sez. 3, n. 10976 del 14/01/2010, Zhu, Rv 246336), posto che - per quanto si è
detto - quel che occorre, ai fini dell’operatività dell’aggravante, è che alla commissione del reato oggetto di
aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale.
7.9. Nell’individuazione dell’ambito concettuale del “contributo causale” non può certo sottacersi che, dal
punto di vista del sistema penale interno, “contribuire” alla realizzazione di un reato implica
compartecipazione delittuosa e, dunque, concorso nella relativa commissione. Ma siffatta evenienza non
collide, di certo, con la sfera di previsione della norma di cui all’art. 4, in quanto le due ipotesi attengono a
distinti versanti concettuali: uno, afferente al gruppo in sè considerato; l’altro, all’eventuale partecipazione e
responsabilità di taluni suoi componenti. Insomma, il gruppo organizzato può aver contribuito alla
costituzione del sodalizio delittuoso (il quale, ad esempio, si sia formato proprio nella prospettiva dell’apporto
logistico e funzionale di un gruppo operante all’estero), senza che tutti i suoi componenti possano poi secondo il diritto interno - ritenersi partecipi, o concorrenti esterni, del reato associativo commesso in ambito
nazionale. Si tratta, a ben vedere, di un principio mutuato dalla elaborazione giurisprudenziale in tema di
associazione per delinquere, secondo cui la partecipazione ad una consorteria criminale non comporta, eo
ipso, l’imputabilità a tutti i sodali dei reati-fine dalla stessa pianificati.
Il riferimento non deve ritenersi poco pertinente, ove si consideri che il gruppo criminale organizzato
transnazionale può anche essere stato costituito in Italia ed avere qui sede operativa, restando, quindi,
soggetto alla giurisdizione nazionale.
È, dunque, pacifico che, “in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell’ambito della
257
Parte speciale struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica
responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all’organizzazione e
inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che
materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e
consapevole all’attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso
di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall’ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi
forma di anomala responsabilità di posizione o da riscontro d’ambiente” (Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, dep.
21/01/2008, Saltalamacchia, Rv. 238402; Sez. 6, n. 37115 del 28/09/2007, Vicorito, Rv. 237291).
Applicando siffatti principi alla fattispecie in esame, consegue che, per offrire contezza al maggior tasso di
disvalore insito nell’aggravante derivante dall’essersi avvalsi, per la commissione di un reato, del contributo
offerto da “un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, occorre
postulare una necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato “comune” e quella che vale a
realizzare il “contributo” prestato dal gruppo “transnazionale”, giacchè, ove i due fatti si realizzassero
reciprocamente all’interno di una sola condotta, mancherebbe la ragione d’essere per ipotizzare la diversa - e
più grave - lesione del bene protetto. Si avrebbe, in tale ipotesi, un’unica associazione per delinquere
“transnazionale”, ossia una fattispecie complessa, secondo il paradigma dell’art. 84 c.p., comma 1, in cui la
circostanza aggravante - corrispondente, del resto, alla previsione della L. n. 146 del 2006, precedente art. 3,
lett. c), - verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo transnazionale. Si tratterebbe,
però, non già di un’autonoma fattispecie di reato - non prefigurata dal legislatore della novella e neppure
enucleatane in via ermeneutica - bensì di una “ordinaria” associazione per delinquere cui inerisce lo speciale
connotato della transnazionalità, con ogni conseguenziale implicazione.
In tale prospettiva, occorre dunque verificare se ed in che limiti il contributo di un gruppo organizzato
transnazionale, che in sè potrebbe già presentare, in ipotesi, tutti i connotati per realizzare la fattispecie di
una associazione finalizzata alla commissione di determinati delitti - divenendo per ciò stesso perseguibile in
base al quadro normativo vigente - possa rappresentare, a sua volta, quella autonoma condotta
“aggravatrice” rispetto alla stessa fattispecie associativa.
Ebbene, poichè quel contributo - ancorchè realizzato in forma associativa - deve ontologicamente
rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per realizzare la fattispeciebase, se ne può dedurre che l’aggravante in questione non risulta compatibile con la figura della
associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e
funzionale, dando luogo ad un’unica associazione transnazionale.
Ove, invece, l’associazione per delinquere “basti a se stessa”, nel senso che i relativi associati o parte di essi
ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo
di contributo esterno, ben può immaginarsi che, a tale condotta, altra (e autonoma) se ne possa affiancare, al
fine di estendere le potenzialità l’agere del sodalizio in campo internazionale; con la conseguenza che, ove
un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale
collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità,
tale da giustificare l’applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla
circostanza che il contributo offerto dal “gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di
uno Stato” renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo “comune”, posto
che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può
certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati.
7.10. In conclusione, con riferimento alla questione sottoposta alle Sezioni Unite, deve essere affermato il
principio di diritto secondo il quale “la speciale aggravante della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, è applicabile
al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con
l’associazione stessa”.
[...Omissis...]
258
Scheda di giurisprudenza n. 28 Scheda di giurisprudenza n. 28
Concorso esterno in associazione mafiosa e sua evoluzione giurisprudenziale
TRACCIA
Tizio veniva condannato in primo grado dal Tribunale di OMISSIS a titolo di concorso esterno
nell’associazione mafiosa Cosa nostra ex art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, c.p., per aver messo a disposizione
della stessa l’influenza e il potere derivante dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario e
imprenditoriale, in tal modo partecipando al mantenimento ed al rafforzamento, oltre che all’espansione
dell’associazione medesima. Ciò era avvenuto attraverso la partecipazione ad incontri con esponenti anche
di vertice della struttura, intrattenendo, tramite essi, rapporti continuativi con l’associazione e quindi
determinando nei capi la consapevolezza della assunzione, da parte dell’imputato, di condotte volte ad
influenzare, a vantaggio della associazione per delinquere, soggetti operanti nel mondo istituzionale ed
imprenditoriale.
In particolare, Tizio aveva svolto attività di mediazione fra il sodalizio mafioso e gli ambienti imprenditoriali e
finanziari di OMISSIS, dando la propria disponibilità a consentire al sodalizio lauti incassi, frutto di estorsioni
all’imprenditore OMISSIS.
La Corte di Appello confermava la condanna in secondo grado.
Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato, premessi cenni sull’associazione di stampo mafioso e sul
concorso esterno, rediga motivato parere sulla vicenda in esame, illustrando le principali problematiche ad
essa sottese.
1. La questione.
L’ammissibilità del concorso esterno in associazione mafiosa è figura da tempo posta
all’attenzione della giurisprudenza: la problematica investe, invero, la necessità di contrastare
l’attività delittuosa delle organizzazioni mafiose reprimendo, accanto alle condotte di
affiliazione in senso stretto, anche quelle condotte collaterali che non presentano i requisiti
strutturali di una vera e propria partecipazione, ma che spesso siano comunque essenziali per la
sopravvivenza della societas sceleris.
In particolare, viene definito concorrente esterno colui che, non facendo parte
dell’associazione e non avendone intenzione, è privo di affectio societatis, cosa che qualifica,
appunto, il relativo contributo causale come esterno (apporto proveniente da un soggetto non
stabilmente inserito nella struttura associativa). A tale posizione fa da contraltare la posizione
dell’organizzazione criminale che, pur non intendendo chiamare il soggetto a partecipare, gli
si rivolge episodicamente, qualora si manifestano dei “vuoti temporanei” nel proprio
organigramma o comunque quando insorge la necessità di un contributo limitato nel tempo e/o nei
contenuti; tale necessità può, per altro, sostanziarsi anche in un unico episodio.
Per quel che concerne l’elemento oggettivo, l’apporto del concorrente esterno deve essere
concreto, specifico, consapevole e volontario e deve manifestare una concreta efficacia
causale da verificarsi ex post e in concreto, secondo i parametri espressi dalla sentenza
Franzese (Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328) per la realizzazione del reato
associativo (contributo al mantenimento in vita, rafforzamento e promozione
259
Parte speciale dell’associazione). Il contributo deve essere altresì rilevante e decisivo e può essere prestato
sia nella fase patologica della vita dell’associazione (in tali casi, il contributo esterno può
presentare carattere di infungibilità) (Cass. pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 15, Demitry) sia nella
fase di espansione dell’associazione (Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327,
Carnevale).
In relazione all’elemento soggettivo, non è necessario che l’extraneus condivida o voglia attuare
il programma criminoso dell’organizzazione, ma deve comunque essere consapevole dei metodi
e dei fini della stessa e deve sapere e volere che il suo contributo è diretto alla realizzazione,
anche solo parziale, del programma criminoso.
La figura del concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso risulta dalla
combinazione dell’art. 110 c.p. con l’art. 416 bis c.p. e, secondo i principi generali in materia di
concorso di persone, può atteggiarsi come partecipazione materiale o morale.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali.
La giurisprudenza ammette la configurabilità di un concorso eventuale morale (Cass. pen.,
Sez. fer., 23 agosto 1994; Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 1988), quale influsso esercitato sulla psiche
di un altro soggetto in funzione determinatrice o rafforzatrice della sua decisione di partecipare
dell’organizzazione mafiosa o come rafforzamento del prestigio di cui all’esterno essa gode o della
fiducia nel senso di impunità dei suoi membri.
Non altrettanto può dirsi in merito all’ammissibilità del concorso materiale, sul quale vi è contrasto.
Diverso il caso del concorso materiale, sulla cui ammissibilità vi è contrasto.
2.1. Il primo orientamento: Inconfigurabilità del concorso esterno.
Per un primo, ed ormai risalente indirizzo (ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 1998), la
figura, di creazione per altro meramente giurisprudenziale, del concorso esterno sarebbe
del tutto inammissibile. Si affermava, in particolare, che l’art. 110 c.p. non trovava “ingresso
nell’art. 416 bis c.p. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di determinazione o
istigazione a partecipare o a promuovere, costituire, organizzare l’associazione per delinquere”.
1° Argomento: carenza di tassatività e tipicità. Le condotte che si sostanziano nella
partecipazione prevista dalla fattispecie ex art. 416 bis presenterebbero gravi carenze in punto di
tipicità e tassatività, dilatando ulteriormente l’area del penalmente rilevante con il meccanismo del
concorso eventuale.
2° Argomento: esaustività della legislazione. La vigente normativa che regolamenta in
chiave repressiva i fenomeni di contiguità mafiosa deve ritenersi esaustiva: ove il legislatore ha
avvertito la necessità di attribuire rilevanza penale a condotte collaterali o agevolatrici del singolo
associato o dell’intera associazione, vi ha provveduto con l’introduzione di specifiche aggravanti
(ad es., art. 378, co. 2 c.p.; art. 7, L. 203/2001), sicché ritenere configurabile un concorso
esterno nel reato associativo significherebbe privare di valore tali scelte di politica
criminale.
3° Argomento: elementi costitutivi della fattispecie. L’art. 110 c.p. esige che il
concorrente partecipi del medesimo reato e, dal momento che il contributo del concorrente esterno
260
Scheda di giurisprudenza n. 28 si risolve, al pari della partecipazione dell’associato, in un contributo eziologicamente rilevante
rispetto al mantenimento, rafforzamento e promozione dell’associazione, c’è una sostanziale
sovrapponibilità tra la condotta associativa dell’intraneus e quella dell’extraneus. Per altro,
dal punto di vista soggettivo, il medesimo reato deve essere tale in relazione all’elemento
psicologico: il concorrente deve agire in base allo stesso dolo specifico richiesto dall’art. 416 bis
c.p., motivo per cui il dolo del concorrente esterno finisce per coincidere con quello del
partecipante.
2.2. Il secondo orientamento: Configurabilità del concorso esterno.
A mente di un secondo, ed orami prevalente, orientamento (Cass. Pen., Sez. V, 9 marzo 2012, n.
15727, Dell’Utri; Cass. Pen., Sez. Un., 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino; Cass. Pen., Sez.
Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale; Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry), il
concorso esterno in associazione mafiosa sarebbe pienamente ammissibile. Si affermava
così che “risponde di concorso esterno in associazione mafiosa il soggetto che, pur non inserito
stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell’affectio societatis, fornisce tuttavia
ad essa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo, sempre che questo esplichi una
effettiva rilevanza causale e cioè si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il
rafforzamento delle capacità operative dell’associazione o di un suo particolare settore, ramo di
attività o articolazione territoriale, e quindi per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico
protetto che nella specie è costituito dall’integrità dell’ordine pubblico, violata dal l’esistenza e
dall’operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma
criminoso”(Cass. Pen., Sez. Un., 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino).
1° Argomento: atipicità del contributo esterno. In ragione dell’atipicità del contributo
esterno (ex art. 110 c.p.), non può ritenersi sovrapponibile alla partecipazione (ex art. 416 bis
c.p.), che è invece condotta tipica, anche perché il vincolo associativo stabile proprio della seconda
difetta nel primo.
2° Argomento: rispetto del principio di tassatività. La combinazione dell’art. 110 c.p.
con l’art. 416 bis c.p. non determina alcuna violazione del principio di tassatività: la fattispecie
presenta un grado di determinatezza sufficiente a verificarne la rispondenza al tipo delineato
dalla norma incriminatrice.
3. La giurisprudenza maggioritaria.
L’ammissibilità del concorso esterno nei reati di associazione per delinquere e di
associazione di tipo mafioso è stata confermata di recente dalla Cassazione (Cass. pen., Sez.
V, 24 aprile 2012, n. 15727, Dell’Utri), nonostante la tesi negazionista sia stata sostenuta, nel caso
di specie, con decisione dal Procuratore Generale, che ha evidenziato la criticità di tale fattispecie
in relazione al principio di legalità, sotto il profilo della determinatezza, alla luce della più recente
giurisprudenza della Corte EDU in tema di tutela del diritto di difesa.
Nella specie, è stato ravvisato il concorso esterno nella condotta dell’imputato che si era attivato
per propiziare un accordo alla pari tra un imprenditore amico ed esponenti di vertice di cosa nostra,
finalizzato a procurare al primo un servizio di sicurezza privata per sé e i familiari in cambio del
261
Parte speciale versamento di ingenti somme di denaro.
1° Argomento: accoglimento delle conclusioni della tesi favorevole. La Suprema Corte
ha ribadito ancora una volta quanto già in precedenza affermato: la figura de qua non viola il
principio di tassatività e il contributo esterno, proprio in ragione della sua atipicità, non
potrebbe in alcun modo essere sovrapposto alla condotta tipica.
2° Argomento: natura di reato permanente. I giudici di legittimità hanno colto l’occasione
per precisare che il medesimo, al pari della fattispecie associativa, si atteggia quale reato
permanente, che può realizzarsi sia mediante la commissione di una o più azioni penalmente
rilevanti che con azioni di per sé lecite.
L’ammissibilità dell’istituto de quo è stata confermata anche di recente dalla Cassazione,
per la quale “il concorso esterno in associazione oppure in quella specificatamente mafiosa si
atteggia, al pari della partecipazione, di regola, come reato permanente, per tale dovendosi
intendere quello nel quale l’agente ha il potere di determinare la situazione antigiuridica,
mantenerla volontariamente, rimuoverla, provocando, in quest’ultima ipotesi, la riespansione del
bene giuridico compresso. Nel caso dei reati previsti dagli art. 110, 416 c.p. oppure 110, e 416 bis
c.p., le suddette caratteristiche sussistono nella condotta di colui che, come nella specie, favorisce
un accordo che sa e vuole, sotto un profilo di causalità necessaria, produttivo di effetti di
conservazione e/o rafforzamento per il sodalizio. Tale accordo integra esso stesso il momento
consumativo del reato, se dotato di tutti i requisiti per risultare capace di ingenerare negli
appartenenti al sodalizio gli effetti innanzi detti, valutabili alla stregua di parametri obiettivi ex post”
(Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 28225; in termini, Cass. pen., Sez. VI, 18 giugno 2014, n.
33885).
4. Gli orientamenti giurisprudenziali in merito all’elemento soggettivo del
concorso esterno: la condivisione del programma criminoso da parte del
concorrente esterno.
In relazione all’elemento soggettivo che deve sorreggere l’operato dal concorrente esterno, gli
orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo sono due.
4.1. Il primo orientamento: Sufficienza del dolo eventuale.
In un primo momento (Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry), traendo spunto dalla
disciplina dell’art. 110 c.p., secondo cui il dolo specifico non necessariamente deve sussistere in
capo a tutti i concorrenti, la Cassazione ha affermato che la condivisione del programma
criminoso da parte del concorrente esterno avrebbe carattere meramente eventuale: il
concorrente esterno può condividere o meno il programma criminoso, essendo sufficiente che sia
consapevole dell’essenzialità del suo contributo al mantenimento e al rafforzamento
dell’associazione.
1° Argomento: consistenza del contributo. Ciò che rileva è l’apporto di un contributo, che
deve essere dotato di concreta e reale efficacia causale rispetto al mantenimento in vita, al
rafforzamento e alla promozione dell’associazione: il concorrente esterno, ancorché
consapevole che il proprio contributo sia causalmente efficiente rispetto al rafforzamento o al
262
Scheda di giurisprudenza n. 28 mantenimento in vita dell’associazione, ben può ignorare o comunque disinteressarsi della
strategia complessiva dell’organizzazione e degli scopi ultimi che questa intende perseguire,
essendo sufficiente che egli sappia che altri soggetti (gli intranei) fanno parte e vogliono far parte
del sodalizio e realizzarne i fini. Ma anche ove sia a conoscenza del programma criminoso, tale
consapevolezza non vale a mutare il suo ruolo rispetto alla compagine, che resta sempre quello di
un esterno.
A tali conclusioni, tuttavia, si obiettava che: a) lo scopo criminoso è un elemento
essenziale ai fini dell’incriminazione del fenomeno associativo (art. 18 Cost.), per cui non si
comprende come può essere incriminato un apporto non caratterizzato dalla condivisione del
programma criminoso; b) i connotati della rilevanza e decisività del contributo esterno sono
inconciliabili con la mancata condivisione del programma criminoso, per cui non si
comprende come può un contributo esterno avere carattere rilevante e decisivo e non
accompagnarsi alla condivisione del programma criminoso; c) i principi generali in materia di
concorso di persone nel reato postulano la sussistenza in capo al concorrente
dell’elemento soggettivo del reato oggetto di concorso.
4.2. Il secondo orientamento: Necessaria condivisione del programma
criminoso.
In un secondo momento, la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. Un., 20 settembre 2005, n. 33748,
Mannino; Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale) ha fatto proprie le critiche
avanzate all’orientamento pregresso, statuendo che il concorrente esterno deve condividere il
programma criminoso e deve volerne la realizzazione.
1° Argomento: netta distinzione fra le posizione all’interno dell’organizzazione. La
situazione di chi “entra a far parte di una organizzazione”, condividendone vita e obiettivi, e
quella di chi, pur non entrando a farne parte, apporta dall’esterno un contributo rilevante alla
sua conservazione e al suo rafforzamento sono chiaramente distinguibili.
2° Argomento: connotati della qualità di concorrente. Assume la qualità di concorrente
esterno la persona che, priva dell’affectio societatis e non inserita nella struttura associativa,
fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a carattere
occasionale o continuativo, dotato di effettiva rilevanza causale per la conservazione o del
rafforzamento dell’associazione.
3° Argomento: profilo soggettivo. Il concorrente esterno nel reato di associazione di tipo
mafioso è tale quando, pur estraneo all’associazione, della quale non intende far parte, apporti un
contributo che “sa’’ e “vuole’’ sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del
programma criminoso del sodalizio.
Sulla scia di tali affermazioni, la Cassazione ha altresì affermato che il dolo dell’extraneus
deve investire, nei momenti della rappresentazione e della volizione, tutti gli elementi
essenziali della figura criminosa tipica nonché l’efficacia causale della propria condotta
rispetto alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di
interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del
“medesimo reato”.
263
Parte speciale Il concorrente, pur privo dell’affectio societatis, deve essere consapevole dei metodi e dei
fini dell’organizzazione, a prescindere dalla condivisione o indifferenza per siffatti metodi e fini e
deve rendersi pienamente conto che la sua attività di sostegno è eziologicamente vantaggiosa per
la conservazione o il rafforzamento dell’associazione: “egli “sa” e “vuole” che il suo contributo sia
diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso”.
Alla luce dei principi di diritto suesposti, si ritiene di dover pervenire alla seguente:
SOLUZIONE DELLA TRACCIA
Nel caso di specie, si ritiene di non poter non condividere la posizione assunta dalla Corte d’Appello,
dovendo così un eventuale ricorso per Cassazione inutile. Invero, la condotta di Tizio (si ricordi, l’aver messo
a disposizione dell’associazione mafiosa Cosa nostra l’influenza e il potere derivante dalla sua posizione di
esponente del mondo finanziario e imprenditoriale, avendo così contribuito al suo mantenimento e
rafforzamento, oltre che alla sua espansione) non potrebbe non essere qualificata, in ragione della
giurisprudenza ormai maggioritaria in tema, in termini di concorso esterno nell’associazione mafiosa.
La condanna di Tizio a titolo di concorso esterno ex art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, c.p. deve essere dunque
ritenuta del tutto conforme ai recenti approdi giurisprudenziali.
LE GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA
Cass. pen., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727
Estratto
[...Omissis...]
2. Invero, sul tema della configurabilità, in linea di principio, del concorso esterno in associazione per
delinquere semplice e poi, a partire dal 1982, di stampo mafioso non sono stati sollevati dubbi dogmatici
neppure dalla difesa nè vi è motivo di sollevare specifiche perplessità.
La prima figura (che è quella originariamente contestata al Capo A, poi assorbito dal B) secondo una
giurisprudenza che appare costante (vedi, tra le molte, Sez. 1, Sentenza n. 40203 del 29/09/2010 Cc. (dep.
15/11/2010) Rv. 248461, relativa invero alla “partecipazione” ad associazione) è stata agevolmente
ammessa dalla giurisprudenza di legittimità una volta stabilizzata la ammissibilità teorico- dogmatica del
concorso esterno in associazione mafiosa (vedi Sez. 3, Sentenza n. 38430 del 09/07/2008 Cc. (dep.
09/10/2008) Rv. 241274; Sez. 1, Sentenza n. 19335 del 22/04/2009 Ud. (dep. 08/05/2009) Rv. 244064; Sez.
5, n. 12591 del 10/11/1995 (dep. 28/12/1995) Rv. 203948).
Non è stato apprezzato, del resto, alcun ostacolo dogmatico, sullo stesso versante, per configurare il
concorso esterno in altri reati a partecipazione necessaria anche nei più recenti approdi della giurisprudenza
di legittimità come Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006 (dep. 17/01/2007) Rv. 235290 (relativa a concorso esterno
in associazione con finalità di terrorismo internazionale), ribadita da Sez. 1, Sentenza n. 16549 del
14/03/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246937.
La seconda figura, d’altra parte, come ricordato anche nella sentenza impugnata che si è espressamente
avvalsa degli insegnamenti delle Sezioni unite di questa Corte citando le sentenze Mannino e Dimitry a
pag.260 e seg. non solo per escludere, dunque, ma anche per asseverare la parte accreditata di reato
contestato, è stata oggetto di ripetute e positive analisi da parte della supremo consesso della Cassazione.
La necessità di dettagliare i contorni di tale fattispecie giuridica - che comunque incontra il sostegno teorico
anche di una parte importante della dottrina - dipende invero dalla estrema delicatezza della operazione che
264
Scheda di giurisprudenza n. 28 l’interprete è chiamato ad effettuare operando sulla fusione di una norma di parte generale (art. 110 c.p.) ed
altra di parte speciale (il reato a concorso necessario) e dovendo trovare, senza ricorso a semplificazioni non
accettabili nè permesse, prove di tutti i passaggi normativi richiesti da siffatta complessa operazione
ermeneutica: la cui difficoltà riguarda comunque essenzialmente la individuazione della linea di discrimine tra
la condotta “partecipativa” vera e propria e quella di chi invece agisca in assenza di affectio societatis, con il
medesimo fine, però, e con condotte a volte non dissimili da quelle del primo. Con la prospettiva, sul piano
ermeneutico, che ove, nella sede istituzionalmente propria, si incidesse sulla possibilità teorica di configurare
il concorso esterno, si attiverebbe il dibattito dottrinale sulla ampiezza e i confini della operatività della
partecipazione vera e propria, rimanendo in area di liceità penale non certo tutte le condotte ascrivibili
all’area del concorso eventuale. E dovendosi altresì rammentare, alla luce dei principi generali in tema di
partecipazione ad associazione fissati dalla sentenza delle SSUU del 2005, che l’area di tale “partecipazione”
non potrebbe certo ritenersi automaticamente e necessariamente dipendente solo dai criteri di “affiliazione”
propri della associazione criminosa, dovendo invece essere delineata sulla base dei criteri propri della
fattispecie penale e della sua interpretazione giuridica, che è sensibile a indicatori dinamici e funzionali (v.
Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670).
Tali considerazioni comunque non riguardano il processo in esame, nel quale si conferma la condivisione
della giurisprudenza consolidata, frutto di ripetute analisi delle Sezioni unite, giunte reiterata mente alla
medesima conclusione: quella di ritenere che il concorso esterno in associazione anche mafiosa è
configurabile sulla base dei requisiti che, nel tempo, sono stati via via sempre più dettagliatamente rimarcati,
essendo comunque tratti dai principi e dai precetti positivamente espressi nella parte generale e in quella
speciale del codice sostanziale: non è inutile ricordare, in proposito, la sentenza delle SSUU del 2005,
preceduta da quelle del 1994 e del 2002 .Ma anche plurime sentenze conformi delle sezioni semplici come,
fra le sole edite, la n. 1073 del 2006, la n. 542 del 2007, la n. 54 del 2008, e la n. 35051 del 2008, per non
parlare della rilevante entità di quelle non edite ma pubblicate fino alla data odierna.
Che, semmai, la proiezione della decisione più recente delle Sezioni unite è stata, si, nel senso di pretendere
una rigorosa dimostrazione del nesso di causalità e dell’elemento psicologico dell’agente, ma anche nella
direzione di sostenere che la dimostrazione del rafforzamento della associazione, superando la fase
patologica della sua “fibrillazione”, è una (e forse la più evidente ed efficace) ma non Tunica possibilità
probatoria data alla accusa, come del resto già sostenuto dalla giurisprudenza a sezioni semplici (v. Rv.
229242). E quindi, nella direzione di non restringere a tutto campo l’ambito di operatività della fattispecie.
[...Omissis...]
3. Tanto premesso sulla assenza di dubbi a proposito della configurabilità del concorso eventuale nel reato
associativo a concorso, cioè, necessario, deve, a questo punto, riprendersi il tema lasciato sospeso sopra,
che è quello della rilevanza della questione della mancanza di motivazione sul comportamento in concreto
tenuto dall’imputato nel periodo, durato alcuni anni, dell’allontanamento dall’area imprenditoriale
berlusconiana, tra l’altro facendo registrare la sua assunzione alle dipendenze di imprenditore diverso e
autonomo, il Ra..
Ebbene, siffatto arco temporale che viene riferito al periodo complessivo decorso dalla fine del 1977 al 1982
(v. retro pag. 26) ha formato oggetto da parte dei giudici a fini che qui non rilevano direttamente (assenza di
illiceità dei rapporti D. - Ra.), cogliendosi invece un totale vuoto argomentativo per quanto concerne la
possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza del reato già commesso. Deve infatti darsi atto,
a questo punto della presente disamina, che, con riferimento ai fatti sopra ricordati e riportati nella sentenza
impugnata attraverso la illustrazione delle fonti di prova e la loro valutazione critica, il reato contestato è
rimasto configurato sul piano obiettivo e materiale e dello stesso deve potersi indicare il momento
consumativo e quello di cessazione, mediante la analisi della sua natura, quale reato, come si vedrà,
permanente. È infatti indubbio e costituisce espressione del concorso esterno da parte dell’imputato nella
associazione criminale denominata Cosa nostra, facente capo - per quello che qui interessa- nella metà degli
anni 70, anche a Bo. e T., il comportamento consistito nell’avere favorito e determinato- avvalendosi dei
265
Parte speciale rapporti personali di cui già a (OMISSIS) godeva con i boss (vedi dichiarazioni di D.C. citate retro a pag.25,
con rinvio a pag. 262 sent. imp.) e di una amicizia in particolare che gli aveva consentito di caldeggiare la
propria iniziativa con speciale efficacia presso quelli- la realizzazione di un incontro materiale e del correlato
accordo di reciproco interesse, tra i boss mafiosi - nella loro posizione rappresentativa- e l’imprenditore
amico ( B.).
In questo senso, la Corte territoriale valorizza e impernia la propria decisione sul rilievo della attività di
“mediazione” che D. risulta avere svolto nel creare il canale di collegamento o, se si vuole, di comunicazione
e di transazione che doveva essere parso, a tutti gli interessati e ai protagonisti della vicenda, fonte di
reciproci vantaggi per i due poli: il vantaggio, per l’imprenditore B., della ricezione di una schermatura rispetto
ad iniziative criminali (essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano ad opera di entità
delinquenziali non necessariamente e immediatamente rapportabili a cosa nostra o quanto meno alla
articolazione palermitana di Cosa nostra di cui veniva, in quel frangente, sollecitato l’intervento, e quello di
natura patrimoniale per la stessa consorteria mafiosa.
Questa aveva cioè, grazie alla iniziativa di D. che si era posto come trait d’union, siglato con l’imprenditore un
patto, all’inizio non connotato e tantomeno sollecitato da proprie azioni intimidatorie (si veda a pag.239,240,
270 la citazione, da parte dei giudici, delle emergenze probatorie a sostegno della tesi che le minacce
ricevute da B. fossero di matrice forse catanese ma, soprattutto, calabrese) oltre che finalizzato alla
realizzazione di evidenti risultati di arricchimento: un patto che,peraltro, risentiva di una certa, espressa (v.
colloqui citati a pag. 241 della sentenza) propensione dell’imprenditore B. a “monetizzare”, per quanto
possibile, il rischio cui era esposto e a spostare sul piano della trattativa economica preventiva, l’azione delle
fameliche consorterie criminali che invece si proponevano con annunci intimidatori.
Ed è appena il caso di ricordare che, rispetto a tale ricostruzione, non era indispensabile illustrare, ai fini della
configurazione del reato di cui all’art. 110 c.p. e art. 416 c.p. o art. 416 bis c.p., anche quale avrebbe potuto
essere il vantaggio del concorrente esterno, posto che un simile elemento, la cui acquisizione certamente
potrebbe essere utile per meglio scolpire e definire l’atteggiamento psicologico di questi - e su cui appresso
ci si soffermerà- tuttavia non è astrattamente imprescindibile ai fini della motivazione sulla responsabilità,
essendo richiesta, in tale ottica, la prova della condotta che determini la conservazione o il rafforzamento
della associazione e non anche il requisito del vantaggio, patrimoniale o meno, dell’agente.
Per tale ragione sembra utile evidenziare anche che lo scrupolo del Procuratore Generale di udienza secondo cui si sarebbe dovuta esplorare fino in fondo la natura estorsiva (o meno) degli esborsi di B. in
favore della mafia, per comprendere esattamente la posizione di D. che tali esborsi aveva favorito- finisce per
porsi in conflitto, come censura sul merito, con il costrutto accreditato dai giudici a quibus, costrutto che
prescinde da quella prova e che, ciò nonostante appare razionale e plausibile.
Infatti se, come ammesso dallo stesso PG, il concorso esterno può realizzarsi sia mediante la commissione
di una o più azioni in sè penalmente rilevanti o anche con azioni in sè lecite, non vi è ragione di negare
ingresso alla tesi dei giudici secondo cui i pagamenti effettuati da B. avevano, si, natura necessitata perchè
ingiustamente provocati, all’origine, da spregevoli azioni intimidatorie poste in essere in danno della sua
famiglia, ma non l’avevano avuta - ai tempi- in riferimento ai rapporti con D. e con Bo. e T. e l’associazione
che essi immediatamente rappresentavano: soggetti, dunque, che erano stati evocati in una trattativa che,
all’origine, appariva concepita “alla pari”, per il conseguimento di un risultato che, così come avrebbe potuto
e dovuto essere perseguito presso le istituzioni all’uopo previste, era stato invece cercato presso chi era
parso capace di garantire un servizio di sicurezza di tipo privato e particolarmente efficace ed affidabile.
Ne consegue che la dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, del reato di concorso esterno non
passa attraverso la necessaria dimostrazione della sussistenza anche del reato di estorsione da parte di D. e
della associazione all’epoca evocata, e tantomeno potrebbe affermarsi che la negazione della commissione
di fatti di estorsione da parte dei medesimi soggetti faccia venir meno la configurabilità del primo reato in
capo all’imputato o la posizione di vittima in capo all’imprenditore B.. Appare invece plausibilmente sostenuto
dai giudici del merito che la condotta di rilevanza penale addebitata a D., con riferimento al periodo in
266
Scheda di giurisprudenza n. 28 questione, è stata quella dell’avere richiesto e quindi determinato l’incontro più volte sopra menzionato,
finalizzato al consapevole e voluto conseguimento, poi avvenuto, di un accordo del genere di quello descritto,
fra B. e il sodalizio rappresentato da Bo. e T., laddove con i termini “richiedere “ e “sollecitare” si intende qui
esplicitare ulteriormente il senso già fatto palese dalle parole usate dai giudici, a proposito della opera di
“mediazione” svolta da D. e di apertura del “canale di collegamento” fra i due poli.
Nozioni che ingiustificatamente sono parse insufficienti al Procuratore Generale e che invece stanno a
dimostrare, in termini di causalità necessaria, il comportamento per effetto del quale la catena di eventi
descritti fino a qui non si sarebbe verificata in modo analogo, nel senso cioè che raccordo transattivo per la
protezione “privata” voluto da B. e da cosa nostra con l’arrivo peraltro alla villa dell’imprenditore di un
esponente del sodalizio e con il pagamento, attraverso gli accertati canali, dei pagamenti sinallagmatici, non
avrebbe fatto la sua comparsa nel mondo fenomenico e tanto meno sulla ribalta penale.
A nulla vale in contrario osservare che D. è stato probabilmente un catalizzatore di eventi che erano pronti a
maturare autonomamente come quello della estorsione di tangenti da parte di consorterie criminali, e in
particolare di cosa nostra, a danno di B..
Certamente la causalità di un furto realizzato grazie all’opera di un basista non viene meno solo perchè
sarebbe stato reperibile altro basista o perchè del basista si sarebbe potuto fare a meno.
La causalità necessaria- che oltretutto è destinata ad operare con lo standard probatorio della “alto o elevato
grado di credibilità razionale” o “probabilità logica” (v., da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006
Ud. (dep. 06/02/2007) Rv. 235658, ma nello stesso senso di SSUU n. 30328 del 10/07/2002 Ud. (dep.
11/09/2002) Rv. 222138) - entra in gioco con riferimento al modo specifico di realizzazione di un dato reato,
quando cioè l’agente determini un evento che, senza il suo apporto, non si sarebbe verificato o si sarebbe
attuato in maniera diversa ed è difficile, in tale prospettiva, negare rilevanza ad una condotta dell’agente
descritta come “adoperarsi” e concretizzatasi nei termini sopra descritti: una condotta che, dunque, non è
una categoria astratta e inconducente, come sembra sostenere il Procuratore Generale, ma, come nozione
giuridica, è comunemente evocata dalla giurisprudenza proprio per delineare l’apporto del concorrente che
non ponga in essere direttamente l’azione tipica del reato cui concorre ma che apporta quel genere di
contributo, proprio di chi si pone come intermediario, alla sua realizzazione (Si veda in tal senso, per citare
solo qualche esempio, Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 18/12/2006 Cc. (dep. 25/01/2007) Rv. 235343; Sez. 2,
Sentenza n. 5845 del 16/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201334; Sez. 6, Sentenza n. 45644 del
04/11/2009 Cc. (dep. 26/11/2009) Rv. 245480; Sez. 1, Sentenza n. 7921 del 22/01/2010 Cc. (dep.
26/02/2010) Rv. 246571).E, ovviamente, non dal lato, esclusivamente, della vittima. Tanto premesso, può
dunque concludersi che i giudici hanno adeguatamente rappresentato come la condotta dell’agente, riferita
agli anni che vanno dal 1974 fino alla fine del 1977, abbia costituito un antecedente causale quantomeno
della conservazione, se non del rafforzamento del sodalizio criminoso cosa nostra,posto che tale sodalizio si
fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere e
moltiplicarsi e anche per il mantenimento della sua stessa “forza lavoro” e quindi della organizzazione
attraverso la quale opera e si rafforza. Ed è indubbio che l’accordo di protezione mafiosa propiziato da D.,
con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di cosa nostra, vada ad inserirsi in un rapporto di
causalità, nella realizzazione dell’evento del finale rafforzamento di cosa nostra, dovendosi anche escludere
rilievo al fatto che cosa nostra comunque si arricchisce di mille altri affari illeciti anche più lucrosi. Il principio
della causalità necessaria opera, come chiarito anche dalla giurisprudenza, nel senso che “ai sensi dell’art.
40 c.p., comma 1, un antecedente può essere considerato condizione necessaria dell’evento quando rientri
nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del genere di
quello in esame,indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole
sufficienti a determinare l’evento (vedi Rv. 213693).
Ed è indubbio che la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati
empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purchè fondato
su elementi di innegabile spessore (Rv. 219426).
267
Parte speciale Rispetto alla obiezione della difesa sul punto vale, inoltre, ricordare che nell’ordinamento normativo vigente le
cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento per il necessario porsi delle prime
come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa dell’evento in base al principio della
causalità materiale fondato sull’equivalenza delle condizioni (v.Sez. 4, Sentenza n. 578 del 19/12/1996 Ud.
(dep. 28/01/1997) Rv. 206647, con seguenti conformi).
4. Riprendendo la questione, sopra anticipata, che riguarda la necessità di verificare fino a quando la
descritta fattispecie abbia registrato una perduranza penalmente rilevante per D. - tenuto conto del fatto
pacificamente acquisito che egli si allontanò a partire dal 1978, dalla area imprenditoriale di B. - si passa ora
ad evidenziare l’effetto che una simile situazione contingente - in sè considerata- potrebbe avere prodotto
sulla configurazione del reato e quindi a sostanziare il senso dell’annullamento per vizio di motivazione sul
punto, chiarendosi in quale direzione si impone una richiesta di nuova motivazione al giudice del rinvio, su
tale argomento. Occorre dunque evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di
legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 542 del 10/05/2007 Ud. (dep. 08/01/2008) Rv. 238241), il concorso esterno in
associazione per delinquere oppure in quella specificamente mafiosa si atteggia, al pari della partecipazione,
di regola, come reato permanente.
Reato permanente è quello nel quale l’agente ha il potere di determinare la situazione antigiuridica ed anche
di mantenerla volontariamente, nonchè di rimuoverla, così dando luogo egli stesso, come sottolinea una
autorevole dottrina, alla riespansione del bene giuridico compresso. Nel caso del concorso esterno ad
associazione per delinquere o mafìosa le suddette caratteristiche si ravvisano nella condotta di chi favorisca
un accordo - come nella specie- di cui sa e vuole che produca effetti di conservazione e/o di rafforzamento
per il sodalizio mafioso, accordo che assurge esso stesso a momento consumativo del reato se dotato di tutti
i requisiti per risultare capace di ingenerare negli appartenenti al sodalizio gli effetti di cui si è detto, valutabili
anche obiettivamente ed ex post.
Un accordo, che, in ipotesi, avesse ad oggetto la promessa dell’aiuto elettorale da parte del capo di una
consorteria mafiosa e, dall’altro lato, la promessa chiara e seria dell’impegno, da parte del candidato alle
elezioni, di sdebitarsi assumendo specifiche iniziative legislative o amministrative di sua competenza, ben
potrebbe costituire l’elemento materiale del concorso esterno da parte del politico, non essendo per nulla
decisiva la verifica dell’effettivo rispetto dell’impegno stesso ad opera di costui (Sez. 5, Sentenza n. 4893 del
16/03/2000 Ud. (dep. 20/04/2000) Rv. 215963; conf. Rv 216815; Sez. 1, Ordinanza n. 11613 del 04/02/2005
Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 231630), e pur potendo costituire, questa, un prezioso elemento di prova della
serietà o meno dell’impegno.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni unite nel 2005 quando, nell’affermare la necessità della
verifica che “gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè sulla
conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue
articolazioni settoriali”, hanno però anche precisato che una tale verifica ben può “prescindere da successive
ed eventuali condotte esecutive dell’accordo”.
Allo stesso modo, l’accordo serio e affidabile relativo alla protezione da attentati, assicurata, a chi è costretto
da necessità effettive, a pagare cifre assai rilevanti per tale servizio, da parte di Cosa nostra costituisce, esso
stesso,- per chi se ne fa promotore, dal lato, anche, del sodalizio profittatore-un evento capace di contribuire
all’avvio della compressione del bene giuridico tutelato dalla norma contestata, ossia l’ordine pubblico, che è
vulnerato per il solo fatto che un’associazione mafiosa sia posta in condizioni di estendere ed estenda la
propria area di illeciti affari sul territorio, anche sostituendosi ai poteri istituzionali, nella garanzia della difesa
dei beni fondamentali (libertà, vita) di taluni cittadini.
Tuttavia- ed a prescindere dai rilievi di parte della dottrina sulla figura del reato “eventualmente” permanentefintantochè il concorrente esterno protragga volontariamente la esecuzione dell’accordo che egli ha
propiziato e di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i due poli dei quali si è detto, si manifesta il carattere
permanente del reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza riassume nella locuzione
secondo cui “la suddetta condotta partecipativa(esterna) si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività
268
Scheda di giurisprudenza n. 28 concordate (Sez. 1, Sentenza n. 21356 del 17/04/2002 Ud. (dep. 30/05/2002) Rv. 222439).
Il reato in esame può, cioè, dirsi iniziato con la realizzazione dell’accordo mafia-imprenditore ed era destinato
a cessare quando e se fossero cessati i comportamenti che l’imputato teneva in esecuzione dell’accordo
stesso (essendo irrilevante, per quello che si è detto, che il danno patrimoniale non fosse a suo carico),
sempre ovviamente impregiudicata l’analisi dell’atteggiamento psicologico, del quale si dirà poi (per una
visione analoga della cessazione del reato permanente, v. Rv. 248108). Una simile impostazione, del resto, è
già stata elaborata con riferimento alla cessazione della appartenenza alla associazione mafiosa, da parte
del sodale, al quale, pur in presenza, nel nostro ordinamento,della concezione monistic del concorso di
persone nel reato, è data la prova del recesso volontario. E questa- nonostante la denuncia di omessa
motivazione sul punto, formulata dal Procuratore Generale di udienza- è stata anche la conclusione
chiaramente fatta propria - in linea di principio- dalla Corte di appello di Palermo che a pag. 635 ne ha fatto
applicazione, univocamente ancorando la data di cessazione del reato in parola al 1992, e cioè alla data di
effettuazione, secondo il costrutto da essa accreditato, degli ultimi pagamenti da parte di B. alla mafia,
tramite D., in esecuzione del patto di protezione. Senonchè, in concreto, questa Corte rileva che i giudici
dell’appello non hanno tenuto conto o comunque non hanno motivato sulle ragioni in base alle quali una
prima fase di cessazione non possa essere individuata nel periodo (1978-1982) durante il quale D. non era
rimasto più alle dipendenze dell’imprenditore in favore del quale il patto con la mafia era stato stipulato. Il
vuoto argomentativo, sul punto, si traduce in un evidente vizio della motivazione che la difesa, sostenuta poi
dal Procuratore Generale di udienza, ha denunciato fondatamente: un vuoto che necessita di essere
colmato, ove ne ricorrano gli elementi, con specifiche indicazioni di quale sia stato il comportamento, nel
periodo, da parte di D., non potendo darsi ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia
con B.: rapporti che da soli non provano il perdurare della intromissione di D. in affari penetranti per la vita
individuale dell’imprenditore dal quale si era allontanato, atteso che di ciò non risultano esplicitate neppure la
ragione e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono comunque avvenuti, materialmente
dunque anche ad opera di terzi, a partire dal 1978. In realtà, una simile apparente interruzione degli stretti
rapporti precedentemente instaurati con B. potrebbe risultare, all’esito della nuova analisi demandata al
giudice del rinvio, indicativa della definitiva fine della permanenza del reato fino a quel momento consumato,
con evidenti riflessi sul computo del termine prescrizionale, che il giudice del rinvio dovrà pure considerare.
Oppure potrà risultare compatibile, con motivazione diversa però da quella qui cassata, con il costrutto
accusatorio.
Oppure, ancora, potrà rappresentare la manifestazione della cessazione del reato permanente cui potrebbe
avere fatto seguito- ove il giudice del rinvio ne argomentasse plausibilmente la sussistenza, anche alla luce
dei rilievi ulteriori che qui si formuleranno- una forma di ripresa dello stesso reato, all’atto del ritorno
dell’imputato nell’area imprenditoriale facente capo a B.: una condotta capace quindi di porsi nuovamente in
violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. e che potrebbe dover essere valutata in una relazione di
“continuazione” ex art. 81 c.p., con quella precedente e cessata una prima volta: evenienza quest’ultima che,
così come la seconda ipotesi appena formulata, cambierebbe ancora una volta - ma in pejus- i termini del
calcolo della prescrizione, la quale decorrerebbe dalla ultima delle condotte dell’imputato di cui il giudice del
rinvio possa sostenere motivatamente che è la oggettiva e soggettiva manifestazione della protrazione della
condotta antigiuridica in esame (troverebbe applicazione, infatti, il regime della prescrizione antecedente alla
riforma del 2005, che valorizza il reato “continuato”).
5. Per tornare alla disamina del quinto motivo di ricorso e soprattutto dei motivi nuovi con i quali lo stesso è
stato ripreso ed ampliato dalla difesa, deve ancora ribadirsi, ora, alla luce dei principi fino a qui enunciati, che
con esso, intrecciato poi con il successivo settimo motivo, la difesa ha denunciato fondatamente il vizio di
motivazione con riferimento sia alla già esaminata questione del periodo di quattro anni almeno in cui D. si è
posto alle dipendenze di Ra., sia alla questione del dolo che avrebbe assistito la fase dei successivi
pagamenti.
Quanto a questi ultimi, dal punto di vista oggettivo, invero, deve ribairsi che la motivazione esibita dalla Corte
269
Parte speciale di merito a proposito del protrarsi dei pagamenti da B. a cosa nostra sostanzialmente supera il controllo di
legittimità perchè- diversamente da quanto pur sostenuto dal ricorrente, è congrua e logica, richiedendo una
opportuna chiarificazione solo sul se si sia trattato di una prosecuzione senza soluzione di continuità dopo
l’allontanamento di D. ovvero di una ripresa dopo una interruzione. Invero, sulla realtà oggettiva dei
pagamenti negli anni ‘80 e poco oltre, comunque ad opera di D., e sulla base della nota causale del patto di
protezione con la mafia, la sentenza risulta rispettosa dei parametri normativi, soprattutto in ordine al tema
principale della denunciata inattendibilità dei collaboratori di giustizia e smentendo che un vizio di
motivazione sul punto si sia concretizzato.
Lo stesso Procuratore Generale di udienza ha escluso che possano formularsi apprezzabili rilievi sulla
ricostruzione del fatto ed è sufficiente rimandare a quanto sopra già osservato in ordine ai principi
giurisprudenziali che escludono la valutazione delle dichiarazioni dei soggetti gravitanti su sodalizi mafiosi, i
quali in ragione di tale loro ruolo hanno appreso i fatti pertinenti la vita del sodalizio stesso, come
dichiarazioni “de relato”. Ed anzi affermano l’attitudine di tali dichiarazioni ad assurgere al valore di prova
della diffusione e della circolazione delle notizie stesse all’interno del sodalizio, con la aggiunta della
necessità degli elementi di riscontro.
Nel caso di specie di dichiarazioni dei collaboratori (peraltro in taluni casi, frutto di percezione diretta dei fatti
narrati, come nel caso di G. che aveva udito personalmente, nel 1986, C. protestare per il comportamento
scostante di D. in occasione dei pagamenti - v. retro pag. 29-, e nel caso di F. che aveva riferito di avere
assistito personalmente in una occasione, dopo il 1988, al pagamento di una somma proveniente da canale
5, versata poi da Ga.Ra. al suo capo mandamento, per il tramite di Bi. - v. retro, pag. 31) hanno formato
oggetto di un’approfondita disamina anche incrociata da parte del giudice del merito che ha plausibilmente
spiegato anche le ragioni delle diverse indicazioni dei riferimenti cronologici in esse contenuti (relative
soltanto all’epoca di acquisizione della notizia da parte di ciascuno degli dichiaranti e non della notizia
stessa).
Non sono neppure mancate, come già sottolineato, da parte del giudice del merito aperture, derivanti dalla
propalazione di G. e dalla conversazione intercettata tra D. e C. la mattina del 16 gennaio 1987 (vedi retro
pagina 30-31), verso una ricostruzione che vedeva la effettuazione dei pagamenti da parte di B.,
successivamente al 1980, dovuta alla solita causale della protezione e non anche alla installazione delle
emittenti televisive: in tal modo evidenziando come il nucleo delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenuto
rilevante, fosse quello relativo alia effettività dei pagamenti e non anche quello relativo alla precisazione delle
relative causali, oggetto di possibile incertezza proprio per la natura indiretta delle dichiarazioni.
Sono stati infine enumerati (vedi retro pag. 29-30) gli elementi di riscontro obiettivo rappresentati in
particolare da convers
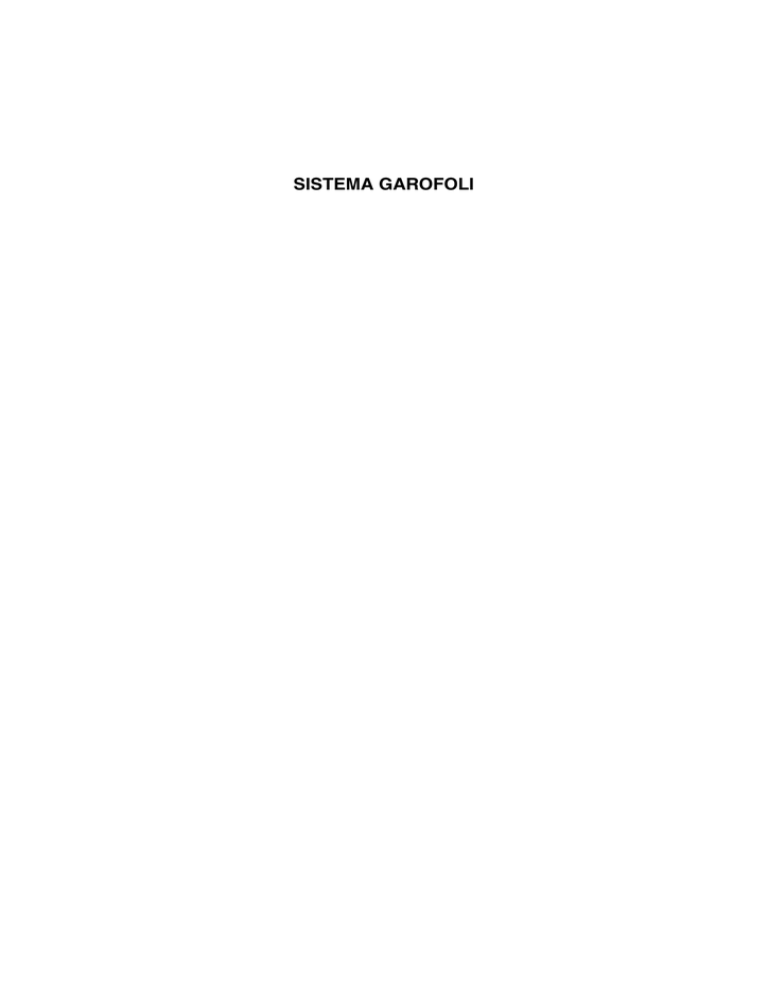
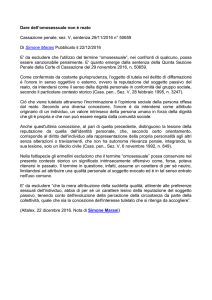
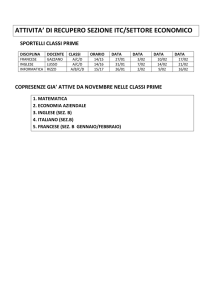
![Seminario della Cananea[1] - Associazione dei Costituzionalisti](http://s1.studylibit.com/store/data/002637490_1-0e7fc1c250f9f0c48cf0612878399e3d-300x300.png)