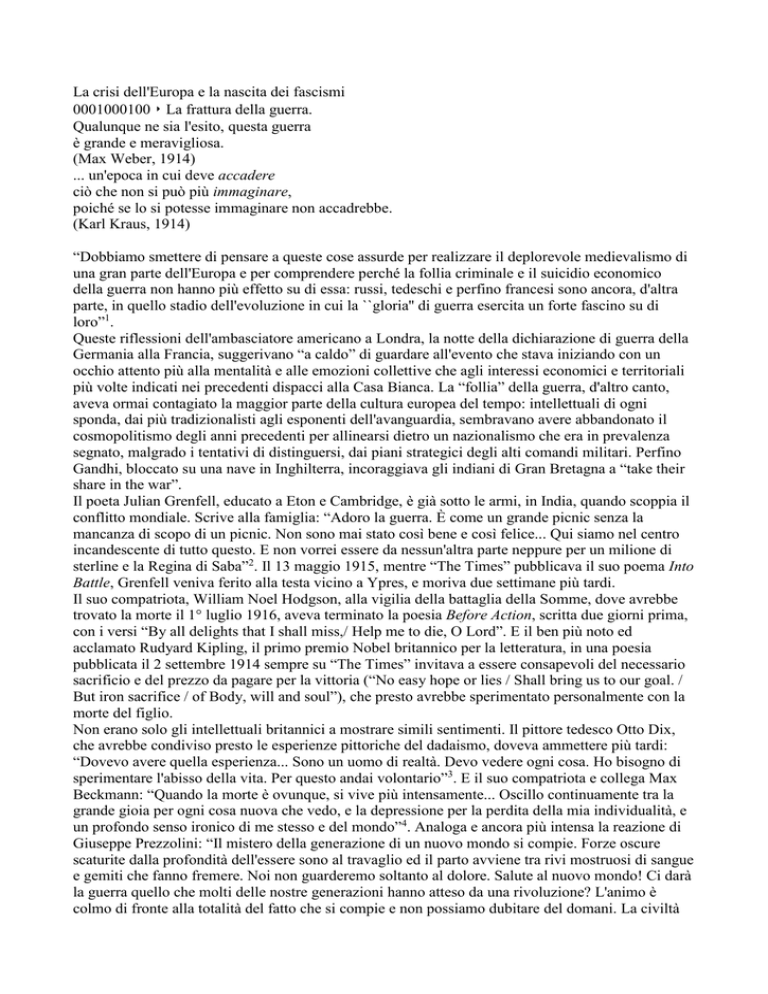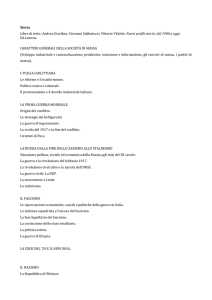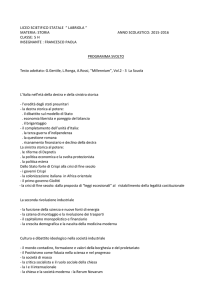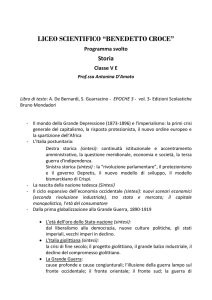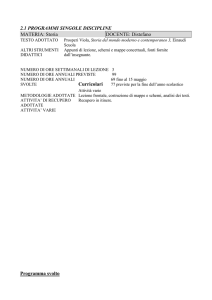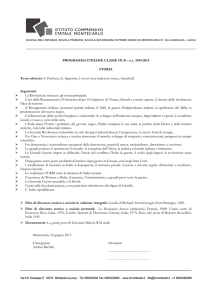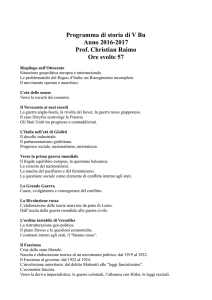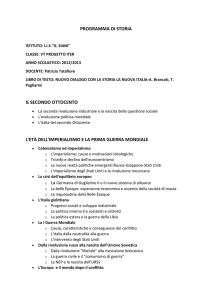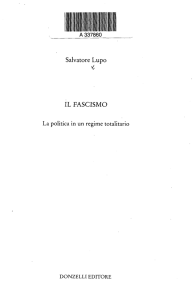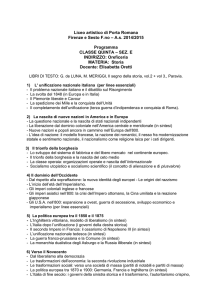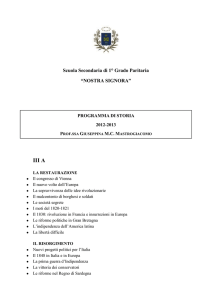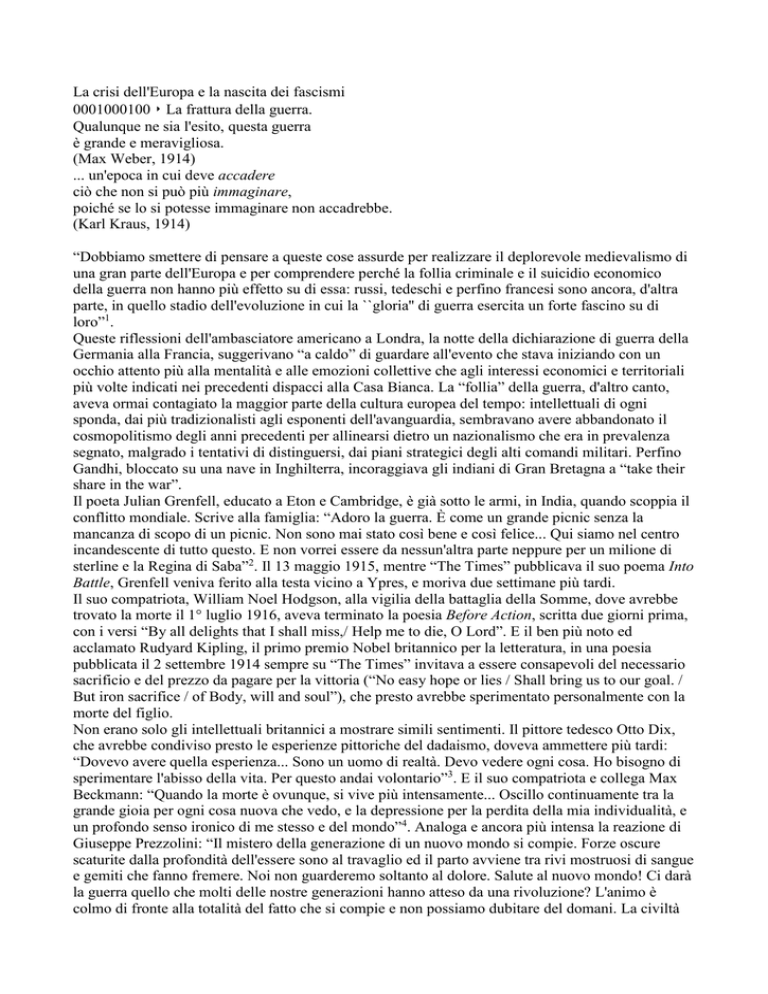
La crisi dell'Europa e la nascita dei fascismi
0001000100 ‣ La frattura della guerra.
Qualunque ne sia l'esito, questa guerra
è grande e meravigliosa.
(Max Weber, 1914)
... un'epoca in cui deve accadere
ciò che non si può più immaginare,
poiché se lo si potesse immaginare non accadrebbe.
(Karl Kraus, 1914)
“Dobbiamo smettere di pensare a queste cose assurde per realizzare il deplorevole medievalismo di
una gran parte dell'Europa e per comprendere perché la follia criminale e il suicidio economico
della guerra non hanno più effetto su di essa: russi, tedeschi e perfino francesi sono ancora, d'altra
parte, in quello stadio dell'evoluzione in cui la ``gloria'' di guerra esercita un forte fascino su di
loro”1.
Queste riflessioni dell'ambasciatore americano a Londra, la notte della dichiarazione di guerra della
Germania alla Francia, suggerivano “a caldo” di guardare all'evento che stava iniziando con un
occhio attento più alla mentalità e alle emozioni collettive che agli interessi economici e territoriali
più volte indicati nei precedenti dispacci alla Casa Bianca. La “follia” della guerra, d'altro canto,
aveva ormai contagiato la maggior parte della cultura europea del tempo: intellettuali di ogni
sponda, dai più tradizionalisti agli esponenti dell'avanguardia, sembravano avere abbandonato il
cosmopolitismo degli anni precedenti per allinearsi dietro un nazionalismo che era in prevalenza
segnato, malgrado i tentativi di distinguersi, dai piani strategici degli alti comandi militari. Perfino
Gandhi, bloccato su una nave in Inghilterra, incoraggiava gli indiani di Gran Bretagna a “take their
share in the war”.
Il poeta Julian Grenfell, educato a Eton e Cambridge, è già sotto le armi, in India, quando scoppia il
conflitto mondiale. Scrive alla famiglia: “Adoro la guerra. È come un grande picnic senza la
mancanza di scopo di un picnic. Non sono mai stato così bene e così felice... Qui siamo nel centro
incandescente di tutto questo. E non vorrei essere da nessun'altra parte neppure per un milione di
sterline e la Regina di Saba”2. Il 13 maggio 1915, mentre “The Times” pubblicava il suo poema Into
Battle, Grenfell veniva ferito alla testa vicino a Ypres, e moriva due settimane più tardi.
Il suo compatriota, William Noel Hodgson, alla vigilia della battaglia della Somme, dove avrebbe
trovato la morte il 1° luglio 1916, aveva terminato la poesia Before Action, scritta due giorni prima,
con i versi “By all delights that I shall miss,/ Help me to die, O Lord”. E il ben più noto ed
acclamato Rudyard Kipling, il primo premio Nobel britannico per la letteratura, in una poesia
pubblicata il 2 settembre 1914 sempre su “The Times” invitava a essere consapevoli del necessario
sacrificio e del prezzo da pagare per la vittoria (“No easy hope or lies / Shall bring us to our goal. /
But iron sacrifice / of Body, will and soul”), che presto avrebbe sperimentato personalmente con la
morte del figlio.
Non erano solo gli intellettuali britannici a mostrare simili sentimenti. Il pittore tedesco Otto Dix,
che avrebbe condiviso presto le esperienze pittoriche del dadaismo, doveva ammettere più tardi:
“Dovevo avere quella esperienza... Sono un uomo di realtà. Devo vedere ogni cosa. Ho bisogno di
sperimentare l'abisso della vita. Per questo andai volontario”3. E il suo compatriota e collega Max
Beckmann: “Quando la morte è ovunque, si vive più intensamente... Oscillo continuamente tra la
grande gioia per ogni cosa nuova che vedo, e la depressione per la perdita della mia individualità, e
un profondo senso ironico di me stesso e del mondo”4. Analoga e ancora più intensa la reazione di
Giuseppe Prezzolini: “Il mistero della generazione di un nuovo mondo si compie. Forze oscure
scaturite dalla profondità dell'essere sono al travaglio ed il parto avviene tra rivi mostruosi di sangue
e gemiti che fanno fremere. Noi non guarderemo soltanto al dolore. Salute al nuovo mondo! Ci darà
la guerra quello che molti delle nostre generazioni hanno atteso da una rivoluzione? L'animo è
colmo di fronte alla totalità del fatto che si compie e non possiamo dubitare del domani. La civiltà
non muore! Indietreggia per prendere un nuovo slancio. Si tuffa nella barbarie per rinvigorirsi”5. Lo
stesso percorso e discorso si ritrova presso scrittori e poeti francesi, perfino tra coloro che dettero
vita al surrealismo. Jacques Vaché, che sarebbe morto suicida poco dopo l'armistizio, scriveva a
Jean Sarment dal fronte: “In ognuno di questi momenti ho avuto rivelazioni di umanità, rivelazioni
che mi stordiscono positivamente, sì è questa la parola, questo vuoto mi ha sconcertato – questa
carneficina – questo straordinario momento per coloro che sanno come vedere – tutto questo mi ha
dato momenti di stupore che ho tenuto per me stesso”6. E Aragon, giovane aiutante medico, doveva
scrivere subito dopo la guerra: “Amammo la guerra come una negra. E con quale emozione... Non
abbiamo mai sufficientemente rimpianto questo stato eccezionale. Sacrifico volentieri l'umanità allo
spaventoso. Il sole della paura è un infuso incomparabaile. La guerra, malgrado i suoi piccoli
veleni, ha la grandezza del vento”7.
“Per me – avrebbe sintetizzato con estrema efficacia il poeta inglese Siegfried Sassoon – la Guerra
fu inevitabile e giustificabile. Il coraggio rimaneva una virtù. E questo sfruttamento del coraggio, se
posso permettermi di dire una cosa tanto ovvia, fu la tragedia fondamentale della Guerra, che, come
adesso tutti concordano, fu un crimine contro l'umanità”8. Sassoon aveva cambiato idea, come
molti, probabilmente la maggioranza, nel corso del conflitto e a contatto con l'orrore della guerra di
trincea. La sua “Dichiarazione di un soldato”, una protesta letta di fronte alla Camera dei Comuni il
30 luglio 1917, diceva tra l'altro: “Ho visto e sopportato le sofferenze delle truppe e non posso più a
lungo essere partecipe di questa sofferenza per fini che ritengo malvagi e ingiusti. Non sto
protestando contro la condotta militare della guerra, ma contro gli errori politici e le menzogne per
le quali sono sacrificati gli uomini che combattono”9. Lo aveva capito, in modo analogo, Edmund
Blunden, riflettendo su quanto aveva visto la prima giornata della battaglia della Somme: “sul finire
del giorno, entrambe le parti avevano letto nell'atroce realtà della terra dilaniata e degli uomini
assassinati la risposta al quesito. Chiuso. Divieto di transito. Nessuno dei due popoli aveva vinto, né
poteva vincere la guerra. Era la guerra ad aver vinto, e avrebbe continuato a vincere”10. Era quanto,
in modo diverso, aveva scritto Renato Serra nel suo Esame di coscienza di un letterato : “Crediamo
pure, per un momento, che gli oppressi saranno vendicati e gli oppressori saranno abbassati; l'esito
finale sarà tutta la giustizia e tutto il maggior bene possibile su questa terra. Ma non c'è bene che
paghi la lagrima pianta invano, il lamento del ferito che è rimasto solo, il dolore del tormentato di
cui nessuno ha avuto notizia, il sangue e lo strazio umano che non ha servito a niente. Il bene degli
altri, di quelli che restano, non compensa il male, abbandonato senza rimedio all'eternità”11. La
perdita dell'innocenza, cantata più tardi da Philip Larkin nel suo poema MCMXIV 12, trova la sua
radice proprio nell'autoinganno di una partecipazione entusiasta trasformata in pochi mesi o qualche
anno in disillusione cocente e totale. La metafora dadaista della follia come forma di resistenza e
opposizione alla guerra, e che il giovane studente di medicina André Breton aveva verificato nei
molti casi di malattia mentale vera o simulata osservati all'ospedale militare di St. Dizier, gettava
luce postuma su quella che, a conflitto terminato, sembrava a molti una pazzia collettiva di cui non
si riusciva a stabilire l'origine, ma che avrebbe segnato gli anni della pace in maniera profonda e
indelebile.
Le nevrosi da guerra, soprattutto gli shock da granata – i shell-shock, come vennero
immediatamente chiamati in campo medico e psichiatrico – divennero il simbolo di una realtà
nuova e terribile, incomprensibile a chi non aveva sperimentato la crudezza del fronte, ma anche lo
schermo dietro cui confondere l'orrore soggettivo suscitato da quella stessa realtà. “Francamente
non sono preparato a tracciare una distinzione tra codardia e shock da granata – scriveva un
ufficiale medico britannico sul fronte francese – per codardia intendo l'azione sotto l'influsso della
paura e il tipo normale di shell-shock per me ha sempre voluto dire paura cronica e persistente”13.
L'intreccio tra terminologia medica e morale, tra valori e comportamenti, per quanto negata dai
comandi militari segnala l'esistenza di un trauma collettivo che viene vissuto individualmente in
modo drammatico dai soldati al fronte; e che si trasforma nel tempo in un conflitto d'identità che
capovolge l'entusiasmo con cui la guerra era stata accolta dovunque: “Dopo un violento shock
emotivo, accompagnato o no da commozione fisica e ferite, il soldato coraggioso diventa un
codardo. È amputato del suo coraggio guerriero. Quando sente i cannoni ha paura, trema e non può
nascondere né controllare il proprio turbamento. È stato preso da una sorta di anofilassi emotiva;
non può più resistere vittoriosamente all'agonia del campo di battaglia. È un invalido morale,
mancante di coraggio”14.
È l'ideale maschile di eroismo, disciplina e sacrifico che viene qui messo in discussione, se è vero
che alla fine del 1915 il 40% dei feriti britannici in zone di combattimento venne diagnosticato di
origine psicologica. Se con la guerra la nazione aveva cooptato l'ideale della mascolinità come
propria (Mosse), aiutando a fare diventare i maschi uomini e gli uomini cittadini in un intreccio
crescente di mascolinità e patriottismo, le nevrosi psicologiche indotte dalla guerra lasciano un
segno di tutt'altro tipo. Gli shell shock segnalarono la devastazione psicologica prodotta dalla
guerra, una devastazione che la vecchia psichiatria era incapace di comprendere. Come scrisse un
soldato, “chiunque è stato in trincea a lungo come la nostra fanteria, deve almeno avere perso la
sensibilità per un sacco di cose. Troppo orrore, troppa incredulità sono stati gettati addosso ai nostri
poveri fanti. Il nostro piccolo cervello non ce la fa a sopportarlo”. Ernst Simmel, un giovane tedesco
studente di Freud elaborò in questo modo: “Non è solo la guerra sanguinosa che lascia queste tracce
devastanti... è anche il conflitto difficile in cui si dibatte la personalità stessa...Qualsiasi cosa
nell'esperienza di una persona è troppo potente od orribile per essere afferrata dalla mente conscia,
si muove attraverso dei filtri fino ai livelli inconsci della sua psiche. Lì giace come una mina, pronta
ad esplodere15.
La crisi che conduce allo scoppio del conflitto mondiale enfatizza e radicalizza immaginari
nazionali contrapposti e stereotipi culturali di sé e del nemico che avevano trovato sempre più
spazio a partire dall'inizio del secolo. Un simbolismo identitario crescente si era imposto con
modalità proprie in ognuna delle grandi potenze europee, accompagnando il processo di costruzione
della cittadinanza comune con una nazionalizzazione delle masse che proseguirà con nuovo slancio
e forme nuove anche dopo la guerra16. L'educazione scolastica e l'enfasi posta sullo studio della
storia e sull'immaginazione patriottica, il culto pubblico della memoria nazionale, il ruolo della
letteratura colta e popolare nel fornire modelli comuni d'identificazione collettiva, l'immaginazione
scatenata e incanalata dal cinema, la celebrazione di ricorrenze e la costruzione mediatica e
pubblica di eroi, creano una lealtà e un senso di appartenenza nazionale che superano i conflitti
sociali e le contrapposizioni di classe. Questo simbolismo identitario non si sviluppa astrattamente
ma si radica nelle dinamiche sociali di ogni paese: “È il prodotto, storicamente e politicamente
costruito all'interno dello spazio nazionale, dell'inserimento progressivo di ciascun individuo,
famiglia, comunità rurale o cittadina, di ogni gruppo, in un reticolo di punti di riferimento esterni
definiti dalle élites e dalle istituzioni (educative, amministrative, religiose, professionali, ecc.) che
canalizzano le loro linee di reazione comune in circostanze in cui la sopravvivenza oltrepassa i
processi d'adattamento quotidiani o le strategie di breve portata”17.
L'interiorizzazione dell'autorità nazionale, del dovere nei confronti della comunità, del legame
patriottico trasversale alle divisioni sociali sono alla base del carattere profondamente nazionale e
anticosmopolita della nuova cultura di massa. Ma anche del fallimento dell'internazionalismo
socialista che si scioglie in poche settimane di crisi e che neppure l'assassinio di Jaurès, in Francia,
per quanta commozione susciti, riesce a frenare o interrompere. I voti unanimi dei parlamenti sui
crediti di guerra e l'adesione dei socialisti alle “unioni sacre” che si costituiscono in molti paesi non
sono tanto la vittoria del nazionalismo politico, ma delle profonde e ormai radicate rappresentazioni
identitarie, i cui riflessi culturali stereotipati sono alla base dell'entusiasmo bellicista e
dell'intossicazione sciovinista dell'estate 1914.
La guerra spinge a vedere nella nazione il riflesso degli ideali sociali e a farne il collettore e
promotore di un sistema di valori in cui fedeltà, disciplina e coraggio sembrano venire prima di ogni
altra cosa. A molti – i futuristi per primi: “Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del
mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore
e il disprezzo della donna”, recitava il nono paragrafo del Manifesto futurista del 1909 – il conflitto
mondiale appare l'ipostasi del progresso, una sua accelerazione e sintesi estrema, capace di
affrettare e selezionare le trasformazioni sperate. L'opposto della percezione che di quegli anni ebbe
il pittore dadaista Max Ernst: “Una guerra terribile e stupida frustrò la nostra esistenza per cinque
anni. Facemmo il nostro dovere in questo collasso generale ridicolizzando e disonorando ogni cosa
che avevamo creduto giusta, bella e vera. Il mio lavoro in questo periodo non fu indirizzato a
sedurre, ma a urlare”18.
0001000100 ‣ Modernizzazione e mondializzazione.
Dobbiamo o creare una capacità politica
o andare in malora con la Democrazia,
che ci è stata imposta dal fallimento dei sistemi precedenti.
(George B. Shaw, Uomo e Superuomo, 1903)
Nel momento del passaggio dal XIX al XX secolo, la visione del mondo che prevale non è
omogenea, ma è caratterizzata da tendenze divergenti, da ideologie contrapposte, da atteggiamenti
contraddittori, da analisi differenziate. Non esiste un zeitgeist [spirito del tempo] unico, anche se
nella percezione della maggioranza prevale senza dubbio l'idea di un progresso continuo e
inarrestabile, la fiducia che le trasformazioni in atto riescano a unificare il mondo non solo
materialmente – con la rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni – ma anche culturalmente,
trascinati dalle forze innovatrici che l'Occidente ha dispiegato in ogni campo negli ultimi venti o
trent'anni. La nascita delle Olimpiadi moderne si affianca alla istituzione dei premi Nobel, le
convenzioni dell'Aja sulle leggi “umanitarie” di guerra si sovrappongono ai trattati commerciali
internazionali, l'adozione del Greenwich Meridian Time fa da ponte al passaggio dal telegrafo al
telefono che simboleggiano la possibilità di comunicare ormai su scala planetaria.
Tra i caratteri fondamentali della coscienza di inizio secolo vi è quella – per l'Occidente,
naturalmente – di appartenere a una civiltà imperiale che, sia pure in modo non unitario ma diviso
per entità geopolitiche spesso contrapposte, ha conquistato il mondo, puntando adesso alla sua
unificazione e modernizzazione. Questa penetrazione ha da una parte un carattere materiale,
fondamentalmente economico e tecnologico; dall'altra una manifestazione culturale che si fonda
sulla convinzione e l'orgoglio di appartenere a una civiltà unica per dinamismo, forza, capacità di
modellare a propria immagine il mondo intero.
Questa coscienza della superiorità dell'Occidente è largamente condivisa anche dalle forze che
criticano la limitatezza della democrazia liberale o le disuguaglianze sociali del capitalismo. Sia per
chi pensa ancora in termini di religione e tradizione, sia per chi ragiona influenzato dalle idee di
progresso o di selezione naturale, di successo del più adatto o di chi è destinato a prevalere in
futuro, questa superiorità materiale e culturale acquista un connotato di egemonia “naturale”
inevitabile. Pur diverse e in alcuni momenti contrapposte e antagoniste, l'idea della civilizzazione
del mondo come “fardello dell'uomo bianco” o come “mission civilisatrice ” e quella della
conquista sistematica, brutale, annientatrice, coesistono e s'intrecciano nella coscienza popolare
dell'Occidente.
In imperi di più lunga tradizione, come quello britannico o francese, sembra prevalere culturalmente
il carattere di civilizzazione e modernizzazione dell'intervento occidentale, anche se questo si
manifesta spesso con la brutalità della conquista francese dell'Algeria o delle campagne di Lord
Kitchener in Sudan e altrove. Nel caso della Germania, e in misura più ridotta dell'Italia, con una
politica coloniale tarda e fortemente segnata dal militarismo, la conquista con ogni mezzo del
territorio prescelto è il risultato di una teorizzazione geopolitica influenzata da un'idea di
Lebensraum [spazio vitale] come area geograficamente necessaria alla crescita della popolazione,
che s'intreccia con l'ossessione della Weltpolitik. Il tentativo, prevalentemente tedesco – attraverso
Otto Peschel e soprattutto Friedrich Ratzel –, di dare un fondamento scientifico e antropologico alla
geografia politica, porta all'identificazione dello stato nazione con lo spazio vitale necessario a un
popolo. L'espansione territoriale diventa un bisogno fisiologico, legittimato dal suo carattere
naturale e condiviso (almeno dalle nazioni e dai popoli occidentali): “Nel concetto di Lebensraum il
darwinismo e la tradizione tedesca del Völkskunde [tradizione etnica] si fusero assieme”19. Se lo
spazio coloniale è l'orizzonte “mondiale” comune a tutti gli stati-nazione imperiali (mentre gli
imperi multinazionali soffrono, al contrario, per la perdita di territori e la difficoltà a tenere insieme
quelli su cui esercitano il dominio), vi è un altro spazio in cui s'incarna la sensibilità e s'identifica la
coscienza della modernizzazione novecentesca: la città. È nella città che si appunta l'immaginazione
sociale dell'epoca, l'eccitazione e le speranze di un progresso dinamico e travolgente e l'angoscia e
l'orrore di una minaccia all'equilibrio e alla tradizione. A Londra, che era stata la precorritrice, si
affianca adesso Parigi, che nel corso della Belle Epoque si configura come archetipo della città
moderna, e Berlino, che ne diverrà il paradigma nel corso degli anni Venti.
La città è la struttura fisica in cui sono visibili lo sviluppo demografico e tecnologico che
caratterizzano la modernità, è il modello delle nuove relazioni sociali, è il terreno di
sperimentazione dei nuovi comportamenti collettivi e del nuovo controllo sociale. È nella città che
si radica spazialmente ogni idea di modernità, che si svolge lo scontro tra i suoi fautori e i suoi
denigratori, che ha luogo la frattura di una coscienza spazio-temporale secolare e si anticipa un
futuro incentrato sulla trasformazione e l'innovazione. La natura impersonale e precaria
dell'esperienza urbana, dove la società si costituisce attraverso una moltitudine di legami transitori
ed effimeri, intreccia tecnologia e burocrazia ma separa aspetti della cultura (scienza, morale, arte)
un tempo unificati dalla religione e dalla metafisica. La città rende visibile la crisi d'identità e di
controllo su cui la modernità s'interroga ambiguamente, si rende terreno disponibile e privilegiato
per le avventure rivoluzionarie (urbane per eccellenza).
Anche dove è maggiormente consolidata, in Inghilterra, con la fine dell'età vittoriana la città diventa
il luogo di nascita di miti parzialmente apocalittici che sfidano il dogma del progresso evolutivo: la
campagna femminista delle suffragette, la lotta di classe dei sindacati e degli operai, il nazionalismo
irlandese, la percezione di una minaccia tedesca, che s'ingrossa con l'avanzare del secolo, si
mescolano alla rappresentazione del mito imperiale che nei music-hall, nei pub, nei teatri e nei
cinema cerca di uniformare nella cultura quotidiana una società attraversata da divisioni crescenti.
“La base psicologica del tipo metropolitano di individualità – scrive George Simmel nel 1903 –
consiste nella intensificazione delle stimolazioni nervose che sono il risultato del mutamento rapido
e ininterrotto di stimoli interni ed esterni”20.
Nella città, emblema di modernità, l'isolamento dell'individuo si manifesta in tutta la sua pienezza,
insieme alla sua debolezza, precarietà, alienazione. L'instabilità urbana, che è un elemento
oggettivo, viene percepita soggettivamente come insicurezza, evidenziando la richiesta di un
“bisogno” comunitario che saranno i miti patriottici, le ideologie, la demagogia, le religioni
politiche a cercare di soddisfare con la guerra e nel dopoguerra. La cultura liberale, che cerca
inutilmente di combattere queste aspirazioni comunitarie in nome della libertà individuale, resiste
solo, nel medio periodo, dove la modernizzazione è stata più lenta e radicata, dove si sono create
istituzioni capaci di mitigare l'isolamento e l'alienazione individuale; soccombe invece dove le
strutture sociali tradizionali sono travolte da una modernizzazione più rapida e accelerata.
“Dissolversi nel numero incalcolabile – scrive lo scrittore Robert Musil nel 1912 – è quello che
costituisce la differenza culturale fondamentale tra questa e ogni altra epoca, la solitudine e
l'anonimato dell'individuo in una moltitudine sempre più affollata, e questo porta con sé una nuova
disposizione intellettuale le cui conseguenze sono ancora impenetrabili”21. Si trattava di un'analisi
accurata che era, all'epoca, affiancata da un ottimismo radicato nella dinamica di mondializzazione
che la modernità portava con sé. Dopo il 1914 questo ottimismo viene certo meno, anche se lo
sforzo di Musil di ricomporre la realtà del mondo dei sentimenti, di non contrapporre scienza e
letteratura e soprattutto coscienza emotiva e conoscenza scientifica, deve fare i conti con una crisi di
vitalità della cultura occidentale, accolta come sfida e non considerata definitiva e inevitabile; anche
se le esperienze più intime e personali – l'amore, l'introspezione, l'umiltà – sembrano difficili da
trasmettere e mantengono un connotato “abbastanza personale e quasi antisociale”22. Ancor più
drastica l'idea di degrado culturale e morale che caratterizza, per Spengler, “l'abitante delle grandi
città”: “un parassita, il puro uomo pratico senza tradizione, ripreso in una massa informe e
fluttuante”23.
L'ascesa del capitalismo – proprio nell'epoca della seconda rivoluzione industriale in cui si
generalizza e mondializza – si accompagna con la crisi della modernità, che è difficoltà a sostituire
una forte e univoca identità collettiva radicata e convincente come le poche esistenti nelle società di
antico regime. La complessità del mondo moderno – di cui la vita urbana è uno specchio fedele
oltre che una metafora – parcellizza e scompone gli individui attribuendo loro tante e diverse, e
sempre nuove, identità. Anche se all'epoca non sono in molti a rendersene conto, perché l'equazione
progresso uguale ragione sembra avere il sopravvento, le componenti irrazionali, emotive e affettive
del mondo moderno sono decisive nel permettere di resistere e fare i conti con quella crisi
“spirituale” di cui parlava anche uno scrittore tutt'altro che apocalittico come Musil. Ed è quindi
dentro la crisi della modernità che sorgono i primi miti moderni, “credenze cariche di emotività, che
esprimono il modo in cui i popoli sperimentano i periodi formativi della loro storia...
rappresentazioni simboliche della realtà ma anche autentiche risposte al mutamento sociale”24. I
miti dell'ascesa del capitalismo e della potenza degli stati-nazione sono i due pilastri, uno
economico e l'altro politico, del mito più diffuso dell'epoca, quello del progresso. Esso stesso,
tuttavia, si declina in forme nazionali differenziate, che sono modi diversi di fare i conti in contesti
diversi con la crisi della modernità. Quello che in Gran Bretagna è il mito del progresso per
eccellenza, si trasforma in Germania nel mito della volontà di potenza, in Francia nel mito della
Repubblica dei cittadini e negli Stati Uniti in quello del destino della nazione.
Questi miti, radicati in una realtà oggettivamente diversa (negli Stati Uniti l'ascesa capitalistica ha
luogo in una democrazia consolidata e negli anni dell'ottimismo della frontiera e dell'egemonia sul
continente americano; in Germania in un contesto nazionale appena unificato e guidato da élites
economiche e militari fortemente legate nell'aristocrazia e ostili alla democrazia) si divaricheranno
ancora di più con la guerra mondiale e negli anni successivi. L'ottimismo interventista di Wilson
non riuscirà a prevalere su una mitologia ancora fortemente economica, che spingerà gli Stati Uniti
a puntare sul potere industriale e tralasciare momentaneamente di svolgere un ruolo attivo nella
politica mondiale, imboccando la strada di una crescita produttiva improntata al consumo, di cui il
fordismo e il sistema manageriale sono gli aspetti più noti e distintivi insieme alla creazione di una
estesa classe media. In Germania sarà invece la politica alla base della mitologia pubblica, in una
società dominata dal senso di umiliazione e sconfitta e dalla contrapposizione sociale che la crisi
economica accentuerà oltre misura. Il mito della volontà di potenza si declina in negativo attorno
alla scelta politica vincente, quella fondata sull'odio razziale e sulla promessa di dominare il mondo.
Se le mitologie nazionali trovano strade differenziate e si manifestano in modi diversi e
contrapposti, perché sono le risposte emotivo-culturali a condizioni strutturali disomogenee, e se le
ideologie che accompagnano la modernità e la sua crisi sono difficilmente assimilabili una all'altra
(il nazionalismo al socialismo, l'american way of life al Lebensraum, la rivoluzione al patriottismo),
pure vi è un elemento della cultura della modernità e della crisi che è presente, sia pure in forme
diverse, in ognuna delle ideologie e dei miti cui esse danno luogo. Questo tratto comune è il
socialdarwinismo, le cui eredità legittime sono l'idea americana di ricchezza e di espansione
capitalista ma anche il primato della razza su cui la Germania costruirà la sua volontà di potenza, la
convinzione britannica della superiorità del proprio modello imperiale e quella francese della
propria forma di stato e di amministrazione, la dinamica rivoluzionaria perseguita dalla Russia e la
ricerca di un posto al sole tardo-coloniale rivendicata dall'Italia.
0001000100 ‣ Cultura e cultura di massa.
Ho una teoria secondo cui l'individuo rappresenta
nel suo sviluppo l'intera schiera dei propri avi,
e l'improvviso volgersi al bene o al male nasce
da una forte influenza che proviene dal suo albero genealogico.
(Arthur Conan Doyle, 1905)
L'eredità culturale del socialdarwinismo si manifesterà in vario modo e con diversa intensità lungo
tutto il XX secolo. Frutto di una stagione intellettuale in cui la cultura alta tende a unificare sotto la
spinta delle scienze esatte ogni elaborazione del pensiero, il socialdarwinismo diventa,
popolarizzato e semplificato, uno dei cardini della cultura popolare e degli stereotipi e pregiudizi
che la sorreggono. La “sopravvivenza del più adatto”, la “lotta per l'esistenza”, la “minaccia
d'estinzione”, il “prevalere del più forte”, sono alcuni dei concetti attribuiti a Darwin, anche se in
realtà farina del sacco di Spencer; ma servono a utilizzare l'idea rivoluzionaria e innovativa della
selezione naturale e la geniale teoria dell'evoluzione applicandole meccanicamente al contesto
sociale.
La potenza dell'uso della metafora, soprattutto nella società di massa, tradisce spesso il pensiero da
cui si origina: se in ambito biologico parlare di riproduzione e variazione, adattabilità e
sopravvivenza era stato un momento fondamentale per mettere in crisi le diffuse credenze
creazioniste, nella vita sociale la teoria della selezione ambientale può solo suggerire che le
innovazioni si affacciano quando le circostanze sono propizie. E Darwin sarà infatti usato da chi
difende i principi gerarchici e da chi li combatte, da chi giustifica l'individualismo e da chi lo
condanna.
I socialdarwinisti discutono quali forme di competizione sociale siano desiderabili e utili per il
progresso, e indicano – a differenza degli scienziati e biologi per i quali ogni specie ha un valore –
quelle che potrebbero invece venire isolate, controllate o finanche soppresse (i criminali, i pazzi, i
malati...). Alla competizione (selezione) naturale subentra l'intervento dello stato a favore della
specie e degli individui che la morale sociale ha deciso essere i vincitori nella lotta per la
sopravvivenza, i “normali” o “migliori”. La retorica socialdarwinista crea nella coscienza pubblica
un senso permanente di crisi, e suggerisce che politiche differenti possono condurre la società verso
il trionfo della propria identità culturale e superiorità nazionale o, al contrario, verso la mera
sopravvivenza o addirittura verso l'estinzione. L'ammonizione di scienziati come Edwin Ray
Lankester25 o i suggerimenti della nuova criminologia positiva26, in un contesto di competizione
economica mondiale e di crescita dei partiti socialisti, possono manifestarsi al tempo stesso in
angoscia sociale o in spinte imperialiste, frantumando le illusioni liberali di progresso continuo.
La superiorità nei confronti degli altri popoli, non occidentali, si presenta legittimata dalla scienza,
appare come naturale, allo stesso modo della supermazia maschile sulla donna, che viene riproposta
con ossessiva paura proprio mentre la nuova donna moderna rivendica diritti politici e uguaglianza
culturale.
Ciò che è comune alle spiegazioni socialdarwiniste di stampo soprattutto europeo, è la visione
organica delle malattie che accompagnano la modernità e minano la solidità dell'Occidente. Nel
mezzo della guerra, al termine della sua lunga lunga carriera, lo psichiatra vittoriano Henry
Maudsley vedeva nella guerra il risultato delle sue decennali previsioni: “la degenerazione organica
è la continuazione dello sviluppo organico, nessuna organizzazione sociale può sentirsi del tutto
esente dalla legge dello sviluppo e della decadenza”. E prevedeva il momento in cui “un gruppetto
di autoesaltati e illusi demagoghi” (da lui identificati nei socialisti) sarebbe stato capace di sfruttare
“le egoistiche passioni e gli ignoranti pregiudizi delle masse che li hanno portati al potere”27. Non
diversa è la deriva pessimista di filosofi come Spengler e Ortega y Gasset, che classificano come
tramonto e crisi della civiltà occidentale l'incapacità di comprendere l'ingresso delle masse
nell'arena pubblica e i loro bisogni sorti sull'onda delle grandi trasformazioni tecnologiche, sociali e
culturali della modernizzazione.
Nella cultura di derivazione socialdarwinista, tuttavia, le reazioni ambigue, o addirittura
“degenerative”, all'urbanizzazione e all'industrialismo, alla mondializzazione e all'espansione
coloniale, all'irruzione delle masse nella politica e allo spettro di nuove rivoluzioni, si focalizzano e
“si spiegano” scientificamente col richiamo al sangue, che diventa sempre più elemento riassuntivo
per connotare l'identità nazionale, razziale, culturale.
L'antagonismo tra individuo e massa, l'irriducibilità del primo alla seconda ma al tempo stesso la
sua trasformazione psicologica quando vi si trova dentro, sono elementi centrali nel dibattito
culturale e nella sua trasmissione. La folla studiata a fine secolo da Le Bon, con un
socialdarwinismo elitario e antisocialista ma con un'attenzione profonda ai comportamenti
irrazionali delle masse, critica la democrazia perché essa rappresenta l'istituzionalizzazione della
regressione, delle risposte riflesse e imitative dove coscienza e critica sono sospese. La folla, infatti,
è la parte più arretrata e irrazionale del popolo, di cui le donne sono ovviamente componente
fondamentale. L'anima della folla – con forti analogie con l'anima delle razze “arretrate” – è
modellata e analizzata sulla base del concetto di follia, che priva l'identità individuale della propria
coscienza e favorisce quei comportamenti emotivi utilizzati (o suggeriti) dal “prestigio” del leader
attraverso un “contagio mentale”. La folla diventa una categoria non più sociale ma
psicopatologica; e le masse trovano in emozioni disordinate e in passioni pericolose la propria
identità: per non cadere vittima di allucinazioni collettive (com'era accaduto con la Comune, su cui
si basa la prima analisi di Le Bon) deve trovare una guida autoritaria cui potersi affidare.
Il conflitto e l'intreccio tra individuo e folla sarà una costante di molte delle prime narrazioni
prodotte dal cinema, strumento tipico della società di massa e della nuova cultura comunicativa su
cui si fonda: Metropolis di Fritz Lang (1926) e La folla di King Vidor (1928) riassumeranno alla
fine degli anni Venti la doppia faccia della massa, pericolosa e alienante, irrazionale e rassegnata,
caotica e passiva.
L'idea della scienza come consapevole controllo della società da parte di élites si esprime con forza
attraverso l'eugenetica, una sorta di darwinismo capovolto: attraverso una selezione sociale
controllata, lo stato deve supplire a quello che la selezione naturale non può più attuare, la
soppressione dei meno adatti e degli ostacoli alla evoluzione. La preoccupazione per il livello della
salute mostrata dai soldati britannici nel corso della guerra anglo-boera aveva spinto a creare il
Comitato Parlamentare sul Deterioramento Fisico, mentre in Germania viene fondata nel 1905 la
Società d'Igiene Razziale.
Non dovunque l'eugenetica si presenta con gli stessi caratteri: alle proposte di sterilizzare e
segregare i malati o addirittura gli “undeserving poor ” – come li chiama la English Charity
Organisation Society – si affiancano i fautori di un'eugenetica egualitaria, capace di frantumare le
barriere di classe, o femministe spinte a favorire il controllo delle nascite con un'eugenetica
“positiva”. Non ha senso riassumere sotto un unico comune denominatore le politiche razziali del
nazionalsocialismo e quelle della socialdemocrazia scandinava o di alcuni degli stati degli USA,
così come le teorie di Galton o le aspirazioni eugeniste e socialiste di H. G.Wells. Che sia stato un
ginecologo di Heidelberg, nel 1897, a realizzare il primo intervento – illegale – di sterilizzazione su
un essere ritenuto “inferiore”, non deve indurre a un determinismo che rintracci nella sola cultura
tedesca le origini e le tare del successivo razzismo genocidiario. Al tempo stesso, però, è importante
riconoscere la crescente trasversalità di idee e culture rispetto alle appartenenze ideologiche e ai
regimi politici, che è un tratto distintivo della modernità e che produrrà non pochi corto-circuiti
nella cultura e nella politica tra le due guerre. È l'idea stessa di razza che crea i presupposti per
considerarne una sua possibile adulterazione (e quindi per l'eliminazione o emarginazione degli
“adulterati”); e questa trova la sua origine nelle classificazioni tassonomiche delle scienze naturali,
nelle gerarchie culturali stabilite dall'antropologia, nelle ambigue formulazioni del
socialdarwinismo. In una parola nell'uso politico che della scienza fanno gli avversari della
democrazia e dei diritti naturali dell'uomo e nell'avallo che la scienza fornisce – indirettamente ma
più spesso direttamente – alla legittimazione, popolarizzazione e semplificazione di pregiudizi
culturali artificialmente accentuati dall'educazione patriottica e dalla istituzionalizzazione delle
appartenenze nazionali.
La confluenza dell'individuo nella massa è percepita in modo ambiguo: come regressione a una
indistinta pre-individualità ma anche come possibilità di sopravvivere e integrarsi nella modernità,
nella nuova realtà urbana e industriale. Democrazia e socialismo sono una minaccia per le élites
liberali e conservatrici, ma una speranza di affrancamento e libertà per lavoratori, donne, giovani.
La cultura dominante, tanto nelle sue versioni colte quanto nelle sue espressioni più popolari,
individua nella partecipazione di massa alla vita pubblica il germe della degenerazione, e cerca di
trovare una nuova sintesi identitaria capace di legare le masse al vecchio ordine, per quanto precario
e indebolito. È la Nazione a costituire la risposta a questa ricerca, che avviene in realtà sul terreno
culturale prima ancora che su quello politico, ideologico, della mobilitazione elettorale ed
extraparlamentare. Il patriottismo – di cui gli inglesi danno prova in una versione “imperiale”
durante gli anni della conquista africana e della guerra anglo-boera, e gli stati continentali in forme
ognuna diversa dall'altra – rappresenta una potente ideologia interclassista, un antidoto al timore
dell'eclisse della civiltà o del suo inquinamento. In nome della Nazione ci si può opporre al tempo
stesso al pericolo esterno – degli stati-nazione avversari e delle razze inferiori – e a quello interno –
delle masse operaie pronte a trasformarsi in plebaglia ribelle. Una pratica congiunta di
assimilazione ed esclusione, condotta attraverso mobilitazioni emotive e gratificazioni narcisistiche,
grazie a un discorso “scientifico” tradotto in un'ideologia fatta di passioni e simboli, giuramenti
d'appartenenza e demonizzazione non solo dei nemici ma anche degli estranei, trova nell'idea di
sicurezza nazionale il pendant dell'essere (o divenire, o restare) grande potenza. Ed è questo
elemento di irrazionalità, di richiamo alle passioni e alle emozioni, a permettere all'interclassismo di
acquisire una forza che le ideologie razionali e le spiegazioni materialistiche non riescono a
comprendere. Il senso di crisi che accompagna la modernità si manifesta nella ricerca di valori e
progetti morali capaci di riempire il vuoto creato dal tramonto dell'egemonia cristiana. Le due
risposte che si radicano con maggiore rapidità sono il solidarismo del cattolicesimo sociale e il
socialismo internazionale umanitario, che si manifesta anch'esso con forti connotati religiosi. A
cavallo del secolo si affaccia con prepotenza il nazionalismo popolare, capace di riempire attorno
alla religione della patria, in una dimensione nazional-egoistica differenziata, il vuoto che le
tradizioni confessionali hanno lasciato in tutti i paesi europei. Si rafforza la convinzione che le
culture nazionali sono uniche e irripetibili, dotate di caratteri originali scarsamente condivisi,
avversarie una dell'altra per fatalità territoriale e storica. È sempre più il timore del declino razziale
e la paura dell'incombere dell'altro, dell'alien, dello straniero che si coniugano in una concezione
biomedica della massa, in “una scienza positiva (un distillato di psicologia, biologia e antropologia
razziale) delle precipue, tradizionali caratteristiche della folla (punto di coagulo delle differenze di
classe) e del suo rapporto con la ``civiltà''”28.
La Grande guerra sembra porre fine ai ragionamenti sulla degenerazione, che rimane soltanto una
caratteristica biologica del nemico di turno, sia esso nazionale, o razziale, o di classe. “Sembriamo
minacciati da una nuova epoca di invasioni barbariche”, scrive Thomas Hardy nel 1922,
riconducibile alla “sinistra follia dell'ultima guerra, all'implacabile diffondersi dell'egoismo in tutte
le classi, alla pletorica crescita della conoscenza cui si accompagna un arresto della saggezza”29.
L'immagine d'inizio secolo della modernità – l'individuo solo di fronte a una minacciosa società di
massa, come la racconta Strindberg nel romanzo Ensam (“Solo”) del 1903 – è stata travolta,
trasformata, radicalizzata dal trauma collettivo del conflitto mondiale. La ricerca di un nuovo
universale, di un nuovo assoluto, caratterizza gli anni Venti e si protrae nel corso del successivo
decennio. Ed è questa mancanza, tuttavia, analizzata o rimpianta nel corso del primo scorcio del
secolo, che ha favorito la nascita di nuovi movimenti che hanno trovato nel “sangue”, e nella sua
purezza, il simbolo della consonanza tra corpo, anima e mente di una comunità nazionale.
All'indomani di un evento collettivo in cui il sangue effettivamente versato ha portato la violenza a
irrompere nella politica e nella vita collettiva in forme inaspettate e durature. “La comunità tedesca
– scrive nel 1933 Eric Voegelin – è diventata un terreno eccellente per il fiorire di nuovi elementi
politici – per il liberalismo e il socialismo al loro tempo così come per il nazionalismo dittatoriale di
oggi – perché i nuovi movimenti non sono stati contrastati da un'idea politica costituita che informi
l'intera comunità”30.
0001000100 ‣ Masse, politica, nazionalismo.
custode di tutto ciò che è comune,
comune valore umano, non è l'umanità come somma
di tutti gli individui, bensì la nazione.
(Thomas Mann, 1918)
È soprattutto attraverso la crescita dei partiti socialisti e degli altri partiti popolari di massa che si
diffonde la percezione che il destino dello stato moderno vada sempre più a coincidere con la
sovranità popolare, con l'estensione del suffragio, per quanto l'idea di democrazia porti con sé
– soprattutto tra le classi medie – un connotato di ansia e pessimismo sul proprio futuro. È il
popolo, infatti, che ci si sforza di presentare come corpo politico unitario benché sia diviso e
frammentato al suo interno, fondando la sovranità popolare sull'illusione che il soggetto del potere
politico sia il medesimo su cui si esercita il governo, lo sfruttamento economico e la soggezione
socio-culturale. La massa – cioè la maggioranza del popolo esclusa dalla politica – diventa la fonte
proprio della legittimazione della politica, anche se a fatica e contro gli ostacoli frapposti
dall'elitismo di proprietà, censo e cultura che era stato l'incarnazione del liberalismo ottocentesco.
Le due grandi tappe dell'ingresso “politico” delle masse nella storia sono quelle del suffragio
universale maschile (che avviene quasi ovunque entro il primo quindicennio del XX secolo) e della
concessione del voto alle donne (che avviene in molti paesi all'indomani del primo conflitto
mondiale), collegate tra loro dal coinvolgimento traumatico, violento e totale del popolo nell'arena
pubblica che avviene con l'ingresso in guerra sia sul terreno sociale ed economico, sia su quello
culturale e istituzionale.
Nell'insieme del corpo sociale coesistono livelli di conflittualità differenti: quello economico tra
possidenti e contadini, borghesia e classe operaia, si manifesta con maggiore evidenza e aggiunge
così una connotazione sempre più politicizzata alla nozione di massa. Ma perfino il sempre più
esteso coinvolgimento in una organizzazione a carattere sindacale o politico non riesce a risolvere
l'antinomia individuo-massa propria della fase storica della modernizzazione. Di fronte al potere le
masse adottano – collettivamente e individualmente – strategie differenziate di adattamento e
integrazione. Reagiscono alla repressione eventualmente violenta delle proprie rivendicazioni e dei
propri comportamenti attraverso i partiti e i sindacati, ma sembrano impreparate a contrastare la rete
diffusa e disciplinante dei poteri su cui si articola lo stato moderno. La crescente rappresentazione
simbolica di cui si dota l'autorità statale per orientare gli attori sociali, porta i singoli individui a
interiorizzare le relazioni di forza e i discorsi di sapere su cui si fonda il dominio indiretto sulla
società. Le istituzioni politiche non sono più solo gli strumenti attraverso cui soggiogare la società o
la manifestazione e materializzazione del potere; sono il risultato di una battaglia in cui i diversi
attori sociali, cercando di imporre i propri valori e stili di vita contribuiscono alla creazione di un
ordine simbolico che costituisce la visione legittima e condivisa del mondo, il modo comune in cui
esso viene percepito dalle diverse classi sociali e dagli individui atomizzati.
I modelli interpretativi per comprendere il potere nell'epoca della modernità (da quello di Weber a
quello di Arendt, da Foucault a Bourdieu) sono tutti utili per individuare aspetti diversi di una realtà
che si è fatta complessa e articolata. Il processo di istituzionalizzazione che accompagna il potere
nel suo percorso di modernizzazione rappresenta la nuova cornice in cui le masse e i singoli
individuo-massa tendono a identificarsi – in modi spesso conflittuali e contraddittori – in una
comunità nazionale. Il potere, pur senza una precisa e coerente strategia, offre un “orientamento”
che, nella sua normatività, intreccia conoscenza ed emotività. La costruzione del cittadino è un
percorso tutt'altro che lineare, e il suo risultato è tutt'altro che omogeneo. Eppure ci sono elementi di
fondo che, pur declinati differentemente, si ritrovano – come modalità di una “integrazione
normativa”31 – in ognuno dei paesi europei, siano essi grandi o piccoli, nell'ovest o all'est, al nord o
al sud. Tra questi elementi comuni e riassuntivi spicca senz'altro il nazionalismo, capace di essere al
tempo stesso modernamente occidentale (tanto nella versione “imperiale” britannica quanto in
quella “repubblicana” francese) e di costituire il punto d'incontro delle risposte modernizzatrici
antioccidentali (in Russia e in quasi tutta l'Europa centro-orientale); di rappresentare la cornice
dell'assimilazione e dell'assorbimento delle minoranze o lo strumento per la loro radicalizzazione e
richiesta di autonomia e indipendenza.
Nel corso dell'Ottocento si era assistito a una progressiva essenzializzazione dei caratteri nazionali
nelle culture colte e popolari dei diversi stati occidentali. La Gran Bretagna celebrava il proprio
contributo al progresso civilizzatore incardinato nei valori liberali e costituzionali; la Francia si
proponeva come profeta e alfiere degli immortali principi dell'89 tramandandoli attorno a una
pedagogia nazionale liberale; la Germania rivendicava la superiorità filosofica e letteraria della
cultura tedesca; l'Italia celebrava la civiltà romana e la tradizione delle città-stato medievali. La
spinta a trovare caratteri “eterni” alla propria nazione e lo zelo nel dimostrarne l'unicità storica
oscurava gli aspetti comuni dell'eredità europea e al tempo stesso ipostatizzava alcuni momenti
come riassuntivi dell'intera storia nazionale. All'unicità “parlamentare” dell'Inghilterra si
contrapponeva quella “rivoluzionaria” della Francia, all'unicità di stato-forte della Germania quella
della missione civilizzatrice di Roma per l'Italia. La continuità nazionale viene artificialmente
costruita e radicata “naturalmente” nel passato in una dimensione che coniuga, necessariamente,
l'unicità con il senso di superiorità, la propria identità con la sconfitta e la negazione di una realtà
ritenuta inferiore. La missione civilizzatrice britannica contrappone il progresso all'arretratezza (del
mondo coloniale, India per prima, ma anche dell'Europa orientale, Russia compresa); lo spirito
rivoluzionario francese sbeffeggia le imitazioni repubblicane riscattate soltanto dai codici
napoleonici; la giustapposizione tedesca di Kultur versus Zivilisation si accompagna alla
denigrazione della barbarie slava; l'esaltazione dell'eredità comunale, e in alcuni casi anche etrusca,
rivolge la romanità contro la minore rilevanza delle culture celtiche e germaniche. Il passato è
fermato e immobilizzato, perché queste sono nuove “teologie nazionali designate a legittimare il
presente e a prevenire mutamenti futuri”32. La tradizione parlamentare inglese si fonda sulla Magna
Charta del 1215, la Rivoluzione del 1789 segna geneticamente la Francia repubblicana, il Reich
tedesco è il successore del Sacro Romano Impero e l'Impero romano è il precursore dello Stato
nazionale italiano.
La competizione di discorsi nazionali storici contrapposti tende a unificare le società mentre cresce
l'antagonismo e la differenziazione sociale al loro interno. I conflitti sia per la prevalenza europea
sia nel corso della conquista coloniale, soprattutto durante lo scramble for Africa di fine Ottocento e
inizio Novecento, rafforzano la convinzione di una diversità di lunga durata e lontana origine. Se il
nazionalismo tedesco sembra essere maggiormente particolaristico ed esclusivo, con un richiamo
costante all'ethos politico dello stato, in realtà al suo interno la componente militarista aristocratica
convive con la pulsione imperialistica di stampo liberale. È sul terreno della politica internazionale,
almeno fino al 1914, che il nazionalismo manifesta la sua aggressività verbale e la sua capacità di
mobilitazione e consenso, anche da parte di molti pensatori appartenenti al progressismo europeo.
Sul versante interno prevalgono politiche liberali o conservatrici, tutte orientate – pur se in modi
diversi – a sviluppare la sfera pubblica, il welfare, la parlamentarizzazione della politica.
La nazione – realtà, concetto e mito al tempo stesso – è il luogo in cui più forte è l'intreccio tra
discorso razionale e coinvoglimento emotivo, tanto nella narrazione della storia e delle origini
quanto nella difesa di una politica estera espansiva e nell'esaltazione del particolare ruolo da
ricoprire nel mondo. Nella nazione s'incardina una trilogia di passioni primordiali (avidità, potere,
speranza) che vengono razionalizzate con il richiamo alla necessità del possesso (o espansione)
territoriale, del dominio su altri popoli e nazioni, dell'autostima (per il proprio destino e ruolo). La
Gran Bretagna è la più equilibrata e coerente a dare luogo a una comunità nuova fondata sull'idea di
progresso e di ordine: nell'appartenenza all'impero, infatti s'incontrano e mescolano l'identità sociale
(caratterizzata dall'imborghesimento della classe operaia), l'identità nazionale (riaffermata con o
senza l'Irlanda) e l'identità politica (un sistema elettorale e di libertà politiche più avanzato di
chiunque altro). È lo splendido isolamento che caratterizzerà superficialmente il paese fino allo
scoppio della guerra ma sarà invece segnato dalle stesse dinamiche che porteranno a una diffusa ed
esaltata volontà di morire per la patria, che le giovani generazioni sembrano rivendicare per
accentuare e rendere più realistico il committment nazionalistico dei loro padri. Quello britannico,
tuttavia, resterà un modello poco applicabile agli stati continentali: in Francia la pedagogia
centralistica di costruzione del cittadino francese avverrà con un sincretismo ideologico capace di
tenere insieme gli ideali rivoluzionari e l'espansionismo imperiale napoleonico, la cultura di ordine
e affari del Secondo impero con le tensioni laiche della Terza Repubblica e i tentativi di contrastarli;
in Germania e Italia, giunte tardi all'unificazione politica e territoriale, la costruzione del cittadino e
della stessa coesione patriottica sembrerà obiettivo delle successive generazioni e avverrà in
un'epoca di crescenti divisioni sociali.
Con il Novecento, ormai, la nazione non è più il romantico “plebiscito di tutti i giorni” vagheggiato
da Renan, fondata su un principio spirituale, una storia comune e un consenso condiviso e
indifferente, in fondo, alla razza, alla lingua e alla religione; è invece una realtà organica, unica e
originale, che lega i propri cittadini in un rapporto totalizzante ed esclusivo, basato sul sangue e
sulla cultura, con una missione particolare e un destino che si deve conquistare con coraggio e
sacrificio. Il nazionalismo organico che si affaccia nel Novecento – e che trova alcune tra le voci
più chiare in Francia (Barrès e Maurras) e in Italia (Corradini e Rocco) – con la sua idea integrata,
unica e indivisibile di popolo e stato, offre risposte che il nazionalismo “civico” liberale non è più in
grado di dare alle masse immerse nel processo di modernizzazione. La scelta “istituzionale”
compiuta dai governi liberali e conservatori, di procedere all'acculturazione delle masse, alla loro
trasformazione in cittadini, alla nazionalizzazione delle coscienze attraverso una rete di agenzie
pubbliche e di processi guidati o incoraggiati di socializzazione (la scuola, le comunicazioni e i
trasporti, la cultura popolare, il servizio militare, le ricorrenze e le celebrazioni), viene riempita in
modo crescente da una cultura antiliberale, imbevuta di socialdarwinismo e antilluminismo, che
cerca di rispondere emotivamente e semplicisticamente (con generici e astratti richiami alla razza,
alla classe, alla nazione, allo stato) al bisogno di comunità e d'identità che le profonde
trasformazioni socioeconomiche hanno creato soprattutto tra le giovani generazioni.
L'idea di nazione – come per altro verso quella di rivoluzione – trascende i conflitti sociali e
mobilita senza compromessi (è per questo che in questo nuovo nazionalismo giocheranno un ruolo
fondamentale i sindacalisti rivoluzionari), nella direzione più consona al contesto in cui si vive:
come nazionalismo di minoranza all'insegna dell'irredentismo (nell'impero austro-ungarico e
ottomano, e in parte anche russo) ma soprattutto come nazionalismo della maggioranza, che ha il
diritto di escludere chi ritiene possa indebolire o infettare la nazione. La militarizzazione degli statinazione, concausa e conseguenza della guerra mondiale, è il risultato di una radicalizzazione
culturale che trova la confluenza di settori spesso agli antipodi della società (la burocrazia militare e
l'avanguardia artistica, il sindacalismo dell'azione diretta e i grandi cartelli industriali) e il consenso
di quelle classi medie che costituiscono l'ossatura fondamentale della nuova politica di massa.
0001000100 ‣ Guerra e rivoluzione.
Ma come è potuta scoppiare una guerra
in un'epoca storica decisamente pacifista?
(Robert Musil, 1922)
“Ci pare che mai un evento storico abbia distrutto in tal misura il così prezioso patrimonio comune
dell'umanità, turbato tante delle più lucide intelligenze, inabissato così profondamente tutto quanto
ci è di elevato”33. Non sono, queste, né le uniche né le più forti parole che Freud scrisse contro la
Prima guerra mondiale, ma certo non furono molti gli intellettuali di inizio secolo che seppero
esprimere fin dai primi mesi di guerra un giudizio così drastico e preoccupato sulle sorti comuni
dell'umanità. La maggior parte di loro, come si è ricordato in precedenza, reagì con entusiasmo alle
dichiarazioni di guerra dei propri governi. Tra questi, in realtà, non mancò chi vide nel conflitto il
crollo necessario e inevitabile di un mondo osservato già prima con critico disappunto, come ebbe
modo di fare notare Thomas Mann: “Perché l'artista, il soldato nell'artista, non avrebbe dovuto
lodare Dio per il crollo di un mondo di pace che egli non riusciva più, proprio più, a sopportare?
Guerra! Era una sacra purificazione, ciò che sentivamo, una liberazione e un'enorme speranza”34.
La guerra degli “appelli” che scrittori, artisti, scienziati e intellettuali dei diversi paesi appartenenti
ai due schieramenti produssero in modo parallelo a quella in corso più tragicamente sui campi di
battaglia e nelle trincee, non fu solamente la verifica che il mondo della cultura condivideva in
pieno i pregiudizi, le semplificazioni e l'indottrinamento dei loro meno acculturati concittadini;
permise, anche, di cogliere con quanta articolata sofisticatezza si potesse giustificare e auspicare la
loro morte in battaglia. Nel Aufruf an die Kulturwelt del 4 ottobre 1914, firmato da 93 personalità, e
dodici giorni più tardi in un nuovo manifesto redatto dal filologo classico Ulrich von Wilamowitz
Moellendorf e sottoscritto, questa volta, da ben quattromila cattedratici e accademici della
Germania, il militarismo tedesco era difeso come l'unica possibile garanzia contro l'annientamento
della cultura: “L'esercito e il popolo tedesco sono animati dallo stesso spirito, poiché sono un'unica
cosa. [...] Noi crediamo che il destino dell'intera cultura europea dipenda dalla vittoria che sta per
essere conquistata dal militarismo tedesco, il quale altro non è che l'espressione della disciplina,
della fedeltà al dovere e dello spirito di sacrificio del popolo tedesco, parte della sua unità e della
sua libertà”35. Inglesi, francesi e russi reagirono con manifesti altrettanto eloquenti, in cui la barbara
condotta delle operazioni militari da parte degli Imperi centrali faceva tutt'uno con i caratteri della
loro civiltà.
Era stato Kipling, del resto, a gettare il peso del suo recente premio Nobel nell'arena nazionalista
scrivendo a guerra appena scoppiata, nel 1914: “For all we have and are / For all our childrens' fate
/ Stand up and take the war / The Hun is at the gate”. In questa guerra letteraria sembra
stupefacente, quindi, che già nell'aprile 1915, al terzo intervento collettivo, un gruppo di oltre
settanta scrittori russi – tra cui Gor'kij, Blok, Sologub, A. Tolstoj, Bunin, Gippius – potessero dirsi
certi che “la malvagità abbandonerà il cuore degli uomini e il reciproco risentimento scomparirà
senza lasciare amarezza. Quando le pannocchie di granturco ondeggeranno sui campi che sono stati
scavati di trincee e innaffiati di sangue umano e i fiori copriranno i tumuli di terra, arriverà il
momento in cui i popoli divisi si riuniranno di nuovo sulla comune, ampia strada dell'umanità,
quando ritorneranno alle grandi parole universali”36.
Quell'ingenua fiducia dovette fare i conti, due anni dopo, con l'entusiasmo della “rivoluzione di
febbraio” e poi con l'angoscia e l'eccitazione che accompagnarono la presa bolscevica del potere. La
guerra iniziata in nome della Nazione si era trasformata in Rivoluzione, per adesso in un solo paese,
ma col rischio di contagiare e trascinarvi presto anche gli altri. È il connubio guerra-rivoluzione che
rende ancora più traumatica, nell'esperienza del XX secolo, la cesura della Prima guerra mondiale.
Quanto scrive Stefan Zweig (“D'un sol colpo la generazione del dopoguerra si era brutalmente
emancipata da tutto quanto fino ad allora era stato considerato autorevole, e gettata dietro alle spalle
ogni tradizione, aveva preso decisamente nelle sue mani il proprio destino, abbandonando il passato
e incamminandosi verso l'avvenire”37) e quanto ricorda Viktor Sklovskij (“L'aria della rivoluzione
era l'aria della nostra giovinezza. [...] Nascemmo in un'epoca borghese, ma fummo liberati dal
disinteresse della rivoluzione, fummo innalzati dal suo slancio e pensammo in modo nuovo”38)
fanno parte della stessa percezione dell'epoca, di uno stesso universo mentale che la guerra ha
diffuso superando i confini e le differenze nazionali. La rivoluzione, che venga vista come la
sconfitta e il capovolgimento del sacrificio nazionale o come l'avverarsi sia pure inatteso di una
palingenesi sociale e culturale auspicata, condivide con la guerra l'essere un momento di
azzeramento e di rottura con l'era precedente. Tranne che in Russia, tuttavia, essa non ha successo
perché le manca quella capacità di mobilitazione unitaria, oltre che totalizzante, che aveva
accompagnato la guerra. Dove potrebbe coinvolgere maggioritariamente le masse – come in
Germania – si divide sui metodi e sulle finalità e degenera in una guerra fratricida; altrove, come in
Italia, la retorica massimalista e la radicalizzazione degli obiettivi favorisce e surroga un isolamento
sociale che non era necessariamente scontato.
Per poter avere successo, e cioè raccogliere dietro di sé un largo fronte unitario, la rivoluzione
avrebbe dovuto – paradossalmente – essere democratica: ma non vi erano forze adeguate, all'epoca,
convinte culturalmente che fosse davvero la democrazia la priorità storica e capaci socialmente e
politicamente di agire di conseguenza. Solo a Weimar, in modi parziali e ambigui, si cercherà di
muoversi sulla strada della Costituzione e delle istituzioni democratiche, ma accanto a fallimenti
ripetuti di tentativi insurrezionali e putschisti mascherati o scambiati per ondate rivoluzionarie. Non
è un caso, e non solo per motivi di collocamento internazionale, che il wilsonismo non trovi in
Europa una sponda decisa in alcun schieramento politico. Il paradosso della rivoluzione è che essa
tende a dividere società frammentate e scollate dalla guerra che hanno bisogno di ritrovare
coesione, ma al tempo stesso sembra l'unica proposta capace di infondere nuovo slancio e speranza.
Anche il principio di autodeterminazione – una delle spine nel fianco del Trattato di Parigi insieme
alle riparazioni – accresce insicurezza e insoddisfazione per i confini, e verrà infatti abbandonato
anche da Wilson sotto la spinta di Robert Lansing che teme possa “creare problemi in diversi
territori”39. L'influenza delle grandi potenze, per quanto ridimensionata dalle nuove nazioni sorte
sulle spoglie degli imperi asburgico e ottomano, rimane fondamentale nel nuovo equilibrio europeo:
ma nessuna di esse è capace di dotarsi di un “progetto” che possa lasciare il segno nell'epoca. Le più
solide democrazie liberali – Gran Bretagna e Francia – non vogliono rinunciare al loro impero
coloniale e cercano di sfruttare il ruolo di vincitori difendendosi all'interno dalle richieste di
trasformazioni sociali e all'esterno chiudendosi, soprattutto la prima, in un sostanziale isolamento.
La rivoluzione, pur se per poco – meno di un biennio – rappresenta l'unica proposta dirompente che
può apparire adeguata alle attese e alle ansie della generazione uscita dalla guerra. L'universo
simbolico che l'accompagna affascina settori più ampi di quelli direttamente coinvolti dagli obiettivi
sociali che essa rivendica. La classe operaia rimane maggioritariamente ostile a un'avventura che si
presenta – la Russia insegna – come una dittatura giacobina non certo adatta alle esigenze di paesi
moderni e di istituzioni articolate e rappresentative. Come riassumerà uno degli interpreti più lucidi
del dopoguerra – John Maynard Keynes – il bolscevismo si presentava come “una religione e non
solamente un partito, e difatti Lenin è un Maometto, non un Bismarck”; era quindi difficile “per un
figlio colto e passabilmente intelligente dell'Europa trovare qui i suoi ideali, a meno che non abbia
sofferto qualche orrendo e strano processo di conversione che ha mutato tutti i suoi valori”40 e lo ha
indotto ad accettare il dottrinarismo e l'autoritarismo di quella esperienza. Secondo l'economista che
aveva messo inutilmente in guardia a Versailles sulle conseguenze catastrofiche che il Trattato di
Pace avrebbe avuto per l'Europa, “se il comunismo raggiungerà un certo successo economico non lo
raggiungerà per un miglioramento della tecnica economica, ma come religione. [...] Odiamo tanto il
comunismo come religione da esagerare la sua inefficienza economica; siamo così colpiti dalla sua
inefficienza economica che lo sottovalutiamo come religione”41.
La “religione” bolscevica continuerà a diffondersi, con crescente successo, nei successivi decenni;
ma non riuscirà mai, in Europa, a costruire un potenziale che potesse – nel suo insieme o in singoli
stati – portare alla conquista del potere. La solidità e l'ulteriore diffondersi dello stato-nazione,
infatti, “modellarono gli effetti economici e sociali della guerra in modo tale da bloccare ogni
movimento verso la rivoluzione politica”42.
Con il fallimento dell'ipotesi rivoluzionaria, riemerge nel dopoguerra il modello autoritario come
risposta generale alla modernizzazione: tanto negli stati appena costituitisi in modo indipendente
quanto nei paesi usciti sconfitti dalla guerra. La gestione nazionale, egoistica e particolaristica, delle
crisi economiche e finanziarie che si sovrappongono fino a quella assai più esplosiva del 1929,
rafforza la tendenza dirigista dei governi e l'intreccio degli apparati statali con settori rilevanti del
mondo industriale ed agrario. Lo sviluppo riprende con contraccolpi e lentezze in una logica di
progresso da cui è sostanzialmente esclusa la partecipazione democratica di massa. Questa, agli
occhi delle élites agrarie e dei comandi militari, di gran parte degli industriali e delle classi medie
impaurite per il conflitto sociale e la mancanza d'ordine, è percepita come una possibile anticamera
a una vittoria della rivoluzione che è ormai antistorico ipotizzare. Quasi tutti i paesi, e in modo
particolare quelli del sud e dell'est dell'Europa, vivono una crisi politica di transizione che è resa più
precaria dalla crisi militare che riemerge tra le due grandi potenze continentali sulla revisione degli
accordi di pace; ma che è esacerbata soprattutto da una crisi ideologica che fa emergere
ripetutamente la necessità o possibilità di una “terza via”, capace di governare la modernizzazione
eliminandone gli aspetti ritenuti meno desiderabili e più pericolosi.
Sono le condizioni storiche complessive dell'entre-deux-guerres e quelle particolari dei singoli
paesi a modellare le forme dei nuovi regimi politici, costretti in ogni caso ad assorbire elementi
diversi e a mantenere una fluidità più o meno lunga. L'Italia fascista e la Germania di Weimar sono
le risposte che emergono nel corso degli anni Venti, cui si affianca il contraddittorio esperimento
della Nuova Politica Economica in Russia. Negli anni Trenta queste esperienze sembreranno
trovare maggiori punti in comune, pur se tra le prime due e la terza si acuirà il contrasto
internazionale e la contrapposizione ideologica.
Si è cercato, soprattutto da parte dei testimoni dell'epoca, di individuare una sorta di legge comune
capace di spiegare il perché dell'avvento in alcuni paesi di regimi autoritari e dittatoriali di tipo
nuovo: “Che Italia, Germania e Russia rappresentino, in questo ordine, casi di rivoluzione totalitarie
sempre più complete, è strettamente determinato dalla struttura del tempo dei loro periodi
democratici. Il fascismo è favorito dal fatto che l'unificazione nazionale seguì di decenni il suo
periodo di repubblicanesimo liberale rivoluzionario, ed è ostacolato dal fatto che questo periodo era
strumentale a produrre l'unificazione nazionale. Il totalitarismo in Germania è più corposo del
fascismo in Italia perché l'unificazione nazionale arrivò come conseguenza della guerra prussiana
mentre il movimento liberal-repubblicano degli anni Quaranta non ebbe praticamente nessuna
influenza su questo evento. E la rivoluzione totalitaria in Russia è probabilmente la più completa
perché l'effettiva rivoluzione liberale ha preceduto quella comunista solo di pochi mesi”43.
Pur se ricca di suggestioni, questa interpretazione tende a sottovalutare il ruolo fondamentale che
svolse il contesto – internazionale e nazionale – entro cui si svilupparono vittoriosamente le
esperienze dei nuovi regimi dispotici di massa.
0001000100 ‣ I caratteri del dopoguerra.
La tolleranza della democrazia
verso la completa libertà per lo sviluppo
dell'opinione pubblica non implica l'approvazione
di movimenti che mirano all'oppressione dell'opinione
e quindi della democrazia stessa.
(Emil Lederer, 1934)
Gli anni Venti e Trenta, l'epoca dell'entre-deux-guerres, sembrano irriducibili a una definizione
comune soddisfacente, valida per le esperienze totalitarie come per le società democratiche, per i
regimi fascisti come per quelli parlamentari. Proprio il contesto generale della crisi – una crisi
internazionale con risposte nazionali profondamente differenziate – sembra rappresentare l'unico
punto di riferimento ragionevole per comprendere un periodo in cui la crisi del liberalismo e la
nascita dei fascismi sono, comunque, l'elemento di primaria importanza. L'entre-deux-guerres si
consuma tra la vittoria della Rivoluzione russa con i suoi effetti internazionali e lo scatenamento
della guerra da parte del nazismo. Parlare di “età dei totalitarismi”, come è stato fatto più volte, è
quindi certamente legittimo, anche se rischia di oscurare il carattere prolungato di una crisi che, con
la vittoria del nazismo, cambia direzione e velocità ma continua a suscitare in Europa tensioni
disomogenee, risposte contraddittorie, strategie differenziate.
Il culto della violenza e il ricorso alla guerra, anche se contrastati con intensità e passione,
rappresentano un lascito ineliminabile del primo conflitto mondiale e degli intrecci rivoluzionari
che seguono, e tale lascito segnerà l'intera epoca tanto nelle sue formulazioni aggressive quanto
nelle sue risposte difensive o impotenti. Il mito della nazione, malgrado la nazione sia uscita a pezzi
dalle trincee di tutta Europa, troverà una nuova e più radicale stagione di diffusione continentale
sotto forma di progetti universalistici ambiziosi e folli o di chiusure provinciali e narcisistiche
attorno a una tradizione (liberale o repubblicana) mai coerentemente e compiutamente democratica.
La contrapposizione di stati-nazione aveva condotto alla guerra europea; la divisione in statinazione (ancora più numerosi) dopo la pace rende difficile un esito rivoluzionario della crisi, che
viene percepita come “nazionale” quasi in ogni stato, soprattutto per la diversa scansione temporale
degli effetti economici e sociali della guerra. Sono i fattori politici ad essere sempre più decisivi,
perché le diverse politiche nazionali offrono una soluzione diversificata della crisi. Nel corso degli
anni Venti sono i regimi capitalistici più periferici o meno stabilmente modernizzati a essere
soggetti a crisi di regime (e l'Italia rappresenta il più “avanzato” tra questi paesi periferici). Con la
crisi del 1929-32 – più “normale” per molti aspetti, ma assai più profonda e destabilizzante per la
sua intensità e ramificazione internazionale – anche la Germania seguirà quel modello,
manifestando una sorta di “eccezionalismo” che verrà visto, successivamente, come componente
decisiva e prevalente dell'intero periodo. Il terreno su cui si misura la crisi è, prevalentemente,
quello delle istituzioni: delle risposte che danno e delle trasformazioni che subiscono, sotto la spinta
di contrapposizioni ideologiche crescenti e di frammentazioni politiche che colpiscono soprattutto
l'appartenenza elettorale delle classi medie. La perdita di centralità dei parlamenti gioca sempre più
a favore di interessi organizzati attorno a forme politiche extraparlamentari, sottratte a regole e
trasparenza che inquinano complessivamente la moralità della sfera pubblica44. Un capitalismo
ormai ampiamente mondializzato – pur con la brusca frenata della guerra e la ripresa ambigua e
differenziata del dopoguerra – viene gestito negli stati-nazione europei con una forte connotazione
locale; le istituzioni pubbliche (le agenzie dello stato, le burocrazie, i partiti e sindacati)
circoscrivono la loro azione nell'ambito della sovranità statale, contribuendo a spostare l'attenzione
e l'interesse collettivo sugli antagonismi, anche economici, a carattere nazionale. È proprio la
diversità della risposta e della tenuta istituzionale a segnare il terreno dove la crisi politica si può
trasformare o no in spazi per nuovi regimi e nuove organizzazioni dello stato.
L'Europa liberal-democratica, dove il liberalismo non è tanto un'ideologia ma l'istituzionalizzazione
di norme e valori condivisi e dove la democrazia si articola in agenzie politiche di partecipazione, si
dimostra capace di controllare la mobilitazione sociale e gli ondeggiamenti elettorali del
dopoguerra. Sono le istituzioni parlamentari – legittimate dalla tradizione e da un consenso messo
in discussione solo da piccole minoranze – a governare il conflitto; e i partiti di massa sono gli eredi
(per confluenza o per rinnovamento) delle élites che avevano in mano gli stati anche
precedentemente alla guerra. Che di questa Europa facciano parte i due maggiori paesi vincitori del
conflitto, la Gran Bretagna e la Francia, sembra una garanzia per il futuro che rimane ambigua e
irrisolta. Un'altra metà dell'Europa, infatti, si caratterizza per una deriva autoritaria che, in forme
diverse, racchiuderà nell'entre-deux-guerres la maggioranza dei “nuovi” stati, le regioni centroorientale e meridionale del continente, la penisola iberica. Cosa divide queste due Europe diverse,
soggette allo stesso contesto internazionale? Risposte differenti alla medesima crisi o una crisi che
si articola e si declina per aree e per stati?
La crisi – o, meglio, la combinazione delle crisi (economica, politica, ideologica, sociale, militare) –
appare necessaria per produrre una radicale trasformazione istituzionale, ma si dimostra sufficiente
soltanto nelle aree regionali indicate, che rappresentano, con alcune eccezioni, i paesi sviluppatisi
più tardi sia sul terreno economico del capitalismo sia su quello politico del parlamentarismo, sia
sul piano della creazione dello stato-nazione. È in questi che potremmo chiamare, con una
terminologia di fine Novecento, stati di transizione, che i partiti trovano maggiore difficoltà a
proporsi come collettori di istanze unitarie e universali; che le istituzioni non riescono a superare il
loro carattere duale e antagonista (ad esempio tra parlamento ed esecutivo, tra forze armate e
parlamento, tra notabili e partiti); che lo stato non riesce a controllare e incanalare le ideologie di
mobilitazione e conflitto che accompagnano l'allargamento del suffragio. Il fascino
dell'autoritarismo, intrecciato strettamente col nazionalismo, non si manifesta tanto sul versante
economico e sociale ma su quello politico e ideologico. Le risposte concrete alla crisi sono
generiche, interclassiste, demagogiche e fondate su valori più che su politiche. Ci si rivolge con
particolare attenzione (blandendoli o favorendone la nascita) ai movimenti giovanili, spesso
paramilitari e aggressivi, capaci di rappresentare agenzie di socializzazione tanto per chi è fornito di
un'educazione medio-superiore (e cerca il connubio tra i valori della modernità e la morale della
tradizione) quanto per i declassati, gli sbandati, coloro che sono soggetti a una rapida
proletarizzazione o emarginazione socio-culturale. La violenza è l'eredità più forte e traumatica che
la guerra ha lasciato, un connotato al tempo stesso culturale e comportamentale che viene sempre
più vissuto come naturale e necessario. È l'esperienza terribile e in parte incomunicabile della
guerra al fronte che può rappresentare il punto di partenza per la rifondazione morale della società:
legando in un patto non esplicitato la generazione delle trincee che ha stabilito in qualche modo –
sotto le “tempeste d'acciaio” di cui parla Ernst Jünger45 – di non accettare più dopo la guerra il
ritorno della società prebellica.
Il rifiuto di una concezione di classe spinge a tralasciare il cuore del conflitto tra capitale e lavoro in
un'ottica di suo superamento che trova il consenso soprattutto delle classi medie, di chi guarda con
paura o fastidio alle lotte sociali, dei marginali e degli sradicati ma anche degli opportunisti, dei
carrieristi, di chi intende muoversi in modo dinamico sul terreno della promozione sociale. Il
richiamo costante alla sacralità dello stato-nazione – e il contemporaneo etichettare i suoi avversari
come nemici e traditori – trova un fecondo ascolto tra i veterani e gli impiegati, i maestri e i
lavoratori del settore pubblico. I movimenti fascisti saranno quelli maggiormente capaci – in Italia
all'inizio degli anni Venti e in Germania all'inizio degli anni Trenta – a rivolgersi a queste moderne
constituencies e a coinvolgere così, accanto ai militanti, ampi strati di popolazione irrequieta e
impaurita pronta a dare fiducia a un qualsivoglia progetto autoritario vincente. La retorica
nazionalista, radicalizzata e modernizzata, differenziata per gruppi sociali e unificata attorno al
richiamo all'orgoglio di una nuova identità collettiva, si presenta con un connotato generale che
manca, paradossalmente, ai movimenti socialisti e comunisti che proprio sui valori universali si
fondano, ma rivolgono solo alla classe operaia la loro azione di penetrazione e propaganda sulla
soluzione socio-economica della crisi, dopo avere fallito l'assalto rivoluzionario al potere politico.
La deriva autoritaria dell'entre-deux-guerres è stata spesso vista come un risultato della crisi della
democrazia liberale. Se si escludono l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista – su cui si
tornerà più avanti – sarebbe più giusto, in realtà, parlare di crisi di stati semiliberali o semiautoritari,
in transizione verso una pienezza di democrazia parlamentare e di stato-nazione spesso ai suoi
albori. L'eredità della guerra e il contesto presente della crisi economica spingono questi stati di
transizione a mantenere sul terreno del nazionalismo, dopo la mobilitazione per l'indipendenza e
l'unità della patria, anche la dialettica del periodo di costruzione parlamentare, con grave detrimento
per il livello di democrazia delle nuove istituzioni.
La nuova Europa centro-orientale, che emerge dal vuoto lasciato dalla fine degli imperi, sembra
indecisa se seguire la strada della modernizzazione occidentale (il modello prescelto almeno fino
alla guerra mondiale) o se mettere sotto accusa i valori su cui essa era cresciuta, in particolar modo
la democrazia politica e il liberismo economico. Resta solo, tra i cardini del modello europeo, lo
stato-nazione, impoverito però dallo svuotamento politico ed economico e legittimato da una forte
accentuazione della sua identità ideologico-culturale. Quest'ultima si caratterizza con un
atteggiamento (psicologico e legislativo, normativo e istituzionale) di contenimento o
emarginazione delle robuste minoranze nazionali (circa il 30%) che sono presenti in Cecoslovacchia
e Romania, Jugoslavia e Polonia come eredità degli imperi multinazionali.
Dove la modernizzazione era avvenuta più lentamente, lo stato nazionale aveva una storia lontana e
le istituzioni parlamentari si erano radicate e intrecciate con le nuove agenzie di socializzazione e
costruzione della cittadinanza cui avevano dato luogo tra Ottocento e Novecento, la crisi dello stato
liberale si risolve con una trasformazione di cui esso stesso è il protagonista, senza crollare e offrire
spazio a regimi di tipo fascista o autoritario. È quanto accade con maggiore stabilità in Gran
Bretagna, nei Paesi Bassi e nelle regioni scandinave, ma anche in Francia, seppure con maggiori
ostacoli e tentennamenti. Manca, in generale, la percezione di quel bisogno “comunitario” su cui
fanno leva le nuove ideologie nazionaliste radicali, ed è ambigua la capacità di rispondere in modo
positivo e dinamico alle richieste di partecipazione politica delle masse. Sono le istituzioni, infatti,
che si dimostrano capaci di mitigare l'alienazione e atomizzazione individuale e di neutralizzare le
sirene di nuove utopie comunitarie di stampo nazionalista o razzista. Non è certo una saldezza
apparente, anche se l'educazione imperiale britannica e la pedagogia repubblicana francese, per fare
un solo esempio istituzionale, non sembrano mantenere lo stesso fascino e capacità di mobilitazione
che avevano nell'anteguerra. La “visione della società” delle democrazie parlamentari tra le due
guerre, pur sottoposta a tensioni molteplici perché incapace di riassumere le nuove dimensioni della
realtà postbellica e le nuove richieste e bisogni dei cittadini, sembra reggere all'interno; ma è
incapace di svolgere un ruolo di propagazione sul terreno internazionale, di proporre un'alternativa
o di frapporre ostacoli alla demolizione delle istituzioni liberali nei paesi vicini.
Dove il consumo di esperienze sembra andare di pari passo, o ancora più rapidamente, del consumo
delle nuove merci e dei beni disponibili sul mercato, è senza dubbio la Germania di Weimar e le
aree limitrofe della Mitteleuropa. Qui lo stato sembra impossibilitato a divenire l'effettivo garante di
un compromesso sociale tra le classi, che si trascina ambiguamente per oltre un decennio; e risulta
impotente a rispondere alle diverse esigenze di sicurezza (economica, sociale, politica, culturale) e
di ordine che i diversi segmenti della società avanzano e rivendicano. Nella concezione dei padri
della Costituzione di Weimar, lo stato rappresenta una forma democratica di potere, l'unità
organizzativa per dare efficacia pubblica alle decisioni prese; e la politica è l'uso di questa efficacia
per fini comuni, per attuare la concezione di valori condivisi all'interno di un ordine istituzionale.
Legittimazione e consenso, nella cornice weimariana, si rincorrono e intrecciano; la prima non ha
luogo senza il secondo, ma se si fonda solo su esso (inteso come indicatore di successo) rischia di
accantonare quella parte di legittimazione fondata sulla contrattazione e sul compromesso, sulle
intese e sui risultati delle battaglie sociali e delle lotte economiche, quel processo di integrazione
popolare che si svolge sul lungo periodo. La legittimazione del potere, che si fonda su una legalità
impersonale, viene erosa a vantaggio della credenza in valori nuovi o tradizionali e della fiducia
crescente in un'autorità carismatica, su cui si gioca la battaglia ideologica nella Germania di
Weimar. L'ideologia, così, diventa il surrogato e il sostituto della legittimazione; e la politica perde
progressivamente le sue funzioni di regolazione (che permette ad attori diversi di proporre opzioni e
soluzioni differenti entro la cornice unitaria sancita dalla costituzione) e di integrazione (intesa
come l'insieme delle agenzie, dei provvedimenti e della cultura capace di rendere coesa la società).
La capacità di svolgere un ruolo di guida per l'integrazione dei cittadini, non si può manifestare solo
nelle procedure per individuare la volontà razionale e i processi decisionali, ma deve concretizzarsi
in una rappresentazione simbolica dei valori condivisi della comunità. Per quanto articolata e
moderna, la Costituzione di Weimar non riesce a svolgere questo compito, che le forze politiche
repubblicane tendono a sottovalutare, come fanno con la ricerca di un programma unitario sul
terreno sociale e di una sintesi di valori comuni sul versante simbolico. Il semplice richiamo alla
democrazia e alle sue regole – senza che essa stessa diventi, in qualche modo, la spinta emotiva alla
propria affermazione come collante valoriale e simbolico della comunità – non funziona soprattutto
perché i partiti di Weimar la usano, strumentalmente e proceduralmente, per affermare la propria
forza e presenza in un sistema politico ritenuto solido, che non a caso criticano senza timore di
delegittimarlo. L'intreccio che i movimenti fascisti compiono tra l'azione (la forma primaria di
identità e organizzazione che offrono ai propri militanti) e la nazione (il contenitore dei valori
comuni su cui si cerca il consenso astratto ed emotivo dei cittadini), permette di stabilire – in forme
certo rozze ma efficaci – una sorta di Weltanschauung capace di dare un senso generale all'epoca, ai
suoi problemi e alle richieste di superarli, di offrire consolazione e riscatto come era compito in
passato delle religioni. Il diffuso paramilitarismo di stampo nazionalista che il fascismo sussume e
rinnova, costruisce attorno alla violenza una nuova cultura politica, che si legittima col costante
richiamo alla guerra e alla sua esperienza rigeneratrice, adesso, anche per una “nuova” politica.
Come mai questa dinamica riesce a manifestarsi e a prevalere, in forme diverse e a un decennio di
distanza, solo in Italia e Germania? Non per motivi economici e sociali, tanto diverso è il grado di
sviluppo capitalistico e il contesto di crisi in cui hanno luogo la vittoria politica di Mussolini e di
Hitler, anche se quella cornice favorisce fortemente quell'esito. Né solo per una forza ideologica che
anche altrove si cerca, però, di imitare e importare in momenti diversi. Se non ci si vuole risolvere
ad una spiegazione personalistica – pur senza sottovalutare l'enorme ruolo svolto dalle figure
carismatiche del duce e del führer – non si può che tornare alla dimensione istituzionale e politica
della crisi: la prima capace di dare conto delle debolezze e contraddizioni che si sono coagulate nel
medio periodo e che la rottura della guerra e l'esito del dopoguerra hanno radicalizzato e accentuato;
la seconda di spiegare, tra altri ugualmente possibili, perché proprio quello fu l'esito di una crisi
maturata nel giro di pochi anni e precipitata in pochi mesi. Anche se l'esito di affidare alla politica il
ruolo di imporre un'ideologia dai connotati fortemente emotivi e irrazionali in una visione
organicistica della comunità e delle istituzioni si è storicamente risolta in una tragedia, quella
proposta ha avuto successo in una fase adolescenziale o giovanile della società di massa, in stati
solo recentemente e parzialmente democratici, in un'Europa segnata dal trauma del conflitto
mondiale e alla difficile ricerca di una uscita dalla crisi del dopoguerra. È probabilmente
nell'articolazione delle risposte istituzionali e politiche date in Italia e in Germania al contesto di
quella crisi che si possono individuare i motivi e le tappe che hanno reso l'opzione fascista
particolarmente attraente e capace di imporsi.
0001000100 ‣ La dinamica della crisi.
La democrazia non è una Repubblica davvero
amata, né mai lo sarà. Ma è meno odiosa
di altre forme contemporanee di governo, ed entro
questo limite merita il nostro appoggio.
(Edward M. Forster, 1938)
Dove le istituzioni parlamentari e liberali sono più recenti e meno radicate, la guerra ha lasciato
un'eredità più profonda, perché non è stata metabolizzata in modo unitario e partecipe. Dove la
guerra è stata perduta, o dove la vittoria viene percepita come “mutilata” o inutile, il peso del
conflitto perdura negli anni del dopoguerra informando di sé la battaglia politica e diventando un
momento centrale di quella ideologica. Non sono i risultati e neppure le cause che hanno portato
alla carneficina del 1914-18 a essere poste al centro del dibattito pubblico: ma l'esperienza in sé. Il
significato della guerra s'identifica con l'esaltazione della nazione e chi mette in discussione
quest'ultima diventa responsabile o della “pugnalata alle spalle” che ha favorito la sconfitta militare
o del sacrificio inutile perché svenduto alla Conferenza di pace. La mobilitazione nazionalista
ingloba tra i suoi avversari tanto il pacifismo wilsoniano quanto il socialismo, poco importa se in
versione riformista o massimalista. L'avventura dannunziana di Fiume sembra, da questo punto di
vista, esemplare. La partecipazione di forze sociali e culturali eterogenee, attratte tanto dal
nazionalismo e dall'irredentismo quanto dal desiderio d'avventura e dall'incapacità a rientrare nel
mondo della pace, vede in controcanto l'attesa ambigua e sospettosa di Mussolini e l'interessata
contrapposizione del governo Giolitti. I socialisti sono al tempo stesso vittime di un conflitto civile
che tende a considerarli estranei alla nazione, e responsabili di una guerra politica interna al
proletariato che lo rende diviso, indebolito, incapace di proporsi come guida del paese e dello stato.
È un conflitto che in Italia assume sembianze violente nella prima versione, in Germania nella
seconda: in un caso indebolendo la possibilità di reagire all'ascesa al potere del fascismo, nell'altro
la capacità di gestire la propria autorità nel governo e nelle istituzioni statali.
La crisi liberale, in Italia, si manifesta prevalentemente come distruzione di una sfera pubblica
appena abbozzata, come incapacità della società borghese di darsi autonomia e fiducia attorno a
valori che non siano quelli delle classi medie e della burocrazia, del modernismo reazionario delle
professioni o del conservatorismo sociale e culturale del mondo agrario. La democrazia, non a caso,
è un valore rivendicato e difeso da pochi, contro cui si scatena la propaganda e la mobilitazione di
nazionalisti e socialisti, di radicali e comunisti, e verso cui prendono le distanze sia i liberali
conservatori che quelli reazionari. Il fascismo incoraggia e riassume queste spinte offrendone una
versione giovanile, aggressiva e arrogante, in cui l'azione, con i suoi connotati ineliminabili di
violenza, è l'antidoto al disfattismo e diventa essa stessa cardine di una nuova ideologia nazionale.
Nella repubblica di Weimar quelle spinte, che sono minoritarie nel nuovo sistema politico ma
allignano nell'apparato statale e istituzionale, vengono considerate dalla socialdemocrazia al potere
un residuato bellico destinato a scomparire. La tenuta di Weimar, infatti, è prevalentemente frutto di
un compromesso sociale e di continue alchimie politiche, non di un vero patto costituzionale capace
di affondare sempre più le radici della democrazia e di farne il valore reale e la rappresentazione
simbolica della nuova Germania. L'azione della socialdemocrazia, pur orientata all'accordo e al
rispetto di regole vincolanti, viene percepita come un progetto di parte; ed è incapace di presentarlo
e trasformarlo in una sintesi di valori che possano – in un momento di crisi – diventare il nucleo
politico e il cuore simbolico dell'intera comunità.
Nella crisi del dopoguerra, il bisogno di totalità che accompagna la modernità diventa ancora più
forte, e si connota dei tratti ereditati dalla guerra: gerarchia e cameratismo, immagine del capo e
fascino dell'istituzione totale, elitismo e disprezzo delle masse, voglia di potere e disumanizzazione
dell'avversario. È su queste linee che si crea l'organizzazione politica e paramilitare del fascismo,
che fa della glorificazione della violenza – democratizzata dalla guerra – uno dei suoi tratti
maggiormente distintivi. L'intreccio tra il nazionalismo organico e il radicalismo politico avviene in
una dimensione di lotta (contro i valori amorali e decadenti dell'individuo, della democrazia e del
mercato) e di esaltazione simbolica (della patria-nazione in Italia e dell'unità völkisch in Germania).
Anche se il fascismo privilegia l'immedesimazione nello stato e il nazismo l'identità razziale, è il
nazionalismo a offrire a entrambi il terreno di mobilitazione e consenso, che i due movimenti
radicalizzano con la trasformazione della politica in attivismo, dal forte contenuto emotivo. Pur
nella loro diversità, fascismo e nazionalsocialismo propongono un modello di politica che presume
di trascendere il conflitto sociale e l'alternativa liberalismo-socialismo, e cioè gli aspetti
maggiormente visibili della crisi in atto. Il modello integrativo o corporativo, fondato su una
radicale repressione preventiva, propone un'idea di uomo-massa liberato all'apparenza
dall'isolamento e dall'alienazione della società liberale-industriale. Il culto dell'azione popolarizza
questo modello, tende a farne un'organizzazione dal basso, dove la violenza è presentata come
difensiva e vittoriosa ma può rivolgersi aggressivamente contro i propri nemici, legittimata e
sacralizzata dal richiamo allo Stato e alla Nazione.
Quali sono gli strati e i gruppi sociali attratti da questo insieme fumoso e retorico di proposte
politiche, in cui – per restare al programma dei “fasci di combattimento” del 1919 – obiettivi
fortemente progressisti (suffragio universale anche femminile, otto ore lavorative, tassazione
fortemente progressiva, confisca delle proprietà religiose) vengono declinati con linguaggio
nazionalista, antidemocratico e antidisfattista? Sono la piccola borghesia di cui parlava Luigi
Salvatorelli nel 192346; le classi medie che “stavano progressivamente smarrendo le già scarse
connotazioni di classe ereditate dall'Ottocento, ed erano sospinte dai processi strutturali verso una
collocazione sociale ambigua”47; la folla composita di falliti, emarginati, ambiziosi, che cercano una
contropartita psicologica “autoritaria” alla crisi della famiglia e all'invadenza della “nuova” donna.
Accanto a essi ci sono quegli strati professionali (architetti, medici, ingegneri, urbanisti, statistici) in
cui “si fa strada l'illusione che la ``mano forte'' del fascismo avrebbe favorito – di contro al superato
modello classista di un conflitto ``a somma zero'' tra ceti inferiori e superiori – l'espandersi dal
centro alla periferia, dall'alto verso il basso, di un'opera di modernizzazione urbana già avviata, in
genere su sollecitazione dei socialisti e dei cattolici, in alcuni grandi e medi comuni”48. E ci sono
coloro che temono la minaccia sociale e culturale del bolscevismo, tutti quelli che pensano di potere
usare il fascismo come strumento indiretto per le proprie finalità economiche e politiche.
Non vi è una corrispondenza chiara e meccanica tra ideologia e base sociale, e l'identità sociale, del
resto, sempre meno nella società moderna viene data unicamente dalla classe d'appartenenza. Il
rivolgersi ai gruppi sociali che oscillano inquieti tra il capitale e il lavoro, infastiditi e impauriti
dalla lotta di classe, offrendo loro un programma “culturale” e non sociale, che legittima le proprie
idiosincrasie come i propri comportamenti violenti, rappresenta la vittoria di un'ideologia che è
totalizzante e si rifiuta di declinare e precisare i propri contenuti. Il nazionalismo antisocialista
riesce a imporsi nel dopoguerra perché si presenta come ribellione generazionale verso gli aspetti
del liberalismo cui vengono imputate la sconfitta in guerra e la pace punitiva o mutilata: razionalità,
tolleranza, diversità. La percezione del pericolo rivoluzionario, enfatizzata dal radicalismo
nazionalista, è in realtà condivisa e spesso gestita in prima persona dalle istituzioni statali e non
(polizia, magistratura, esercito, Chiesa) che ritenevano il socialismo la più pericolosa forza antisistema dell'epoca storica pre e post-bellica. Il fallimento internazionale nella repressione del
bolscevismo russo, mantiene vivo il timore del socialismo anche quando gli scoppi rivoluzionari si
sono ormai esauriti o sono stati sconfitti, offrendo così ai movimenti fascisti “una riserva di
integrazione socio-politica negativa potente e facile da manipolare”49.
I movimenti fascisti si presentano come alleati dello stato nel combattere i suoi nemici e come
demolitori dello stato per la sua incapacità a offrire soluzioni adeguate ai bisogni delle masse,
intrecciando un utopismo rivoluzionario anticonservatore con una funzione pubblica di
preservazione del sistema nel suo complesso. È una contraddizione che, lungi dal penalizzare
elettoralmente per la sua contraddittorietà, sembra invece pagare anche sul terreno del consenso, pur
in contesti differenti. Era un'epoca – ricorderà Stefan Zweig – “di fervidi entusiasmi e di frodi, un
misto di impazienza e di fanatismo. Era un periodo aureo per tutto ciò che fosse stravagante e
incontrollabile: teosofia, occultismo, spiritismo, sonnambulismo, antroposofia, chiromanzia,
grafologia, misticismo, paracelsismo. Tutto ciò che permettesse sensazioni più intense di quelle
provate fino ad allora, ogni genere di stupefacenti, morfina, cocaina, eroina trovava facile smercio;
l'incesto e il parricidio nel teatro, il comunismo e il fascismo nella politica rappresentavano gli unici
argomenti desiderati; bandita nel modo più assoluto era invece qualsiasi forma di normalità e di
misura”50.
Gli elementi descritti da Zweig erano presenti, in misura più ridotta e circoscritta, anche nell'epoca
prebellica, dove costituivano il versante irrazionale di una cultura fondata sull'idea di progresso.
Adesso, dopo la “follia” della Grande guerra (“Una sola cosa è chiara – aveva scritto Maksim
Gor'kij il 2 agosto 1914 – sta iniziando il primo atto di una tragedia universale”51) rappresentano un
terreno che aspira a sostituire quella ragione fallita tragicamente. In misura crescente, del resto, la
cultura di massa è diventata parte integrante della vita quotidiana postbellica; e di quella cultura
l'immagine – con la sua dirompente carica emotiva – è momento sempre più preponderante. Le
ideologie e le culture di massa, e l'intreccio che si opera tra esse, sono il tentativo di accentuare ma
anche istituzionalizzare la vita emotiva collettiva. Nel percorso ormai ampiamente riconosciuto di
estetizzazione della politica nell'entre-deux-guerres, un ruolo cruciale è affidato al contagio
emotivo della politica, che perde progressivamente la sua dimensione di mediazione critica a
vantaggio di reazioni identitarie fondate sull'azione.
Se si osserva attraverso questa lente la diffusione delle pratiche di commemorazione e il culto dei
morti in battaglia (glorificazione ed esorcizzazione del trauma della Grande guerra), la ricerca del
capo carismatico capace di incarnare il mito collettivo prevalente (la nazione, la razza, la classe, lo
stato), l'esaltazione del corpo dopo la sua brutalizzazione e mutilazione bellica, le forme di
superstizione legittimate dalla Chiesa come esperienze mistiche (è il caso paradigmatico di
Lourdes), si comprende come l'emozione possa inserirsi con una spinta formidabile nella
partecipazione collettiva. In un'epoca che ha raggiunto la modernità e che vive un discorso – si
pensi al cinema e alla pittura, alla fotografia e al teatro, al varietà e al fotogiornalismo – in cui è
l'immagine a riassumere spesso il significato, ad alludere il senso, a suggerire analogie e richiami.
L'emotività diventa, al tempo stesso, surrogato e supporto all'azione, unificando in tal modo le
avanguardie attive e le masse in attesa, e salvaguardando l'identità individuale pur all'interno di una
deriva collettiva. Questo ingresso dell'emotività non ha ancora una sua legittimazione scientifica
(che rifiuta di prenderla in considerazione) né un riconoscimento sociale (rimane un atteggiamento
“femminile”), e può quindi manifestarsi soltanto in forme ideologicamente forti e organizzate
(gruppi giovanili maschili) che incarnano la speranza collettiva non con modalità razionali e
pragmatiche ma in forme mitico-utopiche.
Non è un caso, forse, che uno degli scrittori più lucidi dell'epoca, Robert Musil, cercasse di far
coesistere la conoscenza emotiva e la conoscenza scientifica, pur senza riuscire a convincersi di
questa possibilità: “Manchiamo dei concetti per assorbire quanto abbiamo sperimentato; o forse
manchiamo dei sentimenti il cui magnetismo metta in moto i concetti”52. È su questa base, di
accettazione della complessità, irregolarità e imperfezione del mondo, che la psicoanalisi diventa
una componente sempre più centrale del panorama culturale dell'entre -deux-guerres : infatti, “da
una parte essa scavò la strada verso un mondo interiore e liberò il processo primario del pensiero
senza cui la razionalizzazione sarebbe rimasta esterna; dall'altra divenne una parte stabile
dell'organizzazione sociale, aiutando a incorporare la vita personale e la sessualità nella struttura
stessa di progettazione e ordine”53.
Benché gli studi di genere e di storia delle donne abbiano affrontato con crescente attenzione questi
anni, ancora manca una convincente interpretazione del ruolo svolto dal processo di emancipazione
femminile e di ridislocazione del ruolo delle donne durante e dopo la Grande guerra. Una volta
raggiunto il suffragio, le donne si orientarono maggiormente al raggiungimento di libertà personale
e sessuale e a una crescente autonomia sia dentro sia fuori la famiglia, ottenendo probabilmente un
successo più elevato – a livello di élites almeno – sul terreno culturale che su quello economico e
sociale; e provocando in tal modo una forte reazione difensiva del mondo maschile, soprattutto
dove la gerarchia dei ruoli sessuali e la subordinazione sociale e culturale della donna era più
radicata. In gran parte d'Europa, agli occhi dei veterani e della maggioranza dei cittadini, le donne
“moderne” emerse dal conflitto mondiale apparivano “come un miscuglio di desiderio appena
soppresso e di profondo risentimento per la loro irraggiungibilità, e di fiducia in se stesse”54.
L'insistenza sui valori “maschili” di coraggio e disciplina da parte dei movimenti nazionalisti e
fascisti, attrae l'elettorato conservatore: che vede come una minaccia alla propria esistenza e ai
propri privilegi l'avanzata della democrazia sotto l'aspetto di miglioramenti per gli operai, le donne,
le minoranze nazionali. La tragedia del liberalismo – frutto della sua incapacità a confrontarsi con la
modernità di massa – fu invece quella di deludere quegli stessi settori della società che percepirono
la democrazia prevalentemente come sola concessione del voto, orientandosi così in molti casi
verso il richiamo socialista e comunista a un capovolgimento graduale o rivoluzionario dell'assetto
sociale.
All'interno del mondo liberal-conservatore, reazionario o autoritario, la concezione della donna è
assai simile soprattutto nella difesa della famiglia, nel rafforzamento della componente religiosoeducativa, nel ruolo domestico e culturalmente non autonomo in cui la si vuole mantenere. Su
questo terreno, per fare un esempio particolare ma significativo, i programmi dei due grandi
contendenti per l'egemonia politica in Polonia – la coalizione dei “senza partito” di Pilsudsky e il
Partito nazionale democratico di Dmowski – sono assolutamente identici. Più difficile è identificare
quale fu la strategia del fascismo e del nazionalsocialismo, tanto nella logica di conquistare adesioni
prima della conquista del potere, quanto nel rafforzare il consenso femminile durante gli anni del
regime. Di sicuro l'idealizzazione della madre casta in costume contadino convisse, nel nazismo,
con l'incoraggiamento della maternità anche per le singole madri55. Di certo il fascismo valorizza la
famiglia come fulcro della Nazione (e lo stesso fa il nazismo rispetto alla Razza), non tanto come
valore conservatore-religioso: “Immagini femminili erano usate per rappresentare gli ideali per cui
gli uomini lottavano: i veterani avevano fatto la guerra nel nome delle loro mogli e figli, così come i
fascisti difendevano le donne e i bambini contro gli ebrei e i comunisti (entrambi dipinti spesso
come violentatori)”56. Da parte del fascismo e del nazismo, i cui strumenti per il potere sono i partiti
di massa, vi è la necessità di incorporare anche le donne nella mobilitazione popolare,
organizzandole dentro le proprie istituzioni in cui possono agire con una limitata autonomia che è
tuttavia compatibile “con un più sfumato atteggiamento verso le richieste specifiche avanzate dalle
diverse componenti del movimento delle donne”57. Anche rispetto alle donne, il fascismo si rivolge
all'insieme della società, cercando di reclutare da mondi femminili diversi e magari contraddittori,
inserendo tanto il radicalismo egualitario quanto il conservatorismo o il riformismo familista entro
l'orizzonte di una Nazione definita in termini populisti.
0001000100 ‣ La rivoluzione italiana e la crisi di Weimar.
L'odio esplose improvvisamente,
senza avviso, dal nulla.
(Christopher Isherwood, 1934)
Tanto la crisi italiana quanto, dieci anni più tardi, quella tedesca, non avevano come unico sbocco
possibile la soluzione fascista e nazionalsocialista. Alle indubbie capacità tattiche mostrate sia da
Mussolini sia da Hitler nei mesi e nei momenti più acuti delle crisi, vanno aggiunte la
sottovalutazione profonda e la convinzione di potere manovrare questi nuovi movimenti da parte
delle forze conservatrici tradizionali, tanto politiche che militari.
In poco più di tre anni i “fasci di combattimento” creati da Mussolini nel marzo 1919 mettendo
insieme nazionalisti e sindacalisti, antiparlamentari e rivoluzionari, conquistano il potere dopo avere
assunto una sempre più netta fisionomia nazionalista e antisocialista. La trasformazione in Partito
nazionale fascista, al terzo congresso del movimento nel novembre 1921, consacra una formazione
che è di massa per il numero degli iscritti (oltre trecentomila) più ancora che per il consenso
elettorale acquisito (35 deputati dentro il Blocco Nazionale nel maggio dello stesso anno). Ma è la
duttilità ad adattarsi alle condizioni della lotta politica (di piazza e parlamentare) che fanno del
fascismo un elemento sempre più centrale della vita politica italiana: braccio della repressione
sociale antisocialista e auspice, in nome dell'ordine, della pacificazione politica con i socialisti;
squadrismo diffuso contro il sovversivismo “rosso” e alleanza con Giolitti; reducismo nazionalista e
disimpegno nell'avventura dannunziana di Fiume; radicalismo repubblicano e legalismo
monarchico.
L'ambivalenza – interpretata dagli avversari come ambiguità e quindi come debolezza – di muoversi
sul terreno paramilitare di una violenza aggressiva ma propagandata come difensiva e su quello
delle alleanze politiche senza preclusioni, costituisce la novità e la forza del fascismo. L'azione
continua a essere ritenuta lo strumento principe per centralizzare un movimento disomogeneo e
diviso, ma i contenuti di questa forza d'urto acquistano un carattere sempre più moderato,
istituzionale e nazionale che legittimano Mussolini come possibile soluzione di transizione. La
marcia su Roma di fine ottobre 1922 viene accolta con indifferenza e presunzione, sottovalutazione
e fatalismo dai vertici politici, militari e istituzionali dello stato. La fiducia che il capo del fascismo
ottiene in parlamento il 17 novembre 1922 apre la strada al nuovo regime, con l'appoggio di
nazionalisti e popolari, liberali e democratici. Nel suo intervento alla Camera, il futuro leader che
avrebbe guidato 25 anni dopo la prima repubblica democratica, Alcide De Gasperi, giustificava il
suo appoggio al governo, malgrado il “fascismo rivoluzionario” di cui non riusciva ancora a
comprendere le intenzioni58.
In Germania la lunga crisi di Weimar è stata generalmente osservata nell'ottica del suo esito
conclusivo, tutt'altro che inevitabile e scontato se si considerano le diverse opzioni “autoritarie” che
si fronteggiavano confusamente all'inizio degli anni Trenta. Weimar è anche l'esempio di un
tentativo di impiantare la democrazia “tra le peggiori condizioni possibili”59, dentro una crisi
strutturale del sistema economico e politico internazionale e cercando di tenere insieme le spinte
contraddittorie che si erano accumulate almeno dall'inizio del secolo: “Il doppio volto della
modernizzazione condizionò la vita quotidiana e dominò anche il dibattito culturale. In un clima di
frenetica mondanità, la cultura di Weimar volle interpretare tutti i ruoli possibili della modernità,
provandoli e rifiutandoli quasi simultaneamente”60.
Il profondo senso di insicurezza e disorientamento che caratterizza l'esperienza weimariana man
mano che prosegue nel suo contraddittorio cammino, ha due radici che sembrano emergere con
maggiori evidenza di altre: gli effetti di medio periodo del compromesso sociale e quelli immediati
della sua conclusione; la metabolizzazione della sconfitta da parte dell'opinione pubblica e di un
corpo sociale frammentato e alla ricerca di una nuova identità comune. Le debolezze del sistema
politico di Weimar sono state delineate con chiarezza venti anni fa61. Il sistema proporzionale porta
i partiti al centro degli equilibri governativi e li rende simbiotici con gli interessi organizzati
(sindacati, industriali, ecc.), concedendo al Presidente del Reich, fortemente influenzato dai gruppi
militari e burocratici tradizionali, poteri eccessivi che possono ignorare la volontà della
maggioranza. La capacità della socialdemocrazia – a metà tra Klassenpartei e Volkspartei, anche se
prevale l'attenzione agli interessi quotidiani della classe operaia organizzata – di guidare il paese tra
il 1924 e il 1930, viene messa in discussione con il sopraggiungere dell'onda della crisi economica
internazionale. La logica di proteggere, prevalentemente o esclusivamente, i ceti operai e i
lavoratori occupati nel corso della depressione, allontana il consenso di disoccupati, classi medie e
mondo degli affari, acutizzando il conflitto tra industriali e mostrando l'incapacità istituzionale del
sistema politico a organizzare efficaci negoziati sociali tra le diverse élites e i cittadini nel loro
complesso: “La Repubblica di Weimar non godè dei vantaggi della capacità istituzionale necessaria
a quel tipo di cambiamenti politici che bisogna attendersi nelle repubbliche parlamentari”62.
È la frammentazione dei partiti delle classi medie, conservatori e borghesi, l'incapacità della
socialdemocrazia di espandersi oltre il proprio elettorato operaio, il radicalismo retorico dei
comunisti, a favorire la conquista nazista di consensi tra disoccupati e insicuri, fautori di soluzioni
autoritarie ma anche seguaci di un liberalismo nazionale protezionista e autarchico. Sono in gran
parte le divisioni interne alle élites capitaliste (avvantaggiate o strangolate dalla politica delle
riparazioni, dalle scelte commerciali e dagli appoggi governativi, dalla logica di welfare che nel
1931 è il più forte ed esteso del mondo) a impedire l'emergere di una politica nazionale; così come è
il peso eccessivo della socialdemocrazia a rendere impossibile l'ipotesi di una Grande Coalizione.
Il rivolgersi verso il nazismo di settori forti dell'economia – dalle miniere all'industria pesante e
all'agricoltura – è favorito dal crescente consenso popolare, a carattere largamente interclassista, che
il nazionalsocialismo è riuscito a conquistare, con una radicale polemica contro le debolezze e
divisioni della democrazia parlamentare. Le difficoltà economiche (scarsità di risorse e blocco della
crescita) accentuano le tradizionali divisioni sociali, radicalizzando il conflitto distributivo tra le
classi. La polarizzazione – esemplificata dalla scelta imprenditoriale di ridurre salari e tenori di vita
e porre fine al compromesso sociale, e dall'incapacità socialdemocratica a proporre alternative
diverse dalla difesa corporativa degli occupati – spinge le classi medie, timorose di perdere il
proprio status, verso ideologie che si presentano come interclassiste e popolari.
Il Partito nazionalsocialista, che inizia la corsa elettorale proprio in concomitanza con la crisi
economica nel 1929, affida la propria identità alla lotta contro un governo ritenuto l'emblema della
sconfitta e dell'umiliazione nazionale. La Repubblica sembra vivere per inerzia, senza trovare una
solida difesa da parte di alcuno del proprio carattere democratico, che era l'unica garanzia possibile
per trovare un risvolto positivo della sconfitta bellica. Essa si trova così sottoposta dapprima alle
pressioni rivoluzionarie, destinate a spaccare il fronte popolare; successivamente alla sempre più
diffusa reazione vittimista e revanscista, che diventa un punto centrale del nuovo nazionalismo a
sfondo sempre più dichiaratamente razzista. Il desiderio di rivincita delle élites tradizionali di fronte
a una politicizzazione di massa che modernizza il paese in modo più radicale e spregiudicato che
altrove, s'intreccia con la perdita di legittimazione della Repubblica a seguito del tramonto del
compromesso sociale e della mancanza di solide istituzioni politiche di compensazione. Tra i
progetti di svolta autoritaria quello nazionalsocialista si caratterizza per la forte spinta
all'integrazione sociale attorno a un'idea etnica ed esclusiva di nazione e di popolo, per la proposta
di ricreare grande la Germania dando seguito al suo bisogno di Lebensraum, per la spregiudicatezza
dell'uso delle forze paramilitari che raggruppano le giovani generazioni attorno alla priorità
dell'azione.
Il bacino elettorale su cui si fonda il nazionalsocialismo (che nel luglio 1932 arriva al 37% dei
suffragi) è costituito dai contadini, il gruppo sociale più significativamente abbandonato dai partiti
tradizionali, dagli abitanti delle piccole città minacciati e intimoriti dalla modernizzazione (all'epoca
il 60% dei cittadini vive in centri con meno di ventimila abitanti), da appartenenti alle classi medie
o da disoccupati che hanno precedentemente votato per altri partiti o non avevano votato. La
disoccupazione ha colpito circa un terzo della forza-lavoro e ha raggiunto i 6 milioni di persone.
L'organizzazione efficiente, la mobilitazione continua, la propaganda a carattere religioso e
l'elasticità e disponibilità ad adattarsi alle situazioni locali reclutando le persone più diverse e
favorendo una struttura carismatica piramidale, conquista i piccoli centri e le comunità rurali,
mentre il radicalismo violento, l'antisocialismo militante, l'insistenza su un nazionalismo intriso di
antisemitismo – tratti riassunti nella denuncia della “pugnalata alle spalle” e del pericolo comunista
– attraggono seguaci nelle grandi città e vi creano il clima per una richiesta d'ordine e di ripristino
dei valori su cui si era andati in guerra nel 1914.
L'erosione e la messa in discussione della stabilità istituzionale, di cui la violenza nazista è
responsabile con il suo appello al bisogno borghese di “vigilanza” e l'offerta di sfogo alle tensioni
sociali e generazionali postbelliche, è accompagnata da una promessa di legge e ordine che è anche
minaccia di ulteriore insicurezza e pericolo. “La violenza politica nella Repubblica di Weimar
comportò un processo assai complicato di negoziazione pubblica, che risiedette pesantemente su
una sorta di approvazione popolare per la sfida al monopolio della forza da parte dello stato”63.
Se al fascismo italiano ci vollero alcuni anni per rendere stabile e irreversibile la dittatura fascista, il
nazionalsocialismo ottenne lo stesso risultato in pochi mesi dal momento in cui Hindeburg, a fine
gennaio 1933, dette l'incarico a Hitler di formare un governo di coalizione, e con rapide tappe: lo
scioglimento del parlamento, l'incendio del Reichstag, il decreto “per la protezione del popolo e
dello stato” che mette fuori legge i comunisti e sopprime i diritti costituzionali fondamentali, le
elezioni di marzo con il raggiungimento del 43,9% dei voti, la sostituzione dei governi regionali
non allineati con governatori nominati da Berlino, il rogo dei libri contrari allo spirito nazionale
tedesco e contaminati dal bolscevismo e dal giudaismo.
0001000100 ‣ Il fascismo come problema storiografico.
Voglio dichiarare con chiarezza ed enfaticamente
che in Italia non esiste nulla che possa far parlare
di tirannia o di soppressione della libertà personale
come è garantita dalla costituzione in ogni terra civilizzata.
Crediamo che Mussolini goda dell'appoggio entusiasta
e dell'ammirazione di coloro soddisfatti di un ordine
e prosperità a un livello mai conosciuti
in Italia e probabilmente senza confronti oggigiorno
anche tra le altre grandi nazioni
che stanno ancora patendo per la guerra.
(Winston Churchill, 1926)
Nelle sue grandi linee, le indicazioni interpretative riassunte da Mosse nel 1979 sono ancora tra le
più efficaci e convincenti: “Il fascismo fu dappertutto un ``atteggiamento verso la vita'' fondato su
una mistica nazionale che poteva variare da una nazione all'altra. Fu anche una rivoluzione, che si
sforzò di scoprire una ``terza via'' tra marxismo e capitalismo, ma che cercava tuttavia di sfuggire a
un concreto cambiamento economico e sociale ripiegando sull'ideologia (la ``rivoluzione dello
spirito'' di cui parlava Mussolini e la ``rivoluzione tedesca'' di Hitler). Esso incoraggiò però
l'attivismo, la lotta contro l'ordine esistente”64.
La contrapposizione durata per anni tra studiosi che hanno privilegiato l'analisi delle idee e delle
tendenze culturali sottese all'esperienza fascista (le “origini ideologiche”), e storici interessati alla
specifica esperienza del fascismo tra le due guerre con una forte enfasi sulle scelte politiche
compiute dai movimenti e regimi (definire il fascismo è scriverne la storia, avrebbe detto Angelo
Tasca), ha dato luogo negli ultimi anni alla ricerca di un consenso su alcuni punti fermi,
denominatori comuni, definizioni generiche, che hanno ampliato l'arco delle interpretazioni
riassuntive: in molti casi sulla base di una differenziazione puramente nominalistica e sulla
rivendicazione autoreferenziale a una primogenitura terminologica.
Sull'importanza del nazionalismo (definito una volta come “ipernazionalismo palingenetico”,
un'altra come “ultranazionalismo populista” e un'altra ancora come “nationalism plus ”), Mosse
aveva riassunto una già ricca stagione di studi ricordando come fosse “il nazionalismo, la forza
essenziale che in primo luogo rese possibile il fascismo”65. Che questo nazionalismo fosse di tipo
nuovo e particolare (organico, olistico, radicale), capace di trascendere le ideologie coeve
(liberalismo e socialismo) era più importante che attribuirgli un carattere controrivoluzionario o la
discendenza dissidente dalla tradizione socialista, perché in questo modo si potevano seguire le
dinamiche di trasformazione con cui l'esperienza del potere e le influenze esterne condizionavano e
modificavano le idee e la pratica del fascismo. Scavenger 66 fu il termine con cui Mosse riassunse la
capacità del fascismo di appropriarsi di tutto ciò che tra Ottocento e Novecento aveva
ideologicamente affascinato avanguardie e masse: romanticismo, liberalismo, socialismo,
modernismo tecnologico, socialdarwinismo, creando un intreccio tra attivismo e ordine, rivoluzione
e assorbimento delle tradizioni del passato.
L'eclettismo rappresenta l'originalità, la forza e la caratteristica del fascismo, che punta con
“determinazione a portare il nazionalismo in prima linea della vita politica e sociale, calpestando
ogni cosa per subordinarla alle sue esigenze”67. La nazione, nell'ottica fascista, comprende il popolo
(la cultura e il sangue sottoposti all'autorità dello stato), il territorio (fondato sulla storia che ne
rivendica l'espansione), la società (intesa come comunità integrata, unita contro i nemici esterni e
capace di emarginare quelli interni), la cultura (tanto le espressioni artistiche canonizzate e accettate
dal regime quanto le attività rituali collettive che diventano momento d'identità quotidiana), la
politica (vista come attivismo e come “stile”, capace di mettere in comunicazione il popolo e il suo
duce nella subordinazione alla Nazione). Il discorso che ne emerge è sostanzialmente
antirazionalistico, essenzialistico, anche se utilizza i mezzi della comunicazione moderna, gli
strumenti della propaganda e le risorse dell'ingegneria sociale.
Il progetto organico d'integrazione sociale perseguito dal fascismo si sviluppa nella fase di
movimento soprattutto come attivismo govanile che si autoproclama laboratorio del nuovo uomo
fascista, come violenta distruzione dei responsabili del declino e della crisi della nazione e come
proposta interclassista di un partito che annacqua sempre più il proprio programma economico e
sociale. Nella costruzione del regime il partito unico diventa il fulcro della nuova architettura
politica e istituzionale, che si identifica e appropria dell'orizzonte nazionale attraverso la
mitizzazione del passato. La progressiva identificazione di fascismo e nazione, grazie alla
costruzione continua di una lealtà alla Patria che solo il regime riesce a garantire, si proietta in una
dimensione che – diventando imperiale – cercherà (pretenderà) di trascendere le precedenti
antinomie e contraddizioni interne. Il fascismo fu così “un progetto unico di ingegneria sociale di
massa che adattò una tradizione intellettuale alle circostanze della propria epoca, produsse uno stile
idiosincratico di pratica politica e particolarizzò il contenuto della sua utopia attraverso una sintesi
dell'ideologia con l'azione”68.
Lo “stile” della politica fascista può essere riassunto – anche se certo non ridotto – nel binomio di
violenza e consenso, che conobbe momenti cronologicamente alterni di egemonia e di emergenza
all'interno del movimento e del regime, e che ebbe articolazioni differenti nell'esperienza italiana e
in quella tedesca. L'avere introdotto la violenza nella politica – in forme attiviste e dinamiche
presentate come difensive, all'opposto di quelle socialiste e comuniste che, pur quando si
proponevano in un'ottica rivoluzionaria, sembravano mancare di una coerente volontà di brutalità –
è un elemento chiave del successo fascista perché accentua e legittima la crisi parlamentare e l'esito
antiparlamentare che essa potrà prendere in seguito. È attraverso la violenza che il fascismo riesce a
mantenere e riproporre l'esperienza della guerra entro il proprio orizzonte, occupando un vuoto che
la sinistra
– sottovalutando per ostilità ideologica e retaggio pacifista la forza politica del mito della guerra69 –
aveva lasciato scoperto, dimenticando quanto “la guerra [fosse assunta] a simbolo della gioventù,
del suo attivismo, del suo ottimismo e del suo eroico sacrificio”70.
Il fascismo cresce nella modernità creata dalla guerra e la sua violenza si manifesta in modo
tutt'altro che irrazionale: come violenza agraria, e cioè come risposta alla minaccia di collasso
sociale; come violenza squadrista, e cioè come mezzo di affermazione politica e di promozione
sociale dentro il movimento, come risposta comportamentale e impulsiva ai valori etici di una
borghesia impaurita e divisa. L'agenda rivoluzionaria del fascismo si presenta con il volto di una
modernizzazione generazionale che alimenta tensioni e disordini ma propone integrazione e ordine.
“Il fascismo è un genere di politica di massa moderna e rivoluzionaria, che mentre è estremamente
eterogenea nella sua base sociale e nella ideologia specifica promossa dalle sue numerose
mutazioni, trae la sua coesione e ruolo guida da un mito centrale che da un periodo percepito come
declino e decadenza nazionale crea la strada per un periodo di rinascita e rinnovamento in un nuovo
ordine post-liberale”71. La capacità di attrarre seguaci appartenenti alle diverse classi da parte dei
fascismi si accentua una volta raggiunto il potere. Nella fase del movimento sono i rappresentanti
delle classi medie (la piccola borghesia di cui parlava Salvemini per il fascismo o la borghesia
ordinata ridicolizzata da Kraus per il nazismo) a costituire il supporto elettorale della militanza
giovanile del partito e dei gruppi paramilitari. Una volta divenuto regime, il fascismo articola una
politica di ricerca del consenso che è anticipata da una serrata e violenta strategia repressiva e che si
concretizza nella progressiva conquista dello stato da parte del partito unico, con cui tenderà a
identificarsi.
In Italia, “l'insediarsi della politica, sotto forma di organizzazione di partito, tra amministrazione
pubblica e cittadini”72 trasforma in modo radicale anche se non improvviso l'apparato dello stato e
le istituzioni pubbliche, contribuendo a un crescente controllo dello stato sulla società e a una
presenza sempre più forte del partito sullo stato. Alla fine degli anni Venti, infatti,
“l'amministrazione pubblica emergerà succube di una nuova ``razionalità'', quella tutta politica,
della ricerca del consenso delle masse di cui costituirà parte integrante il ``popolo numeroso'' degli
uffici”73. L'espandersi di una nuova burocrazia, più giovane e con radici geografiche centrosettentrionali e non più meridionali, rappresenta al tempo stesso il riconoscimento tangibile del
regime al sostegno offerto al primo fascismo dai giovani studenti, professionisti, ex uffficiali e
disoccupati, ma anche la crescente affinità sociologica tra il partito che ha conquistato il potere e lo
stato che esso ha progressivamente occupato. Il prevalere di una cultura amministrativa di tipo
politico (clientelare e con tratti di modernizzazione ed efficienza) su quella tradizionale di taglio
giuridico (con maggiori aspirazioni universalistiche e garantiste), rende la burocrazia statale
l'epitome della classe media di cui il regime farà la base sociale della nuova identità nazionale del
paese.
Anche in Germania i ceti impiegatizi e professionali allargano il proprio appoggio al regime, il cui
dinamismo modernizzatore fondato sul riarmo e su progetti di vasto respiro (ad esempio la rete
autostradale) raccoglie un consenso legato alla grandezza riconquistata dalla nazione e al suo ruolo
internazionale. La svolta in politica estera, soprattutto a partire dal 1936, per la creazione di un
nuovo ordine territoriale, permette di leggere come continuità delle precedenti aspirazioni nazionali
la nuova strategia aggressiva fondata sul Lebensraum. La visione fascista del Mare Nostrum e
quella nazista di un impero “orientale” vanno ben oltre le tradizionali politiche espansionistiche
manifestate dai due paesi soprattutto prima della guerra mondiale; sono la combinazione di elementi
geopolitici e ideologici che fondano sulla razza o nella storia (il glorioso passato) il diritto di
rivendicare una grandezza futura. In quest'ottica gli obiettivi particolari dei due regimi “vennero
messi in ordine di precedenza (l'Adriatico, il Nord Africa, Suez e i Balcani meridionali per l'Italia;
la Mitteleuropa e l'Unione Sovietica per la Germania), ma la tempistica e la pianificazione furono
largamente determinate dall'opportunità e dalle limitazioni esterne”74. Opportunismo e flessibilità
da parte dei due regimi non nascondono una minore coerenza ideologica, ma la valorizzano, anzi,
nel suo aspetto di sublimazione imperiale, in cui le aspirazioni nazionaliste e identitarie che erano
state mobilitate in precedenza si coniugano con il destino e l'ineluttabilità della storia.
I grandi miti su cui fascismo e nazismo hanno costruito la propria forza non sono solamente
l'estrinsercarsi del loro carattere di religione politica, insufficiente pur se necessaria a costruire una
coesione interna e a diventare forza direttrice della loro azione. Essi sono l'aspetto trascendente di
una politica in cui interessi e valori cercano di riformularsi in equilibrio reciproco. La deriva
razzista cui anche il fascismo italiano cede definitivamente con il 1937-38 (ma che aveva già offerto
le sue credenziali nel corso della guerra di aggressione all'Etiopia), nasce proprio dal bisogno di
rinnovare uno slancio utopico e di ritrovare i motivi di una nuova mobilitazione in un contesto
segnato ormai dall'egemonia nazionalsocialista: se l'antisemitismo non è centrale nell'idea fascista
di Nazione, quest'ultima può benissimo convivere e inglobare in un particolare momento storico la
persecuzione degli ebrei.
Il fascismo, per articolare sulla base dell'intenso dibattito storiografico dell'ultimo decennio le
considerazioni di Mosse ricordate precedentemente, si presenta come una visione del mondo capace
di assorbire e valorizzare interessi economici e politici anche differenziati e contrapposti, grazie a
una visione utopica atta ad offrire un connotato di sacralità a una modernità in decadenza. A quella
“crisi di civiltà”, che contribuisce ad accelerare introiettando positivamente l'esperienza di guerra,
contrappone un diverso “stile” politico che si riassume nell'azione e il cui attivismo è connotato da
forti tensioni emotive. “I fascisti furono generati in gran numero dalle crisi post-belliche nelle
relazioni ideologiche, etniche, militari, di potere politico, alle quali una ideologia di stato-nazione
trascendente trascinata da un paramilitarismo popolare offrì una soluzione plausibile”75.
La gestione del potere da parte dei regimi fascisti, che comportò scelte economiche e soluzioni
sociali rilevanti e articolate, avvenne attraverso un uso nuovo della politica (il partito unico e il
führerprinzip) e un mutamento radicale delle istituzioni: con l'obiettivo di costruire una classe
media unica, omogeneizzata socialmente e culturalmente, capace d'identificarsi con lo stato (la
Nazione e/o la Razza) attraverso la partecipazione mitico-simbolica alla sua storia ricostruita ed
esaltata.
L'esperienza dei fascismi appartiene in toto – e si potrebbe dire “esclusivamente” – all'epoca
dell'entre-deux-guerres, e questo già dovrebbe suggerire i confini entro cui ricercare una loro
definizione e interpretazione “generica” o “generale”. La necessità di continuare ad approfondire
con studi particolari e settoriali i differenti casi nazionali, non deve oscurare il carattere epocale
entro cui s'inserisce l'esperienza storica dei fascismi. L'epoca è quella segnata in modo indelebile
dalla Prima guerra mondiale, dalla sua inaudita violenza e dal coinvolgimento totale della
popolazione quanto dal fallimento dello stato-nazione come involucro di un progresso infinito
capace di inserire democraticamente le masse nella vita pubblica. Quel fallimento, e il modo
traumatico con cui si consumò sui campi di battaglia europei, non segnò però la fine dei
nazionalismi che quella guerra avevano auspicato e favorito. La vera battaglia sui destini
dell'Europa del dopoguerra si svolse sul terreno delle istituzioni e della politica; su quali istituzioni
fossero maggiormente capaci di incanalare la partecipazione delle masse ormai definitivamente
inserite nel processo di modernizzazione e su quale politica potesse meglio servire a ricostruire e
rafforzare lo stato, la sicurezza e l'identità di nazioni sottoposte a tensioni e competizioni
reciproche.
La guerra, pur se rese più favorevole in singoli paesi il terreno alla rivoluzione, tanto sul piano
sociale che culturale, l'affossò invece definitivamente nella sua possibilità di successo
internazionale, perché bloccò il processo di mondializzazione e dette l'avvio a un periodo di
deglobalizzazione
– per usare un termine di oggi – che sarebbe durato fino alla Seconda guerra mondiale e avrebbe
segnato in profondità la “guerra civile europea” dell'entre -deux -guerres. Le ragioni di questa
“guerra civile” sono radicate tanto nelle scelte economiche quanto nelle decisioni di politica
internazionale che vennero fatte nella Conferenza di pace e che la gestione miope e provinciale dei
diversi governi rese ancora meno capaci di creare un equilibrio interno ai singoli stati e una
prospettiva unitaria all'intera Europa.
Nella transizione postbellica a una nuova realtà politica e istituzionale, si radicalizzò una divisione
europea tra i regimi liberal-parlamentari di più antica tradizione, quelli giunti più recentemente
all'unificazione nazionale e ancora fortemente limitati nelle loro conquiste democratiche e quelli
divenuti indipendenti con il crollo degli imperi e il termine della guerra. Ognuno di essi cercò di
reagire alla richiesta di sicurezza e cambiamento, di identità e trasformazione, di utopia e
rassicurazione intrecciando risposte istituzionali e costruzioni ideologiche. Le maggiori novità, in
entrambi i casi, furono quelle che emersero dai movimenti fascisti, capaci di conquistare il potere e
diventare regime – in Italia e Germania – a distanza di dieci anni. Fu la loro saldatura, a metà degli
anni Trenta, a imprimere definitivamente alla storia europea una direzione conflittuale che sancì –
con lo scatenamento della Seconda guerra mondiale – la perdita di centralità e di egemonia che
l'Europa aveva iniziato a intravedere proprio negli anni in cui veniva combattuta la prima.
Anche lo studio dei fascismi, quindi, non può che continuare ad avvenire all'interno di una
comparazione che abbracci l'intera epoca tra le due guerre, che si muova sul versante del confronto
tra le diverse esperienze totalitarie e autoritarie ma anche su quello con le dinamiche nuove
d'intervento statale nell'economia e di creazione di istituzioni “sociali” di cui fanno parte anche le
esperienza nordeuropee o del New Deal americano. Senza dimenticare come il tema della classe
media – costruita socialmente negli USA attorno alla logica dei consumi di massa negli stessi anni
in cui veniva politicamente omogeneizzata con forza e consenso dai regimi fascisti e violentemente
distrutta e rigenerata nella Russia sovietica – rimanga centrale per la comprensione della modernità
e della modernizzazione nonché delle culture ambivalenti e contraddittorie che hanno
accompagnato l'ingresso e la partecipazione delle masse alla vita pubblica. Note al saggio L'ultima
strofa recita: Never such innocence, / Never before or since, / As changed itself to past / Without a
word–the men / Leaving the gardens tidy, / The thousands of marriages, / Lasting a little while
longer: / Never such innocence again. Contro questo Stato accentratore e monopolizzatore, il partito
popolare ha proceduto con opera di critica e con propositi di legale trasformazione. Il fascismo
invece è insorto con l'azione diretta e violenta”. Il testo in:
http://www.degasperi.net/show_doc.php?id_obj=416sq_id=0.
1 - Walter H. Page, ambasciatore americano a Londra, al Presidente Wilson il 3 agosto 1914, in
Martin Gilbert, A History of the Twentieth Century. Volume One: 1900-1933, HarperCollins,
London 1997, p. 331.2 - Julian Henry Francis Grenfell, Into Battle, in “The Times”, 12 maggio
1915.3 - Citato in Iain Boyd Whyte, Otto Dix's Germany: From Wilhelmine Reich to East/West
Divide, in Otto Dix, Tate Gallery, London 1992, p. 28.4 - Citato da Carla Schulz-Hoffmann, War,
Apocalypse, and the ``Purification of the World'', in The Romantic Spirit in German Art, 17901990, Thames & Hudson, London 1994, p. 198.5 - Giuseppe Prezzolini, Facciamo la guerra, in “La
Voce”, Firenze 28 agosto 1914.6 - Citato in Le rève d'une ville, Nantes et le Surrealisme, Ed.
Réunion des Musées Nationaux et Musée des Beaux Arts de Nantes, Paris 1994, p. 2017 “Littérature”, n. 15, 1920.8 - Citato in “Anthem for Doomed Youth. Writers and Literature of The
Great War, 1914-1918. An exhibit commemorating the 80th anniversary of the Armistice,
November 11, 1918”, Brigham Young University, Provo UT 1998.
http://www.lib.byu.edu/~english/WWI/newmain.html.9 - “The London Times”, 31 luglio 1917.10 Paul Fussell, La grande guerra e la memoria moderna, il Mulino, Bologna 2000, p. 20 [tit. orig.
The Great War and Modern Memory, Oxford University Press, New York 1975].11 - Renato Serra,
Esame di coscienza di un letterato, in “La Voce”, Firenze 30 aprile 1915.12 http://www.lib.byu.edu/~english/WWI/influence/MCMXIV.html.13 - Report of the War Office
Committee of Enquiry into ``Shell-shock'', HMSO [Her Majesty Stationery Office], London 1922, p.
28.14 - André Leri, Shell-Shock, Commotional and Emotional Aspects, University of London Press,
London 1919, p. 118.15 - Eli Zaretsky, Secrets of Soul. A Social and Cultural History of
Psychoanalysis, Alfred A. Knopf, New York 2004, p. 121.16 - Cfr. Eugen Weber, Da contadini a
francesi. La modernizzazione della Francia rurale (1870-1914), il Mulino, Bologna 1989 [tit. orig.
Peasants into Frenchmen: the Modernisation of Rural France, 1870-1914, Stanford University
Press, Stanford CA 1976]; George L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico
e movimenti di massa in Germania (1815-1933), il Mulino, Bologna 2004 [tit. orig. The
Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the
Napoleonic Wars through the Third Reich, H. Fertig, New York 1975]; Pierre Nora, Les lieux de
mémoire, I-III, Gallimard, Paris 1984-1992; Mario Isnenghi, I luoghi della memoria, I-III, Laterza,
Bari-Roma 1996-1997; Raphael Samuel, Theatres of Memory, v. I-II, Verso, London 1996-1999.17
- Christophe Charle, La crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande-Bretagne 19001940. Essai d'histoire sociale comparée, Seuil, Paris 2001, pp. 203-04.18 - Citato in Annette
Becker, The Avant-Garde, Madness and the Great War, in “Journal of Contemporary History”, vol.
35, n.1, Sage Publications, London gennaio 2000, p. 81.19 - J. W. Burrow, The Crisis of Reason.
European Thought 1848-1914, Yale University Press, New Haven CT 2000, p. 92.20 - Georg
Simmel, Metropolis and Mental Life [1903], citato in Anthony Mc Elligott, The German Urban
Experience, 1900-1945. Modernity and Crisis, Routledge, London 2001, p. 78.21 - Robert Musil,
Politics in Austria [1912], in Precision and Soul: Essays and Addresses, a c. di Burton Pike e David
S. Luft, University of Chicago Press, Chicago 1990 pp. 19-20.22 - Musil, Helpless Europe [1922],
in Precision and Soul cit., p. 132.23 - Oswald Spengler, Il tramonto dell'occidente, Longanesi,
Milano 1978, p. 3 [tit. orig. Untergang des Abendlandes, Beck, München 1918].24 - John Girling,
Myths and Politics in Western Societies. Evaluating the Crisis of Modernity in the Unites States,
Germany and Great Britain, Transaction Publishers, New Brunswick NJ 1993, p. IX.25 - “Soggetti
alla legge dell'evoluzione, possiamo tanto progredire quanto degenerare”, Edwin Ray Lankester,
Degeneration. A Chapter in Darwinism, Macmillan, London 1880, p. 60.26 - “Se da un lato febbre
tifoidale, vaiolo, colera e difterite sono arretrate dinanzi ai rimedi applicati dalla scienza
illuminata... dall'altra vediamo come insanità mentale, suicidio e delinquenza stiano aumentando
rapidamente”, Enrico Ferri, citato in Daniel Pick, Volti della degenerazione, una sindrome europea
1848-1918, La Nuova Italia, Firenze 1999, p. 20.27 - Henry Maudsley, Organic to Human,
Psychological and Sociological, Macmillan, London 1916, pp. 26, 236-37.28 - Pick, Volti della
degenerazione cit., p. 307.29 - Thomas Hardy, Late Lyrics and Earlier, Macmillan, London 1922,
p. XIV.30 - Eric Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, v. 2: Race and State [tit. orig.
Rasse und Staat, Mohr, Tübingen 1933], Louisiana State University Press, Baton Rouge LA 1997,
p. 16.31 - L'espressione è di Gerhard Goehler, Constitution and Use of Power, in Power in
Contemporary Politics. Theories, Practice, Globalization, a c. di Henry Goverde et al., Sage,
London 2000, p. 50.32 - Stefan Berger et al., Writing National Histories. Western Europe since
1800, Routledge, London 1999, p. 11.33 - Sigmund Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e
sulla morte, Bollati Boringhieri, Torino 1975 [tit. orig. Zeitgemasses über Krieg und Tod, lecture,
Wien 1915, poi pubblicato da Internationaler Psychoanalytische Verlag, Leipzig 1924].34 - Thomas
Mann, Pensieri di guerra [1914], in Gesammelte Werke in dreizhen Bänden, S.Fischer, Frankfurt
am Main 1974 v. 13, p. 533.35 - Wilamowitz nach 50 Jahren, a c. di W. M. Calder et al.,
Wissenschaftliche Brichgesellschaft, Darmstadt 1985, p. 649.36 - Citato in Gli intellettuali e la
Grande Guerra, a c. di Vincenzo Calì et al., il Mulino, Bologna 2000.37 - Stefan Zweig, Il mondo
di ieri. Ricordi un europeo, Edizioni del Prisma, Catania 1995, p. 270 [tit. orig. Die Welt von
Gestern. Erinnerungen eines Europäens, Bermann-Fischer Verlag, Stockholm 1944].38 - Viktor
Sklovskij, C'era una volta, il Saggiatore, Milano 1994, p. 181 [tit. orig. Zhili-Byli, SNKLU, Praha
1965].39 - Robert Lansing, The Peace Negotiations: a Personal Narrative, Houghton Mifflin,
Boston 1921 p. 97.40 - John Maynard Keynes, A Short View of Russia, Hogarth Press, London
1925, pp. 12, 14.41 - Ivi, p. 24.42 - Ken Post, Communists and National Socialits. The Foundations
of a Century, 1914-1939, St. Martin's Press, London 1997, p. 188.43 - The Collected Works of Eric
Voegelin, vol. X, Published Essays 1940-1952, University of Missouri Press, Columbia CO 2000,
pp. 54-55.44 - Cfr. Charles Maier, La rifondazione dell'Europa borghese. Francia, Germania, Italia
nel decennio successivo alla prima guerra mondiale, il Mulino, Bologna 1999 [tit. orig. Recasting
Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I,
Princeton University Press, Princeton NJ 1975].45 - L'esperienza “fondante” della guerra è
raccontata nei diari di guerra, Ernst Jünger, Nelle tempeste d'acciaio, Guanda, Parma 1999 [tit. orig.
In stahlgewittern, aus dem Tagebuch eines stosstruppführers, E.S. Mittler & Sohn, Berlin 1922].46
- Luigi Salvatorelli, Nazionalfascismo, Gobetti, Torino 1923.47 - Alberto De Bernardi, Una
dittatura moderna. Il fascismo come problema storico, Bruno Mondadori, Milano 2001, p. 46.48 Mariuccia Salvati, L'inutile salotto. L'abitazione piccolo-borghese nell'Italia fascista, Bollati
Boringhieri, Torino 1993, p. 32.49 - Aristotle A. Kallis, Studying Inter-war Fascism in Epochal and
Diachronic Terms: Ideological Production, Political Experience and the Quest for ``Consensus'', in
“European History Quarterly”, v. 34, n. 1, gennaio 2004, p. 18.50 - Stefan Zweig, Il mondo di ieri
cit., pp. 272-73.51 - Maksim Gor'kij, lettera a I. M. Kasatkin del 20 luglio-2 agosto 1914, in Letopis'
Zhizni i Tvorchestva A.M. Gor'kogo, vol. 2: 1908-1916, Akademiia nauk SSSR Institut mirovoi
literatury, Moskva 1958, p. 450.52 - Robert Musil, Helpless Europe [1922], in Precision and Soul
cit., p. 117.53 - Eli Zaretsky, Secrets of the Soul. A Social and Cultural History of Psychoanalysis,
Alfred A. Knopf, New York 2004, p. 141.54 - Women, Gender and Fascism in Europe 1919-1945,
a c. di Kevin Passmore, Manchester University Press, Manchester 2003.55 - Il dibattito suscitato dal
libro di Claudia Koontz (Mothers in the Fatherland: Women, the Family, and Nazi Politics, St.
Martin's Press, New York 1987) si riferisce prevalentemente alle politiche di “regime”, qui appena
sfiorate. L'uso femminile dell'idealizzazione nazista della maternità, cioè una pragmatica
negoziazione che porta a raggiungere parzialmente alcuni obiettivi dei movimenti femminili prenazisti, si ritrova anche nel lavoro dedicato al fascismo da Vicky De Grazia (Le donne nel regime
fascista, Marsilio, Venezia 1993); mentre maggiormente legata a un più tradizionale giudizio di
patriarcato anti-femminile è Gisela Bock (Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur
Rassenpolitik und Frauenpolitik, Westdeutscher Verlag, Opladen 1986); si veda anche Elisabeth
Harvey, The Failure of Feminism? Young Women and the Bourgeois Feminist Movement in
Weimar Germany 1918-1933, in “Central European History”, n. 28, University of California,
Riverside CA 1995, pp. 1-28.56 - Women, Gender and Fascism in Europe 1919-1945 cit., p. 240.57
- Ivi, p. 241.58 - “Ma in verità, il tono rude con cui il Presidente del Consiglio ha iniziato il suo
discorso ci richiama ad una realtà ancora più dura, cioè al fatto rivoluzionario che ha condotto il
presente Governo al potere e alle condizioni rivoluzionarie dalle quali non siamo ancora del tutto
usciti e che, per assegnare nettamente le responsabilità e per stabilire il giuoco delle forze agenti
nella politica del paese, sarebbe opera vana e dannosa voler nascondere sotto le forme
convenzionali e tradizionali del costume parlamentare. [...] Le ragioni dello sviluppo di questo
rivolgimento istituzionale possono addebitarsi a vari fenomeni della guerra e del dopoguerra e
anche alla crisi economica; ma in parte notevole, è vero, devono attribuirsi alla paralisi statale
causata dall'eccessivo accentramento dei poteri negli organi centrali del parlamentarismo e della
burocrazia, all'accumulamento di ogni potere legislativo nella Camera, alla atrofia del Senato e alla
mancanza di organi periferici con la conseguente disintegrazione delle forze locali.59 - Detlev J. K.
Peukert, La Repubblica di Weimar, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 288.60 - Ivi, p. 289.61 Cfr. The Rise of the Nazi Regime. Historical Reassessments, a c. di Charles S. Maier et al.,
Westview, London 1986.62 - David Abraham, The Collapse of Weimar, ivi, p. 3.63 - Bernd
Weisbrod, The Crisis of Bourgeois Society in Interwar Germany, in Fascist Italy and Nazi
Germany. Comparisons and Contrasts, a c. di Richard Bessel, Cambridge University Press,
Cambridge 1995, p. 36.64 - George L. Mosse, Il fascismo. Verso una teoria generale, Laterza,
Roma-Bari 1996, p. 83.65 - Ivi, p. 86.66 - Spazzino, animale necrofago.67 - Aristotle A. Kallis,
Studying Inter-War Fascism in Epochal and Diachronic Terms cit., p. 13.68 - Ivi, p. 26.69 Incapace in questo di seguire, anche i comunisti, l'insegnamento di Lenin.70 - Mosse, Il fascismo.
Verso una teoria generale cit., p. 28.71 - International Fascism. Theories, Causes and the New
Consensus, a c. di Roger Griffin, Arnold, London 1998, p. 14.72 - Mariuccia Salvati, Il regime e gli
impiegati, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 6873 - Ivi, p. 77.74 - Aristotle A. Kallis, Fascist Ideology,
Territory and Expansionism in Italy and Germany 1922-1945, Routledge, London 2000, p. 196.75 Michael Mann, Fascists, Cambridge University Press, Cambridge 2004, p. 365.