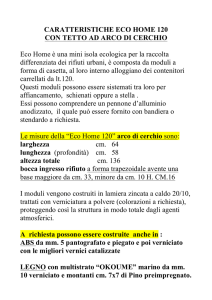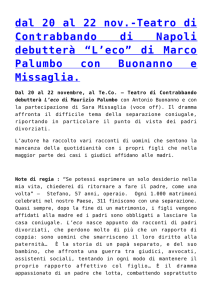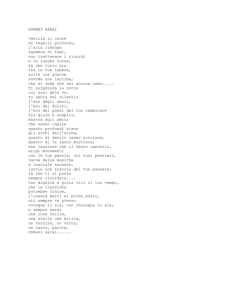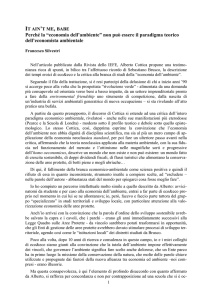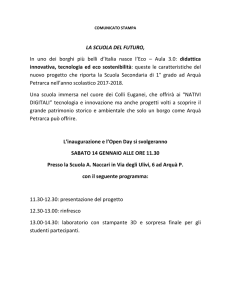Riccardo Becheri
IL RE NUDO UMBERTO ECO
Prato 2013
1
©Tutti i diritti riservati all’autore
[email protected]
www.riccardobecheri.it
2
INDICE
1 PERCHE’ HO LETTO ECO.
2 IL PENDOLO DI FOUCAULT.
3 PERCHE’ HO SCRITTO QUESTO SAGGIO
4 STRUTTURA E STILE DEL SAGGIO
“SULL’ESSERE” DI UMBERTO ECO.
5 IL DOVERE PROFESSIONALE.
6 I LIMITI DELL’ESSERE.
7 I RISPETTOSI CONFRONTI POLEMICI
8 LA NOTA 14.
9 GIUDIZI E PREGIUDIZI.
3
Pag. 5
“ 7
“ 9
“
“
“
“
“
“
11
18
21
29
33
38
4
1. PERCHE’ HO LETTO ECO
Il saggio di Umberto Eco “Sull’essere” è una stronzata
accademica.
E qui devo spiegare perché e come l’ho letto. In genere
cerco di evitare di leggere scritti di Umberto Eco, ma la mia
figlia maggiore Barbara è socia di Euroclub, una società
editoriale che ristampa libri di successo. Le era venuta l’idea
di ordinare “Kant e l’ornitorinco” di Eco e aveva cominciato
a leggerlo. Ne era stata respinta in malo modo.
Alla prima occasione, un paio di mesi fa, mi ha passato il
libro dicendomi: “Tienilo tu. Io non riesco nemmeno a
leggerlo.” Col volume in mano e stuzzicato dalla curiosità di
vedere cosa avesse tanto mortificato lo spirito di mia figlia,
non ho potuto far altro che aprirlo e dare un’occhiata
all’indice. Confesso una qualche sorpresa vedendo che
conteneva saggi filosofici. Dalla popolarità del libro ritenevo
che si trattasse di un romanzo tipo “Il nome della rosa”.
Evidentemente sottovalutavo le possibilità del successo, se
uno scrittore di successo riesce persino a vendere libri di
filosofia.
Comunque la mia curiosità si era accesa. E a casa mia, a
comodo, ho letto l’introduzione, il saggio “Sull’essere” e la
seconda appendice su “Croce, l’Intuizione e il
Guazzabuglio”; in più ho scorso qualche capoverso qua e là.
Fra me e me ho trinciato un giudizio: “Kant e l’ornitorinco”
era la solita pappardella accademica farcita all’inverosimile
per impressionare i lettori. Non ci ho pensato più e ho messo
via il volume.
Dopo due o tre settimane, per caso, sul banco di un
supermercato vedo l’altro libro di Umberto Eco “Il pendolo
di Foucault”. Era in edizione economica, per di più scontato
5
del venti per cento; e con la bellezza di quattordicimila lire
l’ho fatto mio. Mi spingeva la curiosità di vedere se anche
questo era una raccolta di saggi o un romanzo. Era un
romanzo, anche se misterico-filosofico. Ho letto i due
capitoli iniziali e quasi per intero i due capitoli finali. E l’ho
messo via: ho già detto che cerco di evitare di leggere scritti
di Umberto Eco. E dopo dirò perché.
Infine, e ci avviciniamo al dunque, una quindicina di
giorni fa mi è capitato di leggere sul “Venerdì di
Repubblica” un articolo di Giorgio Bocca dal titolo
“Computer, utile e pericoloso”. Vi si accenna di malanimo a
qualche utilità trascurabile del computer, ma soprattutto se
ne denunciano con veemenza i pericoli sostanziali. Lo
scrittore di professione, dice Bocca, accatasta nel computer
qualcosa tutti i giorni, magari insieme al riso “anche la
polvere e qualche bacheronzolo”;
e poi inevitabilmente
“pensa che sarebbe uno spreco non usarlo tutto. Sicché ne nasce
una letteratura a incastri dove abbonda la mala pianta delle
citazioni”.
Più giù Bocca aggiunge che ha amici molto noti che
hanno scritto libri fortunati; amici che si offenderebbero se
gli dicesse che si capisce che li hanno scritti al computer
dalla loro
“confezione a polpettone”
dove al limite
gl’ingredienti possono essere anche buoni ma sono troppi.
Bocca non fa nomi, ma a me è venuto subito in mente
Umberto Eco, grande profeta dell’informatica. E questo mi
ha spinto a ripescare i suoi libri fra i miei scaffali.
6
2. IL PENDOLO DI FOUCAULT
Confesserò un altro peccato: a me i libroni provocano una
specie di vomito da indigestione e col tempo ho imparato a
guardarmene. E’ un peccato, non un vanto.
“Il pendolo di Foucault” è un librone di 680 pagine diviso
in ben 120 capitoli ciascuno dei quali ha premessa una bella
citazione, più altre due in testa al volume. Alcune citazioni
sono in latino, spagnolo, francese, al primo capitolo
addirittura in ebraico; e non sono tradotte. Altre citazioni
dalle stesse lingue sono riportate direttamente in italiano e
non si capisce perché. Tutte le citazioni sono assai peregrine
e sembra che ripetano per 122 volte al lettore: “Béccati
anche questo, ciuco ignorante!”
Un paio di citazioni che ho controllato corrispondono agli
originali. Le altre non so. Mi auguro anzi che molte siano
inventate e che nelle 680 pagine si spieghi il perché di tante
citazioni, vere o false che siano. Di più, vorrei sperare che
l’ironia, che ogni tanto affiora in Eco, sia il vero sostegno dei
misteri di questo romanzo: una gigantesca risata beffarda che
riscatti la mala pianta delle citazioni erudite e spinga questo
verboso malloppo verso il Don Chisciotte.
Parrebbe assistermi in questa speranza la prima citazione
in testa al volume, dove si dice che l’opera è stata scritta solo
per i figli della dottrina e della sapienza e che ciò che è
occultato in più luoghi viene manifestato in altri, affinché la
saggezza dei lettori possa comprendere l’intenzione del libro.
Conforta la mia speranza di un’ironia beffarda anche la
citazione numero sette di un polacco di nome Lec: “Non
aspettatevi troppo dalla fine del mondo”. Mi piace, è corta,
la citerò anch’io.
7
Purtroppo la speranza mi muore quasi al ricordo dei
capitoli già letti e di qualche mezza pagina scorsa. Dovrei
leggere tutto il libro, passo passo sino alla fine, per vedere se
la fiammella della speranza resiste. Ma incombono le 680
pagine e le 122 citazioni. E se poi vomito?
Allora mi dico che di sicuro fra i tanti compratori del
libro ci saranno anche tanti che l’hanno letto per intero.
Aspetterò con calma che qualcuno mi spieghi se almeno le
citazioni nel “Pendolo di Foucault” abbiano un senso. Allora
potrò forse decidermi a leggerlo. O forse lo lascerò sepolto
per sempre dove accatasto il ciarpame letterario italiano.
Un’ultima annotazione a proposito di lettori per intero:
siamo sicuri che se questo romanzo fosse arrivato per posta
ordinaria a qualsivoglia casa editrice, sotto il nome di Gian
Mario degli Abruzzi , sarebbe stato pubblicato?
8
3. PERCHE’ HO SCRITTO QUESTO SAGGIO
Sempre spinto dal Bocca, dopo aver ponderato “Il
pendolo di Foucault” come ho detto, ho ripreso in mano
“Kant e l’ornitorinco”, più che altro per divertirmi. E tutti i
miei ricordi sulla letteratura a incastri, sulla mala pianta delle
citazioni, sul polpettone informatico, sono stati confermati
dalla seconda lettura dei passi che più o meno avevo già
letto.
Qui però è sorta anche la domanda fatale: ma è possibile
che solo io veda l’inconsistenza di queste argomentazioni?
Non sarà invece la mia pigrizia e il mio pregiudizio a non
farmi cogliere il vero e il bello dei suoi saggi? Non sarò
mosso dal peccato per eccellenza, l’invidia?
E allora ho preso a campione il saggio “Sull’essere” e
l’ho riletto e annotato e riassunto e sminuzzato e riletto
ancora più volte, come se fosse la quintessenza non tanto del
pensiero e della scrittura di Umberto Eco, ma dell’eterna
lotta fra il bene e il male, o se preferite dell’eterna
batracomiomachia, la mitica guerra fra le rane e i topi.
Alla fine mi sono trovato con un fascio di appunti. Li
avrei potuti bruciare, ma ormai la fatica l’avevo fatta. Potevo
scrivere una nota ipocritamente elogiativa per il gran nome
con qualche riserva nel merito, ma avrei dovuto essere un
cacciatore di cattedre. O potevo scrivere pari pari le mie
riflessioni. Ma perché farlo?
Certo, per vendicare mia figlia. E già questo è un buon
motivo. Mettiamoci pure per dare soddisfazione alla mia
vena di meschina maldicenza. E già questo per me potrebbe
bastare. Ma per gli altri? Cioè, se mai un lettore estraneo
dovesse capitare su queste pagine, perché le dovrebbe
leggere?
9
Ebbene, questo mio sfogo vuole soltanto auspicare un
modo onesto di scrivere filosofia. Quando proprio vogliamo
scrivere saggi filosofici, si deve dire la nostra senza tanti
fronzoli. Certo che occorre leggere e studiare, confrontarsi
con gli altri filosofi e riprendere i problemi dal punto in cui li
hanno lasciati coloro che ci hanno preceduti. Ma questo non
significherà mai lo scambio del mezzo per lo scopo, il
rimanere a questionare con gli altri senza mai affrontare
direttamente il problema. E mai e poi mai sarà ammissibile
l’ammantare di paroloni e oscurità il proprio vuoto,
rimasticando per la centesima volta con un’altra terminologia
il già detto.
Con ciò non metto in discussione, anzi rivendico la serietà
scientifica delle storie della filosofia, delle monografie su un
singolo autore, delle bibliografie, delle recensioni e delle
memorie accademiche. Ed anche, dei termini tecnici
imprescindibili.
Ma se per serietà scientifica si vuol far passare la
sicumera professorale, ancorché ilare, e l’adozione d’un
proprio formulario iniziatico per autorizzare a parlare solo i
cooptati nel circolo, ebbene ciò è quanto di più contrario
esista rispetto alla filosofia. Questi circoli con i loro gerghi
hanno il medesimo scopo delle corporazioni medievali,
quello di proteggere i soci; e in questo caso, quello di
conferire loro una presunzione di scienza.
Questa presunzione non esiste per nessuno.
10
4.
STRUTTURA
E
STILE
DEL
“SULL’ESSERE” DI UMBERTO ECO
SAGGIO
Esamino intanto la struttura e lo stile del saggio. Si
compone di 42 pagine a stampa più due di note. Il testo è
diviso in una premessa di tre pagine e in dodici paragrafi. Vi
sono citati 55 nomi differenti per un totale di 155 evocazioni
(Aristotele 23 volte, seguito da Heidegger con 19, Eco stesso
con 6, fino alla sola volta di Sapir-Whorf che ho contato per
uno); le citazioni fra virgolette sono 65, le parentesi oltre
230 e le note 14. Vi sono infine, comprese le ripetizioni,
oltre 400 parole straniere, alcune greche in caratteri latini.
Tutto questo in 44 pagine.
Incastri? Mala pianta? Polpettone? Lasciamo perdere
l’informatica e “l’epifania silicea del computer” come la
chiama Eco. In fondo è indifferente lo strumento con cui si
scrive: un nulla inciso sulla pietra rimane un nulla.
Facciamo piuttosto qualche altro piccolissimo rilievo. La
nota 11 non ha il rinvio nel testo, ma presumo che debba
stare alla fine del quarto paragrafo, sparita per uno scambio
da esponente a un maiuscolo 1.1. Hjelmslev viene citato a
pagina 4 senza la prima elle. Sotto la voce “refusi” e non fra
gl’inganni bibliografici metterei la “Theologia Mistica” per
“De theologia mystica”. Un altro refuso è a pagina 37 dove
una a è diventata e. Forse ci sono altri refusi, ma non li ho
scoperti.
Altre minuzie? La pagina 32 e la nota 14 ci presentano
designamo e disegnamo con la i a –gniamo. Vi sono due
“quale è” a pagina 1 e a pagina 35. Opinioni differenti
sull’ortografia? Anche ammesso, si tratta sempre della scelta
peggiore.
11
Per gl’inganni dei rinvii bibliografici, segnaliamo:
Heidegger 1923; Heidegger 1973:1969; Gilson 1984 e
Gilson 1948; Vattimo 1984; e chiaramente anche Eco 3.4.7
che non esiste ed è 3.4.6.
Per la meritata fustigazione degl’ignoranti adopriamo i
termini:
filogeneticamente,
ontogeneticamente,
somatopatico, infundibolare, borborigma, rizomatico,
figmento, apofatica e altri gergali.
Per confondere le acque possono anche servire i troppi:
“non è che è, che cos’è… se non, altro non è, non si può… se non,
il problema non è … bensì, non si potrà che, non è tanto…
quanto, non si direbbe che non” , eccetera eccetera.
Per l’esattezza terminologica riscontriamo, restando ai
termini principali: “l’insopprimibile evidenza dell’essere,
l’insopprimibile evidenza dell’esistenza degli individui,
l’insopprimibile evidenza dell’individuale esistente; e poi, l’essere
è anche prima che se ne parli, l’essere è solo effetto di linguaggio,
il nulla e la negazione sono puro effetto di linguaggio”.
Per impressionare i deboli possono servire le maiuscole:
Mondo, Universo, Mente, Poeti, Filosofi, Fondamento, Uno,
Sostanza, Evento, Svolta, Frattale, Demiurgo, Filosofia
Prima, Teologia, Negatività, Limite, No e altri. Per civetteria
“essere” è maiuscolo solo due volte e una in maniera
dichiarata.
Per il contorsionismo sintattico basterebbe indicare
l’intero testo, ma ci sono dei campioni che meritano una
medaglia: rimandiamo perciò alla pagina 2 col periodo che
comincia con “Tuttavia”, alla pagina 3 “Non solo o non
tanto”, alla pagina 5 “Si ha indicalità” , sempre alla pagina 5
“Nel più elementare”, alla pagina 11 dove in un solo periodo
si sviscera la
“questione centrale della Metafisica
aristotelica”; per brevità saltiamo al periodo di pagina 40
che inizia con “Ma Habermas”.
12
Basta sullo stile di Eco? No, qualcosa sulle parentesi e
sulle citazioni devo pur dirlo.
Tutti, me compreso, usiamo talvolta le parentesi al posto
delle virgole, ma è un errore. Perché togliamo forza al loro
uso proprio: quando l’interruzione è brusca al di là del
consentito alle virgole e quando, soprattutto, non è
eliminabile. Lo sa bene Eco, non qui, ma in “Come si fa una
tesi di laurea”, dove dice che in prima stesura potete scrivere
qualunque cosa vi passi per la testa, ma poi vi accorgerete di
esservi allontanati dal centro dell’argomento: “Allora
toglierete le parti parentetiche”.
Il punto è questo: nella stesura del saggio “Sull’essere”
non c’è stata una seconda volta, come testimoniano le 230 e
passa parentesi. Prendete il quarto capoverso all’inizio, il già
citato che comincia con “Tuttavia”. E’ composto di un solo
periodo lungo nove righe e con tre parentesi. Vi sono dodici
verbi coniugati con i seguenti soggetti: si impersonale,
essere, che, noi sottinteso, gatto, noi sottinteso, essere in
buona salute, si, si, si, equazione, ex-istere.
A una seconda stesura questo orribile capoverso sarebbe
sparito perché è tutto fuori dal centro del discorso, o al
massimo sarebbe stato accolto così: talvolta usiamo il verbo
essere come sinonimo di esistere la cui etimologia significa
“uscire da”, “manifestarsi” e quindi “venire all’essere”.
Come sa benissimo chiunque scriva anche solo un
annuncio mortuario è molto più difficile essere concisi che
prolissi. Spesso ci vuole un’intera giornata di lavoro soltanto
per abolire una parentesi. Però la fatica sarà ampiamente
ricompensata, non dalla concisione per se stessa, ma dalla
purificazione del pensiero che, all’inizio confuso, ora fa
tuttuno con lo stile.
13
Qui però non c’è stata una seconda volta, non c’è stata
nessuna fatica, né semplice rilettura. Balzano agli occhi solo
una grande fretta e una sciatteria inammissibile. Certo che
Eco altrove, e se vuole, può scrivere bene, ma qui non lo ha
fatto. E pubblicando uno scartafaccio senza ripulirlo ha
offeso i lettori. E io sono un lettore.
E veniamo ora alle citazioni. Se uno scrive su un altro
autore, come faccio io qui con Eco, lo deve citare di
continuo. Ed è giusto. Se uno non può fare a meno di
riportare un brano di altri, lo deve citare per pagare un
debito. Ed è bene. Ma si dovrebbe presumere che quando
uno scrive su un argomento abbia qualcosa di personale da
dire e voglia metterlo in bella evidenza, non nasconderlo
dietro 155 nomi, 65 virgolette e buona parte delle 230
parentesi. La rabbia è che queste cose Eco non solo le sa, ma
le ha anche scritte e raccomandate agli studenti, sempre in
“Come si fa una tesi di laurea” da cui ho rubato l’espressione
“pagare un debito”.
Scrivendo così, nella migliore ipotesi un autore dà inizio a
un processo all’infinito di rimandi, che non è affatto la mai
esauribile ricerca della verità, ma solo un eterno nascondersi
a se stessi. Nella peggiore ipotesi, il lettore fa come mia
figlia, butta via il libro.
Ma allora, perché Eco lo ha fatto?
Perché da sempre Eco è affetto da logorrea irrefrenabile
di tipo umoristico-erudito. Questo è il suo stile e questo è il
vero suo pensiero che fa tuttuno col suo stile.
Si guardi (pilucco nell’ordine del testo): la collera
greimasiana, la philosophia pertracta di Wolff, l’Oggetto
Dinamico di Peirce che ci spinge a produrre un
representamen che a sua volta produce in una quasi-mente
un Oggetto-Immediato, il gavagai di Quine, la poesia di
14
Valéry, il dibattito tra Anselmo e Gaunilone e quello tra
Anselmo e Cioran, la situazione e l’ipotesi berkeleyana,
l’intero paragrafo quarto col duetto fra Aristotele e san
Tommaso con l’intermezzo di Parmenide e la chiusa fra Eco,
Aristotele, Porfirio e ancora Eco, l’architettura tetragona di
Spinoza, il Sein-Dasein- Seiende di Heidegger, il saggio di
Elea a più di una pagina di distanza da dove veniva chiamato
col suo nome, il verso di Holderlin , la De theologia mystica
e il De coelesti hierarchia dello pseudo-Dionigi, le quattro
incapacità di Peirce, van Gogh come Dasein, lo spazio
bruniano, Pollicino insieme a Odino e Pitagora, il
fichtianamente costruito, l’anything goes di Feyerabend, il
camolato e tutto il resto di Vattimo, la reazione humeana di
Nietzsche, la lettera di Rimbaud a Demeny, le affordances
percettive di cui Eco parla nell’inesistente 3.4.7, il mening di
Hjelmslev, Habermas che nel cercare il nocciolo della critica
di Peirce alla cosa in sé kantiana sottolinea il problema
peirceano, la virginis ruinam di san Tommaso, senza andare
a cascare nelle note con l’imbarazzato Seneca.
Che si tratti di logorrea, e di tipo erudito, mi pare
evidente. E non dirò altro. Che si tratti anche del tipo
umoristico risalta dal tono generale del discorso, impostato
subito nel primo periodo con le sue tre parentesi scherzose
(sì, sì, li so i rimandi cosiddetti seri) e rinfrescato qua e là
con battute che vanno da Pollicino, van Gogh e l’epifania
silicea già rammentate alla nascita di Heidegger in
Oklahoma, agli scienziati in seduta medianica, al taglio di
bue dal muso alla coda, al Qualcosa che risponde con una
scala reale al nostro tris d’assi, alla radice quadrata che ha
per padre un cammello e per madre una locomotiva, per non
dire del Qualcosa-che-ci-prende-a-calci il cui riscatto serio
attendiamo dai tedeschi.
15
Che poi i due tipi, erudito e umoristico, possano essere
uniti dal trattino e diventare un nuovo tipo di logorrea, che
potremmo anche chiamare accademica, emerge con
chiarezza dai due esempi seguenti.
Il primo viene nel testo dopo l’altro ma non importa. E’ il
cacciavite nell’orecchio di Rorty. Cos’è tutta questa storia
del dibattito fra professori che fanno una battuta, e uno la fa
sparire dagli atti a stampa e l’altro invece ce la mette? Ci
manca effettivamente un Goldoni che sviluppi il canovaccio.
Il secondo è lo Sfero di Empedocle. Empedocle avrebbe
potuto essere riconosciuto Budda come il suo quasi
contemporaneo Siddharta, se solo la storia fosse giusta.
Purtroppo le cose andarono diversamente ed Eco oggi, senza
ricevere anatemi dai buddisti empedocliani, può definire il
ciclo cosmico di Empedocle come “mobile, metamorfico,
metempsicotico,
compulsivamente
riciclante,
inveterato
bricoleur…”
Il punto non è l’inveterato bricoleur con i
puntini. Il punto è: perché il nome di Empedocle non
compare fra i famosi 55? Non vi compare Goethe dell’attimo
bello, né Dante a cui mancò possa. E la “gaja scienza”, che
sarà anche di Leopardi, è soprattutto di Nietzsche con
retrosapori di Heidegger e Vattimo. Queste, e altre citazioni
anonime e allusioni che di sicuro mi sono perso e che non ho
la pazienza di ricercare, perché? Sì, sì, son tutte cose
risapute e non c’è bisogno di dirle fra di noi. Ecco, è il “fra
di noi” che mi dà noia. Io vedo come un ammiccare fra
professori, quasi un:
“Accettiamo scommesse su chi
indovina”.
Citare Tizio, Caio e Sempronio, alludere a X, Y, e Z,
presumere che tutti abbiano studiato non solo le opere
precedenti dell’autore ma anche la letteratura critica di
16
contorno, sono cose che fanno soltanto i professori
universitari di pessimo gusto.
Ma Eco non sa il danno che provoca nei lettori,
specialmente giovani, con quel suo modo di scrivere? Con la
sua autocompiacenza e il suo esibizionismo? E il rifiuto e il
rigetto irrecuperabili che provoca in chi si accosta ai suoi
libri non dico verso la filosofia, che forse non è più altro che
una materia accademica, ma verso l’amore per la verità e per
la ricerca della sapienza?
17
5. IL DOVERE PROFESSIONALE
E veniamo al contenuto filosofico del saggio.
Inizia dichiarando che parlerà dell’essere nel suo senso
più vasto e impregiudicato e termina esortando ad andare
incontro all’essere con gaiezza per coglierne le aperture e gli
accenni mai troppo espliciti. L’inizio è chiaro, anche se ci
sono volute tre pagine per dire quello che sta in un rigo, e la
conclusione è positiva. Farebbe ben sperare se nella
premessa non ci fosse detto, fra parentesi, che la riflessione
filosofica non risolve le ambiguità nell’uso del termine
“essere”. Allora dobbiamo smettere subito di leggere?
Nemmeno l’ultimo rigo: “Il resto è congettura” aiuta
granché. Non dubito che Eco teorizzi, da qualche altra parte,
qualcosa su congettura e ipotesi e ne individui tre o quattro
tipi differenti in modo da parlarne per un bel pezzo. Ma
messo lì secco, a mo’ d’epitaffio, quel rigo ha un suono
vagamente minaccioso, come di abbandono eterno
all’inconoscibile.
Però non scoraggiamoci subito. La prima domanda da
porsi è: quanto c’è di Eco in questo saggio?
Il percorso fra quell’inizio e quella fine oscilla dai
confronti metafisici con Aristotele, Nietzsche, Heidegger e
Vattimo alle indicazioni semiotiche di Peirce, Hjelmslev ed
Eco stesso.
Nell’introduzione all’intero volume
“Kant e
l’ornitorinco”, lui stesso, spiegando il perché del saggio
“Sull’essere”, dichiara:
“Non si tratta di delirio di
onnipotenza, bensì di dovere professionale”. Forse basterebbe
questa ammissione per dimostrare il mio giudizio iniziale.
Ma innanzi tutto è fuori del testo, e io mi sono preso il
compito di fare il pignolo su un saggio preciso: lì devo
18
trovare le conferme. E poi gli autori generalmente, nelle
introduzioni, prefazioni, post-fazioni, risvolti e risguardi,
dovunque presentino i loro lavori, fanno mostra di umiltà per
suggerire il contrario. E’ questo il caso di Eco?
No, lui è sincero. Solo in un delirio di onnipotenza
potrebbe credere di dire qualcosa di personale sull’essere. Ed
è vero che tutto ciò che sull’essere fiocamente traspare di
profondo dal saggio di Eco non è di Eco , ma è patrimonio
dell’umanità conquistato per noi dai veri filosofi che osarono
il delirio di onnipotenza. Quello che è di Eco è il “dovere
professionale” con tutte le sue regole e gelosie cattedratiche.
Il primo paragrafo del suo saggio sembra quasi rivolto ai
professori delle porte accanto, titolari delle cattedre di
Filosofia Teoretica, o di Storia della Filosofia, o dovunque si
nasconda e venga spezzettato lo studio dell’essere nelle
università. Sembra che Eco dica a ciascuno di loro: “Scusa,
sai, se io professore di semiotica invado il tuo campo, ma
sono autorizzato da Peirce e Hjelmslev”.
E a me lettore che importa? Se si parla dell’essere
parliamo dell’essere, senza tanto preoccuparci su chi poi
interrogherà ai prossimi esami, ai quali comunque io lettore
non mi presento.
Eco, dopo questa rivendicazione di competenze, per dieci
paragrafi tratta il suo argomento in termini più o meno
metafisici. Nel penultimo paragrafo torna sulla sua cattedra e
traduce quanto ha detto dalla luce della metafisica alla luce
della semiotica di Hjelmslev: l’essere diventa il continuum
del contenuto e le linee di resistenza diventano sensi vietati.
Tutto qui. Diciamo allora brutalmente come stanno le cose:
Eco ha finalmente scoperto la metafisica se non addirittura la
filosofia.
19
Si ritorni all’introduzione al volume e si rilegga la
seconda ragione per cui non ha scritto un aggiornamento del
suo “Trattato di semiotica generale”. Negli anni, dice, si era
reso conto di due cose: primo, che nella seconda parte del
suo “Trattato” presupponeva senza esplicitarlo che se
parliamo è perché “Qualcosa” ci spinge a farlo; e secondo,
che dai limiti dell’interpretazione culturale e testuale era
stato spinto a chiedersi se non esistano limiti più profondi.
Questo significa, come ho detto, che Eco ha scoperto la
metafisica. Scoperta, è chiaro, come problema suo, non come
libri letti e studiati. In più Eco avverte di non essere capace
di architettare un capovolgimento sistematico della sua
filosofia. Qui il mio cuore si è aperto e l’ho riconosciuto
fratello in questa valle d’ignoranza.
Subito dopo, però, aggiunge che forse nessuno può farlo
da solo e comincia a parlare in semiotichese. Il mio cuore si
è richiuso. Stava parlando del suo testo universitario e non di
una crisi sulla via di Damasco che, come ognun sa, prelude
sempre a grandi opere.
Per non ingannarmi avrei dovuto continuare a leggere la
citazione di dianzi: “Non si tratta di delirio di onnipotenza,
bensì di dovere professionale. Come si vedrà, parlo dell’Essere
solo in quanto mi pare che quello che c’è ponga dei limiti alla
nostra libertà di parola.”
Finalmente siamo al nocciolo di ciò che Eco ritiene suo
nel saggio: le linee di resistenza dell’essere e i sensi vietati
del continuum.
20
6. I LIMITI DELL’ESSERE
Visto che Eco parla dell’essere solo perché gli pare che
ponga dei limiti alla nostra libertà di parola, ci si
aspetterebbe che il problema dei limiti, delle linee di
resistenza, dei sensi vietati fosse messo subito al centro
dell’attenzione.
Invece no. Il primo accenno esplicito a un limite è nel
nono paragrafo, quando parlando di Nietzsche dice che “egli
avverte l’esistenza di costrizioni naturali”. Fino a quel momento
ha parlato dell’essere, degli enti, dell’evidenza
insopprimibile sia dell’essere che dell’esistenza degli
individui, della polisemia
e dell’aporia dell’essere
aristotelico, delle soluzioni per sfuggire all’aporia, del
linguaggio poetico e di un modello di conoscenza del
mondo. Finalmente, quando l’essere si sta dileguando con
Vattimo, per bocca di Nietzsche appaiono le costrizioni
naturali.
Che parlare dell’essere, fin da prima di Parmenide,
comporti anche distinguerlo almeno dal nulla e dal divenire
lo sappiamo tutti. Che parlare degli enti e degli individui
significhi anche parlare dei confini che separano un ente da
un altro ente e un individuo da un altro individuo è pacifico.
Che tutto ciò, proprio perché notissimo, si dia per implicito
in un saggio filosofico è concesso. Non si capisce però,
quando si voglia creare una nuova teoria della conoscenza,
cercare cioè “qualcosa di resistente” che ci spinge “a
inventare termini generali (la cui estensione possiamo sempre
rivedere e correggere)”, per quale motivo Eco non parta da
quei nobili e antichi precedenti, ma li lasci sottintesi per due
terzi del saggio, parlando d’altro.
Poi, nelle ultime sei pagine, viene al suo argomento:
“Quello di cui parlo non è la Legge delle leggi. Cerchiamo
21
piuttosto d’individuare delle linee di resistenza, magari mobili,
vaganti, che producono un ingripparsi del discorso, così che pur
nell’assenza di ogni regola precedente sorga, nel discorso, il
fantasma, il sospetto di un anacoluto, o il blocco di un’afasia.”
Parlando così, di che cavolo stiamo parlando? C’è
bisogno d’una logopedista? Ce l’ho in famiglia.
Da una tale premessa circa l’esigenza di un “Limite”
dell’essere che ci impedisca (Dio volesse!) di parlarne a
caso, non si poteva che fare un salto stratosferico nella
metafisica più rarefatta, quella di Heidegger, e scoprire “la
fondamentale esperienza di un Limite che il linguaggio può dire
anticipatamente… l’esperienza della Morte… quel limite che è
l’essere-per-la-morte”. Solo dopo aver fatto questa
fondamentale esperienza, ci ammonisce Eco, scopriamo altri
limiti, tipo quello che da un cane e un gatto non nasce nulla.
Se questo non bastasse per una teoria del limite come
base della conoscenza umana, ci possiamo rivolgere alla
semiotica di Hjelmslev dove l’essere diventa il continuum,
anzi in danese mening che in italiano vuol dire “senso”, non
solo nel senso di significato ma anche nel senso di direzione.
E
questo
essere-continuum-mening-senso-significatodirezione “può non avere un senso, ma ha dei sensi; forse non
dei sensi obbligati, ma certo dei sensi vietati. Ci sono delle cose
che non si possono dire.” E in conclusione: “Il linguaggio non
costruisce l’essere ex novo: lo interroga, trovando sempre e in
qualche modo qualcosa di già dato… Questo già dato sono
appunto le linee di resistenza.”
Cos’è quest’affastellamento di parole, questo rincorrersi
di banalità, astrattezze metafisiche e minuzie semiotiche?
Cos’è questo partire da un punto, le “linee di resistenza”,
fare un bel giro di metafore e tornare al solito punto? E’
l’apporto di Eco alla teoria dell’essere e dei suoi limiti.
22
Facciamo pure un’analisi più dettagliata e cominciamo
intanto dalle premesse: c’è qualcosa; siamo gettati
nell’essere; l’essere si dice in molti modi ; ogni enunciato su
ciò che è, e su ciò che potrebbe essere, implica una scelta,
una prospettiva, un’angolatura. Da queste premesse sorge la
prima domanda: “Significa questo che una vale l’altra, che tutte
sono egualmente buone, che ogni affermazione su ciò che è dice
qualcosa di vero…?”
A questa domanda ne seguono altre otto dello stesso
tenore: cosa ci impedisce di credere che tutte le prospettive siano
buone? Cosa ci impedisce di credere che l’essere sia effetto del
linguaggio del mito e della poesia, puro flatus vocis? Ci sono
interpretazioni cattive? Quali garanzie ci autorizzano a tentare un
nuovo paradigma? Qual è il criterio che ci permette di distinguere
tra sogno, invenzione poetica, trip da acido lisergico e
affermazioni accettabili sulle cose del mondo fisico o storico che
ci circonda? Quale regola nuova la Comunità deve preferire e
quale altra condannare come follia? Esiste uno zoccolo duro
dell’essere tale che alcune cose che diciamo su di esso non
debbano essere prese per buone? Esiste uno zoccolo duro
dell’essere tale che le cose dette dai poeti siano riferibili a un
mondo possibile ma non al mondo dei fatti reali?
Queste domande si snocciolano da pagina 31 all’inizio di
pagina 37, inframmezzate con le divagazioni su Nietzsche e
Vattimo che riportano sempre a questi punti di domanda
senza mai azzardare una risposta; ripeto: senza mai azzardare
una risposta.
Certo, per rispondere a queste domande si dovrebbe tirar
fuori un’ontologia e una gnoseologia, un’etica e un’estetica,
una teoria della storia e una teoria delle scienze fisiche, una
politica e persino un trattato sull’acido lisergico. Non ci
aspetteremmo tanto, ma qualcosina sì.
E una risposta di Eco appare, a pagina 37 poco sotto
l’ultima domanda e subito dopo il blocco dell’afasia: “Se
23
assumessimo che dell’essere si può dire tutto non avrebbe più
senso l’avventura della sua interrogazione continua. Basterebbe
parlarne a caso. L’interrogazione continua appare ragionevole e
umana proprio perché si assume che ci sia un Limite.”
Questa non è una risposta, ma una petizione di principio
si sarebbe detto una volta. Assume come premessa la
conclusione da dimostrare. Tutte quelle domande di prima
chiedono proprio se vi sia qualcosa che ci salvi dalla perdita
di senso e dal caso. E siccome, risponde Eco, non vogliamo
perdere il senso e abbandonarci al caso, qualcosa ci sarà e lo
chiamiamo “Limite”. E’ appunto un pio desiderio che
vorrebbe dimostrare se stesso.
Tralascio, perché ne parlo dopo, i poeti, i mondi possibili
e le regioni dell’essere di cui non siamo in grado di parlare.
Siamo dunque al punto in cui viene in soccorso
Heidegger con l’esperienza di quel limite che è l’essere per
la morte con i trattini , e l’esperienza spicciola dei cani che
non figliano con i gatti. Vale a dire che sperimentiamo il
“Limite” sia metafisicamente che in maniera semplice e
immediata nella zoologia;. Inoltre è stato dimostrato, con
logica purtroppo fallace, che il “Limite” ci salva dal caso e
dalla perdita di senso. Ora possiamo abbandonarci alla lirica.
Riassumo Eco: affermare che ci siano le linee di resistenza
non vuole ancora dire che ci siano leggi universali operative
in natura, tuttavia ci spingono a inventare termini generali
sempre rivedibili e correggibili; e la realtà in ogni caso
rifiuta interpretazioni false.
Come? Dove? Quando? Chi? Perché? Sono domande
oziose. L’importante è volare infine nel cielo mistico:
“L’apparire di queste Resistenze è la cosa più vicina che si possa
trovare … all’idea di Dio… che si presenta come pura Negatività,
puro Limite, puro No”.
24
Da una sì grande altezza non si può che cadere; e infatti
tutto ad un tratto ci viene detto che il nulla e la negazione
sono puro effetto di linguaggio e che l’essere si presenta
sempre in positivo.
E il puro No, il puro Limite, la pura Negatività? Niente;
scherzavamo; giochi di parole: “Correggiamo allora un’altra
metafora, che ci è apparsa così comoda per ragioni retoriche, per
‘mettere sotto gli occhi’ ciò che si voleva suggerire. L’essere ci
oppone dei ‘no’ nello stesso modo in cui ce li oppone una
tartaruga a cui chiedessimo di volare.” Di conseguenza il limite
perde la maiuscola e dall’essere dove trionfava solo per
metafora si ritira in noi con l’umile minuscola: “Ma il limite
è nel nostro desiderio, nel nostro tendere a una libertà assoluta”.
Ed anche la Morte, maiuscola e metafisica, diventa un
capriccio da ragazzini: “La stessa morte appare come limite a
noi, che capricciosamente vorremmo vivere ancora…”
25
7. I RISPETTOSI CONFRONTI POLEMICI
Non basta. Torniamo all’introduzione al volume. Eco vi
apre una parentesi (dice così esplicitamente, poi in effetti ne
apre sette) per chiarire la sua posizione rispetto alla
“proposta di pensiero debole il cui copyright apparteneva da
tempo a Vattimo.”
Per aver partecipato nel 1984 a una
raccolta di scritti sul pensiero debole, Eco veniva arruolato,
nel doppio “ambito dei mass media” e “di certa pamphletistica
popolare”, tra i “debolisti tout court”. Orbene, specialmente
nel nostro saggio Eco ribadirà “anche attraverso alcuni
rispettosi confronti polemici” di essere stato allora casomai tra i
“debolisti deboli” e non tra i “debolisti forti” perché “C’è
differenza tra dire che non possiamo capire tutto (una volta per
tutte) e dire che l’essere è andato in vacanza (anche se ritengo che
nessun ‘debolista’ sia mai arrivato a tanto).”
Dio mio, ma che mondo è questo? Copyright? Debolisti
di tre tipi? Mass media e pamphletistica popolare? Rispettosi
confronti polemici?
E per questo dovrei scomodare l’essere, Parmenide,
Aristotele e san Tommaso? Bastava scrivere due pagine dal
titolo “Alcune postille su certi detti di Vattimo a proposito di
Nietzsche e Heidegger” e pubblicarle in qualche oscura
rivista universitaria.
Comunque questi squarci dell’introduzione illuminano
parte dell’andamento del saggio “Sull’essere”, oltreché
delimitare bene in quale mondo si muova l’autore. Si capisce
cioè per quale ragione si passi da una prima parte, la
premessa e i primi cinque paragrafi, di stampo, diciamo così,
greco-latino-francese alla seconda parte di stampo
germanico. Nella prima parte infatti c’è la scoperta della
metafisica e la sua rivendicazione alla semiotica fin dal
primo vagito filosofico. Nella seconda si consumano i
26
famigerati confronti polemici non tanto con Vattimo, che
stando all’introduzione non c’entrerebbe nulla e
bisognerebbe prendersela con la “pamphletistica”, ma con la
metafisica moderna che è quasi esclusivamente tedesca.
Tramite questi confronti con Heidegger, Nietzsche e
Vattimo, Eco tenta di annettere alla sua semiotica alcuni temi
di questi autori.
Abbiamo già visto l’uso che fa Eco dell’essere-per-lamorte di Heidegger per teorizzare i suoi limiti dell’essere.
L’altro tema di cui cerca di appropriarsi è quello del
linguaggio dei poeti nella sua relazione con la conoscenza
dell’essere.
Esaminiamo come Eco tratta quest’ultimo tema.
L’argomento viene introdotto appunto tramite Heidegger,
con la sua divisione fra il linguaggio senescente della
metafisica e il linguaggio forte dei poeti, dove si attuerebbe
l’autodisvelamento dell’essere.
Eco avverte subito che l’idea è antica e trova le sue
origini nella mistica e nella teologia negativa. E giustamente
salta agli albori dell’epoca romantica, quando in verità
cominciò il processo di riduzione della conoscenza
scientifica ad ambiti specialistici e nello stesso tempo il
discorso poetico assurse sempre più a strumento privilegiato
di conoscenza. Qui finalmente Eco dice l’unica frase bella ed
asciutta del saggio, se levasse le maiuscole: “Non sono i
Poeti a vincere, sono i Filosofi ad arrendersi.”
Anche qui ci attenderemmo che affrontasse di petto
l’argomento dell’arte come conoscenza e che disboscasse la
superfetazione dell’estetica che c’è stata in questi ultimi
duecento anni. La quale, da una parte, ha condotto la
filosofia in strade senza uscita; e dall’altra, ha succhiato
all’arte la sua vitalità e l’ha ridotta a posa. Che fa invece?
27
Come narcotizzato dal fatto di essere cattedratico di
semiotica, si getta nelle braccia del suo amato Peirce e tira
fuori una risibile dimostrazione che non è consentito
presupporre l’inconoscibile in partenza. E poi osserva che i
poeti non dicono l’essere, ma lo emulano; e spolvera l’ “ars
imitatur naturam in sua operatione”, quando nella pagina
precedente aveva liquidato la concezione dell’arte come
imitazione di un’imitazione fra le vecchie teorie che
andavano da Platone a Baumgarten. Aggiunge che il
linguaggio dei poeti non produce un sovrappiù di essere, ma
un sovrappiù di interpretazione. E dopo si appoggia su una
ipotetica seconda estetica di Heidegger, con la sua
terminologia direi superfetistica se esistesse questo
aggettivo. Questa seconda estetica, secondo Eco: “non ci
dice che nel discorso dei Poeti si svela l’essere. Ci dice che il
discorso dei Poeti non sostituisce la nostra interrogazione
dell’essere, bensì la sostiene e la incoraggia.”
E finalmente conclude, non senza citare prima un veloce
detto di Peirce, che “l’esperienza dell’arte non è qualcosa di
radicalmente diverso dall’esperienza del parlare di Qualcosa, nella
filosofia, nella scienza, nel discorso quotidiano. Ne è al tempo
stesso un momento e un correttivo permanente.”
Così dicendo liquida l’arte e la poesia, il che non sarebbe
male; ma le liquida senza accorgersene, tanto è vero che alla
fine rivaluta i poeti: il che è male.
A questo punto ci viene presentato il modello di
conoscenza del mondo dell’ottavo paragrafo. In sé è un utile
esercizio mentale per gli studenti: qui ha il solo scopo di dare
una base semiotica alla sua rivendicazione di temi e parole di
Heidegger e di Aristotele. Infatti inizia il paragrafo
successivo così: “Abbandoniamo ora il nostro modello, poiché
esso si è trasformato nel ritratto (realistico) del nostro essere
28
gettati nell’essere, e ci ha confermato che l’essere altro non può
essere che ciò che si dice in molti modi.”
Da qui cominciano le divagazioni su Nietzsche e Vattimo,
che, per ciò che riguarda i limiti dell’essere, non fanno che
ripetere e specificare l’interrogativo iniziale di Eco, come
abbiamo visto prima. E per ciò che riguarda l’arte
aggiungono poche pennellate al quadro.
Per Eco, Nietzsche vede la verità come un esercito di
metafore e antropomorfismi elaborati poeticamente, non
riconosce alcun valido metodo di avanzamento delle verità
scientifiche e il cambiamento è possibile solo
“come
rivoluzione poetica permanente”. Da queste premesse si esce
solo in un sogno ingannatore “e sarebbe il dominio dell’arte
sulla vita” oppure, continua Eco, se ne esce con la filosofia
di Vattimo: “l’arte può dire quello che dice perché è l’essere
stesso, nella sua languida debolezza e generosità, che accetta
anche questa definizione…”, cioè quella del sogno ingannatore
e del dominio dell’arte sulla vita.
Siamo all’essere che si dilegua e a un’ontologia retta da
categorie deboli. Vale a dire, siamo ai rispettosi confronti, il
cui limitato interesse si può misurare dal variare delle nove
domande di prima. In più da Vattimo Eco trae le “proposte
‘poetiche’ di mondi altri”.
E una volta catturata questa
espressione, la inserisce subito nell’ultima domanda delle
nove: i poeti si riferiscono a un mondo possibile distinto dal
mondo dei fatti reali. Qui c’è la volata lirica: “Di un’altra
regione dell’essere fanno parte i Mondi Possibili”. In questi
mondi possibili, stranamente, fra le locomotive, le radici
quadrate e le geometrie non-euclidee, Eco non cita più il
linguaggio dei poeti. C’è però l’ascesa mistica: “E’ possibile
che esistano anche regioni dell’essere di cui non siamo in grado di
parlare.” Questo viene concesso sulla presunzione “che un
giorno l’umanità possa elaborare linguaggi diversi da quelli noti.”
29
Sottolineo che nei paragrafi dieci e undici non si parla
mai dei poeti o dell’arte; vi si teorizzano le resistenze
dell’essere insieme ai sensi vietati, con in più gli accenni a
queste eteree regioni dei mondi possibili e di quelli
ineffabili. I poeti ricompaiono in chiusura.
Dunque, riassumendo: per ciò che riguarda l’arte e la
poesia come strumento di conoscenza dell’essere, primo, non
sono i poeti a vincere, sono i filosofi ad arrendersi; secondo,
l’esperienza dell’arte non è diversa dall’esperienza del
parlare nella filosofia, nella scienza, nel parlare quotidiano.
Fin qui sono affermazioni coerenti, banali, che anch’io come
tanti potrei sottoscrivere. Purtroppo il vizio accademico di
parlare dei problemi non direttamente ma attraverso altri
autori, con confronti rispettosi o no, porta inevitabilmente a
contraddizioni, oscurità, presupposti, in un viluppo di
terminologie fuori contesto.
Che vuol dire che i poeti non dicono l’essere ma lo
emulano? Che significa che il linguaggio dei poeti non
produce un sovrappiù di essere, ma un sovrappiù di
interpretazione? Quando “i Poeti ci invitano a riprendere a
ogni istante il lavoro dell’interrogazione e di ricostruzione del
Mondo” fanno qualcosa che solo loro possono fare o lo fa
anche la filosofia? La seconda affermazione di sopra
nell’originale continua come abbiamo visto: “Ne è al tempo
stesso un momento e un correttivo permanente”. Bene: questo
correttivo lo fa solo l’esperienza dell’arte? Se così fosse
l’arte sarebbe diversa dalla filosofia, e quanto radicalmente
diversa sarebbe secondario perché in effetti senza l’arte
l’essere non si conoscerebbe in nessun modo.
Oscurità e contraddizioni che rendono, non dirò faticoso,
ma inutile qualunque tentativo di interpretazione.
Inutilissimo sarebbe andare a cercare il filo logico in
30
Heidegger, che ha discusso i problemi per i suoi scopi e non
per quelli di Eco. Alcuni o molti lo fanno in simili casi; e
così facendo si allontanano ancor di più dai problemi veri e
si avviluppano nei rimandi, nelle citazioni e cioè nelle
chiacchiere.
Similmente con Nietzsche e Vattimo. Eco vuol
riaffermare una visione dell’essere positiva e non debolista,
in cui “Il linguaggio non costruisce l’essere ex-novo” ma trova
sempre un “già dato”, su cui in qualche modo sia possibile
basarsi per interrogare l’essere e coglierne le aperture, cioè
per intraprendere e continuare il percorso inesauribile della
conoscenza. Ottimo proposito.
Oscurato dal rispetto accademico; che non è rispettoso,
non è troppo, non è poco. E’ inutile e dannoso; e affoga
nell’oscurità l’intento stesso. Eco aveva un progetto
sacrosanto? Bene: doveva fregarsene di Nietzsche e di
Heidegger che tanto sono morti, e tacere su Vattimo a cui si
augura lunga vita. E citare questi filosofi, e altri ancora, solo
di sfuggita e quando non ne poteva fare a meno, badando
solo al filo del proprio ragionamento. Facendo come invece
ha fatto si avviluppa nelle loro terminologie e tematiche,
autorizza il sospetto di un’appropriazione indebita a favore
della sua cattedra e rende il tutto sfocato e contraddittorio.
Per restare ai poeti, che del “già dato” su cui basare la
conoscibilità del reale ho parlato prima a proposito dei limiti
dell’essere, Eco domanda se esista uno zoccolo duro per cui
le cose dette dai poeti siano prese per buone solo se riferite a
un mondo possibile e non al mondo dei fatti reali. Qui Eco
pensa all’ermeneutica di Vattimo, con le proposte poetiche di
mondi altri? E se invece i poeti si riferissero al mondo dei
fatti reali, che facciamo? Li mettiamo in galera? Gli si ride
31
dietro? Inutili domande che non aspettano nessuna inutile
risposta.
Torniamo sulla terra: non sono i poeti a vincere, sono i
filosofi ad arrendersi. Ed Eco si arrende. Il suo scopo non è
nemmeno quello di lottare. E’ quello di essere presente e
dibattere, di sottilizzare e chiosare, di fraintendere e
precisare: l’eterno rimestare accademico.
E a riprova del circuito inconsistente delle
argomentazioni ci possiamo rileggere la chiusa del saggio
dove ricompaiono i poeti. Che c’entrano i poeti? Non
cercavamo a questo punto la regola nuova comunitaria? Il
linguaggio dei poeti, ci era stato detto, non era niente di
radicalmente diverso da quello della filosofia, e in più ci
espone da duecento anni a enormi rischi di fraintendimento.
Perché allora sono i poeti a dirci che bisogna andare incontro
all’essere con gaiezza? E i filosofi non ce lo potevano dire?
O i filosofi devono limitarsi alla congettura, così almeno
continua il rimestio?
Io non voglio certo sostituire qui una mia filosofia a
quella di Eco. Mi limiterò ad osservare che quella sua
scoperta della metafisica scopre in verità l’intrinseca
debolezza della semiotica. E il suo tentativo di ribattezzare in
termini semiotici la metafisica esistenziale e l’ontologia
dell’arte rivela non “una galassia in espansione”, come lui
dice, ma l’esaurimento dei temi propri della semiotica. Viste
le tradizioni che hanno alle spalle la metafisica contro la
semiotica, o anche l’estetica contro la semiotica, non è
difficile prevedere che sarà la semiotica a sparire; e se ne
rimarrà qualcosa, saranno poche analisi sparse.
32
8. LA NOTA 14
Ci sono infine da esaminare le regioni dell’essere, quella
dei “Mondi Possibili” e quelle “di cui non siamo in grado di
parlare”. Ho già segnalato la stranezza che le cose dette dai
poeti vengono prese per buone quando si riferiscono a un
mondo possibile e quando invece si parla dei mondi possibili
i poeti non vengono nemmeno rammentati. Ora segnalo
l’ulteriore stranezza dell’essere diviso in misteriose regioni
mai discusse né prima né dopo. E per far vedere a tutti i
pericoli che si corrono quando si parla tanto per parlare
domando: che bisogno c’era di tirar fuori le regioni di cui
non siamo in grado di parlare? Innanzi tutto, anche solo
evocandole, Eco ne parla ed è una prima contraddizione. Poi
ci dice che forse un giorno se ne potrà parlare. Se si potrà
fare in futuro, si sarà fatto certamente anche in passato. E
infatti fino a duecento anni fa nessuno parlava delle
geometrie non-euclidee ed oggi lo fa anche Eco. Allora
queste regioni sono il mistero che circonda le poche cose che
conosciamo e che la filosofia, la matematica e le scienze
aggrediscono di continuo con nuovi linguaggi? Ed anche: ci
sono decine di teorie estetiche che dicono che ogni poeta
inventa un suo linguaggio. Le regioni di cui oggi non si può
parlare sono i mondi di cui parleranno i futuri poeti? O
finalmente: che differenza c’è fra queste regioni ineffabili e
il puro “Limite” e il puro “No” “di cui il linguaggio non deve
o non può parlare”?
Tutte stranezze, contraddizioni, oscurità che nascono da
un periodo di nessuna utilità messo lì per caso.
C’è un’ultima cosa da esaminare che rivela forse l’unico
aspetto veramente sentito del saggio. Si tratta della nota 14 e
33
di certe risonanze nuove che questa nota estrae da alcuni
passi, in parte già esaminati.
In pratica la nota 14 è un altro finale del saggio,
incomparabilmente migliore di quella filippica edificante sui
poeti che gli è stata preferita. Già questa scelta di mettere il
finale migliore fra le note basterebbe a provocare rabbia e
ribellione verso l’autore.
Nella nota Eco rammenta Luigi Pareyson e rende
omaggio alla sua “Ontologia della libertà”. Ora non ci
interessano i distinguo fra ciò che è di Pareyson e ciò che è
di Eco e le precisazioni rispetto a Heidegger e Aristotele.
Vediamo quello che Eco ne ricava.
All’inizio: “Così come nutriamo l’aspirazione all’immortalità,
e il desiderio di volare, aspiriamo sempre alla promessa che esista
da qualche parte una zona di libertà assoluta. Ma è proprio la
libertà che pone il Limite.”
E alla fine: “Ancora prima di Dio l’essere ci viene incontro
con dei ‘no’, che altro non sono che l’affermazione che alcune
cose, noi, non possiamo dirle. Noi avvertiamo come Resistenza
questo avviso profondo e nascosto che espone a rischio continuo
(compreso il rischio del male) ogni nostra ricerca di verità e ogni
nostra affermazione di libertà.”
Qui non siamo nel chiacchiericcio. Però non siamo
nemmeno nella filosofia. Siamo ai presupposti di ogni
filosofia: c’è un mistero che ci mette a rischio del male, della
falsità, della non libertà e insieme c’è il nostro desiderio di
volare, di immortalità, di libertà assoluta. Da qui è sempre
nata e sempre nascerà la buona filosofia.
Io immagino che Eco, come tutti gli uomini arrivati a una
certa età, improvvisamente si sia trovato davanti l’ultima
domanda: “E poi?”
Non una domanda libresca. Dentro. Certo che a quella
domanda ognuno reagisce secondo il suo vissuto. Eco si è
34
chiesto: “perché Qualcosa ci spinge a parlare?” ed anche: ci
sono limiti che “si annidino più in profondo”? Le risposte che
ha dato finora a questa che ho chiamato la sua scoperta della
metafisica sono frutto della maledizione logorroica da cui
non riesce a liberarsi. Purtuttavia la domanda è sorta e il
presupposto c’è; gliene va riconosciuto il merito.
Da queste considerazioni prendono nuova luce almeno
due aspetti del saggio. Il primo, già da me sbrigativamente
deriso, è quella che Eco chiama “la fondamentale esperienza
di un limite”, l’esperienza della morte che può essere detta
anticipatamente. Da un punto di vista teorico su un limite
siffatto non si può costruire nulla. Dal punto di vista umano,
però, quel limite è sentito da tutti; e costituisce esperienza
profonda su cui non è lecito scherzare; e io su questo non ho
scherzato.
L’altro aspetto è il Dio che aleggia nel saggio e la cui
esistenza viene, direi, quasi dimostrata sulla fine
dell’undicesimo paragrafo. O almeno auspicata e desiderata.
“Questo già dato sono appunto le linee di resistenza.
L’apparizione di queste Resistenze è la cosa più vicina che si
possa trovare, prima di ogni Filosofia Prima o Teologia, alla idea
di Dio o di Legge. Certamente è un Dio che si presenta (se e
quando si presenta) come pura Negatività, puro Limite, puro ‘No’,
di cui il linguaggio non deve o non può parlare.”
E come avviene in questi casi fin dal primo, preistorico
fremito religioso, non se ne deve parlare ma se ne parla. Ed
Eco ne parla come una qualunque teologia negativa, con
metafore e personificazioni e arriva, con l’aiuto di san
Tommaso, a rintracciare una sostanziale parentela del suo
Dio col Dio delle religioni rivelate. Il profumo di sacro
pervade tutta l’aria e basterebbe a testimoniarlo la cascata di
maiuscole nel brano che di nuovo ho citato.
35
Purtroppo ho una riserva anche su quest’ultimo aspetto
del saggio. Per buttar giù queste mie osservazioni ho dovuto
ricercare la mia vecchia copia di “Come si fa una tesi di
laurea”. Mi ha subito colpito l’ultima avvertenza
nell’introduzione, dove Eco praticamente si scusa, e
seriamente, di usare le parole “studente” e “professore”
anche nel significato di studentessa e professoressa. Mi ha
assalito una folla di vecchi ricordi di contestazioni
femministe e studentesche. E via via che saltavo fra le pagine
riemergevano gli studenti lavoratori, Gramsci, le radio libere,
lo zen a San Francisco, le tesi di laurea politiche: in una
parola, il clima universitario degli anni settanta. Orbene, tutti
siamo figli del nostro tempo; ma non ci sarà in Eco
un’adesione ipertrofica alle mode del momento? Oggigiorno
sono di moda Dio, il papa e la religione. Questa scoperta del
“Qualcosa” che ci spinge a parlare, del “Limite” che è
quanto di più vicino a Dio, non sarà solo una moda senza
nessun aggancio profondo?
Forse hanno ragione certi avversari di Eco che di lui
hanno sempre evidenziato l’opportunismo e la smania di
emergere fin da quando militava nell’Azione Cattolica.
Comunque non m’interessa la sua storia personale, resto al
saggio che ho analizzato e al profilo di lui che ne è emerso.
Di sicuro Eco, se tenesse a freno la sua erudizione invece
di farsene dominare, potrebbe anche scrivere qualcosa di
valido, dopo essersi liberato, beninteso, dall’ossessione di
essere in libreria tutti gli anni con un libro nuovo, e sui
giornali tutti i giorni con un articolo. Se potessi gli darei un
consiglio: di ritirarsi per cinque anni in un convento, o nella
sua villa in campagna se ce l’ha, e lì fare opere di
contrizione, di rinuncia, di silenzio, di solitudine, di ascesi e,
dopo, scrivere un saggio di non più di 100 pagine, e senza
36
citazioni, o un romanzo di non più di 200 pagine. Forse
queste opere sopravviverebbero.
37
9. GIUDIZI E PREGIUDIZI
Non ce l’ho con Umberto Eco. Ma confesso di avere
verso di lui un vecchio pregiudizio di cui non mi curo
particolarmente di liberarmi e che, purtroppo, nelle
sporadiche frequentazioni coi suoi scritti mi si rinnova
sempre.
Questo pregiudizio risale proprio alla mia prima lettura di
“Come si fa una tesi di laurea”. Godo nell’abbandonarmi
anch’io al vizio dell’autocitazione e così riporto un passo
del mio diario che è nient’altro che un giornale di letture:
“21 ottobre 1977
Nell’ultimo mese ho letto (o riletto) quattro libri: Umberto
Eco “Come si fa una tesi di laurea”, Della Corte e Paolini
“La mistificazione”, Schucking “Sociologia del gusto
letterario”, Maremmi “L’agenda dello scrittore”. Per primo
ho letto il libro di Umberto Eco che mi ha ridato il gusto per
le schede di lettura; perciò di questi quattro libri ho fatto
ampie schede, dove ho riportato citazioni, sunti e impressioni
varie. Pertanto qui sul diario non voglio ripetermi; voglio
soltanto tirar giù un’impressione generale e un confronto.
Ebbene, i primi due libri di sopra, a parte la loro validità
manualistica o di documento, sono due libri vecchi. Si
rifanno a una visione del mondo sorpassata, postulano una
società che non esiste più o non è mai esistita. Gli altri due
libri invece, lo Schucking e il Maremmi, fanno presa piena
sulla realtà, sono libri vivi e aiutano a capire quella parte del
mondo che prendono in considerazione. Ognuno
naturalmente ha pregi e difetti propri , tutt’e quattro. Ma
quella che ho detto è la sostanza di fondo che regge
l’insieme, o, se si vuole, la caratteristica della personalità
38
degli autori. Tutt’e quattro parlano in senso lato dello
scrivere, di come, quanto e che cosa scrivere perché poi
qualcuno legga. Ciascuno però da un angolo particolare, ma
dal quale è possibile ricavare la visione che l’autore ha
dell’attività letteraria.
‘Come si fa una tesi di laurea’ di Umberto Eco è un libro
pregevole per studiosi e saggisti, mentre per gli studenti è
una dannosa tentazione a buttar via tempo e fatica per fare
una tesi di laurea seria e inutile. Utili le indicazioni per la
schedatura, le bibliografie, la battitura e l’eventuale stampa
dei testi ecc.. Ma questo libro è falso, fuorviante, per ciò che
riguarda la serietà scientifica, l’entusiasmo per lo scrivere e
il leggere, la caramellosa (o suina) immagine della tesi:
‘Fare una tesi significa divertirsi e la tesi è come il maiale,
non se ne butta via niente.’
Ah, non lo so! Forse della tesi non si butta via niente, ma di
dottori che hanno scritto tesi se ne butta via a centinaia di
migliaia, a milioni, a decine di milioni in tutto il mondo.
Quello che sorregge tutto questo libro è un mondo
accademico putrefatto e irrigidito nei suoi privilegi e
paludamenti. Anche la fortuna commerciale del libro
dipende dal fatto che ha sicuramente un milione di
compratori, perché questo è il numero degli iscritti alle
università. A me Umberto Eco fa nello stesso tempo invidia,
sbigottimento e fastidio. Invidia perché poteva stare a Parigi
a studiare san Tommaso e perché scrive e ha successo con
facilità. Sbigottimento perché non riesco a capire come
faccia a essere tanto sicuro e felice della serietà scientifica
delle sue opere. E fastidio per quel suo metter bocca su tutto,
fare il saccente, citare questo e quello e non darti mai la
sensazione che l’umanità nel suo insieme sia qualcosa di
grande, valido, sublime e tragico.”
39
A distanza di ventitré anni non ho cambiato una parola,
perché il mio giudizio generale su Eco rimane quello di
allora. E mi congratulo con me stesso per la mia
lungimiranza.
Per scrivere questo mio saggio avevo ben chiaro che
dovevo limitarmi fermamente all’analisi del testo di Eco
“Sull’essere” senza farmi distrarre da altri suoi scritti se non
quei pochi che avevo già letto e per quel tanto che me ne
ricordavo.
Questa esigenza rispondeva pienamente allo scopo che ho
dichiarato: auspicare un modo nuovo di scrivere filosofia
mostrando un campione di come non si deve scrivere. Non
volevo, e l’ho detto, sostituire nessun’altra filosofia a quella
di Eco. Per questo era necessario ignorare per quanto
possibile ciò che non era nel saggio “Sull’essere”. Ed era
necessario esaminare il testo da fuori del suo mondo, dal
punto di vista della lingua italiana comune, del buon gusto e
della misura; e poi della coerenza interna, della chiarezza dei
suoi scopi e dell’efficacia delle argomentazioni portate a
sostegno.
Alla fine però mi sono levato una curiosità. Ho preso in
prestito da una biblioteca pubblica cinque libri teorici di Eco,
compreso il “Trattato”, e li ho sfogliati. Qualcosa ho saltato,
qualcosa ho letto, qualcosa ho letto due volte. Non mi sono
nemmeno sognato di analizzare altri testi come ho fatto col
saggio “Sull’essere”.
In genere ho saltato le minuzie analitiche: gliele concedo
tutte. Sull’insieme, evidentemente, non posso esprimere
nient’altro che un’impressione generale: si avverte come un
senso di soffocamento. L’”esempiese”, che Eco fa finta di
40
deplorare da qualche parte e che è invece tutta la fantasia di
cui sia capace, ti toglie il respiro e costringe il cervello ad
appiattirsi in terra e a contare le briciole. Quando parla di
altri autori, o li usa in “esempiese” o mostra come non siano
semiotici come lui. Non ha nessuna capacità di sintesi; dopo
il “Trattato” non ha scritto niente di organico e se ne
dichiara incapace, come abbiamo visto. E le analisi a che
servirebbero? Non si sa, sembrano fine a se stesse; forse
sono l’unico acquisto e non sembra un grande acquisto. Una
volta ci si poteva illudere che la semiotica aprisse chissà
quali orizzonti verso l’intelligenza artificiale, la vera
informatica o la logica formale: tutti progetti abortiti o fuori
portata.
Del resto lo stesso Eco rivendica: “Il discorso di una
semiotica generale ha lo statuto di un discorso filosofico”, cioè
non è un discorso scientifico; “che ogni discorso teorico abbia
lo statuto di discorso ‘scientifico’… è solo un idolum tribus”. Ma
poi vedo che sacrifica parole a questo idolum e si dichiara
fiero di aver posto negli anni sessanta quella che poi sarebbe
diventata la riduzione dell’analogico al digitale nella
televisione; e fiero di vedere nel codice genetico dei biologi
come un’applicazione inconscia della semiotica.
Sul piano filosofico, poi, i due punti su cui più ribatte
sono: primo, la polemica contro la deriva decostruttiva delle
misinterpretazioni di un testo; e, secondo, la caldeggiata
generalizzazione della semiotica nella teoria della
conoscenza, basata sul processo abduttivo di Peirce e
chiamata perciò “fallibilismo” e da ultimo “realismo
contrattuale”.
Sul primo punto basta uscire dalla ristretta cerchia dei
semiologi per rendersi conto dell’ovvietà dell’assunto: tutta
la storia della critica letteraria e filosofica è un richiamo
41
continuo ai testi e a ciò che di essi non si può dire e che altri
invece dicono. Il difficile casomai è capire perché questo
processo sempre si ripropone e come faccia a risultare
positivo.
Sul secondo punto, la teoria della conoscenza, ho già
mostrato ampiamente l’inconsistenza delle argomentazioni di
Eco. Al di fuori del saggio “Sull’essere”, sul solito punto,
c’è un’altra caterva di chiacchiere, ma un unico elemento in
più: “Quale regola nuova la Comunità deve preferire, e quale
altra condannare come follia” che a pagina 35 del saggio
“Sull’essere” veniva ricercata e domandata col punto
interrogativo, alla fine viene scoperta. La regola nuova che la
comunità può e deve accettare come valida tappa della
conoscenza, nel suo percorso fallibilista, viene ogni volta
sancita dagli esperti, innanzi tutto uscendo “da una ontologia
forte” e poi “Escogitando una ontologia indebolita della Mente
della Comunità (i cui rappresentanti privilegiati sono, a seconda
dei settori, gli Esperti).” Questo a pagina 261 di “Kant e
l’ornitorinco”; e farebbe venir voglia di gettare il volume
fuori dalla finestra.
E’ una concezione falsa anche solo perché è meschina.
Senza dubbio Eco immagina se stesso fra gli esperti che
giudicano: un collegio di docenti universitari che cooptano
un collega con la sua nuova teoria. Una visione corporativa
della vita spirituale che di per sé farebbe auspicare una legge
che vieti ai professori universitari di scrivere libri. Ed è una
concezione pericolosa. Se il collegio degli esperti che
devono giudicare i libri di Eco fosse composto da me, mia
moglie e i miei sei figli, e se giudicassimo Eco non solo
nulladicente ma lo condannassimo al rogo, lui che fa?
Contesta il collegio degli esperti o brucia tranquillamente?
42
Da che mondo è mondo gli esperti non solo hanno
decretato ciò che era vero e ciò che era falso, ma hanno
anche inflitto le meritate pene a chi diceva il falso. E così gli
esperti ateniesi di morale della gioventù condannarono
Socrate alla cicuta; e gli esperti della legge a Gerusalemme
condannarono Gesù come bestemmiatore; e gli esperti
teologi romani costrinsero Galileo all’abiura e bruciarono
Giordano Bruno. Con tutto ciò, siamo ancora alla ricerca di
“Esperti” con la e maiuscola? addirittura “rappresentanti
privilegiati”
della “Mente della Comunità”, con le
maiuscole?
Se dopo trent’anni di studi semiotici si arriva a scrivere
simili bestemmie, è evidente che c’è qualcosa che non
funziona nella semiotica, o in Eco, o in tutt’e due.
Ma basta con Eco e concludo: per il saggio “Sull’essere”
di Umberto Eco confermo il mio giudizio del primo rigo, ora
ampiamente provato. Il re è nudo e non c’è modo di dirlo con
parole gentili se non facendo finta che sia vestito.
Maggio-Giugno 2000
43