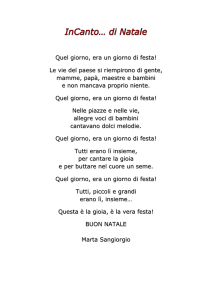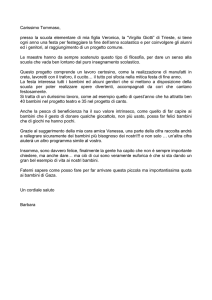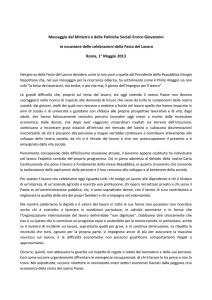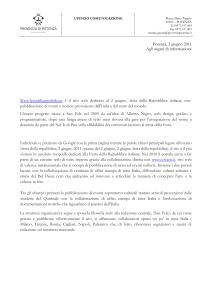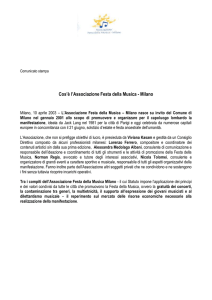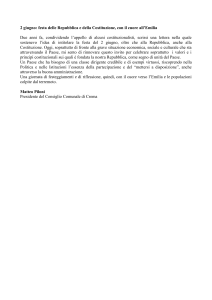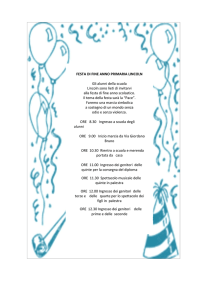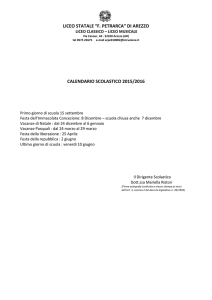Katia Ballacchino
ETNOGRAFIA
DI UNA PASSIONE
I Gigli di Nola tra patrimonializzazione e
mutamento ai tempi dell’UNESCO
Armando
editore
Sommario
Ringraziamenti
9
Nota introduttiva
13
Parte prima: Discorsi
19
Capitolo I: Questioni di patrimonio
I.1L’Italia dei beni immateriali
I.2Antropologia e patrimonio festivo
I.3Una festa “buona da pensare”
21
21
34
40
Parte seconda: Etnografie
45
Capitolo II: I campi e le scelte metodologiche
47
II.1Premessa su una festa al plurale
47
II.2L’arrivo in città. Un luogo, delle caratteristiche
54
II.3 Le fonti contese: tra scelte di appartenenza e intimità culturale 62
II.4 Tempo totalizzante e pratiche mobili: sta festa tanne nasce,
81
quanne more
II.5 Vivere al “centro” e in equilibrio
98
II.6 Il linguaggio e la pratica del visuale come spazio d’incontro 108
Capitolo III: Dire o fare la festa tra il materiale e l’immateriale:
l’orgoglio di essere nolani
III.1 I dubbi della devozione: una storica contesa di poteri
III.2 La pratica della questua e la reciprocità dello scambio:
l’economia delle “tavuliate”
III.3Le ingegnose guglie e l’artigianato delle botteghe d’arte
III.4L’assordante linguaggio della musica
119
119
134
143
162
III.5Le donne: una moderna invisibile visibilità
III.6 La festa innata: di generazione in generazione
III.7Incorporare la festa
III.7.1 Corpi segnati: teatri della distinzione
174
183
196
200
Capitolo IV: Paranze tra condivisione, conflittualità
217
e appartenenza
IV.1 L’associazionismo dei cullatori: motore concreto e simbolico217
IV.2 Il capoparanza tra leadership, organizzazione e gerarchia
228
del sociale: ‘o professore
IV.3 La FT e l’onore della maglia: fare la differenza
252
IV.3.1 Il web e la “piazza virtuale”: un anonimato
276
che consente la denuncia
Capitolo V: Dislocazioni e contesti migratori
V.1 Migrante per indole
V.2Il proliferare dei Gigli: tratti e conflittualità
di una caratterizzazione regionale
V.3 Il Giglio a New York: un secolo di migrazioni
V.5Praticare passione, diventare comunità
285
285
Parte terza: Riflessioni
325
Capitolo VI: Politiche e strategie di patrimonializzazione
VI.1L’UNESCO e il Patrimonio Immateriale
VI.2Prime candidature: un capolavoro mancato
VI.3 Dall’Università ai Fori Imperiali: lo spettacolo
della tradizione come icona della patrimonializzazione
VI.4Comunità in rete tra politiche locali e politiche globali
VI.5 Sulle manipolazioni di passioni: l’antropologo
e i suoi confini
327
327
330
Bibliografia
Sitografia
Filmografia
363
393
394
287
302
321
340
348
359
Ad ogni nolano/a che ha permesso di
farsi incontrare, ascoltare, osservare e seguire senza riserve
e in particolare alla memoria di Paolino Iorio
che mi ha insegnato, più di chiunque altro a Nola,
a comprendere una festa corporea
nel limite, prima, e in assenza, poi, del corpo
Ringraziamenti
Come accade sempre, un lavoro che coincide con oltre 9 anni di vita
meriterebbe ringraziamenti a ciascuna delle persone che in un modo o
nell’altro hanno contribuito a produrne ogni riflessione. Ma in questo caso
sarebbe un’impresa chimerica. Mi limito, dunque, a rendere esplicita la
mia gratitudine ad alcune figure che hanno emblematicamente segnato il
mio percorso di vita personale, accademico e di campo in questi anni, lasciando agli interstizi delle pagine che seguono i riferimenti ai numerosi protagonisti di questa ricerca. Scusandomi per le eventuali, inevitabili,
mancanze.
Per quanto riguarda la vita affettiva, ringrazio la mia famiglia che asseconda da sempre la mia passione per la ricerca e in particolare Valeria e
Paolo, che con l’arrivo di Chiara hanno fatto acquisire peso e valore alla
mia distanza. Un’amica con la quale condivido la dedizione per la ricerca
e molto di più, Valeria Rosato, con la quale procedo sin dagli anni universitari nella necessità di ricordarci vicendevolmente le nostre motivazioni
sostanziali, per non mollare.
Per il mio percorso accademico, la guida generosa e autorevole di Luigi
M. Lombardi Satriani, che ha sempre seguito i miei passi indicandomi la
strada e che ha creduto in questo volume, prima ancora che ci credessi io.
Tre antropologhe, ma prima di tutto tre amiche, che con il loro esempio
hanno concorso in modo diverso a mostrarmi che questa professione può
diventare speciale quando è praticata da donne intense. Letizia Bindi, che
negli anni da maestra è diventata un esempio di tenacia umana e forza
scientifica che trova la sua narrazione nel quotidiano lavoro comune in
Molise. Alessandra Broccolini, che con la sua generosità intellettuale mi ha
indicato la strada dei Gigli e con cui oggi condivido lo sguardo, il sentire
e la passione per la straordinaria potenza etnografica campana e non solo.
Mara Benadusi, con la quale e grazie alla quale ho iniziato anni fa – e continuo oggi – a pensare forte.
9
A Francesco Faeta, Lello Mazzacane, Paolo Apolito, Dino Palumbo,
incrociati in questi anni in dibattiti pubblici o rintracciati fra le pagine dei
contributi che più stimolavano le mie riflessioni, porgo la mia gratitudine
per avermi offerto ciascuno in modo diverso stimoli produttivi.
A Bianca Spadolini, che ha accettato di pubblicare il volume nella collana di Antropologia della casa editrice Armando che dirige.
Questo lungo viaggio umano e professionale mi ha, inoltre, regalato
scambi scientifici d’oltreoceano divenuti poi amicizie, grazie alle quali ho
affinato lo sguardo sul mio campo locale: Joseph Sciorra, Luisa Del Giudice e Laura A. Ruberto.
Tra i numerosi nuclei familiari nolani a cui mi sono dedicata è doveroso ringraziarne in particolare alcuni, perché oltre ad essere stati testimoni privilegiati, sono divenuti per me una famiglia sul campo: Nina Iorio,
Francesco Castaldo e Antonio D’Elia, della cui storia e memoria mi hanno
resa custode, traendone io stessa ogni giorno insegnamenti di vita e immenso affetto; Giovanni Iorio e Maria Napolitano, con i loro dolori e gioie
che sono ormai diventate anche le mie; Nicola Sangermano e Annamaria
Rubino, dei quali testimonio l’unione nella vita, intrecciata all’amicizia e
alla passione per i Gigli; la famiglia Mazzeo a Nola con Pasquale, Mimma,
Enzo, Gabriele e Pietro; le famiglie Corvino, Dente e Manna (e in particolare la memoria di Felice) a Williamsburg, nelle cui case ho trovato riposo
e fiducia per attribuire volti e nomi all’etnografia.
I gruppi festivi, i comitati e le associazioni: La Contea Nolana con Antonio Napolitano; Meridies con Angelo Amato de Serpis; Vittorio Avella e
la sua arte esterna ma sempre da stimolo intellettuale alla festa; il Giglio
Boys Club Nola-New York con la famiglia Criscuolo; la Compagnia di San
Paolino con Luca De Risi; gli Innamorati della festa con Antonio D’Ascoli; quella che è stata l’Ente Festa per diversi anni e quella che è oggi la
Fondazione Festa dei Gigli con Raffaele Soprano; le botteghe d’arte Tudisco, Scotti, Nal; artigiani e artisti, musicisti, cantanti e parolieri, nessuno
escluso. Le amministrazioni comunali che si sono susseguite e la Diocesi
di Nola, che in certi casi hanno contribuito ad aggiungere spunti di riflessione e ulteriore opportunità alla ricerca.
Le paranze di cullatori dei Gigli incontrate in questi anni, che sono state
la mia lente di ingrandimento sulla festa: La “San Massimo” di Nicola Trinchese, I “Volontari” di Peppe Cutolo, la “Stella” di Giuseppe Guerriero e
poi del figlio Lello, la “Pollicino” di Gennaro Pollicino, la “Risorgimento”
di Paolino Vecchione (Saccone) e Felice Nappi, La “Franzese” di Nello
10
e Antonio Franzese, la “Simpatia” di Ciccio Chiaravalle, La “Regina” di
Felice Marotta, “Orgoglio Nolano” di Luca Iorio e le paranze forestiere.
In particolare, poi, non posso che essere debitrice ed estremamente riconoscente nei confronti dei cullatori, dei giglianti e dei tifosi sui quali
mi sono concentrata e attraverso i quali ho vissuto la festa dal di dentro,
partendo da singole storie per comprendere la collettività: la paranza “Fantastic Team” o “FT” di Vincenzo Scala. Che, inoltre, ha fatto sì che questo
volume diventasse in qualche modo un “oggetto festivo”, decidendo di sceglierlo come dono da regalare ai partecipanti della questua del Giglio del
Sarto del 2015 per festeggiare il ventennale della paranza – i cui maestri di
festa ringrazio simbolicamente per tutti: Vincenzo Scala, Guido Lombardi,
Franco Rinaldi, Agostino Della Chiana, Carlo Fusco, Fabio Barbato, Lino
Sorrentino. Esprimo tutta la mia gratitudine, quindi, indistintamente a tutti
gli almeno trecento “FanTastici”, molti dei quali sono citati, fotografati o
“sottintesi” nelle pagine seguenti in relazione a specifiche questioni. I caporali, i cullatori di varra e di varretiello, quelli di destra e quelli di sinistra,
quelli ncopp’ e quelli ncann’ ’e varre, quelli di cantone, gli allazzatori di
varre, chi “porta l’acqua”, le famiglie, i bambini e le donne che seguono
i Gigli. Per tutte Sabrina Iorio e la sua famiglia, per avermi insegnato con
un comune e intenso linguaggio di amicizia cosa significa a Nola essere
“gigliante”, pur essendo donna. Inoltre, a lei e in particolare a Paolo Peluso, come agli altri fotografi citati nelle didascalie delle immagini usate,
va un ringraziamento per lo straordinario supporto visivo offerto a piene
mani nell’ottica di narrare insieme la festa, anche attraverso il loro sguardo
competente o appassionato.
Infine, ringrazio coloro che potrebbero definirsi “non giglianti” e coloro
che non hanno un ruolo riconosciuto nel sistema festivo, perché sono stati
essenziali per guardare la festa in controluce.
I limiti del volume dipendono dalle mancanze di chi scrive e dalla necessità di aver dovuto fare delle scelte di narrazione o determinate dal tempo, mentre la sua forza, se mai ne avesse, deriva da queste e da molte altre
persone citate o dimenticate nella frenesia della scrittura finale e dalle loro
storie, che in maniera porosa ho cercato di assorbire e rielaborare e senza le
quali l’etnografia non sarebbe diventata quella “narrazione densa” – limitata al tempo della ricerca e, dunque, da intendersi in senso istantaneo e non
certo esaustivo o assoluto – che vorrebbe essere contenuta qui.
11
Nota introduttiva
“Etnografia di una passione” è il titolo che ho voluto dare a questo
lavoro monografico, per sottolineare la dimensione della ricerca concentrata sulle passioni quotidiane, su quelle che potremmo definire “emozioni
patrimoniali”, che regolano equilibri e rapporti tra chi pratica, vive e usa
la festa di cui si scrive qui. Ma passione, alla fine – come spesso capita
per gli studiosi che adoperano la ricerca sul campo intensiva ed estensiva
come metodologia di indagine – ha finito per provarne anche l’antropologa
nei confronti della sua stessa ricerca. Si è trattato, infatti, di uno studio che
ho voluto portare avanti nel lungo periodo e che ho scelto di vivere con
forte vicinanza agli stessi protagonisti, come spesso capita agli antropologi quando condividono anni di studio, ma anche di vita, con le persone indagate. Questo aspetto di coinvolgimento è divenuto chiaramente la
cifra dell’intensità dei rapporti che ho istaurato e che, probabilmente, ha
condizionato il lavoro, nel bene e nel male. In antropologia, come è noto,
ogni ricerca dipende indubbiamente dai soggetti di studio ma anche dal
ricercatore che “partecipando” alla loro vita prova a “osservarla” tentando di superare il più possibile la condizione ossimorica dei due termini
metodologici costitutivi. In questo specifico caso ho preferito lasciare il
più possibile che la mia stessa passione nei confronti della ricerca rimanesse leggibile lungo queste pagine, a partire dalla scelta di una scrittura in prima persona, perché credo che essa abbia determinato in maniera
consistente i risultati di questo lavoro. E anche perché in questo modo la
stesura potesse mantenersi il più possibile radicata, familiare e, quindi, più
prossima agli stessi protagonisti della ricerca, che rimangono per impegno
di restituzione i primi destinatari di questa monografia, oltre agli specialisti antropologi.
Il volume raccoglie i frutti di un’indagine antropologica svolta nell’arco
temporale di più di 9 anni, iniziata nel 2006 a Nola, in provincia di Napoli,
13
per un progetto pensato in seno a un Dottorato di Ricerca in Etnologia ed
Etnoantropologia, svolto presso la Facoltà di Lettere della “Sapienza” Università di Roma, ma che poi è proseguito ben oltre la dissertazione della
tesi, avvenuta nel 2009.
A Nola da diversi secoli si volge la festa dei Gigli, cerimoniale particolarmente interessante dal punto di vista antropologico, che descriverò
nei dettagli nella seconda sezione del volume. Su questa tradizione si è
svolta un’etnografia nei termini disciplinari più classici, sostanziata dal
cambiamento continuo di punti di vista e prospettive come vuole la più
recente metodologia etnografica definita “multi-situata”, che prevede che
si seguano flussi e cambiamenti contemporanei del terreno indagato, fino a
giungere a spostare il focus o il luogo di indagine in cui essa si svolge, se
è lo stesso campo a richiederne la necessità. Questa festa, molto nota nella
letteratura antropologica, raccoglie ancora oggi passioni e coinvolgimenti
numerosissimi e trasversali alle più diverse dimensioni generazionali di
diverse località. Siamo ogni anno nell’ordine di diverse migliaia di protagonisti che si impegnano in prima persona e con le rispettive famiglie a
mantenere viva una tradizione che ne segna profondamente la vita sociale,
politica, economica, culturale ed emozionale. Nonostante questo istituto
festivo sia noto in ambito scientifico e nonostante sia stato oggetto di numerosi lavori, soprattutto di letteratura locale, questo studio vuole riflettere
in termini nuovi sulla città di Nola e sul suo legame col cerimoniale nel
corso dell’anno di vita cittadina.
L’approccio utilizzato nell’indagine su questo complesso insieme di
rituali fatto di pratiche e saperi tradizionali costantemente rinnovati e dunque sempre moderni è, da un lato, lo studio approfondito dei significati antropologici celati dietro a una “comunità di pratica” patrimoniale numerosa
ed eterogenea, che non trascuri i diversi altri luoghi in cui si svolge un rito
similare nella stessa regione Campania o in contesti di dislocazione migratoria d’oltreoceano, come in Nord America. Dall’altro lato, recentemente
si è rintracciata nello scenario globale una potente assunzione in chiave patrimoniale dei saperi e delle pratiche tradizionali, dovuta alle nuove normative internazionali UNESCO con la Convenzione per la Salvaguardia del
Patrimonio Culturale Immateriale del 2003, ratificata in Italia nel 2007.
Questa rivoluzione normativa su scala internazionale ha determinato
non pochi interessanti cambiamenti nei paesi interessati dalla Convenzione.
In particolare per lo Stato italiano l’esempio dei Gigli di Nola rappresenta
un interessante caso “buono da pensare” nella doppia lente di un’antropo14
logia del patrimonio e dei processi di patrimonializzazione, come anche in
quella di un’antropologia delle istituzioni locali e sovralocali.
La recente (4 Dicembre 2013) iscrizione della festa dei Gigli nella Lista Rappresentativa UNESCO del Patrimonio Immateriale dell’Umanità
(Ballacchino, 2014c, p. 239), in un’ottica innovativa di candidatura di rete
italiana di feste con grandi macchine cerimoniali portate a spalla, è l’epilogo di una storia complessa di ben altri tre precedenti tentativi singoli di
candidature della stessa festa.
Si rintraccia in questo senso una torsione della rappresentazione pubblica del mondo tradizionale in bene culturale: un insieme di saperi e pratiche,
profondamente ancorati ai diversi territori, in cui si mescolano antichi mestieri tarati su professionalità e interessi sempre innovativi e contemporanei; un legame antico tra le comunità territoriali e il mondo tradizionale, ma
anche moderne tecnologie di adattamento alle pratiche rituali, una progressiva esasperazione delle performances del trasporto collettivo delle macchine cerimoniali, un sempre maggior interesse del mercato turistico verso
il ‘mondo della tradizione’ come risorsa per lo sviluppo dei territori, etc.
Ma dietro a questo adattamento all’UNESCO e alle nuove traiettorie di
senso, intimo e pubblico, delle località che sembrano necessitare sempre
più di essere riconosciute all’esterno, rimangono passioni intime ed emozioni locali, attività devozionali, interessi familiari, economici e politici,
saperi e pratiche ereditate di generazione in generazione, valori specifici
delle comunità, etc. la cui visibilità spesso viene celata nella rappresentazione mediatica dei processi di patrimonializzazione pubblici e che forse
solo grazie a un’indagine etnografica di lungo periodo possono venire alla
luce.
Un volume, quindi, che a partire dall’approfondimento di un caso di
studio particolarmente interessante, nell’ottica dell’analisi di un granello di
sabbia per riflettere sul mondo, come direbbe Geertz, tenta di ragionare in
termini di antropologia del patrimonio immateriale, del rito, ma anche delle istituzioni e dei processi identitari che storicamente si vanno articolando
e ripensando in un’epoca in cui le istituzioni internazionali come l’UNESCO segnano la via giuridica della tutela dei beni meritevoli di essere riconosciuti di valore per l’umanità, producendo inevitabilmente gerarchie,
competizioni e conflitti tra le realtà locali. E proprio per indagare la località
durante la ricerca si è scelto di vivere a Nola per lunghi periodi, intessendo
quotidianamente una fitta rete di rapporti che hanno permesso di eseguire un’indagine in profondità sulla comunità protagonista del cerimoniale
15
che conta migliaia di individui pienamente impegnati nell’organizzazione
dell’intero anno “giglistico”. La profonda consuetudine di rapporti, vicinanza e intimità che si è creata con la comunità indagata, come dimostrano i dati messi in luce lungo il lavoro, hanno permesso di acquisire a chi
scrive una legittimazione a stare sul territorio e di individuare le più intime
dinamiche relazionali e sociali che sostanziano la festa nel contesto locale.
L’indagine, che ha cercato di non trascurare nessuno degli aspetti della festa, si è concentrata poi sullo studio intensivo di una delle “paranze”, cioè
di un gruppo di “portatori” della macchina da festa e della loro organizzazione gerarchica, sociale, valoriale e di potere.
Pensato in tre sezioni, Discorsi, Etnografie, Riflessioni – con un ampio
spazio dedicato alla seconda sezione costituita da quattro capitoli sul lavoro di ricerca sul campo – il volume tenta di partire dalla letteratura classica
sul tema della festa, dialogando però oltre che con le diverse fonti locali,
anche con la letteratura internazionale attenta al rapporto tra il locale e il
globale che intercetta e modifica la produzione di cultura, le migrazioni e
le problematiche e complesse strategie di patrimonializzazione che investono oggi i beni demoetnoantropologici. E proprio nel quadro di un’analisi dei processi contemporanei che condizionano la produzione di cultura,
come fanno per esempio i fenomeni migratori, si è svolta una parte dell’etnografia in contesto nordamericano, per indagare la dislocazione secolare
della festa a Williamsburg, distretto di Brooklyn, da parte della comunità
italoamericana residente a New York e non solo.
La metodologia utilizzata per la ricerca nei vari luoghi si è avvalsa di
diversi strumenti, con un’attenzione particolare alla dimensione visuale,
ritenuta centrale nella vita quotidiana della comunità festiva nolana. L’uso
della vasta produzione video e fotografica dei molti momenti festivi durante il corso dell’anno e non esclusivamente durante il giorno di festa, non
è stato però solo di tipo documentaristico. La scelta di condivisione con i
protagonisti delle centinaia di ore di filmati – girati a Nola come a New
York e in altri contesti di migrazione della festa – si sono rivelati una preziosa pratica di acquisizione di dati fondamentali sulla vita comunitaria che
altrimenti sarebbero rimasti opachi a uno sguardo esterno, sul rituale, sulla
sua “incorporazione” e sui suoi aspetti più interni al sistema emozionale e
sociale. In un momento in cui la festa stessa riverbera in maniera esponenziale le conseguenze di un’iper-documentazione visiva, acuita anche dalla
sovraesposizione mediatica contemporanea dovuta alla corsa verso il riconoscimento UNESCO, sono partita dallo studio critico delle fonti (locali e
16
non), anche visive, giungendo ad una riflessione sulla dimensione visuale
come pratica e spazio di incontro con gli interlocutori indagati.
A partire dalla classica interpretazione del “tempo festivo” come tempo
ludico, separato dal tempo quotidiano di fatica e lavoro, si è tentato di ragionare criticamente su un’interpretazione del tempo festivo come “tempo
totalizzante” che tesse rapporti sociali, economici e politici durante tutto
l’anno, reinventa dinamiche relazionali, rafforza sentimenti, produce conflittualità, supporta azioni di potere, attiva processi di costantemente rinnovata significazione del quotidiano e genera “comunità di pratica” connesse
alla comune “passione” per la festa.
Attraverso l’indagine della migrazione, sia reale che virtuale – su quella
che può intendersi come una “piazza virtuale” – si sono analizzati i contesti
più diversi di dislocazione della festa dei Gigli, come quello di Brooklyn.
Ma le migrazioni rilevate sono anche di ordine regionale, dove molteplici
“copie” dei Gigli proliferano di paese in paese; e poi ancora la promozione turistica del territorio attraverso la ballata della macchina cerimoniale
all’estero o in Italia per la sponsorizzazione della candidatura UNESCO.
Eventi locali e sovralocali che hanno visto protagonista la festa dei Gigli,
il cui monitoraggio ha dato luogo a una riflessione critica sulle strategie di
potere celate dietro i processi di patrimonializzazione dei beni immateriali
e del rischio della loro “spettacolarizzazione” e manipolazione da più parti
e su piani differenziati: politici, intellettuali, sociali, etc.
Si è ricostruita, quindi, l’indagine di un rituale come fabbricazione della
dimensione locale e di rimodulazione dei suoi confini attorno a tematiche
più globali. In questo senso il festivo è uno strumento che inserisce nella
dimensione locale quella globale, per mezzo del suo radicamento al passato ma soprattutto grazie a pratiche ibride, al suo carattere mutevole, alla
sua tensione perennemente al passo coi tempi e, dunque, sempre contemporanea. Questa festa che diviene, quindi, “buona da pensare”, rappresenta l’espressione culturale della località ma è pure, all’interno del contesto
geografico e storico-politico in cui si celebra e in cui viene “utilizzata”, un
quadro di elementi fissi ma potenzialmente e di fatto mutevoli e permeabili
che determinano concezioni del mondo e differenze con l’esterno. L’istituto festivo sembra quasi divenire per gli attori locali una lente d’ingrandimento del mondo, un vero e proprio “fatto sociale totale”, intorno al quale
si esplicita un’effervescenza collettiva, si narra la propria intimità culturale
e attraverso cui la dimensione identitaria, nella temperie contemporanea, si
cimenta a fissare il proprio ruolo e la propria presenza, grazie ai mezzi con
17
cui la stessa si muove, si modifica nel tempo e acquista senso e significato
diverso. La cultura è intesa in senso mobile, dinamico, processuale e plurimo e l’istituto festivo ne canalizza e rispecchia perfettamente i cambiamenti e i meccanismi di mutamento in termini rituali e performativi.
Attraverso l’analisi in profondità dell’organizzazione e della creatività
quotidiana attivata attorno ai Gigli, si è indagato lo spettro di tensioni ermeneutiche che riguardano il rapporto complesso tra globalizzazione della
cultura e dimensione locale dell’appartenenza, secondo un’antropologia
che attraverso l’“etnografia multi-situata del sistema mondo” di Marcus
analizza i flussi culturali globali, rincorre gli spostamenti dei migranti, problematizza i confini del terreno di ricerca. I principali dibattiti avviati oggi
nelle retoriche pubbliche chiamano in causa concetti come comunità, località, partecipazione dal basso, sussidiarietà orizzontale, bene comune, comunità patrimoniale e di eredità. E forse questi andrebbero indagati attraverso lavori etnografici su specifiche realtà articolate, terminali di sistemi
più estesi a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale; in particolare osservando la festa, come direbbe Bourdieu, si registra un interessante
campo di interazione conflittuale tra gruppi di attori che aspirano a gestire
il potere a vari livelli. Inoltre, è indispensabile riflettere, con Herzfeld, sui
cortocircuiti che possono rintracciarsi nei processi di messa in valore dei
beni demoetnoantropologici immateriali, quando la “gerarchia globale del
valore” a cui si rifanno sistemi internazionali come l’UNESCO, tende a
non tenere in conto i valori locali insiti e propulsori del patrimonio immateriale, che determinano la differenza e la diversità culturale.
Come nota a margine occorre specificare, poi, che questo testo non può
soddisfare le esigenze di esausitività di un oggetto culturale complesso
come la festa dei Gigli ma vuole essere un tentativo di interpretazione rivolto a due tipologie di lettori: a quelli più strettamente accademici o comunque agli studiosi di antropologia, ma anche e soprattutto agli stessi
protagonisti della festa che hanno contribuito a far sì che questo lavoro
potesse avere vita. Quindi si tratta di un piccolo contributo a una storia antropologica italiana che ragiona a partire da una circoscritta fetta di paese,
ma anche e soprattutto un volume che sente il senso e il peso della restituzione di una ricerca che ha prelevato a lungo tempo e spazio dalla vita
dei protagonisti. Infine, occorre precisare che diverse parti di questo testo,
opportunamente segnalate, sono state pubblicate in forme simili in altre
sedi e sono il frutto di discussioni multidisciplinari avviate in convegni e
seminari nazionali e internazionali avvenute lungo gli anni di lavoro.
18
Parte prima
Discorsi
Capitolo I
Questioni di patrimonio
I.1 L’Italia dei beni immateriali1
La prima e lungimirante definizione di beni culturali “volatili” fu di
Alberto Mario Cirese (1991; 2002, pp. 66-69; 2007). Nel suo concetto di
volatilità risiede l’idea della condizione necessaria che i beni culturali debbano riprodursi e debbano essere rieseguiti ogni volta per poter essere socializzati e fruiti. Nel dibattito internazionale sul patrimonio culturale, che
negli ultimi decenni vede più impegnati gli studiosi di antropologia in contesto italiano, al termine “volatile” si è preferito quello di “immateriale”,
mutuato dalla traduzione francese della legislazione giapponese del 1948
(Law for the Protection of Cultural Properties), mentre nel mondo anglosassone è l’espressione “intangibile” ad essere più utilizzata. Tuttavia, al
di là del termine scelto per definirli, la caratteristica di vitalità dinamica
e di dimensione “effimera” di questi beni, che rinvia a tutte le necessarie
accortezze da usare in un’azione di salvaguardia, tutela e valorizzazione
degli stessi, rimane costante. E in questo senso la festa dei Gigli di Nola,
se indagata a partire dai processi di patrimonializzazione che l’hanno coinvolta negli ultimi quindici anni, si inserisce perfettamente in una lunga e
oggi più che mai vivace riflessione sulle retoriche, sulle politiche e sulle
pratiche legate al relativamente nuovo concetto di “patrimonio culturale
immateriale”, nella sua specifica traduzione italiana (Mariotti, 2008, pp.
91-104). A partire innanzitutto dal dibattito nazionale che su questo concetto si è avviato investendo in pieno gli studi, le ricerche e le politiche di
valorizzazione culturale dei territori, quella del patrimonio immateriale è
una delle questioni che oggi impegna molti degli studiosi di antropologia
e non solo. Una sorta di premessa teorico-metodologica diviene necessaria
1
Questo capitolo è una rivisitazione dell’articolo: Ballacchino, 2014a, pp. 17-31.
21
per pensare buone pratiche di sviluppo locale, a partire da una postura critica e riflessiva quale è quella antropologica, sul legame tra ciò che si intende per patrimonio, territori, comunità e identità locali. Termini come tradizione, autenticità, mutamento, eccellenza, eredità, comunità patrimoniale,
partecipazione, diventano i cardini di un intenso processo di ridefinizione
delle identità locali e della riflessione sulle diversità culturali, in risposta
proprio all’introduzione del concetto di “intangible heritage” formalizzato
a livello internazionale dall’UNESCO (Lèvi-Strauss, 2005). La nozione di
antropologia del patrimonio culturale deriva, infatti, anche dal prevalere
della nozione di patrimonio sia nella legislazione europea (Fabre, 1994;
Ariño, 1999, pp. 167-188; 2000, pp. 9-35; 2002a; 2002b, pp. 129-150;
Matarasso, 2006, pp. 50-62; Zagato, Vecco, 2011) che nella terminologia
dell’UNESCO (Ariño, 2005; Zagato, 2008; Clemente, 2011, pp. 72-78).
Le conseguenze e lo spirito de La Raccomandazione per la Salvaguardia
della Cultura Tradizionale e del Folklore stilata dall’UNESCO nel 1989,
della creazione di programmi come Il Sistema dei Tesori Umani Viventi
del 1994, de La Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio Orale e
Immateriale dell’Umanità del 1997 e della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003, fino all’ultima recente Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società
del 2005 – seppur molto diversa nei contenuti e relativa alla Convenzione
Quadro del Consiglio d’Europa (Ferracuti, 2009, pp. 655-670) –, nei loro
adattamenti alle legislazioni nazionali degli Stati firmatari dell’agenzia
internazionale e nelle diverse interpretazioni e applicazioni locali avviate
nei processi di riconoscimento dei beni culturali immateriali, diventano il
tema centrale di un interessante dibattito internazionale. Dibattito che vede
gli antropologi impegnati in prima linea e fautori essi stessi, forse per la
prima volta con questa incisività, della stessa definizione, legittimazione
e patrimonializzazione dei valori tradizionali delle comunità locali. La dimensione del dibattito internazionale e poi nello specifico quella italiana
– che si vedrà essere stata per sua natura particolarmente attenta ai concetti
di tradizione, folklore e beni culturali – è tracciata proprio in relazione alle
politiche UNESCO in materia di patrimonio immateriale che negli anni
hanno fatto mutare gli indirizzi di studi, la postura critica degli stessi e i
processi politici e di ricerca sui beni culturali. Ultima e particolarmente
importante in questo senso è proprio la notizia del 2013, annunciata dal
ministero per i Beni e le Attività Culturali secondo cui l’Italia ha, seppur
tardivamente, firmato la Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul
22
valore dell’“eredità culturale” per la società, più comunemente conosciuta
come la Convenzione di Faro del 2005. Dopo anni di lavoro l’Italia giunge
all’adesione al quadro di riferimento europeo sulla governance democratica e sulla partecipazione attiva dei cittadini al patrimonio culturale. Un
testo complesso e importante, sui cui effetti ci si dovrà concentrare nei
prossimi anni per monitorarne le conseguenze. Patrimonializzare, infatti,
può essere inteso come quel processo che “mette in valore” gli oggetti
culturali e, nello specifico, per comprendere il patrimonio immateriale bisogna assumere la natura di cambiamento degli stessi oggetti patrimoniali
e non la loro staticità. Occorre guardare al patrimonio non in un’ottica di
neutralità ma come esito di un processo costantemente reinventato, dinamico e relazionale, come è del resto quello identitario, in cui intervengono
molti attori sociali, spesso anche in conflitto tra loro. Sul patrimonio e sui
processi di azione e costruzione del valore patrimoniale si rispecchiano e
producono mutamenti all’interno delle comunità locali, in corrispondenza
o in conflitto delle istanze universali che, per dirla in termini herzfeldiani,
si rifanno a una sorta di “gerarchia globale dei valori” (Herzfeld, 2004).
Per quanto riguarda il contesto nazionale italiano ben nota è la supremazia che fin dalle origini e per lungo tempo la tradizione di studi folklorici e
demologici, in una dimensione legata al positivismo e allo storicismo, ha
avuto in Italia rispetto a quelli relativi all’etnologia extraeuropea, come accadeva invece in Gran Bretagna, Francia e Germania soprattutto in riferimento alla scoperta del mondo coloniale che per l’Italia si è tradotta in una
relativamente breve storia di dominazione (Fabietti, 2011; Alliegro, 2011).
La ricca raccolta e l’intenso studio delle tradizioni popolari delle varie regioni italiane coincide nel Novecento (Signorelli, 2000) con il ritardo della
nascita di un concetto di nazione postunitario. Proprio all’indomani della
proclamazione dell’unità d’Italia, infatti, il paese manteneva ancora e per
moltissimo tempo enormi differenze di lingua, di disequilibri economici
tra ceti sociali e tra regioni; in questo senso gli studiosi si dedicarono soprattutto al Mezzogiorno d’Italia, rimasto contadino e povero, a confronto
del mondo urbano e industrializzato che stava avanzando. L’eterogeneità
delle tradizioni popolari italiane è stata da sempre la caratteristica principale degli studi demologici nostrani; si faceva leva sul concetto di “autenticità” legata, per esempio, al folklore in Sicilia con i lavori di Giuseppe Pitrè
e ai costumi dei ceti popolari italiani in esposizione alla celebre Mostra di
Etnografia Italiana del 1911, organizzata da Lamberto Loria in occasione
del cinquantenario dell’unità d’Italia (Cavazza, 1997; Puccini, 2005).
23
Dunque si trattava di un’Italia dalle molte differenze, soprattutto tra
cultura di élite e culture popolari locali e su queste gli stessi studi demologici composero la loro storia e la loro fortuna attorno alle riflessioni sul
concetto di identità culturale e di nazione vincolato proprio all’indagine sul
folklore, condizionato dall’influenza del fascismo e dall’idealismo crociano che ne rallentò gli studi. Quindi di folklore, a partire dalle considerazione postbelliche di Gramsci e poi di de Martino, fino al passaggio agli studi
sul patrimonio culturale in relazione alla costruzione e valorizzazione delle identità, le discipline antropologiche italiane si sono sempre occupate,
con un particolare intenso momento di dibattito negli anni Settanta2. Nel
processo di ri-folklorizzazione di quel periodo così produttivo e vivace,
relativo anche al declino contingente della civiltà contadina, si inserisce
lentamente una presa di coscienza sul concetto di patrimonio, chiamato
dallo stesso Cirese Dea, Demo-etno-antropologico (Clemente, Caldeloro,
2000, pp. 191-220; Bravo, Tucci, 2006). Per cui il patrimonio Demo-etnoantropologico poteva essere pensato come l’insieme dei fenomeni culturali, materiali e immateriali, che rendevano conto delle differenze culturali
italiane, che proprio Cirese chiamava “dislivelli interni di cultura” (1997).
Il mutamento che arresta la tendenza classica degli studi italiani, attiva
innanzitutto una innumerevole rivitalizzazione “dal basso”, il cosiddetto
Folk Revival, che avvia la produzione di musei locali che muovono tutta
una serie di azioni politiche e riflessioni accademiche sui territori e il patrimonio in un discorso di rinnovato concepimento della museografia3. Da
questo momento in poi si avvia una fase in cui il patrimonio Dea comincia
ad essere maggiormente concepito all’interno della politica e della legislazione dei beni culturali e gli antropologi per primi sono chiamati a spendere le loro riflessioni sulla rinnovata produzione di tradizioni in un’ottica di
sempre più attenta rivisitazione dei concetti di cultura d’èlite, cultura popolare e cultura di massa (Dei, 2002b). I problemi epistemologici e politici
2
Si pensi per esempio ad alcuni dei diversi contributi di riflessione scientifica sul folklore: Buttitta, 1971; Lombardi Satriani, 1973; 1980 (ed. or. 1974); Cirese, 1973 (I ed. 1971);
Bravo, 1984. Senza contare l’enorme produzione scientifica e di documentazione che negli anni Settanta si avvia da più parti sul folklore locale e nazionale in tutta la penisola.
Interessante a tal proposito è l’attività scientifica prodotta dal 1980 in poi dalla Rivista «La
Ricerca Folklorica, contributi allo studio della cultura delle classi popolari» e Clemente,
Meoni, Squillacciotti, 1970; Clemente, Mugnaini, 2001.
3 A tal proposito si vedano i numeri della Rivista «AM» e gli studi effettuati sul patrimonio da un punto di vista dell’antropologia museale di Pietro Clemente e Vincenzo
Padiglione dagli anni Novanta.
24
appaiono radicalmente mutati da quelli degli anni Settanta, innanzitutto
per via della crisi dei concetti antropologici chiave di cultura e identità che
fanno sì che si riveda necessariamente il ragionamento sulle appartenenze
locali. Inoltre, l’“uso pubblico” della cultura popolare fa mutare le stesse
politiche di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio etnografico. Ma,
soprattutto, come fa notare Fabio Dei, una definizione di cultura popolare
non può evitare da un certo punto in poi di leggere il rapporto tra il folklore
tradizionale e quello dell’industria culturale di massa. Quindi una cultura
popolare che con i Cultural Studies passa ad essere concepita come settore di consumo e non di produzione. Se l’antropologia ha cercato nella
sua storia italiana di tenere separati i campi, proteggendo l’“autenticità”
della tradizione dall’invadenza omologante della cultura di massa, successivamente se ne evidenziano le relazioni, inserendole in una teoria delle
differenze culturali nella società contemporanea (Ibidem). Più in generale,
del vuoto legislativo in materia di beni culturali che dal 1939 al 1967 si ha
in Italia, i beni che più subiscono le conseguenze negative sono proprio i
beni etnografici. Solo con la Commissione Franceschini e Papaldo si ha
l’apertura a un concetto di bene legato a ciascuna “testimonianza materiale
che abbia valore di civiltà”; sembra un intento più in linea con la visione
antropologica ma che nei fatti rimase quasi per nulla realizzato.
Al di là e nonostante le varie riformulazioni istituzionali in ambito nazionale che in questa sede non si possono ripercorrere, il patrimonio Dea in
Italia stenta per molto tempo a ottenere un riconoscimento formale e, quindi, a ricevere indicazioni sulla sua tutela, conservazione e valorizzazione
istituzionale. La situazione sembra semplificarsi con le leggi sull’autonomia regionale che rivendica il ruolo dell’identità locale e del suo valore
antropologico a partire dagli interessi della comunità locale, in linea con la
già citata nascita dei musei locali avviati e gestiti da ex contadini e giovani
scolarizzati nel tentativo di recupero della memoria storica locale.
Tuttavia a livello legislativo solo le leggi speciali in materia di catalogazione dei beni degli anni Ottanta sembrano occuparsi concretamente e fattivamente di beni Dea, fino alla strutturazione nel 1989 dei dati per le schede di catalogo relative agli oggetti di interesse demo-antropologico, che
però non è riuscita a uniformare i linguaggi in termini nazionali4 e spesso
ha prodotto importanti campagne di censimento territoriale dei beni, al di
4 Cfr. le pubblicazioni regionali come quelle della Regione Lazio e dell’ICCD, Istituto
generale del catalogo e della documentazione, in particolare i contributi di Tucci e Simeoni
sulla catalogazione di beni Dea.
25
là di una progettualità nazionale. Intanto la nozione scientifica di identità
viene intesa in senso sempre più dinamico, si ha un’apertura maggiore della definizione di patrimonio che però non coincide sempre necessariamente
con una facilità di gestione del suo utilizzo e significato. Da un tentativo
di lavorare solo sulla conservazione dei beni Dea, si è passati all’idea di
una valorizzazione degli stessi in un’ottica dinamica dei processi di patrimonializzazione dei beni culturali etnografici. Quindi, dall’urgenza di
raccogliere e consegnare alla memoria e di salvare gli oggetti culturali,
si è passati al voler mantenere la loro vitalità culturale e la loro fruizione,
salvaguardando il loro valore anche in un’ottica affine alle nuove tendenze
turistiche ed economiche. È mancata in Italia una visione centralista del
potere politico nella gestione dei beni culturali che ha fortemente condizionato le politiche nazionali come quelle locali sulle pratiche da adottare
in materia di tutela, conservazione e valorizzazione di un patrimonio come
quello “immateriale”, già difficilmente codificabile (Clemente, 1996, pp.
237-45). A questa storia tutta italiana, si interseca negli ultimi decenni la
storia dell’agenzia internazionale dell’ONU che muove una riflessione su
quelle tradizioni che tanto hanno caratterizzato gli studi demo-etno-antropologici fin dalle origini.
Il più recente dibattito sui patrimoni culturali interno all’antropologia italiana vede la luce con i lavori di antropologia critica di Berardino
Palumbo sulla Sicilia sud-orientale (Palumbo, 2003), editi peraltro nello
stesso periodo in cui, sul piano dei beni immateriali, si avviava la stesura
della Convenzione UNESCO del 2003. Un lavoro attento ai processi di patrimonializzazione e ai rapporti tra comunità locali e procedure transnazionali della patrimonializzazione come esperienza di conflitto, mutamento,
immaginazione (Palumbo, 2013, pp. 123-152). Le “tassonomie globali”,
così le chiama Palumbo, possono rintracciarsi nella dinamica locale-globale nata tra UNESCO, comunità locali e soggetti delle istituzioni o della
società civile. A partire dallo studio sui rapporti tra costruzione di oggetti
culturali e costruzione di soggetti e identità collettive sul piano dell’economia politica più ampia che li crea, occorre chiedersi in che modo le leggi,
le politiche e i discorsi UNESCO contribuiscano a far mutare anche gli
studi sul patrimonio immateriale e di conseguenza anche le politiche legate
ad esso, con la problematicità insita nella natura dinamica, problematica e
spesso conflittuale della nozione stessa di patrimonio immateriale.
I recenti discorsi, le retoriche e le politiche UNESCO hanno incrementato gli heritage studies, da cui si parte in questa sede senza alcuna pretesa,
26
però, di dar conto in modo esaustivo della loro varietà. Col termine anglosassone heritage studies si intende il settore scientifico, in particolare le
discipline storiche e antropologiche, che si interessa del patrimonio come
fenomeno complesso (Pratz, 1997). Negli ultimi decenni del XX secolo
grazie soprattutto allo sviluppo tecnologico le attività di selezione e conservazione di oggetti patrimoniali hanno subìto ridefinizioni e cambiamenti (Lowenthal, 1998; Harvey, 2001, pp. 319-338). La tematica della conservazione dei beni culturali si è affermata alla fine del XV secolo ma solo nel
XIX secolo si sono elaborate le prime teorie e tecniche di conservazione.
L’assunto principale è quello per cui a seconda della cultura e dei gruppi
sociali muta la concezione del patrimonio e dell’“eredità culturale” in base
al diverso rapporto che i soggetti instaurano col passato, di generazione in
generazione, per cui diventa difficile rintracciare un modello interpretativo
universale del fenomeno patrimoniale (Journet, 2002). Inoltre il legame
col passato e col proprio senso di appartenenza identitario che si sviluppa
attraverso il rapporto con i beni culturali è un legame formale e ideologico
ma soprattutto profondamente emotivo (Palumbo, 2002, pp. 14-19).
La connessione tra quelle che venivano definite tradizioni popolari –
ampiamente studiate in Italia – e la cultura nazionale, ha sviluppato processi conflittuali, per esempio, tra minoranze per affermare o imporre una
identità in contrasto ad altre. Il patrimonio concorre spesso, infatti, alla
costruzione di confini e alla demarcazione di differenze. Nell’approccio
patrimoniale, a differenza di quello storico, il passato può essere più facilmente modificato in base alle esigenze e, quindi, oggetto di manipolazioni.
È proprio nel rapporto dell’uomo col passato che avviene la selezione di
elementi locali e la successiva contestualizzazione degli stessi in un quadro
più ampio, sovralocale, mondiale. Il contributo di Palumbo ha affrontato
dal punto di vista antropologico i processi di “patrimonializzazione” (Palumbo, 2009a, pp. XXXVIII-XL), cioè le costruzioni sociali di oggetti che
assumono valore patrimoniale in un’ottica di “oggettivazione culturale”
(Handler, 1988), quindi di fissazione e immobilizzazione dei processi socioculturali complessi. Da qui, una serie di nodi concettuali sono stati oggetto
di un dibattito interno all’antropologia italiana tra lo stesso Palumbo e Dei,
concentrato sul rapporto tra processi e costruzione di identità, sui diversi
livelli di definizione/aggregazione identitaria, sull’uso della categoria di
nazionalismo nei processi di patrimonializzazione e sul ruolo che in questi
processi assumono gli antropologi e gli intellettuali (Palumbo, 2002, op.
cit.; Dei, 2002a, pp. 34-37; Pizza, 2004, pp. 57-62). La recente attenzione ai
27
processi di patrimonializzazione dei beni immateriali provocata dall’UNESCO diventa così più articolata nella sua trattazione italiana e investe l’ambigua relazione tra beni culturali, mondo intellettuale, politica e processi di
essenzializzazione delle identità collettive. Lo studio del bene culturale e in
particolare di quello demo-etno-antropologico, si interseca in questo senso
con l’analisi parallela del contesto sociale e politico che lo produce e in cui
esso opera. Dal dibattito internazionale si mutua la necessità di una antropologia critica che si interroghi sui processi storici, intellettuali, artistici,
economici e politici che conducono alla costruzione di un oggetto patrimoniale. Nel mondo contemporaneo sempre più fecondo di costruzioni di
prodotti immaginari come sono quelli culturali e in cui la stessa produzione
dell’immaginario (Bourdieu, 1983, ed. or. 1979; Anderson, 1996, ed. or.
1983; Appadurai, 2001, ed. or. 1996) è fondamento delle economie post
capitaliste, lo sguardo critico sui processi di patrimonializzazione diviene
centrale. Secondo Palumbo occorre mostrare la connessione inevitabile tra
discorso identitario e logiche dello Stato-nazione moderno (Handler, 1988,
op. cit.; Herzfeld, 2003) e comprendere l’incisività di quel discorso e dei
suoi aspetti patrimoniali attraverso una teoria dell’agency e dell’identità
strutturata in pratiche storiche in trasformazione (Hall, 2002, ed. or. 1996);
cioè attraverso la capacità dinamica degli individui di attribuire senso e
significato ad eventi e rappresentazioni, accettandole o rifiutandole per adagiarsi o resistere, avviando una forma personale di soggettività.
L’etnografia critica – quella che ha assunto le revisioni teoriche e metodologiche con la crisi postcoloniale dell’autorità etnografica – non si interessa più solo alle tradizioni in sé, come faceva in passato la tradizione
italiana, ma alle retoriche di costruzione di tradizionalità. Il mondo sociale,
quindi, diviene oggetto di una continua costruzione e riproduzione. Tradizioni, identità, cultura, sono tutti termini che non rimandano a “cose”
fisse, ma a processi di costruzione e reinvenzione. L’antropologia critica
dei beni culturali analizza e decostruisce il “common sense patrimoniale”,
individua le logiche che regolano la produzione delle cose culturali (Choay, 1992). In una virata autoriflessiva della disciplina si analizza anche il
ruolo che l’antropologia e gli stessi antropologi rivestono all’interno del
campo patrimoniale, cioè nella produzione delle “cose culturali”. Questo
ruolo, per Palumbo, consiste nell’aver fornito all’immaginazione storiografica nazionalista il linguaggio della cultura e dell’identità.
Per spostare l’attenzione sui beni immateriali, occorre ribadire che rispetto allo statuto del patrimonio culturale immateriale, gli interventi e le
28
pratiche devono essere labili perché il concetto stesso elaborato dall’UNESCO, soprattutto all’inizio, è di difficile interpretazione e apre orizzonti
problematici. Nel caso del patrimonio immateriale viene meno il discrimine tra ciò che è opera d’arte e ciò che non lo è (Brandi, 1977); quindi se il
riconoscimento del valore estetico per il singolo è causa della conservazione, bisogna individuare cosa indirizza l’attività di promozione e difesa dei
beni immateriali che, invece, non vengono considerate opere d’arte.
Allo stesso modo è complesso l’approccio alla diversità culturale per
attori istituzionali come i governi degli Stati parte dell’UNESCO. Gli Stati
nazione, da sempre impegnati a uniformare e omologare le differenze interne per evitare conflitti, invece di recente, seguendo i discorsi dell’UNESCO, devono misurarsi all’inverso con la valorizzazione e la promozione
della diversità sia rispetto agli altri che al loro interno. Una sfida che crea
di volta in volta non poche difficoltà. L’antropologia internazionale e poi
quella italiana sono chiamate ad indagare il funzionamento di sistemi come
il patrimonio che vive nelle dimensioni locali, nazionali e globali contemporanee. Il patrimonio diviene protagonista del processo di costruzione della herzfeldiana gerarchia globale dei valori (Herzfeld, 2003, ed. or. 1996,
op. cit.). Si indaga, inoltre, attraverso quali poetiche incorporate o strategie
politiche i diversi protagonisti riescano a trovare spazi di azione/manipolazione nelle tassonomie formali ufficiali, attraverso l’analisi delle strutture
di classificazione transnazionali che operano, oggi, nella produzione della
gerarchia globale dei valori e nella costruzione della loro rappresentazione
mondiale. In questo senso le riflessioni antropologiche possono per certi
versi influenzare la governance politica e culturale globale di istituzioni
sovrastatali come l’UNESCO (Matsura, 2002; UNESCO-ACCU, 2006).
Le norme e le convenzioni che ogni singolo Stato dovrebbe seguire
in accordo con gli organismi sovranazionali come l’UNESCO vengono
ratificate ma non sempre producono pratiche locali affini agli intenti prestabiliti. Gli studi italiani sui beni culturali, a cui si è brevemente accennato, erano legati a un approccio demologico di scoperta e valorizzazione
delle culture locali, quindi erano più attenti all’oggetto. Dagli anni OttantaNovanta, invece, l’approccio italiano diviene, seppur lentamente, sempre
più impegnato nei processi di patrimonializzazione5, a partire dagli stimoli
5
A parte i numerosi contributi di Palumbo già citati e al suo più recente Palumbo,
2011, pp. 8-23, altri contributi disciplinari stimolati in questo senso sono: il numero della
rivista «La ricerca folklorica» del 1999; e di «AM», in particolare il numero 2, 28-29 del
2011, curato da Alessandra Broccolini e dedicato all’UNESCO; Il volume: Maffi, 2006, che
29
internazionali e dal dibattito attorno alle attività dell’UNESCO6. Quindi,
inizialmente con la Dichiarazione del 1989, ma soprattutto con la sottoscrizione da parte dell’Italia della Convenzione UNESCO del 2003, ratificata
nel 20077, gli studiosi e gli amministratori locali vengono sommersi da
stimoli innovativi rispetto agli studi sui processi di patrimonializzazione.
Senza omettere i cortocircuiti che gli antropologi – abituati da sempre a
sollecitare riflessioni sulle località e sulle differenze culturali, in linea col
dibattito tra relativismo e universalismo – si sono trovati a gestire, di fronte
a importanti azioni politiche generalizzanti di agenzie internazionali tendenzialmente uniformanti come l’UNESCO, che forse per la prima volta
restituiva centralità ai tradizionali ambiti dell’antropologia, spesso però
senza riconoscere il ruolo delle pratiche conoscitive e di indagine antropologica e senza investire gli antropologi di un ruolo formale in questi
processi istituzionali.
L’unico campo in cui più esplicitamente gli antropologi sembrano essere legittimati ad avere una qualche autorità, se non assoluta ma di traduzione e mediazione tra comunità e istituzioni locali e nazionali, è proprio
l’attività di inventariazione nazionale richiesta dall’UNESCO come prerogativa necessaria per richiedere formalmente l’iscrizione di un bene nelle
Liste Rappresentative. In questo campo in Italia l’Iccd (Istituto centrale
per il catalogo e la documentazione interno al Mibac) aveva già realizzato
presenta il patrimonio come un “ideascape” transculturale di appadurajana memoria; le attività delle Associazioni di settore Aisea e Simbdea; un recente numero della Rivista «Voci.
Annuale di Scienze Umane», Anno X/2013, la cui parte monografica curata da Letizia
Bindi si concentra sul legame tra patrimoni culturali e economia.
6 In Italia una prima riflessione sull’UNESCO e il patrimonio immateriale è contenuta
sul contributo: Bortolotto, 2008a. Inoltre negli scorsi anni un interessante dibattito internazionale sul patrimonio immateriale si è prodotto in Italia, sul lago di Como, al quale ha
preso parte chi scrive per due edizioni. Negli anni in cui sono intervenuta ai lavori, il seminario trinazionale aveva i seguenti titoli: Atelier de recherche en sciences sociales et humaines «Allemagne, France, Italie» Institutions, territoires et communautés: perspectives
sur le patrimoine culturel immatériel translocal, Premier Atelier, L’inscription territoriale
du patrimoine immatériel, Dfg/Villa Vigoni/Maison des Sciences de l’Homme-Forschungskonferenzen in den Geistesund Sozialwissenschaften (23-26/03/2010) e Kulturerbe-Politik
im zwischenstaatlichen Vergleich * La politique du patrimoine: perspectives comparatives
entre différents systèmes politiques * La politica del patrimonio: prospettive comparative
tra diversi sistemi politici, (26-29/06/2011).
7 Cfr. alcuni contributi critici sulla Convenzione del 2003 e sulle politiche UNESCO:
Harvey, 2001, op. cit.; Risse, 2003, p. 74-89; Kurin, 2004, pp. 66-76; 2007, pp. 9-20;
Mariotti, 2007-2008, pp. 51-54; Pietrobruno, 2009, pp. 227-247; Bortolotto, 2007, pp. 3945; 2008a, op. cit.; 2008b, pp. 21-33; 2008c; 2008d; 2009, pp. 81-94; Tauschek, 2010;
Scovazzi T. et alii, 2011; Bendix, Eggert, Peselmann, 2012.
30
la scheda BDI, Beni demo-etno-antropologici immateriali (Tucci, 2002,
pp. 66-69, 2006, pp. 20-29, 2007-08, pp. 62-67; Simeoni, Tucci, 2007, pp.
41-45), per documentare secondo uno schema informatico riconosciuto a
livello ministeriale le attività sociali e le performances culturali irripetibili
e, appunto, volatili, immateriali.
La pratica della catalogazione, in realtà, è molto più complessa e identificatrice e produttrice essa stessa di valore patrimoniale di quanto si possa immaginare; e nel suo uso e funzione si può negoziare il senso stesso
della rappresentazione pubblica del patrimonio immateriale, soprattutto se
la scheda è, come dovrebbe essere, pensata in termini di compartecipazione della “comunità” protagonista del bene inventariato. Infatti, da quando
l’UNESCO ha imposto agli stati membri l’apertura di inventari sempre più
partecipati “dal basso” come conditio sine qua non della pratica di candidatura del bene, l’attività di catalogazione ha attirato su di sé un fervido
dibattito internazionale e interno all’Italia, sia nel mondo delle istituzioni
che, in questi termini forse per la prima volta, nel mondo accademico. Si è,
quindi, cominciato a riflettere anche in Italia sull’“imperativo partecipativo” che a livello internazionale le recenti politiche UNESCO impongono.
Dall’idea politica dell’urgenza, se così si può definire, prevista nei programmi di conservazione de Il Sistema dei Tesori Umani Viventi del 1994
e de La Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio Orale e Immateriale
dell’Umanità del 1997 – in cui concetti come tradizione, eccellenza, capolavoro, etc. venivano usati in un senso non vagliato dallo sguardo critico
antropologico – si è passati alla concezione più dinamica e processuale
del bene e di conseguenza delle stesse misure di salvaguardia da adottare.
Delle due liste nazionali, la “Lista per i beni che necessitano salvaguardia
urgente” e la “Lista rappresentativa”, l’Italia si è concentrata quasi esclusivamente su quest’ultima, residuo forse di logiche ereditate dalle politiche
di riconoscimento e proclamazione dei Capolavori, in cui l’UNESCO adoperava ancora una visione eurocentrica, più materialista e monumentale,
connessa a criteri gerarchici di eccellenza (Bortolotto, 2008a, op. cit), da
cui la Convenzione del 2003 e, in modi diversi, la Convenzione di Faro del
2005 cercano di emanciparsi. La Convenzione UNESCO del 2003, infatti,
ha introdotto la questione della “partecipazione comunitaria” in linea con
un percorso di democratizzazione delle culture locali, sviluppato attraverso
la progettazione di azioni di salvaguardia, trasmissione e valorizzazione di
un patrimonio culturale immateriale inteso in un’accezione più matura in
termini antropologici. L’attenzione dell’UNESCO ai temi della partecipa31
zione di soggetti comunitari e singoli portatori del bene patrimoniale trova
corrispondenza nella normativa internazionale che già da tempo sostiene
un criterio partecipativo nei settori dello sviluppo sostenibile e dei diritti
umani.
Questa sollecitazione è entrata in vigore anche in ambito europeo con
l’introduzione dell’idea di “comunità patrimoniale”, “comunità di eredità” – che chiaramente mette in discussione il classico riferimento al
concetto di comunità esclusivamente legato all’appartenenza a un comune territorio, spostando l’idea sul patrimonio come elemento di valore
che crea comunità8 – nella Convenzione di Faro del 2005 del Consiglio
d’Europa che riconosce un ruolo attivo delle comunità locali e dei soggetti portatori nella definizione e gestione del patrimonio. Questa nuova
“gerarchia globale dei valori”, obbliga lo stesso campo antropologico a
ridefinire il ruolo professionale in questo panorama mutato. E gli inventari divengono ancor più un terreno fondamentale nel dibattito sul rapporto
tra partecipazione comunitaria e competenze scientifico-disciplinari. Secondo l’art. 12 della Convenzione del 2003, infatti, gli inventari devono
realizzarsi in un’ottica partecipata, con un coinvolgimento bottom-up delle comunità nell’individuazione e nella definizione del bene. Negli Stati
parte, però, esistono diverse tradizioni di inventariazione, adattate alle
specifiche politiche nazionali dei beni culturali e di riconoscimento di
ruoli professionali9.
Nonostante le diverse problematicità e opacità qui solo accennate, il
merito della Convenzione UNESCO del 2003 è quello di aver offerto un
tavolo internazionale di dibattito e confronto tra le culture locali e il mondo dei loro rappresentanti istituzionali, musei, associazioni, Ong, agenzie,
etc10. In un mondo globalizzato e pieno di conflitti sempre più acuti, reali
o mediatici, in parallelo alla crescita del dibattito internazionale sui diritti
umani, si attiva un’attenzione e un interesse avvertito sull’idea di bene co8
Sarebbe interessante mutuare, in questo senso, un concetto come quello di “comunità di pratica” avanzato da Lave, Wenger, 2006 (ed. or. 1991) e di cui si discuterà in
seguito.
9 Per una recente riflessione critica sulla pratica di catalogazione e inventariazione si vedano, oltre ai testi citati precedentemente, anche: Bortolotto, 2011a, pp. 62-69; Bortolotto,
Severo, 2011b, pp. 24-32; Broccolini, 2011, pp. 41-51; 2012, pp. 289-308; 2015, pp. 175188; in corso di stampa.
10 Interessante è la recente attività di dialogo con l’UNESCO della rete italiana per la
salvaguardia del patrimonio immateriale di Simbdea-ICH, ONG accreditata nel 2010 presso l’UNESCO dall’Assemblea Generale degli Stati parte.
32
mune, di cultura veicolata dal patrimonio immateriale, basato sullo scambio tra diversità e sul dialogo tra culture diverse e paritarie, almeno negli
intenti. Tuttavia spesso le pratiche locali si inspessiscono e complessificano in senso contrario ai termini delle convenzioni UNESCO e alla linea
di dialogo tra culture, cioè producendo conflitti e acuendo spesso quelle
diversità visibili attraverso le pratiche rituali e identificabili nelle retoriche
pubbliche e delle politiche culturali.
Il ruolo degli antropologi in questo senso diventa sempre più importante in un’ottica bifocale che, da una parte, indaga i beni immateriali con
etnografie in profondità e, dall’altra, monitora e riflette sui processi di patrimonializzazione e sulle conseguenti ricadute locali di queste politiche
mondiali. L’antropologia non può esimersi dall’indagare con postura critica: la produzione dei conflitti locali, che spesso sono nella natura stessa dei
patrimoni immateriali; le manipolazioni delle istituzioni locali e le eventuali ingerenze sul bene mutuate dalla “missione” dell’UNESCO; il ripensamento e l’identificazione in termini di eccellenza di località supportate
spesso da lobbies che nelle loro retoriche stimolano la conflittualità contro
altre località per riaffermare la loro “unicità” e “originalità”; il monitoraggio di atteggiamenti competitivi e di dialogo tra culture locali, mantenendo l’intento disciplinare fondante di rendere la complessità e la ricchezza
culturale dei patrimoni nei termini della modernità, senza far perdurare un
atteggiamento di egemonia intellettuale o di etnocentrismo nei confronti
delle diversità culturali. L’antropologia contribuisce in questo modo a far
sì che il patrimonio culturale immateriale diventi un paradigma fondamentale della configurazione culturale contemporanea.
In questa direzione sembra andare l’ultima azione politica del Consiglio d’Europa, su cui gli studiosi hanno lavorato negoziandone i termini e
le definizioni concettuali, la Convenzione di Faro. Una Convenzione che
innanzitutto per la nozione di “comunità di eredità”, rimane un documento
fondamentale per le nuove riflessioni della disciplina antropologica, come
anche per l’avvio di buone pratiche nelle politiche locali. L’articolo 2 di
questa Convenzione è decisivo per ripensare un cambiamento che dia maggiore valore all’ambito patrimoniale, restituendo centralità ai protagonisti e
al loro ruolo attivo di azione sul bene e sulla stessa cultura di appartenenza.
Per l’Italia la firma della ratifica della Convenzione di Faro rappresenterà
un passaggio istituzionale europeo importante, sul quale gli antropologi del
patrimonio e le associazioni locali saranno sempre più chiamate a ragionare. Si tratta di una nuova normativa che merita attenzione critica e che farà
33
divenire forse ancora più urgente e necessaria una mappatura etnografica
delle ricadute a livello locale di Convenzioni di questo tipo.
I.2 Antropologia e patrimonio festivo
Quando si parla di patrimonio immateriale ci si riferisce anche e soprattutto alla festa, intesa come un complesso e articolato apparato di universi, conoscenze, memorie, saperi, oggetti, dinamiche relazionali, sociali,
economiche, politiche che sostengono, coinvolgono e investono, a livello
concreto e simbolico, le comunità nel tempo e nello spazio in cui i riti
si svolgono e se ne rifonda periodicamente il senso. A partire da questa
premessa tenterò una sintesi, di certo non esaustiva, per inquadrare alcune
strade percorribili nella vasta letteratura antropologica sulla festa (Satta,
2007). Nella pur ricca tradizione di studi italiana sulla dimensione festiva, l’analisi della dimensione rituale e cerimoniale non sempre è sembrata
essere supportata da etnografie di lungo periodo riguardanti la vita delle
comunità locali indagate (Faeta, 1995a; 2005; Faeta, Ricci, 2007). Ed è
in risposta a questa considerazione che intende provare a muoversi questo
volume, concepito proprio come uno studio delle località la cui vita comunitaria viene a costituirsi attorno al nucleo festivo.
Nella tradizione di studi demologici italiani del secolo scorso la festa
popolare è stata per lo più analizzata come espressione di cultura dei ceti
subalterni secondo un approccio gramsciano e marxista, frutto dell’influenza nella scena intellettuale di Antonio Gramsci (Gramsci, 1950; 1975;
1976; 1992)11 che individua nel folklore una potenzialità critica e rivoluzionaria rispetto alle concezioni del mondo “ufficiali” espresse dalle parti
colte delle società; e di Ernesto de Martino (de Martino, 1959; 1961; Gallini, 1971; 1977; 1982) che riflette sul folklore progressivo tracciando la
rotta degli studi italiani.
Per quanto riguarda, invece, l’antropologia angloamericana e l’etnologia europea, l’influenza principale proviene dall’approccio sociale di Durkheim (1963). La scuola sociologica francese di Durkheim e Mauss (1976)
intende la festa come momento rituale per rinsaldare ciclicamente l’unità
sociale nella società stessa, quindi un momento di effervescenza collettiva, di integrazione sociale. Come nota Faeta (2005, pp. 154-5, op. cit.),
11
Per una riflessione antropologica su Gramsci si veda, fra i numerosi contributi, Pizza,
2004, pp. 57-62, op. cit. e in relazione al patrimonio: Dei, 2013, pp. 131-146.
34
è proprio l’approccio culturale che prevalse negli studi italiani nel dopoguerra che soppiantò in qualche modo l’approccio sociale delle riflessioni
durkheimiane e di quelle di Van Gennep, Evans-Pritchard, Lévi-Strauss,
Gluckman, Turner.
Nel decennio che va dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta il dibattito
in Italia sulla cultura popolare raggiunge elevate vette di interesse civile e
politico. Il proficuo dibattito si nutre di riflessioni sulla definizione di “folklore”, sulla demarcazione tra cultura popolare e non popolare, sull’analisi
dinamica dei momenti cerimoniali e rituali e l’influenza di de Martino è
evidente. Le intense riflessioni di Alberto M. Cirese (1973, ed. or. 1971,
op. cit.; 1976) sul rapporto tra cultura egemone e culture subalterne producono, a partire dall’influenza gramsciana, un’analisi dei dislivelli interni
di cultura, che fanno considerare il folklore in chiave relazionale e non più
essenzialista. Una parte del dibattito su questi temi si svolge in quegli anni
su riviste come La ricerca folklorica (n. 1, 1980) e Problemi del socialismo (n. 15, n. 16, 1979). Si ragiona sulla possibilità di guardare al folklore
come a una cultura tradizionale volta al passato e si traccia anche una certa
“autenticità” folklorica, che si scontra con l’inautenticità degli oggetti prodotti dall’industria culturale di massa.
Alcuni tra gli studi più emblematici della rigogliosa temperie culturale
degli anni Settanta (Di Nola, 1970; 2001, ed. or. 1976), nella quale si teorizza anche il folklore meridionale come cultura di contestazione da parte
della cultura subalterna rispetto alle classi egemoni e dove si riflette sul
legame tra folklore e logiche economiche, sono quelli di Luigi M. Lombardi Satriani (1966; 1968, pp. 64-88; 1971; 1974; 1979; 1980, ed. or. 1974;
2000a; 2000b; 2004a) e quelli scritti con Mazzacane (Lombardi Satriani,
Mazzacane, 1974; 1976, p. 383). Si riflette sulle tecniche di distruzione
di una cultura (Lombardi Satriani, 1973, op. cit.) a proposito dei fenomeni di messa in scena e commercializzazione di feste, spettacoli folklorici,
musiche tradizionali indirizzati ai ceti borghesi. E, in questo caso, le feste
rappresentavano il luogo strumentale di maggiore riscoperta delle tradizioni locali.
Si teorizza l’inconoscibilità della festa (Jesi, 1977), posizione teorica
che troverà risposta nei successivi studi (Faeta, 2005, op. cit., pp. 151167). La festa è analizzata in termini esperienziali, come luogo in cui l’individuo sperimenta momenti di collettività, che sembrano sempre più rari e
repressi in una borghesia che impediva l’esperienza festiva come momento
collettivo. Dal dopoguerra fino agli anni Ottanta si sviluppa l’identificazio35
ne tra dimensione locale (Appadurai, 2001, ed. or. 1996, op. cit.) e folklore,
che porterà a un processo di rivendicazioni identitarie ancora in parte attivo. Negli anni Ottanta la festa è unità discorsiva, delimitata e organizzata
secondo criteri sintattico-semantici, semiotici, secondo codici e registri di
cinesica, prossemica, dimensione alimentare, sonora, cronologica (Falassi,
1987, pp. 173-83; Giallombardo, 1990; Grimaldi, 1993), etc. Si tenta di
individuare delle logiche interne alla strutturazione della festa (Mazzacane, 1976; 1983; 1985; 1990), caratterizzate da un approccio metodologico
anche visuale che coinvolge la Campania (Di Nola, 1998; Porcaro, 1990;
1991), intercettando la stessa festa dei Gigli di Nola, oggetto di questo
volume. E, ancora, di sviluppano riflessioni di etnografia visiva dedicate
al Mezzogiorno e in particolare alla Calabria (Faeta, 1995c, pp. 49-54;
1996b, pp. 131-140; con Gallini, 1999; 2006). Due convegni in particolare
segnano momenti significativi di confronto tra studiosi che si occupano di
festa e, a partire da alcuni contributi lì presentati, ho orientato alcune delle
mie riflessioni. Il primo convegno, svoltosi nel 1978, vede la luce in un volume di qualche anno dopo (Bianco, Del Ninno, 1981), mentre il secondo
viene svolto a venticinque anni di distanza ed edito nel 200412.
Negli anni Ottanta fioriscono gli studi storico-religiosi (Lanternari,
1976, ed.or. 1959; 1981, pp. 132-150; 1983) che passano anche per la festa
dei Gigli (Lanternari, 1988, pp. 152-165), risentendo dell’influenza di de
Martino e avviando un approccio comparativo. Lanternari analizza, nel suo
studio del Capodanno nelle civiltà “primitive” distanti dall’Italia, quello
che viene definito il “tempo di festa”, come tempo magico che rompe un
ordine quotidiano intriso di male. La festa diventa un momento di catarsi
verso qualcosa di meglio, auspicato simbolicamente; quindi diviene annullamento della negatività dell’esistenza. A questo proposito mi sembra utile
riflettere sulla pubblicazione curata da Bianco e Del Ninno degli atti del
congresso del 1978, nella quale alcuni autori fondano la propria riflessione
proprio sul concetto di “tempo” nella festa, che mi permetterà in seguito di
tornare criticamente sull’idea di “tempo festivo”.
Gli anni Ottanta rappresentano un periodo in cui viene rimesso in discussione l’oggetto di studio, criticando la reificazione delle tradizioni e
ponendo l’accento soprattutto sui processi di costruzione sociale e sull’uso
che i soggetti fanno di esse. Negli anni Novanta l’Etnologia dell’Europa
12 Si tratta degli atti del VIII Congresso dell’Associazione Italiana per le Scienze
Etnoantropologiche, del 26-28 Giugno 2003 svoltosi a Torino, dal titolo: Festa. Tradizione,
Riproposta Reinvenzione. Cfr. Bonato, vol. 1, vol. 2, 2004a; 2004b.
36
si concentra proprio sui processi di rivitalizzazione dei rituali (Boissevain,
1992). Le trasformazioni della festa, la secolarizzazione, l’invenzione delle
tradizioni13 divengono, quindi, tematiche centrali. Il nodo tra folklore e tradizione in rapporto alla modernità – nel quale si incastona il ragionamento
sul festivo – è quasi implicito nello statuto epistemologico di una parte
delle scienze antropologiche (Bauman, 1992). L’etnologia e l’antropologia
culturale propongono nuovi studi sulla cultura di massa secondo una matrice riflessiva, cioè guardando alle proprie culture di appartenenza, fino
agli approcci più recenti che riflettono sulla festa tradizionale in Europa
meridionale e sui cambiamenti dati dalla modernità, sulla rivitalizzazione,
l’identità locale e il turismo (Simonicca, 1997).
Dagli anni Novanta, si registra un ripensamento critico degli studi antropologici che coinvolge molte sfere e tematiche e che deriva dall’intento
precedente di un ripensamento decostruttivo dei concetti fondanti della disciplina come cultura, identità, tradizione, etc., – analizzati fino a questo
momento in un’ottica essenzialista e oggettivista e declinati spesso al singolare – che vengono dunque ripensati al plurale, con dimensioni multiple,
carattere dinamico e processuale.
E su questa linea ancora oggi l’universo festivo raccoglie attorno a sé,
con rinnovato vigore, contributi diversi14. Quindi, se precedentemente una
festa veniva studiata secondo criteri più o meno attribuibili ad una esigenza
13 È noto quanto il dibattito sul concetto di invenzione della tradizione, a partire dal
testo col titolo omonimo, sia stato acceso nelle scienze sociali, concentrandosi sull’analisi
di fenomeni di ritradizionalizzazione o rivitalizzazione degli universi festivi (soprattutto in
ambiente europeo), come testimonianze di un presunto rapporto col passato, con la storia
e con la creazione di tradizioni ritenute immutabili nel tempo. La messa alla prova del modello di invenzione della tradizione nei diversi campi etnografici, tuttavia, creò non poche
problematiche e riflessioni. In realtà il paradigma innovativo di Hobsbawm se all’inizio,
negli anni Ottanta, era servito per accertare il distaccamento dagli scenari essenzialisti della disciplina, successivamente evidenziò delle ambiguità teorico-epistemologiche. Le sole
critiche che subì inizialmente furono mosse da parte dell’antropologia postmoderna americana, poi fu la Francia a rivedere criticamente la questione della storia, della tradizione e
dell’identità negli anni Novanta, con una riflessione concentrata sui rapporti tra identità e
costruzione di patrimoni etnologici. Per la letteratura sull’argomento si veda per il panorama inglese Hobsbawm, Ranger, 1987 (ed. or. 1983); Handler, Linnekin, 1984, pp. 273-90,
per quello francese Pouillon, 1975, pp. 155-173; Boyer, 1986, pp. 309-331; Lenclud, 2001.
Per un contributo su questo dibattito cfr. Broccolini, 2000.
14 Ariño, Lombardi Satriani, 1997; Cardini, 1998; Lombardi Satriani, 2000a, op. cit.;
2000b, op. cit.; 2004, op. cit.; Faeta, 2000; Scarduelli, 2000; Buttitta I. E., 2002; Tambiah,
2002; Bravo, 2005; Bonato, 2004a; 2004b, op. cit.; 2006; Esposito, 2005; Satta, 2007, op.
cit.; Niola, 2007, op. cit.; Apolito, 1993; 1994; 2008, pp. 16-20; 2014; Mugnaini, 2009, pp.
223-248.
37
di descrizione e valorizzazione, prima, e di problematizzazione, poi, rispetto all’idea di un’Italia da scoprire e soprattutto di un Sud da “assumere culturalmente” e controllare, oggi la situazione è cambiata. Gli istituti festivi in
generale sono mutati proprio in parallelo a sconvolgimenti planetari come
le migrazioni, la tecnologizzazione dei sistemi di comunicazione, la ridefinizione geografica e politico-culturale di assetti nazionali e internazionali,
etc., che si ripercuotono nei singoli territori e nei discorsi intellettuali o
politici che li coinvolgono in maniera trasversale. Pertanto, chi si occupa
oggi di feste non può esclusivamente descrivere o problematizzare un territorio e i suoi specifici rituali, ma deve necessariamente misurarsi anche con
mutate visioni di insieme – come la stessa idea di Sud – o compararsi con
culture lontane fisicamente, con idee di comunicazione tra gruppi umani
trasversali a comuni, province, regioni, spesso a nazioni stesse, per non
dire a “comunità” virtualmente planetarie. Queste prospettive problematizzano il modo di guardare alla dimensione festiva contemporanea, intesa
come una rappresentazione quotidiana di rapporti e dinamiche relazionali
tra individui e gruppi legati ad uno specifico territorio e alla sua memoria,
ma in relazione a luoghi distanti e culture diverse che, tuttavia, potrebbero
ritrovarsi a svolgere pratiche simili. La festa diviene, quindi, un ambito del
fare sociale dotato di autonomia discorsiva e di senso, ma che vive legato
ai tempi extrafestivi – il lavoro, il tempo libero, il calendario agricolo e
quello amministrativo – e ai contesti extrafestivi del vivere sociale – la
politica, l’economia, la religione – e con una produzione culturale costante
che la rappresenta e che ne tratteggia il contesto di fruizione (Mugnaini,
2009, p. 247, op. cit.).
Ed è attorno al costituirsi di un’idea di “patrimonio culturale”, che in
qualche modo si è cominciato a ragionare su processi, cause e modalità
con cui i beni culturali italiani – non solo quelli esclusivamente materiali,
o meglio, non soltanto le dimensioni materiali dei beni – vengono “agiti”
dagli individui, dalle collettività, ma anche da sistemi globali, per rivendicare identità, appartenenze, ma anche differenze, conflittualità, poteri.
Nel complesso contenitore di senso quale sembra essere il concetto di
patrimonio – che negli ultimi anni è protagonista in convegni, dibattiti mediatici e testi scientifici – si inserisce la nozione di patrimonio immateriale,
intangibile, volatile; concetti, questi, problematici che coinvolgono a catena interessi di comunità locali e di istituzioni a carattere nazionale, come i
Ministeri della Cultura o le agenzie internazionali come l’UNESCO. Questo convergere di interessi, anche e soprattutto politico-economici, innesca
38
l’attivarsi di un dibattito tra protagonisti delle feste a vari livelli e amministratori locali, politici nazionali, internazionali e, non ultimi, antropologi.
Ma oltre al dibattito che costringe a ripensare le culture in termini di
patrimonio, si sono moltiplicate riflessioni sulle sempre più numerose strategie e politiche di patrimonializzazione, cioè quei processi concreti che
viaggiano però anche su piani simbolici – attivando sentimenti di riconoscimento comunitario e di appartenenza culturale, come anche di conflittualità – che determinano l’attribuzione di un valore collettivo, globale, a
quelle dimensioni tradizionali che contengono e producono oggetti, documenti, memorie, saperi, emozioni, a livello locale. I processi di patrimonializzazione, con le loro pratiche di inclusione/esclusione, svelano gerarchie
di valori, sistemi di economia celata, apparati di produzione di consenso e
divengono ingranaggi del potere. In qualche misura si tratta di analizzare
forme e modalità con le quali ci si appropria dell’alterità. Questo perché
nel costante moltiplicarsi di concettualizzazioni e attribuzioni di significati
attorno al concetto di “tradizione”, nella sua accezione più ampia, si inserisce lo studio del conferimento di valore – che spesso si traduce soprattutto
in natura economica e turistica – che le agenzie internazionali da qualche
tempo attribuiscono per attivare riconoscimenti di beni da tutelare perché,
appunto, considerati di interesse collettivo, “Patrimoni dell’Umanità”.
Questo procedimento di riapertura del sipario sulle tradizioni e sul loro
valore – che richiama per certi versi quella avvenuta negli anni Settanta
del secolo scorso – che riformula la voce e attiva, non sempre consapevolmente, la messa in scena di dimensioni tradizionali diverse tra loro,
può contribuire a far recuperare nell’immaginario nazionale, ma anche e
soprattutto in quello locale, un rinnovato interesse verso le tradizioni, che
inevitabilmente modifica gli stessi istituti festivi.
Le logiche economiche evidenziate come orientatrici spesso di tali
meccanismi di “rivitalizzazione”, venivano evidenziate già negli anni Settanta (Lombardi Satriani, 1973, op. cit.), come si è accennato. In quegli
anni il fenomeno della rivitalizzazione andava di pari passo a processi di
folk revival e riattivazione consumistica delle tradizioni, spesso sottesa al
ripristino turisticizzato, al riuso di antiche tradizioni e prodotti locali a scopi commerciali.
In questo contesto teorico rinnovato, o almeno apparentemente centrato
su un diverso versante, un lavoro come quello proposto qui – che partiva
da un’ipotesi di ricerca stretta attorno al nucleo rituale di una festa specifica, delle sue torsioni contemporanee locali e non e della loro costruzione
39
– ha subìto necessariamente, in corso d’opera, dei mutamenti d’intenti, o
meglio dei cambiamenti di concetti su cui concentrarsi. In altre parole, sebbene il mio intento iniziale non fosse esplicitamente quello di occuparmi di
“patrimonio” o di UNESCO, l’avanzare dell’etnografia ha provocato una
torsione di interesse, prodotta dagli eventi e dai “dati” raccolti sul campo.
Col risultato di un tentativo di analizzare, a partire dalla lunga etnografia
di una comunità e della sua festa, i principali gangli di questo frangente di
riflessione che coinvolge in pieno gli studi demoetnoantropologici, sia dal
punto di vista teorico che metodologico.
I.3 Una festa “buona da pensare”
Come si è accennato, molteplici sono stati nel tempo i tentativi di formalizzazione teorica della dimensione festiva, tra questi per analizzare la
festa dei Gigli di Nola si parte da quello secondo cui essa diviene espressione culturale di una dimensione micro (Appadurai, 2001, ed. or. 1996,
op. cit.), che si concentra sul concetto di rito come fabbricazione della
dimensione locale e di rimodulazione dei suoi confini. La festa dei Gigli
orienta in questo senso i “confini del mondo” nel territorio in cui si svolge, a partire dall’insieme di rituali che la comunità sente propri e vive
in maniera esclusiva. I Gigli saldano nella dimensione identitaria locale
la prospettiva globale, attraverso il radicamento al passato ma soprattutto
grazie a pratiche ibride, a una struttura antiolistica, al carattere mutevole
e permeabile alle innovazioni, a tensioni perennemente creative. Questa
festa sembra quasi divenire per gli attori locali una lente d’ingrandimento
del mondo, attraverso cui la dimensione identitaria si cimenta nel contemporaneo per fissare il proprio ruolo e la propria presenza, grazie ai mezzi
con i quali la stessa si muove, si modifica nel tempo e acquista senso e
significato diverso.
Responsabilità dell’antropologia è, quindi, quella di indagare i meccanismi con cui le unità portatrici di significati all’interno di una comunità si
organizzano in significati più complessi. Uno studio morfologico che introduce alle teorie sulla festa tentando una sistemazione teorica del festivo,
in rapporto al suo nucleo rituale e alla sua origine mitopoietica, partendo
però dalle dinamiche di autorappresentazione che si attivano attorno alle
presunte origini mitiche del rituale e da un’analisi dell’organizzazione e
dell’elaborazione creativa, quotidiana della festa. In relazione a uno spettro
40
di tensioni ermeneutiche come il rapporto locale-globale, si tentano interpretazioni possibili.
Assunto che, soprattutto nei termini patrimoniali, la festa debba intendersi come un bene “vivo” e in continuo mutamento, si deve tentare di analizzarlo inserito nei cambiamenti interni alla società. Su una simile linea di
argomenti si sposta un’antropologia più recente definita “transnazionale”,
che analizza i flussi culturali globali, rincorre gli spostamenti dei migranti,
problematizza i confini del terreno di ricerca e che con Marcus diventa
“multi-situata” nella pratica etnografica.
Faeta (2005, op. cit.) sostiene che la località rappresenta, riprendendo
Appadurai, una fragile conquista che va mantenuta; essa è una realtà articolata che è terminale di sistemi più estesi a livello locale, regionale, nazionale e sopranazionale perché, rileggendo Bourdieu (1983, ed. or. 1979;
2003a, ed. or. 1972; 2003b, ed. or. 1980), essa è un campo di interazione
conflittuale tra gruppi che vogliono gestire il potere. A proposito dei fenomeni di ibridazione che hanno sempre caratterizzato la tradizione, come
evidenziano i processi della sua costruzione, ri-tradizionalizzazione e della
sua invenzione, già Turner nel suo “Dal rito al teatro” notava come la conflittualità propria del dramma sociale fosse il luogo del maggior dinamismo
e creatività della communitas. Una riflessione sul rituale e la performance,
utilizzando le categorie di societas e communitas rituali e festive (Turner,
1982; 1990, ed. or. 1987; 1997a, ed. or. 1993; con Turner, 1997b).
L’analisi etnografica della festa dei Gigli parte proprio dall’ipotesi di
una imponente centralità della festa nella località, non solo strettamente relativa ai confini della città di Nola. Questo sollecita il tentativo di decostruire la nozione di “tempo festivo” visto esclusivamente come tempo ludico
o libero, loisir, chiaramente frutto della modernità (Fournier, Crozat, Bernié-Boissard, Chastagner, 2009). Il mio ragionamento viene mosso induttivamente dall’esperienza etnografica, che conduce ad avanzare l’ipotesi di
una necessità di analisi del festivo come di un tempo “totalizzante” rispetto
alla vita della comunità locale e non solo. L’idea di una festa che relega
le energie dei protagonisti e degli amanti della stessa al momento rituale
distanziato dal quotidiano non potrebbe assumersi realisticamente per la
festa dei Gigli di Nola, come si comprenderà nel corso del volume. Il tempo quotidiano, che rimane tempo della fatica e della precarietà – mai più di
oggi, potremmo dire – si fonda, a livello simbolico, sul “tempo forte” della
festa (Lombardi Satriani, 2004b, p. 103). Non si tratta di un tempo festivo
che si alterna al tempo del lavoro e della vita quotidiana, come lo intendeva
41
Lanternari. Si tratta di un tempo che è talmente percepito e condotto come
“tempo forte” dalla comunità che “pratica” a vari livelli la festa, che riesce
a plasmare la quotidianità in maniera pervasiva, attraverso l’inserimento
nella sfera lavorativa, in quella economica, in quella politica, in quella sentimentale, etc., attraverso l’occupazione massiccia dei principali e innovativi mezzi di comunicazione. A Nola le immagini, i valori, i saperi mutuati
dalla festa e soprattutto i discorsi e le retoriche su di essa, occupano, per
esempio, la dimensione dialogica virtuale quotidiana dei protagonisti; così
come i festeggiamenti, le celebrazioni hanno frequenza almeno mensile e
assorbono gli spazi e i tempi dell’intero anno “giglistico”.
Ma l’idea di tempo festivo totalizzante, viene assunta oltre che in riferimento alla dimensione temporale, anche rispetto alla dimensione fisica,
“corporea” della festa. In altre parole, molti dei dati dimostrano come, sia
a livello individuale che collettivo, la festa dei Gigli venga dai protagonisti
quotidianamente “incorporata”, come direbbe Bourdieu e come la dimensione festiva investa completamente i livelli di comunicazione con l’esterno, gli spazi e i tempi della comunità.
A questo proposito il concetto di “comunità di pratica” riflette i protagonisti che, a prescindere dal territorio e dalle origini comuni, sono legati
tra loro soprattutto dalla “pratica” e sono accomunati da una condivisione
di una passione che investe sensi, emozioni e valori più intimi. Il mondo
“giglistico” si assume così come una dimensione legata all’esperire più che
al conoscere e si sviluppa sulla pratica di un atto condiviso, che richiede il
coinvolgimento attivo dei protagonisti, il coordinamento delle loro energie
individuali in funzione di imprese riconosciute collettivamente.
Dunque, il legame con il dibattito sul patrimonio immateriale, i nuclei
teorici qui sopra solo accennati e molti altri aspetti insiti in questo lavoro,
credo possano far guardare alla festa dei Gigli di Nola – analizzata sia
come categoria antropologica che come oggetto di attenzione etnografica
– come ad una festa “buona da pensare”, parafrasando una espressione
ben nota nella letteratura (Lèvi-Strauss, Harris, 1992). Nel suo complesso
concretarsi e nei suoi aspetti più moderni, infatti, essa diviene un “oggetto”
che investe trasversalmente molti dei dibattiti contemporanei e che chiama
in causa alcuni tra i gangli più cocenti del pensiero antropologico.
La festa diviene un contenitore di significati mutevoli, riprendendo la
definizione di simbolo di Barthes, proprio perché è analizzato come un
oggetto dalle sfaccettature infinite, un prisma. La festa dei Gigli di Nola,
infatti, oltre a rappresentare una delle maggiori sporgenze tradizionali nel
42
panorama meridionale, si presenta particolarmente complessa al suo interno, ma soprattutto viene ripetuta da diverso tempo in vari luoghi e per
varie ricorrenze e motivazioni, ed è proprio questa dimensione “migrante”,
a vari livelli, che ha suscitato parte dell’interesse di ricerca.
Come dimostrerà lo spoglio della letteratura sui Gigli, si tratta di una
festa che da sempre ha suscitato l’attenzione degli antropologi ma che
in realtà registra una mancanza di etnografie di lungo periodo. I Gigli si
reinventano costantemente dal di dentro secondo un processo che li rende
sempre “contemporanei” e soprattutto sempre più partecipati dalle giovani
generazioni. Le nuove tecnologie, che rappresentano gli strumenti di dialogo e comunicazione più utilizzati da giovani e meno giovani, diventano
spesso i luoghi in cui la stessa festa viene dibattuta, organizzata, rappresentata, guardata e riguardata (Bindi, 2008a, pp. 87-95; 2008b, pp. 151-177).
Dunque si parte, qui, dall’idea di migrazione della festa a vari livelli: la
dislocazione di essa in vari territori in ambito regionale, la sua esportazione in Italia e in Europa, la pluri-riproduzione del rito in contesto migratorio
americano e, non ultima, la sua dislocazione nel mondo virtuale che giorno
dopo giorno vede aumentare la presenza dei suoi protagonisti sul web.
La festa dei Gigli si conferma poi “buona da pensare” in senso antropologico, proprio perché si trova al centro di dibattiti che investono le nuove
tendenze degli studi sul patrimonio culturale immateriale suscitando, volente o nolente, interesse e attenzione da più parti e rischiando di diventare
oggetto di manipolazione interna ed esterna. Le comunità che sostengono,
sono protagoniste e praticano la festa, sono accomunate da un’unica “passione” sulla quale rileggono costantemente il loro orizzonte di valori, la
loro visione del mondo, il loro ciclo di vita e i loro orientamenti religiosi,
politici, economici e di senso. Le storie che propongo narrano di persone
diverse fra loro, di famiglie, di comunità legate a doppio filo da una “pratica” comune che racconta oggi una parte del Sud dell’Italia, ma anche una
parte della migrazione italiana in America, unendo nuclei di protagonisti di
un teatro di emozioni e passioni che il tempo sembra non ledere.
Infine, quella presentata qui è un’istantanea di un cerimoniale e di una
comunità che oggi è inscritta nella lista rappresentativa dell’UNESCO relativa al Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità insieme a molte
altre nel mondo e come tale occorre analizzarla, perché ancora più essa
può dirci dei rapporti tra comunità locali e mondo globale e dei processi di
patrimonializzazione delle passioni.
43