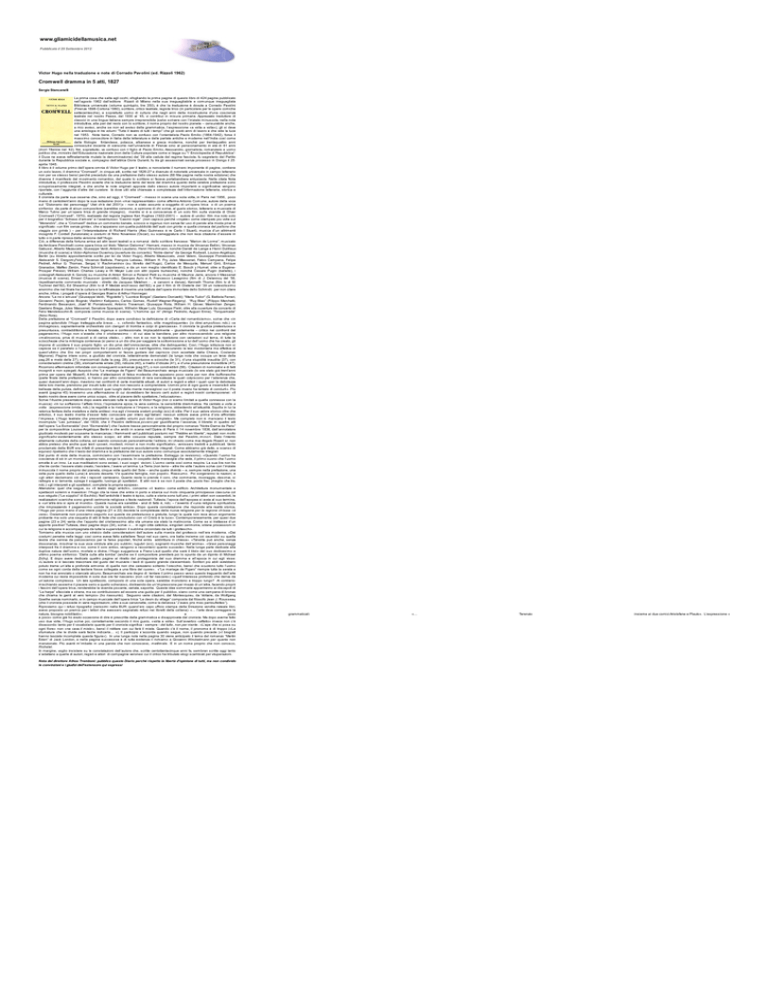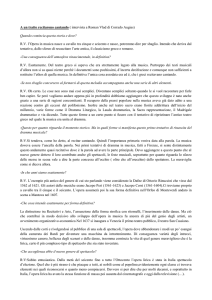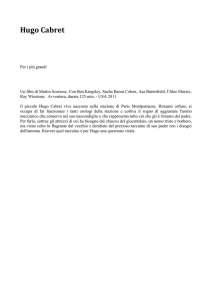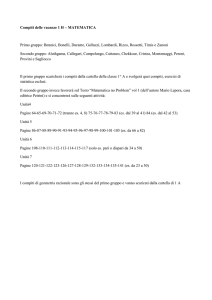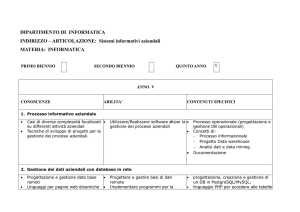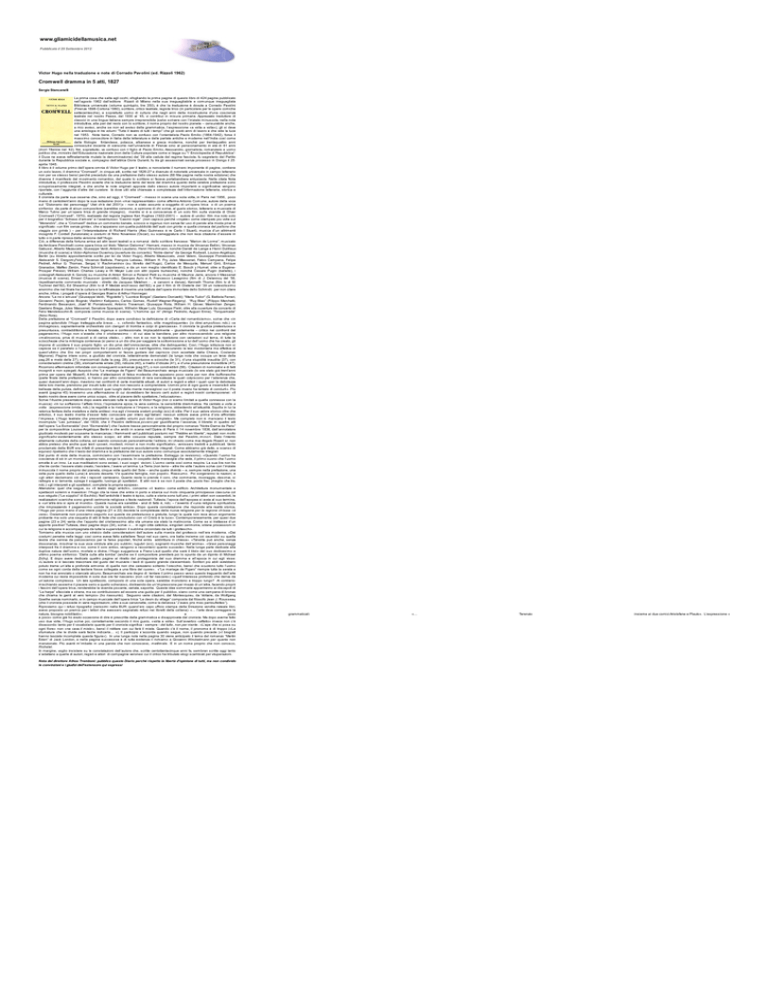
www.gliamicidellamusica.net
Pubblicato il 29 Settembre 2012
Victor Hugo nella traduzione e note di Corrado Pavolini (ed. Rizzoli 1962)
Cromwell dramma in 5 atti, 1827
Sergio Stancanelli
La prima cosa che salta agli occhi, sfogliando le prime pagine di questo libro di 424 pagine pubblicato
nell’agosto 1962 dall’editore Rizzoli di Milano nella sua ineguagliabile e comunque ineguagliata
Biblioteca universale (volume quintuplo, lire 350), è che la traduzione è dovuta a Corrado Pavolini
(Firenze 1898-Cortona 1980), scrittore, critico teatrale, regista lirico (in particolare per le opere comiche
settecentesche), e soprattutto uomo di cultura che negli anni della ricostruzione d’una coscienza
teatrale nel nostro Paese, dal 1930 al ’45, vi contribuì in misura primaria. Apprezzato traduttore di
classici in una lingua italiana sempre irreprensibile (salvo scrivere con l’iniziale minuscola, nella nota
introduttiva, alla pari del resto con lo scrittore, il nome proprio del nostro pianeta – censurabile anche,
a mio avviso, anche se non ad avviso della grammatica, l’espressione «a volta a volta»), gli si deve
una antologia in tre volumi “Tutto il teatro di tutti i tempi” che gli costò anni di lavoro e che vide la luce
nel 1953. Nota bene, Corrado non va confuso con l’orientalista Paolo Emilio (1864-1942), forse il
massimo conoscitore in Italia della letteratura e delle parlate antiche e moderne nell’India così come
delle filologie finlandese, polacca, albanese e greca moderna, nonché per trentaquattro anni
consecutivi docente di sànscrito nell’università di Firenze sino al pensionamento in età di 61 anni
(morì 78enne nel ‘42). Né, soprattutto, va confuso con il figlio di Paolo Emilio, Alessandro, giornalista, romanziere e uomo
politico che, ministro dell’Educazione nazionale (non della Cultura popolare come si legge su “l’ Enciclopedia di Repubblica”:
il Duce ne aveva raffinatamente mutato la denominazione) dal ’39 alla caduta del regime fascista, fu segretario del Partito
durante la Repubblica sociale e, compagno dell’attrice Doris Duranti, fu tra gli assassinati senza processo in Dongo il 25
aprile 1945.
Il libro è il volume primo dell’opera omnia di Victor Hugo per il teatro, e nonostante il numero imponente di pagine, contiene
un solo lavoro, il dramma “Cromwell”, in cinque atti, scritto nel 1826-27 e divenuto di notorietà universale in campo letterario
non per se stesso bensì perché preceduto da una prefazione dello stesso autore (68 fitte pagine nella nostra edizione) che
divenne il manifesto del movimento romantico, del quale lo scrittore si faceva portabandiera entusiasta. Nella citata Nota
introduttiva, il professore Pavolini avverte che la traduzione tanto del testo del dramma quanto della celebre prefazione sono
scrupolosamente integrali, e che anche le note originali apposte dallo stesso autore importanti e significative vengono
riportate, con l’aggiunta d’altre del curatore là dove utili alla chiarezza e completezza dell’informazione letteraria, storica e
culturale.
Il cronista da parte sua osserva che, sino ad oggi, il “Cromwell” - messo in scena una sola volta, in Paris nel 1956, poco
meno di centotrent’anni dopo la sua redazione (non «mai rappresentato» come afferma Antonio Comune, autore della voce
sul “Dizionario dei personaggi” Utet ch’è del 2001)» - non è stato assunto a soggetto di un’opera lirica o di un poema
sinfonico da parte di alcun compositore (sarebbe consono, a opinione di chi scrive, al gusto storico, letterario e musicale di
Marco Tutino per un’opera lirica di grande impegno), mentre si è a conoscenza di un solo film sulla vicenda di Oliver
Cromwell (“Cromwell”, 1970), realizzato dal regista inglese Ken Hughes (1922-2001) – autore di undici film ma noto solo
per il biografico “Schiavo d’amore” e l’avventuroso “Casinò royal” (non capisco perché «royale» come stampato più volte sul
“Morandini”, che a “Cromwell” dedica un commento banale, sciocco e ingenuo non senza far uso di parole alla moda prive di
significato: «un film senza grinta», che s’appaiano con quella pubblicità dell’auto con grinta e quella cronaca del pallone che
viaggia con grinta ) – per l’interpretazione di Richard Harris (Alec Guinness è re Carlo I Stuart), musica d’un altrimenti
incognito F. Cordell (funzionale) e costumi di Nino Novarese (Oscar), su sceneggiatura che non reca citazione d’essere in
tutto o in parte ripresa dalla versione dell’Hugo.
Ciò, a differenza della fortuna arrisa ad altri lavori teatrali e a romanzi dello scrittore francese: “Marion de Lorme”, musicato
da Amilcare Ponchielli come opera lirica col titolo “Marion Delorme”; Hernani, messo in musica da Vincenzo Bellini, Vincenzo
Gabussi, Alberto Mazzucato, Giuseppe Verdi, Antonio Laudano, Henri Hirschmann, nonché Daniël de Lange e Henri Dutilleux
(musiche di scena) e Victor-Alphonse Duvernoy (ouverture da concerto); “Notre-dame” da George Rodwell, Louise-Angélique
Bertin (su libretto appositamente scritto per lei da Victor Hugo), Alberto Mazzuccato, José Valero, Giuseppe Poniatowski,
Aleksandr S. Dargomy?skij, Vincenzo Battista, François Lebeau, William H. Fry, Jules Massenet, Fabio Campana, Felipe
Pedrell, Arthur G. Thomas, Sergej V. Rachmaninov (su libretto dell’Hugo), Carlos de Mesquita, Manuel Giró, Enrique
Granados, Maffeo Zanòn, Franz Schmidt (capolavoro), e da un non meglio identificato E. Bosch y Humet, oltre a EugèneProsper Prévost, William Charles Levey e W. Meyer Lutz con altri (opere burlesche), nonché Cesare Pugni (balletto), i
coreografi Aleksandr A. Gorskij su musiche di Anton Simon e Roland Petit su musiche di Maurice Jarre, ancora il Massenet
(musica di scena), Ernest Chausson (poemetto), Georges Auric e A. Francesco Lavagnino (film di J. Delannoy del ’56,
rispettivamente commento musicale - diretto da Jacques Metehen - , e canzoni e danza), Kenneth Thorne (film tv di M.
Tuchner dell’82), Ed Shearmur (film tv di P. Medák anch’esso dell’82); e per il film di W. Dieterle del ’39 un notevolissimo
anonimo che nel finale ha la cultura e la raffinatezza di inserire una battuta dall’opera immortale dello Schmidt: per non citare
anche, infine, i progetti d’opera di Georges Bizet e di Arthur Honneger.
Ancora: “Le roi s’amuse” (Giuseppe Verdi, “Rigoletto”); “Lucrèce Borgia” (Gaetano Donizetti); “Maria Tudor” (G. Battista Ferrari,
Giovanni Pacini, Ignác Bognár, Vladimir Kašperov, Carlos Gomes, Rudolf Wagner-Régeny). “Ruy Blas” (Filippo Marchetti,
Ferdinando Besanzoni, Józef M. Poniatowski, Antonio Traversari, Giuseppe Rota, William H. Glover, Maximilian Zenger,
Gaetano Braga, Jules Massenet, Senatore Sparapani, Wilhelm Meyer Lutz, Giuseppe Pietri, oltre alla ouverture da concerto di
Felix Mendelssohn-B. composta come musica di scena). “L’homme qui rit” (Arrigo Pedrollo, August Enna). “Torquemada”
(Nino Rota).
Della prefazione al “Cromwell” il Pavolini, dopo avere condiviso la definizione di «Carta del romanticismo», scrive che «in
pagine splendide l’Hugo tratteggia alla b rava… », «sfondo fantastico, stile magniloquente» (io direi am polloso, ndc.) «e
immaginoso, sapientemente orchestrato con clangori di tromba e colpi di grancassa». Il cronista la giudica pretestuosa e
presuntuosa, contraddittoria e forzata, ingenua e confessionale. Implacabilmente – giustamente – critico nei confronti del
paganesimo, l’Hugo non s’avvede che il cristianesimo – di cui alza la bandiera, per altro riconoscendolo una religione
«malinconica, priva di muscoli e di carica vitale», – altro non è se non la ripetizione con variazioni sul tema, di tutte le
sciocchezze che la mitologia conteneva (si pensi a un dio che per saggiare la sottomissione a lui dell’uomo che ha creato, gli
impone di uccidere il suo proprio figlio: un dio privo dell’onniscienza, oltre che delinquente). Così, l’Hugo istituisce non si
capisce se il parallelo o l’opposizione fra il pseudo Longino e sant’Agostino, trascurando la tesi involontaria ma effettiva di
quest’ultimo che Dio nei propri comportamenti si faccia guidare dal capriccio (non accettata dalla Chiesa, Costanzo
Mignone). Pagine intere sono, a giudizio del cronista, letteralmente demenziali (la lunga nota che occupa un terzo della
pag.26 e metà della 27), manicomiali (tutta la pag. 28), presuntuose e sciocche (la 31), d’una stupidità inaudita (37), con
considerazioni cretine (38), storicamente errate (39), ridicole (40), a livello d’idiozie (41), e d’una presunzione incredibile (47).
Ricorrono affermazioni infondate con conseguenti scemenze (pag.57), o non condividibili (58). Citazioni di nominativi e di fatti
incogniti e non spiegati. Auspicio che “Le mariage de Figaro” del Beaumarchais venga musicato (lo era stato già trent’anni
prima per opera del Mozart!). A fronte d’attestazioni di falsa modestia che appaiono poco serie per non dire buffonesche
(parte finale della prefazione), si hanno per altro considerazioni di rara sensatezza le quali colpiscono per l’aderenza che,
quasi duecent’anni dopo, rivestono nei confronti di certe mentalità attuali, di autori e registi e attori i quali «per la debolezza
della loro mente, prendono per insulti tutto ciò che non riescono a comprendere. Uomini privi di ogni gusto e insensibili alla
bellezza della pulizia, definiscono ridicoli quei luoghi della mente meravigliosi cui il poeta invano ha tentato di condurli». Più
avanti (pagina 45) troveremo una affermazione di cui dovrebbero far tesoro certi autori e registi nostri contemporanei: «Il
teatro nostro deve avere come unico scopo, oltre al piacere dello spettatore, l’educazione».
Scrive l’illustre presentatore dopo avere elencato tutte le opere di Victor Hugo (noi ci siamo limitati a quelle connesse con la
musica): «In lui soffiarono l’afflato lirico, l’ispirazione epica, la vena satirica, la sensibilità drammatica. Ha cantato a volta a
volta (espressione òrrida, ndc.) la regalità e la rivoluzione e l’impero, e la religione, obbedendo all’attualità. Squilla in lui la
retorica fanfara delle metafore e delle antitesi: ma egli v’innesta oratorii prodigi (sic) di stile. Per il suo valore storico oltre che
artistico, il suo teatro merita d’esser fatto conoscere per intero agl’italiani: nessun editore aveva prima d’ora affrontato
l’impresa. L’Hugo teatrale che presentiamo in quattro volumi può dirsi completo». Ma completo non è: mancano il testo
incompiuto “Les jumeaux”, del 1839, che il Pavolini definisce povero per giustificarne l’assenza; il libretto in quattro atti
dell’opera “La Esmeralda” (non “Esmeralda”) che l’autore trasse personalmente dal proprio romanzo “Notre-Dame de Paris”
per la compositrice Louise-Angélique Bertin e che andò in scena nell’Opéra di Paris il 14 novembre 1836, dall’annotatore
giudicato modesto per scusarne la mancanza; i frammenti varî pubblicati postumi nel “Théâtre en liberté”, reputati non molto
significativi evidentemente allo stesso scopo; ed altre cosucce reputate, sempre dal Pavolini, m inori. Dato l’intento
altamente culturale della collana, ed avendo conosciuto personalmente l’editore, mi chiedo come mai Angelo Rizzoli sr. non
abbia preteso che anche quei testi «poveri, modesti, minori e non molto significativi», venissero tradotti e pubblicati. Vanto
proclamato della BUR era infatti di presentare testi sempre assolutamente integrali. Come abbiamo già detto, a scanso di
equivoci ripetiamo che il testo del dramma e la prefazione del suo autore sono comunque assolutamente integrali.
Dal punto di vista della musica, cominciamo con l’esaminare la prefazione. Estraggo (e revisiono). «Quando l’uomo ha
coscienza di sé in un mondo appena nato, sorge la poesia. In cospetto delle meraviglie che vede, il primo suono che l’uomo
emette è un inno. Le sue meditazioni sono estasi, i suoi sogni visioni. L’uomo canta così come respira. La sua lira non ha
che tre corde: l’essere stato creato, l’esistere, l’avere un’anima. La Terra (non terra – altre tre volte l’autore scrive con l’iniziale
minuscola il nome proprio del pianeta, cinque volte quello del Sole – anche quale divinità – e, sempre nella prefazione, una
volta pure quello della Luna) è ancora deserta. V’è qualche famiglia, non popoli». Riassumo. Poi sorgeranno le nazioni, e
«gli attori declamano ciò che i rapsodi cantavano. Quanto resta lo prende il coro, che commenta, incoraggia, descrive, si
rallegra e si lamenta, spiega il soggetto, lusinga gli spettatori. E altri non è se non il poeta che, posto fra» (meglio che tra,
ndc.) «gli interpreti e gli spettatori, completa la propria epopea».
Attenzione: quel che segue, su «Il teatro degli antichi», concerne «il teatro» come edificio. Architettura monumentale e
spettacoli solenni e maestosi: l’Hugo cita la nave che entra in porto e sbarca sul molo cinquanta principesse ciascuna col
suo sèguito (“Le sùpplici” di Eschilo). Nell’antichità il teatro è èpico, culto e storia sono tutt’uno, i primi attori son sacerdoti, le
realizzazioni sceniche sono grandi cerimonie religiose o feste nazionali. Tuttavia, l’epoca dell’epopea si avvia al suo termine,
e «un’altra èra si apre al mondo». Questa nuova era sarebbe - anzi di fatto è, ndc. – l’avvento d’«una religione spiritualista
che rimpiazzando il paganesimo uccide la società antica». Dopo questa constatazione che risponde alla realtà storica,
l’Hugo per poco meno d’una intera pagina (21 e 22) decreta la completezza della nuova religione per la ragione ch’essa «è
vera». Ovviamente non possiamo seguirlo sui questa via pretestuosa e gratuita, lungo la quale non reca alcun argomento
probante ma solo una sequela di atti di fede che concludono con «il Cristo è la luce». Contemporaneamente, per quasi due
pagine (23 e 24) vanta che l’apporto del cristianesimo alla vita umana sia stato la malinconia. Come se si trattasse d’un
apporto positivo! Tuttavia, dieci pagine dopo (34), scrive: «… in ogni città cattolica, singolari cerimonie, strane processioni in
cui la religione è accompagnata da tutte le superstizioni: il sublime circondato da tutti i grotteschi».
Torniamo alla musica con uno stralcio dalle considerazioni dell’autore sulla marcia del grottesco nell’era moderna. «Dai
costumi penetra nelle leggi: così come aveva fatto saltellare Tespi nel suo carro, ora balla insieme coi causidici su quella
tavola che serviva da palcoscenico per le farse popolari, finché entra addirittura in chiesa». «Talvolta può anche, senza
dissonanza, mischiar la sua voce stridula alle più sublimi, lugubri (sic), sognanti musiche dell’anima». «Gravi personaggi
interposti fra il dramma e noi, come il coro antico, vengono a raccontarci quanto succede». Nella lunga parte dedicata alla
duplice natura dell’uomo, mortale e divina, l’Hugo suggerisce a Franz Liszt quello che sarà il titolo del suo dodicesimo e
ultimo poema sinfonico: “Dalla culla alla tomba” (anche se il compositore prenderà poi lo spunto da un dipinto di Michael
Zichy). E dopo avere dedicato quattro pagine al ritratto del protagonista del suo dramma e all’epoca in cui egli visse:
«L’autore si è lasciato trascinare dal gusto del muovere i tasti di questo grande clavicembalo. Scrittori più abili avrebbero
potuto trarne un’alta e profonda armonia: di quelle non che carezzano soltanto l’orecchio, bensì che scuotono tutto l’uomo
come se ogni corda della tastiera fosse collegata a una fibra del cuore». «”Le mariage de Figaro” riempie tutta la serata e
non ha mai annoiato o stancato alcuno. Beaumarchais era degno di tentare il primo passo verso questo traguardo dell’arte
moderna cui resta impossibile in sole due ore far nascere» (non «di far nascere») «quell’interesse profondo che deriva da
un’azione complessa. Un tale spettacolo, composto di una sola opera, sarebbe monotono e troppo lungo? Al contrario:
mischiando assieme il piacere serio e quello scherzoso, distraendo da un’impressione per mezzo di un’altra, facendo proprii
i fascini dell’opera lirica, renderebbe la vicenda piccante, variata, saporita. Queste idee sommarie appariranno ai discepoli di
“La harpe” sfacciate e strane, ma se contribuissero ad essere una guida per il pubblico, siano come una campana di bronzo
che chiama le genti al vero tempio» (ho riassunto). Seguono varie citazioni, dal Montesquieu, da Voltaire, da Wolfgang
Goethe senza nominarlo, e in campo musicale dell’opera lirica “Le devin du village” composta dal filosofo Jean J. Rousseau
(che il cronista possiede in varie registrazioni, oltre a sue canzonette, come la deliziosa “J’avais pris mes pantouflettes”).
Riproviamo qui i refusi tipografici (rarissimi nella BUR: quand’ero capo ufficio stampa della Direzione vendita rateale libri,
avevo proposto un premio per i lettori che avessero segnalato refusi nei libretti della collana): «… l’arte deve correggere la
natura, bisogna nobilitarlo»;
e
poco
a poco» come già ho avuto occasione di dire è prescritta dalla grammatica e disapprovata dal cronista. Ma dopo averne fatto
uso due volte, l’Hugo scrive poi, correttamente secondo il mio gusto, «volta a volta». Sull’avverbio «affatto» invece non c’è
disaccordo: tanto per il vocabolario quanto per il cronista significa - sempre - del tutto , non per niente . «L’ape che si posa su
ogni fiore» non «ne cava il miele », bensì il nèttare con cui farà il miele. Quando c’è il nome, il pronome è di troppo («La
sfumatura che le divide sarà facile indicarla… »). Il participio s’accorda quando segue, non quando precede («I biografi
hanno lasciata incompleta questa figura»). In una lunga nota nella pagina 30 viene anticipato il tema del romanzo “Martin
Eden” di Jack London, e nella pagina successiva è di tutta evidenza il richiamo a Giovanni Winckelmann per quanto non
menzionato. Più avanti m’imbatto in una parola che non conoscevo, mettimàle. E in un nome proprio che non conosco,
Richelet.
In margine, voglio insistere su le constatazioni dell’autore che, scritte centottantacinque anni fa, sembran scritte oggi tanto
s’adattano a quelle di autori, registi e attori di compagnie veronesi cui il critico ha tributato elogi scambiati per vituperazioni.
Nota del direttore Athos Tromboni: pubblico questo Diario perché rispetto la libertà d'opinione di tutti, ma non condivido
le convinzioni e i giudizi dell'estensore qui espressi
grammaticali:
«…
Terenzio
insieme ai due comici Aristofane e Plauto». L’espressione «