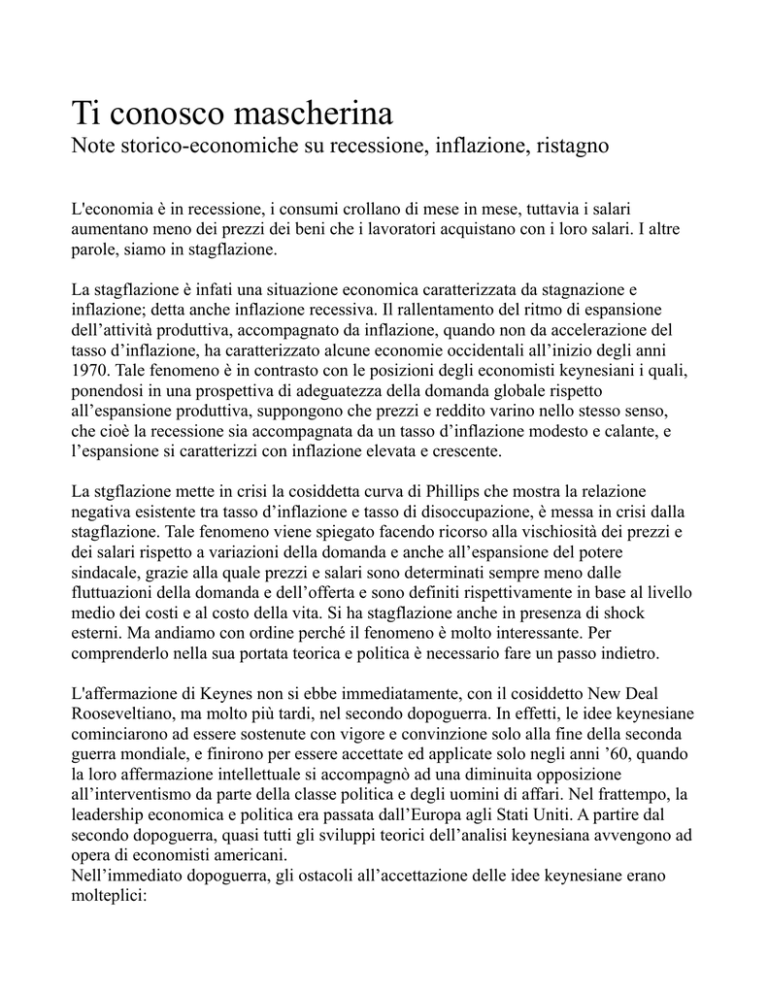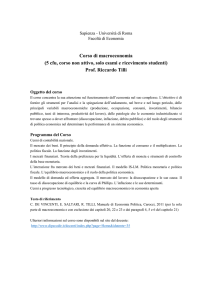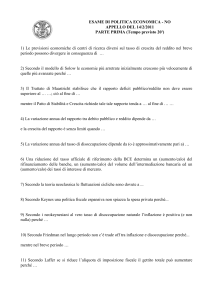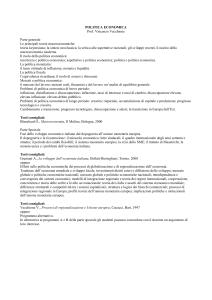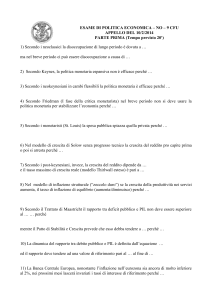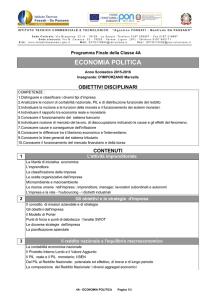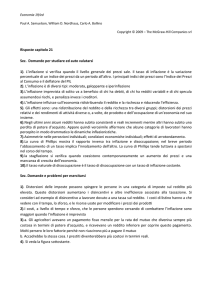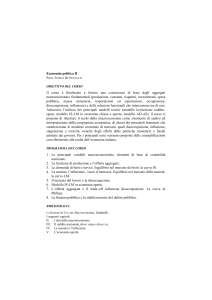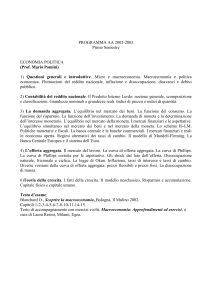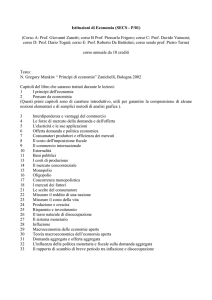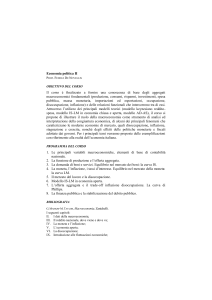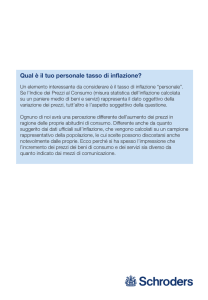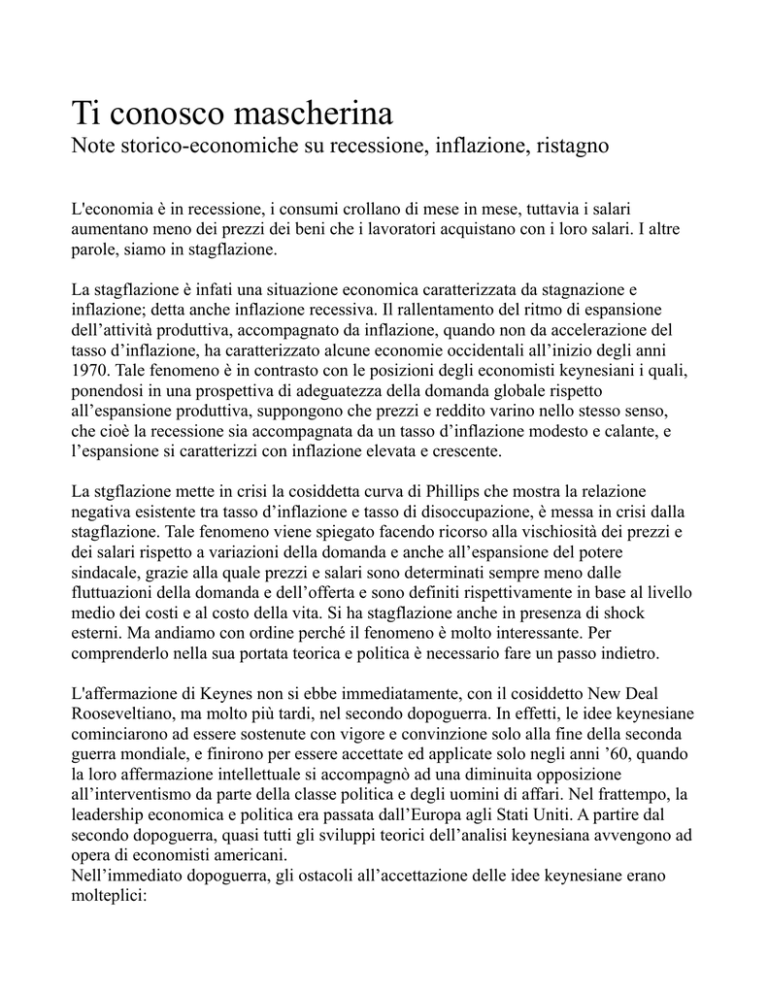
Ti conosco mascherina
Note storico-economiche su recessione, inflazione, ristagno
L'economia è in recessione, i consumi crollano di mese in mese, tuttavia i salari
aumentano meno dei prezzi dei beni che i lavoratori acquistano con i loro salari. I altre
parole, siamo in stagflazione.
La stagflazione è infati una situazione economica caratterizzata da stagnazione e
inflazione; detta anche inflazione recessiva. Il rallentamento del ritmo di espansione
dell’attività produttiva, accompagnato da inflazione, quando non da accelerazione del
tasso d’inflazione, ha caratterizzato alcune economie occidentali all’inizio degli anni
1970. Tale fenomeno è in contrasto con le posizioni degli economisti keynesiani i quali,
ponendosi in una prospettiva di adeguatezza della domanda globale rispetto
all’espansione produttiva, suppongono che prezzi e reddito varino nello stesso senso,
che cioè la recessione sia accompagnata da un tasso d’inflazione modesto e calante, e
l’espansione si caratterizzi con inflazione elevata e crescente.
La stgflazione mette in crisi la cosiddetta curva di Phillips che mostra la relazione
negativa esistente tra tasso d’inflazione e tasso di disoccupazione, è messa in crisi dalla
stagflazione. Tale fenomeno viene spiegato facendo ricorso alla vischiosità dei prezzi e
dei salari rispetto a variazioni della domanda e anche all’espansione del potere
sindacale, grazie alla quale prezzi e salari sono determinati sempre meno dalle
fluttuazioni della domanda e dell’offerta e sono definiti rispettivamente in base al livello
medio dei costi e al costo della vita. Si ha stagflazione anche in presenza di shock
esterni. Ma andiamo con ordine perché il fenomeno è molto interessante. Per
comprenderlo nella sua portata teorica e politica è necessario fare un passo indietro.
L'affermazione di Keynes non si ebbe immediatamente, con il cosiddetto New Deal
Rooseveltiano, ma molto più tardi, nel secondo dopoguerra. In effetti, le idee keynesiane
cominciarono ad essere sostenute con vigore e convinzione solo alla fine della seconda
guerra mondiale, e finirono per essere accettate ed applicate solo negli anni ’60, quando
la loro affermazione intellettuale si accompagnò ad una diminuita opposizione
all’interventismo da parte della classe politica e degli uomini di affari. Nel frattempo, la
leadership economica e politica era passata dall’Europa agli Stati Uniti. A partire dal
secondo dopoguerra, quasi tutti gli sviluppi teorici dell’analisi keynesiana avvengono ad
opera di economisti americani.
Nell’immediato dopoguerra, gli ostacoli all’accettazione delle idee keynesiane erano
molteplici:
la tradizionale mentalità ciclica (i cicli facevano parte dell’ordine naturale delle cose ed
erano perciò ineliminabili);
il pregiudizio della derivata prima (se la direzione del cambiamento era positiva, ed il
reddito continuava a crescere, ciò era sufficiente ac acquietare l’opinione pubblica);
l’ipotesi di disoccupazione strutturale (per cui la disoccupazione era dovuta alle
caratteristiche specifiche del mercato del lavoro e non ad una insufficienza della AD);
il principio della sana finanza ortodossa, per cui il bilancio pubblico doveva essere
rigorosamente in pareggio.
La conquista del primato ideologico da parte della teoria neokeynesiana e la conseguente
investitura ufficiale come corrente di pensiero dominante avvenne nei primi anni ’60
negli Stati Uniti con l’Amministrazione Kennedy, la quale propose un programma di
politica economica decisamente innovativo, ispirato dall’impostazione teorica della
cosiddetta New Economics. Tale denominazione voleva sottolineare il fatto che essa
rappresentava un nuovo approccio alla macroeconomia, diverso dall’ortodossia
neoclassica. Nella realtà, però, la base teorica della New Economics era un
compromesso tra la Teoria Generale di Keynes e la stessa Teoria Neoclassica, presto
denominata in letteratura con il termine “Sintesi neoclassica di Keynes”. Tale sintesi era
di natura sia positiva, con riferimento alla teoria, sia normativo, con riferimento alla
politica economica.
1. La sintesi nel campo dell’analisi teorica.
Nonostante i principi ispiratori e le finalità della New Economics fossero tipicamente
keynesiani, lo schema di base era decisamente mutato rispetto a quello della Teoria
Generale.
In particolare i nessi causali keynesiani, riconducibili allo schema:
M
i
I
Y
N
P
L
L
EMC
PmaC,G
W
Y
sono giustificati dal rilievo attribuito al tempo storico, alle aspettative ed alle difformi
velocità di aggiustamento dei vari mercati. Tali nessi vengono eliminati dal modello
della sintesi neoclassica, a favore di uno schema di equilibrio generale in cui si cerca la
combinazione di Y e di i in grado di eguagliare domanda e offerta su entrambi i mercati
dei beni e della moneta. Tale modello è dovuto ai contributi di Hicks, Hansen,
Modigliani e Patinkin, ed è noto in letteratura con il nome di MODELLO IS-LM.
Questo schema, in generale, rappresenta una pesante deviazione dal pensiero
keynesiano, in quanto il ruolo del tempo storico viene eliminato, le aspettative vengono
esogenizzate, e le diverse velocità di aggiustamento sui vari mercati sono eliminate, pur
accettando la possibilità che le curve IS-LM, che restano indipendenti, possano subire
spostamenti.
Il modello si caratterizza per il sistema di equazioni simultanee:
IS:
Y = C(Y,T,R) + I(i) + G
LM:
M/P = L(Y,i,R)
La IS è costituita dal luogo delle coppie (Y,i) per cui il mercato dei beni è in equilibrio,
mentre la LM è costituita dal luogo delle coppie (Y,i) per cui il mercato della moneta è
in equilibrio.
Nel modello la ricchezza (R) è costituita sia dalla componente finanziaria (M+B)/P, sia
dalla componente reale Kq, dove K è lo stock di capitale e q è il rapporto fra il valore di
mercato e il costo di riproduzione dei beni capitali. Si suppone inoltre che allo stock di
capitale corrisponda un analogo valore delle azioni emesse.
Nello schema IS-LM la flessibilità di prezzi e salari è teoricamente in grado di riportare
il sistema al livello di piena occupazione. Infatti, in presenza di disoccupazione, se
cadono i salari monetari, cadranno anche i prezzi, con un conseguente spostamento
verso destra sia della IS (a causa dell’aumento dei saldi di cassa reali e
conseguentemente dei consumi) sia della LM (a causa dell’aumento dell’offerta reale di
moneta). Il processo descritto è necessariamente convergente una volta esclusi i possibili
effetti destabilizzanti di cambiamenti nelle aspettative o della deflazione sui debiti delle
imprese.
In conclusione, pertanto, con la New Economics la rigidità del salario monetario W
torna ad essere la causa di fondo della disoccupazione (proprio come nella teoria
neoclassica), nonostante si riconosca che dal punto di vista pratico il processo
riequilibratore automatico sia lento ed oneroso.
2. La sintesi sul terreno della politica economica
Mentre l’equilibrio di sottoccupazione keynesiano costituisce un’impossibilità (e una
contraddizione) logica in presenza di W e P flessibili, per cui, secondo la sintesi
neoclassica, la teoria di Keynes è teoricamente erronea, dal punto di vista operativo essa
si presenta invece utile nel suggerire provvedimenti in grado di raggiungere più
rapidamente il livello di piena occupazione. In effetti lo strumento più appropriato a tale
fine è la politica fiscale, che consente di stimolare direttamente e con effetti più potenti
la AD. Rispetto alla possibilità di utilizzare la politica economica al fine di raggiungere
il pieno impiego, le argomentazioni neokeynesiane possono essere distinte in due fasi
cronologicamente successive, a seconda delle ipotesi avanzate sulla pendenza relativa
delle curve IS e LM.
In una prima fase, corrispondente agli anni ’50, la teoria neokeynesiana viene identifica
con una posizione di tipo “fiscalista” (sulla base delle considerazioni che si
illustreranno tra poco). In tale prospettiva le tesi di Keynes vengono interpretate in senso
statico: l’investimento, poco sensibile al tasso di interesse, determina una IS rigida;
mentre la domanda di moneta, molto sensibile al tasso di interesse, dà origine ad una
LM elastica. L’inclinazione relativa delle curve IS e LM, corrispondenti a questa visione
originaria dei neokeynesiani nei primi anni ’50, è rappresentata nella figura 1. A causa
della configurazione delle due curve, ne consegue che spostamenti della IS, generati da
shock della AD o da politiche fiscali governativi, generano ampie fluttuazioni del
reddito. A motivo del fatto che la LM è molto piatta, inoltre, il moltiplicatore effettivo
del reddito non è di molto inferiore a quello potenziale ed il fenomeno del crowding-out,
pur presente ed inevitabile, è abbastanza limitato. Per contro, nello stesso schema, la
politica monetaria non è quasi per nulla efficace: la scarsa pendenza della curva fa sì
infatti che incrementi anche notevoli dell’offerta di moneta generino variazioni limitate
dei tassi di interesse; queste ultime, poi, a motivo della rigidità della IS, hanno scarsi
effetti sull’investimento. Di qui il significato del termine “fiscalismo”, attribuito alle
prime versioni della New Economics degli anni ’50: nel modello rappresentato dalla fig.
1, la politica monetaria è praticamente inefficace, mentre la politica fiscale è molto
potente. Volendo estremizzarne le conclusioni, si potrebbe in effetti affermare che “solo
la politica fiscale conta, mentre la moneta non conta”.
Fig. 1. Politica fiscale e shock della AD nel modello keynesiano “fiscalista”
i
LM
IS
IS’
Y*
Y
A seguito delle critiche monetariste al modello fiscalista (che saranno esaminate nel
prossimo capitolo), l’originario punto di vista neokeynesiano muta sensibilmente, con il
risultato di produrre un modello di consenso la cui struttura di fondo diventa accettabile
tanto dai monetaristi quanto dai keynesiani. Questo modello di consenso è il tradizionale
modello IS-LM dei libri di testo, dove, rispetto alla versione fiscalista originaria, sono
mutate le pendenze relative delle due curve: la IS è meno rigida, la LM è meno elastica.
Tali modifiche sottendono una rivalutazione del ruolo della politica monetaria, negato
negli anni ’50.
Con l’accettazione del modello di consenso si aprono però nuove prospettive nella
gestione della politica economica: tanto la politica monetaria quanto quella fiscale
possono infatti essere adottate per raggiungere Y*, adottando un “policy mix” che
consente di ottenere più obiettivi, con diverse strutture della AD.
In effetti, avendo a disposizione due strumenti (politica monetaria e politica fiscale),
risulta riduttivo puntare ad un solo obiettivo (il pieno impiego), ma diventa ragionevole
perseguire obiettivi più ambiziosi quali:
un obiettivo statico: la piena occupazione;
un obiettivo dinamico: la crescita economica.
In particolare, il primo obiettivo è facilmente raggiungibile, tramite diverse
combinazioni di politica monetaria e fiscale, mentre per ottenere il secondo occorre
favorire un uso più intenso della politica monetaria, volto a stimolare una maggiore
accumulazione di capitale, essendo g = g(I).
La combinazione ottimale della politica monetaria e fiscale, ovvero il policy mix di
lungo periodo ideale per ottenere i due obiettivi del pieno impiego e della crescita, è
mostrato nella figura 2. Come si può osservare, mentre il pieno impiego può essere
ottenuto sia con una politica monetaria espansiva ed una concomitante politica fiscale
restrittiva (punto A) o con una combinazione esattamente opposta (punto B), solo la
prima combinazione consente di stimolare la crescita, tramite tassi di interesse bassi e
perciò investimenti elevati.
Fig. 2. Il “policy mix” ideale di lungo periodo
i
LM
LM’
B
A
IS’
IS
Y*
Y
È appena il caso di osservare che, in un mondo dominato dalla guerra fredda, ed in cui la
supremazia tecnologica degli Stati Uniti era stata messa in dubbio dai successi spaziali
sovietici, i Consiglieri economici neokeynesiani di Kennedy suggerirono al Presidente la
combinazione corrispondente al punto A: una strategia che si rivelò in seguito vincente,
grazie al recupero della superiorità tecnologica americana, che si finì con lo stimolare.
Il policy mix ideale di lungo periodo sopra illustrato appare del resto coerente con la
logica della sintesi neoclassica: nel breve periodo qualsiasi manovra della AD è utile per
neutralizzare scostamenti di Y da Y*; ma nel lungo periodo rimangono valide le
indicazioni neoclassiche sui fattori determinanti il tasso di crescita del sistema
economico, ovvero maggiori dotazioni di fattori produttivi (lavoro e capitale) e ritmo del
progresso tecnologico.
Il policy mix precedentemente discusso riguarda la combinazione ottimale di politica
monetaria e fiscale in un’ottica di lungo periodo. Anche nel breve periodo tuttavia è
possibile sostenere l’esistenza di un policy mix ottimale. In particolare, i sostenitori della
New Economics ritenevano possibile una stabilizzazione completa delle fluttuazioni
cicliche, attraverso un FINE TUNING degli strumenti disponibili. L’esistenza di
stabilizzatori automatici, proposti dagli stessi economisti keynesiani, serviva a smussare
le fluttuazioni, ma essi non erano tuttavia sufficienti a stabilizzare completamente
l’economia, continuamente sottoposta a shock di AD esogeni. In particolare gli
stabilizzatori automatici potevano ridurre l’ampiezza ma non la durata delle fluttuazioni;
inoltre gli shock esogeni potevano essere particolarmente accentuati. Si suggerivano
quindi politiche discrezionali di stabilizzazione anticiclica, le quali, come si osserverà
fra poco, implicavano un policy mix di breve periodo ben preciso. Vale la pena di
osservare peraltro come con la New Economics si registra in tal modo un ulteriore
allontanamento rispetto alla posizione originaria di Keynes: il problema non è più
raggiungere N*, ma piuttosto quello di ridurre le fluttuazioni di Y intorno a Y*. La
politica economica assume così caratteristiche ed obiettivi di “STABILIZZAZIONE”,
ovvero ci si propone di minimizzare , inteso come minimizzazione dell’ampiezza e della
durata delle fluttuazioni cicliche intorno al reddito potenziale o di pieno impiego.
Nell’affrontare gli shock di breve periodo, però, gli strumenti di politica fiscale e
monetaria non hanno lo stesso ruolo:
la politica monetaria ha effetti asimmetrici, e risulta quindi più utile ed efficace, oltre
che rapida, nel reprimere eventuali boom inflazionistici;
la politica fiscale, invece, è più idonea ad affrontare situazioni di temporanea
depressione, quando le aspettative sono pessimistiche, mettendo in moto effetti
moltiplicativi sulla AD.
Rispetto a Keynes, infine, la New Economics si contraddistingue per l’enfasi posta sulla
tassazione, piuttosto che sulla sola spesa pubblica, come strumento di bilancio: se lo
scopo delle autorità di Governo è quello di stabilizzare il reddito, cambiamenti del
regime fiscale, soprattutto se di carattere temporaneo, modificano la convenienza
temporale a consumare, e diventano un importante strumento di fine tuning. L’uso della
tassazione, anziché della spesa pubblica, non implica possibili contrasti tra interessi
privati e pubblici, impliciti nelle decisioni di spesa. Essa lascia inoltre pienamente nelle
mani dei privati, tramite l’aumento del reddito disponibile e dei consumi, lo stimolo ad
aumentare produzione ed occupazione.
Dal punto di vista dell’uso della tassazione, vale la pena tuttavia di osservare che il suo
moltiplicatore, peraltro negativo, è inferiore, in valore assoluto, a quello della spesa
pubblica diretta, ovvero della spesa per acquisto di beni e servizi: ciò è dovuto al fatto
che mentre tale tipo di spesa aumenta la domanda direttamente, mettendo quindi in moto
l’operare del moltiplicatore dei consumi, la tassazione influisce anzitutto sul reddito
disponibile, e solo tramite questo, sulla spesa per consumi, e quindi indirettamente sulla
domanda aggregata. Se per esempio la tassazione è di tipo lump-sum, e la propensione
marginale al consumo è pari a c, il moltiplicatore della spesa pubblica diretta sarà 1/(1c), mentre quello della tassazione sarà –c/(1-c). Naturalmente se la spesa pubblica è di
tipo per trasferimenti (pensioni, sussidi, pagamenti di interessi, ecc.), il suo
moltiplicatore sarà analogo a quello della tassazione, ovvero pari a c/(1-c). L’esistenza di
moltiplicatori difformi per la spesa pubblica e la tassazione consente di attribuire un
ulteriore grado di flessibilità alla politica fiscale. Si immagini infatti di aumentare la
spesa pubblica diretta e la tassazione di uno stesso ammontare: G=T, di modo che la
misura sia ininfluente sul bilancio dello Stato, che non muta (per questo si parla di
bilancio in pareggio). A motivo della difformità dei moltiplicatori, la misura non avrà
effetti nulli sul reddito, ma anzi quest’ultimo aumenterà nella stessa misura in cui sono
aumentate tasse e spese, per cui avremo: Y-G=T (per cui potremo parlare di
“moltiplicatore del bilancio in pareggio”).
Questo risultato appare in contrasto con l’ortodossia tradizionale, secondo la quale
qualsiasi manovra di bilancio in pareggio sarebbe ininfluente sul livello della
produzione. Dal punto di vista pratico, inoltre, la manovra si presenta utile perché
aumenta gli strumenti a disposizione delle autorità, consentendo inoltre di utilizzare una
manovra che si sottrae alla critica di generare indesiderati disavanzi di bilancio.
Gli insegnamenti fiscali keynesiani sopra illustrati furono messi in pratica dalla
Amministrazioni Kennedy e Johnson nei primi anni ’60: robusti tagli fiscali permisero di
contrastare la diminuzione spontanea della domanda che avrebbe generato effetti
negativi su reddito e occupazione.
Con l’aumentare delle transazioni di beni, servizi e capitali con il resto del mondo, nel
corso degli anni ’60 diventava necessario considerare esplicitamente le caratteristiche di
un’economia aperta; ciò ha importanti conseguenze per l’uso più appropriato degli
strumenti di politica economica per fini alternativi.
In un’economia aperta, l’obiettivo esterno è rappresentato dall’equilibrio della Bilancia
dei Pagamenti (BP), così definibile:
BP = BPC+MC = NX(Y,E)+K(i-i*-) = X(E)-EM(Y,E)+K(i-i*-)
La bilancia dei pagamenti sarà pertanto in equilibrio se:
BP = X(E)-EM(Y,E)+K(i-i*-) = 0
Il modello elaborato negli anni ‘60 da Mundell e Fleming ha per oggetto l’uso
appropriato della politica monetaria e politica fiscale in una economia aperta: a seconda
del regime di cambi vigente, il modello suggerisce la combinazione ottimale degli
strumenti di politica economica per il raggiungimento dell’obiettivo interno (il pieno
impiego) e di quello esterno (l’equilibrio della bilancia dei pagamenti). Tale
combinazione ottimale finisce per dipendere in maniera fondamentale dal sistema
monetario di riferimento, ovvero dal fatto che si operi in regime di cambi fissi o
flessibili.
Se i cambi sono fissi, E è dato (ed inoltre =0), per cui l’equazione BP = 0 individua tutte
le coppie (Y,i) in grado di assicurare l’equilibrio esterno; tale equazione quindi può
essere introdotta come e equazione aggiuntiva, nello schema IS-LM, come scheda BP. Il
nuovo sistema è ora costituito da tre equazioni (IS,LM,BP) e da due incognite (Y,i); esso
risulta così sovradeterminato: un’ulteriore variabile deve allora risultare endogena; come
si vedrà tra poco, ciò implica che uno strumento non è più sotto il controllo delle
autorità.
La BP è positivamente inclinata, e si assume essere più piatta rispetto alla LM. Infatti la
pendenza della LM dipende dalla sostituibilità tra moneta e titoli, cioè tra attività
finanziarie con liquidità e scadenze diverse; la pendenza della BP dipende invece dalla
sostituibilità tra attività finanziarie nazionali ed estere, e quindi tra attività finanziarie
con scadenze simili: in mercati dei capitali sviluppati, la sostituibilità è maggiore nella
BP che nella LM, per cui la BP è più piatta della LM.
Fig. 3. Il modello Mundell-Fleming
i
LM
BP
IS
Y*
Y
Consideriamo ora, nel modello Mundell-Fleming, gli effetti di una politica monetaria
espansiva. Le conseguenze di tale manovra sono illustrate nella figura 4.
Fig. 4. La politica monetaria in cambi fissi
i
LM
LM’
BP
E
E’
IS
Y*
Y
Il punto E rappresenta una situazione di equilibrio iniziale simultaneo sui mercati della
moneta, dei beni e dei cambi. Una espansione monetaria in un’economia chiusa
porterebbe il sistema da E ad E’, posizione che implica un deficit di BP (una caduta del
tasso di interesse genera movimenti di capitale in uscita); pertanto la posizione E’ non è
di equilibrio stabile. Lo squilibrio di BP in regime di cambi fissi genera un deflusso di
moneta corrispondente alla riduzione delle riserve ufficiali. Essendo = (componente
interna + componente esterna), le autorità, a fronte dello squilibrio di BP, hanno due
alternative:
sterilizzare il deflusso di moneta mediante >0; in tal caso, però, la BP rimarrebbe
perennemente in passivo e le riserve diminuirebbero continuamente fino ad arrivare ad
una situazione insostenibile;
seguire la regola aurea di Wicksell, cioè tenere costante e lasciare che segua BP. In tal
caso il deflusso di valuta riduce l’offerta complessiva di moneta e riporta il sistema in E.
Se ne conclude che in cambi fissi LA POLITICA MONETARIA E’ INEFFICACE:
l’offerta di moneta è subordinata all’equilibrio esterno; reddito e tassi di interesse sono
determinati dall’incontro tra la IS e la BP. La terza incognita del sistema deve essere ,
che diventa variabile endogena. Si ha dunque un sistema di tre equazioni (IS,LM,BP) e
tre incognite (Y, i, M).
Consideriamo ora, nel modello Mundell-Fleming, gli effetti di una politica fiscale
espansiva. Le conseguenze di tale manovra sono illustrate nella figura 5.
Per raggiungere Y* è sufficiente implementare una espansione fiscale tale da portare la
IS in IS’ (molto meno che in economia chiusa, dove sarebbe necessario far spostare la IS
più a destra e in alto, fino ad intersecare la LM al livello di reddito di pieno impiego). Si
passa così dal punto di equilibrio E al punto di equilibrio E’; qui si ha un surplus di BP,
il quale, sulla base dei meccanismi esposti in precedenza, sposta la LM fino a
raggiungere l’equilibrio esterno (ed interno) in E’’.
Se ne conclude che LA POLITICA FISCALE E’ MOLTO PIù EFFICACE CHE IN
ECONOMIA CHIUSA; qualora la BP fosse piatta essa sarebbe addirittura
PIENAMENTE EFFICACE, in quanto l’invarianza del tasso di interesse non
determinerebbe alcun effetto di crowding-out.
Fig. 5. La politica fiscale in cambi fissi
i
LM
LM’
E’
BP
E’’
E
IS’
IS
Y*
Y
Sulla base della discussione precedente, si ricavano le seguenti conclusioni:
In cambi fissi una corretta assegnazione degli strumenti agli obiettivi prevede che la
politica monetaria sia impiegata per raggiungere l’equilibrio esterno, mentre la politica
fiscale sia impiegata per raggiungere l’equilibrio interno.
In un regime di cambi flessibili le conclusioni precedenti vengono totalmente rovesciate.
Cominciamo a considerare gli effetti di una politica monetaria espansiva, le cui
conseguenze sono illustrate nella figura 6. Per raggiungere Y* è sufficiente una
espansione monetaria da LM a LM’ (molto meno che in economia chiusa, dove era
necessario spostare la LM a destra e verso il basso fino a intersecare la IS al livello di
pieno impiego). In seguito alla manovra, e alla conseguente riduzione di i, la BP va
inizialmente in deficit (punto E’) ed il cambio si svaluta. Sotto la validità della
condizione di Mashall-Lerner (), la IS si sposta a destra e contemporaneamente la BP si
sposta in basso (in quanto se E si svaluta è sufficiente un i inferiore per tenere in
equilibrio la BP); ciò condurrà al raggiungimento della posizione di equilibrio finale E’’.
Qualora la condizione di Marshall-Lerner non valesse, si genererebbe un effetto
perverso di su NX. Infatti si ha: NX=X-EM. Qualora E si svaluti, aumenta X e si riduce
M, ma E sale, con un effetto finale perverso sulla BP se la condizione di MarshallLerner non risulta valida. La condizione è quindi necessaria.
Fig. 6. La politica monetaria in cambi flessibili
i
LM
LM’
BP (E)
BP’ (E)
E
E’
E’’
IS’ (E)
IS (E)
Y*
Y
Si ottiene così la conclusione che in regime di cambi flessibili i movimenti del cambio
ripristinano automaticamente l’equilibrio esterno, per cui la politica monetaria diventa di
nuovo libera da condizionamenti e può essere utilizzata per l’equilibrio interno; in
particolare, come già sottolineato, la politica monetaria è più efficace che in
un’economia chiusa. In particolare, se la BP fosse piatta, la politica monetaria sarebbe
pienamente efficace, con una variazione del reddito pari al prodotto della variazione
dell’offerta di moneta per la sua velocità di circolazione (immutata, perché i è costante).
D) Manovra di politica fiscale
Fig. 7. La politica fiscale in cambi flessibili
i
LM
E’
BP’
E’’
BP
E
IS’
IS’’
IS
Y*
Y
Un’espansione fiscale consistente in uno spostamento della IS da Is a IS’ porterebbe il
sistema in E’, dove si raggiungerebbe il pieno impiego Y*. In tale situazione, tuttavia, la
BP è in surplus: il cambio allora si rivaluta, facendo tornare indietro la IS;
contemporaneamente la BP si sposta verso l’alto. Il sistema quindi si sposta in un punto
come E’’. L’efficacia della politica fiscale è ridotta.
Qualora la BP fosse piatta, la politica fiscale sarebbe addirittura completamente
inefficace.
Sulla base della discussione precedente, si ricavano le seguenti conclusioni:
In cambi flessibili, la corretta assegnazione degli strumenti agli obiettivi prevede che la
politica monetaria sia occupi dell’obiettivo interno, dato che l’obiettivo esterno, cioè
l’equilibrio della bilancia dei pagamenti è già assicurato dalla flessibilità dei cambi.
Come correttamente sottolineato da Tobin, cambi fissi, mobilità dei capitali e politiche
economiche nazionali indipendenti costituiscono un terzetto incoerente. Benché ciascun
elemento della triade sia di per sé stesso desiderabile, tuttavia nella pratica una
condizione deve essere abbandonata affinché il sistema sia consistente.
1. Se non si vuole rinunciare allo strumento della politica monetaria, si deve
necessariamente passare ad un sistema di cambi flessibili: in questo modo si otterrebbero
tre equazioni, tre variabili endogene e tre obiettivi. In effetti questo è l’orientamento
prevalente a livello mondiale dove i rapporti di cambio tra le monete sono flessibili.
2. Se si vuole mantenere un sistema di cambi fissi e continuare a realizzare tre obiettivi,
bisogna introdurre un terzo strumento indipendente, come ad esempio:
a) un sistema di crediti d’imposta legato alla realizzazione di programmi di
investimento da parte delle imprese; ciò consentirebbe di aumentare il volume di
investimenti spontaneo e stimolare la crescita;
b) l’imposizione di una tassa (implicita o esplicita) sulla detenzione di attività finanziarie
estere (ad esempio la cosidetta Tobin Tax), la quale ridurrebbe la sostituibilità tra attività
finanziarie interne ed estere, spostando la BP e restituendo efficacia alla politica
monetaria.
Vale la pena di osservare che nell’UEM il problema del terzetto incoerente è stato
risolto, con cambi fissi e perfetta mobilità di capitali, eliminando le sovranità nazionali
nella conduzione della politica monetaria ed attribuendo alla BCE il compito di gestire
la politica monetaria unica dell’Unione.
Verso la fine degli anni ’60 ai tradizionali obiettivi keynesiani in precedenza esaminati,
se ne aggiunse un altro, costituito dall’opportunità di mantenere sotto controllo il tasso
di inflazione. Il perseguimento di tale obiettivo risultava piuttosto complesso; anche
perché era evidente la difficoltà di conciliarne il raggiungimento contestualmente a
quello degli altri obiettivi, ed in particolare con quello della piena occupazione.
Si poneva anzitutto un problema teorico: l’analisi di Keynes non conteneva una teoria
specifica dell’inflazione; essa considerava piuttosto un apparato analitico di
determinazione del livello dei prezzi, in base al quale questi dipendevano dal livello dei
salari monetari e dal valore della produzione di equilibrio. Tale situazione era rimasta
sostanzialmente invariata negli anni ’50, quando, sempre ad opera della Sintesi
Neoclassica, il sistema keynesiano era stato ricondotto ad un’analisi in termini di ADAS in grado di determinare il valore di equilibrio di Y e P.
In particolare, la scheda AD deriva dalla combinazione delle equazioni IS ed LM:
Y = C(Y,T,R) + I(i) + G+NX(Yf,PfE/P)
M/P = L(Y,i,R).
Ricavando i dall’equilibrio tra domanda ed offerta di moneta, e sostituendo nella IS, si
ottiene proprio la scheda AD:
P = D (Y), D’(Y) < 0
La AD rappresenta il luogo delle coppie (Y,P) in grado di assicurare l’equilibrio reale e
monetario. La posizione della curva dipende dalle grandezze esogene che influenzano
consumi, investimenti ed esportazioni nette, nonché dagli strumenti di politica
economica monetari e fiscali; la sua pendenza decrescente riflette l’elasticità dei
consumi alla ricchezza, delle esportazioni nette alla competitività e degli investimenti
rispetto al livello dei prezzi, ovvero l’elasticità della IS e della LM rispetto a i.
La scheda AS viene invece derivata dalle ipotesi avanzate circa il funzionamento del
mercato del lavoro e la determinazione dei prezzi da parte delle imprese. In particolare:
si assume una tradizionale funzione di produzione Y = Y (N);
si impone la condizione di massimizzazione dei profitti neoclassica, ovvero si suppone
che le imprese eguaglino il salario reale alla produttività marginale del lavoro: W/P = Y’
(N);
si suppone infine che i lavoratori chiedano un salario monetario crescente all’aumentare
di N, ovvero: W = W°+W(N).
Dalle tre condizioni deriva la formulazione della AS:
P = S (Y), S’(Y) > 0
In effetti, dall’eguaglianza tra prezzo e ricavo marginale, sostituendo per il livello del
salario monetario determinato dalla contrattazione sindacale, come sopra illustrato,
avremo:
.
La scheda AS è inclinata positivamente perché si assumono rendimenti decrescenti e
salari monetari crescenti al crescere di N.
La stessa relazione, peraltro, può essere ottenuta con ipotesi diverse e aggiuntive:
metodo del mark-up nella fissazione di P;
strozzature nella AS;
influenza dei prodotti agricoli nell’indice di P (il cui livello cresce al crescere della
produzione).
Come raffinamento ulteriore si può ipotizzare che, mano a mano che ci si avvicina ad
N*, i lavoratori intensifichino le loro rivendicazioni in termini di W monetari; in tal
modo la AS risulta abbastanza piatta per bassi livelli di reddito diventando sempre più
inclinata in corrispondenza di Y*, come nella figura 8.
Fig. 8. Lo schema AS-AD
P
AD
AS
Y*
Il punto di incontro AS-AD consente di individuare la coppia (Y,P) di equilibrio
necessaria a identificare il livello di P che, inserito nello schema IS-LM, determina la
posizione delle due curve (la IS e la LM infatti risultano parametriche rispetto ad un
certo livello di prezzi), da cui derivare il tasso di interesse i compatibile con l’equilibrio
generale.
Lo schema AS-AD venne utilizzato negli anni ’50 per descrivere e discutere le cause ed
i rimedi dell’inflazione. Esso consentiva di distinguere tra:
P
AD’
AS
AD
Y
Y’
Y*
Spostamenti a destra della AD, causati da incrementi dell’offerta di moneta, della spesa
pubblica, del consumo autonomo, degli investimenti, o delle esportazioni nette;
l’inflazione da domanda genera un aumento del livello dei prezzi che si accompagna ad
una variazione positiva del reddito, come si può osservare nella figura 9.
Fig. 9. L’inflazione da domanda nello schema AS-AD
Fig. 9. L’inflazione da domanda nello schema AS-AD
P
AD’
AS
AD
Y
Y’
Y*
INFLAZIONE DA COSTI
Essa è conseguente ad innalzamenti della curva AS dovuti ad incrementi di W superiori
a quelli della produttività o, in un modello più generale, ad aumenti dei prezzi delle
materie prime importate o del livello del mark-up. Nel caso di inflazione da costi, come
si può facilmente osservare dalla figura 10, la crescita dei prezzi si accompagna ad una
caduta del livello del reddito.
La cura dell’inflazione da costi è quindi particolarmente difficile, generando un dilemma
di politica economica: se si vuole mantenere invariato il livello di reddito di partenza,
bisognerà aumentare la AD, ma ciò genererà un ulteriore aumento di P; se invece si
vuole mantenere la stabilità dei prezzi, occorrerà ridurre la AD, ma ciò determinerà una
ulteriore caduta di Y, tanto più pronunciata quanto più la AS è piatta.
Fig. 10. L’inflazione da domanda nello schema AS-AD
P
AS’
AS
AD
Y’
Y
Y*
CASO ESTREMO
Qualora la AS abbia una forma ad L rovesciata (se ad esempio la produttività del lavoro,
i salari monetari ed il mark-up sono costanti fino al pieno utilizzo della capacità
produttiva), spostamenti delle due curve non generano necessariamente gli effetti appena
descritti. In particolare, dalla fig. 11, è facile verificare che:
1) spostamenti della AD producono variazioni positive nel reddito senza alcuna
variazione di P fino a Y*; superato tale livello del reddito esse generano esclusivamente
inflazione;
2) spostamenti della AS provocano sempre variazioni del livello dei prezzi pari alla
traslazione della curva, indipendentemente dalla caduta nel livello di attività che peraltro
si verifica sempre.
Si deve inoltre osservare che l’intersezione tra la IS e la LM a sinistra del livello di
reddito di pieno impiego era un risultato che apparteneva alla prima fase della teoria
neokeynesiana. Con l’affermazione della sintesi neoclassica, l’intersezione tra la AS e la
AD normalmente avviene, come mostra la fig. 12, a livello di pieno impiego, pur
essendo possibili nel breve periodo scostamenti da tale posizione in seguito a shock di
domanda o di offerta.
Fig. 12. Lo schema AS-AD della sintesi neoclassica
P
AD
AS
Y*
Nello schema AS-AD, uno spostamento della AD o della AS sono peraltro in grado di
spiegare solo una variazione “una tantum” del livello dei prezzi, la quale
necessariamente si arresta una volta raggiunto il nuovo livello di equilibrio.
Nella realtà l’inflazione è un processo dinamico di crescita persistente dei prezzi,
compatibile con lo schema AS-AD solo ammettendo che le curve traslino continuamente
nel tempo. Ciò può essere concepibile per spostamenti della AD in seguito ad espansioni
ripetute della quantità di moneta, mentre è più difficile da ipotizzare nel caso di una
politica fiscale espansiva, che dovrebbe comportare disavanzi sempre più elevati. Le
stesse considerazioni risultano rafforzate se si considera la curva AS: variazioni reiterate
del livello dei prezzi richiedono spostamenti ripetuti della curva verso l’alto, che si
accompagnerebbero, in assenza di politiche accomodanti sulla AD, a continue riduzioni
del reddito. In ogni caso bisognerebbe spiegare perché questi eventuali ripetuti
spostamenti della AS verso l’alto di fatto si verificano.
Un ulteriore problema pratico dello schema AS-AD concerneva la sua incapacità di
fornire una spiegazione convincente al fenomeno concreto della stagflazione, ovvero di
una situazione in cui, a fronte di un tasso di inflazione positivo, il reddito risultava
stagnante. L’assenza di una correlazione tra tasso di inflazione e variazione del reddito si
era presentato per la prima volta agli occhi degli economisti nella seconda metà degli
anni ’60.
I neokeynesiani, di fronte al fenomeno dell’inflazione, adottarono un nuovo apparato di
riferimento, non più statico ma dinamico, grazie al contributo di Alban Phillips, il quale,
in un famoso articolo del 1958 su Economica, aveva evidenziato, con riferimento
all’esperienza del Regno Unito, l’esistenza di una relazione di lungo periodo tra il tasso
di variazione dei salari monetari ed il tasso di disoccupazione, del tipo:
W˙ = g (u )
g '(u ) < 0 , g ''(u ) > 0
Tale relazione empirica, rappresentata nella figura 13, era di forma inversa, non lineare,
ma soprattutto stabile, per tutto il periodo di tempo considerato da Phillips (dal 1861 al
1957). Essendo una relazione solo di tipo empirico (“come un personaggio pirandelliano
in cerca di autore”, secondo Tobin), essa stimolò successivamente una serie di contributi
analitici volti a fornirle una razionalizzazione teorica.
LIPSEY interpretò la relazione come risposta dei salari monetari ad undisequilibrio sul
mercato del lavoro, misurato dall’eccesso di domanda sull’offerta, di cui il tasso di
disoccupazione corrente rappresenta una proxy. In tal modo risulterebbe:
ND − NS
W˙ = f
; f(0)=0
NS
f risulta essere una funzione non lineare e crescente rispetto all’eccesso di domanda di
lavoro, ovvero decrescente rispetto al tasso di diccupazione.
Fig. 13. La relazione di Phillips
.
W
u
SAMUELSON & SOLOW sostituirono, nella relazione originaria di Phillips, Ẇ con Ṗ ,
utilizzando implicitamente un metodo di formazione dei prezzi caratteristico
dell’oligopolio e consistente nell’applicazione di un mark-up costante sul costo del
lavoro. In particolare, in tal caso si ha: P
W
(1 q)
a
con a = produttività media del
lavoro; q = q , allora P = W − a ; qualora a sia esogeno, tale grandezza può essere ritenuta
una costante. La relazione di Phillips può quindi essere trasformata nella più tradizionale
curva di Phillips dei libri di testo, come nella figura 14, per cui:
.
.
.
.
.
P = f ( u)
f ' ( u ) < 0, f '' ( u ) > 0
Fig. 14. La curva di Phillips secondo Samuelson-Solow
Ṗ
u
5,5%
Le conseguenze ricavabili da questo nuovo strumento analitico furono diverse a seconda
del punto di vista degli economisti: per gli ottimisti esisteva la possibilità di un menu di
scelta che le autorità di politica economica potevano sfruttare; per i pessimisti invece
sorgeva un dilemma di politica economica dovuto al TRADE-OFF tra inflazione e
disoccupazione. In particolare, secondo le stime di Samuelson e Solow, solo accettando
un u=5,5%, era possibile garantire un tasso di inflazione nullo.
Il problema della scelta tra le infinite combinazioni tra inflazione e disoccupazione di
fatto raggiungibili poteva peraltro essere risolto, come avevano mostrato Lipsey e lo
stesso Samuelson, attraverso l’uso di FUNZIONE DEL BENESSERE SOCIALE di tipo
bergsoniano, che tenesse conto del trade-off esistente tra i due obiettivi e della disutilità
arrecata da entrambi. A seconda dei diversi orientamenti governativi si avrebbero diverse
funzioni del benessere sociale, e quindi diverse strutture delle curve di indifferenza tra i
due obiettivi delle autorità, con il risultato di produrre diverse combinazioni ottimali tra
.
P e u. In particolare autorità più avverse all’inflazione avrebbero scelto una
combinazione di equilibrio caratterizzata da minore inflazione e maggiore
disoccupazione, e viceversa nel caso contrario.
L’evidenziazione dell’esistenza di un trade-off tra inflazione e disoccupazione portò
altresì alla nascita di alcune controversie all’interno della scuola neokeynesiana. Per
Modigliani non esisteva più un unico livello di pieno impiego, ma piuttosto un insieme
.
di possibili livelli di disoccupazione di equilibrio, ognuno associato ad un P diverso,
con l’effetto di rendere obsoleto e indecifrabile lo stesso concetto keynesiano di
“equilibrio di sottoccupazione”.
Tobin invece era piuttosto preoccupato della possibilità di identificare il pieno impiego
.
di Keynes con il tasso di disoccupazione, di natura frizionale e strutturale, associato a P
= 0, e della conseguente implicazione per cui le autorità dovevano necessariamente
mirare a conseguire tale tasso di equilibrio da lui ritenuto troppo alto. Secondo Tobin, in
.
effetti, il tasso di disoccupazione corrispondente a P =0 era sistematicamente superiore a
quello di pieno impiego. Ciò era dovuto al fatto che la curva di Phillips rappresentava il
risultato di un’aggregazione a livello macroeconomico di funzioni di reazione di singoli
mercati del lavoro, in stato di perenne disequilibrio stocastico. Essendo N D = N + V e
N S = N + U (dove V rappresenta il numero di posti vacanti e U il numero di disoccupati),
l’equilibrio sul mercato del lavoro prevede che sia N D = N S , e quindi U=V (come si può
osservare, pertanto, l’equilibrio sul mercato del lavoro non implica una disoccupazione
nulla, ma positiva; tale disoccupazione di equilibrio viene normalmente definita naturale
ed il tasso di disoccupazione corrispondente è detto tasso naturale di disoccupazione.).
.
In equilibrio, qualora il mercato del lavoro fosse omogeneo, si avrebbe P =0. Poiché
tuttavia il mercato del lavoro è disomogeneo, nel senso che è composto di tanti specifici
mercati del lavoro settoriali, a livello aggregato può risultare U=V, compatibilmente con
disequilibri specifici a livello disaggregato. Ad esempio, supponendo per semplicità
l’esistenza di due singoli micromercati i e j (vedi fig. 15), sia:
U i − Vi > 0 eccesso di offerta di lavoro (OA) sul mercato i
e
U j − V j < 0 eccesso di domanda di lavoro (OB) sul mercato j.
Fig. 15. Il bias inflazionistico
.
W
B
O
A
U i − Vi
Supponendo che i due mercati abbiano la stessa dimensione, la variazione dei salari
.
.
media ( W ) del sistema è la media aritmetica delle singole variazioni W sui due mercati,
ed è perciò maggiore di zero a causa della non linearità della curva di Phillips. Il sistema
economico incorpora quindi quello che Tobin chiama un “bias”, ovvero un pregiudizio
inflazionistico: quello che a livello aggregato appare come tasso di disoccupazione
.
naturale (u*), al quale dovrebbe corrispondere P =0, non è il tasso di disoccupazione
naturale (sostanzialmente corrispondente al pieno impiego), ma un tasso di
disoccupazione maggiore. Il livello di disoccupazione naturale è più basso del livello di
disoccupazione cui corrisponde un’inflazione nulla. Per avere stabilità dei prezzi occorre
dunque accettare un tasso di disoccupazione più alto di quello naturale, definito da Tobin
NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment). In particolare, il bias
inflazionistico sarà tanto più elevato quanto maggiore è l’incertezza stocastica e la forza
sindacale.
L’esistenza di un bias inflazionistico, conseguenza della non linearità delle curve di
Phillips e del fatto che l’equilibrio macroeconomico è compatibile con squilibri
microeconomici sui vari mercati del lavoro specifici, giustifica l’obiettivo più ambizioso
delle autorità di puntare ad un tasso di disoccupazione minore di quello compatibile con
l’inflazione nulla, pari secondo Samuelson e Solow, al 5,5% (in particolare, si puntava al
livello del 4%, come previsto dal programma iniziale della New Economics). Qualora, a
motivo della pendenza della curva di Phillips, l’inflazione corrispondente al vero pieno
impiego sia ritenuta troppo elevata, non rimarrebbe che ricorrere a forme dirette di
controllo della dinamica di P e W. Secondo Tobin, in effetti, le autorità di politica
economica, poste di fronte a tre obiettivi (stabilità dei prezzi, pieno impiego e assenza di
controlli su P e W), potevano raggiungerne al massimo due (un altro esempio di terzetto
inconsistente).
In conclusione, ,nonostante le palesi deviazioni rispetto alla posizione teorica originaria
di Keynes, il suo minore spirito critico e la fiducia incondizionata nella capacità delle
autorità di politica economica di manovrare la AD per ottenere gli obiettivi desiderati, la
New Economics ha avuto l’indubbio merito di essere riuscita a produrre quel radicale
cambiamento intellettuale nei confronti dell’interventismo statale responsabile di un
netto miglioramento nell’evoluzione di breve-medio periodo del sistema economico.
Verso la fine degli anni ’60, però, le teoria keynesiana entrò definitivamente in crisi. Tale
crisi era in particolare il risultato della presunta scomparsa della curva di Phillips e
dell’incapacità di spiegare il fenomeno della stagflazione. In effetti, sul finire degli anni
’60, a seguito di una maggiore conflittualità sindacale, il tasso di crescita dei salari
monetari aumentò notevolmente rispetto all’esperienza storica. I neokeynesiani
spiegarono tale fenomeno con uno spostamento verso l’alto della curva di Phillips. Tale
spiegazione tuttavia era carente, in quanto il requisito essenziale di un trade off tra
inflazione e disoccupazione è la sua stabilità. Se la curva si sposta continuamente, essa è
inutilizzabile come strumento di politica economica per le autorità di governo. Inoltre,
dal punto di vista empirico, il trade off asserito dai keynesiani era incompatibile con il
fenomeno della stagflazione, in quanto la nuova curva di Phillips avrebbe dovuto
consentire alle autorità di spostarsi lungo di essa, riducendo il tasso di inflazione ma al
costo di una maggiore disoccupazione. La realtà empirica, invece, sembrava indicare che
lo stesso tasso di disoccupazione era compatibile con diversi livelli del tasso di
inflazione, in maniera del tutto incoerente con la curva di Phillips.
E così, proprio mentre Nixon si sbilanciava a dichiarare “siamo tutti keynesiani ora”,
l’incapacità dei keynesiani di fornire una convincente spiegazione della stagflazione, e
di fornire ricette di politica economica atte ad affrontarla, determinava la fine della
supremazia intellettuale della New Economics, collegata alla cosiddetta rivoluzione
keynesiana. I tempi erano maturi per una controrivoluzione, di natura monetarista, legata
al nome del leader carismatico di tale scuola di pensiero, il Professor Milton Friedman
dell’Università di Chicago.
Fin qui la teoria dominante. Nessun interesse è presente per le forme di mercato, come
se il modo in cui le imprese mono-oligopolistiche fanno i prezzi e controllano la
produzione non avessero alcuna influenza sul fenomeno della stagflatione. Ma si tratta
di un palese errore. In altre parole, si registra una colpevole separazione tra macro e
microeconomia, laddove sarebbe più che mai necessaria una loro integrazione.
Le decisioni riguardanti gli investimenti sono contestuali a quelle riguardanti i prezzi e,
come dimostrò Kalecki, dipendono, fra le altre cose, dal grado di monopolio delle
imprese; cosicché, parafrasando Ackley, si potrebbe parlare, a ragione, non solo di di
inflazione da salari nel caso in cui questi ultimi aumentino più della produttività media,
ma anche ii inflazione da profitti, a causa di un aumento eccessivo del margine di
profitto usato nel calcolo dei prezzi d vendita dei prodotti.
Ciò pone il prblema del ristagno economico. Nel linguaggio economico al termine
'stagnazione' non viene attribuito un significato univoco; in generale, esso è stato usato
per descrivere la situazione dei paesi poveri in cui la crescita economica è del tutto
assente, o in cui la crescita del prodotto interno lordo è più lenta del tasso di incremento
della popolazione, sicché il reddito pro capite resta stazionario. Tali paesi erano assai
numerosi prima della rivoluzione industriale nel XVIII secolo, e sino al secondo
dopoguerra. Oggi una situazione di questo tipo è presente soprattutto in Africa e nei
paesi non produttori di petrolio del Medio Oriente. Il concetto di stagnazione entrò
nell'uso negli anni trenta con la rivoluzione keynesiana, soprattutto nel tentativo di
spiegare un declino nella produzione mondiale mai verificatosi nei precedenti cicli
economici.Il periodo compreso tra gli anni cinquanta e i primi anni settanta vide una
eccezionale crescita economica senza fasi di stagnazione, eccettuate quelle sperimentate
dalla Gran Bretagna nel quadro della politica economica del cosiddetto 'stop-go' ('freno e
accelerata'), in cui a periodi di espansione di breve durata seguiva la necessaria
applicazione di misure di restrizione economica. Un ingegnere britannico passato
all'economia, A.W. Phillips, propose un modello economico di sostituzione (trade off)
tra disoccupazione e inflazione, in base al quale i responsabili della politica economica
si trovano a scegliere tra i due mali dell'aumento dei prezzi e di un elevato tasso di
disoccupazione. Gradualmente l'analisi keynesiana fu messa sotto accusa in quanto
incapace di fornire spiegazioni adeguate dell'esperienza dell'epoca, né le politiche
keynesiane diedero risultati economici soddisfacenti. All'inizio degli anni settanta la
crescita economica subì un rallentamento, le teorie monetariste cominciarono a sostituire
quella keynesiana, e si arrivò alla conclusione che la 'curva di Phillips' è verticale
anziché convessa all'origine, ossia che esiste un 'tasso naturale' di disoccupazione al
quale una data economia tenderebbe a tornare. Verso la metà degli anni sessanta, inoltre,
venne coniato un nuovo termine, 'stagflazione', per indicare una combinazione tra
inflazione e ristagno economico. Per un certo tempo 'stagnazione' venne usato come
sinonimo di 'rallentamento' per descrivere una fase del normale ciclo economico. Di
stagnazione si può parlare anche in riferimento al ciclo economico di lungo periodo
delle nazioni - non quello cinquantennale di Kondrat´ev, ma un ciclo più lungo, di durata
irregolare. Una volta che un paese abbia intrapreso la strada dello sviluppo economico,
l'andamento della crescita tenderà a seguire una curva logistica (chiamata talvolta 'curva
di Gompertz' o 'curva a S'), in cui a un avvio lento fa seguito un'accelerazione, poi un
rallentamento e infine una fase di stabilizzazione. Il rallentamento che si verifica
all'apice della curva può essere considerato una stagnazione, perlomeno rispetto alla
crescita più rapida che l'ha preceduto.
2. I paesi in via di sviluppo
Secondo la moderna teoria della crescita economica, un paese o un gruppo di paesi con
tecnologie avanzate assumono un ruolo guida rispetto ad altri paesi in via di sviluppo,
che cercano di mettersi alla pari in un processo di 'rincorsa' (v. Abramovitz, 1986). Lo
sviluppo di alcuni paesi può aver subito un arresto a seguito di una guerra, di un disastro
naturale o di altre cause esterne. Passato il momento di crisi, questi tendono a crescere
rapidamente emulando i paesi leaders e servendosi delle tecnologie più recenti acquisite
in vari modi, a volte attraverso prestiti di capitali dai paesi più avanzati. In questo
processo di rincorsa i livelli di reddito pro capite dei paesi in via di sviluppo tendono a
convergere, ma ciò non si verifica per tutti (v. Landes, in corso di pubblicazione nel
1997). Il modello della rincorsa cerca di spiegare la mancata convergenza di alcuni paesi
imputandola all'assenza di 'capacità sociali' - un concetto dichiaratamente vago che si
riferisce, grosso modo, al livello di specializzazione e di qualificazione della forza
lavoro (v. Abramovitz, 1986). Douglass North (v., 1990, p. 34) imputa la povertà
all'assenza di istituzioni efficienti; secondo questa concezione, l'incapacità di alcune
società di sviluppare sistemi efficienti di esecuzione dei contratti è la causa principale
della stagnazione nella storia e dell'attuale sottosviluppo nel Terzo Mondo.Nei secoli
successivi alla rivoluzione industriale vi fu un lento progresso tecnologico, ma la
crescita nel complesso fu di tipo 'smithiano', vale a dire conforme al modello teorizzato
da Adam Smith, secondo il quale la crescita economica deriva da un ampliamento del
mercato, che porta a una maggiore specializzazione nella produzione e nello scambio.
Con l'avvento della rivoluzione industriale alla fine del XVIII secolo, il mutamento
tecnologico prese l'abbrivio, proseguendo con ritmo accelerato. Paese leader in questo
processo fu l'Inghilterra; l'Europa continentale aveva cominciato la rincorsa quando le
guerre napoleoniche segnarono una battuta d'arresto. Dopo il 1820, tuttavia, il processo
di convergenza del continente subì un'accelerazione allorché vari paesi, in particolare la
Francia e la Prussia, si appropriarono delle tecnologie della Gran Bretagna attraverso
visite nel paese, importazioni di macchinari, un aggiornamento costante sulla più recente
letteratura tecnica e scientifica, l'acquisizione di alcuni imprenditori e di una certa quota
di capitali britannici.
Al di fuori dell'Europa, i grandi territori aperti degli Stati Uniti, del Canada e
dell'Australia conobbero una rapida crescita economica grazie alle istituzioni, fondate
sul modello britannico, introdotte dai colonizzatori. I paesi dell'America Latina che
avevano conquistato l'indipendenza dalla Spagna e dal Portogallo con le guerre
napoleoniche sperimentarono una breve fase di crescita, seguita presto da una
stagnazione imputabile agli intralci delle istituzioni burocratiche ereditate dalla penisola
iberica. Lo stesso avvenne in quegli anni nei paesi dell'Est. Secondo le stime azzardate
da Angus Maddison, tra il 1820 e il 1870 i tassi di crescita di Brasile, Messico, Russia,
India e Cina si aggirarono intorno allo 0,1% del prodotto pro capite per anno, mentre in
Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e Giappone si ebbero tassi che andavano dall'1,1
all'1,5% (v. Maddison, 1989, tab. 8.1).
L'adeguamento e la convergenza tra i principali paesi industrializzati raggiunsero il
culmine nel secondo dopoguerra, tra il 1950 e il 1973. In precedenza, nel periodo
compreso tra il 1870 e il 1913, i cinque paesi leaders ebbero un tasso di crescita pari
all'1,5% annuo, mentre quelli in via di sviluppo raggiunsero l'1%. Il periodo tra il 1913 e
il 1950 si differenzia notevolmente da quello precedente e da quello successivo, dati gli
effetti ineguali delle due guerre mondiali e della 'grande depressione'. Dopo il 1950,
tuttavia, la rincorsa procedette a pieno ritmo. I cinque paesi industrializzati arrivarono a
una crescita pari al 4,3% annuo, mentre i paesi in via di sviluppo superarono tutti i
precedenti risultati di entrambi i gruppi, senza peraltro raggiungere il livello dei paesi
leaders, con una crescita della produzione pro capite pari al 3,4% annuo (ibid.).
La povertà nei paesi arretrati, tuttavia, è un fenomeno assai più complesso, che non può
essere spiegato solo con l'inadeguato livello di qualificazione della forza lavoro e con
l'inefficienza delle istituzioni. Un caso interessante a questo riguardo è quello della
Svezia, che nella prima metà del XIX secolo poteva essere considerata, secondo la
definizione di uno storico dell'economia, come un paese 'impoverito ma sofisticato':
impoverito - ma sarebbe meglio dire 'povero', visto che il termine presuppone una
perdita rispetto a un precedente standard superiore - ma con un elevato tasso di
alfabetizzazione della popolazione e un sistema di istituzioni bancarie allo stato
embrionale (v. Sandberg, 1978 e 1979). L'abrogazione delle leggi protezionistiche sul
grano in Gran Bretagna nel 1846 e, nel 1849, quella del dazio sul legname e dei
Navigation acts segnarono un'espansione delle esportazioni svedesi - in particolare di
avena verso la Gran Bretagna (grazie all'abrogazione delle leggi protezionistiche sul
grano), del legname, spedito via mare a minor costo su navi norvegesi, e dei minerali
ferrosi - determinando una crescita economica di notevoli proporzioni. La validità del
modello smithiano trovava così una conferma.
3. La 'grande depressione' degli anni trenta
L'uso del termine 'stagnazione' per indicare un basso livello o l'assenza di crescita
economica si affermò, come si è detto, negli anni trenta, in connessione con la
rivoluzione keynesiana e con i tentativi di individuare le cause della 'grande
depressione'. Alvin Hansen - considerato il principale divulgatore delle teorie keynesiane
negli Stati Uniti, sebbene avesse sviluppato intuizioni originali sulla stessa linea in modo
autonomo prima del 1936 - riteneva che la durata e l'ampiezza della depressione
dipendessero dal graduale restringimento delle opportunità di investimento. Riferendosi
in particolare al caso degli Stati Uniti, egli affermò che la perdita dei territori di frontiera
a seguito del popolamento del continente, il rallentamento della crescita demografica
dopo il breve exploit del primo dopoguerra (v. Keynes, 1937; v. Hansen, 1939), con le
sue ripercussioni sull'edilizia abitativa e sulla domanda di auto~mobili, nonché i
mutamenti nel tipo degli investimenti - non più in invenzioni risparmiatrici di
manodopera ma in invenzioni risparmiatrici di capitale - avevano determinato una
diminuzione nella domanda di investimento e l'incapacità dell'economia americana di
assorbire i risparmi. Questa ipotesi divenne nota come 'tesi della stagnazione di Hansen'
(v. Hansen, 1938).
Hansen era interessato non solo all'analisi economica, ma anche e soprattutto a trovare
soluzioni concrete per i problemi contemporanei. Egli riteneva che il fenomeno della
stagnazione economica avesse un'importanza storica pari a quella della rivoluzione
industriale, e proponeva come soluzioni la creazione di una 'nuova frontiera', l'adozione
di politiche sociali che garantissero ai poveri standard minimali di sussistenza,
condizioni sanitarie adeguate, alloggio, istruzione e previdenza sociale al fine di
accrescere i consumi, nonché un aumento, costante e non solo in funzione anticiclica,
della spesa pubblica in opere di risanamento urbano, edilizia abitativa, sviluppo delle
vallate fluviali, elettrificazione delle campagne, rimboschimento e tutela del suolo.
Hansen era contrario ai bilanci annuali in pareggio, ma sosteneva l'opportunità di
separare quella parte del bilancio dello Stato che riguarda gli investimenti e il modo in
cui finanziarli dalle entrate e dalle uscite correnti, anziché mettere insieme
indiscriminatamente tutte le spese governative.La teoria della stagnazione cadde
rapidamente in discredito nel secondo dopoguerra. Da un lato, la tesi di Hansen secondo
cui all'origine della depressione degli anni trenta vi sarebbe stato un declino delle
opportunità di investimento lasciò il posto ad altre interpretazioni, che chiamavano in
causa di volta in volta la riduzione creditizia che avrebbe portato a un calo dei prezzi e a
una deflazione del debito (v. Fisher, 1933; v. Kindleberger, 1986), l'errata politica
monetaria degli Stati Uniti (v. Friedman e Schwartz, 1963, cap. 7), e gli effetti del gold
standard in Europa e negli Stati Uniti (v. Temin, 1989; v. Eichengreen, 1992). Dall'altro
lato, gli eventi successivi alla seconda guerra mondiale smentirono ampiamente le
previsioni delle teorie stagnazioniste di Hansen, e lo stesso vale per la tesi largamente
condivisa degli economisti keynesiani, secondo cui alla fine della guerra la contrazione
della spesa pubblica avrebbe dato luogo a un'altra grave depressione. A trainare
l'economia nell'immediato dopoguerra non furono né la spesa pubblica né gli
investimenti privati, ma i consumatori che spendevano il denaro accumulato in tempo di
guerra, quando vi era scarsità di beni d'acquisto. Il declino demografico non continuò,
ma si ebbe una brusca inversione di tendenza quando gli eserciti vennero smobilitati e i
soldati tornarono a casa, sfociata nel cosiddetto 'baby boom' che durò sino ai primi anni
sessanta.
I progressi tecnologici iniziati negli anni della guerra determinarono una crescita degli
investimenti negli Stati Uniti, rapidamente emulati dagli altri paesi in una spettacolosa
rincorsa. A ciò fece seguito quello che venne ironicamente definito 'keynesismo
militare', ossia le ingenti spese pubbliche nel settore militare con la guerra in Corea, la
guerra fredda e, negli anni sessanta, la guerra in Vietnam. La rapida crescita economica
coinvolse praticamente tutto il mondo, fatta eccezione per l'Africa subsahariana. I paesi
leaders in questo processo furono la Repubblica Federale Tedesca e il Giappone, in cui
la sconfitta militare e il discredito dei nazionalsocialisti tedeschi e dei militaristi
giapponesi avevano distrutto i potenti interessi degli anni trenta e aperto la strada a
uomini nuovi (v. Postan, 1967; v. Olson, 1982). Alcune prime analisi attribuirono il
boom degli anni cinquanta a un controllo del livello della domanda di tipo keynesiano
(v. Maddison, 1964; v. Shonfield, 1965; v. Heller, 1966). Una tesi diametralmente
opposta fu avanzata nell'immediato dopoguerra da Luigi Einaudi, secondo il quale
l'espansione keynesiana rappresentava la soluzione meno adatta per il problema della
disoccupazione in Italia, le cui cause andavano ricercate nello squilibrio tra terra, lavoro
e capitale dato il livello tecnologico esistente, e avrebbe richiesto una soluzione
strutturale anziché macroeconomica (v. Hildebrand, 1965). Un'interpretazione analoga
degli elevati tassi di crescita in Giappone, Germania, Francia e Italia metteva l'accento
sull'eccessiva offerta di manodopera che alimentava l'espansione in un processo di
feedback positivo, in quanto manteneva i salari al livello dell'incremento della
produttività, o al di sotto, consentendo ai profitti di restare elevati, il che, a sua volta,
favoriva gli investimenti (v. Kindleberger, 1967). Tutte le interpretazioni concordavano
sui vantaggi apportati alle economie avanzate e persino a quelle arretrate dal sistema
monetario internazionale istituito con gli accordi di Bretton Woods alla fine della guerra,
che ampliò il commercio mondiale, stabilizzò le condizioni monetarie e determinò una
ripresa dei movimenti internazionali di capitali.
4. La politica economica di 'stop-go' in Gran Bretagna
Il giudizio degli osservatori britannici sul periodo compreso tra il 1950 e il 1973 è
ambivalente. Da un lato, con un tasso di crescita pari al 2,5% annuo, la Gran Bretagna
ebbe un ritmo di sviluppo superiore a quelli registrati in qualunque lungo periodo del
passato per il quale esistono stime anche solo approssimative. Dal 1820 al 1870, anni in
cui la Gran Bretagna era il paese leader nell'economia mondiale, il tasso di crescita fu
solo dell'1,5%. D'altro canto, il valore del 2,5% registrato nel periodo 1950-1973 assieme a quello del 2,2% degli Stati Uniti - era ben al di sotto di quelli degli altri paesi
industrializzati (8,4% per il Giappone, 5% per la Repubblica Federale Tedesca, 4,8% per
l'Italia e 4,2% per la Francia). Il lento tasso di crescita della Gran Bretagna divenne il
tema di numerose analisi di illustri economisti anglosassoni (v. Kaldor, 1966; v.
Beckerman, 1979). Il Regno Unito era superato dagli altri paesi europei, compresi la
Svezia e la Svizzera, anche per quanto riguarda il livello di reddito reale pro capite. Le
cause del problema furono identificate nella cosiddetta politica economica di 'freno e
accelerata' (stop-go) - ma sarebbe più opportuno invertire l'ordine dei due termini e
parlare di 'accelerata e freno'.In questa esperienza britannica si aveva un aumento della
spesa in immobili e beni durevoli da parte dei consumatori, nonché un aumento degli
investimenti aziendali e governativi, con una conseguente espansione della produzione,
che presto però incappava in strozzature del mercato del lavoro. Durante la depressione
degli anni trenta e negli anni della guerra, la maggiore preoccupazione degli economisti
keynesiani e di lord Beveridge era stata quella di evitare che nel dopoguerra si
riproducessero gli elevati livelli di disoccupazione che avevano caratterizzato gli anni
venti e trenta. Se dopo l'esperienza dei primi anni venti l'incubo dei Tedeschi era
l'inflazione, quello degli Inglesi era la disoccupazione. Di tanto in tanto nel dopoguerra i
livelli di disoccupazione calarono in Gran Bretagna sino all'1,5%. In questi periodi, la
pressione sui tassi salariali era enorme, aumentavano le importazioni, l'incremento dei
prezzi rendeva le esportazioni non competitive, e questi due fattori influivano in modo
pesantemente negativo sulla bilancia dei pagamenti. A questo punto, il Tesoro e la Banca
d'Inghilterra si ritenevano costretti ad applicare freni macroeconomici - aumento della
pressione fiscale, riduzione degli investimenti pubblici e aumento dei tassi di interesse.
All'accelerata ('go') faceva seguito il freno ('stop'). La disoccupazione non aumentava in
modo significativo, in quanto le imprese non licenziavano i lavoratori per timore di non
essere più in condizione di riassumerli una volta che fosse iniziata la fase di espansione.
Naturalmente vi erano strozzature nel mercato del lavoro, specialmente nel settore
minerario. In tutta Europa i minatori che erano riusciti a sottrarsi a questo duro mestiere
arruolandosi nell'esercito durante la guerra, al loro ritorno cercavano per quanto
possibile altri sbocchi occupazionali. In Gran Bretagna la proposta di assumere
immigrati polacchi per rimpolpare i ranghi dei minatori fu respinta per l'opposizione del
sindacato. Questa situazione contrastava nettamente con quella di altri paesi europei, in
cui vi era un notevole afflusso di gruppi di rifugiati e di esiliati provenienti dai territori
sottratti alla Germania sconfitta, di Gastarbeiter - come venivano chiamati in Germania ossia immigrati temporanei dall'Italia meridionale in un primo tempo, e poi anche da
Grecia, Spagna, Portogallo, Iugoslavia e Turchia, e dal Nordafrica nel caso della
Francia, di contadini che abbandonavano le campagne per trovar lavoro in città nel
settore industriale e in quello dei servizi; a ciò si aggiungeva la crescita naturale della
popolazione, in precedenza controbilanciata dal flusso migratorio verso i territori
coloniali (come ad esempio l'emigrazione olandese verso le Indie orientali), ma che a
seguito della decolonizzazione non aveva più alcuno sbocco extraeuropeo. La
manodopera era relativamente abbondante ovunque nell'area europea, tranne che in Gran
Bretagna.
A.W. Phillips elaborò un modello di scambio (trade off) tra inflazione e disoccupazione,
con il saggio della disoccupazione sulle ascisse e il tasso di incremento dei prezzi sulle
ordinate. La curva di Phillips è orientata verso il basso e verso destra, in quanto un
saggio di disoccupazione più alto implica un saggio di inflazione più basso, addirittura
una deflazione dei prezzi, quando la curva interseca l'asse delle ascisse. In base a questo
modello, è impossibile evitare sia l'inflazione che la disoccupazione, sicché i governi si
vedono costretti a scegliere tra un elevato tasso di inflazione, con conseguenze negative
sulla bilancia dei pagamenti, e un alto livello di disoccupazione. A parere di alcuni
sarebbe stato meglio ignorare la curva di Phillips, non preoccuparsi del deficit della
bilancia dei pagamenti nel breve periodo e continuare la politica di espansione,
nell'attesa, o nella speranza, che l'incremento della produzione aumentasse la
produttività del lavoro, portando a una diminuzione dei prezzi e infine a un
aggiustamento della bilancia dei pagamenti. Non fu questa però la politica adottata, e i
governi britannici continuarono il sistema di 'freno e accelerata', svalutando di tanto in
tanto la sterlina - prima nel 1949, poi, dopo una serie di contrasti, nel 1967, e infine nel
1976 (v. Cairncross ed Eichengreen, 1983; v. Burke e Cairncross, 1992).Un corrispettivo
statunitense della curva di Phillips fu la cosiddetta 'legge di Okun', una regola empirica
formulata da Okun secondo la quale un aumento della disoccupazione di un punto
percentuale rispetto al livello del 4%, ritenuto necessario per far fronte ai cicli stagionali
e altri fattori transitori, porterebbe a una diminuzione del 3% del prodotto nazionale
lordo potenziale (v. Okun, 1962). La sconfitta di Jimmy Carter nelle elezioni
presidenziali del 1980 fu interpretata da Galbraith (v., 1994, p. 193) come la risposta
dell'elettorato a una situazione in cui a un tasso di inflazione annuo pari al 12-13% si
associava un livello di disoccupazione prossimo al 7%, che fece balzare il cosiddetto
'indice di povertà', derivato dalla somma delle due misure, oltre il 20%. Riferendosi a
questa situazione Carter parlò di "malessere economico", formula che suscitò l'aperto
scherno dell'opposizione repubblicana.
5. La stagflazione
La tesi del trade off tra inflazione e disoccupazione non resse a lungo. L'inflazione
continuò nella maggior parte del mondo indipendentemente dal livello di
disoccupazione. Fu in riferimento a questa situazione che venne coniato il termine
'stagflazione', composto di 'stagnazione' e 'inflazione'. A creare il neologismo sembra sia
stato nel 1965 un influente esponente del partito conservatore britannico, Ian MacLeod,
che in seguito divenne ministro delle Finanze. La curva di Phillips venne messa in
discussione da Milton Friedman, il quale introdusse il concetto di 'tasso naturale di
disoccupazione' affermando che la curva di Phillips è da intendersi come verticale e che
i tentativi di ridurre forzosamente il tasso di disoccupazione determinerebbero una
stagflazione (v. Blaug, 1985, p. 64). In un'altra formulazione l'interazione tra salari e
prezzi venne definita 'inflazione inerziale': esisterebbe cioè una tendenza inerziale
all'aumento dei prezzi impossibile da correggere nel breve periodo, e che può essere
arrestata nel lungo periodo solo adottando serie e prolungate misure antinflazionistiche.
Al trend dell'inflazione inerziale si accompagnerebbero movimenti effimeri di rialzo e di
abbassamento dei prezzi (v. Eckstein, 1981). L'espressione 'inflazione inerziale' non
ebbe nel linguaggio economico lo stesso successo di 'stagflazione', sebbene il fenomeno
designato fosse in gran parte lo stesso. A trent'anni di distanza dall'invenzione del
termine 'stagflazione', esso riapparve in un articolo pubblicato nel maggio del 1995 dal
"New York Times" dal titolo Un fantasma economico: la stagflazione, in cui si faceva
riferimento al fatto che nell'aprile di quell'anno i prezzi erano cresciuti più rapidamente
di quanto non fosse accaduto negli otto mesi precedenti, mentre la disoccupazione era in
aumento.
6. Il rallentamento dell'economia dopo il 1973
Al periodo d'oro della crescita economica, dal 1950 al 1973, fece seguito un vistoso
rallentamento nei decenni successivi. Il tasso di crescita medio (pro capite, annuo) del
4,3% registrato in precedenza nei cinque principali paesi industrializzati si ridusse tra il
1973 e il 1987 di più della metà, scendendo all'1,9% (v. Maddison, 1989, tab. 8.2). Nei
principali cinque paesi in via di sviluppo, inclusa l'Unione Sovietica, si ebbe un
rallentamento analogo, sebbene di proporzioni ridotte, con un calo dal 3,4 al 2,3%. In
quest'ultimo gruppo, inoltre, si evidenziava una divergenza anziché una convergenza, in
quanto sia in Cina sia in India si ebbe un aumento anziché una diminuzione del tasso di
crescita. Per descrivere questo fenomeno Maddison (v., 1983 e 1987) parla tanto di
'stagnazione' che di 'rallentamento' dell'economia.Le cause del declino dei tassi di
crescita sono varie e molteplici, ed esiste disparità di vedute tra gli economisti in merito
al peso da attribuire ai singoli fattori. Una causa va individuata nella crisi del sistema
monetario internazionale istituito con gli accordi di Bretton Woods, che segnò la fine nel
1968 del pool dell'oro sostenuto a Londra da importanti banche centrali, la dichiarazione
di inconvertibilità del dollaro nell'agosto del 1971 e il passaggio a tassi di cambio
fluttuanti nel 1973, quando la Bundesbank tedesca smise di sostenere il dollaro. Nel
novembre del 1973, a seguito della sconfitta della Siria e dell'Egitto nella guerra dello
Yom Kippur, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio (OPEC) decise di rialzare
il prezzo del petrolio da 3 dollari a più di 12 dollari al barile, determinando così la prima
delle due crisi petrolifere che segnarono il decennio. La seconda si verificò nel 1979,
quando l'embargo dell'OPEC fece lievitare il prezzo del petrolio oltre i 30 dollari al
barile. Entrambi i rialzi del prezzo del petrolio ebbero pesanti ripercussioni sulla bilancia
dei pagamenti dei paesi importatori, costringendoli all'indebitamento. Il debito fu
contratto sul mercato dell'eurodollaro, piuttosto che sotto forma di crediti nei confronti
dei paesi produttori di petrolio. Questi ultimi crearono saldi in dollari che venivano poi
'riciclati' verso i paesi importatori. L'aumento del prezzo del petrolio - uno dei prodotti
più importanti nel commercio internazionale - ebbe dunque l'effetto di aumentare
l'inflazione.
A un livello economico forse più fondamentale, dopo il 1970 si verificò una perdita di
fiducia nella politica economica, alla luce di quello che veniva considerato il fallimento
delle politiche keynesiane prima e del monetarismo dopo, dimostratisi incapaci di
stabilizzare i prezzi e la produzione. Molti anni prima la Francia aveva condotto un
esperimento di 'pianificazione indicativa', affidando a una commissione composta da
rappresentanti del governo, degli industriali e dei sindacati il compito di formulare
programmi settoriali per indicare gli obiettivi generali dello sviluppo. Nel lungo periodo,
risultò che il sistema economico francese tendeva a seguire linee di produzione
remunerative, anziché quelle imposte dall'alto.
Un meccanismo meno formale di guida dell'economia, noto come 'politica industriale',
venne sviluppato in Giappone e preso a modello dagli altri paesi. L'opinione degli
economisti è nettamente divisa in merito ai pregi e ai difetti della pianificazione:
secondo i suoi fautori il sostegno del governo ai settori produttivi 'vincenti', con
potenziali economie di scala, può stimolare la crescita economica, mentre secondo gli
scettici lo Stato sarebbe altrettanto incapace quanto le imprese private di prevedere quali
settori produttivi si dimostreranno vincenti in un mondo incerto e competitivo. Sia lo
Stato che le imprese di tanto in tanto fanno scelte sbagliate, ma gli errori di queste
ultime comporterebbero perdite più contenute e sostenibili.
Un esperimento di pianificazione fu condotto anche nel Regno Unito, dove nel 1957
venne istituito un Council on prices, productivity and incomes, che durò solo sino al
1961; l'anno successivo venne creato in sua vece il National economic development
council (chiamato familiarmente Neddies dalle iniziali NEDC) che nel 1965 elaborò un
piano per l'economia britannica. Il Comitato era articolato al suo interno in una serie di
sottocomitati, noti come 'little Neddies', preposti ai singoli settori industriali. Furono
creati inoltre un Ente per la riorganizzazione industriale (Industrial reorganization
corporation) e una Commissione nazionale per i redditi (National incomes commission).
Per la maggior parte queste istituzioni vennero utilizzate dal governo conservatore nel
tentativo di arginare le rivendicazioni salariali dei lavoratori, e non ebbero l'appoggio dei
sindacati. Nel 1964, quando i laburisti andarono al governo, la situazione della bilancia
dei pagamenti era sensibilmente peggiorata, e il tentativo di pianificazione britannico era
in una fase di stallo. Come osserva lord Croham, importante uomo d'affari e membro del
governo, negli anni sessanta i fautori di una crescita più rapida erano convinti che le
politiche fiscali e monetarie fossero insufficienti, e sostenevano che per contenere la
bilancia dei pagamenti si rendevano necessarie una politica industriale e una politica dei
redditi, oltreché l'introduzione di controlli sulle importazioni. Secondo altri lo Stato
avrebbe dovuto introdurre nuove tasse e stanziare sussidi per varie regioni e industrie.
Queste politiche vennero abbandonate nel corso degli anni settanta.
Un altro insuccesso della politica dei redditi si era verificato in precedenza, nel 1963, in
Olanda, dopo un decennio di stretta cooperazione tra imprenditori, sindacati e governo,
allorché uno 'slittamento salariale', ossia la differenza tra i salari guadagnati dai
lavoratori e i tassi salariali correnti o di mercato, balzò al 17% e più. Questo fenomeno
creò un crescente malumore tra gli imprenditori che perdevano forza lavoro in favore di
società che pagavano salari più alti di quelli di mercato e tra i lavoratori iscritti al
sindacato che ricevevano solo salari ai tassi correnti. Progressivamente il sistema
cominciò a disgregarsi e dare segni di cedimento e alla fine crollò. L'aumento dei tassi
salariali registratosi in un solo anno, il 1962, fu in larga misura dovuto alla decisione di
incorporare lo slittamento salariale nello standard. Il governo si ritirò dalle contrattazioni
nazionali annuali, molte imprese stipularono accordi separati con i sindacati al di fuori
dell'organizzazione che rappresentava imprenditori e sindacati, e la politica dei redditi
fallì (v. Kindleberger, 1967, pp. 47-52).
In retrospettiva è chiaro che il rallentamento della crescita a partire dal 1973 aveva cause
lontane, e che il quarto di secolo di crescita eccezionale che l'aveva preceduto va
considerato un fenomeno unico, e non già una situazione che possa ripresentarsi in modo
regolare. Tuttavia, in che termini vada definita la stagnazione, o il rallentamento, dopo il
prolungato periodo di crescita elevata è una questione aperta. In riferimento al declino
del tasso di crescita giapponese, passato dal 6,2% del 1988 allo 0,2 del 1993, un analista
economico ha affermato che il surplus nella bilancia dei pagamenti del Giappone
potrebbe essere annullato se il paese riuscisse a superare la stagnazione economica
tornando a un tasso di crescita anche solo del 2% (v. Passell, 1995). Nello stesso tempo,
gli elevati tassi di disoccupazione in Europa (23% in Spagna, 14% in Francia e in Italia,
9% in Germania, 8% nel Regno Unito) non furono interpretati in termini di stagnazione
ma in termini strutturali.In questi sistemi di Welfare un orario di lavoro ridotto, ferie
prolungate, un'elevata spesa per la previdenza sociale e livelli salariali di norma
piuttosto alti hanno fatto lievitare il costo del lavoro al di sopra della produttività
marginale del lavoratore medio. Sia il rallentamento che la stagnazione sono considerati
quindi un problema macroeconomico piuttosto che un problema strutturale, sebbene
ovviamente manchi un insieme di definizioni universalmente accettato.
7. La stagnazione come processo di invecchiamento economico
Secondo alcuni, l'analisi macroeconomica può essere estesa al di là del ciclo economico,
persino di un ciclo eccezionalmente lungo come quello del dopoguerra, per coprire un
ciclo globale di crescita nazionale di varia lunghezza. Il rallentamento che ha
caratterizzato l'ultimo quarto del XX secolo e, nel caso britannico, il secolo precedente,
può essere attribuito in gran parte a un processo di invecchiamento o di sclerosi
economica. In questa prospettiva lo sviluppo economico non procede attraverso tassi di
crescita costanti percentuali per anno, ma segue una curva logistica, o di Gompertz, o a
S: dopo un avvio lento, acquista gradualmente velocità e poi, raggiunto un punto
massimo, si stabilizza e infine rallenta. Alcuni paesi possono allora entrare in una fase di
declino; di norma, tuttavia, il declino è relativo e non assoluto, in quanto mentre in tali
paesi si verifica una stagnazione e un rallentamento, in altri la crescita continua a ritmo
accelerato. Secondo il famoso modello di W.W. Rostow (v., 1960), nel processo di
sviluppo si possono individuare i seguenti stadi: precondizioni del decollo, decollo (take
off), raggiungimento della maturità, e infine diffusione dei consumi di massa a livello
elevato. Il modello di Rostow non include il declino, anche se questo potrebbe essere
implicito nella fase di stabilizzazione dell'economia. Se il rallentamento che si verifica
all'apice della curva possa essere definito stagnazione è forse una questione di gusti;
alcuni, come ad esempio Olson (v., 1982), preferiscono parlare di 'stagflazione'.
L'attenzione degli studiosi negli ultimi decenni si è focalizzata sulla crescita nei paesi
sottosviluppati e sul declino nei paesi industrializzati. L'interesse per questo tema
peraltro non è nuovo. Gli storici dell'economia hanno analizzato le cause del declino
economico dei Comuni italiani e della Spagna dell'età moderna, attribuendolo al
'consumo vistoso' (v. Cipolla, 1968), a un persistente squilibrio nei bilanci statali e
all'aumento del debito pubblico (v. Veseth, 1990), a imprese e campagne militari
eccessivamente ambiziose - come quella contro l'Olanda in cui rimase invischiata per
ottant'anni la Spagna nel XVI e nel XVII secolo (v. Kennedy, 1987) - e
all'infiacchimento del ceto imprenditoriale. Secondo quest'ultima teoria, a una
generazione di imprenditori di successo che accumulano ricchezza succede una
generazione meno creativa, che si limita a conservare la fortuna accumulata dai genitori,
e infine una terza generazione che la dissipa.Mancur Olson (v., 1982) attribuì il declino
economico e la stagflazione a ciò che egli definisce 'coalizioni distributive', ossia quei
gruppi della società che si organizzano attraverso partiti politici e lobbies legislative per
cercare di sottrarsi agli oneri finanziari comportati dalla guerra e dalla ricostruzione nel
periodo postbellico, o in tempo di pace per eludere le tasse destinate a finanziare le spese
militari, gli investimenti pubblici, i trasferimenti sociali, ecc.
Altre spiegazioni del rallentamento della crescita economica nel processo di
invecchiamento in particolare, e talvolta in generale, fanno riferimento ai 'limiti alla
crescita' posti dai rendimenti decrescenti nello sfruttamento delle risorse naturali (v.
Meadows e Meadows, 1973); questa tesi è stata sostenuta dal Club di Roma, ma ha
trovato ampia risonanza anche al di fuori del suo ambito. In una sofisticata
interpretazione economica questo fenomeno è stato descritto in termini di entropia (v.
Georgescu-Roegen, 1992, pp. 147-149). Sin dalla rivoluzione industriale, tuttavia, il
limite alla crescita posto da rendimenti decrescenti è stato superato con l'invenzione e
l'innovazione.
L'interpretazione di Marx e di Lenin del declino del capitalismo attribuiva un ruolo
fondamentale al sottoconsumo, derivante da salari eccessivamente bassi per creare una
domanda sufficiente di beni di consumo. Secondo una interpretazione moderna, lo stesso
effetto sarebbe provocato dal progressivo spostamento dell'interesse degli imprenditori
dal settore commerciale a quello industriale e infine a quello finanziario, che
provocherebbe sensibili rallentamenti nel tasso di incremento della produttività, uno
squilibrio nella distribuzione dei redditi e quindi ancora una volta fenomeni di
sottoconsumo (v. Burke, 1974). In tempi recenti si è sostenuto che l'interesse degli
imprenditori si è spostato dalla produzione a basso costo e dalle vendite per il consumo e
per l'investimento al corso azionario delle società, all'acquisto in blocco di altre società
per fini speculativi, alla costituzione di conglomerate, ecc. Gli investitori dal canto loro
sono sempre più interessati ai redditi di capitale anziché ai redditi derivati dai dividendi
e dagli interessi. I risultati finanziari a breve termine vengono privilegiati rispetto al
reale progresso a lungo termine. Persino il settore della ricerca e sviluppo può essere
indirizzato verso i redditi di capitale, in quanto anziché investire per il lungo periodo si
creano società con capitale di rischio che vengono vendute a breve termine. Le
specializzazioni in economia e commercio e in scienza della finanza attirano gli studenti
più brillanti, mentre cala l'interesse per l'ingegneria, il marketing e l'amministrazione
aziendale.
Una particolare situazione che può causare un rallentamento della crescita è nota come
'sindrome olandese', in quanto si verificò in Olanda a seguito della scoperta di
giacimenti di metano nel Mare del Nord: l'aumento dei salari in un settore ristretto
dell'economia determinò una richiesta generalizzata di aumenti salariali, anche in quei
settori in cui non si era avuto un incremento della produttività, danneggiando le altre
industrie. Un effetto analogo, che potrebbe essere chiamato 'sindrome spagnola', si ebbe
nell'età moderna a seguito della scoperta del Nuovo Mondo e del conseguente afflusso di
metalli preziosi, soprattutto di argento. L'agricoltura e il commercio vennero trascurati, i
consumi delle classi agiate aumentarono in modo considerevole e il prolungarsi della
guerra contro la Gran Bretagna e i Paesi Bassi esaurì le forze della Spagna.
Le diverse cause del declino economico e della stagnazione di lungo periodo non sono
mutuamente esclusive. Alcune - come la guerra, l'esaurimento delle risorse e le calamità
naturali - sono di tipo esogeno; altre, e sono forse le più importanti, sono di tipo
endogeno e legate al ciclo economico nazionale - in particolare il progressivo
spostamento del centro di gravità dal settore commerciale e industriale a quello della
finanza, il declino dei tassi di produttività e di innovazione, nonché l'infiacchimento
dell'energia imprenditoriale (v. Kindleberger, 1986). La tesi secondo cui il declino
economico della Gran Bretagna iniziato verso il 1890 sarebbe imputabile all'incapacità
della classe imprenditoriale è stata messa in questione da alcuni econometristi, a parere
dei quali essa incontrò limiti e ostacoli dovuti a strozzature che portarono
inevitabilmente a un declino del tasso di crescita. A ciò si può ribattere osservando che
anche nel momento di massimo rigoglio dell'economia britannica, negli anni della
rivoluzione industriale, gli imprenditori incontrarono strozzature e riuscirono a
superarle, mentre alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento lasciarono ad altri il
compito di trovare una via d'uscita. Con poche eccezioni, le industrie più fiorenti in
Gran Bretagna a partire dal 1890 sono state gestite da imprenditori stranieri.
Analogamente, la tesi secondo cui il declino economico degli Stati Uniti sarebbe iniziato
nell'ultimo quarto di secolo, e la leadership statunitense nell'economia mondiale sarebbe
prossima alla fine è stata confutata, soprattutto dagli studiosi di scienza politica che
hanno analizzato il ruolo dell'America su scala internazionale (v. Nau, 1990; v. Nye,
1990).
Un fenomeno notevole nella crescita dell'economia mondiale del dopoguerra è stata la
miracolosa ripresa della Germania e del Giappone dopo la sconfitta militare e le
distruzioni causate dalla guerra; una fase di stagnazione sembrava probabile date le
necessità della ricostruzione. La situazione di questi paesi offre un netto contrasto
soprattutto con quella degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, in cui la crescita, sebbene
più rapida di quella registrata in precedenza nello stesso secolo, nel dopoguerra fu più
lenta di quella che si ebbe nei paesi sconfitti. Una spiegazione può essere ricercata nel
fatto che furono proprio le distruzioni causate dalla guerra a favorire in Germania e in
Giappone l'introduzione di nuovi impianti dotati delle tecnologie più avanzate. La Gran
Bretagna perlomeno, se non gli Stati Uniti, pagò invece lo scotto di essere partita in
vantaggio nella rivoluzione industriale, trovandosi con impianti obsoleti ma ancora
funzionanti che imprenditori e amministratori non erano disposti a smantellare,
rallentando in questo modo l'introduzione delle tecnologie più avanzate (v. Jervis, 1947).
Tuttavia la spiegazione più convincente è quella che attribuisce un ruolo fondamentale al
ricambio della classe dirigente. Con la stessa rapidità con cui rimpiazzarono il capitale
investito distrutto durante la guerra, la Germania e il Giappone procedettero anche a
sostituire la classe dirigente politica ed economica. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti,
usciti vincitori dal conflitto, non si rese necessario invece un mutamento radicale dei
quadri, nonostante la sconfitta del primo ministro Winston Churchill ad opera di
Clement Attlee nel luglio del 1945. Per usare la terminologia di Olson, nei paesi sconfitti
vennero spezzate le coalizioni distributive che in passato avevano rallentato il progresso.
In Germania la sconfitta nel primo conflitto mondiale non aveva avuto lo stesso effetto,
in quanto aveva lasciato immutate le vecchie categorie sociali - Junker, industriali,
sindacati, pubblici funzionari e contadini -, ognuna pronta a opporre resistenza a
qualunque azione che richiedesse il sacrificio dei propri interessi. La conseguenza fu
l'iperinflazione del 1921-1923 (v. Feldman, 1993). Dopo la seconda guerra mondiale,
invece, gli Junker erano stati spazzati via dalla sconfitta militare e dalla distruzione della
loro base agricola con la creazione della frontiera orientale sulla linea Oder-Neisse, le
organizzazioni sindacali, dei pubblici funzionari e dei contadini erano state distrutte dal
nazismo, e gli industriali erano stati screditati dal collaborazionismo e dalla sconfitta. La
disgregazione di questi interessi costituiti rese possibile l'importante riforma monetaria
del giugno 1948, che contribuì in misura significativa alla ripresa e alla crescita
economica della Germania.
Un caso interessante è quello della Francia, in cui si ebbe un'alternanza di fasi di crescita
e di rallentamento che Jack Goldstone attribuisce ai periodici collassi dei governi
francesi e all'esigenza di iniziare da zero con uomini nuovi. Verso la metà del XVII
secolo vi fu l'agitazione della Fronda, in seguito sedata; l'inizio del Settecento vide
l'effervescenza del Mississippi, causa di nuovi tumulti, e alla fine del secolo si ebbe la
Rivoluzione, con una rapida successione di leaders sino alla sconfitta di Napoleone nel
1815; seguirono un'altra rivoluzione nel 1848, la Comune di Parigi nel 1870, una vittoria
che lasciò il paese stremato nel 1918, e una vittoria ambigua nella seconda guerra
mondiale. Tutti questi rivolgimenti rappresentarono per la Francia un susseguirsi di
nuovi inizi con uomini nuovi, che contribuirono a evitare una stagnazione di breve
periodo.
La storia è ricca di esempi di economie in cui si verifica una ripresa dopo prolungati
periodi di stagnazione. La Catalogna conobbe una fase di declino nel XVII secolo, per
poi ripresentarsi nel XIX secolo come forza trainante della limitata industrializzazione
della penisola iberica. Le città italiane che avevano vissuto l'esperienza comunale ebbero
un periodo di rigoglio di maggior durata, entrarono in una fase di stabilizzazione nel
XVI secolo e rimasero più o meno quiescenti sino agli ultimi decenni dell'Ottocento, con
il Risorgimento che portò all'unificazione del paese. Il precedente rallentamento
economico è stato interpretato da alcuni studiosi come una 'mancata transizione'
dall'espansione del commercio e dell'industria su piccola scala all'industrializzazione
moderna. Un altro, più breve periodo di stagnazione e di mancata transizione fu quello
delle Province Unite olandesi, che raggiunsero il culmine dello sviluppo economico nel
1672 secondo alcuni storici, nel 1730 secondo altri, ma subirono pesanti perdite con la
guerra e l'occupazione napoleonica, quando erano in una fase di prosperità e di
stagnazione; la transizione all'industrializzazione avvenne infine verso la metà del XIX
secolo (v. Kranz e Hohenberg, 1974). Può esservi dunque una certa elasticità economica,
con lo sviluppo di nuove curve di Gompertz dopo una fase di stabilizzazione, di declino
e di stagnazione.Il grande storico francese Fernand Braudel critica la tesi espressa in un
testo tedesco del 1934, secondo cui in ogni unità economica esisterebbe una tendenza
intrinseca al declino; egualmente opinabile sarebbe a suo avviso l'idea, sostenuta da
alcuni economisti, che la stagnazione di una società sarebbe imputabile alle disfunzioni
di settori vitali dell'economia - industria, investimenti, navigazione e finanza pubblica:
ogni caso infatti è diverso dagli altri (v. Braudel, 1949). Questo è il punto di vista di uno
storico, e tuttavia per un economista le generalizzazioni non solo sono possibili, ma sono
addirittura necessarie. Nelle nazioni dotate di sufficienti capacità sociali e di istituzioni
adeguate lo sviluppo economico segue una curva logistica o a S; il rallentamento che
segue a una fase di crescita, quando non intervengono fattori traumatici, va visto come
una sorta di sclerosi economica. Le disfunzioni non investono un settore vitale in
particolare, ma coinvolgono gradualmente tutti i settori via via che l'economia perde
vitalità ed entra in una fase di stagnazione