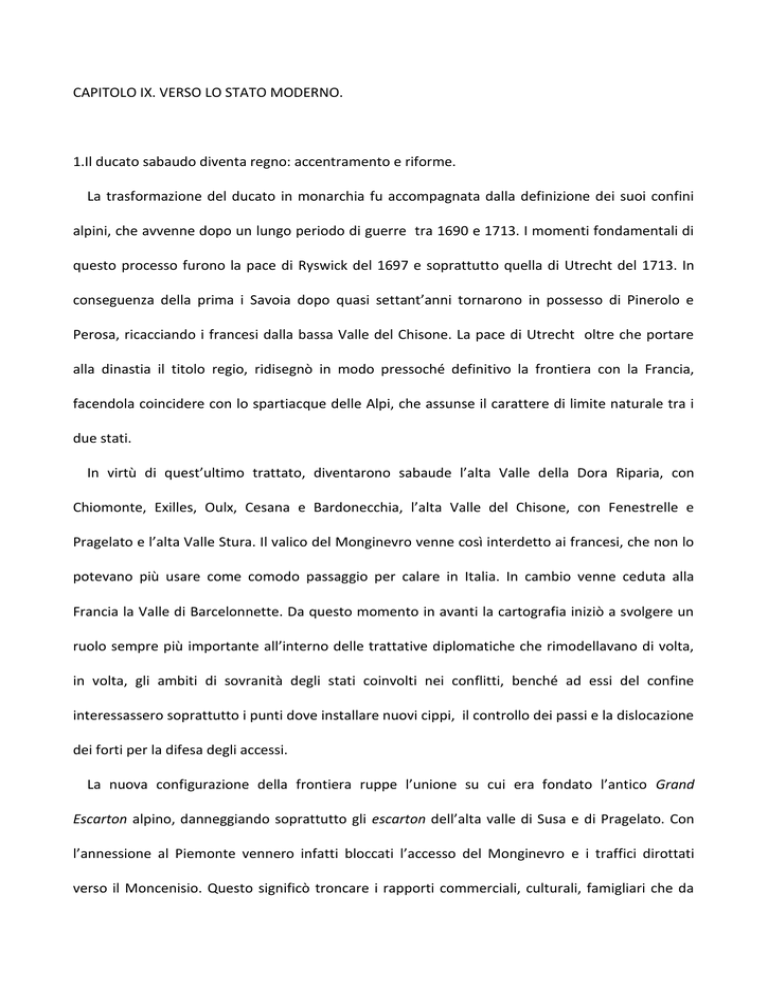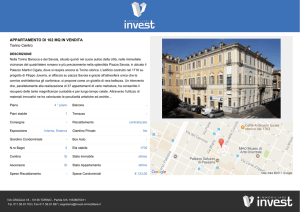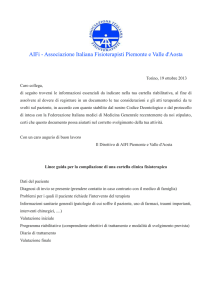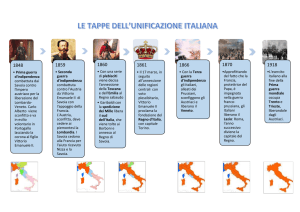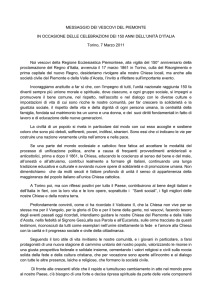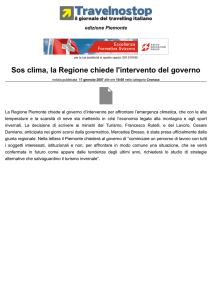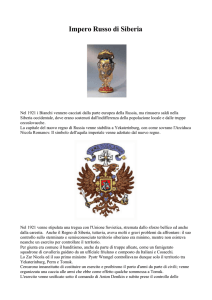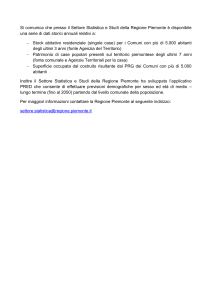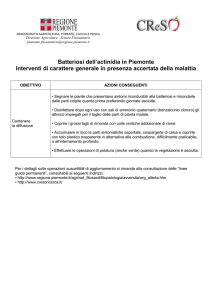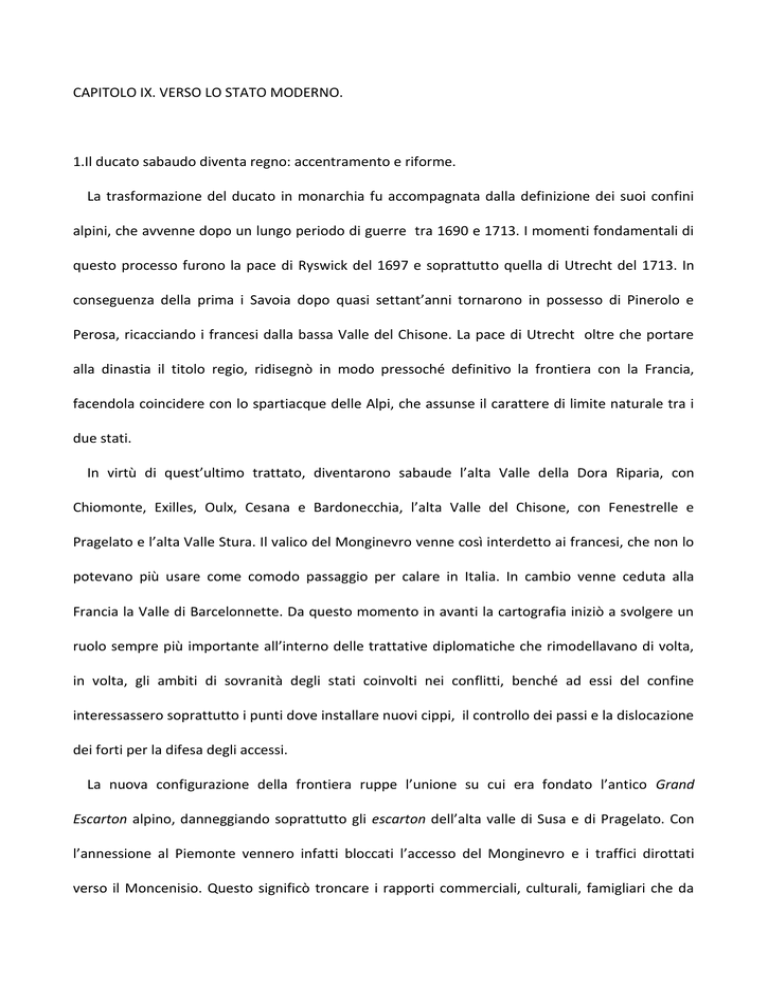
CAPITOLO IX. VERSO LO STATO MODERNO.
1.Il ducato sabaudo diventa regno: accentramento e riforme.
La trasformazione del ducato in monarchia fu accompagnata dalla definizione dei suoi confini
alpini, che avvenne dopo un lungo periodo di guerre tra 1690 e 1713. I momenti fondamentali di
questo processo furono la pace di Ryswick del 1697 e soprattutto quella di Utrecht del 1713. In
conseguenza della prima i Savoia dopo quasi settant’anni tornarono in possesso di Pinerolo e
Perosa, ricacciando i francesi dalla bassa Valle del Chisone. La pace di Utrecht oltre che portare
alla dinastia il titolo regio, ridisegnò in modo pressoché definitivo la frontiera con la Francia,
facendola coincidere con lo spartiacque delle Alpi, che assunse il carattere di limite naturale tra i
due stati.
In virtù di quest’ultimo trattato, diventarono sabaude l’alta Valle della Dora Riparia, con
Chiomonte, Exilles, Oulx, Cesana e Bardonecchia, l’alta Valle del Chisone, con Fenestrelle e
Pragelato e l’alta Valle Stura. Il valico del Monginevro venne così interdetto ai francesi, che non lo
potevano più usare come comodo passaggio per calare in Italia. In cambio venne ceduta alla
Francia la Valle di Barcelonnette. Da questo momento in avanti la cartografia iniziò a svolgere un
ruolo sempre più importante all’interno delle trattative diplomatiche che rimodellavano di volta,
in volta, gli ambiti di sovranità degli stati coinvolti nei conflitti, benché ad essi del confine
interessassero soprattutto i punti dove installare nuovi cippi, il controllo dei passi e la dislocazione
dei forti per la difesa degli accessi.
La nuova configurazione della frontiera ruppe l’unione su cui era fondato l’antico Grand
Escarton alpino, danneggiando soprattutto gli escarton dell’alta valle di Susa e di Pragelato. Con
l’annessione al Piemonte vennero infatti bloccati l’accesso del Monginevro e i traffici dirottati
verso il Moncenisio. Questo significò troncare i rapporti commerciali, culturali, famigliari che da
secoli univano le terre del Grand Escarton, mentre l’unione con la bassa valle risultava piuttosto
artificiosa. Nonostante l’apparente logica del limite naturale, basata sul principio delle “eaux
pendantes”, la precedente linea di confine che passava per Gravere aveva segnato ben più della
divisione tra alta e bassa valle; in realtà aveva separato mondi diversi a livello linguistico, culturale
ed economico.
Benché Vittorio Amedeo II fin dal 1708 avesse promesso di rispettare gli usi locali delle valli di
Oulx e Pragelato, così come erano stati riconosciuti fino a quel momento dai re di Francia, le
franchigie dei due escarton vennero disattese, provocando le proteste della popolazione. Soltanto
nel 1737 Carlo Emanuele III diede piena esecuzione alle clausole del trattato di Utrecht,
confermando i tradizionali statuti valligiani.
Il loro rinnovo comportò la formazione di una enclave in qualche modo autonoma nel regno
sardo, anche se ormai si erano allentate le sinergie che avevano costituito la forza del Grand
Escarton. Gli escarton francesi e italiani continuarono a radunarsi, ma separatamente e le loro
decisioni sul piano economico e culturale furono sempre meno efficaci a causa della separazione
da Briançon, che era sempre stato il centro propulsore della piccola repubblica. L’ultima riunione
dell’escarton di Oulx avvenne nel 1791, alla vigilia dello scoppio della «guerra delle Alpi» tra la
Francia rivoluzionaria e il Regno di Sardegna.
L’assestamento della frontiera comportò una nuova intensa opera di fortificazione della regione
alpina, che impegnò per tutto il XVIII secolo il governo torinese, secondo il quale ogni valle
d’entrata doveva essere sbarrata materialmente da una fortezza inespugnabile. A partire dunque
dal 1713, ma con un impegno finanziario ancora maggiore dopo il 1750, venne realizzata una
barriera difensiva, formata da tante «sentinelle di pietra», tra le quali possiamo citare Bard, la
Brunetta di Susa, Exilles, Fenestrelle, Demonte, che impedivano ogni sbocco nella pianura del Po.
Attorno a queste opere ne furono costruire altre di fiancheggiamento e protezione, così che
vennero modificate ampie zone montagnose. La progettazione e la realizzazione impegnarono
come nei secoli precedenti valenti architetti e ingegneri militari: Antonio e Ignazio Bertola,
Francesco de Willencourt, Bernardino Pinto, Benedetto Nicolis di Robilant, Giovanni Antonio Rana.
Il forte di Bard, situato sullo sbocco dell’anfiteatro morenico di Ivrea, sorvegliava la Valle
d’Aosta, cerniera per il passaggio attraverso le Alpi per la Savoia e per il lago di Ginevra e l’Europa
centrale.
La fortezza della Brunetta a guardia della strada del Moncenisio, sostituì quella
cinquecentesca di Santa Maria. I lavori durarono per circa ottant’anni, trasformandola in uno dei
migliori baluardi montani d’Europa. Exilles, conquistata nel 1708, fu completamente ristrutturata
e nel giro di pochi anni diventò il fulcro di un sistema difensivo che comprendeva decine di altre
opere minori dislocate sui due versanti della valle.
Quanto a Fenestrelle, era una porzione di grande «muraglia cinese» trasferita sulle Alpi. Venne
costruita sui resti del forte francese Mutin e si snodò con uno sviluppo di proporzioni ciclopiche
senza interruzioni sul costone occidentale del monte Orsiera. Costituiva un tipico esempio di
organizzazione difensiva a «serravalle» e sbarrava il punto più stretto della Val Chisone. Pur non
essendo mai interessata da azioni militari, Fenestrelle al pari delle altre fortezze svolse un
importante ruolo strategico e di deterrente, come avvenne per esempio nel 1747 durante la
guerra di Successione Austriaca, quando i francesi cercando di aggirare Exilles e Fenestrelle,
incapparono nella sconfitta dell’Assietta. A Fenestrelle spetta inoltre un altro merito, quella di
essere l’unica fortificazione settecentesca ad essere giunta intatta fino ai nostri giorni.
La trasformazione dei forti in vere e proprie piazzeforti, cambiò definitivamente la scala delle
economie di tipo locale (sfruttamento agricolo, boschivo e minerario del territorio, reclutamento
di competenze specifiche legate al cantiere) sulle quali essi si erano basati fino a quel momento e
introdusse i primi meccanismi di sfida alla montagna. Infine, La realizzazione di strade militari
adatte al trasferimento delle artiglierie pesanti, contribuì ad invertire i criteri di inaccessibilità dei
valichi alpini, sui quali dal Cinquecento in poi si erano fondate le strategie sia del governo francese,
sia di quello sabaudo.
Una vicenda esattamente opposta interessò invece Pinerolo, che dopo essere passata sotto la
Francia nel 1631 divenne una fortezza di enormi dimensioni, tanto da raggiungere il livello di
«fortezza reale di primo rango», destinata a fungere anche da carcere di massima sicurezza, in
grado di ospitare personaggi importanti come ad esempio la misteriosa «Maschera di ferro», che
vi soggiornò diversi anni prima di essere trasferita al forte di Exilles.
Dal 1669 nella città fu impegnato anche il celebre architetto militare Vauban e la costruzione
trasformò completamente il tessuto urbano, poiché le periodiche demolizioni non risparmiarono
case, chiese, laboratori artigianali. L’ultimo ampliamento tra 1670 e 1673 determinò la definitiva
crisi della locale manifattura laniera, causando la distruzione di filande e opifici. Quando Pinerolo
venne riconquistata dai Savoia nel 1693, la fortezza venne completamente smantellata.
Tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo furono poste le basi della trasformazione del
Piemonte in stato moderno. Ad accelerare questo processo furono le vicende belliche in cui esso
fu coinvolto. Mentre infatti i conflitti di fine Seicento permisero ai Savoia di raggiungere
l’emancipazione dalla Francia e di ottenere il titolo regio (prima quello di re di Sicilia, poi sostituito
nel 1720 da quello di re di Sardegna), le guerre di successione della prima metà del Settecento
sancirono l’entrata del regno sardo nell’Europa delle monarchie assolute e del balance of power.
In entrambi i casi, per fronteggiare l’enorme sforzo militare la struttura politica, economica ed
istituzionale dello stato venne sottoposta ad una profonda riorganizzazione, che rafforzò i poteri
del sovrano. Tale opera riformatrice venne portata avanti da Vittorio Amedeo II, ultimo duca e
primo re di Casa Savoia (1684-1730) e perfezionata dal figlio Carlo Emanuele III (1730-1773).
L’intervento demiurgico di Vittorio Amedeo si concretizzò anche sul piano architettonico,
contribuendo ad arricchire il patrimonio degli edifici pubblici, sia civili come Palazzo Madama,
ristrutturato dall’architetto siciliano Filippo Juvarra, sia religiosi come l’imponente Basilica di
Superga, realizzata per adempiere ad un voto fatto dal principe al momento del grande assedio di
Torino da parte dei francesi nel 1706. Egli inoltre non rinunciò a costruire anche una propria
«delizia»: la Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Le riforme amedeane procedettero in due fasi: l’una tra 1685 e 1713, in cui furono poste le
premesse, l’altra tra 1714 e 1730, in cui si passò alla realizzazione. I principali obiettivi furono la
limitazione della potenza nobiliare, il controllo del territorio, la gestione uniforme e razionale
delle risorse finanziarie. A partire dalla metà degli anni ottanta del Seicento fu creata una rete di
nuovi funzionari, gli intendenti, che pur modellata sull’esempio francese, ebbe caratteri originali.
Le prime realtà ad essere interessate furono la Savoia, dove l’intendenza venne fondata nel 1686,
mentre nel 1688 fu la volta di Nizza. Gli intendenti erano dotati di ampi poteri, specie in campo
economico e presero il posto dei referendari in ciascuna delle province in cui era suddiviso il
ducato.
Nonostante la guerra, venne iniziata una grande opera di perequazione delle proprietà
fondiarie, attraverso il censimento dei beni e la revisione dei catasti comunali. Questo
provvedimento colpì duramente il clero e i nobili, i cui privilegi vennero sottoposti al vaglio del
governo. Tramite i «consegnamenti d’arme»
venne operata una regolamentazione
dell’aristocrazia, che favorì l’inserimento nel sistema degli onori anche dei ceti non nobili, che
intrapresero un percorso di ascesa sociale, costituendo una nuova nobiltà di servizio
completamente legata al sovrano.
Fu inoltre portato avanti un progetto organico di codificazione, che portò nel 1723 alla
promulgazione delle Regie Costituzioni, ristampate con aggiunte nel 1729. Dopo la pace di Utrecht
venne riorganizzato l’apparato burocratico a livello centrale: nel 1717 la Segreteria di Stato fu
divisa in tre sezioni autonome (Interni, Esteri e Guerra), affidate ognuna ad un primo segretario
(vero e proprio ministro), mentre la gestione dell’economia venne semplificata con la costituzione
di una Tesoreria generale, che operava di concerto con il Consiglio delle Finanze.
L’opera riformatrice fu completata con la riorganizzazione dell’Università di Torino, che avvenne
in netto anticipo rispetto alle riforme che avrebbero interessato gli istituti scolastici italiani ed
europei nel secondo Settecento. L’intento regio era duplice: centralizzare l’istruzione superiore,
sottraendola agli ordini religiosi e creare poi una rete di scuole secondarie dislocate sul territorio.
Il progetto intendeva rispondere alla crisi nella quale era caduto l’ateneo durante il XVII secolo,
per cui le cattedre che erano 38 nel 1586 si erano ridotte a 13 nel 1701. La direzione
dell’Università venne affidata al Magistrato della Riforma (una specie di Ministero della Pubblica
Istruzione), composto in maggioranza da funzionari statali.
Nel 1720 furono promulgate le Costituzioni universitarie e l’anno seguente la nuova Università
venne insediata ufficialmente nell’attuale palazzo di via Po (costruito sotto la direzione
dell’architetto Garove, con la collaborazione del Bertola e dello Juvarra). L’ubicazione, non
lontana dal «polo regio» formato dalle Segreterie, dal Palazzo Reale e da altri edifici pubblici quali
la Zecca e l’Accademia Militare, stava ad indicare la forte volontà accentratrice del sovrano.
L’educazione primaria rimase fuori dalla riforma e continuò ad essere a carico dei comuni, senza
alcuna istituzionalizzazione. A questo proposito bisogna però osservare che alcune regioni come la
Savoia e la Valle d’Aosta erano già dotate di un sistema scolastico di base, che si era rivelato
efficiente, soprattutto per quanto riguarda le comunità di montagna. In Valle d’Aosta per esempio
l’istruzione della popolazione rurale era affidata alle écoles des humeaux, le scuole di villaggio, che
rappresentarono una delle più significative realizzazioni della società valdostana in età moderna.
Le scuole rurali nacquero per la necessità, imposta dalla conformazione del territorio, di
assicurare in ogni parrocchia l’istruzione dei bambini. L’istituzione era sovvenzionata dagli stessi
paesani, i quali si riunivano in società, creavano casse specifiche o provvedevano tramite lasciti a
costituire i fondi necessari alla retribuzione del maestro, il quale nella maggior parte dei casi,
almeno fino al XVIII secolo, fu il parroco o comunque un sacerdote. Le materie insegnate erano in
genere francese, aritmetica, geometria e la religione cattolica.
La scuola era aperta nei mesi invernali, quando i giovani non risultavano impegnati nel pascolo
del bestiame o negli altri lavori agricoli alla loro portata. Le prime classi elementari vennero
fondate a Gressoney nel 1682 e a Lillianes nel 1692, grazie al lascito testamentario di un privato.
La precoce alfabetizzazione di una parte degli abitanti della valle del Lys fece crescere il numero
dei notai operanti nella zona, che nel Seicento erano circa una dozzina. La bassa percentuale di
analfabeti rispetto alle altre regioni italiane, non impedì tuttavia che all’inizio del Settecento circa
metà della popolazione firmasse ancora con la croce o tutt’al più con l’iniziale maiuscola di nome e
cognome.
Notevole impulso alle scuole venne dato nella seconda metà del secolo dal vescovo PierreFrançois de Sales, nipote del santo savoiardo, tanto che a quell’epoca se ne contavano più di 350.
Esse si diffusero in tutta la valle, spesso incorporando i fondi delle cappelle o delle confraternite
locali, che continuarono in questo modo a svolgere il proprio ruolo di assistenza. L’istituzione
scolastica valligiana divenne un simbolo dell’autonomia nei confronti dello Stato centrale, grazie
alla conservazione di tre elementi: l’insegnamento del francese, l’istruzione religiosa e la
salvaguardia degli interessi delle comunità.
La Valle d’Aosta tuttavia non sfuggì al processo di accentramento politico operato da Vittorio
Amedeo II. La progressiva abolizione dei privilegi aostani fu favorita dalle difficoltà in cui la regione
si venne a trovare durante le guerre tra fine XVII e inizio XVIII secolo, che causarono due rovinose
invasioni francesi, la prima nel 1691, la seconda più lunga tra 1704 e 1706, che iniziò con un
cruento assedio del forte di Bard. La regione fu inoltre messa a dura prova dal continuo transito di
truppe, con il conseguente obbligo di fornire vitto e alloggio.
La necessità di fronteggiare le spese militari, fornì al governo sabaudo il pretesto per diminuire
le franchigie della valle, soprattutto in campo fiscale e per intervenire sempre più
nell’amministrazione locale tramite l’intendente. I Savoia cercarono di estendere anche ad Aosta
la normativa valida per le altre parti dello Stato, imposero agli abitanti l’obbligo di prestare servizio
nell’esercito regio e agli studenti di conseguire la laurea nella sola Università di Torino.
Fu soprattutto Carlo Emanuele III a portare avanti un’azione mirante ad annullare gli antichi
privilegi aostani e ad uniformare il sistema politico-amministrativo della valle al resto del regno.
Principale obiettivo di tale politica fu il Conseil des Commis, le cui prerogative vennero
progressivamente limitate. A partire dal 1730 l’intervento sovrano si articolò in diversi campi,
disciplinando l’amministrazione comunale, la sanità, l’ordine pubblico. Particolare attenzione
venne rivolta alla gestione economica delle comunità, al fine di conservare i beni pubblici e di
garantire allo stato un adeguato gettito fiscale.
Nel corso degli anni sessanta anche nella Valle fu avviata la verifica delle proprietà ecclesiastiche
e feudali, primo passo verso la perequazione. Nel 1767 il re impose la stesura del catasto e con le
Regie Costituzioni del 1770 stabilì l’uniformità delle leggi in tutto il regno, abolendo il Coutumier.
Tre anni dopo decise l’affrancamento dei censi, che consentì alle comunità di villaggio e ai privati
di riscattare i diritti signorili su pascoli ed acque, analogamente a quanto stava avvenendo nella
vicina Savoia.
Qui le riforme erano iniziate nel terzo decennio del secolo con l’insediamento di un’intendenza
generale a Chambéry e di singoli intendenti in ciascuna provincia al di là delle Alpi. Nel 1720 venne
abolita la Camera dei Conti di Savoia, rea di essersi opposta alle direttive reali e nel 1723 furono
pubblicate le Regie Costituzioni. A partire dal 1728 venne realizzata l’opera di catastazione,
culminata nel 1738 nell’editto di perequazione. Nel 1762 venne abolita la taglia personale che
gravava ancora su molti contadini e nel 1771 fu emanato l’editto che affrancava i feudi, anche se
già da circa un ventennio le comunità avevano proceduto a liberarsi dei diritti signorili, pagando un
corrispettivo ai feudatari.
Nel complesso si può dire che la complessa macchina dello stato, organizzata da Vittorio
Amedeo II e che, partendo dal centro, si rivolgeva ai territori, cercando di renderli uniformi, venne
non solo confermata da Carlo Emanuele III, bensì perfezionata e resa meno contraddittoria. In
questa azione, portata avanti per tutta la durata regno, egli si avvalse dell’opera di due grandi
ministri, che per quarant’anni elaborarobo le linee guida della politica sabauda: prima il marchese
d’Ormea e poi il conte Giambattista Lorenzo Bogino.
Quest’ultimo in particolare dopo la fine della guerra di Successione austriaca (1748) si fece
promotore di un’articolata serie di riforme, che miravano a realizzare un modello di buon
governo, secondo i principi che proprio in quegli anni venivano teorizzati dall’abate Ludovico
Antonio Muratori nel trattato Della pubblica felicità, destinato a diventare il manifesto del
riformismo moderato italiano.
Strumento esemplare di questo sistema politico era la fitta rete di intendenti, che rappresentava
nelle province il potere dello stato sul piano amministrativo e fiscale, confrontandosi con i
problemi locali e costringendo sempre più le comunità ad uniformarsi alle direttive dal centro. La
figura dell’intendente, con le sue competenze e capacità di raccogliere informazioni, assunse
caratteri più precisi rispetto all’età di Vittorio Amedeo II.
A testimonianza di questo processo si può citare la «grande inchiesta» De Gregori, promossa tra
1750 e 1755. Gli intendenti di tutte le provincie furono invitati ad inviare una dettagliata relazione
sulle condizioni socio-economiche del territorio da loro amministrato. Il risultato fu un enorme
massa di documentazione, che per la prima volta nella storia dello stato sabaudo offriva un grande
e articolato affresco della realtà del Paese. La strategia mirante ad uniformare dal punto di vista
amministrativo e legislativo tutte parti del Regno sardo continuò anche negli anni finali di Carlo
Emanuele III, culminando nel 1771 con l’editto che stabiliva le regole per il funzionamento dei
consigli municipali e delle comunità.
A Nizza le trasformazioni destinate a mutare profondamente gli assetti politici e istituzionali
della contea iniziarono già alla fine del XVII secolo, con l’istituzione dell’intendenza nel 1688.
Anche qui le esigenze di reperire le risorse per affrontare le crescenti spese militari, indussero il
duca Vittorio Amedeo II ad attuare una strategia mirante a ridurre i privilegi fiscali e a riformare i
catasti. Tali obiettivi vennero perseguiti in primo luogo dall’intendente Pierre Mellaréde, destinato
a diventare in seguito uno dei maggiori collaboratori del principe sabaudo.
La città difese con forza le libertà e le franchigie, che sosteneva erano state confermate dai
Savoia al momento della dedizione, ma non riuscì ad impedire che fossero sottratte al comune le
gabelle più importanti (tabacco, vino e pesce), che divennero proprietà del demanio ducale. Altro
colpo all’autonomia locale fu l’operazione di verifica del catasto, che alla fine venne rinviata,
rivelando però l’esistenza di sperequazioni che il governo centrale non intendeva più tollerare. Su
98 comunità della contea solo 7 (Nizza compresa) non avevano un catasto aggiornato e ciò
contrastava con la volontà sabauda di razionalizzare il sistema contributivo.
Tali comunità del resto costituivano un insieme eterogeneo. Erano il vero collante socioeconomico della regione e soprattutto controllavano le regole di utilizzo del sistema agropastorale che dominava il territorio, ma avevano condizioni differenti, che dovevano essere
uniformate. Esistevano infatti forti disuguaglianze fiscali tra le zone settentrionali e quelle
meridionali, accentuate dallo status privilegiato di Nizza. L’assestamento della frontiera
conseguente alla pace di Utrecht, comportò inoltre aggiustamento territoriale, per cui la valle di
Barcelonnette con 12 comunità passò alla Francia.
La situazione finanziaria fu aggravata dalle guerre della prima metà del Settecento. Le truppe dei
vari contendenti attraversarono a più riprese la regione e Nizza subì due lunghe occupazioni: nel
1705-1713 da parte dei francesi e nel 1744-48 da parte dei gallo-ispani, le cui conseguenze furono
distruzioni (la città fu assediata nel 1703) e l’imposizione di tasse, che causarono l’aumento dei
debiti delle comunità. Si trattava di un fenomeno già iniziato nel secolo precedente, ma che ebbe
un notevole incremento: ancora nel 1755 il municipio nizzardo aveva un deficit di quasi un milione
di livres e 52 comunità su 86 erano fortemente indebitate.
In questo contesto si inserì l’azione del governo sabaudo, che mirò al controllo delle istituzioni e
al risanamento delle finanze locali. Fino al 1792 si alternarono 18 intendenti, tra i quali oltre al
citato Mellaréde si deve ricordare Gaspard Joanini (1750-59). Nonostante i loro sforzi, Nizza riuscì
a non farsi imporre il catasto, tuttavia già nel 1735 fu costretta ad accettare un considerevole
aumento del tasso. A proposito bisogna ricordare che nella contea mancavano organi provinciali di
rappresentanza come nelle vicine Provenza e Linguadoca, il che rendeva più forte il potere di
intervento dell’intendente. La politica centralizzatrice della monarchia fu infine coronata dalla
riforma comunale del 1775, che consentì all’intendente di esercitare un controllo più stretto
sull’amministrazione locale.
Nella contea venne dunque realizzato quel sistema di «buon governo», che veniva perseguito
dalla monarchia sabauda nelle altre provincie del regno. L’amministrazione era divisa tra il
governatore, gli organi giudiziari (tra cui le 12 prefetture, già create nel 1662 e il Senato, riformato
nel 1723) e l’intendente, che aveva un fondamentale ruolo di coordinamento e supervisione.
Anche la composizione del Consiglio comunale venne riorganizzata, in modo che venissero
rappresentate tutte le categorie dei cittadini.
Nel complesso, nel corso del Settecento il volto della capitale cambiò, anche dal punto di vista
urbanistico, in quanto le distruzioni della guerra favorirono la creazione di nuovi spazi e
l’allargamento del tessuto urbano. Alla fine del secolo la città aveva in parte assunto quell’aspetto
«ameno», in grado di attirare i visitatori e turisti del nord Europa, a cominciare dagli esponenti
della nobiltà inglese, come ad esempio lord Cavendish, il quale vi soggiornò a lungo con la famiglia
tra gli anni cinquanta e sessanta.
Nonostante ciò le condizioni della classi popolari continuarono ad essere difficili e le
disuguaglianze molto nette, specie tra la zona costiera e l’entroterra, favorendo l’emigrazione, che
nelle valli di montagna raggiunse anche il 41% della popolazione nei mesi invernali. L’indicazione
di uno sviluppo economico stentato è fornito dall’andamento demografico: Nizza oscillò tra i
15000 abitanti di inizio ‘700 ai 20000 di fine secolo, con un incremento piuttosto modesto.
2. Territori, economie e società nell’area alpina del Settecento.
Con la definizione dei confini tra la Francia e il Regno di Sardegna, vennero anche meno le
ragioni difensive che in parte avevano condizionato la politica stradale sabauda in prossimità delle
frontiere e che avevano indotto il governo torinese a intervenire solo occasionalmente sulle vie a
lungo percorso, trascurando le altre. Nel corso del Settecento le vecchie strategie furono
abbandonate e prevalsero le logiche del profitto, per cui era necessario agevolare i traffici anche
nelle zone di confine che fungevano da passaggio per le merci che dal Mediterraneo andavano
verso il nord Europa.
L’ammodernamento della rete viaria fu quindi affidato alla Direzione generale delle strade,
creata nel 1761, ma i miglioramenti effettivi interessarono soprattutto le routes royales, quella del
colle di Tenda e quella del Moncenisio. La prima venne sottoposta a massicci interventi specie
nell’ultimo quarto del secolo, che la resero percorribile con carrozze, mentre la seconda fu
interessata da continui miglioramenti al tratto montano, al fine di renderla meno ripida e di
evitare le complesse operazioni di smontaggio dei carri e di trasferimento su muli e sedie di
passeggeri e merci in prossimità del passo.
Differente era la situazione nelle aree pianeggianti al di qua delle Alpi. Nessuna strada di
qualche importanza risaliva per esempio la valli del cuneese e del saluzzese, percorse da sentieri e
mulattiere per le comunicazioni interne e con le vallate al di là dei monti. Lo stesso tragitto per il
Monginevro, che nel Seicento era stata la principale via tra Francia e Italia, venne curato soltanto
per la rilevanza militare e la presenza del forte di Fenestrelle.
A trarre giovamento delle migliorate condizioni delle comunicazioni tra i due versanti alpini fu in
primo luogo l’economia. Nonostante che importasse molti manufatti tessili, prodotti di lusso
(orologi, bigiotteria, porcellane, arazzi, cineserie) e coloniali (caffè, the, zucchero, cacao, tabacco,
spezie) ed esportasse soprattutto semilavorati e alimentari, la bilancia commerciale tra lo stato
sabaudo e la Francia si mantenne stabile, anzi nel periodo 1716-1770 essa realizzò un notevole
avanzo a favore del Piemonte.
Benché interrotte diverse volte dalla guerra o da misure protezioniste, le relazioni commerciali
tra i due stati furono costanti e dettate dalla reciproca dipendenza. L’industria serica francese
dipendeva massicciamente dai filati piemontesi e all’inizio del Settecento i membri della Camera di
Commercio di Lione affermavano che la prosperità della loro regione e del Delfinato era
determinata dalle relazioni con gli stati sardi e di conseguenza dal mantenimento dei rapporti con
Torino.
Comunque sia, la complessa e a volte contraddittoria politica doganale messa in atto da
entrambi e paesi, non impedì l’affermarsi di una fiorente attività di contrabbando su entrambi i
versanti della Alpi. Nonostante la sorveglianza dei rispettivi corpi di polizia, le frodi doganali
vennero perpetrate da nord a sud lungo tutta la barriera alpina.
La più importante delle esportazioni piemontesi era la seta grezza o semilavorata, assorbita
soprattutto dalle manifatture lionesi e in misura minore dal mercato inglese, con una piccola parte
che andava in Lombardia, Svizzera e Germania. Poi seguivano i prodotti agricoli: riso, olio di oliva
(per lo più proveniente da Nizza e Oneglia), tele (specie di canapa e lino), quantità modeste di
cereali, di formaggi e di pellami.
Nonostante fosse un grande produttore di seta grezza, il regno sardo non riuscì a sviluppare
un’industria tessile consistente, importando non soltanto tessuti di seta e di lana, ma anche di
cotone, fibra che si impose sul mercato e nella moda a partire dalla seconda metà del Settecento.
Il Piemonte era del resto il maggior importatore di tessuti di lana, assorbendo metà dei panni
francesi esportati in Italia.
In realtà, nei domini sabaudi non mancava la materia prima; nei territori alpini e prealpini
l’allevamento delle pecore era assai praticato, ma la qualità della lana era mediocre e si prestava
soprattutto alla tessitura domestica e alla produzione di manufatti poco raffinati. Questi tessuti
soddisfacevano più che altro le esigenze del mercato interno e le commesse dell’esercito, mentre i
consumatori più esigenti si rivolgevano ai prodotti di importazione, francesi e inglesi, la cui qualità
era nettamente superiore.
Anche la produzione di tessuti di lino e canapa, realizzati peraltro con tecniche tradizionali, era
prevalentemente destinata al consumo interno ed era abbondante a causa della larga diffusione di
questo genere di coltivazioni, che si adattavano a climi e terreni diversi. Si esportava una certa
quantità di canapa grezza e di cordami da Nizza e dal Piemonte, mentre il lino era penalizzato dalla
concorrenza dei tessuti di cotone, che godevano di un crescente successo, tanto che il governo
sabaudo decise di incentivarne la produzione con privilegi e sconti doganali, sia al di qua che al di
là dei monti.
Risultati discreti diedero la lavorazione del cuoio (molte le concerie presenti lungo i confini delle
Alpi occidentali) e della carta (nell’area nizzarda c’erano numerosi mulini da carta e altre
manifatture), i cui prodotti erano oggetto di esportazione. Modesta fu l’attività estrattiva,
insufficiente ai bisogni del paese, mentre quella metallurgica era più consistente, ma subordinata
alle necessità militari. Gran parte delle imprese che si svilupparono ad esempio in Savoia in campo
estrattivo e metallurgico, come la già citata fonderia dei Castagneri, condussero una vita stentata.
A questo proposito è tuttavia interessante analizzare il caso della Valle d’Aosta, dove le fonti
descrivono in maniera esauriente il complesso rapporto che si venne a creare nel settore della
metallurgia (ferro e rame) tra stato, beni comunali (in particolare i boschi), detentori di diritti
feudali e privati. Dal momento che nella regione continuò ad essere usato il carbone di legna, fin
dalla metà del XVIII secolo, ma ancor più in seguito, emersero i problemi derivanti dallo
sfruttamento selvaggio dei filoni e dalla lavorazione poco controllata.
Lo spreco qualitativo causato dalla scarsa innovazione tecnologica, si traduceva infatti in
aumento del rifornimento di legna, con danni notevoli alle foreste, e in proteste degli abitanti per
le esalazioni provocate dalle fusioni, che conseguenti danni alle coltivazioni. Sorse quindi la
questione di un’organizzazione «razionale» delle risorse, che venne portata avanti da una trentina
di comunità a partire almeno dal 1745. I problemi per così dire «ecologici» non spiegano
comunque da soli il malcontento dei valligiani, che fu determinato dal metodo con cui venne
gestito il settore, cioè come una qualsiasi area di colonizzazione, i cui abitanti subiscono i danni in
nome del progresso. Le concessioni vennero date quasi tutte a imprenditori estranei alla regione,
che si appropriarono così del territorio.
In effetti, più che sull’industria la politica economica sabauda puntò sull’incremento del
commercio, in particolare di quello di transito, cercando di dirottare verso Nizza e il colle di Tenda
i traffici provenienti da Genova. Per raggiungere tale scopo il governo torinese dispose che le
franchigie del porto- franco di Nizza e Villafranca, già creato nel 1612, fossero estese a tutta la
strada della val Roja fino a Tenda e si attivò per renderla tutta carrozzabile. Infine portò avanti la
costruzione del porto di Limpia, iniziata nel 1750.
Progettato per accogliere 400 navi, il nuovo porto contribuì all’incremento delle merci sulla via
principale che univa la contea a Torino, attraverso Escarène, Sospello, Saorgio, Tenda. A metà
Settecento però i carri circolavano soltanto da Nizza a Escarène e poi da Limone a Torino, mentre il
resto della strada veniva percorsa a dorso di mulo.
Nonostante ciò verso gli anni ottanta la «scala» di Nizza era considerata la più importante per la
quantità di merci che entravano in Piemonte: ogni settimana vi transitavano 2000 muli. Vittorio
Amedeo III decise allora di migliorarla e i lavori si conclusero nel 1788 con una spesa di due milioni
di livres . In seconda posizione vi era quella del Moncenisio, percorsa da un terzo delle merci
dirette in territorio piemontese, da un altro terzo di quelle in uscita e da circa la metà di quelle in
transito. Anche i mercanti inglesi nella seconda metà del secolo vennero attirati dalle facilitazioni
della «scala» nizzarda.
Lo scalo provenzale, tuttavia, non riuscì a concorrere con i maggiori porti del Mediterraneo, non
potendo accogliere battelli superiori alle 400 tonnellate. Inoltre, non disponeva di un retroterra
importante sul piano commerciale come Genova e Livorno e di una flotta mercantile al pari di
Marsiglia. Infine, a sfavorire il capoluogo della contea vi erano le asperità della via del Tenda e
soprattutto la mancanza di un valido ceto imprenditoriale indigeno. Così gli scambi rimasero
deboli: nel 1791 le importazioni superavano le esportazioni, che del resto erano costituite per
l’80% da olio d’oliva.
Anche in Savoia i traffici si giovarono della politica governativa di agevolazioni fiscali, concesse
con l’intento di aumentare i rapporti con Ginevra e di monopolizzare il commercio tra la città e la
Francia. A favorire la situazione contribuiva la posizione della regione, al crocevia tra realtà a
vocazione industriale-mercantile come Ginevra e le città svizzere, centri popolosi dagli elevati
consumi, e le provincie francesi a vocazione agro-pastorale.
Al pari di quanto avveniva a Nizza, tutte le merci che percorrevano la Savoia provenendo dalla
Svizzera erano esenti dal pagamento della dogana finché restavano entro i confini sabaudi. A
compensare le perdite impositive vi erano i vantaggi economici derivanti dal transito dei convogli
sulle strade savoiarde, che incrementava una serie di attività secondarie, costituendo
un’importante fonte di guadagno per le popolazioni locali e indirettamente per l’erario.
I ginevrini infine importavano dalla Savoia, soprattutto dal Faucigny e dal Chablais i prodotti
alimentari loro necessari (cereali, vino, frutta e verdura). Nel resto del territorio savoiardo
l’agricoltura era piuttosto modesta. Molto diffuso era l’allevamento bovino e la produzione dei
formaggi pregiati, che erano esportati insieme a carne e cuoio. Il settore industriale era poco
sviluppato e concentrato soprattutto a Chambéry (seta e lana), mentre nei centri minori si
lavoravano cotone e canapa, in manifatture che però erano gestite da stranieri (piemontesi e
francesi del Delfinato).
Il commercio di transito costituì quindi un importante reddito per l’intera regione. Dopo la fine
della guerra di successione austriaca (1748) durante la quale la Savoia aveva subito una lunga
occupazione militare da parte delle truppe gallo-ispaniche, furono avviate numerose iniziative per
sviluppare le attività produttive rovinate dalle distruzioni belliche. Gli sforzi del governo sabaudo si
scontrarono tuttavia con quello che era stato anche in passato un difetto della società locale, cioè
l’assenza di un ceto imprenditoriale indigeno.
Un importante fattore economico era comunque rappresentato dal patrimonio boschivo, sul
quale però si esercitavano le tensioni di entità sociali diverse: lo stato, le comunità, i privati. Alla
fine del XVII secolo in tutti i domini sabaudi e in particolare nelle zone di montagna più ricche di
foreste, era aumentato l’intervento statale, sotto forma di vincoli a salvaguardia di una risorsa
considerata fondamentale sia per le attività civili (edilizia, manifattura), sia militari.
Si era innescato così un conflitto tra due concezione di risorsa forestale, due modelli economici,
due scale di organizzazione e gestione territoriale. Il ruolo di protezione che i provvedimenti
sovrani assunsero da quel momento nei confronti del bosco, nascondevano in realtà un nuovo
modo di produzione e nuovi obiettivi di consumo. A partire dal Settecento si affermò poi
l’economia di scala, basata sull’uso delle risorse in funzione della loro distanza dal mercato o dal
centro di gestione.
Le strade svolsero in questo senso un ruolo di acceleratore del confronto tra due livelli di scala
che si contendevano il controllo sul bosco, dove non si scontrarono semplicemente due modelli
economici, quello supposto dello «spreco» e quello presunto della «razionalità», bensì due sistemi
di cultura e di rappresentazione del mondo. Sulle sorti del bosco si giocò infine la partita tra il
governo centrale e le autonomie locali, il cui risultato fu ben evidenziato dal cambiamento
lessicale, per cui i boschi comuni si trasformarono in boschi comunali.
La Savoia, come abbiamo visto, aveva risentito negativamente della congiuntura bellica e
climatica tra Sei e Settecento. Colpita fu soprattutto l’agricoltura, le cui rese erano per altro già
piuttosto deboli (tre o quattro per uno). Oltre che i cereali soffrirono anche castagni e noci, frutti
che integravano la magra dieta dei contadini. Tra le conseguenze di tale situazione vi furono
l’indebitamento e l’espropriazione, che favorirono non solo l’affermazione di un nuovo ceto di
proprietari borghesi, ma anche un rafforzamento del sistema signorile.
La principale novità dell’epoca fu infatti la ripresa nobiliare, con la riaffermazione dei simboli e
dei diritti signorili. Questo sforzo di restaurazione aristocratica costituì uno dei maggiori fenomeni
della storia sociale della Savoia sotto l’Ancien Regime. Nella regione la nobiltà rappresentava 1,1 %
della popolazione e si concentrava ad Annecy (46 casate) e Chambéry (227). Tale ceto, più
presente in pianura che in montagna, basava il proprio potere sul possesso fondiario, detenendo
circa un quinto delle terre disponibili.
La componente borghese comprendeva avvocati, procuratori e notai, oltre ai mercanti, pochi
dei quali erano ricchi, perché i traffici venivano monopolizzati da Ginevra e Lione. Come si è detto
in precedenza anche i borghesi miravano alla rendita fondiaria. Molto numerosi erano gli artigiani:
nel 1740 se ne contavano 367 ad Annecy, 515 a Chambéry. I settori più rappresentati erano quello
tessile, della lavorazione del cuoio e del legno. Non esisteva alcuna organizzazione di tipo
corporativo, ma piuttosto confraternite, dirette da un priore, con cappella e statuti propri, che
svolgevano un doppio ruolo di assistenza degli affiliati e di controllo della professione.
Quanto al clero, ad inizio Settecento esistevano 3000 religiosi, divisi in 640 parrocchie, 21
capitoli di cattedrali, 45 conventi maschili, 27 femminili. Vivevano in gran parte non tanto grazie
alla ricchezza fondiaria, quanto alle decime. A livello di cultura era piuttosto diffuso lo spirito
giansenista, che aveva il proprio centro nel convento dei domenicani di Chambéry e a cui si
opponevano i gesuiti, tenaci difensori dell’obbedienza al papa, appoggiati dalla nobiltà e dalla
magistratura. Nel corso del secolo tuttavia e con la progressiva penetrazione delle idee illuministe,
incredulità e scetticismo si diffusero nella società, soprattutto tra l’élite intellettuale.
Le aree di montagna sfuggirono alla revanche signorile. Nelle zone alpine i contadini erano
infatti proprietari della maggior parte della terra e l’esistenza di vasti beni comuni favoriva la
pratica dell’allevamento e questa ricchezza collettiva si riverberava sia sui proprietari, sia sui non
possessori. La qualità degli alpeggi e l’adozione di tecniche casearie avanzate, introdotte nel XVII
secolo da affittuari svizzeri (specie del cantone di Friburgo) favorirono la produzione di tome e
groviere, apprezzate al di là dei confini regionali. Il commercio del bestiame era molto attivo: ovini,
bovini e muli della Mauriene, della Tarantaise, del Faucigny e del Chablais venivano venduti nel
Delfinato oppure erano trasportati alla grande fiera annuale di Susa.
Nelle basse vallate e nelle pianure le terre appartenevano invece in larga parte ai nobili e ad altri
proprietari. L’economia agraria savoiarda rimase sempre debole e in balia di crisi frequenti: 1725-
27, 1730-36, 1740-42, 1746-50, 1756-60, 1765-72. Tale andamento influenzò pure quello
demografico, per cui la popolazione rimase stazionaria o ebbe una lieve crescita fino agli anni
settanta, poi crebbe con maggior decisione. In sostanza gli abitanti della Savoia, che erano 320
mila nel 1720, risultavano 346 mila nel 1776 e 384 mila nel 1788.
Un elemento stabilizzatore fu costituito dall’emigrazione. I lavoratori migranti erano soprattutto
facchini, manovali, muratori, domestici e ambulanti. Verso il 1789 i savoiardi che andavano a
lavorare all’estero erano tra i 30 e i 40 mila. Chi faceva fortuna ritornava a visitare il proprio paese
d’origine e spesso vi istituiva una fondazione di carità, apriva una scuola, costruiva una cappella,
offriva ex-voto, donava ornamenti dorati per le chiese e retabli d’altare.
Il fenomeno migratorio, soprattutto stagionale, era del resto caratteristico anche della Valle
d’Aosta, dove anzi aumentò rispetto ai secoli precedenti, a causa delle persistenti difficoltà
dell’agricoltura, soggetta a periodiche crisi di sussistenza. Sull’economia agraria agì in senso
negativo la parcellizzazione fondiaria, tipica del diritto ereditario valdostano e presente pure in
altre zone delle Alpi occidentali. L’emigrazione divenne quindi un elemento fondamentale per
integrare il reddito agricolo e giunse a toccare il 10% dell’intera popolazione (circa 6000 persone).
Tra gli stagionali erano rappresentati i mestieri più diversi: spazzacamini, maestri di legno,
muratori. Gli abitanti di Gressoney, per esempio, approfittando della conoscenza del tedesco,
scendevano nelle pianure elvetiche e germaniche ad esercitare il mestiere di ambulanti, mentre
quelli della Valgrisanche svolgevano attività analoga in Francia e nelle Fiandre. Gli emigranti di
Courmayer erano invece richiesti a Milano e in Piemonte come cardatori di canapa.
Solo verso la metà del Settecento l’economia valdostana si riprese. Allevamento e agricoltura
continuarono però ad essere la principale risorsa del paese. Il primo nel 1734 contava 42000
bovini e oltre 100 000 capre, a fronte di una popolazione di circa 60000 persone. Il numero delle
bestie tuttavia diminuì in seguito all’applicazione dell’Edit des bois, che proibiva il pascolo nelle
foreste, così che alla fine del secolo il totale era sotto le 100 000 unità.
Oltre al bestiame adulto e al formaggio (richiesto in Piemonte), si esportavano prodotti
dell’artigianato e agricoli, come noci, mandorle , vino, soprattutto verso il Vallese e la Tarantaise.
La viticoltura infatti ebbe un notevole sviluppo. Il miglioramento dell’agricoltura fu però favorito
dalla coltivazione del mais e della patata. Il primo, già presente in valle nel 1555, si diffuse solo nel
XVIII secolo; quanto alla patata, una volta sfatate le prevenzioni al suo riguardo, divenne la cultura
privilegiata, perché consentiva la rotazione triennale dei campi.
Al pari del Piemonte anche i vicini territori transalpini subirono importanti trasformazioni in
seguito alla definizione dei confini tra Francia e stato sabaudo avvenuta con la pace di Utrecht del
1713. In particolare il Delfinato, pur essendo una realtà frontaliera, aveva avuto fino alla fine del
Seicento uno scarso valore difensivo, testimoniato dalla presenza di una sola fortezza di rilievo:
Fort Barraux. Dopo il trattato di Cherasco del 1631 la frontiera si era infatti spostata e la chiave
della difesa delle Alpi era diventata Pinerolo.
Con la perdita della città e ancor più delle valli piemontesi, il Delfinato si trovò improvvisamente
proiettato in prima linea e tale situazione ebbe notevoli conseguenze sullo sviluppo della regione.
Grenoble acquistò importanza come base logistica e in generale lo spostamento indietro della
frontiera franco-piemontese fece sì che molti centri, che nel XVII secolo erano stati soltanto tappe
di spostamento dell’esercito, diventarono sede di guarnigioni permanenti. La presenza di truppe
stanziali si trasformò in un fattore di espansione economica, fornendo uno sbocco maggiore ai
mercati cittadini.
Il diverso ruolo strategico assunto dalla provincia, determinò a partire dagli anni novanta del
Seicento l’intensificazione dell’attività di fortificazione, che raggiunse le sue massime espressioni a
Briançon e Montdauphin. La prima fu trasformata in un grande insieme di opere fortificate, a
difesa del Monginevro, circondato da 90 chilometri di strade militari. Dal 1692 al 1700 vi lavorò
assiduamente Vauban e dopo il 1713 costituì il baluardo difensivo del Delfinato. Fondamentale fu
l’intervento lungo l’intero arco alpino occidentale del grande architetto, il quale operò anche a
Fort S.Vincent, Seynes les Alpes, Entrevaux e Colmes les Alpes in Alta Provenza, oltre che a
Chateau Queyras, Fort Mutin in Val Chisone, Pinerolo ed Embrun.
In genere tra XVII e XVIII secolo aumentò il numero dei centri che potevano vantare l’appellativo
di «città». Accanto alle tradizionali 10 villes , si aggiunsero altre realtà come Bourgoin, Le Pont-deBeauvoisin, Saint Marcelin, Saint-Paul-Trois-Chateaux. Questo fenomeno avvenne in un contesto
demografico che vide una debole crescita tra 1698 e 1763 (dal 4 al 5%), seguita da una grande
accelerazione fino al 1790. (più 26%).
Grenoble nel periodo 1698-1790 passò da 132 a 176 mila residenti, Gap da 78 a 95 mila, Romans
da 72 a 108 mila, Vienne da 114 a 183 mila. Nel suo complesso il Delfinato crebbe da 527 a 766
mila abitanti. Certo, le città nel complesso rimasero di piccole dimensioni, visto che all’indomani
della Rivoluzione soltanto cinque avevano una popolazione che superava le 5000 unità. A questa
situazione corrispondeva una dispersione sul territorio degli uffici amministrativi, anche se gli
organi più importanti continuarono ad essere localizzati nelle stesse città che da 200 anni
dominavano la vita della provincia. Così per esempio proseguì la lotta tra Valence e Grenoble per
ottenere il primato come sede universitaria. Il capoluogo alla fine scelse di diventare una città che
ospitava corsi di specializzazione, soprattutto in discipline giuridiche, paramediche e tecniche.
Dal punto di vista sociale il Delfinato, come la vicina Savoia, conobbe una ripresa nobiliare.
Grenoble divenne una città «a sangue blu»: a inizio ‘700 vi risiedevano 200 famiglie nobili (circa un
migliaio di persone), che a fine secolo erano diventate 300, pari a quasi la metà della nobiltà
dell’intera regione. Nella capitale tra 5 e 6% degli abitanti era costituita da membri
dell’aristocrazia, che altrove era dispersa sul territorio.
Il clero rappresentava una percentuale modesta; quello regolare era aumentato nel corso del
Seicento (le monache soprattutto costituivano più del 50% del totale), ma a partire dal secondo
Settecento ebbe un declino. Ufficiali e burocrati erano concentrati nelle tre città «amministrative»
(Grenoble, Valence e Vienne), mentre gli artigiani erano presenti ovunque, ma solo nei centri più
importanti raggiungevano alte concentrazioni, superando la metà della popolazione.
Anche se era stato in qualche modo risolto d’autorità dal governo centrale, il problema della
ripartizione delle tasse tra le città e le campagne continuò ad esistere e causò nel 1694 un
intervento dello stato, che decretò un’imposizione basata su nuovi calcoli. Solo nel 1790 però, in
piena epoca rivoluzionaria, fu varato un sistema che senza essere un’imposta realmente
proporzionata, permise di affrontare con un’approssimazione accettabile la questione della
ripartizione della ricchezza tra le comunità e di proporre una gerarchia delle città e dei grossi
borghi.
Ad aumentare la ricchezza non contribuì molto
l’industria, che pur offrendo diverse
opportunità, non superò i livelli di sviluppo raggiunti alla fine del Seicento. Anzi, il comparto
incontrò notevoli difficoltà nella prima metà del Settecento, trovando solo in seguito altri sbocchi
grazie a produzioni nuovi come la maglieria, i tessuti di seta e le telerie. Nel 1730 nella manifattura
erano impegnate 26000 persone, pari al 4,5% della popolazione complessiva. Molti erano gli
artigiani, ma non esistevano organizzazioni di mestiere.
A partire invece dai decenni centrali del XVIII secolo l’intervento dello Stato in economia
aumentò, secondo una visione ancora tardo mercantilistica, aperta però alle idee illuministe, che
sostenevano il liberismo economico. Il governo centrale promosse così un’effettiva politica
economica di espansione. Grazie alla trasformazione del sistema industriale e alla creazione di
un’organizzazione corporativa, si svilupparono nuovi settori (dal 1766 tele di cotone e tessuti
indiani), mentre altri progredirono (dal 1750 le telerie e le manifatture di seta; dal 1770 la
metallurgia). Notevoli furono i progressi tecnologici, con l’introduzione di nuove macchine; ci fu
anche un cambiamento nella localizzazione delle industrie, che si concentrarono intorno a un
centro in particolare: è il caso di Grenoble per la produzione dei guanti, del Grésivaudan (specie
Allevard) per la metallurgia, di Voiron per le telerie, mentre città come Gap e Briançon divennero
poli industriali.
Al contrario, il settore delle comunicazioni rimase piuttosto arretrato. La struttura stradale non
subì alcuna trasformazione significativa fino all’inizio del Settecento e i percorsi fluviali restarono i
più facili e frequentati. Alla fine del secolo XVIII esistevano ancora poche strade pavimentate e in
definitiva si può dire che, malgrado le opere realizzate, il Delfinato rimase una provincia a scarsa
densità viaria. Ci fu tuttavia uno sforzo per migliorare quelle esistenti, rendendole carrozzabili,
che portò all’aumento del traffico e dell’uso dei carri, che progressivamente sostituirono nel
trasporto i muli, i cavalli e gli uomini.
Un fenomeno che comunque interessò positivamente la regione fu la diffusione
dell’alfabetizzazione, anche se con notevoli differenze tra le diverse zone. Alla fine del Seicento nel
basso Delfinato l’80-85% della popolazione era illetterato, mentre nell’alto Delfinato il livello degli
alfabeti era piuttosto alto. Qui ci fu uno stretto legame tra alfabetizzazione e scolarizzazione;
infatti in quest’area vi era una maggiore presenza di scuole e maestri elementari.
Lo sviluppo economico, sebbene concentrato soprattutto nel polo marsigliese, fu invece
l’elemento che nel XVIII secolo connotò le vicende della Provenza, la quale riuscì a superare le
conseguenze della lunga congiuntura bellica tra Sei e Settecento, determinata dalla politica di
potenza di Luigi XIV. Il suo ruolo militare e strategico di sentinella di Genova e del ducato
sabaudo, la mise a rischio di invasioni come quella del 1692 da parte del duca Vittorio Amedeo II e
di continui passaggi di truppe.
Marsiglia, tuttavia, concentrò sempre di più i traffici e le grandi operazioni commerciali,
specializzandosi negli scambi col vicino Oriente. Si trattò a lungo di un commercio d’importazione,
pagato prima in denaro, poi via, via, con manufatti prodotti in Francia e Provenza. Oltre al Levante,
gli armatori e i mercanti marsigliesi (circa 300) guardavano ormai all’Atlantico e al mare del Nord,
puntando anche alle Antille e all’America. Alla morte del re Sole (1715) la città non era più soltanto
un porto mediterraneo, ma era orientata già verso il Nuovo Mondo.
Tale espansione aveva un corrispettivo nella crescita demografica: quasi 89 000 abitanti nel
1716, con un aumento che non aveva riscontri nelle altre città della regione. L’andamento
demografico in Provenza fu caratterizzato da fasi alterne: un periodo di declino nel primo terzo del
Settecento, marcato drammaticamente dalla peste del 1720 e una ripresa nella seconda metà,
che raggiunse i livelli del secolo precedente e a volte li superò. La capitale sembra rappresentare
un esempio perfetto di questa evoluzione e nel 1765 contava una popolazione di 90 000 individui,
dopo averne persi 50 000 nell’epidemia.
Nel XVIII secolo , più ancora che in passato, la Provenza mostrò due facce: da una parte una
regione rurale e popolosa, dall’altra una città, Marsiglia, che deteneva senza dubbio il primato per
il numero di abitanti, ma che rappresentava se non proprio un corpo estraneo, almeno un modello
di vita completamente differente, grazie alla sua economia portuale. Nel corso degli anni tuttavia
il divario economico e culturale si assottigliò, non soltanto con il resto della provincia, bensì con il
resto del regno.
L’orbita di attrazione marsigliese si allargò e tra i negozianti che affollavano le strade e i palazzi
della città gli stranieri sono numerosi. Provengono non solo da Parigi, Bordeaux, Rouen o Reims,
ma anche da Genova e Ginevra. Ma erano anche rappresentati la Francia del sud-est, la Valle del
Rodano, tutto l’arco alpino. Tra i centri che inviavano il più grande numero di mercanti c’erano
Lione e Grenoble. Le industrie provenzali e marsigliesi nella loro diversificazione, organizzazione ed
evoluzione ben rappresentavano questa dialettica tra la metropoli e il suo territorio.
3.La crisi dell’antico regime e la stagione rivoluzionaria.
Le riforme settecentesche crearono nei domini sabaudi le premesse per una transizione socioeconomica, destinata a trasformare le strutture tradizionali dell’Antico Regime in un sistema di
relazioni più moderne. A dire il vero la grande spinta riformatrice nell’ultimo quarto del secolo si
era affievolita, anche se il regno di Vittorio Amedeo III (1773-1796) si era aperto con la
promulgazione della legge dei Pubblici del 1775, che completava la riorganizzazione delle
comunità iniziata quattro anni prima.
L’uscita di scena di Bogino e l’avvento di ministri che erano espressione della vecchia
aristocrazia più che della nobiltà degli uffici protagonista delle riforme, impressero alla politica
sabauda un indirizzo conservatore, che puntava ad un politica di potenziamento militare sul
modello prussiano e ad un rigido controllo dell’economia e della società. Nonostante i tentativi di
riattivare i meccanismi virtuosi del «dispotismo illuminato», in cui però era il sovrano e non i corpi
burocratici a promuovere le riforme, alla fine degli anni ottanta nello stato sabaudo erano
maturate forti tensioni sociali, che avevano radici profonde e lontane.
In primo luogo vi era la riforma delle comunità, che aveva fatto nascere aspri contrasti tra
patriziati urbani e nuove élites professionali, che aspiravano a partecipare alla vita politica. Poi la
trasformazione dei rapporti di produzione nelle campagne, seguita al mutamento nella
distribuzione della proprietà, che aveva danneggiato i piccoli e medi proprietari a favore della
grande affittanza. Questa situazione aveva fatto aumentare gradatamente la conflittualità tra i vari
ceti sociali e reso più permeabili i domini sabaudi alla recezione delle idee libertarie ed egualitarie.
In questa situazione la rivoluzione francese svolse la funzione di catalizzatore, anche se le sue
conseguenze sul piano politico e sociale si fecero sentire in modo durevole soltanto a partire dal
1798.
Fino a quel momento, specie nel corso della «Guerra delle Alpi» tra 1792 e 1796, il Piemonte fu
contraddistinto da una serie di sommosse, che a volte furono semplicemente causate dalla crisi
annonaria provocata dalla congiuntura bellica, ma che in qualche caso assunsero consapevolezza
politica e vennero dirette da gruppi di «giacobini» piemontesi, come accadde nelle esperienze
repubblicane tentate ad Alba e Asti. Questi sussulti insurrezionali furono repressi dal governo
sabaudo, che tuttavia dovette firmare nel 1796 la pace di Cherasco ed accettare due anni dopo
l’ultimatum francese, che imponeva la consegna della cittadella di Torino e che in pratica costrinse
i Savoia a prendere la strada dell’esilio in Sardegna.
Si formò allora un primo governo provvisorio, che restò in carica soltanto un anno e che era
composto da elementi moderati, espressione di una concezione politica ancora settecentesca ed
elementi democratici reclutati nelle periferie. Benchè il principale problema da affrontare fossero
le finanze dissestate dalla guerra contro la Francia, esso si impegnò in tutti i settori, emanando
provvedimenti innovativi come l’abolizione dei titoli nobiliari, dei diritti feudali e dei privilegi della
Chiesa, l’eguaglianza giuridica delle minoranze religiose, l’imposizione di una tassa patrimoniale.
Presto però nacque un’incompatibilità tra l’atteggiamento governativo, che mirava a creare
un’entità statuale autonoma sul modello delle coeve repubbliche italiane e a tutelare le risorse del
paese, e la volontà centralizzatrice degli occupanti francesi. Tale contrasto portò ad una crisi
politica, che il governo cercò di scongiurare, chiedendo l’unione del Piemonte alla Francia, che
tuttavia per il momento non venne accolta dal Direttorio. Nella prima metà del 1799 scoppiarono
molti tumulti, provocati dalle requisizioni operate dalle truppe di occupazione e da un diffuso
malcontento verso l’annessione.
Parigi affidò allora il potere ad un commissario espressamente nominato, il quale estese ai
territori subalpini l’ordinamento amministrativo francese. Vennero creati quattro Dipartimenti e in
particolare la regione alpina occidentale fu divisa tra il Dipartimento dell’Eridano (Torino, Susa,
Pinerolo, Valle d’Aosta) e quello della Stura (Mondovì, Saluzzo, Cuneo, Alba, Oneglia).
La diffusione delle rivolte, guidate soprattutto da ex ufficiali dell’esercito sardo e da preti, ma
pure da semplici avventurieri, contribuirono alla cacciata dei francesi insieme all’intervento degli
alleati austro-russi, che tra 1799 e 1800 instaurarono un regime effimero, che si mise in luce
soltanto per la dura persecuzione nei confronti degli elementi ritenuti giacobini.
Ben più significativa si dimostrò l’esperienza del secondo governo provvisorio, insediatosi dopo
la decisiva vittoria di Napoleone a Marengo nel maggio 1800. Per far fronte al deficit e alla crescita
dell’inflazione, venne intrapresa la vendita dei beni nazionali, mentre nel 1801 furono inviati nelle
provincie speciali commissari, i quali di fatto sostituirono la figura dell’intendente. L’anno
seguente vennero poi nominati i prefetti e i sottoprefetti, con il compito di fungere da controllori
delle periferie, ma anche da anello di collegamento tra queste ultime e il centro. La creazione di
tali funzionari segnò in pratica l’omologazione del Piemonte al sistema amministrativo francese,
precedendo l’annessione, sancita formalmente alla fine del 1802 con un editto firmato dal console
a vita Napoleone Bonaparte, che di fatto era ormai il padrone della Francia.
Nonostante ciò, anche nei primi anni del XIX secolo continuarono le sommosse.
Il fenomeno
delle insorgenze antifrancesi fu comune ad altre regioni italiane e nei domini sabaudi fu
particolarmente intenso. Si trattò di episodi armati che sono stati spesso ed erroneamente confusi
con il brigantaggio vero e proprio, ma che nascevano dall’avversione verso gli abusi compiuti dalle
truppe di occupazione. Ancora nel 1801-1802 scoppiarono rivolte a Ivrea ed Aosta, che nella valle
arrivarono a coinvolgere più di 6000 insorti.
In Savoia il tramonto dell’Antico Regime fu caratterizzato da importanti mutamenti che
interessarono l’agricoltura, dove la diffusione della patata modificò le condizioni di vita dei
contadini, specie in montagna. Attestata a Thonon nel 1725 e ad Annecy nel 1742, la coltivazione
si estese poi in Tarantaise e Maurienne, e dopo la crisi agraria del 1765-72 divenne una coltura
comune, la cui affermazione fu dovuta al fatto che consentiva la rotazione annuale. Più lenta fu la
progressione del mais, che prima venne usato come cibo per il bestiame, mentre dagli anni ottanta
entrò a far parte anche dell’alimentazione delle popolazioni. L’erba medica e le piante foraggiere
continuarono ad essere poco coltivate. Qualche progresso fece la cultura agronomica: nel 1772 fu
fondata la Società d’Agricoltura di Chambéry, riconosciuta dal governo nel 1774.
Il governo sabaudo, la cui azione come abbiamo visto era volta a incrementare il commercio, si
sforzò di aumentare il controllo delle vie d’accesso alla Francia e alla Svizzera, migliorando le
comunicazioni est-ovest dal Moncenisio a Pont-de-Beauvoisin verso Lione e nord-sud da Ginevra a
Grenoble verso il Mediterraneo. Di notevole importanza fu il tentativo di creare sul lago Lemano
ma in territorio sabaudo, una zona «franca» in alternativa a Ginevra, che ne potesse in qualche
modo intercettare il flusso commerciale.
Nacque così nel 1772 la città di Carouge, la cui fondazione si basò su criteri quali la tolleranza
religiosa e le agevolazioni doganali, al fine di favorire lo sviluppo demografico e l’insediamento di
attività industriali e mercantili. In effetti, la popolazione in pochi anni crebbe: si passò così dai 568
abitanti del 1772 ai 4672 del 1792, ma non fu mai possibile riuscire a competere sul piano
economico con Ginevra.
Il volgere del secolo fu contraddistinto da una crisi congiunturale, aperta da una serie di carestie
tra 1783 e 1790. A rendere difficile la situazione economica e sociale si sommarono diversi fattori:
calamità naturali e l’aumento della tassazione causato dal processo di affrancamento dei feudi. La
conseguente vendita dei beni collettivi favorì i ceti possidenti e indebolì le comunità, la cui
l’autonomia venne inoltre pesantemente condizionata dalla riforma dei comuni varata a livello
centrale nel 1771.
L’aristocrazia mantenne il suo potere, anzi il ceto nobile si chiuse, tanto che nel Settecento ci
furono meno nobilitazioni (57) rispetto ai due secoli precedenti. La borghesia continuò ad avere il
monopolio delle cariche in magistratura, ma si accentuarono i contrasti con la nobiltà, che
conservava il culto del rango e della tradizione. Nonostante le differenze, l’èlite dirigente locale si
trovò accomunata nella difesa del particolarismo savoiardo e nell’ostilità verso la presenza delle
guarnigioni piemontesi di presidio, considerate espressione del regime poliziesco della corte di
Torino.
Tale malcontento costituì un terreno fertile su cui attecchirono le nuove idee, che trovavano
maggior spazio rispetto al Piemonte conservatore governato da Vittorio Amedeo III. In realtà, la
cultura dei Lumi si era già diffusa da tempo in Savoia, come testimoniano i libri presenti nelle
biblioteche dei ceti medio-alti. Tra il terzo e quarto decennio del Settecento nella regione venne
introdotta la Massoneria e la prima loggia si costituì a Chambéry nel 1749. Tra gli adepti numerosi
furono da subito i borghesi e i nobili, che alla vigilia della Rivoluzione rappresentavano il 30% degli
affiliati.
I fermenti rivoluzionari ebbero larga diffusione a partire dall’estate 1789. Aumentarono i tumulti
popolari e le critiche alla monarchia. Nelle campagne si creò un movimento per l’abolizione o
almeno la riduzione delle decime e dei diritti signorili. Quando nel 1792 scoppiò la guerra contro la
Francia da parte di una coalizione di stati europei, a cui aveva aderito anche il Regno sardo, le
truppe francesi occuparono la Savoia, venendo bene accolte dalla popolazione.
Nelle città si formarono società degli Amici della libertà, legate al club dei giacobini di Parigi.
Nell’ottobre 1792 si tenne a Chambéry l’Assemblea nazionale degli Allobrogi, che decise di
chiedere l’annessione alla Francia. La richiesta fu accolta dalla Convenzione, che creò
appositamente il Dipartimento del Monte Bianco. Il nuovo regime ebbe l’appoggio soprattutto dei
ricchi e degli uomini di legge, e di una parte della nobiltà di toga. Aderì anche qualche feudatario,
come il barone di Blonay, che divenne sindaco di Evian e il conte di Viry. La maggioranza dei nobili
tuttavia rimase fieramente ostile alla rivoluzione, così come la Chiesa locale, contraria alla
Costituzione civile del clero e all’obbligo del giuramento per i preti.
Anche i contadini furono avversi al governo francese, contestandone la politica religiosa, il
rigido fiscalismo e l’istituzione della leva obbligatoria. Nell’aprile 1793 scoppiò una vasta
sommossa nel Faucigny, che nonostante la pronta repressione, continuò a covare per anni.
Secondo gli studi più recenti la protesta, più che avere carattere filo-nobiliare o filo-clericale, come
le insorgenze che negli anni novanta caratterizzarono altrove la resistenza agli eserciti
rivoluzionari, fu un movimento anti-borghese, delle campagne contro le città. L’opposizione dei
contadini alla dittatura giacobina, non esprimeva quindi che la loro ancestrale diffidenza verso i
notabili.
Comunque sia, la situazione in Savoia rimase incerta fino al 1799, quando venne respinto un
tentativo di riconquista sabauda. In quegli anni la provincia fu minata dalle divisioni e dagli
interessi municipali, sorti soprattutto fra Chambéry ed Annecy. Quest’ultima sperò di essere
compresa nel nuovo dipartimento del Lemano, che comprendeva Ginevra e altri importanti centri
finanziari e mercantili, ma non riuscì nell’intento, a causa dell’ostruzionismo di Chambéry. Il
regime rivoluzionario dal canto suo favorì la formazione di un nuovo ceto di ricchi, costituito da
contadini possidenti, proprietari terrieri, professionisti (uomini di legge, notai).
Nella Valle d’Aosta gli ultimi decenni del XVIII secolo coincisero invece con la fine dei privilegi
locali e la completa omologazione con il resto dei domini sabaudi. Dal 1773 vi venne insediato un
abile intendente, il savoiardo Vignet des Etoles, il quale imbevuto degli ideali del riformismo
settecentesco, si impegnò a migliorare la situazione della regione, consapevole del delicato
momento di passaggio da un’amministrazione autonoma ad un sistema centralizzato.
Per oltre un ventennio, alla guida della Royale Délégation , organo esecutivo creato nel 1764 che
in pratica aveva sostituito il Conseil dea Commis, l’intendente portò avanti un’azione di ampio
respiro, occupandosi di pascoli, foreste, acque e vie di comunicazione. A lui si deve la sistemazione
della strada reale tra Pont-Saint-Martin e il capoluogo, nonché l’abolizione dei pedaggi che
gravavano sulle merci in transito.
Il processo di modernizzazione non fu tuttavia privo di contraddizioni e generò forti tensioni
all’interno della società valligiana, che furono prontamente registrate da Jean-Baptiste de Tillier.
Per quarant’anni segretario del Conseil des Commis, de Tillier nelle sue opere difese in modo
lucido e documentato il particolarismo autonomistico della valle, ribadendo ancor più nettamente
su un versante laico e civile la teoria dell’intramontanismo, già sostenuta in precedenza da
monsignor Bailly.
Grazie all’impegno di quest’ultimo la Chiesa aostana aveva conosciuto una grande espansione,
così che il Settecento segnò la piena realizzazione della Controriforma. La regione infatti si coprì di
nuove chiese e cappelle, arricchite da sfarzosi altari barocchi, lignei e marmorei. Nuovo impulso
venne dato alle confraternite e agli ordini religiosi, grazie anche all’attività di Pierre-François de
Sales, pronipote di san Francesco di Sales, vescovo di Aosta dal 1741, il quale si occupò in modo
particolare dell’organizzazione delle scuole rurali, di cui si è già parlato.
Un esempio dei contrasti che accompagnarono l’affermarsi dello Stato moderno è costituito
dalle vicende legate alla prima industrializzazione della valle, che si manifestò nel settore della
metallurgia. I boschi valdostani vennero sfruttati in modo selvaggio e ci furono aspri scontri tra gli
imprenditori (indigeni e non) e le rappresentanze locali. Il processo industriale ebbe un notevole
costo ambientale, non solo a causa dello sfruttamento intensivo delle foreste, al quale si tentò
invano di porre rimedio con l’Edit des bois del 1757, bensì della lotta per l’accaparramento delle
acque e dell’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni di fumi dai forni.
Allo scoppio del conflitto tra la Francia rivoluzionaria e il Regno di Sardegna nel 1792, Aosta era
diventata il rifugio di molti esuli che fuggivano dalla Savoia occupata. Durante la Guerra delle Alpi
costituì inoltre il baluardo contro l’invasione del Piemonte da parte delle truppe transalpine. Al
riaccendersi delle ostilità nel 1798, fu velocemente conquistata dai francesi, che crearono un
governo repubblicano, sostenuto da esponenti della borghesia, ufficiali e studenti, venuti in
contatto con le idee d’oltralpe.
La maggior parte della popolazione, soprattutto rurale, rimase ostile alla Francia, a causa delle
requisizioni operate dei soldati, la coscrizione obbligatoria e le violenze contro i beni ecclesiastici.
Tale avversione si tramutò in aperta rivolta nel 1799, che fu una vera e propria controrivoluzione
reazionaria e clericale, che si può collegare con il parallelo fenomeno delle insorgenze nella
penisola italiana. L’insurrezione fu condotta da una massa di contadini che risalirono la Valle e che
fu denominata Régiment de Socques per i sabots da loro calzati.
. Nel Delfinato la diffusione della rivoluzione fu piuttosto veloce e il confronto politico che essa
innescò assunse subito toni molto accesi, in quanto si legò alla questione della preminenza
economica ed amministrativa delle antiche «dieci città» sul resto della regione. Fino alla metà del
Seicento, infatti, i principali centri urbani avevano trovato negli Stati e nelle altre assemblee
provinciali gli ambiti istituzionali per formulare le loro istanze politiche.
Nel Settecento la scomparsa delle assemblee provinciali privò le città della cornice istituzionale
nella quale avevano potuto assicurare la difesa dei loro interessi. A più riprese esse cercarono di
coordinare le loro iniziative, ma l’azione comune risultò difficile e sempre più spesso fu la capitale
Grenoble ad agire da sola in nome di tutte le altre.
Tale unità di intenti venne però meno con la Rivoluzione e la possibilità di una nuova
organizzazione dello spazio amministrativo favorì la nascita di profonde divisioni, rinfocolando la
vecchia rivalità tra Valence e Grenoble, mentre Vienne sperava di ristabilire il grande passato,
quando era stata capitale della Gallia. Grenoble inoltre era contraria alla separazione in
dipartimenti, ma le altre città invece la sostenevano. Così nel 1790 furono costituiti tre
dipartimenti: Nord-Dauphiné (con capoluogo Grenoble), Midy (Valence) e le Alpes (Gap) divisi in
distretti. L’obiettivo dei promotori di tale sistema era più politico che tecnico: si trattava di
stabilire un modo nuovo di abbattere i privilegi provinciali e soprattutto quelli delle grandi città,
che avevano segnato per secoli la storia del Delfinato.
A Nizza il vento della Rivoluzione fu preceduto tra 1788 e 1792 da una crisi economica, che
evidenziò ancora una volta la precarietà della strutture socio-economiche della contea. Nei primi
anni del moto rivoluzionario la città divenne rifugio di oltre 2000 emigrati francesi (preti e nobili) e
nel 1792 venne occupate dalle truppe francesi, che tuttavia non riuscirono a sfondare la linea
difensiva organizzata dai contingenti sabaudi sulle Alpi.
Il governo provvisorio fu subito diviso, come del resto avverrà in Piemonte, tra gli autonomisti,
favorevoli alla creazione di una repubblica alleata della Francia e quelli favorevoli all’annessione
immediata. Questi ultimi vinsero e nel 1793 venne creato il Dipartimento delle Alpi Marittime, che
seguì le vicende del regime giacobino e del Direttorio. Nella regione fu abolita la feudalità e
introdotta le legislazione transalpina; inoltre venne decisa la vendita dei beni diventati nazionali in
seguito al sequestro delle proprietà ecclesiastiche e nobiliari.
4. L’ordinamento napoleonico e la restaurazione.
L’avvento del regime napoleonico segnò la fine del sistema difensivo alpino realizzato dai Savoia
nel corso di tre secoli. Il condottiero corso riuscì in realtà a eludere lo sbarramento e a penetrare
ugualmente in Piemonte con un’audace attraversata del Piccolo San Barnardo, ma il dispetto
causato dalla resistenza di Bard nel 1800 e considerazioni di ordine politico oltre che strategico, lo
indussero a perseguire un’opera di distruzione sistematica, che era già stata progettata da Luigi
XIV alla fine del Seicento.
Napoleone completò quanto era stato deciso nel trattato di pace di Parigi del 1796, che aveva
fatto seguito alla sconfitta sabauda nella «guerra delle Alpi», ordinando la completa demolizione
delle fortificazioni piemontesi. L’operazione di smantellamento era in effetti iniziata già nel 1798 e
nel giro di pochi anni tutte le principali fortezze alpine furono rase al suolo.
L’unica a salvarsi fu Fenestrelle, che fu risparmiata perché ritenuta utile come deposito di armi e
munizioni, nonché come prigione di Stato. Alcune fortezze vennero ricostruite all’epoca della
Restaurazione: è il caso di Exilles a partire dal 1818 e di Bard dal 1827. Furono smantellate anche
le fortezze cittadine, come accadde a Cuneo e alla stessa Torino, che così soltanto all’inizio
dell’Ottocento perse l’aspetto di città murata.
Con l’annessione alla Francia, il Piemonte divenne la ventisettesima divisione militare, divisa in
sei Dipartimenti: Po, Marengo, Tanaro, Sesia, Stura, Dora, i cui capoluoghi furono rispettivamente
Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, Cuneo, Aosta. I dipartimenti corrispondevano ad altrettante
prefetture, ulteriormente suddivise in sottoprefetture o arrondissements. I funzionari messi a
dirigere le nuove amministrazioni, scelti in base alla lealtà verso il governo parigino, erano in parte
uomini nuovi e in parte membri della nobiltà disposti a collaborare.
Si trattava di un sistema piramidale, in cui l’autorità discendeva direttamente dal vertice e si
allargava via, via, ai diversi organi periferici. La struttura verticistica proseguiva con le
amministrazioni comunali, affidate ad un sindaco (maire) e a uno o più vicesindaci, coadiuvati da
un organo collegiale, il Consiglio municipale.
Tutti francesi furono invece i commissari inviati da Parigi per riorganizzare i diversi settori
dell’amministrazione, modellandoli secondo l’assetto transalpino. La réunion fu dunque preparata
scrupolosamente, riformando, assumendo informazioni ed estendendo al Piemonte leggi francesi,
come la leva obbligatoria, che per altro venne fortemente avversata dalla popolazione. In realtà, la
perfetta equiparazione tra i due paesi non si realizzò subito e il processo fu piuttosto lungo, ma il
governo francese, specialmente dopo che Napoleone divenne imperatore, portò avanti una
politica tesa al coinvolgimento dei ceti dell’alta borghesia e dell’aristocrazia anche attraverso il
conferimento di nuovi onori e titoli come ad esempio la Legion d’Onore.
A partire dal 1806 furono creati i nobili dell’impero e il processo di costituzione di una nobiltà
imperiale si accelerò nel 1808, quando il governo del Piemonte fu affidato al principe Camillo
Borghese, marito di Paolina Bonaparte. Con lui a Torino venne organizzata una corte, che in
qualche modo intendeva ricalcare la tradizione di quella sabauda, attirando l’antica nobiltà fedele
ai Savoia e guadagnandone il sostegno.
Una testimonianza del grado di consenso raggiunto dal governo, si ebbe allorché le fortune
francesi declinarono in seguito alle prime sconfitte delle armate Napoleoniche dopo il 1812. Tra
coloro che in quel frangente offrirono aiuto finanziario alla Francia ci furono nobili di antico
lignaggio come i Luserna e i Solaro, ma anche avvocati, giudici, funzionari, banchieri, che
rappresentavano lo zoccolo duro del regime, dimostrando altresì il successo della politica di
amalgama sociale che esso aveva perseguito.
In questo senso va anche intesa la riforma elettorale, che pur essendo su base censitaria ed
esclusivamente maschile, portò nel 1803 alle prime elezioni, indette per nominare gli organi
consultivi periferici. Esse costituirono in ogni caso un’importante esperienza, che contribuì a
sensibilizzare i cittadini a una forma embrionale di partecipazione politica. Inoltre, consentirono
l’emergere di ceti nuovi (piccola e media borghesia degli affari, professionisti, funzionari) e a livello
più alto il coinvolgimento di nobili e grandi proprietari terrieri.
L’omologazione sociale procedette pure attraverso la riorganizzazione del sistema giudiziario e
della legislazione civile e penale. I vecchi organsmii sabaudi vennero soppressi, sostituiti da una
struttura accentrata e gerarchizzata che prevedeva vari gradi di giudizio: le preture, i tribunali civili
e penali di prima istanza, una Corte d’appello con sede a Torino, le cui sentenze potevano essere
appellate presso la Corte di Cassazione di Parigi. Infine, tra 1807 e 1810 vennero emanati i vari
codici civili, penali e di commercio che costituirono il famoso Codice napoleonico.
In effetti, molti provvedimenti emanati dal governo francese favorirono proprio i ceti medioalti, a cominciare dalla soppressione degli ordini religiosi ancora esistenti, i cui beni vennero
dichiarati nazionali e messi in vendita. Di particolare importanza fu la riforma dell’istruzione, che
concentrava l’attenzione sull’insegnamento primario, un settore che era stato trascurato dalla
monarchia sabauda. L’intento era quello di creare una scuola elementare pubblica, affidata ai
comuni, seguita da un ciclo di istruzione secondaria, ad indirizzo prevalentemente professionale.
Dopo l’annessione l’interesse governativo, come accadde in Francia, si concentrò sui licei, creati
per l’insegnamento delle lettere e delle scienze e destinati a formare i quadri della classe
dirigente. Tra 1805 e 1806 ne vennero fondati due, a Torino e a Casale Monferrato. Il sistema
scolastico, affidato fin dal 1800 al Consiglio di Istruzione Pubblica, che aveva sostituito il vecchio
Magistrato della Riforma, prevedeva dunque un livello di istruzione primaria, curato dai comuni,
uno secondario gestito da comuni e privati, quindi i licei statali. Nel 1808 fu infine creata
l’Università imperiale.
L’azione del governo francese si attuò in un contesto socio-economico articolato e dagli aspetti a
volte contraddittori. A livello demografico ad esempio il Piemonte aveva conosciuto un
andamento inverso rispetto al resto d’Italia e d’Europa, caratterizzato da una forte crescita nel
primo Settecento, seguita da una stasi, se non addirittura una flessione. Ciò tuttavia non aveva
arrestato l’aumento della popolazione della capitale, che contava tra 65000 e 70000 abitanti,
mentre in totale il Piemonte arrivava circa a 1.600.000.
L’agricoltura era ancora caratterizzata da una forte parcellizzazione fondiaria, più estesa nelle
zone collinose e montagnose. Il paesaggio agrario era piuttosto diversificato: considerando
soltanto l’area occidentale della regione a contatto con la catena alpina, il Dipartimento del Po
presentava molti pascoli (quasi 25% della superficie) e boschi (18%), situati soprattutto nelle valli
di Lanzo, ma anche di Susa e nel Pinerolese. Più a sud nel Dipartimento della Stura esistevano
molti boschi e castagneti (21%) e un’alta percentuale di pascoli e incolti (35%). A nord invece nel
Dipartimento della Dora (Aosta) metà della superficie era occupata da ghiacciai, montagne e
foreste, l’altra metà da pascoli.
Nelle campagne prevaleva la conduzione diretta, la mezzadria (in diminuzione però rispetto al
secolo precedente e sostituita dall’affitto) e soprattutto la «schiavenza», una forma di contratto a
metà tra il lavoro salariato e la colonia parziaria. L’instaurazione del regime transalpino in un
primo tempo comportò l’espansione di alcune coltivazioni, come il riso, il mais e la patata, che
avevano rappresentato un’importante novità dell’agricoltura settecentesca. Dopo il 1805, a causa
del blocco navale contro la Francia, gli sbocchi per i prodotti piemontesi si ridussero, favorendo
comunque la diffusione di nuove colture autarchiche o sperimentali, come ad esempio la
barbabietola, surrogato della canna da zucchero.
L’alienazione dei beni ecclesiastici comportò tuttavia una rivoluzione fondiaria. Dal 1800 al 1814
oltre 3500 acquirenti comprarono beni nazionali per un ammontare di 70 milioni di franchi. Anche
se a beneficiare del provvedimento furono soprattutto i ricchi (nobili, proprietari terrieri,
commercianti e professionisti si accaparrarono il 70% del totale), ci fu comunque un allargamento
dei ceti possidenti, che nelle campagne diede impulso a una lenta trasformazione dei sistemi di
conduzione e dei rapporti di produzione.
Per quanto riguarda l’industria, nel periodo francese incontrarono difficoltà soprattutto i
comparti già radicati nel territorio, come quello serico e laniero, mentre il cotoniero, di più recente
formazione, pose le basi per il decollo ottocentesco. La produzione della seta era andata in crisi fin
dagli anni novanta, poi dopo il 1800 ebbe una breve ripresa, quando l’organzino piemontese fu
destinato a rifornire le manifatture di Lione. Con il blocco continentale la situazione tornò a
peggiorare, tanto che nel 1810 la quantità di seta grezza prodotta si era dimezzata e nel 1811 dei
1200 telai prima esistenti a Torino, ne rimanevano in attività 660.
L’industria laniera affrontò meglio la congiuntura napoleonica, grazie anche all’effetto positivo
delle commesse governative per il rifornimento
dell’esercito. Ad approfittarne furono per
esempio l’azienda Arduino di Pinerolo, che impiegava 1500 operai, i lanifici del Monregalese e
molte piccole imprese sparpagliate nelle valli alpine. La lana piemontese rimaneva però di qualità
mediocre, adatta a produrre panni poco raffinati, anche se comodi e resistenti.
Per risolvere tale problema alcuni imprenditori cercarono di creare allevamenti di pecore
merinos e incroci con le razze indigene, specie con quella biellese, che dava la lana migliore del
Piemonte. L’esperimento riuscì soprattutto alla Società Pastorale della Mandria di Torino, che
utilizzando la lana di tipo merino e ibrido, costituì nel 1802 una moderna manifattura, che venne
posta alla guida del francese Giovanni Paolo Laclaire, il quale divenne il principale artefice del
rinnovamento tecnologico dell’industria torinese. Nel 1805 la società aveva due filatoi a Caselle e
Rivoli, che impiegavano 300 operai. Quanto al settore cotoniero, conobbe una notevole
espansione, grazie specialmente all’impegno di imprenditori ebrei, tra cui si può ricordare il
chierese David Levi.
Il regime napoleonico, che perseguì una politica protezionistica, non fu favorevole al commercio
piemontese, tuttavia il governo francese compì notevoli interventi nel campo della viabilità. Questi
furono dettati tanto da esigenze politiche e strategiche, quanto da motivazioni economiche e
vennero affidati al Corps des Ingenieurs des Ponts et des Chaussées, che entrò in funzione in
Piemonte nel 1802.
L’impegno governativo si concentrò su due importanti strade: quella del Moncenisio e quella del
Monginevro. Nella prima in particolare i lavori durarono dal 1803 al 1806 e costarono 7 milioni di
franchi. Venne realizzata una strada carrozzabile larga almeno 6 metri, lunga 37 chilometri da Susa
a Lanslebourg, che da quel momento costituì la via più agevole tra Francia e Italia. Considerata al
tempo un capolavoro di ingegneria, essa saliva con grandi curve a forte pendenza che
costringevano ad attaccare ulteriori traini di muli alla vetture di maggiore portata. Negli stessi anni
fu ricostruita la strada del Monginevro. Di minore entità, anche se di notevole importanza, fu la
ristrutturazione delle rete viaria che collegava il Piemonte alla Liguria, nelle tratte Acqui-Savona,
Acqui-Genova, Ormea-Oneglia).
Anche nei territori savoiardi, come in quelli subalpini il regime napoleonico puntò a ricostituire
la coesione sociale, dopo la traumatica esperienza rivoluzionaria. Benché in alcune zone di
montagna (Maurienne, alto Faucigny) ci fossero ancora resistenze contro il rigido fiscalismo del
governo e la leva obbligatoria, gli anni del Consolato e dell’Impero furono caratterizzati dall’ordine
dell’ordine e dalla stabilità. Il concordato del 1801 mise fine al conflitto con la Chiesa, mentre
l’organizzazione in dipartimenti (Mont-Blanc e Lemano), con a capo prefetti e sottoprefetti creava
un modello amministrativo, mirante a controllare sia gli elementi radicali, sia i reazionari.
La politica economica puntò soprattutto allo sviluppo delle infrastrutture. Iniziò l’epoca
dell’apertura delle Alpi grazie alla realizzazione di una grande rete viaria. La strada che da Ginevra
andava al Vallese e al Sempione fu resa carrozzabile, al pari di quella da Chambéry a Lione. Come si
è visto lo stesso fu fatto per il Moncenisio, a cui lavorarono 3000 uomini. Nel 1810 transitarono
sulla nuova strada 3500 vetture passeggeri, oltre 14000 veicoli commerciali e più di 13000 muli.
Vennero incentivate le attività industriali, in primo luogo quella estrattiva, grazie anche alla
fondazione della Scuola nazionale mineraria di Moutiers. Ad Annecy fu impiantata una fabbrica di
tessuti di cotone, che nel 1812 contava 700 operai. Il settore cotoniero ebbe un notevole sviluppo,
con l’apertura di nuove manifatture a Rumilly e a Chambéry.
Poiché l’obiettivo principale del governo era l’amalgama delle
élites dirigenti, nelle
amministrazioni venne dato posto ai nativi, per cui nel 1813 due terzi degli impiegati pubblici
provenivano dalla Savoia. Pure l’esercito offrì possibilità di carriera, basti pensare che ben 18
generali della Grand Armée furono savoiardi. Più refrattaria alle lusinghe francesi si dimostrò la
nobiltà, anche se Napoleone cercò di ottenerne il consenso con una politica di restaurazione dei
titoli e di concessione di onori, come avvenne in Piemonte. Comunque sia, nella pratica mondana
e nelle forme di sociabilità si realizzò una fusione tra nobili e ricchi borghesi e uno dei principali
luoghi in cui avvenne tale fenomeno furono le terme di Aix-le-Bains, frequentate anche
dall’imperatore.
L’avvento del regime napoleonico nella vicina Valle d’Aosta coincise nel 1800-1801 con un’altra
rivolta dei contadini, vessati dalle contribuzioni militari e dalle corvées imposte dalle autorità
francesi. La successiva annessione alla Francia comportò una nuova sistemazione territoriale, per
cui l’intera regione entrò a far parte del Dipartimento della Dora. Benché inseriti in un nuovo
sistema amministrativo, i funzionari valdostani rimasero fedeli ai principi di libertà e di rispetto
delle identità collettive presenti nel movimento giacobino, sostenendo l’ideale di una provincia
autonoma all’interno dello Stato francese.
Il ritorno dei Savoia a Torino nel 1814 comportò l’abolizione di gran parte della legislazione
francese, anche se gli elementi fedeli alla Francia vennero epurati soltanto ai livelli più alti
dell’amministrazione. Furono ristabiliti Senati e intendenze, mentre il nuovo governo fu
organizzato sul modello di quello di Antico Regime e affidato a uomini non collusi con il
precedente regime. Il Congresso di Vienna del 1815 ridisegnò i confini dei domini sabaudi: la
Liguria venne annessa al Regno di Sardegna ed alcune terre intorno al lago Lemano furono cedute
a Ginevra.
La volontà del re Vittorio Emanuele I (1802-1821) fu di ripristinare la struttura politicoistituzionale pre-rivoluzionaria, reintroducendo norme che erano state già abolite alla fine del
Settecento, quali i maggiorascati e i fedecommessi. I diritti civili di ebrei e valdesi furono annullati
e fu portato avanti un programma che mirava a risollevare il prestigio sociale ed economico della
nobiltà e della Chiesa, ristabilendo la Compagnia di Gesù e gli Ordini religiosi soppressi. Tutti i
codici napoleonici furono abrogati, ma il restaurato sistema politico-amministrativo-finanziario si
rivelò subito molto confuso e inefficiente.
Ciò risultò evidente quando il regno dovette affrontare la grave crisi economica che colpì non
solo l’Italia, bensì tutta l’Europa nel biennio 1816-17, con conseguenze particolarmente dure per
Savoia e Liguria. Il sovrano fu allora indotto a un cambiamento di rotta, che comportò l’entrata nel
governo di uomini di tendenze moderate, i quali avevano già collaborato con Napoleone, come ad
esempio Prospero Balbo, che fu chiamato a reggere il ministero degli Interni. Costoro cercarono di
favorire un ritorno, sia pur parziale, alla legislazione francese.
Intanto, si stava sviluppando anche in Piemonte il movimento romantico, che avrebbe dato vita
alla formazione delle società segrete, composte non soltanto da aristocratici illuminati, ma anche
da ex-ufficiali e funzionari napoleonici, professionisti, studenti e nuovi possidenti terrieri. A partire
da questi anni fecero la loro comparsa le associazioni degli Adelfi, dei Sublimi Maestri Perfetti, la
Carboneria e i Federati.
Nel contesto subalpino furono soprattutto tre i filoni rappresentati: legittimista filo-cattolico
(guidato dal savoiardo Joseph de Maistre e da Cesare d’Azeglio), laico conservatore (che schierava
intellettuali quali Gian Francesco Galeani Napione, Alessandro Saluzzo, Carlo Botta, la poetessa
Diodata Saluzzo, il barone Vernazza) liberal-costituzionale (formato dagli “alfieriani-foscoliani”
come Silvio Pellico, Ludovico di Breme, i quali operarono specialmente in Lombardia, Cesare Balbo,
Santorre di Santarosa).
Furono proprio questi ultimi che organizzarono i moti del marzo-aprile 1821, inaugurati da una
manifestazione degli studenti universitari nel gennaio precedente. Il governo, che non si era
accorto dei fermenti che covavano nella società piemontese, si dimostrò impreparato a
fronteggiare la crisi e così il re preferì abdicare, lasciando la reggenza al giovane principe Carlo
Alberto di Savoia-Carignano.
Terminata la sua breve e sfortunata esperienza di governo, salì al trono Carlo Felice (1821-31). Il
nuovo monarca, il quale aveva un carattere meno autoritario e militaresco del predecessore,
introdusse moderate riforme con l’intento di sopire le tensioni sociali e chiamò nel governo alcuni
membri di spicco della nobiltà savoiarda (Sallier de La Tour, Roget de Cholex), che aveva
dimostrato grande fedeltà alla dinastia durante l’occupazione francese.
Carlo Felice mostrò nel corso del suo regno maggiore attenzione per i problemi delle periferie,
migliorando in primo luogo la rete stradale. Pur non amando in modo particolare Torino, si
impegnò per abbellirla. Condusse a termine la Chiesa della Gran Madre, restaurò San Lorenzo, San
Filippo e il palazzo dell’Accademia delle Scienze. Aprì Piazza Vittorio e quella che tuttora porta il
suo nome. Uomo colto, acquistò la raccolta di reperti archeologici raccolti in Egitto da Bernardino
Drovetti, destinata a diventare il nucleo originario del Museo Egizio e curò l’inventario delle opere
d’arte esistenti a Palazzo Reale e nelle altre residenze dinastiche, primo passo per la costituzione
nel 1832 della Reale Galleria di Quadri, diventata poi Galleria Sabauda.
Durante gli anni venti, sull’onda della ripresa economica europea, ci fu un certo risveglio anche
dell’economia piemontese, con lo sviluppo di varie iniziative imprenditoriali, sia nell’agricoltura
che nella manifattura. A testimonianza di ciò si può citare la grande Esposizione dei prodotti delle
arti e delle industrie, tenutasi a Torino nel 1829 con la partecipazione di 500 espositori, che fu la
prima di una lunga serie di manifestazioni che ebbero come sede la capitale del Regno.
Al contrario del Piemonte, che a partire dagli anni venti aveva mostrato qualche segno di
risveglio politico ed economico, in Savoia l’età della Restaurazione coincise con quella che gli
storico hanno definito la «società bloccata». Ancor di più che nei domini subalpini, al di là dei
monti l’Antico Regime venne ripristinato nelle sue forme più retrive. Fu costituito un sistema di
governo che si basava sulla censura e sul controllo poliziesco, di cui era espressione il nuovo corpo
dei Carabinieri reali. Le loro stazioni coprivano l’intero territorio savoiardo con una rete di
sorveglianza e di repressione gestita dai comandanti dei presidi locali, quasi tutti di origine
piemontese.
La Savoia non partecipò ai moti del 1821 e Carlo Felice la predilesse, nutrendo molto affetto per
quella che era l’antica culla della dinastia, rifugio di valori ancestrali, ben diversa dal Piemonte
«giacobino». Il sovrano assegnò alla provincia un ruolo particolare all’interno della sua concezione
paternalistica della monarchia. La visitò a più riprese tra 1824 e 1830, accolto sempre da
manifestazioni di omaggio, e si impegnò nel restauro dell’Abazia di Hautecombe, pantheon di Casa
Savoia.
L’economia savoiarda rimase poco sviluppata e continuarono a mancare i capitali per
l’investimento. L’agricoltura era arretrata e il suo stato fu ulteriormente aggravato dalla carestia
del 1817. Il rigido protezionismo applicato dal governo impediva gli scambi e nell’industria, così
che, come si è detto, ci fu l’espansione soltanto del settore cotoniero, nei poli di Chambéry e
Annecy, dove esisteva una manifattura che nel 1816 diventò Manifattura Reale e conobbe un
notevole progresso. Dopo il 1828 venne dotata di tecnologie moderne, grazie all’introduzione
della macchina a vapore e con la filiale situata a Pont Canavese si impose in tutto il mercato del
Regno sardo.
Nonostante la situazione economica meno florida rispetto al Piemonte, l’influenza politica
esercitata dalla Savoia, specie nelle alte sfere del governo, fu più rilevante. Dal punto di vista
demografico ci fu una crescita (oltre 395 000 abitanti nel 1828), ma in percentuale la regione si
mantenne intorno all’11-12% della popolazione dell’intero Regno, come era successo nel
Settecento. Quella che aumentò fu l’importanza relativa assunta dai ceti dirigenti savoiardi.
La nobiltà fu largamente ricompensata della fedeltà mantenuta durante la rivoluzione e
l’Impero. Essa colonizzò le cariche elevate dei ministeri, della diplomazia, dell’esercito e della
corte. Tale egemonia è testimoniata anche dalla presenza nell’entourage del giovane Carlo
Alberto, futuro re di Sardegna, di molti esponenti dell’aristocrazia savoiarda. L’età d’oro della
nobiltà corrispose all’apogeo della potenza della Chiesa, tanto che la Savoia divenne il perfetto
esempio dell’alleanza tra l’ assolutismo e il cattolicesimo, tra il trono e l’altare.
Dopo la ventata atea o agnostica del ventennio francese, nella regione ci fu una vigorosa
rinascita del fervore religioso, che si espresse nel rinnovato entusiasmo per le cerimonie
grandiose, in grado di colpire, come ai tempi della Controriforma, l’immaginazione popolare. Un
esempio di questa sensibilità fu rappresentato nel 1826 dal solenne rito della traslazione ad
Annecy delle reliquie di S.Francesco di Sales e S.Giovanna di Chantal, a cui parteciparono il re, la
corte, 11 prelati e 600 preti.
Il clero continuò ad esercitare un ruolo determinante nella società savoiarda e la carriera
ecclesiastica costituì un mezzo di promozione sociale, specialmente nelle zone rurali. La Savoia
divenne rifugio di congregazioni di ogni genere, con in testa i gesuiti, forti dei due collegi presenti a
Melan e Chambéry. Gli ordini religiosi controllavano l’insegnamento secondario e i loro istituti
raccoglievano 3000 allievi. Numerosi di questi entravano poi in seminario e dal 1820 molti preti e
religiosi cominciarono a partire per evangelizzare terre lontane, tanto che in un secolo si
contarono 800 missionari e 42 vescovi.
In questi anni la carta delle diocesi fu ridisegnata: quella di Chambéry, creata nel 1779 fu eretta
in arcidiocesi nel 1817 ed ebbe Aosta come suffraganea. Tra 1822 e 1825 vennero poi ristabilite
quelle di Annecy, Moutiers e Saint-Jean-de-Maurienne. L’episcopato non veniva reclutato tra i
nobili, ma tra la borghesia, soprattutto di campagna. Spesso i presuli furono uomini colti, animati
da spirito conservatore, ma molto attivi sul piano dell’azione pastorale.
Abbiamo già accennato alla grave situazione dei contadini, periodicamente colpiti da crisi
alimentari. Nonostante la diffusione della patata dopo il 1817, la malnutrizione continuò a
provocare malattie endemiche, come la tubercolosi, il gozzo e il cretinismo, che in certe aree
montane (Faucigny, Maurienne, Tarantaise), raggiunsero livelli piuttosto alti.
Alla pressione demografica e alla povertà si rispose con l’emigrazione. Tale fenomeno era
peculiare della società contadina, ma tra 1815 e 1860 conobbe la fase più massiccia della sua
storia. Fino al XVIII secolo esso si era diretto in genere verso l’Europa del nord e le regioni
mediterranee, ma nella prima metà dell’Ottocento si concentrò sulle grandi città della Francia,
dove andò in genere ad ingrossare le file del proletariato. Parigi e Lione divennero i principali poli
di attrazione. In quasi tutti i villaggi di montagna le partenze furono numerose, raggiungendo
anche un terzo della popolazione. La durata dell’assenza tendeva ad allungarsi rispetto al passato
e in molti casi non ci fu ritorno.
I mestieri in cui erano occupati questi migranti erano diversi, ma tutti piuttosto modesti.
Nell’immaginario collettivo le figure tipiche dell’emigrazione savoiarda erano gli spazzacamini (di
solito ragazzi), originari soprattutto del Faucigny o delle valli interne alpine. A Lione furono
occupati 10 000 savoiardi, in gran parte donne, impiegati specialmente nell’industria della seta.
Ginevra accolse soprattutto muratori , mentre a Parigi verso la metà del XIX secolo abitavano 60
000 savoiardi. Il fenomeno ebbe un ruolo economico fondamentale per la regione, perché le
rimesse degli emigrati assicuravano un importante flusso di denaro contante.
All’interno della chiusa società savoiarda la borghesia rappresentò in questi anni la categoria
sociale più dinamica. In assenza di una classe operaia, di fronte all’immobilismo dei contadini e al
conservatorismo della nobiltà e del clero, essa manifestò una certa coscienza politica, che
conservava i valori sia del riformismo illuminato settecentesco, sia del liberalismo del periodo
francese.
Questo ceto comprendeva soprattutto agricoltori ricchi, membri dei gruppi professionali urbani
(medici, uomini di legge), mentre pochi erano gli esponenti della borghesia degli affari. La cultura
che si sviluppò in questo ambiente era basata sugli interessi in qualche modo tipici della cultura
savoiarda (diritto, storia, medicina, scienze esatte) e trovava espressione nella Società reale
accademica fondata a Chambéry nel 1820. Figure eminenti di tale contesto furono scienziati come
Berthollet, il quale però dal 1815 si trasferì in Francia e il matematico Fredéric Menabrea.
Nella Valle d’Aosta la Restaurazione comportò una rinnovata attenzione per le fortificazioni.
Come in tutto l’arco alpino occidentale, anche qui furono in primo luogo ripristinate le fortezze
demolite dai francesi, come il forte di Bard, ricostruito da Carlo Felice, che diventò una delle più
notevoli opere di architettura militare ottocentesca.
Il ritorno all’Antico Regime non ostacolò tuttavia la reintegrazione nell’amministrazione di
personaggi che avevano collaborato con il governo napoleonico. Anzi, ci fu una sostanziale
continuità della classe dirigente valdostana, per cui sull’esperienza delle innovazioni
settecentesche e dell’epoca imperiale, si formò un notabilato urbano, non nobile, legato allo Stato
e ad una cultura riformistica, che in seguito abbraccerà le ideologie liberali e parteciperà alle lotte
costituzionalistiche . Durante i moti del 1821 infatti anche ad Aosta ci furono manifestazioni a
favore della Costituzione da parte degli studenti del Collegio Saint-Bénin.
Per la contea di Nizza l’instaurazione del regime napoleonico significò la realizzazione di un
sistema amministrativo capace di allentare le tensioni sociali e di ripristinare l’ordine e la sicurezza
pubblica. La corretta amministrazione assicurata dall’ordinamento prefettizio francese non risolse
però le difficoltà economiche. La regione continuò infatti a dipendere dalle importazioni, sia di
generi alimentari, sia di manufatti, anche se poteva contare su una notevole risorsa come il
bestiame (100 000 animali, di cui 40 000 capre).
La politica di francesizzazione portata avanti dal governo non ebbe molto successo e la
popolazione accolse con favore il ritorno dei Savoia. Nel 1814 la contea appariva però ancora una
realtà isolata rispetto al mondo esterno, stretta tra le montagne e la costa. Dopo l’annessione
della Liguria al regno sardo, il territorio nizzardo aumentò la sua estensione, grazie
all’inglobamento di Ventimiglia nel 1816 e nel 1818 Nizza divenne il capoluogo di un’estesa
provincie, che comprendeva anche Oneglia e San Remo.
Gli abitanti della contea erano intanto cresciuti, toccando quota 86000 nel 1811, di cui 62000
residenti fuori Nizza. Il sistema economico continuava ad essere sottosviluppato e caratterizzato
da un’agricoltura arretrata, specialmente nelle aree montagnose. Anzi, l’economia dipendeva
proprio dalla montagna e dai suoi ritmi: i contadini nella bella stagione lasciavano i campi e
raggiungevano gli alpeggi, dove portavano le greggi. Permaneva infatti una struttura per cui
l’agricoltura coesisteva con la pastorizia. Un notevole problema era poi costituito dalle «bandite»,
di cui si è già parlato. Troppo numerose, esse respingevano le colture verso la pianura, facilitando
il disboscamento e il depauperamento delle montagne, tanto che nel 1848 la superficie delle
foreste era ridotta del 17% rispetto al 1789.
Sul litorale invece la situazione era migliore, a causa del clima mite, che consentiva la
coltivazione di ulivi, viti, alberi da frutta, agrumi. L’olio restava il prodotto principale dell’economia
agraria e nel 1841 arrivò a quasi 4000 tonnellate, pari al 45% del bilancio agricolo. Il settore dava
occupazione a 5000 persone, mentre le vigne a metà secolo coprivano 2650 ettari di terra, per una
produzione media di 15000 ettolitri l’anno.
BIBLIOGRAFIA CAPITOLO IX.
D.BALANI, Per terra e per mare. Traffici leciti e illeciti ai confini occidentali dei domini sabaudi (XVIII
secolo), Torino, 2012.
E.BARATIER (dir.), Histoire de la Provence, Toulouse, 1987.
B.BLIGNY (dir.), Histoire du Dauphiné, Toulouse, 1973.
M.BORDES (dir.), Histoire de Nice et de pays niçois, Toulouse, 1976.
M.DOSSETTI, La demografia nelle valli valdesi dal 1686 al 1800, in «Bollettino Storico Bibliografico
Subalpino», LXXIX, 1981, pp.535-602.
R.FAVIER, Les villes du Dauphiné aux XVIIe et XVIIIe siècles, Grenoble 1993.
D.GARIGLIO, M.MINOLA, Le fortezze delle Alpi occidentali. I, Dal Piccolo San Bernardo al
Monginevro, Cuneo, 1994.
D.GARIGLIO, Le sentinelle di pietra. Fortezze e cittadelle del Piemonte sabaudo, Cuneo, 1997.
E.GAROGLIO, F.ZANNONI, La difesa nascosta del Piemonte sabaudo. I sistemi fortificati alpini
(secoli XVI-XVIII), Cuneo, 2011.
T.GATTO CHANU, A.CELI, Storia insolita della Valle d’Aosta, Roma, 2004.
P.GUICHONNET (dir.), Nouvelle Histoire de la Savoie, Toulouse, 1996.
D.JALLA ( a cura di), Gli uomini e le Alpi. Atti del Convegno Torino 6-7 ottobre 1989, Torino 1991.
P.MERLIN, C.ROSSO, G.SYMCOX, G.RICUPERATI, Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età
moderna, vol.VIII, t.1 della Storia d’Italia, Torino, 1994.
J.NICOLAS, La Savoie au XVIIIe siècle, Paris, 1978, 2 voll.
P.NOTARIO, N.NADA, Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, vol.VIII, t.2
della Storia d’Italia, Torino 1993.
C.POVERO, Missioni di frontiera. La Controriforma nella Valli del Pinerolese. Secoli XVI-XVIII, Roma,
2006.
M.L.STURANI, Inerzie e flessibilità: organizzazione ed evoluzione della rete viaria sabauda nei
territori “di qua dai monti” (1563-1796), in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino» LXXXVIII,
1990, pp.455-512.
M.VIGLINO DAVICO (a cura di), Fortezze “alla moderna” e ingegneri militari del ducato sabaudo,
Torino, 2005.