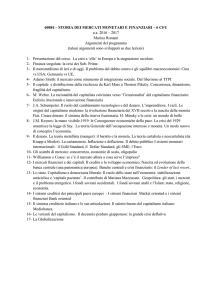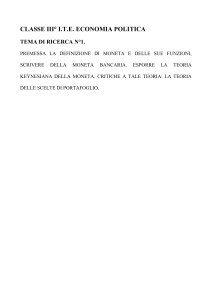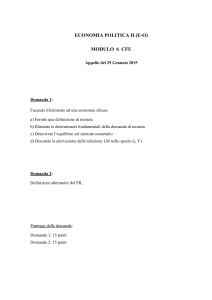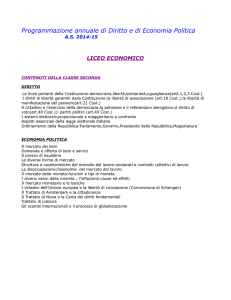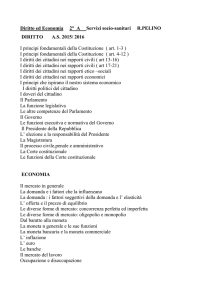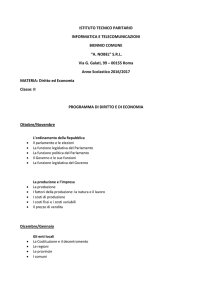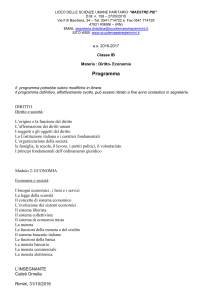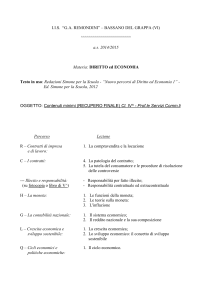PROSPETTIVE ANTIMODERNE N. 04/2012
L’altra faccia
della moneta
Per una filosofia della sovranità
politica e finanziaria
L'altra faccia
della moneta
Per una filosofia della sovranità
politica e finanziaria
n. 04/2012
Antarès, Prospettive Antimoderne
RIVISTA TRIMESTRALE GRATUITA
Direttore editoriale: Andrea Scarabelli
Direttore responsabile: Gianfranco de Turris
Redazione: Rita Catania Marrone, Emanuele Guarnieri
Hanno scritto: Davide Balzano, Andrea Baranes, Claudio Bartolini, Mattia
Carbone, Rita Catania Marrone, Giulio Maria Chiodi, Domenico de Simone,
Stefano di Ludovico, Luca Gallesi, Nino Galloni, Mitsuharu Hirose, Luigi Iannone, Gianpiero Mattanza, Simone Paliaga, Maurizio Pallante, Costanzo Preve, Andrea Scarabelli, Luca Siniscalco, Antonio Venier
Illustrazioni di: Alessandro Colombo, Irene Pessino
Progetto grafico e AD: panaro design
Impaginazione: Studio Caio Robi Silvestro
Edizioni Bietti - Società della Critica srl,
Sede legale: C.so Venezia 50, Milano
www.edizionibietti.it
In attesa di registrazione presso il Tribunale di Milano
Stampa: ProntoStampa srl, Via Redipuglia 150, Fara Gera d’Adda (BG)
[email protected]
www.antaresrivista.it
Antarès è anche su Facebook, alla pagina “Antarès Rivista”.
pag. 2 Economia oltre l’economia
di Giulio M. Chiodi
pag. 4 Editoriale: cronache di inizio millennio
a cura della Redazione
pag. 6 pag. 9 pag. 12
pag. 17
pag. 20
pag. 23
pag. 27
Saggi:
Lo stato delle crisi
di Claudio Bartolini
L’enigma della moneta
di Mattia Carbone
Il MAUSS e l’economia del dono
di Stefano di Ludovico
Ezra Pound: poeta economista?
di Luca Gallesi
La sovranità sul debito
di Luigi Iannone
Demondializziamoci!
di Simone Paliaga
Effetto “boomerang” del libero scambio
di Antonio Venier
pag. 30
pag. 34
pag. 36
pag. 38
pag. 42
Interviste:
Nino Galloni: “Il naufragio del libero mercato”
Costanzo Preve: “Filosofia della crisi”
Maurizio Pallante: “Crescita infelice, decrescita felice”
Domenico de Simone: “La moneta-debito e
le crisi economiche”
Andrea Baranes: “Per un’etica della pratica bancaria”
pag. 45
pag. 47
Recensioni:
Ernst Jünger: Maxima minima
di Andrea Scarabelli
Alain de Benoist: Sull’orlo del baratro
di Luca Siniscalco
pag. 50 Segnalazioni
n. 04/2012
Economia oltre l’economia
di Giulio M. Chiodi
L
attraversando una crisi epocale che la condurrà alle sue
fasi conclusive. Quel pessimismo varia solo di intensità.
Qualcuno cerca rimedi, grazie ad interventi mirati a contenere gli aspetti più negativi,
proponendo, per esempio, di
orientare le disponibilità finanziarie verso investimenti
atti a tutelare tanto l’ambiente naturale quanto un certo
grado di equità distributiva
della ricchezza circolante. Ma
incontriamo anche valutazioni molto meno incoraggianti
che dubitano delle possibilità, o comunque non ne intravedono affatto, di trovare
una via d’uscita da un collasso dell’intero sistema socioeconomico, scorgendo una
vera e propria autodistruzione del sistema liberoscambista e del neoliberalismo che
lo sostiene. Non mancano
poi le contrastanti vedute di
chi suggerisce l’opportunità di contrarre l’espansione economica e ridurre gradualmente i consumi inutili e di chi, al contrario,
sostiene l’importanza di un’intensificazione della produttività,
in quanto capace di garantire nuove prospettive di crescita;
nell’uno e nell’altro caso, però, si indicano vie opposte, quelle
che invocano un più consistente intervento dei governi nelle
dinamiche dell’economia e quelle che preferiscono un maggiore contenimento di qualsiasi intervento pubblico.
Le proposte di superamento delle difficoltà strutturali o
congiunturali o, almeno, di rettificazione di percorso, lette in
queste chiavi, richiedono probabilmente risoluzioni non omogenee, ma confacenti alle differenze di risorse e di esigenze delle
singole aree, purché si abbia l’accortezza di non ignorare che
viviamo in una geo-economia dei flussi e dell’interscambio e
non circoscritta in circuiti autosufficienti. Con riferimento, a
grandi linee, alle condizioni europee, e con tutte le differenze
socio-territoriali che vi incontriamo, le soluzioni di tipo economico non possono essere cercate che nell’ambito di un’intesa abbastanza ampia tra diverse aree autogestibili, che parta
soprattutto da quelle più limitrofe.
Per sottrarsi alla spirale delle logiche attrattive esercitate dagli
accentramenti economico-finanziari, è altresì ovvio che, se vi
a autoregolazione del
mercato si fonda su
valori solo economici
e monetizzabili. Altri, che potrebbero incidere in generale
sull’ofelimità, il noto termine
preferito da Vilfredo Pareto,
vengono assorbiti dal valore
economico potenzialmente
calcolabile. Ma se questo è
determinato dal mercato e il
mercato a sua volta dall’economia, si entra nel risaputo
circolo vizioso, per il quale
il valore di scambio monetario soffoca completamente
il valore d’uso. Non occorre
scomodare vecchie tesi marxiane, che su questo punto
non avevano tutti i torti,
per concludere che il valore
delle cose, appena entra nel
suddetto circolo, finisce per
dipendere soltanto dal loro
prezzo. Il denaro diventa in
tal modo il valore collettivo
ed universale per eccellenza,
col risultato che l’economia viene sostituita dalla finanza e la
banca subentra alla fabbrica, all’azienda, al lavoro, alle cose
stesse e alle persone, quali che esse siano. È per questo motivo
che i luoghi prestigiosi delle nostre città, occupati un tempo
dalle cattedrali e dalle chiese, o da palazzi storici e da edifici celebrativi e pubblicamente significativi, oggi lo sono da banche e
da istituti di credito o da centri commerciali. Schematicamente, diciamo che la finanza tende a crescere con ritmi superiori a
quelli sostenuti dalla crescita delle effettive risorse economiche,
immettendo nel mercato plusvalenze e capitali vuoti o fittizi,
che in realtà non fanno altro che incrementare i costi. I problemi sociali, politici e culturali che ne derivano sono attualmente all’ordine del giorno. Credo perfino che non si vada molto
lontano dalla realtà quando si sostiene che è una specie di mito
della finanza quello che ha voluto costruire un’Europa unita
proprio a partire dalla moneta unica, l’euro, prima ancora che
da altri fattori culturali aggreganti. Gli effetti distruttivi di questa realtà si incominciano oggi a pagare pesantemente.
Analisti di varie tendenze, infatti, condividono una visione alquanto pessimistica delle condizioni prodotte dall’andamento
economico generale del pianeta. È sempre più diffusa l’opinione, per molti decisa convinzione, che la civiltà occidentale stia
2
n. 04/2012
natura non è monetizzabile. Sono risorse naturali, ambientali,
culturali, tradizionali, artistiche, creative, religiose, che convergono a formare un patrimonio sociale e civile, tuttora ancora
disponibile alla intelligenza e al sentimento comune ed idoneo
ad essere vissuto indipendentemente dal suo mero sfruttamento economico (semmai, nelle debite misure, congiuntamente a
quest’ultimo). La scelta dipende solo dalla mentalità, dal costume, dalla formazione, dal senso di sé e del mondo, nonché dalla vitalità interiore che sanno animare la coscienza e la volontà
dei singoli individui, a che siano poi trasmessi nei contesti di
relazione e di comune socialità. È questa una sfida certamente
titanica per la psiche di chi è assuefatto alle passive ricettività
del puro consumatore; richiede sacrificio e convinzione, fede in
ideali e solidi sentimenti di appartenenza, vissuti come energie
irrinunciabili della propria indole. C’è in gioco la dignità di chi
non vuole finire ridotto ad una
qualunque merce. Occorre vincere l’indolenza dello spirito, esausto e conformista, bandire quelle
ingenue e illuministiche idee che
naufragano nel mito del progresso materiale in quanto tale, dove
il bene morale è sinonimo di beni
più materiali. È un mito che sa
riconoscere che ogni conquista
ha i suoi costi, e che quindi comporta una perdita da altra parte,
ma poi se ne ricorda solo quando
riguarda la fatica dei singoli che
producono, e curiosamente se ne
dimentica di nuovo quando pensa alla crescita globale, che presa
nel suo complesso sarebbe esente da negatività. L’uomo dei soli
consumi materiali è in realtà homo vorans che alla fine si scopre
homo voratus, l’uomo dei diritti e non dei doveri. “Le dottrine
puramente economiche devono necessariamente condurre al
cannibalismo”, scriveva Ernst Jünger (Irradiazioni, Parma 1993,
p. 230) negli anni Quaranta.
Conosciamo diverse concezioni della temporalità storica.
La dominante è certamente quella lineare e cumulativa, per la
quale non si dà retroattività. Ma la storia nel suo divenire non è
vincolata dalla necessità naturale. Questo significa che il futuro
non deve essere immaginato secondo un percorso unilaterale,
come ha voluto la scolastica marxista (e su questo punto ha
molti torti); sono possibili più direzioni, perché esse dipendono anche dalla libertà delle nostre scelte. Se ci ritenessimo tutti
predeterminati da una storia guidata fatalisticamente solo da
forze materiali e socialmente organizzate a noi estranee, senza
possibilità decisionale alcuna, allora cancelleremmo dal nostro
lessico operativo le parole libertà, fantasia, ideale, volontà. Se
abbiamo alle nostre spalle un solo passato, davanti a noi ci sono
più possibili futuri. In quale di questi finiremo per vivere dipende, anche se non in toto, in grandissima parte dalle nostre decisioni e dai comportamenti che vorremo assumere. L’economia
non può renderci fatalisti, nel significato deterministico della
parola. La rassegnazione, che appartiene alle anime stracche,
non è mai d’aiuto quando occorre reagire e il futuro, lo si deve
sempre ricordare, è molto più dentro di noi che davanti a noi.
sono soluzioni ai mali più gravi, queste vanno ricercate in direzioni che non si facciano catturare dai meccanismi autoriproduttivi delle condizioni in atto.
Condivido pienamente le preoccupazioni del momento, imputabili sì alle difficoltà economiche, ma a mio avviso bisogna
pensare a cause ancora più radicali di costume e di incuria civile:
occorre trarre le conseguenze dalla convinzione che i problemi
economici non nascono solo dall’economia e nemmeno si risolvono soltanto con essa; e ciò vale, naturalmente, anche per la
finanza. Senza sottovalutare l’importanza dell’una e dell’altra,
nella vita sociale è altrove che dobbiamo guardare, se vogliamo
disporre di criteri fondati per affrontare anche i problemi che
esse sollevano.
Il quadro che osserviamo, quanto più impostato a risolvere
l’economia con l’economia, ci
mostra un mondo che vive contemporaneamente sulla miseria
più assoluta e sull’opulenza più
sfacciata. Nella storia non si è
mai assistito in ugual misura a
tanto divario tra chi muore letteralmente di fame e chi dispone di
una ricchezza che non sa nemmeno come utilizzare; forse mai si è
visto convivere nelle attuali proporzioni, l’uno accanto all’altra,
lo spreco più frivolo e la miseria
più desolante. Si distruggono
tonnellate di risorse alimentari,
mentre a poca distanza le stesse si
vendono a prezzi assolutamente
insostenibili per molte famiglie
disagiate. Si producono oggetti ed attrezzature, di uso tanto
industriale quanto comune, di
durata sempre più limitata, secondo la logica dell’“usa e butta”, che non fa che incrementare rifiuti, sempre più difficili da
smaltire, sì che gli ambienti naturali si convertono in discariche
permanenti, anche altamente nocive. Impera, a favore del bene
quantificabile, la quasi totale disattenzione alla qualità intrinseca delle cose, e con questo anche alla loro cura; anzi, il senso
delle cose e delle persone, che ne esprime valenze e significati e
che valorizza le proprietà dei nostri rapporti, viene completamente cancellato, facendo posto solo ad entità indifferenti ed
inerti. È la perdita della realtà nei suoi sensi affettivi, estetici,
morali, ideali, accomunanti, identitari, in una parola “simbolici”. Se si riflette sulla enorme disponibilità di mezzi tecnologici
altamente sofisticati (il mondo digitale è solo un esempio alla
portata di tutti), di fronte alla più deprimente carenza di risorse spirituali, di cui soffrono i suoi fruitori, ci si rende conto
degli effetti devastanti su esseri umani ridotti a semplici utenti,
passivi, psicodipendenti e seriali, da una téchne sempre più priva di qualsiasi epistéme.
Il nostro compito, in primo luogo, è di rivolgere l’attenzione
alla conservazione, o al perseguimento, di obbiettivi culturali e
sociali e di prestare cura a taluni valori individuali e collettivi,
che per loro stessa natura non sono né costituiti, né acquisibili,
né fruibili per via economica (o, tutt’al più, per coltivare i quali
l’economia rivestirebbe un ruolo soltanto strumentale e non già
autoriproduttivo). Si tratta di saper guardare a quanto per sua
“
Vincere
l'indolenza di uno
spirito esausto
e conformista
”
3
n. 04/2012
Editoriale: cronache di inizio millennio
a cura della Redazione
C
nomista come John Kenneth Galbraith, recentemente ricordato da
Luca Gallesi: “Noi economisti ci proteggiamo dal mondo esterno
adottando un nostro linguaggio specifico e amiamo vederci come
una classe sacerdotale con un sapere o una mistica inaccessibili
all’uomo comune. E se un economista ti chiede di accettare le sue
opinioni come Vangelo perché poggiano sulla sua sapienza, non
credere a una parola di quello che dice” (C’era una volta... l’economia, Bietti, Milano 2012, p. 35). Che dire? Più chiaro di così...
In passato, gli alchimisti, per comunicare tra loro, utilizzavano
un linguaggio cifrato, esoterico, le cui espressioni solo loro conoscevano. Un “profano” guardava i loro trattati e non ci capiva
un’acca. Lo scritto arrivava poi in mano ad un altro alchimista, che,
in possesso delle chiavi di lettura giuste, lo decifrava. Lo stesso accade oggi, con i moderni alchimisti del denaro. Ma se l’oro degli
antichi corrispondeva ad una realizzazione interiore, era un oro
solare, quello di oggi, volgare, nero (petrolifero) o virtuale (finanziario), annuncia lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo – altro che
realizzazione!
Questo numero si muove in direzione contraria. La persuasione
che lo anima è fornire elementi per comprendere l’economia che
siano semplici e chiari. Non è diretto agli specialisti, ma a tutti coloro – come chi scrive, d’altra parte – che non sono “iniziati” ai
moderni misteri dell’economia. Di un’economia, per la precisione,
la nostra.
Poiché è anche di questo che si tratta. Non è crollata l’Economia
né la Politica ma una economia e una politica fra tante. Per ogni
civiltà ce n’è una, come c’è una matematica, una filosofia, una numismatica, e via dicendo. Sono tante quante sono le civiltà. Usare le
maiuscole è fare pessime astrazioni: l’economia non è separata dal
resto della realtà ma obbedisce alle leggi della civiltà che – volente o
(come spesso accade) nolente – l’ha adottata. L’essenza dell’economia non è crematistica (monetaria, finanziaria o virtuale che sia) ma
culturale, antropologica.
È crollata l’economia della modernità, e solo essa. Quale il suo
nome, che i tecnocrati hanno paura di menzionare? Il Capitale.
Esso ha dichiarato bancarotta. La presente crisi, come tutte le altre, non rappresenta alcunché di imprevedibile ma è implicita nelle
premesse del capitalismo, come lo stesso Karl Marx aveva già denunciato. La globalizzazione del mercato, la riduzione di qualsiasi
attività, relazione ed essere umano alla natura di merce, operatasi
sotto il segno del denaro livellatore: questo già venne indicato dal
filosofo di Treviri quale rischio congenito del capitalismo. Eppure,
nonostante il nome di Marx venga spesso e volentieri citato – sovente a sproposito, anche da taluni che volentieri strizzano l'occhio
al capitalismo – continuiamo a ripeterci che non eravamo preparati a tanto.
Il volto della modernità, a seguito del suo ingresso in questo circuito suicida, è intanto profondamente mutato. Una mondializzazione realizzata sui presupposti del liberismo più sfrenato – oggi
risi. Tutti ne parlano, ovunque sentiamo questa parola:
dai telegiornali alle pagine dei quotidiani, dai talk-show
alle conversazioni al bar. La crisi. Chi l’avrebbe mai detto? Pare il suo avvento sia stato imprevedibile. Non c’è dubbio: ci
ha colti di sorpresa. Ed ognuno pensa a come sopravvivere ad essa,
a come potersi permettere il lusso di una fine settimana al mare,
l’ultimo modello di televisore, cellulare o automobile: come a poter fingere che in fondo, sì, la vita continua. Quando va bene; altrimenti, la realtà è di chi, a causa del comportamento iniquo di una
finanza irresponsabile e di una politica accondiscendente, arranca
fino alla fine del mese per ripetere l’esperienza in quello successivo.
Certo è che la priorità assoluta, questo è poco ma sicuro, è ora come
ora uscirne. Così ci dicono. Stringere i denti e resistere, di modo
che, una volta superata, noi si possa (o forse solo chi ci ha condotto
in questo baratro?) continuare come prima.
Ma probabilmente non è sufficiente. Per presentare il conto a chi
ci ha fatto arrivare sin qui bisogna prima comprendere la crisi sino
in fondo, capire da dove e da cosa è stata generata. Imparare a dialogare con essa, insomma. Ogni crisi ci insegna qualcosa di più su noi
stessi, rivela la presenza di un volto notturno del presente, che i periodi di “salute” spesso nascondono. Dispone di una sua sapienza,
ha da impartirci una lezione sua e solo sua che occorre imparare, sia
per attraversarla, sia per non compiere in futuro i medesimi errori
che l’hanno generata. Si tratta di un’occasione, insomma, per capire qualcosa di più su chi tiene le redini del nostro presente – basta
riconoscerla come tale e il gioco è fatto.
Prima di cercare di attraversarla, occorre pertanto domandarsi:
cosa è entrato in crisi? Di che modello si tratta? Non è forse un tipo
di sistema che richiede periodici momenti di criticità come sua possibilità di evoluzione? In altre parole: la crisi che stiamo attraversando è episodica – dipende cioè da circostanze esterne e imprevedibili – oppure strutturale, implicita nelle premesse?
Abbiamo posto queste domande ad una serie di economisti e
filosofi dell’economia, cercando di donare attraverso le loro risposte – assai diversificate, data l’eterogeneità – un affresco del nostro
tempo, che ne restituisca la complessità e le intime contraddizioni.
A queste conversazioni sono affiancati brevi saggi, atti ad illustrare
differenti paradigmi economici, modi alternativi di interpretare il
rapporto tra l’uomo e il denaro rispetto a quello che si è imposto ai
nostri giorni.
Quando Ezra Pound si trovò a dirigere il Supplemento letterario
del Mare di Rapallo, come esergo ai fascicoli pose una frase di Carducci: “Chi dice in dieci parole quello che può dire in due è capace
di uccidere suo padre”. Una citazione assai emblematica, scelta da
un poeta che sempre denunciò chi mischia volutamente le carte in
tavola per rendere complicato agli occhi dei popoli ciò che in realtà
non lo è. Anche questa è una strategia del potere. Mai fidarsi di chi
ci dice che la situazione è complicata o di chi si esprime consapevolmente con terminologie oscure. È quanto sostiene un grande eco-
4
n. 04/2012
pubblico, tutti al comando dell’usurocrazia”. Secondo toni analoghi, in un altro suo scritto (Jefferson e/o Mussolini, Il Falco, Milano
1981, p. 134), il poeta americano – che già aveva processato gli
istituti di credito per la creazione del denaro dal nulla, ex nihilo –
notava: “«Nessuno possiede un diritto innato alla funzione di prestatore di moneta, tranne chi ha denaro da prestare». Così ovvio,
così semplice, così prevedibile anche dal lettore profano, da rappresentare anche oggi un reale stato di fatto, e nello stesso tempo un
impedimento così rovinoso per le illecite pratiche bancarie come è
abituale in tutto l’arco della nostra vita presente”.
E il romanziere Robert Heinlein? In uno dei suoi due romanzi ispirati al Credito Sociale (A noi vivi, Urania, n. 1505, p. 193),
scriveva, in merito al rapporto tra potere pubblico e privato: “Alle
banche non doveva essere affatto permesso di creare denaro, poiché esse, di necessità, sono interessate soltanto ai profitti. Inflazioneranno o deflazioneranno la valuta per fare profitti, senza riguardi
per i bisogni monetari della nazione”. Subordinare la gestione della
cosa pubblica a privati comporta numerosi rischi. Può capitare, infatti, che questi ultimi decidano di non agire per conto di tutti ma
solo per se stessi. Così elementare...
E sul valore del denaro e il suo rapporto con le merci, ennesimo
tema – molto antico – riproposto da questa crisi? Tra gli eretici del
pensiero economico ricordiamo anche che il Maggiore Douglas (I
principi del credito sociale, in A. R. Orage, Il lavoro debilita l’uomo,
Greco&Greco, Milano 2008, pp. 82-83) sottolineò, con notevole
anticipo, che “il denaro non ha alcuna realtà intrinseca (…). La cosa
che lo rende denaro, di qualsiasi cosa sia fatto, è puramente psicologica, e di conseguenza non c’è limite alla quantità totale di denaro,
tranne che un limite psicologico”. Il denaro è una risorsa simbolica:
rimanda sempre ad altro. Sottomettere i popoli alla sua autorità è
tanto insensato come, parafrasando un detto famoso, affermare che
non si possono costruire strade perché mancano i chilometri. Non
eravamo forse stati avvisati? Chi, alla luce di queste testimonianze,
alle quali potremmo aggiungere quelle di Jünger, Carlyle, Simmel,
Sombart, Ruskin, Schmitt, Morris, Anders e tanti altri, può ancora
fingersi sorpreso?
Esse convergono verso un nocciolo centrale, sul quale bisogna
soffermarsi e meditare, non solo perché questa crisi sia superata, ma
anche affinché non sia seguita da altre, ancora più terribili, come è
prassi comune in quelle regioni sottomesse ai Diktat del Capitale.
La si può oltrepassare solo discutendo le basi stesse del capitalismo,
moderno Caronte che ci ha traghettati verso la nostra fine. Non
scendere a patti con esso, come vorrebbero molti dei cosiddetti
“contestatori” o “indignati”, ma ridiscuterne interamente le basi,
sterrare le sue radici per coglierne i presupposti, e salvare così quella
terra che la sua dittatura ha fatto avvizzire. Affinché questa operazione vada a buon fine, non inganniamoci ulteriormente: non è di
revisione che occorre parlare, ma di rivoluzione, nel senso etimologico del termine, ossia distruzione dell’errore e reintegrazione. Ma,
si badi!, senza per questo cadere in assurdi primitivismi, che propongono il ritorno ad una realtà preindustriale, basandosi sull’assurdità della “bontà naturale dell’uomo” al di fuori della società.
Si tratta di rifondare un modus vivendi alieno da una modernità
usurocratica e sanguinaria, luogotenente di un progresso sempre
meno sostenibile e di una globalizzazione intesa come imposizione
totalitaria di un solo paradigma, quello occidentale, che sta ora dichiarando pubblicamente, in prima serata, il suo fallimento.
Questo l’insegnamento della fase storica che stiamo vivendo;
questo il vantaggio più grande che possiamo trarre da quella crisi di
cui, più o meno seriamente, andiamo blaterando da anni.
dogma non passibile di discussione alcuna, come sottolineato da
Antonio Venier nel suo contributo – le delocalizzazioni che prosciugano le risorse lavorative dei popoli, un capitalismo selvaggio
che, come intuì profeticamente sempre Marx, considera ogni limite come ostacolo alla sua realizzazione totalitaria, una dittatura
finanziaria avversa a qualsiasi controllo da parte dei poteri politici,
i piani intrapresi per salvare quelle stesse banche che ci hanno fatto
precipitare nel baratro. Questi i fenomeni del nostro tempo, che
non possono che rivelarne il carattere parossistico. Da qui occorre
prendere le mosse a che questa impasse sia superata.
A ciò va aggiungendosi una gestione biopolitica – per dirla con
Foucault – a carattere planetario delle risorse umane. Lo smistamento e smembramento delle comunità segue le maree dei flussi
di denaro che, in ogni istante, si spostano fulmineamente da una
parte all’altra del globo. Da qui un’immigrazione selvaggia il cui
fine, come ha scritto recentemente Alain de Benoist, ben lungi
dall’essere la solidarietà e l’umanitarismo, si risolve nel controllo
dei salari, affinché rimangano i più bassi possibile. Un terrorismo
umanitario realizzato su scala globale. Le “truppe di rincalzo del
capitale” vengono accolte da una parte da una xenofobia retrograda
e dall’altra da un ipocrita umanitarismo da sradicati. Pochi si sono
resi conto che i flussi migratori sono consustanziali al capitale, alla
sua vecchia idea di sopprimere le frontiere nazionali per una “libera” circolazione della merci. E la merce umana viene sottoposta alla
medesima formula.
Questa crisi ha riportato alla ribalta anche la vecchia questione
dei rapporti tra politica ed economia. Ci ha rivelato l’essenza apolide del denaro, naturale nemico del limite, anche politico. Il suo
potere svuota le democrazie, le relega ad essere braccio secolare della
finanza, come intuì Giano Accame negli anni Novanta.
Ma non fu certo l’unico. Inutile ricordare le voci di tutti coloro
che rivendicarono il primato della politica sull’economia, facendosi
profeti della catastrofe delle tecnocrazie al potere e dei vangeli delle
austerity. Il ricordo di taluni di questi critici può forse dimostrare
che, anche in tempi non sospetti, qualcuno – regolarmente inascoltato – ci ha messo all’erta innanzi ai pericoli di una economia
scatenata. Così, ad esempio, Oswald Spengler (Forme della politica
mondiale, Ar, Padova 1994, pp. 79-80) ebbe a scrivere: “Qualsiasi
vita economica priva di una giusta guida politica del Paese è destinata alla rovina. Questo è ciò che l’orgoglio del dirigente economico non vuole accettare. Egli nutre l’accentuata tendenza a rifiutare
l’operato e il modo di agire del politico come dettati da eccessiva
arroganza e nocività, per poi chiamare immediatamente in soccorso
la politica quando e fintanto che crede di poterla usare per i propri
interessi (…). Anche se oggi questa è la regola in tutto il mondo,
si tratta ugualmente di un atteggiamento meschino, superficiale e
sbagliato, che diventa una sciagura quando la politica stessa è debole e malata, priva di fini propri e senza orgoglio, esposta così agli
interventi dell’economia, concepiti in modo disordinato, estemporaneo, e privo di lungimiranza. La vita economica di una nazione
necessita di una guida politica sempre sovraordinata, non di una
politica subordinata e accondiscendente”. Un’autentica profezia di
quanto sta succedendo, che il filosofo colse nella sua forma aurorale
negli anni Trenta. Sarebbe sufficiente leggere certi libri, invece che
metterli all’indice, come spesso accade. Potremmo così evitare di
fare spallucce e dichiararci “impreparati”.
Per poi non parlare del già citato Ezra Pound (Lavoro e usura,
Scheiwiller, Milano 1996, p. 82), che vide nell’asservimento del
potere politico alle banche una modernissima schiavitù: “Il sistema
democratico è di questa natura: due o più partiti si presentano al
5
n. 04/2012
Lo stato delle crisi
di Claudio Bartolini
S
rispondendo alle crisi che ha dovuto affrontare con altrettanti
rilanci, tesi a evitare l’arresto di un ingranaggio facile da mantenere in moto, più difficile da rimettere in funzione dopo un
collasso. E proprio da un collasso ha origine il viaggio verso i
cambiamenti di stato dell’economia statunitense, che nel Novecento ha conosciuto il secolo evolutivamente più significativo della sua storia. 1929, Grande Depressione: la nazione è
devastata da un terremoto economico senza precedenti, che
mette in ginocchio l’industria e i redditi di milioni di cittadini. 1933, New Deal: Franklin Delano Roosevelt vara un piano
di riforme economiche destinato a durare fino al 1937 e a risollevare le sorti degli States, consegnandoli in piena efficienza
alla Seconda Guerra Mondiale. Sono anni di rinascita, di entusiasmi e interrogativi che trovano ovvio riscontro nelle coeve
espressioni creative.
Il cinema, giovane arte in grado di riflettere sulla realtà in
movimento, elegge Charlie Chaplin a illustratore della contem-
olido, liquido, gassoso. Questione di stati della materia,
del tempo, delle cose. Questione di stati di un progresso
che, scaldando le sue molecole, le induce a evaporare e
assumere connotati nuovi, indefiniti e sfuggenti. A ogni stato
corrisponde una crisi, un punto di rottura degli equilibri che
porta inevitabilmente al cambiamento di oggetti, procedimenti e logiche di comprensione. Che ottengono infine un nuovo
equilibrio, prima di un ulteriore scarto. This is economy: un rito
di incessante evoluzione che mutua le proprie forme da quelle
della contemporaneità in cui è immerso e, nel corso della storia, ha esibito dinamiche tanto lontane nelle modalità espressive, quanto vicine in quelle contenutistiche. Dal baratto al lavoro subordinato, dalla borsa al cybercapitale, l’economia gira
intorno agli assi delle logiche di scambio, del potere d’acquisto
e della sottomissione del più debole.
Il sistema capitalista americano si è (da) sempre posto come
modello socio/economico privilegiato per le realtà occidentali,
6
n. 04/2012
poraneità Usa e l’autore risponde mettendo in scena Modern
Times (Tempi moderni, 1936), spaccato di vita individuale e
industriale capace di rispecchiare e problematicizzare la situazione generale. A story of industry, of individual enterprise recita
il cartello che apre la pellicola, felice mescolanza di muto e sonoro che, a partire dalla dichiarazione di intenti, non nasconde
le proprie ambizioni sovracinematografiche. Chaplin è un cineasta e un comico e, inevitabilmente, utilizza il codice della risata
(tragica) come chiave di accesso a un testo da interpretare scavando oltre la superficie, alla ricerca del reale oggetto narrativo:
la mappatura, sull’asse sociale delle ordinate (alto/basso), di un
sistema capitalista alla ricerca di stabilità. Il film si apre con un
montaggio delle attrazioni che pone in parallelo una mandria
di maiali e un gruppo di operai che si reca in fabbrica, tanto per
mettere a nudo in partenza una tra le disfunzionalità dell’imperante filosofia del lavoro. L’autore inquadra l’universo di riferimento nelle prime sequenze, passando in pochi secondi da
un totale in esterni della fabbrica a un campo lungo in interni
della stessa, fino a riprese in dettaglio dei macchinari sui quali
gli operai sono intenti a lavorare.
Dal presidente nullafacente ai subordinati vessati dai capireparto, dal cartellino da timbrare anche per andare al bagno a un
viaggio tra gli ingranaggi delle macchine, Tempi moderni è un
testo profondamente contemporaneo, tra i pochi ad affrontare
lo stato delle cose negli anni, appunto, della modernità. Stato
solido, dunque, espresso dalla pesantezza degli oggetti, dal sudore fisico che olia i meccanismi di un Moloch legato indissolubilmente ai propri referenti materiali. L’opulenza del New
Deal va a braccetto con la spinta tecnologica, messa a tema da
Chaplin nelle sequenze della catena di montaggio e del “pranzo automatico”, in cui l’operaio protagonista viene costretto a
testare la validità di una nuova creazione meccanica. Sotto il registro grottesco – materializzato nel volto dello stesso Chaplin
inondato di cibo – alberga l’incertezza circa la liceità e l’effettiva bontà del progresso. Il “cameriere sintetico” si inceppa, il suo
motore va a fuoco: è davvero tempo di resurrezioni? Il cineasta
inglese risponde nella seconda parte della pellicola, affrescando
la vita al di fuori della fabbrica in seguito al licenziamento del
personaggio principale. Al di là dell’intreccio sentimentale e
dei reiterati momenti comici, il film procede sulla linea retta dei
propri obiettivi, allargando lo sguardo dalla sola industria (A
story of industry) al viaggio dell’individuo moderno nell’universo capitalista (of individual enterprise). La disoccupazione e
la povertà dei ceti meno abbienti da una parte; i centri commerciali, lo stupore della rinascita, le continue opportunità di
ascesa dall’altra.
L’America di Chaplin vive un’esistenza bipolare, in bilico
tra spinta evoluzionistica e malfunzionamenti strutturali. Crisi
e risalite si alternano tanto nell’economia del singolo (continue assunzioni e altrettanto continui licenziamenti) quanto in
quella generale (chiusura e riapertura delle fabbriche), trovando nella messa in scena innumerevoli espedienti di rappresentazione. Nell’America della rinascita e, successivamente, in quella
del boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta, il cinema
configura la riflessione contestuale in immagini dotate di referenti chiari, materiali e profondamente contemporanei. Il concetto di denaro si incarna nell’inquadratura di una banconota
e quello di lavoro nel dettaglio di un macchinario, secondo le
regole dell’immediatezza di un mondo solido.
Interi generi della Hollywood classica (su tutti il gangster, il
noir e il melodramma) faranno dei soldi – intesi nel loro simulacro cartaceo – il motore drammaturgico primario, messo in
scena senza sconti come protagonista della vita micro e macro
americana. Mentre due milioni di dollari in contanti volano nel
vento sul finale di The Killing (Rapina a mano armata, Stanley
Kubrick, 1956) i tempi moderni si apprestano a cambiare per
sempre. Scaldata dalla fiamma del progresso (del peccato?), la
modernità si scioglie e diviene fluida, scorrevole. Diviene postmodernità, nodo teorico ben teorizzato da Zygmunt Bauman
e Serge Latouche in saggi di rara potenza intellettuale. Materia
liquida in cui nuotano rampanti squali in abiti eleganti, cresciuti nelle business school e pronti a tutto pur di fare soldi. Speculatori azionari svincolati dai supporti oggettivi, le cui relazioni
con l’industria si esprimono soltanto attraverso movimenti di
denaro ideale.
Gli anni Ottanta delle bolle economiche e del benessere
effimero trovano in Oliver Stone l’interprete ideale e nel suo
Wall Street (1987) il testo chiave per comprenderne il funzionamento. Il mondo della speculazione azionaria (gli uffici di
brokeraggio e la Borsa) è limitato e localizzato, ma i suoi referenti (il denaro reale, l’industria produttiva) sono distanti e
sfuggenti. In coerenza con il mondo rappresentato, il regista
newyorchese attinge a svariati espedienti di regia (steadicam,
carrelli, panoramiche, zoom) per configurare il primo, mentre
lascia nel fuoricampo i secondi, in quanto componenti non determinanti per il funzionamento del nuovo contesto capitalista. I suoi protagonisti non sono più operai o capicantiere – e
nemmeno padroni di aziende – bensì archetipi di un sistema
profondamente problematico e ben lontano da quello cui si riferiva Charlie Chaplin.
Gordon Gekko e Bud Fox – interpretati rispettivamente da
Michael Douglas e Charlie Sheen – sono disfunzioni in carne e
ossa, soggetti senza scrupoli destinati a subire le oscillazioni del
sistema di cui sono dirette emanazioni. Gekko, in particolare, è
il self-made man del libero mercato, l’esponente di punta della
contemporaneità che creerà le basi per la futura crisi globale.
«L’avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Teldar
Carta, ma anche l’altra disfunzionante società che ha nome
America» afferma, educando i giovani yuppies ai nuovi flussi
di soldi immateriali. Capitano di un vascello che naviga a vista
nel liquido dei suoi tempi, è consapevole dello stato delle cose:
«Il denaro c’è ma non si vede: qualcuno vince, qualcuno perde.
Il denaro di per sé non si crea né si distrugge. Semplicemente si
trasferisce da una intuizione a un’altra, magicamente». Ma il
vascello è pieno di falle e non tarderà a imbarcare acqua, affondando. Stone mette in crisi il nuovo capitalismo e ne delinea le
potenzialità distruttive, procedendo sui binari paralleli dell’individuo e della finanza. Se l’animo del giovane Bud Fox viene
irrimediabilmente corrotto dai precetti deviati del suo mentore
(«Serve gente povera, furba e affamata. Senza sentimenti»),
i meccanismi economici incastreranno Gekko, trascinandolo
fino al baratro della galera. Specchio della contemporaneità,
Wall Street volge il proprio sguardo alla testa del sistema evitando, come detto, di considerare le ripercussioni dei modelli economici sulla realtà quotidiana dell’uomo medio americano.
A questo aspetto pensa invece John Carpenter l’anno successivo, con They Live (Essi vivono, 1988), saggio cine-economico “dal basso” narrato dal punto di vista della gente comune.
Carpenter metaforizza l’imperante pratica del consumismo in
un contesto sci-fi, nel quale una Los Angeles colonizzata da-
7
n. 04/2012
canadese adotta un linguaggio criptico, verboso, nel quale le
parole e i monitor sostituiscono le azioni e gli uffici. Campi
e controcampi invece che steadicam e panoramiche; dialoghi
(in)interrotti e straniamenti all’interno di un’automobile in
perenne isolamento acustico. L’opera più estrema dell’autore
porta alle estreme conseguenze simboliche e visive la logica
economica attuale, configurando l’affarista 2.0 come una variazione spersonalizzata del suo predecessore.
L’atrofia emozionale di Eric Packer, (s)oggetto misterioso e
totalmente estraneo alla realtà, è lontana dalle pulsioni cannibali di Gordon Gekko, archetipo
di impossibile riattualizzazione,
come dimostra l’anacronistico
Wall Street: Money Never Sleeps
(Wall Street. Il denaro non dorme
mai, Oliver Stone, 2010), sequel
di Wall Street che mette in scena lo stato liquido (ampiamente
superato) delle cose. Il fattore
umano, nel cybercapitalismo, è
sterilizzato dall’inconsistenza
dei dati, che fluttuano su schermi
da guardare svogliatamente. La
distorta ricchezza della gabbia
dorata di Packer, però, viaggia
verso l’autodistruzione assieme
alla sua limousine, senza che il
protagonista possa fare niente
per impedirlo. Anzi, è Packer
stesso a incoraggiare (inconsapevolmente?) l’annientamento
del sistema che presiede, portato
alla rovina proprio a causa di una
mancata considerazione dell’elemento umano, dell’imprevedibile fattore naturale rappresentato
tanto dalle oscillazioni inspiegabili dello Yen quanto da una
metaforica asimmetria alla prostata della quale il protagonista
non ha mai compreso le ragioni. E se nel capitalismo gassoso
del terzo millennio le ragioni della crisi sono incomprensibili
persino agli occhi dei loro responsabili, è ben chiaro quanto il
comune cittadino americano (mondiale) sia distante da ogni
logica finanziaria, tagliato fuori da un mondo che, di fatto,
nemmeno esiste.
Estrema e complessa, la pellicola di Cronenberg rende conto dell’endemica disfunzione alla radice dei collassi globali e
chiude la prospettiva su nuovi, (im)possibili scenari, spalancando le porte del baratro. È il neozelandese Andrew Niccol,
autore da sempre in anticipo sui tempi, a prefigurare un ulteriore scarto futuro nel suo In Time (2011), ambientato alla fine
del XXI secolo in un mondo in cui la logica economica odierna, ormai completamente naufragata, avrà lasciato il posto al
tempo come unità monetaria di scambio. Ma anche questo sistema postapocalittico, ancora una volta a matrice capitalista,
sarà destinato all’inevitabile implosione, provocata dai giochi
di potere dei nuovi Gordon Gekko temporali.
Solido, liquido, gassoso, immateriale: semplice questione di
stati della materia, del tempo, delle cose. Questione totalmente
ininfluente, nella rotta suicida verso la prossima crisi.
gli alieni invia messaggi subliminali, visibili soltanto attraverso
particolari occhiali rivelatori, ai suoi cittadini. Le figure aliene
ben simboleggiano la distanza – espressa ugualmente, ma in
modo diverso, da Stone – che intercorre tra i piani alti e bassi di
un sistema economico inintelligibile, i cui ordini sono eseguiti auto(no)ma(tica)mente da individui ignari. «Consuma»,
«Obbedisci», «Segui i consigli per gli acquisti», «Guarda
molta Tv»: questi gli input, celati dai comuni cartelloni pubblicitari con cui l’economia postmoderna condiziona le menti
dei suoi sudditi. Essi vivono si pone nei confronti della mente assuefatta al modus pensandi
televisivo esattamente come gli
occhiali speciali permettono di
vedere oltre. Invita lo spettatore
contemporaneo a stare molto attento a ciò che lo circonda e in lui
si insinua, mascherandosi da cellula sana.
Nei testi di Carpenter e Stone,
sospesi tra cinema, sociologia dei
consumi e della finanza, emergono abissi di profetica attualità che
si spalancheranno definitivamente con la crisi del 2008, diretta
emanazione dello yuppismo anni
Ottanta come ben esplicitato dal
documentario su speculazioni
immobiliari e bolle economiche
Inside Job (Charles Ferguson,
2010).
Gli scenari borsistici di fine XX
secolo subiscono gli stessi surriscaldamenti che avevano reso
liquida la solidità di inizio Novecento. La materia postmoderna varia, di nuovo, evaporando
allo stato gassoso. Il XXI secolo
diventa il regno dell’intangibile,
della virtualità e della rivoluzione dei rapporti spazio/temporali, riconfigurati sulla base delle sdoganate dinamiche di rete.
L’economia americana, come sempre, è tra i territori simbolici
più flessibili ai mutamenti, sempre pronta a ricollocare l’istanza capitalista nei nuovi scenari disponibili. Il cybercapitale diviene aleatoria e completa astrazione di denaro. Non solo manca il corrispettivo materiale (la banconota, sostituita del tutto,
o quasi, dalla carta di credito) ma passano in secondo piano
anche i luoghi deputati a operazioni di alta e media finanza (la
Borsa, gli uffici di brokeraggio). L’immaginario contemporaneo si svincola dalla geografia reale, a beneficio di un’inedita
mappatura immateriale.
La crisi del 2008 non impedisce al nuovo stadio evolutivo
di affermarsi con decisione, tuttavia ne mina i presupposti
aprendo possibili scenari fallimentari. Come sempre, i cineasti
più attenti alle dinamiche del loro tempo sono in prima linea
nel restituirle, deformandole fino a scoprirne i nervi e i punti
deboli.
Adattando lo spiazzante romanzo omonimo di Don De
Lillo, David Cronenberg realizza Cosmopolis (2012), testo di
punta per comprendere – per quanto possibile – le logiche di
un sistema votato all’azzeramento del fattore umano. Il regista
“
Le ragioni
della crisi sono
risultate
incomprensibili
persino agli
occhi dei
responsabili
”
8
L'enigma della moneta
P
di Mattia Carbone
er introdurre l’uditorio al suo pensiero, Massimo Amato
tira fuori una banconota dal suo portafogli e la mostra ai
presenti. Poi chiede cos’ha in mano e, senza farsi troppo
desiderare, risponde: nulla. Perché la moneta non rappresenta
nulla, o meglio: rappresenta il nulla. E il nulla non si mangia.
Potrebbe sembrare un gioco di parole, neanche troppo generoso di senso. Ma dietro alla boutade si cela un pensiero che ha
fatto propria la missione di un ripensamento radicale della contingenza storica del nostro tempo, un tentativo coraggioso di
sondare la situazione economica di oggi alla luce della storia del
concetto di moneta. Amato porta avanti il suo insegnamento di
storico del pensiero economico nel girone dei bocconiani, tra
tanti sapienti di dogmatica capitalista, incarnando con disinvoltura una figura classicamente eretica, che ha saputo portare
avanti una critica serrata alle basi (o ai baratri, direbbe lui) su cui
si fonda il capitalismo di oggi e di ieri.
9
n. 04/2012
una manifestazione nel campo dell’economico di quella perdita della differenza ontologica che, secondo il filosofo tedesco, è
all’origine dell’ingresso della storia occidentale nell’epoca del
nichilismo. Con l’oblio della differenza, nella lettura heideggeriana, inaugurato da Platone, l’Occidente ha imboccato la
strada del nichilismo perdendo di vista la dimensione dell’essere. La moneta di Amato (più propriamente: il fenomeno originario della moneta) condivide molte affinità con quegli istituti
originari e sacri (come il linguaggio o l’arte) che nella lettura
di Heidegger sono i luoghi di manifestazione dell’essere: essa
infatti si presenta come un ente sottratto per convenzione (nòmoi in Aristotele) alla catena infinita degli enti semplicementepresenti, posto al di sopra di questi (nel momento che Aristotele definisce analoghìa) affinché,
grazie ad esso e in esso, possano
venire alla luce. In modo analogo, Heidegger intende la dimensione dell’essere come condizione d’esistenza degli enti
non in senso causalistico ma
in quanto luogo aperto al loro
manifestarsi.
La perdita della differenza ontologica inaugura un’epoca in
cui può accadere che la moneta
precipiti dalla sua condizione di
ente esemplare al semplice utilizzabile, ridotta a “cosa tra le cose”
(e quindi “merce tra le merci”)
in vista della sua accumulazione
e inevitabile trasformazione in
capitale. E non è forse un caso
che il momento culminante di
questa svolta storica si abbia
nello stesso secolo in cui l’oblio
della differenza trova la sua più
piena realizzazione, con la nascita del pensiero scientifico: è
il Seicento di Cartesio, ma anche
del capitalismo olandese.
Il ragionamento è paradossalmente più semplice da capire
che da accettare, per il fatto che siamo condizionati da una
visione della moneta standardizzata dalla vulgata economica
odierna, che innalza l’esistente a condizione di esistenza, privando la moneta della sua dimensione storica. Anche perché
il pensiero di Amato perviene a conclusioni a dir poco destabilizzanti, che andrebbero dunque indagate a fondo. Ad esempio, negando la validità del tratto di riserva di valore, si nega
l’attendibilità del prestito a interesse, e quindi l’intero sistema
su cui riposano la finanza, gli istituti di credito e i progetti del
cittadino qualunque, pecchia industriosa che confida nella magra certezza della rendita annua del proprio conto in banca.
Addentrandosi più a fondo nel passo aristotelico sulla moneta, la sua lettura ermeneutica perviene a guadagni concettuali che sembrano indicare una possibile dimensione etica
dell’economico.
Affrontando di petto un luogo comune, a tal punto radicato
nel nostro pensiero da porsi addirittura come vero e proprio
fondamento dell’economia odierna, Amato afferma decisamente che il possesso di moneta non rappresenta una ricchezza.
Il compito non è dei più semplici, ma certo è necessario ed
imminente: le periodiche crisi del capitalismo possono leggersi
come un fisiologico calo di tensione del sistema più perfetto al
mondo o come i segnali di un malfunzionamento congenito
che, forse, testimonia di un errore fondamentale, la cui questione è stata trascurata e quindi obliata. Questo errore sta, secondo Amato, nella concezione odierna e corrente di moneta.
Per molti versi la sua si potrebbe definire un’istòria della moneta, in senso greco: una storia, certo, ma soprattutto un’indagine che fa appello agli strumenti del pensiero fenomenologico
del secolo scorso (Heidegger), un’interrogazione che vuole
accedere al fenomeno originario della moneta, fatto libero dalle
successive strutturazioni storiche e teoriche.
Il suo libro più interessante in
questo senso è L’enigma della
moneta, uscito appena due anni
fa. Qui l’autore tenta un ripensamento basato sulla meditazione
di Keynes circa i tre tratti caratteristici della moneta nei tempi:
unità di conto per la misurazione del valore delle merci, mezzo
di scambio e riserva di valore. Di
queste tre componenti, indaga
soprattutto quella di riserva di
valore, che è il tratto fondamentale della moneta capitalista: la
disponibilità, cioè, ad essere accumulata e scambiata in quanto
capitale. Questa possibilità, ben
concreta e solidamente realizzata nell’economia di oggi, non
sarebbe un tratto naturale ma il
risultato di una deviazione originaria, di un sentiero imboccato
dall’economico a una certa soglia
della storia e da allora mai più
abbandonato. L’ingresso in questo “sentiero di mancina” avrebbe
permesso al denaro di configurarsi come riserva di valore e quindi prendere posto tra le altre
merci come possibile oggetto degli scambi: da qui l’economia
finanziaria.
La moneta originaria è indagata da Amato con gli strumenti
della fenomenologia heideggeriana applicata, tra l’altro, a un
fondamentale passo dell’Etica Nicomachea di Aristotele (1). Il
risultato di queste letture è un ripensamento che presenta la
moneta come un ente esemplare, irriducibile e incomparabile
agli altri proprio per il fatto di essere incaricato della verità degli enti stessi: in senso greco (e heideggeriano), del loro svelamento. “La moneta come istituzione è quell’ente messo in opera affinché, in esso e grazie a esso, una verità sia” (2). In quanto
tale è fondamentalmente inappropriabile, “per la ragione assai
semplice che ciò che apre la dimensione dello scambio non può
a sua volta divenire oggetto di scambio, pena una radicale perdita di rapporto con la misura”. Se questa condizione di inappropriabilità della moneta viene meno, si apre la strada alla sua
trasformazione in merce e quindi all’economia finanziaria.
Rileggendo quindi Keynes alla luce di Heidegger, Amato
traduce il fenomeno della riduzione del denaro a merce come
“
Ogni nuova
economia dovrà
prendere le mosse
dal fenomeno
originario della
moneta
”
10
n. 04/2012
francese di Nantes. Costruito come una rete di aziende e privati che consensualmente accettano di ricevere una parte dei
pagamenti in valuta complementare, il progetto affascina perché la valuta di Nantes, il bonùs, è strutturata in modo da non
ammettere la funzione di riserva di valore, e quindi la possibilità di accumulo.
Come è possibile? Presto detto: la somma depositata in bonùs sul conto corrente, se non è spesa entro un certo lasso di
tempo, è diminuita di una percentuale. Il valore di un conto
corrente immobile diminuisce progressivamente: un procedimento esattamente antitetico a quello odierno, per cui il denaro depositato guadagna interesse nel tempo. Questo dovrebbe
ingenerare, all’interno del circuito locale, un flusso virtuoso di
circolazione monetaria inteso a risolvere il problema di quelle
periodiche crisi di liquidità che sono all’origine delle condizioni paradossali in cui versano oggi i mercati. Infatti, la circolazione coatta del denaro indotta dalla certezza del suo progressivo discioglimento in un nulla di valore sarà anche garanzia
di un ritorno di liquidità per chi si separa malvolentieri dal
gruzzolo: se non c’è possibilità di accumulo, banalmente, non
ci sarà incetta e il denaro dovrà inevitabilmente girare, abbassando così la pressione dei mercati (7).
Il funzionamento del progetto sarebbe un passo importante
per le coscienze e per la nostra vita quotidiana d’inizio Millennio. Guadagneremmo a un tempo un concreto progetto di
rifondazione del sistema monetario vigente e un ripensamento dell’economia su basi etiche. In Amato possiamo vedere
un isolato, grandioso tentativo di mettere in pratica l’invito
rivolto da Heidegger ai figli dell’Era della Tecnica a rimettersi
all’ascolto dell’essere, per trovare l’anello che non tiene nella
catena del nichilismo; oppure il folle intento di un reazionario
che vuole riportare il mondo all’età del baratto. La storia ci dirà
chi ha vinto.
Se ne potrebbe parlare: ne converrebbe anche chi si sforzasse
solo di adocchiare più attentamente la situazione di una classe
di ricchi i cui capitali immobilizzati dalla paura e dalla religione dell’investimento sembrano sottrarsi alla fruizione privata,
per consacrarsi a un più metafisico altare della “crescita” – uno
degli ormai tanti miraggi contemporanei che sempre più manifesta la sua natura di non-fine, di vuoto anelito a se stesso. Ma
c’è una ragione più profonda e non banale se Amato identifica la moneta non con la ricchezza ma con la più vera povertà.
Ce lo spiega ancora una volta Aristotele: “Questa in verità è la
mancanza (chrèia) che tiene unite tutte le cose: se infatti non
avessero bisogno di nulla, o se non avessero bisogno in modo
simile, lo scambio non vi sarebbe, o non sarebbe lo stesso; intendo che un sostituto della mancanza è diventata per noi la moneta, di comune accordo, e questo ha il nome di moneta (nòmisma) perché non è per natura, ma per convenzione (nòmoi), e
dipende da noi modificarla o porla fuori corso” (3).
La moneta originaria non è quindi un segno della ricchezza
di chi la possiede bensì un’attestazione della mancanza costitutiva che ha spinto originariamente gli uomini a unirsi in società
e ad aprire la dimensione dello scambio, così da compensare le
reciproche mancanze; e con questo è anche recuperata al senso
l’etimologia della parola stessa oikonomìa: dal greco oikéo, “abitare” e nòmos, “norma”, l’economia è quindi “norma dell’abitare”, possibilità e al tempo stesso necessità della convivenza
basata sul comune riconoscimento della mancanza come tratto
costitutivo dell’umano. Difficile non orecchiare in questa riflessione il presupposto della fenomenologia esistenzialista,
che vede l’esserci come manque-a-être, ente non pienamente
compiuto ma sempre incaricato del suo essere, ancora una volta
sotto il magistero di Heidegger (4).
È qui che viene in luce la portata etica del pensiero di Amato.
Se la moneta nasce come “fondo ipotecario della mancanza”,
bisogna riconoscere che in essa non si manifesta tanto la dimensione del valore e della potenza (come la devianza nichilista della moneta capitalista vorrebbe), quanto quella della povertà e del bisogno che spinge gli individui a unirsi in società
e inaugurare lo scambio come possibilità di una coabitazione
rispettosa della Terra. È una sconfessione esplicita del sogno di
potenza che accompagna il possesso di denaro, e quindi anche
della società per come noi tutti la concepiamo, come campo
sterile su cui si danno battaglia i titani della finanza, sotto gli
sguardi ammutoliti dei sommersi.
In questo senso il denaro è un nulla, come si diceva, in quanto simbolo del nulla. E solo alla deriva nichilista e alla perdita
della differenza ontologica si può riferire l’attuale concezione
della moneta come simbolo di valore, avviata nel solco della volontà di potenza. La perfetta formulazione della questione della
moneta, alla luce della riflessione di Heidegger e del pensiero
della volontà di potenza, si trova nelle ultime pagine: “Ciò che
si mostra già compiutamente con Bentham e che continua a
compiersi sotto i nostri occhi è, a tutti gli effetti, una sostituzione radicale di senso: la mancanza come tratto costitutivo
della moneta è sostituita dal valore come tratto costitutivo di
tutto ciò che è” (5).
Amato non è tuttavia solo un uomo di pensiero. Di recente, assieme a Luca Fantacci, suo collaboratore specializzato nel
pensiero di Keynes (6), ha avviato un progetto di moneta complementare, simile a quello ispirato alle teorie di Silvio Gesell
sulla moneta prescrittibile del Wir di Basilea, nella cittadina
(1) Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, traduzione di C. Natali, Laterza,
Roma-Bari 1999, 1132b 20-1133b 29, pp. 189-195.
(2) M. Amato, L’enigma della moneta, et al., Milano 2010, p. 14.
(3) Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, cit., p. 193. Ho tentato di mediare tra la versione franca e obiettiva di Natali, scarsamente interessata
agli aspetti economici della traduzione, e la lettura ermeneutica di Amato,
onestamente impenetrabile a meno di non seguire tutta la trattazione per
esteso. Si rimanda a M. Amato, L’enigma della moneta, cit., pp. 197-239.
(4) Si è parlato molto di “equivoco esistenzialista” contestualmente a
certe interpretazioni dello Heidegger di Essere e tempo. Se non nelle conseguenze, però, è certo che Heidegger non disapprovò, almeno nei presupposti, il lavoro del suo primo e più elogiato interprete, Sartre. Si veda la
lettera di Heidegger a Sartre, cit. in R. Safranski, Heidegger e il suo tempo,
traduzione di N. Curcio, TEA, Milano 1996, p. 422: “La sua [di Sartre]
opera è retta da una comprensione così immediata della mia filosofia quale
mai finora mi era capitato di incontrare”.
(5) M. Amato, L’enigma della moneta, cit., p. 257.
(6) Con Fantacci, Amato ha scritto un libro altrettanto interessante,
dal titolo profetico: M. Amato, L. Fantacci, Fine della finanza, Donzelli,
Roma 2009.
(7) Si veda anche l’esposizione audiovisiva dello stesso Amato sul sito
internet di Repubblica.
11
n. 04/2012
Il MAUSS
e l'economia del dono
di Stefano di Ludovico
N
el 1980 nasce in Francia, per iniziativa di un gruppo
di economisti e sociologi tra cui spiccano i nomi di
Alain Caillé e Serge Latouche, il MAUSS, Movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali, scuola di pensiero che,
come suggerito esplicitamente anche dal nome adottato e dal
relativo acronimo, intende richiamarsi, nei suoi propositi di
rinnovamento dell’indagine socio-economica, al fondamentale insegnamento del grande antropologo Marcel Mauss, la cui
opera, in particolare il celebre Saggio sul dono (1924-25), ha segnato una svolta nello studio delle società cosiddette primitive
e nella ricerca antropologica in genere. In quel testo lo studioso
francese evidenziava come l’atto del “dono”, articolato nel triplice obbligo di dare, ricevere e ricambiare, rappresenti il fondamento del legame sociale delle società arcaiche, dove esigenze ed intenti di natura essenzialmente relazionale e simbolica
appaiono prioritari rispetto a finalità esclusivamente materiali
ed economiche, pur in rapporto a contesti che in ogni caso assolvono pienamente la funzione di garantire il soddisfacimento
dei bisogni primari della collettività (1).
12
n. 04/2012
antropologo francese la sua autentica valenza, è possibile
mettere in discussione, nella loro complessità, i parametri sui
quali continuano a fondarsi attualmente le scienze sociali –
quelli secondo cui, in ultima analisi, sono sempre e soltanto
gli interessi economici a muovere ed indirizzare le azioni umane – per un’intrapresa che, lungi
dall’interessare le sole diatribe
accademiche di pochi addetti ai
lavori, va a sovvertire la comune
Weltanschauung dominante ed
i modelli stessi di socialità che
regolano l’odierno consorzio
umano.
È dal pregiudizio economicistico tipico della modernità che
quindi l’immaginario collettivo deve essere liberato, da quel
“martello economico” che ci
batte in testa – per usare una celebre espressione di Latouche – e
non ci consente di vedere e valorizzare altra dimensione dell’esistenza umana che non sia quella
relativa al soddisfacimento delle
necessità e degli interessi materiali. Più che limitarsi a proporre
un semplice modello economico
alternativo a quello imperante da due secoli a questa parte,
il MAUSS intende evidenziare
come i consessi umani, sulla base
di quanto dimostrato dallo studio delle società primitive fondate sul dono, possano basarsi
su presupposti “altri”, non necessariamente economici ed utilitaristici, senza per questo eludere
la necessità di soddisfare anche
i bisogni primari dell’uomo;
necessità che di fronte all’attuale crisi del modello di sviluppo
occidentale, incapace di mantenere le sue stesse promesse di benessere illimitato, si dimostrano
sempre più impellenti.
La riflessione del MAUSS
muove dalla critica al cosiddetto “primo paradigma” delle
scienze sociali, definito anche
“individualismo metodologico”,
che guida gran parte degli studi
e delle analisi contemporanee:
in base a tale criterio, erede della tradizione classica liberale e
giusnaturalista, la società è vista
come una semplice giustapposizione di singoli individui, ciascuno volto al perseguimento
del proprio interesse materiale, e l’uomo come mero homo
oeconomicus, il cui agire è mosso esclusivamente dalla ricerca
L’obiettivo che il Movimento anti-utilitarista si è innanzi
tutto prefissato è quello di valorizzare – riattualizzandola –
la lezione di Mauss, a partire dalla carica innovatrice e per
molti aspetti rivoluzionaria che presenta non solo in campo teorico, relativamente allo
studio delle realtà “primitive”
come della società in genere,
ma anche in merito ai possibili
risvolti nell’ambito della prassi e
quindi alla possibilità di incidere operativamente sulla contemporaneità stessa. Non a caso uno
dei fondatori, Serge Latouche,
è anche il principale animatore
della corrente della “decrescita”,
uno dei più interessanti ed originali movimenti di critica al
modello di sviluppo occidentale sorto negli ultimi anni e che,
per molti versi, può essere visto
come la trasposizione a livello
di proposta “politica” di ciò che
il MAUSS è andato elaborando
sul piano più strettamente teorico (2).
Secondo il Movimento antiutilitarista, il carattere dirompente dell’opera di Mauss non
sempre è stato colto ed evidenziato dalla stessa tradizione di
studi antropologici che pur di
essa si dichiara erede, tradizione che il più delle volte non ha
saputo liberarsi dal peso se non
dal vero e proprio pregiudizio
della mentalità moderna, quello di leggere ed interpretare il
passato con le lenti del presente,
attribuendo a contesti e civiltà
“altre” i modi di pensare e di vedere tipici del tempo attuale. In
base a quest’ottica anche il dono
non rappresenterebbe che una
delle tante modalità o varianti
in cui lo scambio economico,
il “mercato”, si è andato configurando nel corso della storia
e che gli uomini hanno istituito per garantirsi il possesso dei
beni materiali, in base a quella
visione economicista ed utilitarista che per gli apologeti della
modernità caratterizzerebbe e
regolerebbe universalmente i
rapporti umani.
È proprio il superamento di
tale pregiudizio, che ha finito
per distorcere e minimizzare anche il significato innovatore
dell’opera di Mauss, a rappresentare il manifesto del Movimento anti-utilitarista: restituendo alla lezione del grande
“
L’obiettivo che
il movimento
anti-utilitarista
si è prefissato
è di valorizzare
la lezione di
Mauss, a partire
dalla carica
innovatrice e
per molti aspetti
rivoluzionaria
che presenta, non
solo in campo
teorico
”
13
n. 04/2012
come vuole la logica mercantilistica. Ed essendo la relazione
un bisogno connaturato all’uomo, attraverso il dono questa
viene sentita come un qualcosa di “buono” in sé, di “disinteressato”, e non quale strumento utile al conseguimento di
qualcos’altro, ovvero il bene o il guadagno materiale, come
pretende il paradigma individualistico. Con tutta evidenza,
l’equivoco in cui esso cade nel collocare anche il dono all’interno dell’ottica utilitaristica dipende in ultima istanza dalla
“ragione strumentale” che guida le analisi dei suoi esponenti,
espressione di quella “logica dell’avere” tipica della modernità che altra dimensione dell’agire umano non sa concepire se
non quella di natura pragmatica. In alternativa, il MAUSS
intende recuperare invece la “logica dell’essere” e della “ragione finalistica”, secondo cui a caratterizzare l’essere umano
è anche e soprattutto l’agire fine a se stesso, motivato da valori riconosciuti come beni in sé, indipendentemente da ogni
secondo fine o interesse.
Parlare di azioni fine a se stesse o di atti disinteressati
non ci deve però far cadere nell’equivoco opposto, ovvero
di considerare quella del MAUSS come una prospettiva di
tipo moralistico o caritatevole, da contrapporre alla presunta “immoralità” della logica di mercato, quasi che il dono si
risolvesse in un gesto altruistico da far valere contro l’“egoismo” del sistema liberistico. Cadere in questo equivoco significherebbe avere una visione del dono alquanto astratta
ed irenistica, improponibile sia in ambito di ricerca sia in
prospettiva politica, fino a confonderlo con quella che più
propriamente sarebbe opportuno chiamare “donazione”, ovvero l’atto di amore gratuito ed incondizionato che nulla attende in cambio. In tal caso però ci troveremmo appunto in
ambito puramente etico, se non addirittura religioso, mentre
l’orizzonte socio-politico nel quale il MAUSS intende collocarsi vede nel dono un atto che presuppone di per sé la reciprocità, quindi l’aspettativa di accettazione e di contraccambio, sempre che questa, come sottolineato, sia intesa nella
sua valenza sociale e simbolica e non meramente economica
e materiale.
Ciò che quindi agli esponenti del MAUSS preme soprattutto sottolineare è che solo ad una visione riduttiva e superficiale il meccanismo del dono può apparire come una
variante dello scambio utilitaristico o, per contro, una sorta
di pratica di beneficenza – in ogni caso, un mero sistema di
distribuzione economica più o meno alternativo a quello di
mercato. Il dono instaura in realtà una relazione di cui la dimensione economica è solo uno degli aspetti conseguenti,
per ciò stesso subordinati e vincolati a quelli di altra natura,
in tal modo capovolgendo ciò che avviene nella moderna società di mercato, dove al contrario sono i rapporti economici
a fondare quelli umani. In una società incentrata sul dono
sono le relazioni tra le persone ad essere privilegiate rispetto
a quelle tra le persone e le cose, secondo quanto aveva già evidenziato un altro eminente antropologo francese “controcorrente”, allievo diretto di Marcel Mauss, Louis Dumont,
in merito alla contrapposizione tra società tradizionale e
società moderna, in cui l’economia, resasi progressivamente
autonoma da ogni ordinamento sociale, politico e religioso, ha finito per fagocitare questi ultimi mercificando ogni
aspetto della vita (3).
In tal senso la riflessione del MAUSS ci riporta alla lezione
del grande economista “eretico” e in parte ancor oggi mi-
del massimo profitto, secondo una logica di costi-benefici
a partire dalla generale precarietà delle risorse disponibili.
Ed è, questa, una visione considerata valida per ogni tempo e luogo, sorta di “archetipo” universale che rende intelligibile qualsivoglia contesto storico-sociale, sia la moderna
economia di mercato siano le economie arcaiche e premoderne, dove lo stesso meccanismo del dono viene ricompreso
all’interno della logica dell’interesse e dello scambio volto al
perseguimento di un utile materiale. E poiché ad ogni teoria
che si rispetti si affianca sempre una prassi conseguente, il
paradigma “individualistico” da semplice parametro di ricerca diventa criterio stesso per l’azione, norma di riferimento
delle condotte umane e sociali, prescrivendo ed esaltando
politiche volte a valorizzare la competizione e il perseguimento dell’utile personale, da cui, grazie al prodigioso quanto ineffabile intervento della “mano invisibile”, scaturiranno
poi l’utile ed il benessere collettivi. Se l’homo oeconomicus
spiega l’intera realtà storica e sociale, a tale modello è bene
che ciascun soggetto si ispiri e si adegui per il buon funzionamento e la prosperità dell’intera società. Ed è per questo
che, come detto, la riflessione del MAUSS, mettendo in discussione i parametri teorici delle odierne scienze sociali, è
indirizzata altresì a delineare nuovi modelli di interazione
umana e di azione politica che si presentino come alternativi
a quelli dominanti, in nome di una diversa visione dell’uomo
e della società.
Tale persuasione trova il suo fondamento in un nuovo
paradigma, quello del dono, che come può offrire nuovi e
più adeguati parametri di lettura del fatto sociale, così può
stimolare altre forme di prassi stessa. Imperniata com’è sul
reciproco obbligo di dare, ricevere e ricambiare, questa dinamica inserisce gli individui in una rete di relazioni stabile
e vincolante che prescinde da interessi e vantaggi materiali,
quanto meno diretti ed immediati. È la stessa antropologia
economicista sottesa all’individualismo ad essere messa in
crisi: come già le analisi di Mauss avevano evidenziato in relazione alle società primitive – e il discorso potrebbe estendersi alle economie dell’India antica come del feudalesimo
europeo, anch’esse assimilabili a tale sistema – attraverso il
dono i membri di una data comunità non si scambiano propriamente beni materiali, bensì, innanzi tutto, “beni simbolici”; ovvero non sono mossi dalla ricerca della mera utilità
economica, ma dalla volontà di fissare relazioni, il cui mantenimento dà sostanza concreta a quei valori etici, politici e
religiosi che reggono quella data comunità e di cui lo scambio di beni materiali rappresenta soltanto lo strumento.
Quello che la sociologia radicata nell’immagine dell’homo
oeconomicus non riesce a vedere è proprio questo: nel dono
il primus, ovvero il fine dell’agire sociale, è la relazione – e
con essa i valori simbolici che questa vivifica – costituendo il bene materiale oggetto dello scambio solo un mezzo,
un medium per il legame sociale. In considerazione di ciò,
il dono è sì un meccanismo che garantisce il soddisfacimento di bisogni, instaurando un legame di tipo economico, ma
all’interno di un contesto che è innanzi tutto relazionale e si
presenta come sovraordinato.
Allo stesso tempo, se è innegabile che dietro il desiderio
di donare vi sia un “interesse”, in questo caso si tratta però
dell’intenzione di stabilire o rinsaldare un legame, una relazione, e non ad ottenere un’utilità o un vantaggio economico,
14
n. 04/2012
all’interno della logica utilitarista, quello olistico – non
sfuggendo da par suo alla tendenza “totalizzante” propria
della modernità di leggere qualsiasi fenomeno tramite le sue
particolari lenti – vede in esso null’altro che il riprodursi a
livello dei singoli di meccanismi redistributivi decisi e dettati dall’alto, negando così agli
atti del dare, ricevere e ricambiare ogni valenza autonoma e
considerandoli alla stregua di
semplici comportamenti rituali e consuetudinari, ai quali del
resto per una simile prospettiva
qualsivoglia azione individuale
si ritrova ad essere ridotta.
Il MAUSS, al contrario, intende sottolineare proprio il
carattere libero e spontaneo
del dono, quale espressione
dell’autonoma e consapevole
determinazione dei diversi soggetti coinvolti nello scambio:
il legame sociale che esso va ad
instaurare vincola sì gli individui, ma non in base a modelli
e sistemi preordinati, bensì a
schemi e forme di interazione
dove le preferenze, le scelte di
ciascuno, nonché l’imprevisto e
l’insolito, svolgono gioco forza
un ruolo essenziale e decisivo.
Pur consapevoli del peso importante che la consuetudine,
e quindi il contesto oggettivo,
rivestono nell’ambito delle società tradizionali, gli esponenti
del MAUSS tendono ad evidenziare le potenzialità libertarie del donare, senza che queste
vadano però a confondersi con
l’individualismo proprio alla
logica di mercato, esaltando
parallelamente la sua chiara dimensione comunitaria.
Il dono, paradossalmente,
può essere considerato al tempo
stesso obbligato e libero: obbligato, perché sono pur sempre i
valori ed i principi che regolano
quella data comunità a fissare il
significato che esso assume per
i suoi membri; libero, perché
non vi è alcuna garanzia certa
in merito all’aspettativa che in esso si ripone, se non la scommessa sulla fiducia e la lealtà della controparte, da conquistare e rinnovare continuamente.
Esaltando la sua peculiarità sia rispetto al modello individualistico sia a quello olistico, il MAUSS ha buon gioco
così nel definire il dono come “terzo paradigma”, il quale,
più che presentarsi come alternativo ai primi due, li supera
dialetticamente, valorizzando la libertà del singolo e la co-
sconosciuto Karl Polanyi, il quale nelle sue opere aveva non
a caso collocato le economie premoderne fondate sul dono
tra quelle in cui la sfera economica era embedded, vale a dire
“inserita” nella società, ovvero nelle sue istituzioni come nel
suo immaginario “simbolico”, fino a confondersi con essa ed
a rendersi quasi irriconoscibile,
anziché incorporare in sé tutte
le altre istituzioni come accade con l’economia di mercato
propria del mondo moderno
(4). Polanyi spiegava così un
fenomeno a prima vista incomprensibile agli occhi dell’uomo
contemporaneo, intriso del
pregiudizio economicistico:
non solo le società premoderne
hanno sempre collocato l’economia all’ultimo posto della
loro scala di valori, ma, essendo questa intrecciata e confusa
con le altre dimensioni dell’esistenza, risultava impossibile
per quelle società concepirla
come una disciplina autonoma; per cui, se per altri rami
del sapere le civiltà del passato
ci hanno lasciato grandiose testimonianze del loro genio, per
la nascita della “scienza economica” come oggi la intendiamo dobbiamo aspettare Adam
Smith, ovvero l’Inghilterra del
Settecento (5), dove l’economia di mercato ha conosciuto
il suo primo trionfo!
La rivoluzionaria logica del
dono permette altresì di superare le incongruenze ed i limiti
insiti nell’altro modello spesso
adottato dalle scienze sociali
contemporanee in alternativa
a quello individualistico dominante, il cosiddetto paradigma
“olistico” o “secondo paradigma”, che invece di erigere il singolo e la sua utilità a strumenti
euristici del fatto sociale, pone
l’accento, secondo una logica opposta ma per molti versi
speculare alla prima, sull’organismo, sul tutto anziché sulle
parti, essendo il primo a determinare e condizionare l’azione e l’immaginario delle seconde. È una prospettiva, questa, che trova il suo risvolto
“politico” negli orientamenti statalisti e dirigisti di scuola
socialista, che svalorizzano la libera iniziativa del singolo a
favore di un più decisivo intervento pubblico, in opposizione alla prassi liberista che, come sottolineato, trova invece il
suo riferimento ideologico nel paradigma individualistico.
E come quest’ultimo arriva a ricomprendere anche il dono
“
Il MAUSS
intende
sottolineare
il carattere
spontaneo del
dono, inteso
quale espressione
dell'autonoma
e consapevole
determinazione
dei soggetti
coinvolti
nello scambio
”
15
n. 04/2012
di esaltare il “privato” o il “pubblico” li comprende entrambi
in una visione di tipo “comunitarista”.
Così, scendendo nel campo della proposta politica più
mirata, sono diverse le battaglie che da decenni ormai vedono impegnato il MAUSS come il movimento della “decrescita” e che, sempre sulla base di quell’ottica partecipativa
e comunitaria che le ispira, riguardano in generale la messa
in discussione delle politiche globaliste perseguite dalle istituzioni economiche internazionali (FMI, Banca Mondiale,
WTO) a favore del ripristino di forme locali e decentrate di
produzione e scambio, per arrivare nel particolare a proposte
quali la riduzione dell’orario di lavoro o l’introduzione di un
reddito minimo di cittadinanza (6). Sono battaglie che, al
di là degli specifici ambiti e settori a cui si riferiscono, sono
da ricollocarsi sempre all’interno dell’obiettivo di fondo,
ben più ambizioso e decisivo, che il pensiero anti-utilitarista
in ultima analisi persegue, ovvero quello di “decolonizzare
l’immaginario” economicista dell’uomo moderno e di andare
oltre l’“economia” stessa, perché l’uomo si riappropri della
sua vera natura e – sempre per usare celebri “parole d’ordine”
della “decrescita” – sappia pensare “altri mondi, altre menti,
altrimenti” (7).
esione sociale, secondo una logica di “rete” che, basandosi
sugli obblighi reciproci che i singoli liberamente assumono,
supera le istanze unilaterali – l’esasperato individualismo, il
rigido dirigismo – proprie degli altri due.
Partendo da tali presupposti questo modus vivendi può offrire tutta una serie di risposte anche politiche agli urgenti
problemi dei nostri tempi, di fronte alla crisi in cui i tradizionali approcci sia liberisti sia assistenzialisti sembrano fatalmente versare. E che il dono riporti per sua stessa natura
ad una logica eminentemente politica lo dimostra proprio
la dimensione “comunitaria” che esso instaura attraverso la
mediazione tra singolo e collettività che si viene a realizzare. Per usare le celebri metafore schmittiane, esso, basandosi
sulla fiducia e quindi sull’“alleanza” che ciascuno ha deciso
di contrarre con l’altro, permette di discriminare tra “amico”
e “nemico”, riportandoci all’essenza stessa del “politico”. In
altre parole, segna il passaggio dallo “stato di natura” – da
una situazione “a-politica” – allo “stato civile”, quindi alla
condizione specificatamente politica; passaggio che, nel suo
essere medium sociale per eccellenza, esso riesce ad esplicare
coerentemente di fronte alla miopia del “contrattualismo” di
tradizione liberale, che pretende di fondare il fatto sociale su
di un atto di semplice natura economica.
In tal senso questa logica si presenta altresì come espressamente “democratica”, se per democrazia si voglia intendere
l’effettiva “partecipazione” della comunità dei cittadini al
governo della cosa pubblica e quindi identificarla con il concetto originario stesso di “politica” quale politeía. Così, se
il paradigma individualistico trova la forma corrispondente
nella democrazia “rappresentativa”, dove governanti e governati sono legati da un rapporto puramente contrattuale
come riflesso delle relazioni antagonistiche di tipo soltanto
economico che vigono nella società, il dono favorisce forme
di democrazia “partecipativa”, ovvero di comunità dove “tutti si danno a tutti”, dove ognuno “dona” se stesso agli altri, superando quella frattura tra “società politica” e “società civile”
che oggi viene denunciata da più parti come uno dei mali
principali degli Stati liberali, sempre più distanti dalle reali
necessità dei cittadini ed incapaci di interpretarne adeguatamente gli effettivi bisogni di socialità e partecipazione.
D’altronde, pur in riferimento agli attuali contesti istituzionali, il modello partecipativo trova il suo naturale terreno di adozione proprio nell’ambito della società civile, nel
mondo del cosiddetto “terzo settore”, ovvero dell’associazionismo e delle società no-profit che, come noto, di fronte
alle difficoltà sempre maggiori che in merito incontrano sia
il mercato sia l’intervento pubblico, assolvono oggi decisivi
compiti di tutela dei diritti dei cittadini relativamente alla
sfera materiale ma anche a quella sociale in genere. E la logica che ispira tale settore è proprio quella del dono, fondata
com’è sulla mediazione tra le libere scelte dei suoi associati
e l’interesse collettivo che va a soddisfare, superando così la
prospettiva unilaterale e del mercato, che ha in vista solo la
libertà individuale tramite la ricerca dell’utile personale, e
dello Stato, che ha di mira solo l’interesse generale tramite
la costrizione pubblica. Una società che voglia ispirarsi alla
logica del dono sa quindi lasciarsi alle spalle la tradizionale querelle tra libero mercato o intervento pubblico e che di
fronte alle sfide che il mondo oggi ci pone sa offrire nuove
alternative, di natura appunto “associazionistica”, che invece
(1) Cfr. M. Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle
società arcaiche, Einaudi, Torino 1965.
(2) Per un’introduzione generale al pensiero del MAUSS, vedi soprattutto A. Caillé, Critica della ragione utilitaria, Bollati Boringhieri, Torino 1991 e S. Latouche, L’invenzione dell’economia, Bollati Boringhieri,
Torino 2010; in relazione al movimento della “decrescita”, S. Latouche,
La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano 2007 e Breve trattato
sulla decrescita, Bollati Boringhieri, Torino 2008. Sullo specifico tema
del dono, vedi in particolare A. Caillé, Il terzo paradigma. Antropologia
filosofica del dono, Bollati Boringhieri, Torino 1998.
(3) Di Louis Dumont (1911-1998) vedi soprattutto le due fondamentali opere Homo hierarchicus. Il sistema delle caste e le sue implicazioni, Adelphi, Milano 1991 e Homo Aequalis. Genesi e trionfo dell’ideologia economica, Adelphi, Milano 1984.
(4) Di Karl Polanyi (1886-1964) vedi in particolare La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974, La sussistenza dell’uomo: il ruolo
dell’economia nelle società antiche, Einaudi, Torino 1977 e Economie primitive, arcaiche e moderne, Einaudi, Torino 1980.
(5) È in tal senso che Serge Latouche arriva a definire l’economia
un’“invenzione” moderna, da cui il titolo della sua nota opera, sopra richiamata, L’invenzione dell’economia. Ovviamente ciò che era assente
nelle civiltà premoderne era la concettualizzazione dell’economia, non
certo l’economia stessa.
(6) Sulle concrete proposte politiche del MAUSS e del movimento della “decrescita”, oltre alle già citate opere, vedi anche S. Latouche,
Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla costruzione di una società altrenativa, Bollati Boringhieri, Torino 2005 e Come si esce dalla società dei consumi. Corsi e decorsi
della decrescita, Bollati Boringhieri, Torino 2011.
(7) Queste “parole d’ordine” danno anche il titolo a due opere di Serge Latouche, per l’appunto Decolonizzare l’immaginario. Il pensiero creativo contro l’economia dell’assurdo, EMI, Bologna 2004 e Altri mondi,
altre menti, altrimenti. Oikonomia vernacolare e società conviviale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004.
16
n. 04/2012
Ezra Pound:
poeta economista?
di Luca Gallesi
Q
uella del poeta svagato, con la testa tra le nuvole e lontano dalle preoccupazioni quotidiane è un’immagine
tanto comune quanto errata, poiché i poeti veri, quelli
che con le parole non ci giocano ma costruiscono visioni del
mondo, hanno i piedi ben saldi e la mente assai lucida. Già, perché poeti furono, tanto per fare qualche esempio, Omero e Virgilio, Dante e Leopardi, Goethe e Hölderlin, Yeats e Baudelaire,
Eliot e Pound; personaggi divisi da epoche e luoghi diversi, ma
accomunati dalla forte determinazione di usare il linguaggio nel
miglior modo possibile per descrivere sinceramente la realtà. Il
poeta è tale, di solito, per la sua grande sensibilità, che lo porta
inevitabilmente ad analizzare il mondo per scoprirne i difetti
e cercare di migliorarlo; questo è esattamente ciò che ha fatto
Ezra Pound, un grande poeta che oggi però viene ricordato più
per la sua forza morale e le sue scelte di campo che per i suoi
componimenti letterari – anche se tra le due cose non c’è una
sostanziale differenza.
17
n. 04/2012
che quello ghildista, di cui Orage era stato promotore, non
avevano minimamente riscosso l’interesse di Ezra. Attenzione che resta viva fino alla fine degli anni Dieci, per poi affievolirsi e infine riaccendersi e divampare all’inizio degli anni
Trenta, dopo che la crisi del 1929 ha trascinato il vecchio
mondo nella polvere.
Molto, fino a un recente passato, è stato scritto per relegare
il pensiero economico di Pound
nello sgabuzzino delle idee
screditate, tipiche del genio sregolato di un poeta e quindi prive di solidità scientifica; il suo
pensiero sociale è stato separato
dall’opera poetica, minimizzato e quindi condannato come
ingenuo, superficiale e soprattutto politicamente scorretto, e
quindi inappellabile.
Dagli anni Novanta del secolo scorso, invece, la comunità
scientifica ha cominciato a ragionare sia sulle scelte politiche
di Pound, a partire dall’ineludibile saggio di Tim Redman sulla sua adesione al fascismo (1),
per continuare con la trilogia di
Leon Surette, da Eleusi al Purgatorio passando per l’occulto
(2), fino all’essenziale raccolta
dell’allieva di Surette, Roxanna Preda, che ha curato pochi
anni fa la corrispondenza di
argomento economico del poeta americano, mettendone in
evidenza la coerenza e l’importanza (3). In Italia, ai curatori
dell’opera poundiana, come
Mary de Rachewiltz e il mai
troppo lodato editore Vanni
Scheiwiller, e agli studiosi accademici, come Massimo Bacigalupo, si affianca la produzione
di un brillante scrittore e giornalista come Giano Accame,
che analizza e affronta senza
pregiudizi le idee economiche
di Ezra Pound pubblicando libri (4), articoli e anche realizzando per RaiTre un originale
documentario della serie Intelligenze scomode del Novecento.
Il tabù si è così finalmente rotto
e, tra mille distinguo e con mille diffidenze, anche le idee politiche di Pound, incentrate sul suo ideale di giustizia sociale,
cominciano a essere prese in considerazione seriamente.
La prima sorpresa viene dalla scoperta che Pound non era né
il primo né l’unico artista o letterato a battersi contro la speculazione ma si inseriva a pieno titolo in un filone di pensiero
e azione politica, tanto britannica quanto americana, più che
Nato a Hailey, Idaho, nel 1885, Pound muore nel 1972 a
Venezia, e tra queste due date e questi due mondi c’è racchiusa
tutta la sua opera, che ha unito il Vecchio e il Nuovo Mondo,
attraversando le passioni, gli entusiasmi, le tragedie e i drammi
del Ventesimo secolo. Nei Cantos, l’opera incompiuta a cui ha
dedicato tutta la vita, il poeta ha
riversato la sua incessante ricerca
del bello, che è anche il giusto,
il vero e il buono. Poema epico,
i Cantos sono intrisi di economia, esattamente come la Divina
Commedia lo è di teologia; l’economia è il motore della modernità, così come la teologia lo fu per
l’età di mezzo, e il suo primato
caratterizza la politica e la storia
degli ultimi duecento anni.
Come si può vedere dai componimenti giovanili, all’inizio della sua carriera letteraria
Pound è un romantico estetizzante, figlio del lungo crepuscolo dell’Ottocento, ma la Grande
Guerra gli fa rapidamente cambiare idea: nel poemetto Hugh
Selwyn Mauberley dà l’addio
alle “dolciastre confessioni” per
denunciare gli orrori di un’inutile strage che “ne ha fatti morire una miriade / e dei migliori,
fra tutti gli altri, / per una cagna sdentata, /per una civiltà
rappezzata”.
Tra le vittime si contano molti
suoi cari amici, come il filosofo
Thomas Ernest Hulme e lo scultore Henri Gaudier-Brzeska, che
aggiungono al dolore per il lutto
la rabbia per il loro insensato e
inutile sacrificio, che ha contribuito a distruggere ulteriormente la civiltà europea, arricchendo gli speculatori. Bisogna
fare qualcosa, impegnandosi innanzitutto a capire le cause della
guerra, per poi neutralizzarle.
Ad aiutarlo nella comprensione
arriva, nella redazione di The
New Age, rivista della quale era
uno dei più assidui collaboratori, un bizzarro personaggio,
il “Maggiore” Douglas, ovvero
l’ingegnere Clifford Hugh Douglas, maggiore della riserva della R.A.F., che convince il direttore del periodico Alfred Richard Orage ad abbracciare le sue
teorie economiche, note come Social Credit (Credito Sociale),
che vengono pubblicate sul New Age e poi raccolte in più volumi, a cura di Orage stesso.
Questo è il primo incontro di Pound con l’economia; esso
lo coinvolge, perché, fino ad allora, sia il socialismo fabiano
“
Il pensiero
economico di
Pound è stato
separato dalla
sua poetica,
minimizzato e
condannato
come ingenuo,
superficiale e
soprattutto
politicamente
scorretto, quindi
inappellabile
”
18
n. 04/2012
per l’Italia, dove si era stabilito dal 1924, e che sembrava reggere meglio della sua patria americana i problemi economici;
da allora fino al 1945, riempie anche la sua produzione poetica di teorie economiche e I Cantos, da poema epico, diventano
– anche – un’opera ricca di economia.
Questa conversione non è piaciuta a molti studiosi e accademici che hanno cercato di separare nettamente la letteratura
di Pound dalle sue idee politiche e dalle teorie economiche,
ma l’impresa è risultata impossibile: recentemente, forse a
causa della crisi da lui profetizzata con largo anticipo, anche
le sue idee economiche sono state ammesse nei salotti buoni,
seppure con riserva.
Il citato volume di corrispondenza economica dimostra
che Pound non era né pazzo né, e questo è il dato più interessante, un bizzarro genio isolato e incompreso. Pound fu
“un intellettuale integrato in un movimento per la riforma del
capitalismo”(8) che si è sviluppato tra le due guerre e ha avuto dignità intellettuale e solidità scientifica. Tra i primi numi
tutelari scelti da Pound ci sono Douglas e Orage, teorici del
Credito Sociale, seguiti a partire dall’inizio degli anni Trenta
da un altro eretico, Silvio Gesell, le cui teorie sul denaro prescrittibile erano state brevemente adottate dal borgomastro di
Woergl, un paesino tirolese (9). Il poeta tenta invano di creare
una sintesi tra le due teorie, ma si trova contro i seguaci di
Douglas, tra cui Gorham Munson e John Hargrave, e quelli
di Gesell, tra cui Hugo Fack, Irving Fisher e Eugene Sydney
Woodward.
Pound non si lascia scoraggiare e inizia a tessere, più o meno
pazientemente, una fitta rete di rapporti tra studiosi e politici di tutto il mondo e di svariati orientamenti, proponendo, ascoltando o semplicemente segnalando a tutti l’esistenza
degli altri, per rendere più efficace la sua battaglia contro la
speculazione e lo sfruttamento del lavoro dell’uomo.
Il sogno si infrange con lo scoppio della guerra, da Pound
inutilmente avversata – il risveglio definitivo e tragico avviene
nel 1945, in una gabbia per gorilla.
dignitoso e ricco di talenti. La parte americana toccava il poeta
nella sua storia personale e affondava le radici nel populismo
USA che ha caratterizzato politicamente, con il People’s Party, la fine dell’Ottocento ma che si riallaccia nitidamente alla
tradizione, prima jeffersoniana e poi jacksoniana, di critica e
lotta contro gli speculatori dell’economia finanziaria, a fianco
dei produttori di quella reale, vale a dire soprattutto i contadini. Quello che diverrà il titolo di un suo polemico libello
pubblicato direttamente in italiano, Oro e Lavoro, inquadra
e definisce chiaramente i termini della questione: o si sta con
i lavoratori, che svolgono qualsiasi tipo di lavoro, compreso
quello intellettuale e artistico, o ci si schiera con gli usurai, che
si arricchiscono come parassiti sulla fatica altrui.
Il filone britannico è invece composto da quella nutrita pattuglia di scrittori che hanno visto e criticato gli orrori della Rivoluzione industriale, cercando una soluzione in una visione
“spirituale” della vita che disprezzava il materialismo di Marx.
A partire dall’antiutilitarismo di Carlyle, passando per l’economia politica di Ruskin e arrivando al socialismo medievaleggiante di William Morris, sono tanti i critici della modernità che, più o meno direttamente, hanno avuto influenza su
Pound. Del resto, basta rileggere qualche brano di Ruskin per
notare la straordinaria affinità con il pensiero poundiano: “La
moneta in se stessa non è altro che un documento trasferibile,
in uso nelle comunità umane, che dà diritto, a vista, a certi
precisi benefici o vantaggi, normalmente a una certa parte dei
beni reali disponibili. Essa è genuina solo in quanto i beni cui
dà diritto sono reali, o i vantaggi certi; altrimenti è «fasulla»,
e può essere considerata un falso, sia che venga emessa da un
governo o da una banca, che da un individuo”(5). E ancora:
“Una nazione fondata sul lavoro, e che abbia cura dei frutti
del proprio lavoro, sarebbe prospera e felice anche se in tutto
l’universo non vi fosse un solo grammo d’oro. E una nazione
oziosa e incline a dissipare il prodotto del proprio lavoro, qualunque esso sia, sarebbe povera e miserevole anche se le sue
montagne fossero d’oro massiccio, e le sue conche ricolme di
diamanti anziché di ghiaccio” (6).
Il pensiero, che potremmo indicare – un po’ cacofonicamente – come “antiusurocratico”, a cui Pound attingerà ha orizzonti vastissimi anche tra i suoi contemporanei, che lui stesso ci
indica in un articolo pubblicato in italiano nel 1937 sul numero di maggio-giugno di Rassegna Monetaria, intitolato Verso
un’economia ortologica, in cui ne traccia una rapida mappa: “È
naturale purtroppo che nelle pubblicazioni economiche regni
la confusione dato che lo studio dell’economia attualmente
viene fatta da empirici, da uomini che mancano di una seria
preparazione terminologica. Vediamo per esempio nel mondo
anglo-sassone quali sono gli scrittori onesti e seri che hanno
costruito la scienza economica viva. Soddy, premio Nobel per
la fisica; Douglas, ingegnere capo del Westinghouse in India;
Larranaga, ingegnere stradale; Orage, giornalista convertito
da Douglas; Kitson, inventore della lampada Kitson; Gesell,
commerciante; ecc. Tutti uomini pratici!” (7).
E, da uomo pratico qual era anche Pound, dal 1931 al 1936
si rimette a studiare economia per cercare una soluzione alla
crisi mondiale iniziata nel 1929. Riprende le teorie del Credito Sociale che lo avevano incuriosito una dozzina di anni
prima e ne ricava una sintesi da aggiungere e mischiare ad altre
teorie eterodosse che gli sembrano additare una via di uscita
dal tunnel della recessione globale, con un occhio di riguardo
(1) Cfr. T. Redman, Ezra Pound and Italian Fascism, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
(2) Cfr. L. Surette, A Light from Eleusis, Clarendon Press, Oxford
1979; The Birth of Modernism, Mc Gill-Queen’s University Press, Montreal 1993; Pound in Purgatory, University of Illinois Press, Urbana and
Chicago 1999.
(3) Cfr. Ezra Pound’s Economic Correspondence, 1933-1940, a cura di
R. Preda, University Press of Florida, Gainesville 2007.
(4) Cfr. G. Accame, Ezra Pound economista, Settimo Sigillo, Roma
1995.
(5) J. Ruskin, Economia politica dell’arte, Bollati Boringhieri, Torino
1991, pp. 141-142.
(6) Ivi, p. 144.
(7) E. Pound, Verso un'economia ortologica, in Lavoro e usura, prefazione di P. Savona, All'Insegna del pesce d'oro, Milano 1996, p. 128.
(8) Ezra Pound’s Economic Correspondence, cit., p. 1.
(9) Cfr. E. Pound, Carta da Visita, a cura di L. Gallesi, Bietti, Milano
2012, pp. 55-56.
19
n. 04/2012
La sovranità sul debito
di Luigi Iannone
L
a globalizzazione è fenomeno antico. Hirst e Thompson
la collocano tra il 1870 e il 1914 e Wallerstein all’epoca
delle scoperte geografiche (1). Ma in un contesto come
quello attuale, dove la capacità di coinvolgimento dei cittadini che partecipano ad una socialità comune tende sempre più
a scemare, vengono evidenziate – come mai era accaduto nella storia dell’uomo e in tutta la loro pericolosità – le relazioni
asimmetriche tra politica ed economia. Ed è evidente la dissonanza tra il quadro ermeneutico che il pensiero dominante
ci propina e i fenomeni empirici sui quali quotidianamente ci
misuriamo. Tali relazioni rappresentano solo un aspetto, necessario ma tutt’altro che sufficiente, per comprendere come i
processi della governance mondiale siano radicalmente mutati
e come la validità teorica della moderna globalizzazione vada
sottoposta a verifiche non approssimative per non incorrere
nell’errore, già segnalato da Giorgio Agamben, di porre la più
oscura e irrazionale delle religioni, quella del denaro, al centro
di ogni ragionamento oltre che di ogni azione.
20
n. 04/2012
Questo capitalismo deterritorializzato può mettere in disparte l’economia reale, senza che la mano invisibile regoli più nulla
(3), ha la forza di imporre sui mercati di scambio contrattazioni
del valore di svariate volte il PIL mondiale e mobilita le masse
affinché si favorisca la crescita attraverso il consumo. Alla luce
di questi elementi è chiaro che la centralità e l’influenza dei
mercati finanziari a livello globale sono smisurate. Un capitalismo finanziario che dà conto del suo operato solo agli azionisti
e dove quasi il 70% dei flussi è controllato da una dozzina di
banche e SIM. Tutto ciò non va decontestualizzato, altrimenti
ci si nasconde furbescamente dietro lo spettro dell’eccezionalità: questa è la sua logica di fondo, che si regge anche sul tentativo di un deterioramento antropologico sotterraneo, durevole
ma evidente.
È quanto mai arduo fornire una topografia esaustiva dei problemi ma la mobilitazione instilla dosi crescenti di paura grazie
a previsioni sempre più pessimistiche, che obbligano a restringere ancora di più i diritti, le sicurezze sociali e le condizioni di
lavoro. Nel suo percorso di trasformazione collettiva determina
diseguaglianze crescenti che si evidenziano soprattutto attraverso canali conosciuti: riduzione del welfare e riassorbimento
della capillare rete di garanzie previste dal diritto del lavoro, disoccupazione, delocalizzazioni (il che permette di privare anche
i sindacati nazionali di capacità contrattuale), deindustrializzazione con guadagni speculativi, riduzione dei salari (che, come
in un circolo vizioso che si auto-alimenta, indurrà le famiglie ad
indebitarsi), precarizzazione del lavoro e contestuale sostegno a
politiche di immigrazione per favorire il basso costo della manodopera, innalzamento dell’età pensionabile, eccetera.
Perpetuando il proprio asservimento alla ricerca illimitata
della ricchezza si provoca quel deterioramento antropologico
di cui sopra e un radicalizzarsi delle tendenze narcisistiche. Cristopher Lasch le ha tratteggiate nel suo libro più famoso, del
1979, in cui descrive questa nuova narrazione su base nichilista,
dove il soggetto si afferma grazie all’accumulo di beni per distinguersi dalla massa, dalla società e dalla famiglia (4). Di grave
c’è che ora questa mobilitazione individuale modella anche lo
spazio pubblico: l’essere individui e non società si associa ad
una ossessione per la sicurezza e si traduce in un pregiudizio per
la dialettica politica e per le scelte di carattere collettivo. Una
volta che questo processo è giunto a compimento, affermazioni
come quella di Margareth Thatcher, “non esiste la società, esistono solo gli individui”, possono essere contrabbandate come
uniche verità.
In più, proprio perché c’è questo rinchiudersi in una sorta di
solitudine solipsistica, tende a scemare l’aspirazione al futuro
che aveva alimentato i processi democratici nella seconda parte
del Novecento e rinvigorito il dibattito pubblico. È un capitalismo che ha “pulsioni autodistruttive” perché non vuole più nessun interlocutore sociale o politico (5), peraltro – diversamente
dal passato – sostenuto da una forza titanica come la Tecnica e
in perfetta simbiosi con essa.
Le ricchezze si muovono a velocità vertiginosa da un capo
all’altro della terra come mai era avvenuto, e contestualmente
si smantellano diritti giuridici con la stessa facilità con cui si
vendono e comprano titoli azionari. La tecnologia velocizza
infatti in maniera impressionante le operazioni ed è moltiplicatrice degli investimenti. Più del 50% degli scambi di Wall
Street sono definiti high frequency trading, cioè gestiti da computer e dai loro algoritmi e si basano sulla duplice pretesa con-
Le vicende degli ultimi anni forniscono abbondante materiale per non cadere in questa tentazione e se si mantiene una linea
di oggettività si scopre una situazione assai diversa da quella
descritta dai media. Infatti, dalla globalizzazione economica
emerge, da un lato, un quadro inclusivo senza dubbio positivo
contrassegnato dalla interdipendenza, dalla fluidità delle comunicazioni e degli scambi commerciali e dalla mobilità delle
persone; dall’altro, come questi stessi elementi, se incrementati all’ennesima potenza, debbano essere indisgiungibili da una
riflessione che li segnali anche come moltiplicatori di diseguaglianze sociali.
La ricerca empirica mostra che nell’interpretare la moderna
mentalità capitalistica è perciò utile non aderire ad una logica
catastrofista e, per un altro verso, in maniera complementare,
raccogliere la sfida facendo appello a motivazioni che appartengono sia alla sfera degli interessi particolari e privati sia ai valori
comunitari, perché la questione riguarda l’incapacità della politica nel riformare un modello di società che contrappone Stato
e mercato e assolutizza il momento individuale rispetto a quello
collettivo.
Tale mentalità trova tuttavia corrispondenze nel quotidiano,
sovrastando ogni aspetto del vivere civile, e si impone come una
delle questioni centrali del nostro tempo. Che si sia affermato
un modello di tal genere, accompagnandosi ad una naturalizzazione del disagio sociale che tende a rendere croniche le condizioni di marginalità, e quanto siano distanti un’etica sociale
dalla moderna etica economica ridotta a crematistica, è sotto
gli occhi di tutti.
La crisi divampata in tutta la sua furia in questo primo scorcio
di terzo millennio ha molte cause, solo in parte riconducibili al
passato: “Il vocabolo crisi – scriveva Ivan Illich nel 1978 – indica
oggi il momento in cui medici, diplomatici, banchieri e tecnici
sociali di vario genere prendono il sopravvento e vengono sospese le libertà. Come i malati, i Paesi diventano casi critici. Crisi,
parola greca che in tutte le lingue moderne ha voluto dire ‘scelta’
o ‘punto di svolta’, ora sta a significare: ‘Guidatore dacci dentro!’
Evoca cioè una minaccia sinistra, ma contenibile mediante un sovrappiù di denaro, di manodopera e di tecnica gestionale” (2).
La causa più evidente è intrinseca al modello economico ed
al fatto che i rapporti con la politica si siano diametralmente
capovolti. È proprio partendo da tali presupposti che le pretese morali di volta in volta sollevate dall’azione politica paiono
non avere più alcun senso. All’inizio, come in un incendio che
si propaga lentamente e poi diventa devastante, il mondo aveva
accolto supinamente le prime avvisaglie e questa crisi era vista
come un momento di transizione, dato che riguardava essenzialmente l’indebitamento delle famiglie americane; in breve
tempo si è passati alla crisi dei subprimes, cioè i prestiti ipotecari
ad alto rischio, ed infine al sovraindebitamento degli stati nazionali che quando si appesantiscono con prestiti a lungo termine sanno di dover pagare interessi assurdi.
Non secondario è il ruolo della Banca Centrale Europea e
del Fondo Monetario Internazionale che garantiscono dei tassi
più abbordabili ma come contropartita pretendono un rigore
economico che, se portato alle estreme conseguenze, ha effetti
devastanti sulla vita dei cittadini. Ora, la riduzione della economia reale a scapito della finanza, l’aumento del debito pubblico
ed una guerra dichiarata apertamente tra ciò che resta degli stati
nazionali e gli speculatori ha fatto esplodere una economia di
indebitamento che dà in pegno il futuro.
21
n. 04/2012
scelte fatte da altri, e quindi opti per l’integrale adesione a tale
modello, agendo solo per “tranquillizzare i mercati”.
Questo incontro alchemico viene portato a termine tramite l’assunto per cui la politica agisce solo localmente mentre
il capitalismo opera globalmente e con strategie di lungo periodo. Quest’ultimo infatti sembra non più capace di autoregolamentarsi, dando così sfogo alla sua teoria palingenetica
di salvezza e, quindi, temi come la rappresentanza popolare, la
democrazia e la solidarietà vengono ritenuti solo utili grimaldelli ideologici con la conseguenza, del tutto dimostrabile, di
non essere mai concretamente connessi con il mondo reale.
Da questo punto di vista, se gli Stati non sono più vantaggiosi per alcun tipo di interesse è difficile prevedere che la sovranità, così come si è andata costruendo negli ultimi due decenni,
possa sopravvivere, soprattutto se il vero potere si muove beneficiando delle massime libertà e franchigie. Già da adesso gli
Stati operano da cuscinetto, nella misura in cui si comportano
quasi esclusivamente come negoziatori tra interessi sovranazionali e transnazionali e interessi particolari interni e quindi
la politica, nel tentativo di modellare un nuovo rapporto tra
capitalismo e democrazia, dovrebbe intercettare meccanismi
in grado di controllare i movimenti del capitale finanziario e
non solo di rilevarne le incongruenze ed imporre alla Borsa di
fare quello che aveva sempre fatto, cioè finanziare le aziende.
Come emerge assai nitidamente dalla situazione attuale,
servono soluzioni politiche globali affiancate da forme partecipate a livello locale e più penetranti di democrazia diretta.
Ciò sarebbe già un buon punto di partenza. In realtà, sarebbe
necessaria una radicale correzione delle posizioni teoriche di
fondo. Il fatto che, per esempio, la popolazione continui ad
aumentare a dismisura, le risorse siano limitate e si invochi
lo sviluppo infinito (quasi a rendere illimitato ciò che per sua
natura non lo è) evidenzia un corto circuito ideologico “e soltanto una fede tenace e irrazionale può spiegare il fatto che
gli economisti e i loro adepti continuino a non capirlo” (7).
In definitiva, nessuno vede come soluzione un ritorno a forme precapitalistiche ma è altrettanto sbagliato pensare che la
condizione attuale si possa imporre come affermazione storica
definitiva di una “metafisica capitalistica”.
traddittoria di garantire nella stessa misura profitti e sviluppo
sociale, interessi di parte e bene comune.
Si aggiunga che questo apparato nichilistico che slega completamente l’economia finanziaria da quella reale, anche se
non viene riconosciuto nella sua concreta configurazione,
assume la forma di una totalità strutturata difficilmente scalfibile. E ciò ha contribuito alla rimozione di ogni residuo trascendente, che ormai si realizza solo nella dimensione privata.
Ne era stato acuto osservatore Augusto Del Noce, quando ne
Il problema dell’ateismo affermò che pure il processo delineato
dallo storicismo marxista sarebbe stato riassorbito dalla concezione nichilistica del capitalismo.
Si è arrivati, negli ultimi decenni, alla globalizzazione come
processo sempre in fieri e al suo carattere intrinsecamente
ideologico in cui si tende a sopravvalutare oltre ogni misura
l’efficienza dei meccanismi di produzione e consumo, accompagnandoli con definizioni moraleggianti universalmente valide (democrazia, diritti umani, libertà economiche, eccetera)
ma in una prospettiva diametralmente opposta all’antica idea
di globalità, che garantiva le identità pur nell’ottica di scambi
commerciali e mobilità di persone e culture (6).
Questo nucleo di valori si inserisce in una cornice di filosofia
della storia nella quale, per dirla con Fukuyama, essi vengono
definiti universalistici ma solo in quanto occidentali e perciò
esportati come fossero delle merci. La conseguenza è che gli
“altri” sono implicitamente accusati di ritardare la fine della
storia, di essere d’intralcio all’affermazione e al consolidamento di una nuova politica che si fonda sul primato dell’economia, la retorica dei diritti e l’esaltazione dell’individualismo.
Questo capitalismo totalitario può esercitare prerogative
sovrane perché ci avviamo in un mondo unificato dalla economia e cristallizzato nello scenario disincantato delle merci, e
l’idea non più peregrina di uno Stato planetario rappresenta il
consolidamento finale di un nòmos che dovrebbe passare attraverso momenti intermedi di cui già intravediamo gli albori. Facendo infatti maturare l’esperienza di un modello multipolare
che aiuterà a rendere standard preferenze e scelte individuali,
tutti i processi potranno prima o poi essere ricondotti alla specificità occidentale. In un contesto di questo tipo aumentano
le diseguaglianze sia tra i Paesi sia all’interno di ciascuno di
essi (ciò va letto in parallelo con quanto accade in Asia, in specie in Stati come la Cina, dove si cresce grazie a strumenti di
sfruttamento della forza-lavoro e vengono sperimentate forme “spurie” di capitalismo, mentre, al contrario, solo l’Africa
continua ad impoverirsi nonostante il neo-colonialismo delle
multinazionali).
Un ulteriore elemento negativo è rappresentato dal fatto che
il capitale finanziario elude il controllo degli Stati ai quali non
resta che “la sovranità sul debito”. Il rigore economico, infatti,
oltre ad aver chiarito che la sovranità monetaria non appartiene più ai singoli Stati, pone al centro di ogni politica la questione del debito. Le banche (ma anche le multinazionali, le
società d’affari e quant’altro) sono per loro natura impolitiche
ed è quindi illusorio pensare che possano avere un benché minimo afflato verso l’interesse nazionale. Fino a qualche anno
fa chiedevano agli Stati di essere aiutate – pena il fallimento
– ora invece incamerano profitti enormi e si muovono con
l’abituale spregiudicatezza. Non deve perciò essere trascurato
il fatto che la politica non governi i processi in corso ed in una
sorta di accettazione passiva dell’esistente appaia succube di
(1) Cfr. P. Hirst, G. Thompson, La globalizzazione dell’economia, Editori Riuniti, Roma 1997; I. Wallerstein, Il sistema mondiale dell’economia moderna, Il Mulino, Bologna 1997.
(2) I. Illich, Disoccupazione creativa, Boroli, Milano 2005, p. 95.
(3) Cfr. A. Smith, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle
nazioni, Mondadori, Milano 1977, pp. 442-444. Contestualmente andrebbe ricordato anche Teoria dei sentimenti morali, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1995, p. 660.
(4) Cfr. C. Lasch, The culture of Narcissism: American Life in an Age of
Diminishing Expectations, Warner Books, New York 1979.
(5) Cfr. L. Gallino, L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino 2005,
p. 258.
(6) Cfr. U. Beck, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della
società planetaria, Carocci, Roma 1999, pp. 22-27.
(7) S. Latouche, L’invenzione dell’economia, Bollati Boringhieri, Torino 2010, p. IX.
22
n. 04/2012
Demondializziamoci!
di Simone Paliaga
S
embra una boutade e in Italia la voce ha appena fatto capolino. Eppure altrove, intorno a essa, ci hanno addirittura costruito una campagna elettorale. La scorsa primavera, le pagine dei giornali francesi rigurgitavano del neologismo.
Arnaud Montebourg, uno degli aspiranti candidati socialisti
alle presidenziali, in occasione delle primarie del suo partito
si è scagliato contro i cantori della globalizzazione e i fautori
dell’austerità, dichiarando apertamente che, per uscire dalla
crisi e restituire dignità ai francesi, sarebbe occorso avviare un
processo di demondializzazione, come ricorda nel suo libro, diventato poi il suo programma politico: Votez pour la démondialisation! (Flammarion, 2011). Solo uscendo dal circolo vizioso
della deregulation dei mercati e restituendo sovranità economica al popolo, secondo il candidato, sarebbe possibile relegare nel
passato la crisi che sta attanagliando la Francia e il continente
europeo. Prima di sbarcare però nell’agone politico, la parola ha
avuto una gestazione intellettuale, anche se ha faticato ad attirare l’attenzione dei media prima di passare sotto il vaglio degli
spin doctor del candidato socialista.
23
n. 04/2012
Per riassumere, nel senso corrente, la mondializzazione (o
globalizzazione, secondo il calco dall’inglese) definisce la situazione in cui si è trovata l’economia mondiale dopo il fallimento delle economie socialiste in Europa orientale, alla fine
degli anni Ottanta. Il suo consolidarsi va di pari passo con
il diffondersi del pensiero neoliberale, persuaso dell’onnipotenza e onnipresenza della logica mercantile, e l’esplosione
delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In una ventina d’anni la mondializzazione ha provocato un duplice effetto: da un lato un movimento di omologazione delle culture sul modello americano, dall’altro delle
forme di reazione identitaria. Di fronte a questo fenomeno,
gli anni Novanta hanno visto dividersi gli animi e l’apparire
di numerosi movimenti di contestazione. Gli antimondialisti da una parte, che si opponevano al processo di mondializzazione da intendersi nel senso letterale del termine (vale a
dire l’estendersi su tutto il pianeta di una medesima idea, di
una stessa organizzazione, ecc.), alla sua natura, al suo metodo e ai suoi effetti. E gli altermondialisti dall’altra, che non
vi si contrapponevano, reputandolo in sé positivo e fonte di
occasioni emancipatrici, ma ne criticavano soltanto l’evoluzione neoliberale.
È nel 2002 però, grazie alla penna del pensatore filippino Walden Bello, che appare il concetto di demondializzazione e prende posto nel dibattito internazionale. Nel testo
Deglobalizzazione. Idee per una nuova economia mondiale
(Dalai, 2004), l’autore spiega che la mondializzazione s’è costruita a spese dei paesi del Sud del pianeta. Appellandosi
alla necessità di un controllo politico dei sistemi economici,
Bello denuncia i rischi nascosti dall’esaltazione della mondializzazione in corso. Il processo avviatosi con il crollo del
muro di Berlino autonomizza le pratiche economiche dalla società, rendendole insensibili alle esigenze degli uomini
e della comunità. Propone, per uscire dai pericoli imposti
dalla liberalizzazione dei mercati, uno smantellamento delle istituzioni finanziarie internazionali (in particolare Banca mondiale, FMI, OMC) e si pronuncia a favore di una
rilocalizzazione delle attività economiche. E se per lungo
tempo le ricette di Bello sono rimaste confinate alle pagine del suo libro, in un contesto di crisi economica come
l’attuale i suoi propositi hanno trovato numerose eco sia
presso altri autori (tutti europei) sia presso uomini politici.
Ripercorrere il dibattito sulla demondializzazione, in corso
particolarmente Oltralpe, permette di chiarire le diverse accezioni con cui questa idea è stata usata.
Nel suo ultimo libro, La via. Per l’avvenire dell’umanità
(Cortina, 2012), il teorico della complessità Edgar Morin
sposa le tesi sviluppate da Bello e spiega che “la demondializzazione darebbe una nuova vivacità all’economia locale e
regionale. (…) Significa egualmente il ritorno all’autorità degli Stati e costituisce un antagonismo necessario, vale a dire
complementare, alla mondializzazione”. Prima però di finire
nell’agenda politica dei candidati francesi, e al di là di questa
concezione conforme a quella partorita dall’autore asiatico,
la demondializzazione ha trovato altri difensori, che, a seconda della propria formazione, ne hanno evidenziato un
aspetto piuttosto che un altro. Parecchie sfumature diverse
ma complementari emergono quindi nel panorama culturale
francese, che si è dimostrato più sensibile al fascino di questa visione alternativa: col procedere del dibattito, accanto
Quando, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta,
trascinati dagli entusiasmi per la fine della Guerra Fredda e
l’esaltazione del liberalismo, si è cominciato a ipotizzare una
nuova era, si pensava che questa sarebbe fiorita sotto il segno
della globalizzazione. La nuova epoca non avrebbe avuto
nulla di artificiale, questo si voleva far credere. Sarebbe stata, una volta schiantato il comunismo, un processo naturale
di consolidamento dei mercati. Lasciandoli liberi da interferenze esterne essi avrebbero dato origine a una armonica
fusione planetaria che avrebbe garantito benessere e libertà
a tutti. L’unico (l’ultimo) intervento richiesto agli Stati sarebbe stato il varo di leggi atte a promuovere la definitiva
deregulation dei mercati: libertà di transito transfrontaliero
per merci, informazioni, capitali e uomini. Ora, però, a distanza di più di quattro lustri, il sogno si appanna e quello
che era stato il mito della globalizzazione si incrina: la crisi
che sta travolgendo l’Europa e provocando un impoverimento crescente della sua popolazione ha risvegliato gli animi
e le energie per cercare delle soluzioni alternative al degrado sociale che è sul punto di irrompere nel Vecchio Continente. Sempre di più, ormai, gli scettici fanno capolino. E si
scopre che la mondializzazione non è stato un movimento
“spontaneo” della storia, ma un progetto umano codificato
e preparato con una lunga serie di accordi e incontri internazionali. Affinché l’unificazione del pianeta attraverso i
mercati vedesse la luce è stato necessario l’intervento di Stati
e istituzioni: però, ora che la crisi sembra acuirsi, si rafforza
il fronte di chi pensa sia giunto il momento di indicare altri
orizzonti oltre la mondializzazione. Così almeno la pensano coloro che ritengono che a queste politiche globali sia
imputabile la crisi che attanaglia il pianeta. Da qui la proposta di Montebourg di usare l’idea di demondializzazione
come cavallo di battaglia alle primarie dello scorso anno, per
portare a casa la sua candidatura alle presidenziali francesi.
I dibattiti sulla demondializzazione rafforzano l’idea che un
nuovo clivage ideologico stia ristrutturando lo spazio politico europeo. La distinzione classica tra destra e sinistra presenta dei tratti residuali in grado di agitare ancora le menti
ma non di infiammarle e, soprattutto, è sempre meno capace di mobilitare entusiasmi politici ed elettorali. Sta invece
progressivamente prendendo piede l’ipotesi del politologo
Pascal Perrineau: lo spazio politico, nei prossimi anni, non
sarà più strutturato lungo i crinali ideologici del secolo passato ma si vedrà plasmato dalle nozioni di chiusura o apertura dinanzi alla mondializzazione. E se in Italia, intrappolata
nella sterile polemica elettorale tra berlusconismo e antiberlusconismo, l’idea di demondializzazione fatica a emergere,
in Francia più di qualcuno ha pensato di agitarla. Al di là
di Montebourg, proprio nella recente contesa elettorale ne
hanno fatto sfoggio le ali opposte del paesaggio elettorale:
da Jean-Luc Mélanchon a Marine Le Pen, numerose sono
state le personalità politiche che hanno cercato di accreditarsi tra gli apostoli della demondializzazione. E la stessa sorte
è capitata a numerose figure intellettuali.
Il primo passo da compiere per comprendere questa nuova
idea consiste nel cogliere il significato della parola che la veicola. E se essa è formata da un prefisso e da un suffisso occorre muovere i primi passi dalla comprensione di quest’ultimo.
La demondializzazione è un neologismo che si oppone alla
parola sulla quale è costruito.
24
n. 04/2012
Secondo il teorico della demondializzazione, Keynes era un
“partigiano della cooperazione internazionale” ma anche un
“accanito avversario dei meccanismi sovranazionali che privano i governi della loro sovranità”. Questa preoccupazione
è onnipresente in Sapir, che ricorda senza indugi che “il fallimento del FMI nella crisi asiatica del 1997 ha restituito una
rilevante vitalità alle politiche nazionali” dei paesi che vi erano stati coinvolti. Ma ciò non è bastato a risolvere il problema. Infatti, le scelte messe poi
in atto da questi, e in particolare dalla Cina, per sottrarsi ai
tentacoli della crisi d’allora, li
ha portati a optare per audaci
strategie di esportazione comprimendo di conseguenza violentemente il mercato interno.
La scelta di questa politica
economica alla fine ha causato quegli eccessi di budget che
erano già finiti nel bersaglio
di Keynes e l’emergere di fondi sovrani, che costituiscono
oggi una parte del problema.
Le conseguenze di queste
audaci politiche si sono cominciate a vedere con la crisi
greca che, accanto a quella
commerciale, ha portato in
primo piano anche le difficoltà di ordine monetario.
Secondo Sapir, nel prosieguo
del suo lavoro di ricerca, Bisogna uscire dall’euro? (Ombre
Corte, 2012), la soluzione per
sfuggire ai tentacoli della crisi
nata dalla mondializzazione
consisterebbe nell’abbandono
dell’euro. La valuta continentale non avrebbe mai potuto
avere la forza del dollaro se
non a condizione di essere sostenuta da un’Europa-potenza
e di mettere fine alla divergenza tra strategie economiche
dei paesi che appartengono
alla zona euro. Ma, a differenza di altri difensori della demondializzazione, Sapir, pur opponendosi alla moneta
unica, è favorevole a una moneta comune valida come mezzo di scambio al di fuori dei confini dell’Unione Europea.
Diverse sono invece le posizioni di altri autori. Emmanuel
Todd, celebre demografo e “futurologo”, nella prefazione
preparata per il libro di Montebourg, pensa che l’innalzamento delle barriere doganali sia indispensabile durante
le fasi di guerra economica come quella in atto. Ma, a differenza di molti altri, tra cui Sapir, ritiene che le politiche
protezioniste, per essere efficaci, debbano essere attuate
a livello europeo e non nazionale. È interessante notare
come proprio in questi autori avvenga il capovolgimento
della logica che ha ispirato il lavoro di Walden Bello: men-
alla concezione commerciale della demondializzazione, finiscono per spuntarne anche una monetaria e una finanziaria,
prossime ma sensibilmente diverse dalla prima.
Per l’economista eterodosso Jacques Sapir, il suo teorico
più acuto e profondo, La démondialisation (per citare il titolo del suo libro apparso lo scorso anno da Seuil) passa in primo luogo per una rinazionalizzazione delle politiche commerciali. Questa sua prospettiva lo ha fatto diventare, suo
malgrado, uno dei difensori del
cosiddetto “patriottismo economico” e uno dei più acerrimi
sostenitori della sovranità degli
Stati, vista da sinistra però. La
demondializzazione, come confessa nella parte conclusiva del
suo testo, non è ancora diventata una strategia dai contorni
ben definiti. Il suo approccio
è quello di un ricercatore e di
uno studioso di economia che
distingue tra una mondializzazione mercantile, attraverso
cui “il processo è cominciato”, e
una finanziaria, che diventa tale
quando è sul punto di attingere la massima diffusione, fino a
diventare un fenomeno politicamente e socialmente insostenibile. Discutendo della prima
fase, Sapir contesta, cifre alla
mano, ciò che è stato presentato dai neoliberali e dai loro sostenitori come il suo principale
merito: il successo del libero
scambio e la globalizzazione
non hanno indotto, a partire
dagli anni Ottanta, la forte crescita profetizzata agli inizi dai
suoi promotori. L’impatto sui
paesi più poveri è stato negativo. E soprattutto, osservazione
estremamente importante per
il seguito dell’argomentazione
dell’economista, i soli casi in cui
si è assistito a una concomitanza di globalizzazione e sviluppo economico sono quei paesi
dove sono state messe in atto “potenti politiche nazionali”.
Questa conclusone porta Sapir a sostenere che “in un mondo
vieppiù deregolamentato, questo tipo di politiche si dimostrano indispensabili”. A cosa serve allora la globalizzazione
commerciale? Lungi dal risultare proficua per i paesi poveri
(come sostiene invece l’OMC), essa ha permesso invece la
“crescita delle grandi industrie” e “la controrivoluzione sociale che si ha avuto modo di conoscere in tutti i paesi, benché a livelli diversi, a partire dagli anni Settanta”.
Per limitare i guasti della globalizzazione, l’economista
francese auspicherebbe una nuova Bretton Woods e la ripresa di numerose idee di Keynes (tra cui quella di penalizzare
i deficit ma anche gli eccessi nella bilancia dei pagamenti).
“
Per limitare
i guasti della
globalizzazione,
Sapir auspica
la ripresa delle
idee di Keynes,
la penalizzazione
dei deficit e
degli eccessi
nei pagamenti
”
25
n. 04/2012
tare la Francia di una politica anti-dumping per contrastare
la concorrenza dei paesi di recente sviluppo e imporre una
gabella doganale ai prodotti provenienti dai Paesi che non
rispettano i protocolli di Kyoto. Dopo il suo fallimento alle
primarie e la candidatura di François Hollande, la sua idea è
stata accolta da altri contendenti lo scranno presidenziale,
che sono così diventati portavoce dell’idea, regalandole altre
occasioni di visibilità: a sventolarne il vessillo ci hanno pensato il capofila del Parti de Gauche, Jean-Luc Mélanchon, il
gollista di sinistra Jean-Pierre Chevènement e, dall’altro lato
dello scacchiere politico, Marine Le Pen, leader del Front
National.
Che a usare l’idea di demondializzazione fossero avversari di diversa formazione
politica conferma ancora una
volta che un’epoca è finita e la
vecchia distinzione tra destra
e sinistra, fascismo e antifascismo, comunismo e anticomunismo sta scricchiolando
ed è sul punto di eclissarsi.
Detto ciò, però, stiamo per
sfiorare un altro punto, che
solo pochi teorici della demondializzazione
hanno
toccato. Essa, oltre a essere
una teoria, sta diventando, a
seguito della crisi delle politiche tradizionali che sembra
inarrestabile, un dato di fatto.
Per Jacques Sapir la mondializzazione finanziaria avrebbe
ormai raggiunto il suo apice.
Dietro l’angolo ci sarebbe la
sua fine: ma occorre capire
con quante vittime. Ciò significa che la demondializzazione sta diventando una realtà
oggettiva oltre che un progetto. Essa sarebbe dunque già in
marcia, come aveva intuito nel
2010 l’annuario francese di
politica internazionale L’État
du monde. E la fine della mondializzazione, sia per l’annuario d’Oltralpe sia per Sapir, si può constatare dal fallimento
dei negoziati di Doha, dal rifiuto della Cina di assumersi le
responsabilità monetarie che le si volevano imporre e, più
in generale, dal massiccio ritorno in auge del protagonismo
degli stati sovrani con politiche che ricordano più le dinamiche dell’Ottocento che i furori ideologici del Novecento. La
Machtpolitik è ormai dietro l’angolo, come ricorda Alessandro Colombo nell’unico libro italiano che cerca di registrare
il cambiamento di paradigma in atto in questi ultimi anni:
si approssima il ritorno a La disunità del mondo (Feltrinelli,
2010) ignorata ancora oggi dalle anime belle per le quali, ancora una volta, l’uscita dalla crisi passerebbe attraverso un’ulteriore accentuazione delle politiche neoliberali e dunque
attraverso un’ulteriore dose di mondializzazione.
tre nel caso del pensatore filippino le politiche di demondializzazione dovrebbero servire a proteggere i Paesi del
Sud da quelli del Nord del mondo, il dibattito scoppiato
in Francia propone una soluzione simile ma che si muove in direzione opposta. Essa dovrebbe tutelare i Paesi del
Nord da logiche che eccedono la loro sovranità nazionale,
dall’aggressività economica e dal dumping sociale messi in
atto dai membri di quello che un tempo si definiva Terzo
Mondo e oggi rappresentato bene dalla vivacità economica
dei paesi “Brics” (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).
Ma non finiscono qui le idee di demondializzazione. Altre
ancora sono le prospettive da
cui è stata auspicata. Alcuni economisti infatti la pensano come
un espediente per regolare semplicemente l’anarchia dei flussi
finanziari. È il caso di Frédéric
Lordon, ricercatore del CNRS
e membro fondatore del Mouvement des économistes atterrés, che
esorta a una rinazionalizzazione
dei debiti pubblici degli Stati,
considerandola mossa indispensabile per frenare la speculazione in atto nelle piazze finanziarie. Tuttavia non sono mancati
dissensi tra gli oppositori della
mondializzazione. Ad alimentare il fuoco sono stati in particolare gli altermondialisti, vale a dire
gli avversari moderati dell’unificazione del mondo attraverso i
mercati. Prima della campagna
di Montebourg, nel giugno del
2011, sul sito Mediapart un
gruppo di economisti legati ad
ATTAC, la celebre associazione
altermondialista, hanno titolato un dibattito: La démondialisation: un concept superficiel
et simpliste, intorbidendo ulteriormente la già scarsa chiarezza
del concetto ma assicurandogli
ulteriore visibilità presso il grande pubblico. Come si vede solo
da questi pochi cenni, questa
idea ha ricevuto numerose interpretazioni in ambito ideologico, prima del suo ingresso sulla scena politica, lo scorso
anno. Tuttavia la vera fortuna le ha arriso nel momento in
cui ha abbandonato il campo delle discussioni politico-culturali per essere usata come strumento di battaglia politica.
Quando nel dibattito delle primarie irrompe lo slogan Votez
pour la démondialisation pochi sapevano di cosa si trattasse.
Eppure ha attirato l’attenzione della stampa e di una parte
dell’elettorato socialista, benché alla fine il suo promotore
non sia stato baciato dalla fortuna elettorale. Nel suo progetto politico e nel suo libro, Montebourg proponeva di sostituire la mondializzazione e quindi la deregulation di tutti i
mercati con un sistema di preferenze commerciali realizzato
attraverso la stipula di trattati bilaterali tra gli Stati, di do-
“
Quando nel
dibattito sulle
primarie irrompe
lo slogan
“votez pour la
démondialisation”
pochi sapevano
di cosa si
trattasse
”
26
n. 04/2012
Effetto “boomerang”
del libero scambio
di Antonio Venier
O
rmai da molto tempo è diventata convinzione quasi
generale, che il libero scambio di ogni sorta di merci
e servizi fra le diverse nazioni sia ottima cosa per lo
sviluppo dell’economia, anzi indiscutibile fattore di prosperità per tutti. Questa convinzione generale è stata ottenuta
attraverso il controllo e l’utilizzo dei mezzi di informazione,
con l’opportuno sostegno di studiosi ed esperti. In questo
modo è stato fatto credere al pubblico che una qualsiasi forma
di protezionismo, anche se moderata e selettiva, deve essere
respinta senza necessità di analisi o discussione. Le voci isolate
di quelli che mettevano in dubbio tali benefici effetti, e che
consideravano invece possibile un rapporto fra libero scambio
ed impoverimento, sono state opportunamente smorzate, in
quanto non conformi alla ideologia politico-economica ormai dominante.
27
n. 04/2012
I dati statistici disponibili circa dal 1830 in poi per i paesi
europei e gli Stati Uniti dimostrano costantemente la coincidenza dei periodi di forte crescita economica con quelli di
politica protezionista, ed al contrario, di crescita debole nei
periodi libero scambisti (per dati, rif. Bairoch, Miti e paradossi della storia economica, ed. 1996). In particolare, vanno
messi in evidenza il forte sviluppo industriale tedesco dal
1885 in poi, e soprattutto quello degli Stati Uniti, rigidamente protezionisti dal 1870 alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, ben più di qualsiasi paese europeo.
7. Ovviamente questa coincidenza statistica non può far
concludere semplicisticamente, che la prosperità possa ottenersi soltanto con la protezione dei prodotti nazionali, industriali ed agricoli. Tuttavia, dovrebbe essere ampiamente
sufficiente per dimostrare la inconsistenza, anzi la falsità,
della affermazione contraria, che il libero scambio senza limiti sia fattore positivo per tutti i paesi, anziché vantaggioso
per alcuni e dannoso per molti.
In realtà, il libero scambio è stato causa di prosperità soltanto in casi particolari, e per periodi limitati nel tempo.
Il caso più tipico è quello di un paese industriale in condizioni di grande superiorità tecnica e produttiva, esportatore
senza concorrenti in settori di grande importanza, quale è
stata l’Inghilterra fino oltre la metà dell’Ottocento per macchinari, ferrovie, costruzioni navali, etc.
La formazione nel secolo XIX di una consistente struttura
industriale è stata possibile soltanto in quei paesi che hanno
efficacemente protetto le loro industrie nella fase di sviluppo, quando non potevano essere competitive con i prodotti
britannici.
Non dissimile appare la situazione degli Stati Uniti, diventati libero-scambisti dopo la Seconda Guerra Mondiale,
appunto dopo avere raggiunto una condizione di superiorità
tecnologia nei settori industriali più avanzati, quali tipicamente sono ora gli aviogetti civili, il nucleare, la grande elettronica ed in generale i sistemi d’arma complessi.
In entrambi i casi citati, la Gran Bretagna del secolo XIX e
gli Stati Uniti d’ora, il libero scambio protegge efficacemente
le condizioni di superiorità acquisite, ed impedisce lo sviluppo di nuovi concorrenti.
Paradossale risultato, che dovrebbe far riflettere i sostenitori intransigenti della libera concorrenza senza interferenze
statali, o almeno quelli in buona fede.
8. L’argomento forte portato a sostegno del libero scambio è quello dei benefici della libera concorrenza, capace di
fornire ai consumatori merci e servizi al prezzo più basso.
Si tratta di argomento solo apparentemente forte, ma che si
rivela molto meno consistente se esaminato più seriamente.
Rimanendo nell’ambito dell’economia di un paese industrializzato come il nostro, conviene tenere presente che oltre i
consumatori esistono anche i produttori, anzi spesso coincidenti nelle stesse persone.
La concorrenza, necessariamente basata sui prezzi più
bassi, riduce od elimina le possibilità di autofinanziamento
delle imprese, ed anzi conduce necessariamente verso il produttore unico attraverso la progressiva eliminazione di quelli
meno efficienti. Quindi il vantaggio per il consumatore risulta necessariamente transitorio, e non certo permanente.
Per inciso, a scanso di malintesi ed incomprensioni, è opportuno sapere che le riduzioni nei prezzi e nei costi dei pro-
2. L’accettazione generale della dottrina libero-scambista
da parte dei paesi industrializzati europei è infatti strettamente connessa, anzi ne è parte integrante fondamentale,
con l’affermazione delle teorie così dette “neo-liberiste”, ormai più o meno da tutti considerate come evidenti ed indiscutibili leggi di natura.
Come è ben noto, queste teorie neo-liberiste sostengono
la fede nel libero mercato di tutto quanto come distributore
ottimale delle risorse; il rifiuto di ogni intervento statale per
sostegno e regolazione delle attività economiche; ed appunto lo scambio libero da qualsiasi limite ad ostacolo, interno
ed internazionale, di tutto quanto possa considerarsi scambiabile; prodotti industriali ed agricoli, materie prime, capitali ed investimenti, etc.
3. Ricordiamo che la dottrina del libero scambio, come
quella più generale neo-liberista, che la include, trova origine nelle rudimentali teorie economiche elaborate circa due
secoli fa dai così detti grandi economisti classici inglesi. Teorie economiche che sono sopravvissute e si sono anzi diffuse,
a dispetto della loro inconsistenza largamente dimostrata
dalla esperienza storica; sopravvivenza e successo attribuibile da un lato alla loro rozza semplicità, che le rendeva facile
oggetto d’insegnamento e comprensibili ai più sprovveduti
lettori e commentatori. Dall’altro, probabilmente più consistente, poiché queste teorie erano ben funzionali agli interessi economici britannici nel secolo XIX.
4. Ritornando al tempo presente, bisogna ricordare che
almeno da due decenni od anche più, il libero scambio è sostenuto energicamente dalle grandi organizzazioni finanziarie internazionali, dal FMI alla Banca Mondiale, oltre che
dall’organismo appositamente costituito per la liberazione
totale del commercio internazionale GATT, diventato dal
1955 “Organizzazione mondiale del Commercio” (OMC).
Neppure si può dimenticare l’azione della Commissione Europea di Bruxelles, che arriva al paradosso di utilizzare fondi e strumenti politici (le “direttive” accettate dai governi
europei) per liberalizzare a forza gli scambi commerciali, a
costo di danneggiare seriamente l’attività economica in alcuni paesi della Comunità Europea, fra i quali ovviamente
soprattutto il nostro, che si distingue per sottomissione e
obbedienza.
5. La diffusione generalizzata del libero scambio, sostenuta energicamente – come abbiamo detto – dalla totalità dei
mezzi di informazione e soprattutto dalle potenti organizzazioni finanziarie internazionali, non è però stata accompagnata da un aumento della prosperità. Questo dato di fatto
appare evidente confrontando l’incremento degli scambi
con quello della produzione di beni e servizi. Per fornire un
riferimento quantitativo, nel periodo dal 1981 al 1996 (secondo dati di fonte GATT/OMC), il commercio mondiale
è più che raddoppiato in termini reali, mentre l’incremento
del PIL (sempre in termini reali, cioè, di volume) è cresciuto
circa del 50 %. Queste cifre riguardano la produzione e l’interscambio di beni e servizi.
Nello stesso periodo enormemente maggiore è stato l’incremento del movimento dei capitali, riconducibile però
solo in minima parte all’interscambio commerciale.
6. Il collegamento negativo fra il libero scambio e il progresso economico non è certo un caso anomalo di questi ultimi anni.
28
n. 04/2012
essere molto vario. Infatti alcuni paesi dotati di consistente
produzione d’alta tecnologia possono sopportare senza inconvenienti, ed anzi talvolta trarre vantaggio dall’entrata nel
mercato internazionale dei prodotti di basso costo, tipicamente beni di consumo a basso contenuto tecnologico.
Ben diverso è il caso dei paesi privi di un forte settore
d’industrie ad alta tecnologia, in quanto tali al riparo della
concorrenza proveniente dai paesi con bassi costi salariali.
Questo è il caso dell’Italia, dove
la massima parte della produzione industriale riguarda prodotti
con medio o basso contenuto
tecnologico, e pertanto esposti e
sensibili a tale concorrenza.
12. Di fronte a questo problema, le proposte dei governanti,
banchieri diversi ed industriali,
sono state le più primitive e le
meno ragionevoli: bassi salari,
così detta flessibilità e tagli alla
protezione sociale. Dovrebbe essere evidente a tutti, che riduzioni nei costi salariali e previdenziali dell’ordine del 5 % o del 20
% non servono a nulla, quando
gli stessi prodotti sono fabbricati
altrove con costi salariali infimi,
oltre ad altri vantaggi. Invece
queste primitive proposte, profondamente sbagliate, se applicate possono avere un effetto
molto dannoso sul nostro sistema economico contribuendo efficacemente all’impoverimento
generale dell’Italia. Osserviamo
che i bassi salari e l’eliminazione
di una protezione sociale decente sono raccomandate al nostro
Paese anche dagli organismi internazionali, quali Commissione europea, FMI e simili, oltre
che dai più autorevoli “esperti”.
Seguendo questi autorevoli raccomandazioni e consigli, l’Italia
potrà in breve tempo assumere la
funzione di serbatoio di lavoro
mediamente qualificato a basso
costo nel quadro dell’Unione
Europea.
13. Una prospettiva di questo genere, che comporta una
prevedibile riduzione dell’attuale livello di vita (peraltro,
già peggiorato a quello di un decennio fa) richiederebbe una
efficace azione per contrastarla, che peraltro finora appare
lontanissima dai pensieri dei governanti, industriali, etc.
dotti industriali sono sempre state dovute a motivi tecnici,
progresso scientifico e produttività industriale, e non certo
alla mitizzata libera concorrenza.
Progresso tecnico e produttivo che presuppone appunto
per le industrie una consistente capacità di autofinanziamento, oppure di sostegno pubblico.
9. Soltanto poche parole merita uno degli argomenti dei
sostenitori del libero mercato e della benefica concorrenza.
Si tratta della possibilità, per
una impresa espulsa dal mercato come perdente nella concorrenza, di dedicarsi ad altro
settore di attività con migliori
risultati. Questa è una evidente
sciocchezza, poiché ovviamente
qualsiasi nuova attività non può
essere né efficiente né competitiva nella sua fase iniziale, ed
inoltre richiede conoscenze tecniche diverse dalle precedenti
normalmente non acquisite.
La conversione di una industria a una nuova attività non
è certamente cosa impossibile,
ma per essere realizzata richiede sia consistenti spese “a fondo perduto” che la protezione
del prodotto, cioè in sostanza
quell’azione di sostegno pubblico rifiutata appunto dai fautori
della libera concorrenza.
10. Il problema della concorrenza e del libero scambio
fra sistemi produttivi fra di lor
molto diversi per livelli salariali, protezione sociale e fiscalità
è diventato da qualche tempo di
grande importanza.
Osserviamo che in questo
caso sono da considerare le caratteristiche specifiche dei diversi sistemi economici, ben più
che l’efficienza delle industrie
produttrici, come invece è nella
concorrenza all’interno di uno
stesso paese.
Consideriamo infatti l’enorme differenza dei costi, fra
prodotti simili fabbricati per
esempio in Italia oppure in un paese dell’Asia sud-orientale
o dell’Europa orientale. Il molto minore costo del prodotto
esterno non è dovuto affatto a una migliore efficienza produttiva, che generalmente anzi non esiste. Invece è dovuto
quasi del tutto ai rapporti di scambio fra le diverse monete,
che alterano enormemente i costi salariali rispetto a quelli
europei, anche in rapporto 1 a 10 o più. A questo si aggiungono importanti diversità nelle condizioni di fiscalità e protezione sociale.
11. L’effetto sull’economia dei paesi industriali avanzati dovuto a questo tipo di concorrenza internazionale può
“
Di fronte
alla crisi, le
proposte dei
governanti sono
state primitive
e irragionevoli:
bassi salari,
flessibilità
e tagli alla
protezione
sociale”
Riportiamo questo articolo di Antonio Venier, apparso su
Critica Sociale (n. 5, 1998), ancora attualissimo dopo quasi
quindici anni dalla sua stesura originale. Ringraziamo l’autore per aver messo a disposizione questo scritto.
29
n. 04/2012
Il naufragio del libero mercato
A colloquio con Nino Galloni, direttore generale al Ministero del Lavoro
Questo si collega all’abbandono del modello stabilito dagli accordi di Bretton
Woods nel ’44 (che fungerà un anno dopo da traccia
per la conferenza un di Yalta), nell’ambito dei quali i
Paesi che dovevano dotarsi
di un apparato industriale
e, conseguentemente, erano costretti a importare,
mettendo le proprie bilance
commerciali in disavanzo,
venivano aiutati dal nuovo
Fondo Monetario Internazionale. In realtà poi questo
programma non venne rispettato e il nuovo FMI diventò un modo per finanziare qualunque disavanzo dei
Paesi, purché fossero allineati agli Stati Uniti d’America.
Negli anni ’80, si ha un’ulteriore svolta e viene stabilito
che ciascun Paese è responsabile della propria bilancia
commerciale. Se questa non
è in equilibrio ci sono tre
possibilità: nel caso che sia
in avanzo deve rivalutare la
propria moneta; nel caso in
cui sia in disavanzo la deve
svalutare; nel caso in cui ci siano i cambi fissi (ovvero la moneta unica) deve importare capitali e quindi trovare l’equilibrio
attraverso la bilancia dei pagamenti. Per importare i capitali li
deve invogliare e, per fare ciò, deve far crescere i propri tassi di
interesse interni (oggi c’è lo spread ma ieri il problema era lo
stesso, in realtà non è cambiato molto).
Ma che cosa succede, a questo punto? Che quando un Paese è già debole e in disavanzo commerciale, cioè non riesce ad
esportare ed importa troppo, fa crescere i propri tassi di interesse e si indebolisce ancora di più. Quindi questo sistema di
libero mercato, che è naufragato alla fine dell’anno scorso, è
insostenibile dal lato dell’economia reale, perché non tutti i
Paesi potevano essere stabili, dato che l’equilibrio di un Paese debole era perseguito indebolendolo ancora di più; tant’è
che la crisi monetaria del ’92 fu causata da questa situazione in
condizione di cambi fissi all’interno dello SME (Sistema Monetario Europeo).
D. Quali sono state, secondo Lei, le cause della crisi attuale? Si tratta di cause episodiche oppure possiamo
considerarle strutturali, cioè
implicite nel sistema stesso?
R. Per comprendere le cause
di questa crisi, nata dall’economia reale, dobbiamo fare
un piccolo passo indietro e
capire ciò che lega la cultura
economica ai sistemi di governo e di produzione.
Fino agli anni ’70, la realtà
era caratterizzata prevalentemente da economie di scala
e, quindi, da costi decrescenti. In questa situazione c’era
spazio per l’aumento dei salari, la tenuta dei profitti e
l’introduzione di tecnologie
sempre più avanzate. Vi era
spazio anche per la crescita
delle piante organiche e delle piante industriali, il che
comportava continue economie di scala, quindi riduzioni
dei costi e, conseguentemente, anche benefici sul piano
dei prezzi.
Con la controrivoluzione liberistica degli anni successivi,
dall’inizio degli anni ‘80 in poi, si è avuta una cultura economica di tutt’altro genere che, in nome del libero mercato, quindi per ripristinare una condizione di accesso di tutti a questo
mercato, si basava su una logica di costi crescenti. I lavoratori
dovevano essere pagati sempre di meno, l’ambiente non doveva
essere rispettato, e le tasse stesse erano soprattutto un costo dal
punto di vista dei singoli. Si è quindi passati da una logica macroeconomica dei decenni precedenti, che avevano conosciuto
un certo sviluppo, ad una in cui prevalevano le esigenze di microeconomia e, conseguentemente, ad una cultura da bassi salari,
flessibilità che diventava precarietà, contraffazione delle regole;
questo perché la globalizzazione (quella che abbiamo chiamato così ma che, in realtà, non è che una competizione sfrenata a
livello internazionale) premiava il produttore peggiore, quello
cioè che era competitivo perché riusciva legalmente o illegalmente a pagare di meno la mano d’opera, a non rispettare l’ambiente e le normative (anche quelle internazionali).
30
n. 04/2012
famiglie e delle imprese (anche criminali): di qui la crisi di liquidità anche perché il “sistema bancario” era stato rimosso e
le singole banche sapevano che il vicino versava in condizioni
di illiquidità simili alle proprie. Il mercato interbancario era
fottuto.
Questa montagna di derivati è solo una parte dei cosiddetti titoli tossici, i quali ammontano invece a tre-quattro milioni di
miliardi (quadrilioni) di dollari. È una situazione, da un punto
di vista finanziario, insostenibile, ingestibile.
Con la illiquidità prima descritta, gli unici soggetti regolatori
sono le banche centrali; ma queste ultime non hanno possibilità
pari al 10% dei titoli tossici, vale
a dire 6/7 volte il PIL mondiale.
Dunque cosa si inventano l’estate scorsa? La illimitatezza del sostegno alle esigenze di liquidità
delle banche: non si cerca una
modalità per frenare i loro comportamenti, soprattutto dividendo nettamente i soggetti che fanno attività speculative da quelli
che devono dare credito all’economia; infatti, non ci può essere
ripresa laddove non vi sia credito
all’economia, se è tutto bloccato
dal lato delle spese pubbliche, se
calano i consumi, se i privati non
fanno investimenti perché non
vedono la ripresa. Sarebbe necessario che ognuno facesse la sua
parte, cosa di cui nessuno invece si preoccupa. La FED dispone
questo tipo di sostegno il 15 settembre del 2011 e la BCE, dopo
alcuni tentennamenti, nel novembre del 2011 si adegua anche
lei, con l’approvazione di Mario
Draghi. Sostegno illimitato alle
esigenze di liquidità delle banche. Senza nessuna contropartita. Ciò che è scandaloso non è
che le banche centrali forniscano illimitatamente liquidità alle
banche, ma il fatto che non dicano loro di smetterla. Per cui i derivati stanno ricominciando a crescere e le esigenze di liquidità
cresceranno parimenti perché la ripresa nel frattempo non inizia. Ecco la situazione nella quale ci siamo trovati.
Dopodiché, si è arrivati alla moneta unica che, diciamolo, è stata una forzatura perché in genere prima si trova una certa unione politica, poi si fa la moneta. Invece, qui si è creata la moneta
e poi ci si è accorti che non c’era nessuna unione politica. E
questa è causa di problemi, non solo a livello europeo ma, a
sentire Obama, anche a livello internazionale (secondo il Presidente americano, tutti i mali parrebbero nascere dall’euro, il
che non è una visione prettamente condivisibile, ma nemmeno
del tutto campata in aria).
Su questa situazione si instaura la crisi finanziaria, o meglio,
si inseriscono i comportamenti
degli agenti speculativi che sono
le banche stesse, diventate anche soggetti speculativi. C’è peraltro da tener conto che, finché
la Borsa è andata bene dopo la
crisi dei titoli obbligazionari
del ’92 e fino all’inizio di questa crisi nel 2001, c’è stato un
certo trainamento, un rialzo
dei titoli tecnologici (e-technology, e-commerce ecc.). Quando
questa corsa si è interrotta e gli
operatori hanno visto che i rendimenti non erano più crescenti
(questo è successo alla fine della primavera del 2001), cambia
il regime e si comincia a svendere, cioè a speculare al ribasso: si
prende oggi un titolo a credito
per rivenderlo immediatamente
domani, saldandolo con l’originario venditore a termine. E in
questo frattempo si fa abbassare il titolo il più possibile e si
guadagna la differenza al ribasso fra i due momenti. Siccome
però le banche avevano emesso
titoli a rialzo e si erano quindi
impegnate coi loro sottoscrittori a livelli notevoli, che più o
meno scimmiottavano l’elevatezza dei tassi di interesse reale
nel decennio precedente (quello che va dall’83 al ’92 e che vedeva alti tassi di interesse sulle
obbligazioni), cosa è successo? Sperando ci sarebbe stata, dopo
uno/due trimestri, la ripresa, le banche hanno fatto operazioni
di derivazione. Per dirla con parole semplici, piccole catene di
Sant’Antonio per garantire il rendimento promesso ai sottoscrittori. Se questo gioco dura tre o sei mesi si può reggere; invece, di trimestre in trimestre, di semestre in semestre, mentre
era prevista una ripresa che non sarebbe mai potuta avvenire
(perché non si sono rimossi gli ostacoli alla crescita dell’economia reale di cui ho accennato prima), questi disgraziati hanno
continuato a fare operazioni di derivazione, che hanno prodotto effetti per circa ottocento trilioni di dollari, cioè ottocentomila miliardi di dollari. Ecco cos’è successo.
Nel 2008, le banche si sono accorte che le perdite da operazioni speculative superavano le rimesse – a vario titolo – delle
“
Si tratta di
rispristinare
la sovranità
monetaria e
di togliere gli
interessi del
debito pubblico
dal bilancio
dello Stato
”
D. Dobbiamo quindi dedurre che la situazione sta degenerando ulteriormente?
R. Assolutamente sì. Ma il mondo è diverso da cinquant’anni fa: allora una situazione del genere avrebbe creato un’inflazione devastatrice dopo la quale poi l’incognita sarebbe stata
quella dell’impatto del disastro finanziario sull’economia reale; tuttavia, poi si ricominciava. Invece qui ci sono meccanismi che consentono di sostenere questo sistema, anche se non
credo illimitatamente. Però, intanto, quello è l’impegno delle
banche centrali. Pensate che basterebbe un decimo di quello
31
n. 04/2012
l’ipotesi di una crisi inflattiva da eccesso di moneta: ma, invece di trarre vantaggio da tale situazione, l’umanità la sta sprecando utilizzandola solo per autorizzare le speculazioni nelle
loro folli corse. La follia la paga la società che rischia di rompersi, in quanto gli speculatori riescono sempre a guadagnarci
su: al ribasso, come ho accennato, e anche sfruttando il fatto
che singole operazioni, in perdita alla fine del termine (giorno,
mese, trimestre, anno…), tuttavia
vengono remunerate al loro ripetersi nell’unità di tempo (secondi, millesimi, nanosecondi, metà
giornata…).
che le banche centrali hanno dedicato alle banche che producono i derivati per avviare la ripresa, per risolvere il problema.
Utilizzando possibilmente anche il volano del credito, che è
la moneta più importante. Tuttavia, quest’ultimo, per essere
utilizzato pienamente, abbisogna che lo stesso soggetto non
faccia sia attività speculativa finanziaria sia attività di credito.
È necessario tornare a distinguere i due soggetti. Questa è la
condizione per iniziare a parlare
seriamente di come uscire da questo casino.
D. Dunque un’inversione di
marcia è ancora possibile, laddove si agisca in tempi brevi?
R. Sì, anche se poi il problema
sarà quello di sterilizzare in qualche modo questi quadrilioni di
titoli tossici. Perché basterebbe
un accordo fra i principali Stati del pianeta (penso alla Cina,
all’India, alla Russia, agli Stati Uniti d’America e ovviamente anche all’Europa) affinché li
congelino ed emettano dei titoli
corrispondenti – da loro garantiti – per finanziare lo sviluppo. Se
questo accordo avvenisse il problema non sussisterebbe. Ma il
vero nodo problematico sta nella
situazione delle singole banche,
per le quali mi pare ormai che la
situazione stia sempre più degenerando, soprattutto per quanto
riguarda quelle più incasinate, tra
le quali escluderei quelle italiane
(dunque, la nostra situazione da
questo lato è migliore di quella spagnola, francese, inglese e
tedesca).
Questo per quanto riguarda le
cause della crisi che stiamo vivendo; da quanto abbiamo detto, si
capisce come siano strutturali,
già implicite nelle premesse del
sistema.
“
Occorre
separare in modo
netto e deciso
i soggetti
che svolgono
attività
speculative
e coloro
che invece
esercitano
attività
di credito
”
D. Esistono, a Suo parere, delle
soluzioni realizzabili per uscire da
questa situazione?
R. Per uscirne bisogna compiere
alcune operazioni fondamentali.
La prima, di cui abbiamo già parlato, è la netta separazione fra i
soggetti che svolgono attività speculative e i soggetti che svolgono
attività di credito.
Per quanto riguarda invece la seconda, si tratta di ripristinare la
sovranità monetaria. Mi riferisco
soprattutto alla situazione attuale
degli USA, i quali possiedono sovranità monetaria, come la Cina
in fondo, solo che, per esempio,
gli USA utilizzano questa potenzialità per fare delle guerre inutili e dannose (ovvero attività che
potremmo definire speculative)
senza sfruttarla abbastanza per
fare investimenti di infrastrutturazione del pianeta e altre cose di
questo tipo. Oggi l’umanità ha a
disposizione, a differenza del passato, tecnologie che consentono
di produrre e di migliorare le condizioni di vita di tutti senza problemi. Infatti, tutta questa moneta che viene creata non genera
inflazione perché qualcosa arriva
comunque anche alle tasche della
gente (o almeno, di alcune categorie) e la domanda rimane sempre
abbastanza alta. I prodotti, i servizi e le capacità produttive inutilizzate ci sono e rappresentano la salvaguardia dall’inflazione,
almeno per il momento. Poi non sappiamo cosa succederà.
In terzo luogo bisogna togliere gli interessi sui titoli del debito pubblico dal bilancio dello Stato. Questo si fa mettendo il
debito pubblico fuori dal perimetro dello Stato in quanto tale,
come amministrazione. È necessario, quindi, creare un fondo
che raccolga tutte le realtà da reddito delle pubbliche amministrazioni e non solo, a garanzia del debito stesso, in modo da
risparmiare, nel caso dell’Italia, quegli 84 miliardi di interessi
all’anno che sono una palla al piede. Il peso, infatti, non è il
D. Qual è la differenza rispetto
alle grandi crisi del passato, ad
esempio con quella del 1929?
R. Dunque, ci sono analogie e
differenze. Un aspetto in comune con la crisi del ’29 è il fatto
che le retribuzioni, quindi i consumi, crescono meno rispetto
alle capacità produttive; da ciò consegue una situazione di insufficienza della domanda. C’è uno spostamento della ricchezza verso la finanza e un risucchiamento, sia attraverso le tasse sia tramite altri sistemi, delle risorse create e prodotte dalla
gente che lavora nei confronti di chi campa in qualche modo di
rendita. Il che non è evidentemente una buona notizia.
La grande differenza è che oggi le capacità produttive rapidamente recuperabili sono talmente ingenti che non esiste
32
n. 04/2012
precari, non ci può essere equilibrio. Stiamo parlando di una
dozzina di miliardi di euro. Ovviamente poi, in fondo, i lavoratori dipendenti e soprattutto i parasubordinati portano invece
risorse e si fa una compensazione per cui il disavanzo dell’INPS è contenuto, ma è un’apparenza: in realtà non si affrontano
i problemi strutturali. Qui si parla tanto di riforme ma poi non
si fanno interventi dove sarebbe più necessario.
Un altro punto da affrontare è il riposizionamento della pubblica amministrazione dello Stato, che deve diventare “amica” dei cittadini. L’impresa e l’artigiano devono vedere in essa
un amico che va a trovarlo e gli sistema il bilancio, gli mette
a posto le inadempienze ecc. perché lo Stato, la pubblica amministrazione si deve posizionare fra la criminalità (che deve
combattere senza tregua) e l’irregolarità per cui deve affrontare
direttamente le inadempienze, aiutandosi nell’interesse comune. Non sconfiggeremo mai l’illegalità e la criminalità in questo Paese finché la faremo alleare con l’esercito degli irregolari,
che sono decine di milioni, perché ci sono troppe leggi, troppi
regolamenti, troppi impicci. Il prossimo governo dovrà cancellare leggi, non farne altre. I funzionari pubblici e gli ispettori
dovranno avere maggiori poteri, nell’interesse dei cittadini; ma
dovranno sentirsi le spalle coperte, non che se vanno in deroga
a qualche normetta pensano di fare una brutta fine. Devono sapere che il loro obiettivo è quello di aiutare l’utenza e, quindi,
se c’è un’inadempienza la devono sistemare loro. Questo è fondamentale per avere una amministrazione pubblica moderna.
Bisogna passare da una logica burocratica ad una logica commerciale. Così si può salvare il Paese.
Ovviamente, se l’euro non regge, bisogna attrezzarsi per fare –
in base alle nostre vocazioni – affari con il Sud America, con
il Nord Africa, coi Balcani, con la Russia. Secondo me l’Italia
ha le risorse per farcela. Tra l’altro oggi ci sono tecnologie di
cui molti brevetti sono italiani (per il trattamento dei rifiuti,
la sostituzione con altre tecnologie per i veicoli di trasporto e
dei modi di trasporto, la produzione di energia, tutte su basi
locali): se messi in produzione consentirebbero veramente di
gestire meglio il Paese e di farci diventare leader di tutta una
serie di aspetti strategici dell’economia. Se però non si riesce a
creare una politica che voglia questo è ovvio che fra poco andremo verso una situazione ancora più grave di quella che stiamo vivendo.
debito in quanto tale, ma i suoi interessi. Il problema dell’Italia
è lo spread (così come negli anni ’90 le modalità di compensazione dei disavanzi commerciali, o prima la politica errata del
debito da parte delle autorità monetarie).
La politica di questo governo non è stata quella di abbassare lo
spread ma quella di mettervi un tetto, oltre il quale deve entrare in funzione il cosiddetto fondo salva-Stati. Ma quel tetto, se
impedisce il tracollo nel giro di poche settimane, ci fa morire
più lentamente. Perché occorrerebbe portare lo spread attorno ai 100 punti massimo. O, se vogliamo, abbassare il tetto ai
100 punti, non tenerlo intorno ai 400 o poco meno… anche
con uno spread a 350 siamo in difficoltà con gli investimenti
per la ripresa! Come si fa a tenerlo basso? Prima di tutto bisogna far crescere l’economia. Questa è la prima cosa. Ovviamente gli stessi mercati internazionali che ci chiedono lo sviluppo vogliono vedere anche i conti in ordine, quindi, in questo
momento dovremmo dare capacità d’acquisto alle famiglie ma
non aumentare il disavanzo pubblico e quindi l’emissione di
titoli. Ad esempio, che cosa succede quando abbassiamo (e
quando abbasseremo, se faremo come la Spagna con le tredicesime) gli stipendi dei dipendenti pubblici? Avremo un calo dei
loro consumi, con tutte le conseguenze sul piano occupazionale dell’indotto del pubblico, i consumi privati delle famiglie
dei dipendenti pubblici. Un fatto assolutamente negativo perché alla fine dell’anno, se continuiamo così, ci accorgeremo che
il PIL è calato del 3%: se non cambiamo rotta tempestivamente le conseguenze saranno devastanti perché lo spread schizzerà più in alto. Per far accettare alla Finlandia, all’Olanda, alla
Germania di intervenire per non farlo alzare oltre i 500-600
punti, dobbiamo dare loro in cambio lacrime e sangue? Ma lacrime e sangue sono proprio quello che ci impedisce lo sviluppo! Possiamo anche, per ipotesi, sospendere le tredicesime dei
dipendenti pubblici, ma dobbiamo dare loro della moneta non
convertibile (dei buoni, dei voucher, dei coupon senza copertura in euro, ovviamente, ma spendibili sul mercato interno)
da utilizzare nei negozi per approvvigionarsi di cibo, vestiario,
oggetti di consumo.
D. Esiste un rapporto tra quanto sta dicendo, il coinvolgimento delle categorie produttive e la previdenza?
R. Occorre un patto con i commercianti e gli artigiani affinché
accettino questa moneta complementare. Perché, a loro volta, queste categorie stanno mandando strutturalmente in disavanzo l’INPS. Non ci si rende conto che questo disavanzo
è dovuto fondamentalmente al fatto che gli artigiani evadono
perché non gli si spiega che gli converrebbe non evadere; andrebbe rivista tutta la posizione dei commercianti all’interno
dell’INPS.
Tutto il mondo agricolo sarebbe da rivisitare, poiché l’agricoltura nel nostro Paese è fondamentale, molto più importante di
quello che comunemente si crede, ma non è l’agricoltura da assistenza degli anni’70. Bisognerebbe ragionare di più su quello
che si potrebbe fare per questo settore.
È ovvio che se le imprese non crescono non c’è domanda di
dirigenti e, mentre quelli di venti, trent’anni fa sono andati in
pensione con alte pensioni, quelli attuali sono pochi; non ci
sono abbastanza versamenti.
Oltretutto c’è ora il problema dei dipendenti pubblici che
sono entrati nell’INPS. È ovvio che, se non si assumono più
dipendenti pubblici ma si pagano le consulenze e i lavoratori
D. Le speranze allora non mancano, laddove vi sia una volontà
politica...
R. Le speranze ci sono. Finché regge la capacità produttiva
industriale dell’Italia, in qualsiasi momento ci possiamo riprendere. Però non ci dimentichiamo che le imprese italiane,
soprattutto quelle del centro-nord, stanno alla canna del gas.
Non hanno banche che le aiutino, infrastrutture che funzionino, una pubblica amministrazione amica, le tre cose fondamentali su cui bisogna intervenire per fare investimenti, per
cambiare i rapporti e gli obbiettivi, per avere una banca (bank
in inglese significa sponda) adeguata.
Nino Galloni (1953) è stato funzionario di ruolo al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero dell’Economia). È stato nominato, nel 1990, direttore
generale al Ministero del Lavoro. Autore di numerosissimi libri
ed articoli di economia, ha anche insegnato nelle Università di
Milano (Cattolica), Napoli, Roma (Luiss), Cassino e Modena.
33
n. 04/2012
Filosofia della crisi
A colloquio con Costanzo Preve, allievo indipendente di Marx e Hegel
causa strutturale è che con
l’avvento della globalizzazione l’Europa non è in grado di sostenere il modello
neo-liberale mantenendo le
conquiste sociali del welfare
state che hanno caratterizzato il Novecento europeo in
tutte le sue varianti: comunista, fascista, socialdemocratica. Per cui, in questo momento, quando parliamo di
crisi, è bene aver chiaro che
non riguarda il mondo intero, perché ci sono aree che
sono in fase di sviluppo, per
cui preferirei che la parola
crisi venisse associata ad un
modello capitalistico di accumulazione legato allo stato nazionale, una volta che
sia stato distrutto dalla finanziarizzazione della globalizzazione, ed è una crisi
sostanzialmente dell’Europa, dei lavoratori e dei popoli europei. Certo, essa si fa
sentire anche in India, Cina
e Brasile, ma non presenta le
medesime caratteristiche che
ha in Europa.
D. Quali sono sono state,
secondo Lei, le cause della
crisi attuale? Si può parlare di ragioni strutturali? Di
episodiche?
R. C’è prima di tutto il discorso della crisi storica in
cui ci troviamo, dovuta alla
fine del bipolarismo russoamericano e all’avvento di
un nuovo unipolarismo imperiale a cui si contrappone faticosamente un multipolarismo in fieri, per altro
potenziale, i cui protagonisti sono Russia, Cina e Brasile, in realtà non ancora
operativo, dal momento che
l’Europa è completamente schierata con l’oligarchia
americana. In secondo luogo, abbiamo il discorso economico. Questa crisi ha avuto cause contingenti, ovvero
la cosiddetta crisi dei subprime americani, che ha avuto
grandi conseguenze, specie
nel settore edile (pensiamo
per esempio alle centinaia di alloggi sfitti in Spagna
che hanno causato il tracollo dell’economia spagnola),
ma certamente è una crisi di sovrapproduzione nella nuova
fase della globalizzazione. La definirei, con terminologia marxiana, una crisi di sovrapproduzione, ovviamente in rapporto
ai beni acquistabili dal mercato. Sovrapproduzione significa
sottoconsumo, sono due aspetti convergenti. Ciò si presenta
però in una situazione storica nuova, nella quale assistiamo al
completo venir meno della sovranità monetaria dello stato nazionale e, pertanto, all’innesco di dinamiche finanziarie globalizzate non più controllabili. È una crisi di svalutazione del
lavoro; essendosi l’Unione Europea basata sull’impossibilità
di svalutare la moneta nazionale, in tempi di crisi si svaluta
la moneta o il lavoro. O si svaluta la moneta, e questo rende
possibile una maggiore concorrenzialità della moneta nazionale, come è stato per duecento anni in Europa, oppure si svaluta il lavoro. In questo momento si sta facendo questo. Ecco
l’aspetto più noto della crisi per i lavoratori europei, particolarmente giovani. Ma le cose che dico sono ben note a tutti. La
D. Quali differenze e analogie si riscontrano tra la crisi contemporanea e altre del passato, come ad esempio quella del
1929?
R. Come in tutti i fenomeni storici, si ritrovano analogie e differenze. Occorre capire se prevalga l’aspetto analogo o la differenza qualitativa, l’aspetto di novità. Analogamente al 1929,
questa è una grande crisi di sovrapproduzione, legata all’impossibilità da parte del consumo di assorbirla, crisi che nel ‘29
fu superata solo dalla Seconda Guerra Mondiale. È ovviamente una leggenda metropolitana l’ipotesi secondo la quale sia
stata risolta dal New Deal. Fu superata grazie alla corsa agli
armamenti e alla Guerra Fredda, che non fu altro che la prosecuzione della guerra, nel periodo che Hobsbawm definisce
“dei trent’anni gloriosi”. Siamo oggi in una situazione diversa
però, perché nel ‘29 non avevamo ancora a che fare con dinamiche globalizzate. C’erano intere aree fuori dal modello capitalistico, come l’URSS o le zone del mondo in cui dominava
34
n. 04/2012
dimensioni che, per la verità, furono sempre intrecciate, sin
dall’Ottocento. Ma da circa trent’anni si è stabilito un netto
dominio del capitale finanziario, il che ha causato la fine della separazione tra l’aspetto speculativo e quello reale. La conseguenza è che l’economia reale è completamente dipendente
dalla finanza, come dimostra l’egemonia del concetto di spread
e il potere delle agenzie di rating sugli Stati. Se ancora esiste,
l’economia reale come fatto indipendente si trova al massimo
nei Paesi in via di sviluppo, come ad esempio la Cina. L’Italia
ha venduto e decentrato tutto, per cui non vedo quale economia reale ci potrebbe essere.
un sistema di produzione precapitalistico. Fra analogia e novità, a mio avviso prevale dunque la novità, come sostiene Alain
de Benoist in Sull’orlo del baratro.
D. A quali conseguenze andiamo incontro?
R. Non lo so. Ho abbandonato la pretesa del marxismo classico di prevedere la storia. Facendo un’ipotesi dilettantistica,
credo che la crisi dell’euro si approfondirà ulteriormente. L’euro è stata un’idea sbagliata, un azzardo. È un fallimento che
non potrà trascinarsi a lungo e provocherà una divaricazione
ancora più forte tra le due Europe, quella del centro-nord e
quella del centro-sud. Altra conseguenza prevedibile è il peggioramento della situazione geopolitica in Medio Oriente,
probabilmente con il tentativo
di distruggere il governo della
Siria di Assad e quello dell’Iran.
La tendenza alla guerra è evidente, ma questo non comporta
necessariamente una vera e propria guerra come quella contro
la Libia o la Serbia.
D. Cosa accadrà sul piano geopolitico? Da quale tipo di ideologia è supportata l’attuale egemonia globale?
R. Gli USA hanno vinto due
Guerre Mondiali e la Guerra
Fredda, o Terza Guerra Mondiale. Questa vittoria ha permesso
di estendere il dominio sui Paesi dell’Europa dell’Est e adesso,
con la cosiddetta Primavera Araba, fenomeno completamente
occidentalizzante, anche in Medio Oriente. Queste sono due
gigantesche vittorie geopolitiche. Non vi sono potenze avversarie e quelle emergenti (Brasile,
Russia, Cina e India) non hanno
intenzione di opporsi in modo
strategico. Molto pericolosa è
l’ideologia che gli USA portano con sé, un’ideologia puritano-protestante, di origine veterotestamentaria, che li spinge a
ritenersi il popolo eletto. Persino i
non credenti si considerano parte di questo popolo, eletto dalla
Storia e da Dio. È una concezione che si arroga il diritto di
portare il bene del mondo attraverso interventi militari. Questo capitalismo messianico ha ereditato alcuni aspetti del vecchio messianismo comunista, ridipingendoli in forma ultracapitalista, ed è un fattore di instabilità permanente. Per citare il
mio amico De Benoist, è il nemico principale. L’Europa deve
staccarsi da questa pretesa egemonico-imperiale, o non c’è futuro
spirituale per essa. È necessario che l’Europa riacquisti una sua
autonomia, culturale, militare e politica, rispetto all’America;
il che non vuol dire necessariamente antiamericanismo, quanto piuttosto recupero di un’indipendenza strategica.
“
L,Europa deve
staccarsi
dall,imperialismo
statunitense o
non c,è futuro
spirituale per essa
”
D. Crede possano darsi risposte
filosofiche a questa crisi?
R. Dal punto di vista della globalità filosofica e degli orientamenti culturali di fondo (degli
anni decisivi, per usare le parole di Spengler), io direi che non
vedo forze socio-politiche in
grado di dare una risposta adeguata alla crisi. Ma, dal punto di
vista filosofico, la risposta esiste
sempre. La possibilità di restaurare il metron greco, una economia non crematistica, una tradizione equilibrata del rapporto
tra economia e politica in teoria
c’è. Ma perchè questa teoria possa prendere gambe e braccia,
avere un fallout per così dire, sono necessarie forze socio-economico-politiche in grado di assumere la sfida di questa crisi.
Non ne vedo. Non penso che sia sufficiente il movimento di
Marine Le Pen in Francia o quello Sirisa in Grecia, che pure
sono migliori di altri e tantomeno Grillo può dar soluzioni ai
problemi di identità storica dell’Italia, che è in caduta libera
perché è in declino sia il modello progressista ex-comunista,
del PD, sia il modello berlusconiano. Lo dimostra la consegna
del potere a un gruppo di banchieri da parte di ambo gli schieramenti. Questi tecnici seguono una forma di teologia economica neoliberale che è forse ancora più dogmatica della teologia
religiosa, che almeno fa riferimento a una spiritualità. La mia
risposta è aldilà del pessimismo e dell’ottimismo: non vedo soluzioni. In realtà, l’umanità come specie è sempre in grado di
trovarne, ma dal punto di vista del medio termine, specie italiano, non ne scorgo.
Costanzo Preve (1943) ha studiato filosofia, scienze politiche
e neoellenistica a Torino, Parigi e Atene. Ha insegnato filosofia
e storia per trentacinque anni (1967-2002) nei licei italiani. Ha
scritto decine di libri e centinaia di saggi d’argomento storico,
politico e filosofico. Ha pubblicato: Il popolo al potere (Arianna
editrice) e Elogio del comunitarismo (Controcorrente), Dove
va la Destra? Dove va la Sinistra? (con Giano Accame, Settimo
Sigillo); L’ideocrazia imperiale americana; Filosofia del presente
(Settimo Sigillo), Del buon uso dell’universalismo. Elementi di
filosofia politica per il XXI secolo (Settimo Sigillo).
D. A suo parere, come può una crisi finanziaria divenire
economico-reale?
R. Con la finanziarizzazione spinta dell’economia non esiste
più separazione tra economia reale e virtuale-speculativa. Due
35
n. 04/2012
Crescita infelice, decrescita felice
A colloquio con Maurizio Pallante, “Movimento per la Decrescita Felice”
D. Quali sono state, secondo
Lei, le cause della crisi attuale?
Sono strutturali o episodiche?
R. Sosteniamo, come movimento della decrescita felice,
che la causa della crisi che stiamo vivendo sia un eccesso di
produzione, che richiede, per
essere assorbito, una continua
crescita dei debiti sia pubblici che privati, delle famiglie e
delle aziende. Questi aspetti,
che solitamente vengono considerati contraddittori – come
il rigore per ridurre il debito
o l’espansione della domanda
per rilanciare l’economia – in
realtà sono interdipendenti
tra loro. Se gran parte dell’assorbimento della domanda e
dell’offerta viene fatta attraverso il debito, la crescita di
quest’ultimo è l’aspetto complementare della crescita di
produzione delle merci.
Perché questa situazione? Perché la concorrenza internazionale, in un sistema economico fondato sulla crescita della
produzione di merci, costringe le aziende a fare continuamente investimenti in tecnologie sempre più performanti
che consentano a sempre meno persone di produrre sempre più cose.
Queste tecnologie, quindi, aumentano sistematicamente l’offerta di merci e ne fanno diminuire la domanda, attraverso la riduzione dell’occupazione. Questa è la causa, diciamo, strutturale.
La causa scatenante, invece, è stata la crisi dei mutui subprime
negli Stati Uniti – crisi che d’altronde risponde perfettamente
a questa logica. Essa è stata determinata dal fatto che le banche
americane prestavano del denaro (economia del debito) a delle
persone che esse stesse classificavano nella categoria dei subprime. Erano quindi i clienti meno affidabili, perché erano stati già
protestati o perché avevano causato fallimenti e così via. Ma perché prestavano soldi a queste categorie, sapendo perfettamente
che non li avrebbero mai restituiti? Perché, in questa maniera,
tenevano alta la domanda di case, impedendo la crisi del settore
dell’edilizia. Del resto, in tutti i Paesi in cui la crisi ha avuto e ha
una maggiore evidenza ci sono grandi quantità di case invendute.
D. Come si palesa la crisi, nei
diversi ambiti della società?
R. È una crisi che si sta manifestando gravemente innanzitutto dal punto di vista occupazionale, ma anche nella
crescita dei debiti pubblici.
Se si adottano le tradizionali misure politiche economiche per affrontare i periodi di
crisi, se si punta a superare il
problema occupazionale e a
rilanciare la crescita e la produzione di merci, bisogna
aumentare la spesa pubblica
e quindi il debito. Se invece si vuole agire per ridurre
il debito – gran parte della
domanda essendo infatti sostenuta da esso – ciò significa aggravare la crisi. Tertium
non datur. Questo è comprovato dal fatto che adottando
le tradizionali politiche economiche, come si è fatto finora, non si è riusciti a superare la crisi.
A fronte di questo, qual è la
proposta che il movimento
della decrescita felice avanza?
La nostra proposta è quella
di trovare del denaro fresco
per fare investimenti senza aumentare i debiti pubblici. Esso può
derivare unicamente dalla riduzione degli sprechi. Perché questi
non sono soltanto, diciamo, la produzione di qualcosa che non
serve, ma comportano altresì dei costi.
Un esempio. Mediamente, per riscaldare le nostre abitazioni, si
consumano duecento chilowattora al metro quadrato all‘anno.
In Germania non si dà la certificabilità alle case che ne consumino più di settanta: un terzo delle nostre. Ma le case migliori
ne consumano quindici: un decimo delle nostre. Se ci fosse una
politica economica finalizzata a ridurre gli sprechi degli edifici,
se per esempio si riducesse il consumo da duecento a settanta si
ridurrebbero di due terzi i consumi delle fonti fossili nel riscaldamento. Non dimentichiamo che il riscaldamento invernale assorbe in cinque/sei mesi la stessa energia che richiedono tutto il
parco macchine e tutti i camion nel corso di un anno, quindi un
terzo complessivo delle nostre importazioni.
36
n. 04/2012
che saranno capaci di sfruttare un’agricoltura di prossimità e di
uscire dalla logica della mercificazione a livello mondiale saranno anche in grado di attenuare le conseguenze negative che la
crisi comporterà anche dal punto di vista alimentare. Non dimentichiamoci che l’agricoltura chimica ha un enorme bisogno
di fonti fossili: per avere una sola caloria di cibo si arriva a consumarne almeno dodici di più in fossili. Questo è il primo elemento della rilocalizzazione.
Il secondo sarà la capacità di garantire la massima autonomia
energetica. Anche da questo punto di vista, occorre percorrere
due strade: la prima è, come detto precedentemente, la riduzione degli sprechi; la seconda, la soddisfazione del fabbisogno residuo con quelle fonti rinnovabili che sono presenti in maniera
differenziata nei vari luoghi del mondo.
Il terzo aspetto sarà la massima valorizzazione della piccola e media industria. Nella logica della globalizzazione, queste vengono massacrate dai grandi gruppi multinazionali, che le sfruttano, utilizzandole come fornitrici di indotto di particolari o come
contoterziste. Occorre invece dare loro un‘autonomia, instaurando un rapporto diretto con i consumatori.
Si tratta di esperienze già avviate, ad esempio, nel settore dell‘abbigliamento. Cominciano ad esserci aziende che si stanno rilocalizzando, sottraendosi alla globalizzazione: non avendo più il
problema del marchio, riescono a mantenere i prezzi bassi, garantendo dei prodotti migliori da un punto di vista qualitativo,
utilizzando tecniche meno invasive nei confronti dell‘ambiente
e pagando adeguatamente i propri dipendenti.
A partire dal settore dell‘abbigliamento si stanno sviluppando
delle interessanti esperienze anche nelle riduzioni degli sprechi
energetici e nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Diverse aziende e società stanno praticando quello che viene chiamato il solare
collettivo: l’acquisto collettivo di pannelli fotovoltaici per favorire al massimo, diciamo così, l’abbattimento dei costi rispetto
ai produttori e la risoluzione dei problemi amministrativi legati
all’installazione – e questo, con lo scopo di valorizzare al massimo l’autonomia energetica di una realtà locale.
Ma se le nostre case consumassero un terzo di quanto accade attualmente, si avrebbero delle riduzioni dei costi di gestione, dovremmo in sostanza comprare meno petrolio dall‘estero. E i soldi
risparmiati potrebbero servire – dovrebbero essere impiegati –
per pagare l’occupazione delle persone che lavorano per ridurre
i consumi delle nostre case. Si introdurrebbero cioè elementi di
riduzione qualitativa nel fare umano e non soltanto di riduzione
quantitativa del PIL.
In questo settore si può lavorare moltissimo e ci sono diverse
cose che potrebbero essere fatte creando quindi non un’occupazione purchessia, ma di qualità, in attività che, riducendo gli
sprechi, consentirebbero di recuperare il denaro necessario a pagare gli investimenti.
D. L’unico modo di uscire da questa crisi, dunque, sarebbe una
riduzione degli sprechi trasversale, che coinvolga cioè tutti i
settori.
R. È una riduzione che si ottiene mediante lo sviluppo di tecnologie più avanzate, che aumentino l’efficienza con cui si usano le
risorse e l’energia e con cui si è in grado di recuperare le materie
prime contenute negli oggetti dismessi.
L‘uso delle tecnologie che noi sosteniamo e che chiamiamo della
decrescita ha questi tre obiettivi: aumentare l’efficienza energetica, incrementare l’utilizzo delle materie prime e favorire il recupero di tutte le materie prime contenute negli oggetti dismessi.
Queste tecnologie hanno una grande possibilità di espansione,
perché nei decenni passati, in conseguenza della grande disponibilità di petrolio a prezzi molto bassi, non è stata fatta nessuna
politica né economica né industriale finalizzata a ridurre gli sprechi. Per cui c’è da moltissimo fare per rimettere le cose a posto.
Naturalmente, se diminuiscono gli sprechi diminuisce anche
quella che noi chiamiamo la produzione e il consumo di merci
che non sono beni. Si ha insomma una decrescita guidata e controllata del PIL. È una cosa da non confondere con la recessione, che è invece una riduzione indiscriminata non voluta né controllata della produzione di merci. Questa decrescita dipende da
scelte volte a ridurre una parte di quelle merci che non hanno
nessuna utilità effettiva e che anzi, molte volte, creano danni e
problemi.
D. Si tratta di proposte assai concrete, dunque. In conclusione, a quali conseguenze andiamo incontro se non si fa marcia
indietro?
R. Ci troviamo oggi alla fine di un’epoca storica cominciata duecentocinquanta anni fa con la Rivoluzione Industriale. Se non
riuscissimo a sviluppare ciò che noi proponiamo – il che è, diciamo, una strada di transizione verso una fase diversa della storia –
della civiltà umana non resterebbe che un crollo rovinoso come
è accaduto nel caso dell’Impero Romano. Certo, le conseguenze
sarebbero molto più gravi sia dal punto di vista dell’estensione –
perché questo crollo interesserebbe l’economia mondiale – sia
dal punto di vista della gravità delle conseguenze, che coinvolgerebbero una porzione ben più vasta della popolazione che si troverebbe a non riuscire a soddisfare i propri bisogni fondamentali.
D. Allo stato attuale delle cose, questa soluzione verrà praticata?
O piuttosto la crisi è destinata ad aggravarsi?
R. La mia opinione è che questa possibilità alla fine non verrà
considerata, perché comporta comunque una decrescita del PIL
e le persone che gestiscono l’economia – a livello politico, industriale, sindacale e così via – non hanno una base culturale per
comprenderla. Cosa occorre fare, a questo punto? Costruire un
blocco sociale in grado invece di individuare in questa proposta una soluzione sia dal punto di vista del reddito sia da quello
occupazionale.
Ecco, per ottenere questo risultato il movimento della decrescita
felice ritiene si debba anzitutto agire nel senso della rilocalizzazione delle attività produttive e delle figure corte; il lavoro deve
ritornare a essere un’attività attraverso cui gli esseri umani possano soddisfare dei bisogni, in un raggio di territorio non eccessivo rispetto alla produzione stessa. Vanno cioè ridotte le filiere.
Questa rilocalizzazione dell’economia dovrà avvenire su tre direttrici fondamentali: la prima è l’attività di produzione di cibo.
Bisognerà fare in modo di valorizzare al massimo quella che si
chiama la sovranità alimentare; le popolazioni e i gruppi umani
Maurizio Pallante (1947) vive da qualche anno in una cascina
nel Monferrato astigiano, dove coltiva ortaggi per autoconsumo,
legge libri di eretici del pensiero e scrive saggi e libri. Ha collaborato con La Stampa, Il Sole 24 ore, Il Manifesto e Rinascita. È
presidente e fondatore del Movimento per la Decrescita Felice e
ha fondato il Comitato per l’uso razionale dell’energia. Gestisce
il sito internet decrescitafelice.it. e un blog per il sito de Il Fatto
Quotidiano.
37
n. 04/2012
La moneta-debito e le crisi economiche
A colloquio con Domenico de Simone, economista eterodosso
proprio qui. Solo che rendersene conto comporta
mettere in discussione il
fondamento stesso del capitalismo, ovvero il capitale e la sua natura. Intendo il
capitale come denaro che si
traduce in mezzi di produzione per l‘esercizio dell‘attività di impresa e genera
profitti. La creazione del
denaro sul debito comporta che la crescita dell‘economia sia accompagnata
necessariamente dalla crescita del debito e quindi dagli interessi che l‘utilizzo di
questo comporta. Ma gli interessi sono per lo più una
rendita, né più né meno di
quanto non lo fosse il possesso della terra all‘epoca
della Rivoluzione Francese.
Una rendita che si impadronisce di quote crescenti della produzione e che, sfruttando il proprio dominio,
ha determinato per la propria esistenza condizioni
di assoluto privilegio. Tra
queste, l‘evidente sperequazione tra il trattamento fiscale delle rendite da azioni
o titoli o gestione di immobili, rispetto alle condizioni direi quasi schiavistiche a cui il regime fiscale sottopone il lavoro. La creazione di denaro sul debito ha due conseguenze
immediate. La prima è che il denaro tende ad essere sempre
più scarso, poiché questo stato ne aumenta la redditività, e la
seconda è che la crescita dell‘economia dipende dalla crescita del debito. Da qui derivano sia le profonde sperequazioni
nella distribuzione del reddito, al punto che nei “paradisi fiscali” poco più di ottantamila persone posseggono tanto denaro quanto il PIL di USA e Giappone messi assieme, sia le
crisi di debito sempre più violente e ravvicinate. Gli effetti
del capitale finanziario nei Paesi non sono molto diversi da
quelli delle cavallette sui campi di grano. Arrivano in sciami
sempre più grandi e incontrollabili, prendono tutto quello
che c‘è da prendere e poi se ne vanno, lasciando solo miseria
e desolazione.
D. Quali sono a Suo parere
le cause della crisi che stiamo vivendo?
R. La crisi economica e finanziaria, che ha investito
il mondo intero con grande virulenza nel 2007 e nel
2010 ha avuto una nuova drammatica fiammata
che dura tuttora, ha radici
lontane.
La verità è che il sistema capitalistico passa da una crisi all‘altra, sempre più violenta e profonda, e non c‘è
nessuna spiegazione soddisfacente di questo fenomeno, né il capitalismo ha elaborato antidoti efficaci per
impedirle. La gente ha poca
memoria, soprattutto dei
fatti spiacevoli, e non ricorda le crisi del passato, se non
quelle di dimensioni tali
da essere passate alla storia,
come quella del ‚29. Anche
il mediatico ha pochissima
memoria, o fa finta di non
averla, e non ricorda le crisi anche recenti. Gli anni
Ottanta hanno rappresentato, almeno in Italia, l‘ultima illusione di una crescita
possibile in un clima sociale relativamente stabile permeato
da un certo ottimismo. Sono gli anni della crescita del debito pubblico in rapporto al PIL, che passa in pochi anni dal
63% del 1982 al 90,83% del 1988, ma anche quelli del “divorzio” tra la Banca d‘Italia e il Tesoro. Ancora quattro anni
e il debito supera il PIL attestandosi nel 1992 al 105,49%.
In quell‘anno ricordo la grave crisi finanziaria che consentì
l‘attacco speculativo di Soros e compagni e che comportò
l‘uscita dell‘Italia dallo SME. Da allora viviamo in uno stato
di crisi permanente, interrotto sporadicamente da periodi di
pausa, sempre più brevi ed episodici.
Ripeto da anni che il nodo del problema è il debito, che è
destinato inevitabilmente a crescere poiché la stessa moneta
viene creata sul debito.
Ora che il debito aggregato è divenuto un multiplo del PIL,
qualcuno si sta rendendo conto che forse il problema sta
38
n. 04/2012
La società dovrebbe avere come fine la tutela della vita e della
libertà dei cittadini per consentire a ciascuno di cercare la felicità, come recita pomposamente la Costituzione americana, e
non dubito che i padri fondatori avessero in mente questo, così
come non dubito che i nostri padri costituenti volessero davvero una società fondata sul lavoro per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona umana. Ma queste sono rimaste solo
buone intenzioni prive di alcun significato concreto. I difensori della nostra Costituzione dovrebbero rendersi conto che l‘azione dei
governi degli ultimi venti anni e la
situazione effettiva del Paese contraddicono in modo palese buona parte dello spirito e della lettera della Costituzione. A cose fatte
qualcuno chiederà di modificarla,
come si chiede all‘esercito sconfitto di ammainare la bandiera dopo
la battaglia perduta.
È ormai evidente che il modello
europeo, la “via socialdemocratica
al capitalismo” o, se si preferisce,
la “via capitalistica al socialismo”,
ha perduto la sua battaglia contro
il liberismo sfrenato nordamericano e che la crisi europea è soltanto
la conseguenza di questa rovinosa
sconfitta.
D. Che differenza c‘è rispetto alle
altre grandi crisi del passato, come
ad esempio quella del 1929?
R. La natura di questa crisi non è
affatto diversa da quella delle crisi
del passato. Si tratta sempre e comunque di crisi di debito e del panico che queste comportano tra gli
operatori economici. La differenza
consiste essenzialmente nel modo
in cui si manifesta, negli strumenti
che sono stati adottati, nella profondità e vastità di quella attuale,
che è molto più grave del disastro
del 1929. In altri termini, sostengo
che le crisi del capitalismo, dai primi dell‘Ottocento sino ai giorni nostri, siano tutte state indotte
dai meccanismi di creazione di denaro sul debito, cosa che peraltro era già nota ai tempi di Marx, quando questi notava, nel
terzo libro del Capitale, che nel 1850 in Inghilterra circolavano
trecento milioni di sterline in cambiali a fronte di ventitré milioni di banconote. E poiché quelle obbligazioni erano esigibili
a semplice richiesta e per l‘intero, “non è questa una situazione che ci può far venire le convulsioni in ogni momento?”. Ovviamente oggi le situazioni sono cambiate, i meccanismi di controllo si sono moltiplicati, le obbligazioni sono completamente
diverse da quelle di cui parlava Marx. Ma la logica del sistema è
identica: basta guardare i bilanci di molte banche per rendersi
conto che le convulsioni possono verificarsi davvero in qualunque momento. Ma, a parte queste ultime, che sono comuni a
D. Da quanto detto, le cause di questa crisi paiono, in qualche
modo, implicite nelle premesse di quello stesso sistema che ora
si trova in una situazione drammatica…
R. Direi che la situazione di crisi permanente cui accennavo sopra non consente di pensare a cause episodiche. Sono convinto che questa sia la crisi terminale del capitalismo di guerra e
che l‘ultima guerra venga combattuta con strumenti finanziari ed elettronici e, solo marginalmente, con strumenti bellici. Gli
effetti sono esteticamente diversi
ma i risultati non cambiano e su
un piano etico si tratta comunque
di un conflitto. Dico subito che
non si avrà un vincitore, ma tutti
i popoli del mondo ne usciranno
sconfitti.
Se questo è vero, dobbiamo anche
dire che la crisi era prevedibile. Il
problema è che per farlo sarebbe stato necessario situarsi al di
fuori della logica del sistema per
sottoporlo ad una critica rigorosa, e questo pochi erano in grado
di farlo e, soprattutto, nessuno di
loro è stato ascoltato. Nel 1989,
con la scomparsa repentina, ma
anch‘essa prevedibile, dei regimi
dell‘URSS e dei paesi satelliti e,
negli anni immediatamente successivi, con la “conversione” della
Cina al capitalismo, restava solo
Cuba a tenere viva l‘idea che fosse
possibile un sistema economico
diverso dal capitalismo delle multinazionali e delle “sette sorelle”.
In pratica, l‘idea stessa di un‘alternativa al capitalismo è tramontata
definitivamente proprio quando
ce n‘era più bisogno. Il capitalismo in Occidente era in qualche
modo temperato dall‘idea della
possibilità di un‘alternativa, anche se il “comunismo” burocratico dell‘URSS non era certo un
sistema né appetibile né praticabile. Nei paesi occidentali la ricerca di una via nazionale al socialismo si era tradotta in un sistema
di welfare e di redistribuzione del reddito tutto sommato accettabile ed in alcuni paesi efficiente, soprattutto in quelli di area
scandinava dove il welfare ancora resiste, anche se con molte
difficoltà. Il “trionfo del capitalismo”, dopo la caduta del muro
di Berlino, ha portato con sé anche l‘affermazione dell‘ala più
estremista del capitalismo, quella che ha determinato la sostanziale abolizione del welfare in mezza Europa, che ha indotto le
imprese a privilegiare l‘aspetto finanziario su quello produttivo,
che spinge per la privatizzazione di ogni settore delle attività
umane, compresi servizi essenzialmente pubblici come la polizia e il fisco, per non parlare della sanità e della scuola. È il trionfo del dominio del denaro sulla vita, dell‘interesse sul benessere,
del debito sulla produzione.
“
Questa è la
fase terminale
del capitalismo:
L'ultima guerra
sarà combattuta
con strumenti
finanziari ed
elettronici,
non solo con
armi materiali
”
39
n. 04/2012
valanga della fuga generale. Con la stessa logica, all‘impresa o
al Paese vengono chiesti interessi più alti per “remunerare” il
rischio che rappresenta finanziare quell‘impresa o quel paese.
Spesso la sfiducia è “provocata” proprio al fine di ottenere interessi più elevati dagli investimenti. Ad esempio, pochi anni
fa la Slovenia è entrata nell‘area dell‘euro con l‘aureola di paese sommamente virtuoso, con un
basso debito pubblico, uno Stato
e un‘industria efficienti, una popolazione laboriosa e attiva, ed
ora si trova sull‘orlo della bancarotta. L‘unico dubbio è se la bancarotta ci sarà a ottobre o a novembre prossimi.
L‘ottica con la quale operano i
gestori di questi grandi capitali è
esclusivamente il profitto più elevato possibile, entro un orizzonte
temporale a volte delle dimensioni di pochi secondi. Non c‘è nessuna strategia “politica” nella testa
dei gestori dei fondi di investimento, l‘unico obiettivo è quello di chiudere la giornata con un
guadagno, anche se piccolo (ma
lo 0,1% su cento miliardi sono
cento milioni, che rappresentano il lavoro di cinquemila persone per un anno a 20.000 euro annui), e chiudere con un discreto
utile, tale comunque da far scattare premi di produzione sempre
molto consistenti. Che per ottenere questo obiettivo siano state
chiuse venti fabbriche e mandate sul lastrico diecimila persone,
i nostri gestori non se ne accorgono nemmeno. È la logica del sistema ad essere totalmente inefficiente, al punto che più il gestore
è “bravo” più il suo lavoro produce paradossalmente effetti deleteri per l‘economia.
molte situazioni di grande tensione, il comune denominatore
è dato dal ruolo del debito e del denaro, sia in moneta che in
banconote. La scarsità del denaro produce indebitamento e il
rallentamento della crescita economica genera insolvenza diffusa nella società e una paura che, a sua volta, induce ulteriore scarsità di moneta. Che differenza c‘è, sotto questo aspetto,
tra allora e oggi? Le autorità che
gestiscono l‘economia mentivano
allora per “dare fiducia” alla gente
e mentono ora per “dare fiducia”
ai mercati.
“
Il “trionfo
del capitalismo”,
che ha abolito
il welfare in
mezza Europa,
è la vittoria del
dominio del
denaro sulla
vita, dell'interesse sul benessere,
del debito sulla
produzione
”
D. A prescindere da somiglianze
e differenze, come può una crisi
di ricchezze virtuali, nata in ambito finanziario, colpire il sistema dell‘economia reale, quindi la
produzione di beni e servizi?
R. Il problema è che il denaro
nel capitalismo svolge tre funzioni, di cui due sono utilissime
mentre la terza genera tutti i problemi. La funzione di unità di
conto, che vuol dire per esempio
che i bilanci delle società, qualsiasi cosa producano o facciano,
sono esposti in moneta e quindi
in una sorta di lingua che ne descrive l‘andamento economico, e
la funzione di mezzo di scambio,
per cui tutti i beni e i servizi hanno un prezzo espresso in moneta
e con lo stesso strumento posso
comprare le cipolle al mercato,
un‘automobile e remunerare il lavoro di qualcuno; queste sono le
funzioni essenziali.
Quella che crea problemi è la
funzione di riserva di valore che
è connaturata all‘essenza stessa
del capitalismo. Si tiene il denaro
perché garantisce il futuro e lo si
spende per comprare le cose che
servono o per investire al fine di
ottenere più denaro ed una “garanzia” per il futuro. Ovviamente, quando non c‘è “fiducia” nel
sistema, quindi principalmente
nei momenti di recessione economica, la gente tende a non
spenderlo e a tenerlo in banca o
“sotto il mattone”. Ma, oltre al risparmio dei privati, il problema deriva dai grandi capitali speculativi, le cavallette di cui
parlavo prima. Basta un poco di sfiducia in un‘impresa o in
uno Stato perché capitali di enormi dimensioni fuggano via
facendo fallire l‘impresa o il Paese. A volte non serve nemmeno che la sfiducia sia provocata da qualche evento oggettivo. Basta solo che qualche grande investitore realizzi i suoi
guadagni, magari semplicemente nella persuasione di trovare
una migliore collocazione in un altro Paese, per provocare la
D. È possibile in qualche modo
prevedere gli sviluppi futuri della crisi?
R. Nessuno può farlo realmente.
La mia idea, che peraltro ripeto
da tempo immemore, è che non
se ne esce se non con una trasformazione radicale del sistema finanziario: altrimenti, si andrà
avanti fino ad un punto in cui le tensioni diventeranno intollerabili. A quel punto può succedere di tutto, da una guerra
mondiale devastante ad una serie di rivolte dei disperati contro i governi, ad un lento affogare in un nuovo medioevo di
tutti contro tutti, di bande criminali che dominano il territorio, in un declino culturale e sociale sempre più accelerato, non diversamente da quanto accadde alla caduta dell‘Impero Romano. Questa ultima fu dovuta al fatto che il sistema
40
n. 04/2012
distribuisca un reddito di cittadinanza a tutti i suoi membri,
che si aggiunga al reddito di lavoro per chi ce l‘ha e chi vuole
farlo. Una comunità fondata su un reale principio di solidarietà tra i suoi membri che però non sacrifichi l‘iniziativa individuale sull‘altare di una pretesa uguaglianza al ribasso, ma
che consenta invece a tutti di esprimere le proprie capacità nel
campo verso cui ciascuno si sente più portato. L‘idea di fondo
è che la ricchezza non è data da un insieme di cose materiali,
ma dalla capacità di una società di utilizzare al meglio le conoscenze di ciascuno consentendogli di collocarsi nel proprio
posto e con l‘impiego giusto. Questa somma di conoscenze individuali costituisce il capitale sociale di qualsiasi società data. È
una sua porzione a venire “prestata” alle imprese quando producono un bene qualsiasi, poiché esso può essere pensato e
prodotto solo in presenza di quelle conoscenze. Questa è la
base teorica del Reddito di Cittadinanza, inteso come remunerazione del capitale sociale. Più questo cresce, più la remunerazione deve aumentare. Che poi mille imprese crescano e
producano e competano sul mercato per ottenere i migliori
risultati e ottenere i migliori guadagni è cosa buona. L‘attività
di impresa è un‘attività al servizio della società e chi la intraprende deve essere messo in grado di avere l‘interesse, oltre che
le capacità e la forza, per farlo. Per le stesse imprese, un sistema del genere, che elimini il peso degli interessi sul capitale e
consenta di ottenere finanziamenti in funzione di parametri
oggettivi, è il migliore possibile. Il reddito di cittadinanza, oltre a consentire alle imprese sgravi consistenti sul sistema del
welfare, creerebbe anche un mercato per i propri prodotti. Per
evitare l‘accumulazione di beni materiali è sufficiente un sistema fiscale di stampo scandinavo a tassazione progressiva.
Chiunque può avere anche cento appartamenti o mille, ma ci
paga una barca di quattrini di tasse, così che nessuno debba
pagarle per averne una o due.
Ho descritto questa alternativa nei miei libri ed in particolare
in uno che ho titolato Faz, acronimo di Zone di Autonomia
Finanziaria, ovvero quei nuovi comuni di cui auspico la costruzione. Per quanto riguarda il denaro, se la ricchezza è conoscenza – e di questo do ampia dimostrazione nei miei libri
– essa non appartiene ai detentori del capitale finanziario, ma
alla società nel suo insieme. Se il denaro deve essere uno strumento di scambio, è sufficiente uno qualsiasi perché lo scambio avvenga. Gli euro, i dollari, gli yen non servono a niente se
non a chi ancora dà loro fiducia. Questa è una società in cui la
fiducia è una merce. Quella che vogliamo costruire è una società in cui la fiducia sia il fondamento dell‘azione sociale. Solo
così si esce dal dominio del capitale sulla vita e si costruisce
una società a misura d‘uomo.
economico che si basava sul lavoro servile e sulle conquiste
territoriali non era più efficiente e l‘impero sopravviveva solo
grazie ad un sistema fiscale sempre più rapinoso ed iniquo. La
situazione attuale non è molto diversa da allora. Anche oggi il
sistema fiscale favorisce la rendita e punisce chi lavora e, nonostante le promesse e le dichiarazioni di intenti, diventa sempre
più rapinoso e pesante. La cosa assurda è che questa pesantezza non serve praticamente a niente. Il debito pubblico è regolarmente cresciuto nonostante le manovre drastiche, e una tassa iniqua come l‘IMU ha avuto un gettito di circa 9,6 miliardi,
pari al 10% degli interessi di un anno sul debito pubblico e a
meno del 2% che si pagherà quest‘anno in Italia sul debito aggregato, ovvero il debito di Stati, enti locali, imprese e famiglie
messo assieme, che a dicembre ammonterà a oltre 500 miliardi, circa un terzo del PIL.
Insomma, se un terzo del PIL va a remunerare la rendita finanziaria, è difficile pensare che la situazione possa reggere ancora
a lungo. Come diceva Gandhi, nel mondo ci sono risorse sufficienti per i bisogni di tutti, ma assolutamente insufficienti per
l‘avidità di pochi.
D. Esistono soluzioni concrete e realizzabili o siamo destinati a precipitare fino in fondo? Magari con la prospettiva che
soltanto un altro conflitto mondiale, come nel secolo scorso,
possa rappresentare l‘unica via d‘uscita possibile?
R. Una guerra come quelle che insanguinarono il secolo scorso
non è più una soluzione praticabile. Sia la Prima che la Seconda Guerra Mondiale comportarono un‘enorme distruzione di
ricchezze ma soprattutto l‘impiego di milioni di disoccupati
spediti al fronte a fare la guerra. Oggi una guerra sarebbe certo terribilmente distruttiva ma durerebbe solo pochi minuti o
pochi giorni. Per risolvere la disoccupazione non è praticabile, poiché le tecnologie belliche non hanno più bisogno di un
gran numero di soldati. A meno che il progetto non sia quello
di eliminare fisicamente milioni di civili dalla faccia della terra
e risolvere il problema in modo radicale (non mi meraviglierei
che ci possa essere al mondo qualche pazzo che coltivi un‘idea
del genere). Anche per questo, un‘alternativa si deve trovare
subito, e l‘alternativa c‘è ed è immediatamente praticabile.
Si tratta di eliminare dalla faccia della terra gli interessi sul capitale e, in sostanza, questo comporta la fuoriuscita dall‘economia del debito. Ora, se è difficile immaginare che ciò possa
avvenire per l‘azione dei governi, che in Occidente sono per lo
più asserviti agli interessi del capitale finanziario, da qualche
tempo alcuni Paesi, e mi riferisco in particolare all‘Ecuador,
alla Bolivia, all‘Islanda, all‘Argentina e al Brasile, hanno cominciato a contestare efficacemente le politiche rapinose delle
multinazionali e delle loro banche. Questa non è ancora l‘alternativa al sistema né la soluzione del problema, ma almeno
dimostra che è possibile fare qualcosa.
Ma qui non si tratta di fare qualcosa o distribuire punizioni esemplari sperando che le cose vadano meglio. Se la crisi è
strutturale, occorre pensare al modo in cui cambiare la struttura,
altrimenti il problema non sarà mai risolto.
La mia idea è che dobbiamo immaginare una nuova epoca
dei Comuni, non fondata, però, sulla logica territoriale, ma
su comunità in parte territoriali in parte virtuali che generino
rapporti economici al di fuori del sistema. Comunità fondate su due capisaldi: un denaro che non sia riserva di valore e
quindi, necessariamente, a tasso negativo, e una comunità che
Domenico de Simone (1949) ha esercitato la professione di
avvocato per circa trent’anni, per poi proseguire gli studi di
economia e di filosofia iniziati durante gli anni caldi del ’68 in
cui ha militato, sino al 1975, con il Manifesto. La forte connotazione libertaria non gli consente alcuna collocazione politica: i suoi scritti sono amati ed osteggiati con pari intensità sia
dalla destra che dalla sinistra. Le sue idee sono fortemente criticate dall’establishment accademico, nei cui confronti nutre
altrettanta se non maggiore ostilità. Fra le ultime sue pubblicazioni: Crac! Il tracollo economico dell’Italia (2011), Il debito
non si paga! (2011), Faz (2012). I suoi libri sono liberamente
leggibili e scaricabili dal suo sito.
41
n. 04/2012
Per un’etica della pratica bancaria
A colloquio con Andrea Baranes, presidente della Fondazione
Culturale di Banca Etica
da moltissimi anni. La crisi è esplosa negli ultimi sei,
però possiamo fare diversi
esempi; oggi abbiamo una
massa di derivati – strumenti della finanza ormai usati
come pure scommesse. Non
hanno nulla a che vedere
con l’economia reale e hanno una dimensione che so,
dodici, quindici, forse venti volte il PIL della ricchezza reale del pianeta – diciamo dodici, quindici o venti,
perché neanche si sa a quanto equivale esattamente. Abbiamo giganteschi capitali
che girano ventiquattro ore
su ventiquattro, alla continua e ossessiva ricerca del
massimo profitto nel minor
tempo possibile. Abbiamo
una finanza che ha totalmente perso di vista il suo ruolo
sociale di strumento al servizio dell’economia e della società ed è diventata fine a se
stessa: fare soldi dai soldi nel
più breve tempo possibile. Le
difficoltà che vediamo oggi
sono prima di tutto legate a
questa situazione dei mercati, alla quale si sommano delle difficoltà dei singoli Paesi ma
anche una costruzione europea che è assolutamente inadatta
a fronteggiare una situazione di crisi, di difficoltà. È quindi
in qualche modo una tempesta perfetta che è dovuta a diversi
fattori strutturali nazionali, europei e internazionali.
D. Quali sono, a suo parere,
le cause di questa crisi? Sono
incidentali o strutturali?
R. Le cause sono abbastanza evidentemente di natura finanziaria, relative cioè
alla dimensione ipertrofica
di una finanza senza nessuna regola. Nel 2007-2008
è esplosa la crisi dei mutui
subprime negli Stati Uniti
che ha causato una fortissima crisi economica a cascata
in tutto il mondo. La maggior parte delle economie
occidentali – gli stessi Stati
Uniti, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna – si è
dovuta indebitare moltissimo per salvare quelle stesse
banche che avevano causato
la crisi e c’è stato un aumento enorme dei debiti pubblici di tutti questi Paesi. I
debiti pubblici vengono finanziati tramite l’emissione
di titoli di Stato, ogni Paese emette i suoi BOT, i suoi
BTP, i suoi CCT. Quindi
in questo momento i Paesi
dalle economie più deboli, come l’Italia e la Spagna,
provano a emettere i loro titoli per finanziare il proprio debito. Il problema è che di questi titoli ce n’è una montagna.
Che cosa succede allora? Succede che gli investitori di capitali
comprano quelli della Germania, perché adesso la Germania
– o la Francia o gli Stati Uniti – è più sicura, ma non comprano i titoli italiani. Questo è peraltro uno solo dei possibili
meccanismi di trasmissione della crisi della finanza all’economia. Ancora oggi, a dispetto di essa, la finanza specula contro
interi Paesi. Quindi, sicuramente ci sono delle cause economiche, sicuramente ci sono delle difficoltà in Italia, in Spagna,
in Grecia, in Irlanda, ma la miccia della crisi e la sua ragione principale è una gigantesca finanza-casinò fuori dal mondo che pesa sull’economia reale e che determina i destini di
tutti noi.
D. Quali sono le differenze con le grandi crisi del passato, ad
esempio con quella del 1929?
R. Con quanto accaduto nel ‘29 ci sono alcuni tratti comuni. Anche in quel caso le banche avevano iniziato a speculare
pesantemente con i soldi dei clienti e si era creata una gigantesca bolla finanziaria sul nulla. Quando è esplosa, le banche
non hanno più avuto la possibilità di rimborsare i loro clienti
e ci sono state ondate di panico. Ricordiamo le immagini di
centinaia di clienti con i sacchi a pelo in fila davanti alle banche. Nel 2007, in qualche modo, c’è stata un’analoga bolla finanziaria, che è scoppiata e che stava trascinando nel baratro
D. Dunque, si tratta di cause intimamente strutturali...
R. Sì, assolutamente. Sono cause strutturali che vanno avanti
42
n. 04/2012
prezzo del grano viene in massima parte pattuito sui mercati
finanziari, nuovamente tramite derivati e prodotti speculativi.
I piccoli contadini, di conseguenza, così come i consumatori e
tutti noi, si trovano costretti a subire le decisioni e le volontà
di pochi grandi speculatori che operano sui mercati finanziari.
Quindi le conseguenze sono moltissime. Oltre a ciò, una seconda
conseguenza abbastanza diretta è
il fatto che questa crisi finanziaria
ha avuto e ha degli impatti durissimi e decisivi su tutti noi perché
ci troviamo nell’obbligo di accettare qualunque misura di austerità, dai tagli alle pensioni alla sanità, eccetera, per restituire fiducia
ai mercati. Questo è il più grande
paradosso che stiamo vivendo in
questo momento, a dispetto dei
terribili comportamenti della finanza degli scorsi anni: noi cittadini siamo costretti a restituire
fiducia ai mercati e quindi ad accettare tagli alla spesa pubblica,
all’istruzione, al welfare, alla ricerca, pur di compiacere l’insaziabile appetito dei signori della
finanza.
le banche. La differenza è che si è scelto di salvare le banche a
qualunque prezzo e in pratica scaricare sugli Stati, sul pubblico, il costo di questa crisi, il costo delle stesse banche. Oggi
sono questi Stati ad essere in difficoltà e paradossalmente gli
stessi mercati finanziari che erano stati salvati approfittano di
questa situazione, di questi eccessivi debiti contratti dagli Stati,
per speculare contro di essi. Sembra che qualunque misura presa in esame dal mondo politico
venga scelta semplicemente per
compiacere i mercati finanziari e non per controllarli, come
invece dovrebbe. Siamo arrivati
all’assurdo per cui i vertici europei o le decisioni di politica nazionale funzionano o non funzionano se la borsa sale o scende.
Siamo arrivati all’assurdo per cui
qualunque misura politica deve
avere come unico obiettivo non
diminuire la disoccupazione,
non garantire un maggiore benessere ai cittadini, ma diminuire lo spread, insomma ossequiare i mercati finanziari. Quindi
ci troviamo in una situazione in
cui, ancora più nettamente del
‘29, l’intero mondo politico ed
economico, nonché l’intera società civile, dipendono dall’andamento dei mercati finanziari.
“
Siamo costretti
a restituire
fiducia ai
mercati e quindi
ad accettare
tagli alla
spesa pubblica,
all'istruzione,
al welfare, alla
ricerca, pur di
soddisfare l'appetito dei signori
della finanza
”
D. In questo gioco perverso, la
crescita viene dunque inibita in
modo congenito...
R. Proprio così. Più che altro mi
verrebbe da dire che qualunque
crescita economica in questo momento viene drenata dal mondo
finanziario. L’economia italiana è in recessione, ma i mercati
finanziari continuano a pretendere profitti in doppia cifra. La
ricchezza reale del mondo, il suo
PIL, cresce del due o del tre per
cento all’anno e gli speculatori finanziari continuano a pretendere
tassi di profitto del dieci per cento o più. Non servono grossi ragionamenti per capire che è una
situazione totalmente insostenibile: la finanza vuole continuare
a crescere con ritmi che sono assolutamente incompatibili con
quelli dell’economia reale. Per realizzare questo proposito, continua a prosciugare qualsiasi risorsa
di quest’ultima, creando all’occorrenza gigantesche bolle sul
nulla che prima o poi scoppieranno. La crisi nasce e si conserva tramite un misto di queste due opzioni e qualunque intervento dell’economia reale, qualunque tentativo di far ripartire
la crescita o lo sviluppo o qualsiasi altra cosa, se non ci sono
delle regole per fermare questa finanza, verrebbe interamente
drenato dalla speculazione. Come sta di fatto avvenendo.
D. Come può una crisi nata in
ambito finanziario e virtuale
avere effetti sull’economia reale, sulla produzione di beni e
servizi?
R. Le ricadute sono dirette e
sono più di una. In qualche
modo, la finanza e la speculazione si nutrono delle oscillazioni dei prezzi e, d’altra parte,
oggi sono persino in grado di
creare queste stesse oscillazioni.
Non c’è speculazione sui titoli
di Stato tedeschi perché il loro
prezzo è sempre costante, quindi
se li compro a cento e li rimetto a cento non posso speculare
sul prezzo. Per così dire, non mi
posso divertire. Molto più divertente è poter comprare titoli
che un giorno quotano ottanta, il giorno dopo cento e quello ancora dopo centoventi. Oggi gli stessi strumenti finanziari
esasperano queste oscillazioni – parliamo dei titoli di Stato,
parliamo del petrolio, del prezzo delle materie prime, persino
di quelle alimentari. Il valore di qualunque bene, prodotto o
servizio viene in gran parte deciso da meccanismi speculativi. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Per esempio, il
43
n. 04/2012
o ambientale? Se tutti noi iniziamo, nel nostro piccolo, dal
basso, a esigere piena trasparenza nell’utilizzo del nostro denaro, sicuramente ciò potrà portare ad un cambiamento nell’insieme del mondo finanziario e assieme costringere il sistema
bancario tradizionale a cambiare rotta. Oggi delle alternative ci sono, per utilizzare i propri
soldi in una maniera trasparente,
secondo modalità che favoriscano l’economia reale, lo sviluppo dell’ambiente e della società.
La finanza etica è un esempio di
questo diverso utilizzo del denaro che è possibile fare.
D. Senza un cambiamento di rotta, quali sarebbero le conseguenze, a quali prospettive andremmo incontro?
R. Beh, i rischi sono enormi e oggi sono sotto gli occhi di
tutti. Ogni giorno, sui quotidiani, si titola dell’euro: futuro
oppure no? Quale può essere il futuro dell’Europa? In questo momento è messa a rischio la
stessa Unione Europea. Di fatto,
parlare oggi di crisi dell’euro o
dell’Unione Europea è la stessa
cosa. L’Unione Europea è stata
costruita sull’unione monetaria,
dei mercati e della valuta ma non
c’è un’Europa sociale dei diritti.
I rischi sono enormi, anche a
breve termine e, appunto, sotto
gli occhi di tutti.
“
A livello tecnico
sappiamo come
diminuire la
speculazione,
bloccare i
derivati, far
abbassare la leva
finanziaria e
chiudere i
paradisi fiscali:
È una questione
di volontà
politica
”
D. Lei collabora con Banca Etica. Ha anche sottoscritto il Manifesto degli economisti sgomenti.
In base alla Sua esperienza, esistono delle soluzioni fattibili
per uscire da questa crisi?
R. Sì, assolutamente. Soluzioni e
alternative ci sono; forse la cosa
che da un lato fa più arrabbiare
ma dall’altro dà qualche speranza
è che a livello tecnico sapremmo
esattamente cosa fare, come diminuire la speculazione, bloccare i derivati, far abbassare la leva
finanziaria e chiudere i paradisi
fiscali. È unicamente una questione di volontà politica. Per
arrestare e superare questo momento di difficoltà, da un lato è
necessario in qualche modo superare il vergognoso potere delle
lobby finanziarie, che malgrado
tutti i disastri che hanno causato, continuano a opporsi a ogni
forma di regolamentazione, a
ogni proposta per chiudere questa speculazione, questa finanza-casinò; quindi, da un lato, diciamo dall’alto, c’è la necessità
di dare nuove regole. Dall’altro,
per così dire dal basso, forse ancora più importante è rendersi
conto che tutti noi, troppo spesso, oltre che vittime siamo anche
complici di questa crisi. Troppo
spesso sono anche i nostri piccoli risparmi – mille, duemila, cinque, diecimila euro, messi sul
conto corrente, nel fondo di investimento, nel fondo pensione – a rimestare e alimentare la speculazione finanziaria. Allora, cominciamo a chiederci: i nostri soldi, sul nostro conto
corrente, vanno a finanziare l’economia reale, l’economia del
territorio, le energie rinnovabili, il bene comune della società, o non vanno piuttosto ad alimentare speculazione sociale
D. Questa è anche la proposta di
Banca Etica...
R. Esattamente. Banca Etica è
l’unica banca in Italia che, per
esempio, pubblica sul proprio
sito internet tutti i finanziamenti concessi ad imprese e cooperative e via discorrendo, che
finanzia unicamente le energie
rinnovabili, l’agricoltura biologica, il commercio equo, la cooperazione sociale: solo ed esclusivamente progetti che hanno
ricadute positive sul piano socio-ambientale. Ovviamente rifiuta qualunque forma di speculazione, i paradisi fiscali o cose
del genere e permette dunque,
grazie alla piena trasparenza, di
far sapere a ciascuno dove finiscono i propri soldi. Se le altre
banche tradizionali non lo fanno, Banca Etica dimostra che se
non c’è nulla da nascondere, allora non è necessario nascondere
proprio nulla.
Andrea Baranes (1972) è presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, della rete
di Banca Etica. È portavoce della
campagna 005 per l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie (“zerozerocinque.
it”) ed è stato responsabile delle
campagne su istituzioni finanziarie private presso la CRBM.
È autore di diversi libri sui temi
della finanza e dell'economia, tra
i quali Finanza per Indignati (Ponte Alle Grazie), Come depredare il Sud del mondo e Il grande gioco della fame (Altreconomia) e Per qualche dollaro in più – come la finanza
casinò si sta giocando il pianeta (Datanews). Collabora con
diverse riviste specializzate nel settore economico e della sostenibilità, quali Valori e Altreconomia e con i siti “Sbilanciamoci.info” e “nonconimieisoldi.org”.
44
n. 04/2012
Ernst Jünger
“Maxima minima”
di Andrea Scarabelli
C
i troviamo in un interregno, in uno Zwischenreich,
scriveva Nietzsche alla vigilia di quel secolo travagliato che ci siamo, da poco più di un decennio, lasciati alle spalle. Un momento storico nel quale i vecchi valori
hanno subito una svalutazione ed i nuovi ancora indugiano
a manifestarsi; i suoi tratti, spesso deformati da un’accelerazione sempre crescente, lasciano intravedere nuovi ordinamenti. È un momento nel quale abbondano certo gli strilloni
del presente ma anche passatismi che paralizzano l’azione e
progressismi semiautistici, che proiettano la soddisfazione
della ansie del presente in un futuro sempre più lontano, secolarizzando il progetto millenaristico giudaico-cristiano. La
tecnica, la scienza, il progresso non sono del tutto soddisfacenti? Nessun problema: domani – o al massimo dopodomani – tutto si risolverà. Così il culto dell’utopia, legato ad una
concezione materializzata del Paradiso terrestre, si sposa con
la modernità. Una stagione di Titani, scriveva Jünger negli
anni Trenta nel suo Operaio.
Per orientarsi occorre affidarsi a sistemi di riferimento diversi da quelli moderni, i quali non fanno che radicarsi nella
crisi, impedendo una fuoriuscita da essa. Tra i manualetti per
sopravvivere alle insidie di questo nostro tempo, non possiamo non menzionare Maxima minima, raccolta di pensieri di
Ernst Jünger finalmente resa disponibile in lingua italiana,
nella traduzione di Alessandra Iadicicco, per i tipi dell’editore
Guanda, storico promotore dell’opera dello scrittore tedesco.
Gli argomenti qui trattati si pongono in diretta linea di continuità con le tesi de L’operaio, trattandosi di un commento
alla stessa opera, composto a distanza di più di trent’anni. È
un bilancio, ma anche un’integrazione. Le vicende dell’operaio vengono proiettate in una cornice che ci riguarda più da
presso.
Per chi voglia sbrogliare la matassa dell’attualità, insomma,
il libro è della massima utilità. Jünger ci propone di adottare
“uno sguardo adatto alla luce crepuscolare” (p. 9), che è quella
del nostro tempo. Viviamo alla fine di un’epoca storica, scrive, e siamo destinati a vederne gli elementi crollare ad uno ad
uno. Ma ciò, senza indulgere a pessimismi di sorta, in quanto,
come scrive poco dopo, “il tramonto altrove è un’alba” (ibidem). Questo “altrove” è, per il momento, solo indovinabile
– purtuttavia, la consapevolezza della sua esistenza già non è
poco, per chi si trovi a vivere nella modernità. Le forme dei
tempi che corrono altro non sono che il prologo ad una nuova
fase. Per comprenderne la portata, occorre però ragionare in
termini assai differenti rispetto a quelli che costituiscono la
valuta corrente del nostro tempo. Dinnanzi al materialismo
tiranneggiante, è invece bene riflettere sul “primato dei cambiamenti spirituali su quelli tecnici, di quelli tecnici su quelli
politici, di quelli politici su quelli strategici” (ibidem). Jünger fornisce una chiave di lettura efficace ed onnicomprensiva, nella inamovibile certezza che ad aprire e chiudere le ere
storiche non sono fattori di ordine materiale ma anzitutto
spirituale.
Il sottotitolo del libro è Note sul Lavoratore: esso nasce
come una raccolta di appunti atti ad integrare le tesi del suo
lavoro degli anni Trenta. In esso, lo scrittore tedesco aveva salutato l’avvento dell’operaio come una fuoriuscita dalla crisi
della modernità. Formatasi attraverso le battaglie dei materiali della Grande Guerra e nelle acciaierie, nelle quali domina
l’elementare scatenato, questa figura è in grado di adottare
nei confronti dell’esistenza un atteggiamento impersonale
ed eroico, in senso superiore, realizzando la persona assoluta, come ebbe a scrivere Julius Evola. Il XX secolo ha visto
l’esplosione dell’elemento in tutta la sua furia: il borghese,
protagonista di quello precedente, non è nemmeno in grado
di intenderne la portata. Spetta all’operaio assumere il controllo, permettendo il transito da quell’epoca provvisoria che
stiamo vivendo – i cui tratti sono il museo e l’officina – ad una
nuova, nella quale la tecnica avrà raggiunto una sua propria
stabilità, facendosi latrice di spiritualità.
Ebbene, a distanza di tre decenni è ancora l’operaio quella
figura cosmica in qualche modo deputata ad aprire la nuova
era che bussa alle porte: “come Anteo, è figlio della terra; il
suo ingresso è accompagnato da scosse che vanno considerate
tettoniche. La notte che precede la sua aurora è accompagna
da fuochi di fusione” (p. 27). Si tratta della prima personalità
il cui sguardo mira al pianeta intero. Mentre il borghese ragiona per divisioni, la tensione dell’operaio è planetaria; egli
supera le divisioni nazionali per imporre il proprio dominio
al globo: “La terra suddivisa gli è ostile come una veste sintetica che costringa il corpo” (ibidem). Sfugge a qualsiasi catalogazione di tipo storico, transitando “non solo attraverso gli
individui, ma anche attraverso le nazioni, trasformandole fino
in fondo” (p. 52).
La raccolta di pensieri contiene anche tutta una serie di
riflessioni sulla tecnica, su cui Jünger sempre ebbe a riflettere. Essa, la divisa dell’operaio, “è il linguaggio mondiale” (p.
100), il minimo comun denominatore dei nuovi poteri che
vanno affermandosi qua e là, la cui differenza tradisce un’unità
fondamentale, una singolare epperò significativa comunione
d’intenti. Come l’operaio, prima di essere il rappresentante di
una classe sociale o di uno Stato, in questo scontrandosi con
la filosofia della storia marxista, è una categoria dello spirito,
lo stesso dicasi per la sua creatura: “Lo scopo della tecnica è la
spiritualizzazione della terra” (p. 90). Essa si pone in una certa
linea di continuità con il precedente ordinamento ma, nelle
45
n. 04/2012
tempo negli anni Cinquanta, e ora giunto al suo ultimo atto.
La terra è, dunque, il fondo inalienabile della storia umana.
Lo scenario delineato è il seguente: sebbene l’uomo moderno
ne sia scarsamente consapevole, la storia mondiale si articola nella continua intersezione tra molteplici “piani”. Ad ogni
movimento della storia, scrive Jünger, le forze telluriche e ctonie della terra rispondono. Purtuttavia, la fase che noi stiamo
vivendo dispone di una peculiarità assoluta rispetto alle altre:
“Quando l’antica Gea prende a muoversi da sé (…), si muove
ben più in profondità degli strati su cui prosperano lo Stato e
la società, più giù ancora delle cripte e delle cantine” (p. 57).
La forza di cui si è fatto portatore
l’operaio trascende insomma la
storia. Prodotto della modernità,
questa figura al contempo la supera, conducendo ad una nuova dedizione verso la Terra. Ciò di cui
abbiamo oggi bisogno è un nuovo
senso della Terra, scriveva Friedrich Georg Jünger negli anni
Settanta sulla rivista di scienze
simboliche e tradizionali Antaios, diretta dal fratello Ernst insieme a Mircea Eliade (fu proprio
in quella sede che apparve la prima parte di Maxima Minima).
Regolare i propri orologi sulle
ciclicità cosmiche o tramontare,
scriveva Jünger negli anni Trenta
– ecco che cosa risarcirà l’uomo
moderno dalla perdita del nomos
di cui sopra.
È un bilancio critico, il quale si chiude con un appello alla
speranza. Occorre inquadrare il
nostro tempo come una discesa,
la quale però si concluderà in una
fase nuova, in cui saranno ancora
i simboli ad orientare il reale, la
metastoria a regolare la storia, il
più che umano (Simmel) a guidare l’umano. “Mentre le potenze storiche si esauriscono, perfino
laddove abbiano costituito degli
imperi, cresce su scala mondiale la potenza dinamica – non
solo in maniera rozzamente plutonica, ma anche tramite un
inaudito affinamento delle materie prime e degli ingranaggi
dell’apparato tecnico. Su un palcoscenico enorme le perdite
sono ancora più evidenti delle conquiste. «Al muro del tempo» si confondono diritti e confini; al loro posto subentrano
dolore e speranza: anche il mondo dell’operaio sarà per l’uomo un paese natio” (p. 110). Così si conclude il prezioso saggio jüngeriano. Gli sconvolgimenti del nostro presente possono essere affrontati ed inquadrati solo laddove si sia capaci
di adottare un punto di vista che superi la storia, la materia e
l’uomo. In caso contrario, la deriva del nostro presente continuerà inarrestabilmente. Ernst Jünger, Maxima minima.
Annotazioni su L’operaio, traduzione e postfazione di A.
Iadicicco, Guanda, Parma 2012, pp. 123, € 12,00.
mani del suo detentore, acquisisce una portata ed una potenza
rivoluzionarie: “Dapprima si avvale degli arnesi e delle armi
ereditati, ma poi li trasforma. Il suo territorio è la terra, il suo
biglietto da visita la padronanza di mezzi specifici tramite una
potenza spirituale” (p. 94). L’essenza della tecnica dunque
non risiede nella mera produzione di macchine ma affonda le
sue radici in una concezione metafisica della storia.
Tecnica, globalizzazione, operaio, spiritualizzazione. Nella congiunzione di detti termini va annunciandosi una forza
atta a scardinare l’antica visione del mondo occidentale per
inaugurarne una nuova. Certo, la sua irruzione comporta una
perdita irrisarcibile, avvertita
drammaticamente dagli ordinamenti esistenti; tuttavia, laddove
lo sguardo si faccia più ampio, risulta evidente che nell’economia
generale tutto si tiene: “L’evanescenza del nomos, che osserviamo ovunque sul pianeta, non
ricade puramente nel calcolo
delle perdite. Il nuovo capitolo
esige un foglio bianco” (p. 109).
L’avvento della nuova era richiede sia fatta tabula rasa di quella
precedente, i cui valori devono
colare a picco. Assieme ai confini tra Stati, viene a cadere anche
la dicotomia tra le classi sociali,
propria ad una visione di tipo
ottocentesco e di fattura eminentemente borghese: “I segni
distintivi del rango e della classe
sociale possono a malapena essere ancora esibiti tra gli aspetti
museali; la loro vista evoca uno
stato d’animo da mercoledì delle
ceneri. Sul mondo viene gettata
una tuta mimetica, una cortina
anonima, dietro cui si prepara
una nuova entrata in scena” (p.
55). Non occorre vedere in questo crollo una perdita – esso preparerà il mondo nuovo.
Tuttavia – e questo è un tratto assai significativo – secondo
lo scrittore il nostro presente
non fa semplicemente da cerniera tra due secoli ma annuncia il trapasso della storia nella metastoria. La velocità dei
cambiamenti del presente fa intravedere il loro radicarsi in
una dimensione che non è più temporale e, forse, nemmeno
umana: “Al di sotto dei travestimenti storici entrano in campo
le potenze dell’essere” (p. 25). È all’interno di detta cornice
che occorre analizzare i vari fenomeni di transizione che ci
caratterizzano: “Decisione, lotta per l’egemonia, epoca della
lotta tra gli Stati – tutto questo non è il senso; sono le doglie
con cui la terra chiude una delle sue grandi fasi metastoriche
per iniziarne un’altra” (pp. 92-93). Lo sguardo jüngeriano
slitta dalla Weltgeschichte, dalla storia del mondo, alla Erdegeschichte, della terra. La prima non è che un capitolo tra i tanti della seconda, apertosi con Erodoto, scrisse in Al muro del
“
L’avvento
della nuova
era richiede
sia fatta
tabula rasa
di quella
precedente, i cui
valori devono
colare a picco
”
46
n. 04/2012
Alain de Benoist
“Sull'orlo del Baratro”
di Luca Siniscalco
S
me di quel divino nascondimento che Pascal ci ha insegnato
ad amare come speranza” (G. Sapelli, Un racconto apocalittico,
Milano 2011, p. 8). De Benoist si attiene ad un’indagine sobria
ma cinicamente realista, basata sulla necessaria acquisizione di
consapevolezza della gravità delle condizioni attuali.
Lo studio del denaro, forma di alienazione totale che abbatte
il valore – in senso greco – della misura proiettando l’uomo
in una corsa catastrofica suicida, è seguito dall’interpretazione della crisi economica contemporanea come sistemica e non
congiunturale, “di natura nuova: crisi del sistema capitalista,
crisi della mondializzazione liberale, crisi dell’egemonia americana” (p. 25). Quando la proficuità degli investimenti tende a
calare, si aprono al capitalista tre soluzioni possibili: l’allungamento dei tempi lavorativi, il ricorso a una manodopera a buon
mercato e, infine, il credito.
È proprio quest’ultimo, l’indebitamento delle classi popolari
e medie, agente in parallelo ad un rafforzamento del peso dei
mercati finanziari, delle agenzie private di rating e della speculazione, in particolare quella connessa alla “titolarizzazione”,
ad aver causato nell’autunno del 2008 la crisi americana dei
subprimes, origo prima della crisi mondiale. La globalizzazione,
infatti, rea di aver veicolato un capitalismo non più commerciale né industriale (nazionale) bensì finanziario (mondiale),
ha fatto sì, a seguito di decenni di politiche neoliberiste, che
la crisi non si arrestasse nel Nuovo Mondo bensì si diffondesse
viralmente su tutto il globo.
Al centro vi è il dollaro, principale moneta di scambio a livello internazionale, le politiche liberoscambiste ed il modello
bancario vigente (soprattutto in Europa, con la Bce), giacché
“la causa immediata dell’aggravamento dei debiti pubblici è individuabile nei piani di salvataggio delle banche private, decisi
dagli Stati nel 2008 e nel 2009. (…) Per salvare le banche e le
compagnie di assicurazione minacciate, gli Stati, presi in ostaggio, hanno dovuto a loro volta chiedere in prestito sui mercati,
cosa che ha fatto salire il debito a livelli insopportabili” (p. 69).
La recessione economica, che ha diminuito le entrate pubbliche e indotto ad un ulteriore indebitamento statale, preceduta genealogicamente dalle politiche di deregolamentazione e
privatizzazione condotte all’epoca di Reagan e della Thatcher,
non fa che retrodatare la scaturigine del dramma economico
contemporaneo. Di dramma infatti, e non di tragedia, potremmo parlare, in virtù del carattere farsesco e paradossale di un
modello economico le cui radici sono integralmente antropologiche e filosofiche: “La tesi di un soggetto sociale riducibile
all’Homo oeconomicus lascia perlomeno a desiderare. La realtà
sociale non si fa rinchiudere in un’equazione, perché l’uomo
non è né un agente fondamentalmente razionale che cerca sempre di massimizzare il suo interesse, né soltanto un produttore-
crisse Nietzsche: “Ha cuore chi guarda nel baratro, ma
con orgoglio. Chi guarda nel baratro, ma con occhi di
aquila, chi con artigli d’aquila aggranfia il baratro: questi
ha coraggio”. Questa audacia è la cifra peculiare dell’operazione
culturale condotta da Alain de Benoist nel saggio Sull’orlo del
baratro. Il fallimento annunciato del sistema denaro. Il testo, introdotto da tre efficaci contributi dell’editore Eduardo Zarelli,
di Massimo Fini e del traduttore Giuseppe Giaccio, affronta
con serietà analitica e profondità speculativa il precipizio nel
quale l’iniqua “società a clessidra” moderna si sta ormai precipitosamente inabissando.
La diagnosi di de Benoist si rivela di particolar pregio in
quanto capace di affiancare metodologie d’indagine eterogenee; la pluralità di una visione capace di abbracciare la modernità sotto un profilo storico-genealogico di chiara matrice
nietzscheana, unita a considerazioni prettamente economiche,
sociologiche, statistiche, inserite nel più ampio contesto della filosofia, dell’antropologia, della geopolitica e della scienza
politica: tale è la molteplice ma organica costellazione metodologica dell’autore. Questa plurivocità è conseguenza diretta
di una sapienza “inattuale”, diretta all’oltrepassamento della dicotomia destra/sinistra mediante un’operazione sintetica – o
alchemica – sfociante nella critica a posizioni ed analisi ormai
stantìe, superate ed ingabbiate nella logica del sistema e nell’affermazione propositiva: “Al «né destra, né sinistra», che suscita un interrogativo sul punto di vista che si cerca di esprimere,
preferisco la forma «e destra e sinistra», che in fondo esprime
lo stesso concetto, ma lo fa mettendo l’accento sullo spirito di
sintesi dialettico e di Aufhebung tipico delle logiche trasversali
e dei nuovi spartiacque” (p. 160).
L’analisi marxista correlata ai concetti di Forma-Capitale,
plusvalore e modo di produzione trae nuova linfa vitale grazie
ad una riattualizzazione conseguita attraverso gli strumenti ermeneutici forniti da Heidegger, per quanto concerne il ruolo
dell’imposizione planetaria della tecnica sull’uomo, da Sorel, a
proposito di una rivisitazione antimaterialistica e volontaristica del marxismo, dal pensiero antimoderno e controrivoluzionario in relazione all’inconsistenza filosofica e spirituale delle
pretese egualitarie, progressiste ed internazionaliste, prodotto
dell’Illuminismo.
Grazie a un siffatto armamentario teorico, de Benoist ha gioco facile nella distruzione dell’ideologia, in senso marxista, e degli idoli, in senso nietzscheano, della società liberal-capitalista.
La pars destruens del saggio, chiara, concisa e tagliente, denota
un “racconto apocalittico” (per impiegare la felice espressione
coniata da Giulio Sapelli nel suo omonimo saggio) ma privo
della speranza escatologica nei confronti dell’Apocalisse, intesa
come “l’attesa di una rivelazione redentrice, (…) una delle for-
47
n. 04/2012
buono», come si spiega che la società abbia tante caratteristiche detestabili? (…) L’uomo non è né naturalmente buono, né
naturalmente cattivo ma, in quanto essere «aperto al mondo»,
capace del meglio come del peggio, capace di superare se stesso
o di ricadere al di sotto di se stesso” (p. 158).
L’orientamento fattivo proposto da de Benoist non appare
tuttavia pienamente evidente, viziato a mio avviso da una contraddizione interna al suo ragionamento. Il filosofo d’oltralpe
afferma da un lato la necessità di un superamento del baratro,
metafora del sistema monetario, liberista e capitalista, nella certezza che riforme interne al modello attuale non possano rendersi efficaci, se non a breve termine. I toni impiegati in questa
sede sono estremamente duri, si evoca il socialismo come forza
di popolo, si afferma che “l’atteggiamento necessario è quello
della più completa radicalità critica” (p. 171), si rifiuta il mito
della crescita (sulla scia della riflessione di Serge Latouche sulla
“decrescita felice”), la psicologia del capitalista ed il feticismo
del denaro. D’altro canto, nel momento in cui de Benoist approfondisce il proprio indirizzo propositivo elenca una serie
di progetti indubbiamente interessanti ed anticonformisti, ma
altrettanto palesemente interni al sistema; la soppressione del
divieto delle banche centrali di prestare denaro direttamente
agli Stati, una “nuova disciplina bancaria che vietasse alle banche d’affari di fondersi con le banche di deposito, (…) una politica fiscale che permettesse di controllare meglio i movimenti
di capitale a breve termine, (…) distinguere il tasso di interesse
«produttivo» e quello «speculativo»” (p. 81), una riforma
dell’Euro, la lotta alla disparità sociale, l’instaurazione di un
reddito di cittadinanza, politiche protezioniste contro la mondializzazione in nome di una “adozione della preferenza comunitaria europea in tutti i campi” (p. 61): si tratta di proposte
che presuppongono un modello economico capitalista, anche
se indubbiamente lontano anni luce dalla degenerazione contemporanea. Sotto questo profilo il pensiero di de Benoist non
sembra lontano da modelli neokeynesiani, come quelli della
MMT (Modern Money Theory), o da proposte conservatrici
quali quelle di Giulio Tremonti (La paura e la speranza, Milano
2008; Uscita di Sicurezza, Milano 2012).
In de Benoist vi è tuttavia un radicamento profondo nella tradizione europea e nei suoi valori, un soggiornare presso
un nomos della terra ormai perduto, in lotta contro la contraddizione di fondo del liberalismo, per il quale si deve “dare
uno Stato (…) il quale rinunci se non alla guida, al controllo
dell’economia, in un’epoca dominata dai valori economici. (...)
L’economia internazionale si «libera» del diritto inter-statale
europeo, fondato sull’esistenza di Stati effettivamente sovrani.
(…) Il linguaggio vittorioso dell’economia e della tecnica esige
un unico spazio” (M. Cacciari, Geofilosofia dell’Europa, Milano
1994, pp. 125-126).
È forse nel seguente invito, egregiamente sintetizzato da
Giaccio, che risiede allora l’insegnamento più importante
del pensatore francese: “Dobbiamo, come i primi cristiani,
stare nel mondo, cioè immergerci nella realtà per meglio conoscerla e criticarla, e costruire dal basso, con pazienza, calma
e umiltà (nel senso di aderenza all’humus) una prospettiva di
cambiamento radicale, senza essere del mondo” (p. 20). Alain
de Benoist, Sull’orlo del Baratro. Il fallimento annunciato
del sistema denaro, prefazione di M. Fini, traduzione di G.
Giaccio, Arianna Editrice-Macro Edizioni, Cesena 2012,
pp. 182, € 9,80.
consumatore. (…) L’economia liberale, neoclassica, afferma
che l’uomo è interamente calcolabile. La crisi attuale fornisce
la prova del fallimento di questa pretesa alla «trasparenza»”
(p. 36).
Così “il vero ostacolo al protezionismo risiede in una mentalità ideologica, che si può definire «liberale-libertaria»:
narcisismo, individualismo, ossessione del denaro, disprezzo
ostentato per il popolo. (…) Questo individualismo è in effetti un individuo-universalismo, e l’universalismo è anch’esso in
sintonia con il libero scambio, nella misura in cui è collegato
all’idea di un «mondo senza frontiere», in cui le nazioni e i
Paesi sarebbero ineluttabilmente «superati»” (p. 63). Tale immagine del mondo, ispirata, per dirla con Marx, alla peggiore
“robinsonata”, offre risultati concreti mostruosi, nel senso etimologico del latino monstrum, che è apparizione sconvolgente
e ammonitrice: “Prima della crisi del 2008, (…) dei 3200 miliardi di dollari che venivano scambiati quotidianamente nel mondo, meno del 3% corrispondeva a beni o servizi reali” (p. 105).
Il baratro comincia a suscitare paura anche nei cuori più arditi
ma è compito dell’intellettuale immergersi nella verità, anche
quando la sua rivelazione arrechi dolore. De Benoist si addossa
con sincerità questo compito, un fardello che la disamina teoretica puntella in parallelo all’enunciazione dei dati più allarmanti. Il filosofo francese non si risparmia da una meditazione
“politicamente scorretta” sul tema dell’immigrazione, “esercito
di riserva del capitale (…) manodopera docile, a buon mercato
e priva di coscienza di classe” (p. 115), nella ferma convinzione
che “chi critica il capitalismo approvando l’immigrazione, di
cui la classe operaia è la prima vittima, farebbe meglio a tacere.
Chi critica l’immigrazione restando muto sul capitalismo, dovrebbe fare altrettanto” (p. 121).
L’impostazione critica di de Benoist è eccellente, in quanto
capace di connettere le riflessioni più acute della controcultura novecentesca instaurando nuove prospettive affascinanti,
suggerendo la possibilità, tematizzata da altri, di “ipotizzare,
lavorare per un’«altra» modernità, che non sia quella desolante, omicida, che ci angustia sempre più. Rovesciare i Moloch.
Sognare forse... un’antimodernità aperta al futuro” (D. Bigalli,
Un’altra modernità, Bietti, Milano 2012, p. 23). Il pragmatismo di de Benoist renderebbe inevitabile, anche al fine di scongiurare visuali fataliste ed inconcludenti, una pars costruens
all’altezza della critica sferrata al modello vigente. Per quanto
concerne questa destinazione, il saggio è indubbiamente meno
persuasivo.
All’autore vanno tuttavia due meriti indiscutibili: in primo
luogo la comprensione del significato profondo e metastorico
della crisi, parola che, come sottolineato da Eduardo Zarelli, “in
cinese, composta nei suoi ideogrammi, può essere interpretata
abbinando il concetto di “crisi” a quello di «opportunità»” (p.
7) e in senso greco krisis, che deriva dal verbo krine, “separare,
dividere, decidere”, dunque “crisi come ambito di un’opzione
decisiva, tramite la quale procedere alla revisione del cammino percorso sino al presente, ispirando il senso di una svolta,
in vista della salvezza comune” (G. F. Lami, G. Casale, Qui ed
ora, Rimini 2011, p. 18); secondariamente, una visione antropologica avvertita, distante da certe moderne infatuazioni
neo-rousseauiane e primitiviste che vedrebbero nell’uomo allo
stato di natura una creatura buona ed integralmente realizzata.
A tal proposito scrive l’autore: “Se il male sociale, la fons et origo malorum, è «la società», mentre l’uomo è «naturalmente
48
n. 04/2012
Di prossima pubblicazione:
Guido Morselli - Una rivolta e altri scritti (1932-1966)
Stefano Giuliano - Le radici profonde non gelano
Giorgio Galli - L’impero antimoderno
49
n. 04/2012
G. Anders, Lo sguardo dalla torre
F. A. Ossendowski, L'ombra dell'Oriente tenebroso
di Davide Balzano
di Rita Catania Marrone
A vent’anni dalla scomparsa dell’autore, Mimesis propone Lo
sguardo dalla torre, opera scritta nel 1968 da Günther Anders e
mai tradotta in italiano. Il volume, arricchito da un interessante
e puntuale saggio di Devis Colombo, curatore, ci offre una raccolta di favole la cui stesura si protrasse per quasi quarant’anni e
che fornisce numerosi spunti di riflessione i quali, nonostante il
tempo trascorso, mantengono uno stretto legame con tematiche
attuali. Filosofo, scrittore e poeta, antimilitarista convinto e profondamente coinvolto nei movimenti antiatomici, Anders usa in
questa occasione il formato della favola per introdurre la sua visione del mondo e della filosofia, in un misto di ironia, cinismo e
crudeltà non sempre immediatamente comprensibile, ma che lascia spiazzati dopo una più attenta riflessione. Proprio la scelta di
tale formato si rivela tuttavia vincente, provocatoria e tagliente al
punto giusto, in grado di porsi senza scrupoli al cospetto dell’élite universitaria e di rivolgersi, al contempo, ad un pubblico più
popolare, non avvezzo al linguaggio specialistico della filosofia
accademica. In un susseguirsi di brani di varia lunghezza – dai
semplici aforismi ai racconti brevi – l’autore espone la propria
personale visione dell’uomo moderno; un affresco in realtà amareggiato, che constata il dominio sempre meno controllabile della
tecnica sulla vita, la quale ci obbliga ormai ad adeguarci ad essa
per sentirci parte del mondo, ad inseguirla invece che utilizzarla
realmente. Infatti l’avvento della bomba atomica ha reso per la
prima volta possibile che la specie umana ottenesse il potere di
auto-esiliarsi dalla storia tramite la perenne minaccia della distruzione totale. È inoltre presente un secondo tema di riflessione,
spesso sottolineato da Anders: il funzionalismo sfrenato della tecnica umana ha fatto sì che l’uomo perdesse sempre più il contatto
non con la semplice fantasia, ma con la stessa capacità di immaginare, facendo precipitare l’umanità in quello che lo stesso autore
definisce il “dislivello prometeico”, una frattura insanabile tra ciò
che possiamo fare e ciò che possiamo immaginare; ed è proprio
il progressivo allontanamento dell’uomo dall’elaborazione concreta dei prodotti del proprio lavoro ad averlo condotto allo stato
attuale, alla perdita di interesse per i quadri d’insieme ed al lento
appiattimento verso la mansione singola, il mero ritorno economico, la sicura incolumità della propria coscienza trincerata tra le
sbarre degli ordini superiori. Tutti questi sintomi di un’umanità
sempre meno “umana” e sempre più “tecnica” vengono abilmente
parafrasati in brani semplici ma efficaci, quali Il telefono, Il microscopio, La consuetudine, Le chiavi, e altri brevi spaccati di una
visione a tratti rassegnata ma che ancora sembra vedere nella filosofia l’arma più potente che l’uomo abbia a disposizione per farsi
luce nell’oscurità in cui sta precipitando. Impossibile non citare
infine, quale ulteriore pregio della pubblicazione, la scelta più che
opportuna di includere nel testo le litografie che Andreas Paul
Weber, tra le altre cose illustratore della Wiederstand, l’organo del
movimento nazionalbolscevico di Ernst Niekisch, appartenente
all’universo polico della cosiddetta Rivoluzione Conservatrice, inserì nella versione originale. Anch’egli sostenitore delle medesime
battaglie di Anders, l’artista tedesco traspone in immagini quella
stessa tagliente e cruda ironia che abita le favole, dando il proprio
contributo all’aumento del senso di amarezza e ambiguo disagio
in cui si viene spinti dai racconti. Günther Anders, Lo sguardo
dalla torre, a cura di D. Colombo, prefazione di G. Fofi, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 194, € 16,00.
19 dicembre 1916: all’alba della “rinascenza” russa, quando
mancavano ancora pochi mesi a quella rivoluzione che avrebbe
definitivamente cambiato il volto di una nazione (e dell’Europa
intera), viene ritrovato nel fiume Neva il cadavere di un uomo.
Si tratta di Grigorij Efimevič Rasputin. Personaggio ancor oggi
in bilico fra storia e leggenda, Rasputin sembra appartenere più
ad una superstizione medievale che alla storiografia moderna.
Eppure, proprio mentre l’intellighenzia russa spianava la strada
all’entrata trionfale del comunismo, che avrebbe soppiantato
con una violenza inaudita l’impero zarista, scagliando la Russia
nell’età contemporanea, alla corte dei Romanov si respirava un
clima ancora medievaleggiante. A dimostrazione di ciò troviamo proprio la figura di Rasputin: mago guaritore o carismatico
cialtrone? Le opinioni, su questo punto, si dividono. Da una
parte c’era chi lo credeva, come la stessa Zarina Aleksandra, un
“uomo di Dio”, un santo mandato dal divino onnipotente per
salvare la famiglia imperiale. Oppure, al contrario, chi lo riteneva essere l’Anticristo, “il servo del diavolo”, da eliminare affinché
il castigo di Dio non si abbattesse sulla nazione intera. Dall’altra
parte, invece, i più disillusi razionalisti lo dipingevano come un
ciarlatano, un ubriacone e un ladro che, grazie alla sua indiscussa capacità di seduzione, era riuscito a raggiungere un incredibile potere politico presso la corte degli Zar. Fatto sta che, qualunque fosse la verità, un personaggio come Rasputin, monaco
guaritore dagli incredibili poteri magici, poteva ancora avere un
peso politico in una nazione come la Russia di inizio Novecento, che noi tutti siamo abituati a immaginare come una delle
culle culturali dell’età contemporanea. Questa immagine che il
mondo ha della Russia rivoluzionaria non è che una maschera,
filtrata dal senno di poi della storia. Una storia null'affatto univoca, come vorrebbero invece gli alfieri del progresso. La realtà
è che, al fianco di Tolstoij, Dostoevskij, Lenin e Trotsky, vi era
un’altra Russia, quell’Ombra dell’Oriente tenebroso che Ossendowski descrive in questo libro assai suggestivo, donato oggi ai
lettori dalla giovane casa editrice Arethusa di Torino. Streghe e
maghi, pirati e sciamani sono solo alcune delle figure che popolano l’affascinante e spietata Madre Russia di inizio Novecento,
dove paganesimo e superstizione si mescolano a cristianesimo e
razionalismo. Un popolo che, cantato da Tolstoij come il “corriere di Dio”, si trovava invece sempre sul filo del rasoio della
più nera miseria, che troppo spesso si tramutava in follia. Come
nel caso di quelle sette religiose (difficile stabilire se cristiane o
pagane) in cui i contadini, aizzati da un sacerdote-santone, si
tagliavano la gola pregando in gruppo, convinti che solo il loro
tributo di sangue avrebbe placato l’ira di Dio. Testimone diretto di questi fenomeni è Ferdinand Antoni Ossendowski, molto
più che scrittore e giornalista: appassionato di viaggi, fu attento
esploratore di alcuni dei luoghi più selvaggi di Europa e Asia.
La sua attività di denuncia dei crimini bolscevichi lo costrinse a
fuggire dalla sua terra natale, la Polonia, per rifugiarsi in Mongolia, dove conobbe il celebre barone “sanguinario” Roman von
Ungern-Sternberg. Fuga, questa, raccontata nel diario romanzato Bestie, Uomini, Dei, altro testo di indispensabile lettura per
chi crede, al di là dell’apparenza, che la verità non sia una sola.
Ferdinand Antoni Ossendowski, L’Ombra dell’Oriente tenebroso, traduzione di I. K. Ravets, Arethusa, Torino 2010,
pp. 188, € 16,50.
50
n. 04/2012
A. Tagliapietra, Icone della fine
M. Iacona, Il liberalismo
di Mitsuharu Hirose
di Gianpiero Mattanza
Che cosa evoca la parola fine? Fine individuale, del mondo,
Apocalisse? O forse solo una paradossale, istantanea transizione tra ciò che ha tempo e ciò che non ne ha? Per quanto sia
impossibile fissare univocamente questo concetto, ogni epoca
ha cercato di rappresentare le suggestioni che esso suscita tramite miti, filosofia e arte, seguendo lo scorrere dell’evoluzione del
pensiero. Ma cosa implica la fine, per come è stata interiorizzata
dall’uomo nel corso della storia? Le interpretazioni sono naturalmente innumerevoli, così come gli ambiti a cui essa viene associata. Andrea Tagliapietra, filosofo e docente presso l’Università San Raffaele di Milano, ci accompagna lungo un percorso
che comincia dalla ripresa di miti (religiosi e non), teorie e idee
elaborati nel corso dei secoli. Icone appunto, che al pari delle
immagini sacre ortodosse ci permettono di “toccare e vedere
ciò che per altro è e rimane invisibile e inattingibile” (p. 11).
Questo insieme di rappresentazioni si è rivelato propedeutico
allo sviluppo delle attuali icone della fine, contemporanee metafore visive che, grazie ai moderni mezzi di comunicazione, oggi
popolano il nostro immaginario massificato. L’autore le seziona
con un occhio di riguardo nei confronti della cinematografia,
la più giovane delle arti, in rapidissimo divenire e destinata ad
un enorme bacino di fruitori. Lo studio è caratterizzato da un
costante parallelismo tra immagini antiche e moderne, tramite
cui emergono elementi comuni e divergenze tra percezioni presenti e passate. Analogie e differenze sono evidenziate tramite la
moltitudine di riferimenti attinti da tutto l’alveo del sapere occidentale. Tra di essi spiccano numerose pellicole (tra cui alcune
di grandissimo successo come Apocalypse Now o 2001-Odissea
nello spazio) ma anche testi sacri, opere filosofiche e letterarie. Si
comincia con l’Apocalisse, evento carico di significati religiosi e
millenaristici, “rivelazione” che apre una nuova fase; la sua concezione è condivisa da culture e religioni diverse ed oggi può
rispecchiarsi nell’emblematica immagine dell’affondamento
del Titanic, che trascina con sé, oltre a migliaia di vite umane,
la certezza di una modernità illuminata dal progresso. Si prosegue analizzando le immagini del tempo, che nella nostra epoca
trovano la massima espressione proprio nella cinematografia, in
un susseguirsi di fotogrammi che, grazie al fluire del tempo, riesce a mostrarne l’evoluzione. L’autore trova nel sopracitato film
di Kubrick una delle massime espressioni di “temporalità come
soggetto stesso della rappresentazione” (p. 58): immagini in
trasformazione si scontrano con le apparizioni di un misterioso
monolite dagli arcani significati. La settima arte è chiamata in
causa anche nel capitolo dedicato alle immagini dell’estremo:
Schindler’s List di Spielberg e La nona porta di Polanski sono
omologhi moderni delle visioni infernali dantesche e di Hieronymus Bosch. Seppur distanti a livello temporale, sono permeate dai medesimi contenuti. Passando per le immagini della fine
individuale, l’opera si completa con quelle della fine collettiva,
che presenta, tra l’altro, un’accurata analisi di Don Giovanni,
eroe moderno che esalta un abbandono ai propri sensi contrapposto alla severità della morale religiosa del suo tempo. Assieme
al lungo percorso contenutovi, le infinite citazioni e i continui
accostamenti tra immagini rendono Icone della fine una ricchissima miniera per approfondimenti sul tema. Andrea Tagliapietra, Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti,
Società Editrice Il Mulino, Bologna 2010, pp. 218, € 13,60.
Il prolifico studioso Marco Iacona, dottore di ricerca in pensiero politico e istituzioni nelle società mediterranee, ha recentemente dato alle stampe un interessante volumetto intitolato
Il liberalismo. Il pamphlet vuole contribuire, con stile chiaro
e scorrevole, a delineare e commentare la cronistoria del movimento politico (o forse è meglio dire della forma mentis) che ha
finito per intridere come dogma religioso la coscienza dell’uomo
occidentale, abituato al “ben pensare”. La presentazione, firmata da Alain De Benoist, lascia presagire sin dalle prime pagine
che il testo non racchiude un’insipida lista di nomi e fatti, ma
rappresenta una ricerca che tenta di raggiungere una piccola vetta, quella del ritratto fedele alla realtà di ciò che non può essere
raffigurato perché proteiforme e cangiante. L’intellettuale francese afferma infatti: “Marco Iacona non sbaglia a sottolineare,
fin dall’inizio del suo libro, le grandi difficoltà che si incontrano
quando si cerca di individuare il concetto di liberalismo. Queste difficoltà sono in parte spiegate dal fatto che, a differenza di
altri sistemi ideologici, l’ideologia liberale non ha un fondatore
unico” (p. 1). Ecco che l’autore diviene creatore, tentando di
modellare con l’eterogenea materia posseduta una nuova forma,
che vada oltre. Iacona imposta il proprio lavoro in modo innovativo, evitando di trattare l’argomento secondo una scansione
contenutistica legata a schemi statici che possano appiattirne i
contenuti. La prima questione posta è, giustamente, quella della
definizione (oseremmo dire etimologica) di liberalismo. L’autore dialoga con autori classici e contemporanei, citando in ugual
misura pensatori come von Hayek e Bedeschi, Bobbio e de Tocqueville. Crediamo di non sbagliare se diciamo che Iacona lascia
trasparire, nelle pagine seguenti, una certa simpatia verso le prese
di posizione dell’antimodernismo: si chiede infatti se il liberalismo non sia mero frutto della rottura della visione tradizionale
piuttosto che una creazione ex novo. Viene citato Julius Evola,
che definisce l’individualismo come “pretesa prevaricatrice di un
io che è (...) quello mortale del corpo” (p. 23). L’analisi non si ferma dunque, come troppo spesso succede, all’ascolto di autori per
così dire accademicamente “curricolari”, ma si avventura in quel
campo spesso criticato (forse in quanto portatore di verità tanto
scomode quanto urgenti) che è quello animato dalle voci eterodosse, non allineate. Una storia del fenomeno liberale è punto di
partenza imprescindibile per un’analisi esauriente: Iacona non si
esime da un’attenta ricerca storiografica e distingue le diverse fasi
di quella che, dai primi vagiti nell’Inghilterra del XVII secolo alla
diffusione nell’intera Europa nella prima metà dell’Ottocento,
si delinea come un’ideologia. L’autore passa in rassegna punti di
vista diversi e procede con un’attenta presa di coscienza dei punti fondamentali dell’ideologia liberale, con ampi riferimenti alla
storia recente. Particolarmente interessante il confronto/scontro tra l’istituzione democratica e la visione liberale, ma anche
tra quest’ultima e l’assetto totalitario dello Stato. Silenzioso filo
conduttore dell’intera opera si rivela il collegamento che l’autore
sapientemente tesse con le tematiche economiche, a partire dal
XVII secolo sempre più fondamentali per le dottrine di stampo
antitradizionale. Il liberalismo assume così l’assetto bifronte di
libro ben strutturato e interessante punto di partenza per riflessioni di più ampia portata, sempre più necessarie nel buio della
contemporaneità. Marco Iacona, Il liberalismo, presentazione
di A. De Benoist, Solfanelli, Chieti 2012, pp. 91, € 8,00.
51
ARRETRATI
n. 04/2012
www.antaresrivista.it
N. 00/2011
H.P. LOVECRAFT
N. 01/2011
IL PENSIERO IN CAMMINO
N. 02/2012
UN’ALTRA MODERNITÀ
LIBRERIE FIDUCIARIE
CHIETI: Home Movies – Via Ortona 3D ✽ CREMONA: Libreria
del Convegno – Corso Campi 72 ✽ MILANO: Libreria Arethusa – Via
Napo Torriani 1 ✽ Libreria Cortina – Largo Richini 1 ✽ Spazio Ritter – Via
Maiocchi 28 ✽ Bistrò del Tempo Ritrovato – Via Foppa 4 ✽ Fiera del Libro – Corso XXII Marzo 23 ✽ Libreria Odradek – Via Principe Eugenio 28 ✽
PERUGIA: L’Altra Libreria – Via Rocchi 3 ✽ Libreria Il Bafometto – Via
Alessi 36 ✽ ROMA: Libreria Aquisgrana - Via Ariosto 28 ✽ Melbookstore
– Via Nazionale 254 ✽ Libreria Aseq – Via dei Sediari 10 ✽ L’Universale – Via
N. 03/2012
J.R.R. TOLKIEN
Caracciolo 12 ✽ Libreria Nero su Bianco – Via degli Spagnoli 25 ✽ Libreria
Europa – Via Tunisi 3/A ✽
TORINO: Libreria Setsu-Bun – Via Cernaia
40/m ✽ Libreria Arethusa – Via Giolitti 18 ✽ Comunardi Libreria – Via Bogino
2 ✽ Libreria Genesi Universitaria – Via Verdi 39/b ✽ Libreria la Bussola – Via
RIMINI: Libreria Il Cerchio – Via Di Mezzo 6/a ✽ BADIA POLESINE: Caffè letterario Antica Rampa - Via Carducci 63
✽ CHIAVARI: Il Libraccio – C.so Gianelli 2 ✽ GENOVA: Libreria
Po 9/b ✽
Editrice Amenothes – Via San Lorenzo 23/4 ✽
52
in questo numero:
LO STATO DELLE CRISI
L’economia attraverso l’occhio della cinepresa,
da Chaplin a Cronenberg
L’ENIGMA DELLA MONETA
Vacuità del denaro: la risposta filosofica di Massimo Amato
IL MAUSS E L’ECONOMIA DEL DONO
Il ritorno ad una dimensione non speculativa del denaro
EZRA POUND: POETA ECONOMISTA?
Tra “antiusurocrazia” e Credito Sociale.
Quando l’economia si fa poesia
LA SOVRANITÀ SUL DEBITO
Il ruolo della globalizzazione nel sistema capitalista
DEMONDIALIZZIAMOCI
L’appello ad un nuovo tipo di antiglobalizzazione
EFFETTO “BOOMERANG” DEL LIBERO SCAMBIO
Il corto circuito del liberalismo e la necessità di altri modelli
INTERVISTE
Fenomenologia della crisi:
Nino Galloni, Costanzo Preve, Maurizio Pallante,
Domenico de Simone, Andrea Baranes
NEL PROSSIMO NUMERO:
Miti moderni: interpretazioni simboliche di letteratura,
arte e cinema