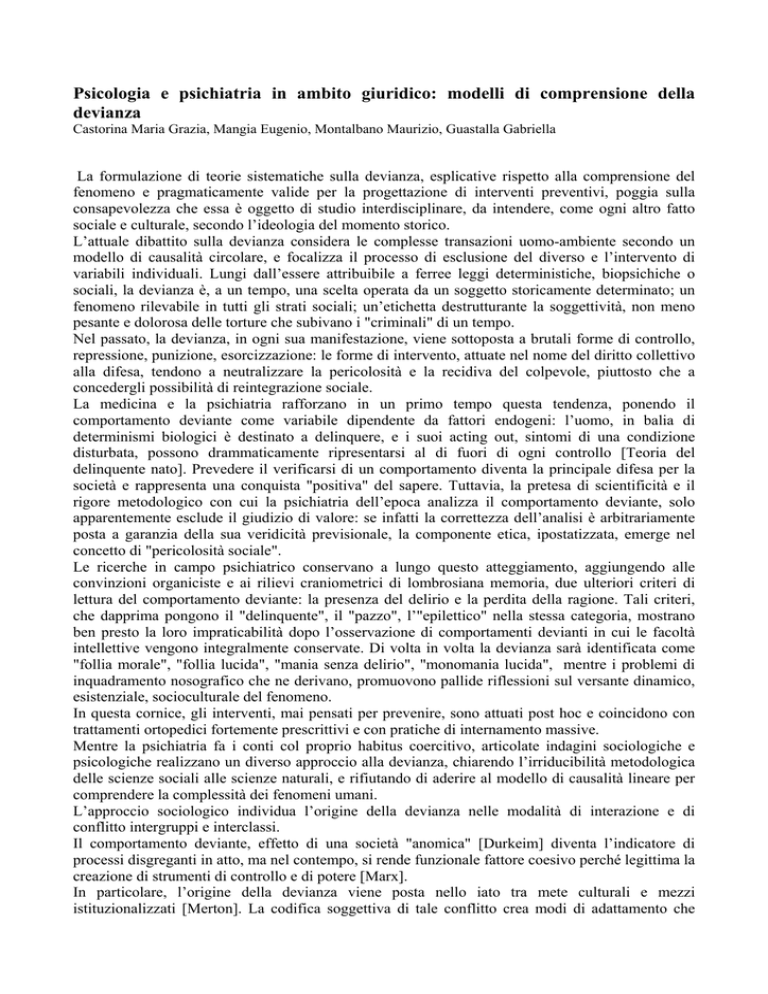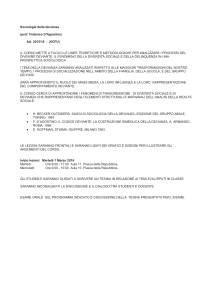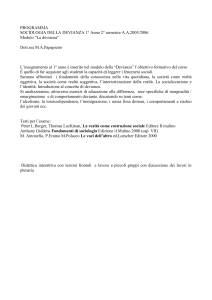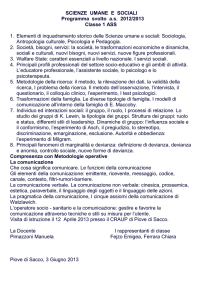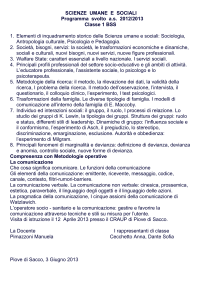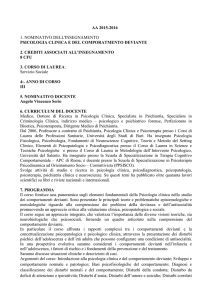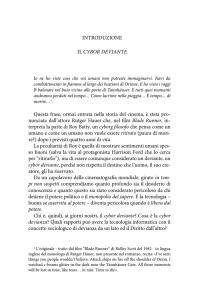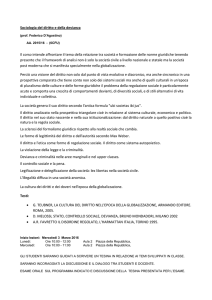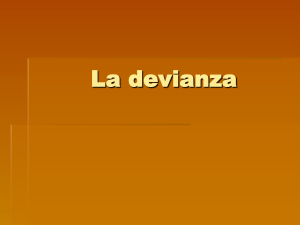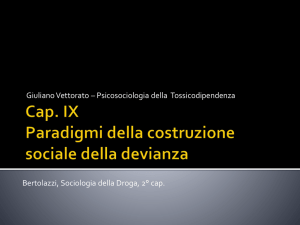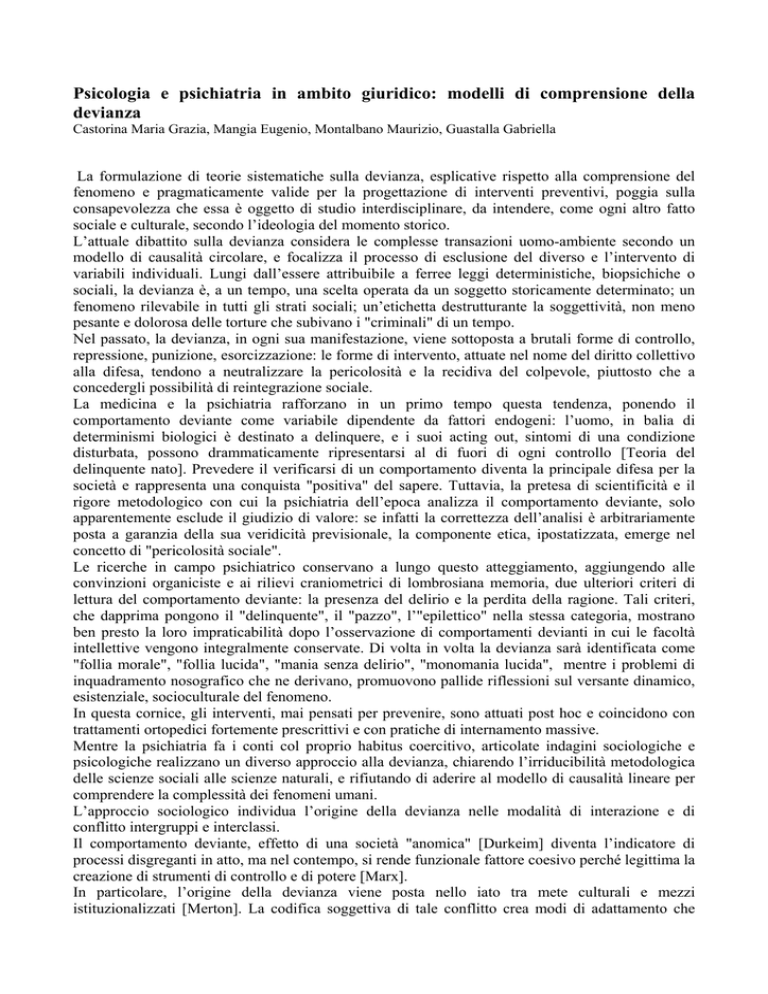
Psicologia e psichiatria in ambito giuridico: modelli di comprensione della
devianza
Castorina Maria Grazia, Mangia Eugenio, Montalbano Maurizio, Guastalla Gabriella
La formulazione di teorie sistematiche sulla devianza, esplicative rispetto alla comprensione del
fenomeno e pragmaticamente valide per la progettazione di interventi preventivi, poggia sulla
consapevolezza che essa è oggetto di studio interdisciplinare, da intendere, come ogni altro fatto
sociale e culturale, secondo l’ideologia del momento storico.
L’attuale dibattito sulla devianza considera le complesse transazioni uomo-ambiente secondo un
modello di causalità circolare, e focalizza il processo di esclusione del diverso e l’intervento di
variabili individuali. Lungi dall’essere attribuibile a ferree leggi deterministiche, biopsichiche o
sociali, la devianza è, a un tempo, una scelta operata da un soggetto storicamente determinato; un
fenomeno rilevabile in tutti gli strati sociali; un’etichetta destrutturante la soggettività, non meno
pesante e dolorosa delle torture che subivano i "criminali" di un tempo.
Nel passato, la devianza, in ogni sua manifestazione, viene sottoposta a brutali forme di controllo,
repressione, punizione, esorcizzazione: le forme di intervento, attuate nel nome del diritto collettivo
alla difesa, tendono a neutralizzare la pericolosità e la recidiva del colpevole, piuttosto che a
concedergli possibilità di reintegrazione sociale.
La medicina e la psichiatria rafforzano in un primo tempo questa tendenza, ponendo il
comportamento deviante come variabile dipendente da fattori endogeni: l’uomo, in balia di
determinismi biologici è destinato a delinquere, e i suoi acting out, sintomi di una condizione
disturbata, possono drammaticamente ripresentarsi al di fuori di ogni controllo [Teoria del
delinquente nato]. Prevedere il verificarsi di un comportamento diventa la principale difesa per la
società e rappresenta una conquista "positiva" del sapere. Tuttavia, la pretesa di scientificità e il
rigore metodologico con cui la psichiatria dell’epoca analizza il comportamento deviante, solo
apparentemente esclude il giudizio di valore: se infatti la correttezza dell’analisi è arbitrariamente
posta a garanzia della sua veridicità previsionale, la componente etica, ipostatizzata, emerge nel
concetto di "pericolosità sociale".
Le ricerche in campo psichiatrico conservano a lungo questo atteggiamento, aggiungendo alle
convinzioni organiciste e ai rilievi craniometrici di lombrosiana memoria, due ulteriori criteri di
lettura del comportamento deviante: la presenza del delirio e la perdita della ragione. Tali criteri,
che dapprima pongono il "delinquente", il "pazzo", l’"epilettico" nella stessa categoria, mostrano
ben presto la loro impraticabilità dopo l’osservazione di comportamenti devianti in cui le facoltà
intellettive vengono integralmente conservate. Di volta in volta la devianza sarà identificata come
"follia morale", "follia lucida", "mania senza delirio", "monomania lucida", mentre i problemi di
inquadramento nosografico che ne derivano, promuovono pallide riflessioni sul versante dinamico,
esistenziale, socioculturale del fenomeno.
In questa cornice, gli interventi, mai pensati per prevenire, sono attuati post hoc e coincidono con
trattamenti ortopedici fortemente prescrittivi e con pratiche di internamento massive.
Mentre la psichiatria fa i conti col proprio habitus coercitivo, articolate indagini sociologiche e
psicologiche realizzano un diverso approccio alla devianza, chiarendo l’irriducibilità metodologica
delle scienze sociali alle scienze naturali, e rifiutando di aderire al modello di causalità lineare per
comprendere la complessità dei fenomeni umani.
L’approccio sociologico individua l’origine della devianza nelle modalità di interazione e di
conflitto intergruppi e interclassi.
Il comportamento deviante, effetto di una società "anomica" [Durkeim] diventa l’indicatore di
processi disgreganti in atto, ma nel contempo, si rende funzionale fattore coesivo perché legittima la
creazione di strumenti di controllo e di potere [Marx].
In particolare, l’origine della devianza viene posta nello iato tra mete culturali e mezzi
istituzionalizzati [Merton]. La codifica soggettiva di tale conflitto crea modi di adattamento che
possono rafforzare o indebolire l’integrazione sociale: l’individuo può infatti decidere di
"conformarsi", accettando di raggiungere le mete attraverso i canali offerti dalla società; oppure di
"deviare", dissentendo dai valori e dai mezzi collettivamente stabiliti.
La condotta deviante, non identificabile tout court con l’atto criminoso, assume le forme
dell’innovazione, della nichilistica rinuncia, della ribellione creatrice, restando comunque
espressione dell’incongruenza tra i bisogni individuali e quelli collettivi.
Il legame tra il comportamento deviante, i processi di interiorizzazione delle norme, e il potere di
definizione delle regole e delle relative pratiche di controllo sociale, costituisce l’area
interdisciplinare nella quale convergono anche i contributi della psicologia e della psicologia
sociale.
L’approccio psicologico alla devianza si concretizza fondamentalmente in ipotesi eziologiche
psicogenetiche, volte alla comprensione delle dinamiche sottostanti la condotta deviante
[prospettiva psicoanalitica], e in teorie esplicative di tipo esogeno, relative all’acquisizione delle
competenze socio-relazionali del soggetto, attraverso i processi di condizionamento e di
interiorizzazione delle regole.
L’interiorizzazione soggettiva dei valori etici e delle norme collettive corrisponde alla costruzione
di un assetto morale che evolve dall’accettazione acritica delle regole alla comprensione delle
stesse.
Il passaggio da una morale eteronoma ad una morale autonoma [Piaget], avviene attraverso
esperienze di apprendimento sociale e processi di "modeling", con cui l’individuo conosce,
condivide e assimila modelli di comportamento esibiti da figure socialmente significative.
In questo modo egli sviluppa una costellazione di conoscenze, abilità, comportamenti, sentimenti,
che rendono più stabile e coerente l’immagine di sé, e lo mettono in grado di partecipare alla vita
sociale.
La competenza dell’individuo agente si rileva nella capacità di usare le regole. Esse, in quanto
socialmente condivise, posseggono, ipse facto, carattere normativo; sono dei simboli che veicolano
l’interazione; vengono significate solo all’interno della teoria conoscitiva del soggetto che le accetta
o le nega.
Secondo il metodo etogenico, le regole sono i meccanismi generativi del comportamento umano,
nell’ambito di un contesto-sistema storicamente definito, i cui elementi si muovono influenzandosi
reciprocamente. Le regole costituiscono, a un tempo, indicazioni pragmatiche e strumenti di
interpretazione: la prescrizione di una condotta richiede l’interpretazione soggettiva del contesto in
cui si dovrebbe svolgere l’azione; questa produce un cambiamento nel significato della situazione
che, a sua volta, può trasformare le direttive del comportamento [Marsh, Rosser, Harrè].
Anche le emozioni dipendono da meccanismi che regolano il modo in cui una situazione è valutata,
espressa, anticipata dal soggetto. Le emozioni, più che essere connotate come parte irrazionale e
perturbatrice del pensiero, vengono considerate come “costruzioni socioculturali”, poiché si
strutturano sulla base di credenze, imperativi morali, norme sociali proprie di determinate comunità
o gruppi. Le emozioni sono funzionali al mantenimento dell’ordine morale. Ad es. la colpa è
funzionale alla repressione del comportamento che l’ha generata.
Le condotte individuali, informate da norme prescrittive-interpretative, vengono agite in modo
coerente, transitorio e adeguato al contesto e alla rappresentazione del sé.
L’azione rimanda all’intenzione e l’intenzione alle regole: rintracciare le regole di un’azione
significa dunque verificarne l’intenzionalità.
L’analisi dell’azione avviene attraverso l’osservazione del comportamento esplicito, del contesto, e
sulla base delle spiegazioni fornite dall’attore. Il resoconto, in particolare, attraverso le categorie
linguistico-concettuali proprie del soggetto, consente l’accesso ai suoi schemi cognitivi, valutativi,
motivazionali.
La verifica dell’intenzionalità da parte dell’osservatore, procede dall’individuazione della
connessione logica tra la descrizione dell’atto e la teoria conoscitiva del soggetto. Poiché
l’intenzione è il significato finalistico con cui il soggetto definisce temporaneamente la sua
condotta, l’agire intenzionale esclude la prevedibilità del comportamento. L’azione infatti può
essere "ridefinita" rivelando il perseguimento di fini diversi.
Nella prospettiva etogenica, la condotta deviante può essere considerata come una momentanea
"ridefinizione" delle norme di tipo prescrittivo; l’azione deviante viola le regole del contesto e si
rifà ad altre regole per essere realizzata. Il deviante contrasta l’aspetto normativo delle regole,
laddove invece il nevrotico dubita della propria possibilità interpretativa per ciò che le regole,
accettate cognitivamente, suscitano emozionalmente.
I teorici del metodo etogenico mettono provocatoriamente in discussione l’approccio tradizionale
alla devianza. Convinti che l’adesione ad un sistema di regole, oltre a costituire un’indicazione
pragmatica per l’individuo, garantisce un efficace controllo della società sul singolo, accettano
l’ipotesi che la devianza non sia nell’atto in sé, quanto nel giudizio degli "imprenditori della
morale" [Becker-Labelling Theory]. Come pratica di controllo, il giudizio sociale non è un destino
ineluttabile che colpisce soggetti passivi: può incidere marginalmente nella struttura psichica
dell’individuo, o determinare una riorganizzazione simbolica degli atteggiamenti nei riguardi del sé
e del proprio ruolo sociale [Lemert]. In questo caso si trasforma in un “cerimoniale di
degradazione” che dà vita a processi di amplificazione della devianza, poiché ingabbia l’esperienza
fenomenologica del soggetto tra i limiti dell’etichetta e della previsione.
“Ridefinire una condotta”, oltre a rimandare concettualmente al senso profondo dell’irripetibilità di
un comportamento, possiede significato euristico per coloro che intervengono sul deviante.
Promuovere un cambiamento significa infatti, operare con il soggetto sulle sue significazioni
socioculturali, sul riconoscimento del suo disagio, sulla possibilità di modificare le condotte non
adattive e di realizzare i suoi obiettivi di crescita.
Negli ultimi anni anche la psichiatria, sempre più attenta agli aspetti relazionali ed esperienziali dei
sintomi e delle condotte [corrente antipsichiatrica], ha privilegiato le caratteristiche dinamicoevolutive della patologia mentale e, conseguentemente, la possibilità di un trattamento
psicosociologico che interviene nel mondo del soggetto come opportunità e diritto, e non come
punizione.
Gli operatori psicosociali sono strumenti di cambiamento e la coscienza di questo ruolo deve fare
riflettere sul limite che riguarda l’obiettivo di “normalizzare” laddove produrre nuove forme di
integrazione secondo modalità correzionali, terapeutiche, affiliative, risponde a pratiche di controllo
sociale, anche se non esplicite come i processi di repressione ed emarginazione.
Bibliografia
BECKER H. S. (1987), Outsiders. Saggi di sociologia della devianza, Gruppo Abele, Torino.
DE LEO G. (a cura di), (1989), Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia
penale, Giuffrè, Milano.
FORNARI U. (1989), Psicopatologia e psichiatria forense, Utet, Torino.
GOFFMAN E. (1972), Asylums. Le istituzioni totali, Einaudi, Torino.
GULOTTA G. (1980), La psicologia giuridica, in Psicologia contemporanea, n.38.
LEMERT E. M. (1981), Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffrè, Milano.
MARSH P., ROSSER E., HARRÈ R. (1984), Le regole del disordine, Giuffrè, Milano.
PONTI G. (1980), Compendio di criminologia, Cortina Ed., Milano.
SZASZ T. S. (1984), Legge, libertà e psichiatria, Giuffrè, Milano.