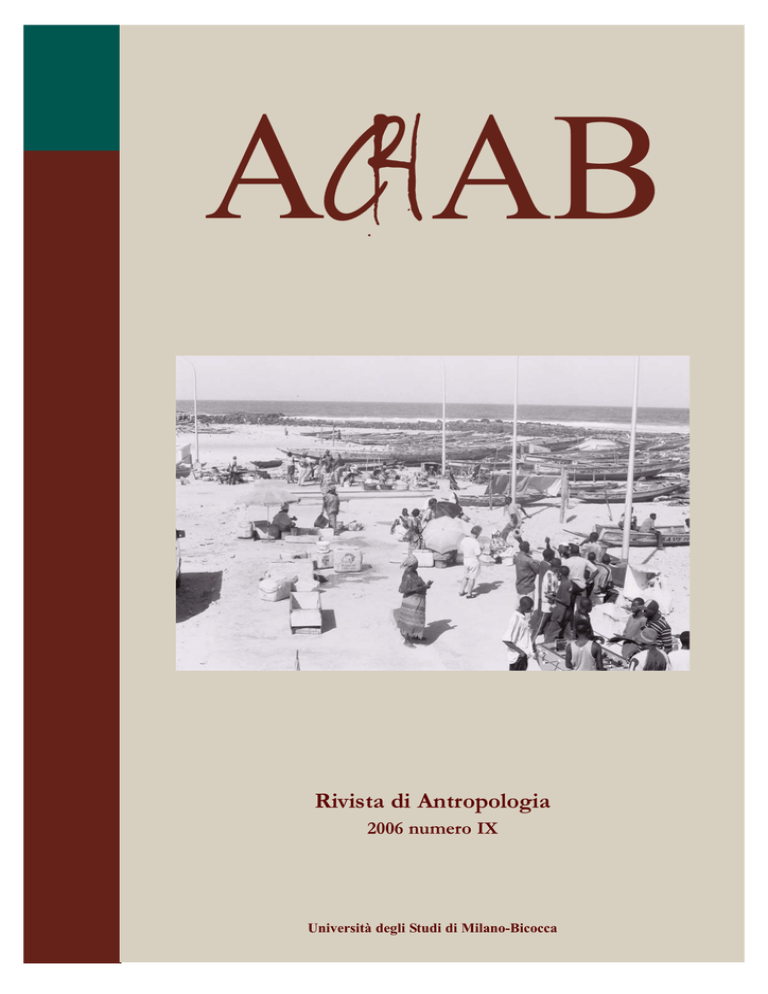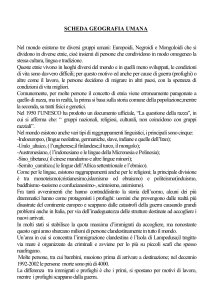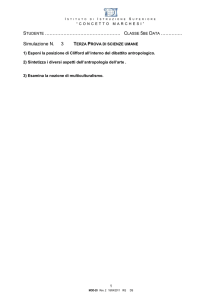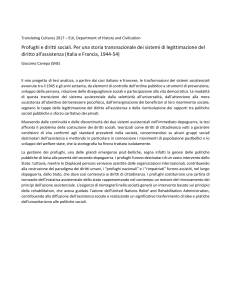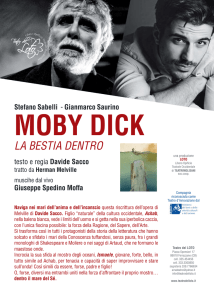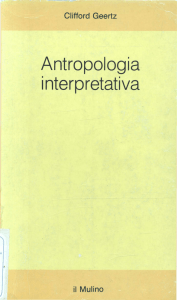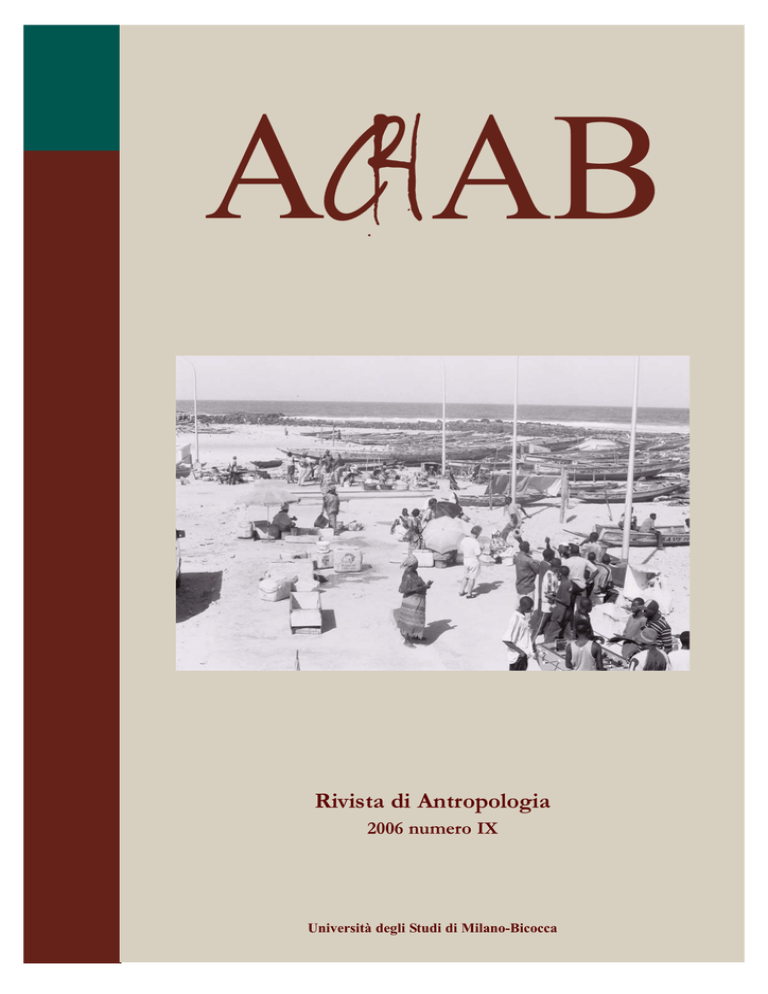
ACHAB
Rivista di Antropologia
2006 numero IX
Università degli Studi di Milano-Bicocca
AChAB - Rivista di Antropologia
Numero IX - ottobre 2006
Direttore Responsabile
Matteo Scanni
Direzione editoriale
Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi
Redazione
Paola Abenante, Paolo Borghi, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi,
Fabio Vicini, Sara Zambotti
Progetto Grafico
Lorenzo D'Angelo
Referente del sito
Antonio De Lauri
Tiratura: 500 copie
Pubblicazione realizzata con il finanziamento del Bando "1000 lire", Università degli Studi di Milano
Bicocca
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 697 - 27 settembre 2005
Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del dominio di alcune immagini qui pubblicate. Gli autori sono
invitati a contattarci.
* Immagine in copertina di Michele Parodi (spiaggia di Yoff, Senegal, Gennaio 2003).
Se volete collaborare con la rivista inviando vostri articoli o contattare gli autori,
scrivete a: [email protected]
ACHAB
In questo numero...
2
La scomparsa di Clifford Geertz (1926-2006)
di Ugo Fabietti
4
Un ricordo di Clifford Geertz
di Roberto Malighetti
6
Autobiografia e immaginazione etnografica
Prime annotazioni
di Pietro Clemente
11
Un contributo al dibattito sulle politiche attinenti alle manifestazioni culturali nello stato
brasiliano di Maranhão
di Arinaldo Martins
15
Welcome to Armenia
Etnografia dell’Ararat nell’identità diasporica armena
di Fiammetta Martegani
23
Rappresentazioni del dolore
I profughi della guerra del Kosovo nella stampa italiana
di Federico Boni e Oscar Ricci
33
Fieldwork between Distance and Intimacy
Reflections on a Photo Exhibition on the Street
di Giovanni Picker
42
Tre preghiere collettive dei musulmani milanesi
Spunti di riflessione sulla fotografia etnografica
testo e foto di Lorenzo Ferrarini
47
Sostenere il mondo
Osservazioni sul concetto di dharma nel brahmanesimo
di Viola Gambarini
51
Silamo Malagasy
Uno sguardo sui musulmani del Madagascar
di Maura Parazzoli
56
La Verifica Incerta
Note a margine di una missione in Angola (Prima parte)
di Michele Parodi
1
ACHAB
La scomparsa di Clifford Geertz (1926-2006)
di Ugo Fabietti
“Nessun ricordo di essere stato una stella può mai impedire
che la fine sia dura”. Così concludeva Clifford Geertz una
conferenza tenuta nel 1999 in cui aveva ripercorso quella che
lui stesso aveva chiamato “una vita di studio”. La “durezza” è
che adesso, a sette anni da quella conferenza, Clifford Geertz
non c’è più. La sua morte abbastanza inaspettata (nonostante
fosse avanti con gli anni), lascia un vuoto importante
nell’orizzonte di riferimento degli antropologi della mia
generazione. Parlare ora, e per di più “dall’Italia”, di Clifford
Geertz, espone inevitabilmente a qualche distorsione
prospettica di non semplice definizione. Quando i suoi lavori
cominciarono a essere tradotti in Italia nella seconda metà
degli anni Ottanta (confermando il proverbiale ritardo con cui
da noi molte discipline – purtroppo l’antropologia non è
l’unica – accolgono certe novità culturali), Geertz fu infatti
“capito poco”, ma per lo più ignorato, dall’establishment
accademico di allora. La sua prospettiva ermeneutica, e la
concezione della “cultura come testo” che accompagnava
quella prospettiva, erano alquanto “disturbanti” per una
comunità antropologica fortemente debitrice o di un
orientamento etnologico più o meno “classico”, o della “magia
strutturalista” o dello storicismo di varia configurazione, da
quello idealista a quello marxista ortodosso.
Anch’io venni a conoscenza dei lavori di Geertz relativamente
tardi, circa una decina d’anni dopo la pubblicazione, nel 1973,
del famoso Interpretation of cultures, il libro che lo consacrò
come uno degli antropologi di primo piano a livello mondiale.
Sino ad allora, di Geertz avevo letto in originale, nei primi
anni Settanta, solo ed esclusivamente La religione come
sistema culturale (1967), ma confesso che ne avevo ricavato
ben poco.
Col tempo tuttavia, Geertz divenne un importante punto di
riferimento per me e altri colleghi italiani che, sebbene per
motivi diversi, si trovavano allora in uno stato di
“indeterminatezza teorica”. Come spesso accade, fu anche
quella volta questione di imparare un nuovo linguaggio. Da
Geertz, ovviamente, imparai quanto fosse importante, nella
costruzione della rappresentazione etnografica, la dimensione
ermeneutica. Questa non va confusa con quello sdilinquimento
della soggettività antropologica contrabbandata per riflessività
che travolse, per un decennio circa, la “meglio gioventù”
disciplinare degli anni 70-80, la quale si faceva forte proprio
della prospettiva geertziana incentrata sul dialogo e sul “punto
di vista del nativo” (che però, per un’ermeneutica stranamente
intesa, diventò per molti “il punto di vista dell’antropologo”).
E’ noto che, a questo proposito, Marshall Sahlins mise in scena
il buffo dialogo tra l’antropologo e il nativo in cui quest’ultimo
chiedeva, implorando, all’antropologo iperriflessivo: “ma non
si potrebbe parlare un po’ anche di me”?
Dirò schiettamente che, di Geertz, mi affascinò in primo luogo
la sua scrittura. Diretta, ironica, suadente, un po’ complice
(riconosciamolo), ma al tempo stesso profonda. In questo, mi
sembra, coniugava il meglio della tradizione anglosassone
(schiettezza nordamericana più ironia britannica) con una
densità argomentativa di matrice tedesca. Ex-studente di
filosofia, benché poco familiare con l’ermeneutica, ritrovai in
Geertz quello “spessore” (le dimensioni del senso, del
significato ecc.) che l’antropologia “classica” (nelle sue
varianti) aveva, diciamo, “rimosso”.
Geertz da noi non fu capito subito perché ribaltava
completamente le regole del gioco, inducendo il sospetto che
benché sia sempre l’antropologo ad avere l’ultima parola
(“scrive…”) non è poi così ovvio pensare che tutto possa
risolversi in descrizione, comparazione e generalizzazione. Il
fatto che anche “gli altri” potessero produrre senso e
significato Geertz lo argomentò in maniera sottile, ricca di
esemplificazioni etnografiche, prendendo spunto dal quanto
mai enigmatico imperativo malinowskiano: vedere le cose dal
punto di vista dei nativi. Perché enigmatico? Perché non si
sapeva bene se l’antropologo dovesse mettersi nella testa del
nativo, se dovesse sostituirsi a lui o imparare tutto ciò che un
nativo sa per essere come lui.
Geertz, che non ha mai amato le teorie chiuse, i sistemi e le
formule, pose invece il problema in termini di comunicazione.
L’antropologia, per lui, era un “ampliamento del discorso
umano”, un tentativo mai concluso di cogliere il modo in cui,
sul campo, si stabiliscono relazioni comunicative capaci di far
emergere oggetti nuovi di riflessione per l’antropologia, “una
scienza”, come lui amava dire, “in divenire”.
Geertz, lo sanno tutti, non è stato il teorico della “cultura come
testo” e basta. Ha studiato la parentela, l’agricoltura, il
mercato, la religione e lo stato alle due estremità opposte del
mondo musulmano. Se si fa eccezione per Bali (immortalata,
forse troppo, in alcuni saggi etnografici) Geertz fu, infatti, e
suona un po’ strano dirlo, studioso dell’islam o, meglio
sarebbe dire, di alcuni aspetti culturali del mondo indonesiano
a est e di quello maghrebino a ovest, proprio ai confini estremi
e opposti dell’islam storico, aspetti culturali che vennero da lui
affrontati in una prospettiva metodologica che era allora
insolita per l’antropologia e del tutto stravagante per
l’orientalismo accademico.
L’opera di Geertz è percorsa dall’esigenza di un continuo
affinamento metodologico ed epistemologico, spesso difficile
da cogliere perché nascosto dietro una scrittura che, come
2
ACHAB
dicevo, si presenta come suadente e ironica, e forse anche un
po’ profetica. Questa scrittura, lieve anche quando si inoltra in
problemi davvero difficili, mi ha sempre rimandato, anche nei
momenti in cui si può dubitare del senso, della giustezza, o
anche solo della semplice opportunità di quello che si sta
facendo, un’impressione di “tranquilla accettazione di ciò che
ci circonda”, almeno quando questi dubbi e queste perplessità
hanno riguardato la mia disposizione verso l’antropologia che,
come appunto Geertz ebbe a dire, “is an excellent way,
interesting, dismaying, useful and amusing, to expend a life”.
Clifford Geertz (1926-2006)
3
ACHAB
Un ricordo di Clifford Geertz
di Roberto Malighetti
Il mio interesse per il lavoro di Clifford Geertz prende le mosse
dalla fine degli anni settanta quando, giovane studente di
antropologia alla McGill University, ho iniziato ad occuparmi dei
fondamenti teorici ed epistemologici dell'antropologia,
insoddisfatto degli approcci positivisti e della sterilità delle
rappresentazioni etnografiche descrittive e oggettivanti. Ricordo
ancora l'entusiasmo con cui nel 1977 scrissi uno dei miei primi
papers, sotto la direzione di John Galaty, sulla descrizione densa.
In esso analizzavo, alla luce delle teorie G. Ryle e di L.
Wittgnestein, il famoso articolo del 1973, Thick Description:
Toward an Interpretive Theory of Culture scritto appositamente
per il volume The Interpretation of Cultures.
L'incontro con l'opera di Geertz contribuì in maniera decisiva ai
miei orientamenti, in un momento in cui, a fronte della crisi dei
paradigmi totalizzanti, si stavano ponendo le basi teoriche di
un'antropologia che andava adeguandosi alle acquisizioni più
recenti dei vari campi del sapere: dalla filosofia post-empiricista
allo studio dei simboli e dei significati, dall'ermeneutica alla
sociologia comprendente, dalla filosofia del linguaggio alla critica
letteraria.
Combinando il lavoro sul campo con sofisticate riflessioni sulla
disciplina e legandosi ai problemi dell'interpretazione del
significato e del simbolismo, l'opera di Geertz mi ha permesso di
ripensare le premesse epistemologiche fondamentali
dell'antropologia e delle scienze sociali in generale. Le sue
raffinate argomentazioni hanno costituito il principale modello
che ha sostenuto le mie attività di ricerca e didattiche, a partire dai
corsi che dal 1980 ho tenuto presso differenti Scuole Regionali a
figure professionali con importanti interessi "applicativi"
(assistenti sociali, educatori professionali, operatori sociali ecc.).
La riscoperta geertziana della tradizione ermeneutica mi
consentiva di analizzare criticamente lo scientismo egemonico in
quegli ambienti "operativi", allora coniugato con interpretazioni
piuttosto rigide e meccanicistice della psicoanalisi. Rammento la
meraviglia e anche la conflittualità provocata dalla messa in
discussione delle ortodossie preminenti che a partire dal
diciassettesimo secolo hanno caratterizzato le concezione
moderna e nomotetica della scienza: il mito di un metodo
scientifico univoco e fisso; la concezione della conoscenza come
rappresentazione e quindi la prospettiva empirista oggettivante; la
rigida separazione fra teoria e "dati" e fra teorie e osservazione; la
ricerca di un linguaggio formale perfetto, ripulito da ogni
riferimento soggettivo; l'ideale mistico della verità.
Tuttavia non si può dire che la comunità antropologica, dominata
dai paradigmi struttural-funzionalistici e marxisti, abbia riservato
una migliore accoglienza al lavoro di Geertz. La sua critica
radicale ha fatto inizialmente molta fatica a trovare interlocutori,
come si può attestare dalla scarsa letteratura su questo autore,
sviluppatasi solo recentemente.
Significativo è il fatto che in Italia il lavoro di Geertz iniziò a
essere pubblicato solamente nel 1987, nonostante gli anni Settanta
e Ottanta si fossero caratterizzati per l'intensa attività di
traduzione di testi antropologici. Conservo ancora la risposta
negativa da parte dell'importante casa editrice di Bologna che
pubblicò il libro 7 anni più tardi, alla mia proposta del 1980 di
tradurre il testo del 1973. Sorprendentemente, la motivazione non
accennava tanto alla scarsa autorevolezza del proponente, quanto
a quella dell'autore. In maniera analoga, quando 10 anno più tardi
cercavo un editore per il mio libro su Geertz, ottenni come replica
dall'unica casa editrice che aveva proposto in Italia nel 1973 un
testo di Geertz (Islam. Analisi socio-culturale dello sviluppo
religioso in Marocco e Indonesia), che l'antropologo statunitense
non solo era un autore invendibile, ma soprattutto scarsamente
rilevante.
In accademia furono scienziati sociali diversi dagli antropologi ad
apprezzare inizialmente la ricchezza e raffinatezza della sua
produzione e l'estensione della sua enciclopedia del sapere,
ponendolo come un'importante figura di riferimento
interdisiciplinare. Del resto la sua stessa formazione e carriera
professionale furono segnate dall'interdisciplinarità: laureato in
Inglese (Ohio, 1945) e in filosofia (1950), ricevette il dottorato dal
Department of Social Relations nel 1956 (Harvard University)
sotto la guida di Talcot Parson e Clyde Klukhohn. La sua attività
di ricerca e di insegnamento si svilupparono in ambienti
fortemente interdisiciplinari, iniziando come ricercatore (195258) al Center for International Studies at the Massachusetts
Institute of Technology, al Harvard University's Laboratory of
Social Relations (1956-57) e come membro del Center for
Advanced Study in the Behavioral Sciences a Stanford (1958-59).
Nel 1958 divenne Assistant Professor di antropologia alla
University of California at Berkeley, dove rimase fino al 1960
quando passò all'University of Chicago come Associate Professor
e Full Professor (1964) per poi approdare nel 1970 all'Institute for
Advanced Studies di Princeton dove divenne Professor Emeritus
alla School of Social Science.
Nonostante si possa rilevare una certa difficoltà a tradurre nella
pratica etnografica (condotta a partire dagli anni Cinquanta a
Java, Bali, Celebes, Sumatra, Indonesia e Morocco) i principi che
discuteva teoricamente in maniera molto sofisticata, Geertz ha
avuto il merito di inaugurare profondi cambiamenti nelle
condizioni della rappresentazione culturale, sia nella natura
dell'esperienza etnografica, sia nella sua restituzione testuale.
Sottolineando il carattere negoziale della situazione etnografica,
fondata sull'interrelazione fra le costruzioni interpretative
dell'antropologo e quelle dei suoi interlocutori, ha permesso di
problematizzare la situazione dello studio sul campo e di
4
ACHAB
analizzare il senso delle condizioni del lavoro, dei microprocessi
della vita quotidiana, della traduzione attraverso i confini culturali
e linguistici, della ricerca di rappresentare in maniera convincente
la diversità culturale dei soggetti investigati.
La principale caratteristica delle revisioni di Clifford Geertz delle
discipline sociali consiste nella riscoperta della dimensione
ermeneutica, in quanto teoria del segno e delle significazioni
equivoche e polisemiche, con la sua enfasi tematica sulla
comprensione e sull'interpretazione e sul carattere costruttivo
della conoscenza. In Geertz il problema ermeneutico assume il
significato di riconoscere, da un lato, che le espressioni e le azioni
umane contengano una componente significativa. Dall'altro
implica che le scienze interpretative siano costituite da modelli
attraverso i quali costruiscono i loro referenti: la scienza è così
ricondotta all'uomo e alla sua capacità di "dare senso" al mondo,
come "fenomenotecnica", tecnica di produzione dei fenomeni,
secondo l'espressione di Bachelard. Di conseguenza gli oggetti
non sono visti come enti dotati di proprietà indipendentemente dal
punto di vista di chi li conosce. Il soggetto, da parte sua, non è
un'istanza paradigmatica, un ente "neutro", bensì un soggetto
storico, inserito in una forma di vita ontologicamente fondato
sulla sua cultura e sul suo sapere. Vi è superamento del concetto
della soggettività e dell'oggettività del comprendere in direzione
del riconoscimento della reciproca appartenenza fra soggetto e
oggetto.
La prospettiva è specificamente ermeneutica. Il discorso è inserito
nel rapporto circolare fra interpretazione e traduzione: fra parti e
tutto, fra familiarità ed estraneità, fra anticipazione di senso e
comprensione, fra soggetto ed oggetto, fra particolare e generale,
fra teoria e osservazione. Comprendere non può dunque
consistere semplicemente nel rappresentare "il punto di vista del
nativo" in una romantica pretesa di uguaglianza o in una difficile
orchestrazione polifonica. I dati antropologici sono complessi e
articolati, "costruzioni di costruzioni", "interpretazioni di
interpretazioni", consistendo in ciò che l'etnografo ha registrato,
di ciò che è stato in grado di comprendere, di quello che gli è stato
detto dai suoi interlocutori a partire da ciò che essi hanno capito.
Non solo il "punto di vista del nativo" è una delle prospettive
possibili. Ma soprattutto esso è sempre mediato. Una volta che i
nativi sono costruiti come informatori, la loro voce è già mediata
e "redatta" dalla comprensione e dalla scrittura antropologica. Ciò
che i nativi dicono non sono verità culturali, semplici
esplicitazioni di concetti presenti nella loro mente, ma risposte
circostanziate alla presenza e alle domande dell'etnografo.
Confinare l'antropologia all'esperienza personale dell'antropologo
o disperdere e ripartire l'autorità etnografica fra i suoi informatori,
significa negare alla disciplina uno specifico statuto scientifico.
Geertz ha insegnato che sebbene i concetti ed i modelli impiegati
dal teorico debbano basarsi sui modi in cui i propri informatori
interpretano le loro azioni e quelle degli altri, essi non possono
esprimere gli stessi significati dell'interpretato. Le interpretazioni
antropologiche, per loro natura, sono diverse dai resoconti dei
nativi, fondando la loro forza su tale eterotopia. L'immersione
analitica nel mondo privato degli interlocutori è scientifica nella
misura in cui riesce a tradurre il linguaggio privato dei nativi nel
linguaggio pubblico e specializzato dell'antropologia.
L'etnografo non può quindi rinunciare alla propria autorità, che da
un lato autorizza i suoi linguaggi e le sue ricerche presso i suoi
interlocutori e presso i suoi fruitori; dall'altro si manifesta
inesorabilmente nella scrittura, fondando la sua "funzione di
autore". In tal senso l'etnocentrismo rappresenta una condizione
ineliminabile e costitutiva del sapere antropologico, costruito
necessariamente a partire "dal punto di vista dell'antropologo".
L'idea che la comprensione passi attraverso la dialettica fra
anticipazione di senso e comprensione e si fondi sull'esame
esplicito dei pregiudizi e delle pre-comprensioni invita a
rappresentare la realtà sociale degli Altri attraverso l'analisi della
propria esperienza nel loro mondo e a considerare la pratica
etnografica, in quanto pratica sociale, come parte integrante
dell'analisi e del lavoro di testualizzazione. L'autoreferenzialità,
racchiusa nella stessa nozione ermeneutica di circolarità e di
storicità della comprensione, sottolinea che la costruzione della
conoscenza antropologica si sviluppa inevitabilmente in chiave
riflessiva e autobiografica: l'accesso all'Altro è sempre mediato
dalla propria ontologia e dalla propria appartenenza a quella
comunità storica e linguistica di cui Geertz è stato uno dei grandi
protagonisti.
5
ACHAB
Autobiografia e immaginazione etnografica
Prime annotazioni1
di Pietro Clemente
pubblicato con gli altri nella rivista L’uomo (n°2) nel 1980, ma
solo nel 1981, con la sua collocazione a premessa nel volume
Intervista a Maria (Palermo, Sellerio) che conteneva anche la
trascrizione della intervista, quella relazione assumeva per me
tutto il suo significato.
Mi ero occupato fino allora di storie di vita soprattutto tornando
indietro all’opera di Scotellaro, ed avevo prodotto e fatto
produrre molti materiali dialogici e narrativi a Siena, nel
quadro di ricerche sulle lotte contadine e la resistenza, e poi in
generale sul lavoro e le condizioni di vita dei mezzadri. Ero
molto attento all’ascolto delle ‘umane dimenticate istorie’.
Eppure quando Clara Gallini parlò (e poi scrisse) di un rapporto
intenso tra informatore e ricercatore (nel suo caso entrambe
donne), che si poteva definire innamoramento, io restai
disorientato e perplesso. Erano tempi di femminismo, e questa
mi pareva un’attenuante. Ma la mia cura delle voci altrui non
prevedeva che esse mi influenzassero sul piano emotivo.
Semmai investivo un senso brechtiano dell’epos, una estetica
proletaria. Nella ricerca la pensavo un po’ da militante (le
passioni non ci concernono) e un po’ da oggettivista alla Nadel,
la macchina uomo che fa ricerca va ben sorvegliata per essere
adeguata, molto self control, prudenza, nell’intervista tanta
attenzione, molta tecnica dell’ascolto e del rilancio.
Riconoscevo allora anche un certo mimetismo del ricercatore,
riascoltandomi nei nastri (poi nelle cassette) notavo che parlavo
con un buffo tentativo di toscanizzare la mia voce.
Ripercorrevo alcuni tracciati di Gianni Bosio2 a modo mio e
avevo scritto un ‘elogio del magnetofono’, mai pubblicato, in
cui trattavo dei problemi tecnici e politici della ricerca con
l’uso di quel mezzo tecnico.
Poi la crisi del marxismo negli anni subito dopo i settanta mi
aveva spinto verso un oggettivismo del mezzo, una filologia
delle fonti, schede, trascrizioni, archivi.
Anche la lettura di Intervista a Maria è una tappa critica della
mia formazione, siamo nel 1981, e Maria è una donna di Tonara
che ricorda tante donne sarde che ho conosciuto, filosofie
popolari di donne che hanno lasciato traccia nella mia vita:
soprattutto Zia Stefana, che aiutava in casa di mia mamma, era
una colf ma aveva una esperienza e una forza che finì per essere
una consigliera di mia madre e favorì il riavvicinamento con
noi giovani ‘sessantotteschi’ in guerra coi genitori, finì per
adottare mia madre come sorella minore e adottò anche noi. Zia
Stefana non nubile come Maria, era la donna che aveva avuto
quattro mariti, aveva tantissimi nipoti e non c’era caso della
vita di cui non sapesse qualcosa. E Zia Colomba, sorella di mio
A Clifford Geertz maestro di immaginazione etnografica:
esiste l’amore in Francia?
La morte di Clifford Geertz , notizia di queste ore, concentra
ora la mia attenzione. Con lui ho discusso dentro di me tutti i
problemi che segnalo in queste pagine, dopo la fine degli anni
’80. Lo ho assunto a mio maestro, litigandoci spesso, ma l’ho
visto per la prima volta nella foto dell’obituary dedicatogli da
Princeton. Maestro virtuale e globale, come però succede dal
tempo della scrittura. L’incipit di Interpretazione di culture con
i dialoghi veri e immaginati di diversi attori sociali su uno
stesso tema visto in modi contrastanti, il forte intreccio tra
antropologia e studi umanistici in generale in Antropologia
interpretativa, la centralità della scrittura e la critica del
‘ventriloquismo’ in Opere e vite, il ruolo della memoria e del
ritorno in Oltre i fatti, la costruzione intellettuale del paesaggio
globale in Mondo globale e mondi locali lo hanno fatto
diventare per me un compagno di strada, uno zio materno
ineludibile. Il modo con cui leggeva le fonti europee della mia
stessa formazione mi ha aiutato a ritrovarle oltre la fine delle
grandi narrazioni.
Forse quel che scrivo qui appresso ha anche a che fare con
l’esergo che egli dedicò in un capitolo bellissimo di Opere e
vite a Emawaysh, la donna etiope incontrata da Leiris, che,
scelta a testimone di canti d’amore, volle a sua volta interrogare
e chiese “Esiste l’amore in Francia?” Una domanda sulla quale
molte volte mi sono interrogato, e che contiene l’ambiguità e la
speranza dell’antropologia post-classica.
Innamorarsi?
Non ho un ricordo ben situato nel tempo, mi sembra molto
lontano e tra i primi convegni importanti, dell’incontro dal
titolo “La ricerca sul terreno” che si tenne a Roma; i riferimenti
dicono che era il 14-15 dicembre del 1979. Ho ricordi vivaci
dell’ironia un po’ da scolaresca con cui i più giovani
commentavano la comparsa in scena di vari relatori, figure fino
allora solo sentite nominare con reverenza. Era un convegno
internazionale. Vinigi Grottanelli elegante e plurilingue, mi
rimase in mente perché nel suo francese abbondava
l’intercalare n’est pas. Ma sul piano conoscitivo ricordo che fui
critico, e così altri, verso un intervento di Clara Gallini, che si
impose in quel contesto per la sua particolarità, che era dedicato
a una donna di Tonara, da lei intervistata come testimone e
protagonista di una immagine del mondo femminile tra
tradizione e trasformazione, per una trasmissione radiofonica
della terza rete radiofonica RAI. Il testo di Clara Gallini fu
6
ACHAB
padre, nubile quasi programmata, che ha allevato o aiutato tre
generazioni di nipoti. Il tema del comparatico di fiori e le
variazioni dell’amicizia, della stima (parola d’eccellenza in
Sardegna) e dell’amore mi colpirono molto nell’intervista a
Maria. Era un altro tempo, e pochi anni dopo avrei criticato
quel libro perché l’autore in copertina risultava essere Clara e
non Maria, o meglio non era ‘a coautore’ come poi imparammo
da Maurizio Catani (M. Catani, S. Mazè, Tante Suzanne. Une
histoire de vie sociale Paris, Librairie des Meridiens, 1982) e
usammo per Io so nata a Santa Lucia storia di Dina Mugnaini
dialogata con Valeria Di Piazza, monumento della mia ricerca
senese (1988 ma la ricerca è dei primi anni ’80, la tesi di laurea
da cui nasce del 1984). Quando uscì il libro la mia prospettiva
stava cambiando, e di lì a poco sarebbe cambiata più
marcatamente.
Spirito documentario, senso del rispetto della fonte, desiderio
di autonomizzare il soggetto narrante mi impedivano di
vedermi nella relazione a pieno.
generalizzare ciò che però scrissi: “si sottrae alla funzione
archivistica”. Forse pensavo che non tutti lo potevano, e vedevo
questo come un caso, non la regola.
Ma nello stesso stage usavo scherzosamente l’espressione che
in qualche modo torna nelle mie note di diario, “innamorarsi”,
pensando a una informatrice anziana e gentile che mi aveva
adottato come suo ricercatore prediletto, e della quale raccolsi
una storia di vita, mai edita, oltre che un elenco di diversi tipi
di patate da sconcertare chi credeva che le patate fossero le
stesse ovunque e di un sol tipo.
Per molte ragioni dunque lo stage della Val Germanasca, i cui
principali documenti furono pubblicati nel 1994 (Gens du Val
Germanasca. Contributions à l’ethnologie d’une vallée
vaudoise, Granoble, Centre Alpin et Rhodanien d’ethnologie),
conteneva la rielaborazione di uno statuto oggettivistico,
benché compartecipativo sul piano ideologico, della ricerca.
Ma mancavano ancora molti elementi per riconoscere le tracce
dell’operare lento e silenzioso del testo di Clara Gallini che
avevo respinto concettualmente ma continuavo a elaborare.
Credo che in tutti gli anni ’80 il mio lavoro abbia vissuto una
dialettica di avvicinamento-allontanamento dell’oggetto di
studio, in cui ci sono improvvise presenze soggettive che però
non affrontano ancora il problema dell’influenza umana
dell’incontro etnografico, ma un’altra difficile frontiera, quella
del ‘me’ come oggetto antropologico, e dell’io come narratore
accreditato a parlare anche di sé. Le tracce fondative di questi
due aspetti della mia tensione epistemologica per lo più vissuta
e non pensata separatamente, sono L’oliva del tempo.
Frammenti di idee sulle fonti orali, sul passato e sul ricordo
nella ricerca storica e demologia (in Uomo e cultura, 33/6,
1986) e Autobiografie al magnetofono. Una introduzione, in V.
Di Piazza, D. Mugnaini, Io so nata a Santa Lucia,
Castelfiorentino, Società Storica Valdelsana, 1986. Nel primo
saggio riemerge un nesso ‘politico’ tra storie orali e pluralità
delle vite, dei racconti, delle verità e si fa strada attraverso i
versi di Apollinaire sulla memoria, versi fortemente legati alle
letture dei 20 anni, prima dell’antropologia. Nel secondo,
legato a un importante lavoro di memoria, un’opera vera e
propria, un lavoro dialogico durato tre anni, riconosco il debito
di conoscenza, di immaginazione antropologica, di accesso ai
vissuti interni di una forma di vita verso questa grande
informatrice che ha fatto dell’incontro con l’antropologia
l’occasione per lasciare traccia del suo passaggio di contadina,
comprendendo che si trattava di un ‘lavoro’ di memoria per
altri, per dopo, per noi.
Ecce homo
Ma nella ricerca era già avvenuto qualcosa che per anni ho
trascurato ed è invece segnato nel mio diario di campo del
primo stage di ricerca-didattica fatto in collaborazione tra
Università di Siena e Università di Aix en Provence, in Val
Germanasca:
“5/5/1981
Ecce homo
P.A.
Via XY n.46, Pomaretto (Val Germanasca, Torino)
Il messaggio di una vita. La madre la moglie due figlie. Una
coscienza conquistata al di là dell’utile e dell’individuale. La
classe operaia come universale kantiano, la sua inattualità come
malattia.
Nati non fummo a viver come bruti.
La coscienza come un fiore impagabile di cui non ci si può
pentire. Un fiore di pirite in una massa di talco.
Il registratore messo da parte. L’informazione cede il campo
alla comunicazione interpersonale. L’altro si impone come
soggetto e si sottrae alla funzione ‘archivistica’”
In questo brano di diario, che pubblicai ne Il terzo principio
della museografia (Roma, Carocci, 1999, pp. 154, 155) perché
la pepita di pirite che il sindacalista e sindaco valdese mi aveva
regalato era stata per me un ‘oggetto d’affezione straordinario
(e i miei oggetti d’affezione come gioco didattico sulle cose
nascono da Man Ray e da Ettore Guatelli), c’è una intuizione
della consapevolezza che, saggisticamente, raggiunsi molti
anni dopo in tutte le implicazioni. Allora c’erano ancora delle
condizioni speciali: il mio interlocutore era un sindacalista di
miniera, di sinistra, era stato del PSIUP, era stato in ospedale
psichiatrico e nel colloquio era generoso e trasparente, era un
incontro tra ‘uomini’, aspetti legati tutti all’immaginario di
sinistra anni 60-70, che forse non mi consentirono allora di
Un racconto e un sogno
Negli stessi anni girammo un film inedito in cui Dina
raccontava la morte del suo primo figlio e il suo sogno
ricorrente in cui incontrava il bimbo morto al camposanto e su
sua richiesta lo rapiva e lo riportava a casa correndo in mezzo
ai campi. Questo racconto, che Dina ha ripetuto con poche
variazioni almeno quattro volte in modo documentato, è anche
il luogo di un dolore insopportabile, un racconto che suo marito
7
ACHAB
non tollerava rendesse a noi, esterni, pubblici, cui egli aveva
raccontato solo del suo ruolo nelle lotte sindacali, io l’ho
portato con me in anni di didattica, e anche in un seminario, in
un convegno, l’ho usato come laboratorio di trascrizione, l’ho
analizzato in una lezione universitaria videoregistrata (in cui ho
i capelli neri e fumo) come ‘testo contestualmente
straordinario. Non ho mai detto che tutte le volte che lo rivedo
piango dentro di me e qualche volta anche fuori approfittando
del buio. E’ un racconto così forte e bello che non sono mai
riuscito a scriverci nulla forse per non dissacrarlo. Qualche
volta ho sentito la scrittura analitica come a rischio di
violazione del sacro.
Credo che il 1990 sia la data in cui ho trovato in un saggio di
Peter Winch la metafora conoscitiva adeguata al mio vissuto,
Comprendere una società primitiva (in F. Dei, A. Simonicca
eds Ragione e forme di vita, Milano, Angeli, 1990). Questo
saggio è ancora adesso per me un luogo eticamente e
epistemologicamente esplosivo, difficile da maneggiare, ci
sono vari passaggi che mi hanno riavvicinato al rilievo
dell’esperienza religiosa e mi hanno consentito di innamorarmi
del libro di Bateson, Dove gli angeli esitano. Non sono solo le
persone che fanno innamorare, anche i libri, forse i quadri, le
poesie, i paesaggi. Non avevo mai pensato all’esperienza
conoscitiva come a un essere cambiati dall’incontro, pensavo
sempre alla conoscenza con metafore di gestione, controllo,
guida, ero stato molto influenzato dal libro Crisi della ragione
(Torino, Einaudi) del 1980 e in specie dai saggi di A. Gargani e
di C. Ginzburg, ma è con Winch che scoprivo una tradizione
ermeneutica e dialogica che pure stava dentro ai miei maestri,
ma forse girata in una direzione che me la rendeva invisibile.
Attraverso questo passaggio gli anni ’90 aprono per me a una
larghissima condivisione, italiana e creativa, verso le linee
connettibili tra antropologia interpretativa e postmoderna
americana. Nei saggi di questi anni c’è proprio un cambiamento
del senso dell’essere studiosi, con metafore teatrali e
informatiche che tendono a mostrare l’antropologo come
regista di molteplici voci, gestore di links su una rete, un
mestiere fatto di percorsi e connessioni come nelle Strade di
Clifford e nel suo surrealismo etnografico.
Ma in un testo inedito e per me paradigmatico del 1991
L’autore moltiplicato. Testi biografici e antropologia
interpretativa in Persone e fonti Dispensa, Uniroma 1, corso
1996/97 si vede che diversamente da James Clifford io faccio
sempre i conti con i miei interlocutori e qui in particolare con
un carbonaio e una contadino della provincia di Arezzo che
hanno scritto la loro storia di vita, e con i materiali
dell’Archivio Nazionale Diaristico di Pieve Santo Stefano che
dai primi anni ’90 entrano sistematicamente nella mia
esperienza di studioso. Non solo l’incontro etnografico, non
solo i libri teorici, ma la lettura delle storie di vita sono
diventate per me luogo di scoperte, rivelazioni, incontri
indimenticabili.
Spettacolo meraviglioso
Ma non sono riuscito nel tempo a costruire una teoria di questi
incontri, forse ci voleva una forza riflessiva maggiore, forse
una distanza ulteriore. Ho scritto testi in cui ho messo pezzi di
cuore, mi sono imposto penitenze, ho riconosciuto debiti, ho
raccontato parenti acquisiti e non, fino a scaricare su una
raccolta di racconti autobiografici un pezzo di memorie urgenti,
quelle legate al ‘68 e alla politica, dove urgeva anche per
contrasto, ricordare il padre (Triglie di scoglio, Cagliari,
CUEC, 2002). I morti sono entrati nella mia scrittura, e tra loro
il mio omaggio sempiterno va, oltre che ai miei più vicini (tra i
quali metto anche Ettore Guatelli, inventore di un museovisione) a Primo Levi e Bruno Bettelheim, maestri dolorosi di
‘900.
Il mio disseppellire diari, anche familiari, è entrato nel discorso
tra colleghi, almeno a Siena, dove un anno ho fatto fare
laboratorio con il Diario di Zio Paulesu, marito della sorella di
mia nonna paterna, che nel settembre del 1942 documentò
l’arrivo a Meana Sardo del suo bisnipote Pietro da Nuoro, via
treno e carro a buoi. Zio Paulesu è diventato una specie di
informatore indigeno mitico, come Ogotemmeli. Per scherzo,
ma anche per sottolineare le distanze di tutto ciò
dall’antropologia classica, che è ancora ben radicata nei nostri
studi e dalla quale vengo sentito distante.
Non so come funziona la coscienza, certo è parecchio in ritardo
rispetto ad altri livelli del vivere, nella mia bibliografia non
capisco molto il senso del prima e del dopo, ci sono anche i
tempi di edizione, ma i pensieri è come se andassero come
granchi, o a zig zag. Così solo quando Saverio Tutino mi ha
chiesto di collaborare alla rivista dell’Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano, “Primapersona”, che hanno
cominciato a venir fuori alcuni riconoscimenti di ciò che avevo
imparato e potevo anche comunicare sul piano del metodo. Tra
il 1998 e il 2000 ultimi anni romani, si collocano i testi più
consapevoli della mia esperienza di antropologo che continua a
imparare dagli altri. Nel 1979 un testimone contadino ci aveva
detto: il contadino è un mestiere che non si smette mai
d’imparare, è da un po’ che ho capito che in questo gli
antropologi sono come i contadini. In questi anni la mia
bibliografia segna percorsi interrotti e squinternati, gioca come
sempre su troppi fronti, ritrova la poesia come compagna di
antropologie, ma è curioso che in tre testi brevissimi, chiestimi
tali per un pubblico ampio da Tutino, compaiano le riflessioni
più nitide di una idea condenda del radicale nesso
interconoscitivo che ci lega ai mondi nostri e altrui quando li
traversiamo sotto la specie del cercare con implicazioni etiche
anch’esse forti e non sempre – a me stesso – esplicite.
“Le storie di vita portano all’antropologo lo spettacolo
meraviglioso – per le scienze sociali – di un mondo ‘altro’ visto
dall’interno”3.
Approfondivo l’idea centrale per l’antropologo dello studio
delle autobiografie, quella del rapporto tra regole e tratti
comuni della società e variazioni individuali, e quindi tra
determinismo socio-culturale e libertà, scrivevo che è lo scarto
8
ACHAB
dell’individuo che vive e interpreta originalmente le regole
collettive, a far sentire nelle biografie una idea di ‘libertà
individuale’.
“E’ questa libertà che produce in noi che leggiamo lo spettacolo
meraviglioso e spesso imprevisto, di una vita raccontata da
dentro una cultura, di una cultura raccontata da dentro una
vita”4.
Riflettendo sul tema della ‘libertà’ nelle condizioni
sociologiche e culturali date, seguivo un’altra importante
influenza e in specie un passo di De Martino in Naturalismo e
storicismo nell’etnologia che mi è a lungo risuonato dentro, e
riguarda il valore dell’azione individuale, difesa sia contro
Durkheim che contro Croce. Un passo fecondo, per me, nel
senso rurale del termine, produttore di fioriture.
Come in una metafora ‘agraria’ del Macbeth, che usai a
epigrafe di un mio testo critico verso Frazer (in I frutti del
Ramo d’oro. James Frazer e l’eredità dell’antropologia in La
ricerca folclorica, 10, 1984):
“Il Re a Macbeth – Benvenuto sul mio petto/Ho cominciato a
piantarti e mi sforzerò/di farti crescere rigoglioso;
Il Re a Banquo – Nobile Banquo/tu non hai meritato di meno,
né deve essere meno noto/che lo hai fatto: lascia che ti
abbracci/e ti stringa al cuore
Banquo – e se qui crescerò/il raccolto sarà vostro”
L’espressione che uso parlando di ‘spettacolo meraviglioso’
non vuol essere esagerata o enfatica, ma dare l’idea della
bellezza della conoscenza antropologica, del senso di scoperta
che spesso si vive, di come leggendo una storia che traversa
dall’interno della propria vita un mondo, questo mondo si apra,
si riveli senza semplificazioni, con complessità e forza
immaginativa comparabili con quelle della letteratura e del
museo.
emozione incontenibile che ebbi nel concepirlo e nello
scriverlo. E’ come se dovessi incorporare la varietà della vita e
dell’antropologia nelle parole, ‘iscriverle’, come ha scritto
Geertz, e la scrittura fosse luogo di obblighi di memoria, lapidi,
monumenti, figuralità collettive, foto di gruppo con autoscatto.
In meravigliosa compagnia di vivi e di morti, come in una
poesia di Apollinaire, quelli che mi hanno cambiato sono
sempre dentro di me, e io cerco di controllare la loro presenza
per evitare quel ‘me variopinto’ che attrasse la riflessione di De
Martino su Kant.
Ho cercato di descrivere il processo di passaggio antropologico
dalla storia dell’altro alla propria, ad esempio, in un testo legato
alla storia del dopoguerra, ho proposto la mia vicenda familiare
come una modalità di un ibridismo del ceto medio meridionale,
basato sul principio ‘moglie e buoi dei paesi altrui’, così come
ho iscritto la mia infanzia nella storia delle radici paesane
scritta da tanti, da Pavese a Guccini. In una pagina didattica ho
così rappresentato il processo:
“Entrando in un oggetto culturale che diventa soggetto,
l’antropologo produce su di sé un movimento inverso, è spinto
a confrontarsi, a riflettere su di sé e quindi a trasformare se
stesso da un soggetto in un oggetto vedendosi come essere
culturale al pari di quello sul quale indaga… Questo effetto è
fortissimo nelle storie di vita giacché queste, mettendo in scena
padri e madri, genealogie, scelte migratorie, competenze, ci
spingono a confrontarci e a cogliere noi stessi come
caratterizzati da una scena che ci contiene in cui ci sono padri
e madri...”6
Forse anche questa descrizione contiene una difesa dal ‘me
variopinto’ alla Kant, restituisce posti nello spazio, anche se in
un processo tra i partners della ricerca. In quanto tale contiene
un principio di documentarismo, forse apotropaico, ma non
lontano da quello che trovai nello Starobinskj di Il testo e
l’interprete (in J. Le Goff, P. Nora, Fare storia, Torino,
Einaudi, 1981). Il mio filologismo non è mai morto, nonostante
alcuni a fondo critici di Vincenzo Padiglione, quando pensava
che dovessi essere più coerente con me stesso. Tra filologia ed
ermeneutica c’è una buona connessione. Essa è ormai una
specie di terrazzamento come nei terreni scoscesi della
montagna per evitare la frana a valle, mi serve molto, crea
riscontri intersoggettivi, comuni itinerari, favorisce che, quella
che ho descritto, sia una modalità della etnografia e della
comparazione antropologica, e non solo un turbamento della
coscienza ‘turbata’.
La nostra infanzia
La sorpresa e lo stupore nell’incontro con le storie mi sono
evidenti, malgrado l’abitudine a leggere storie di vita con
scritture poco esperte, e spesso con asprezze o storie non prive
di somiglianze, le vite raccontate non mi consentono in genere
di essere lasciate a metà, ogni lettura è un viaggio di più iscritto
nella mia vita, più che nella mia labile memoria. Come se il
posto di ogni vita fosse nelle vite di altri, o almeno nella mia
(“e se qui crescerò il raccolto sarà vostro”).
La postura del ricordante. Memorie, generazioni, storie della
vita e un antropologo che si racconta ( in L’ospite ingrato ,II,
1999), il saggio dove tento un bilancio di queste tensioni, è
stata considerato un testo eccessivo, un po’ fuori dei confini
dell’antropologia, una sorta di patchwork in cui si entra e si
esce dalla propria vita dialogando con Fortini, Pirandello, la
gente delle esperienze di ricerca, i propri familiari in una sorta
di girotondo felliniano sghembo, privo di simmetria.
Vite esposte5 è un testo che insieme a Philippe Lejeune, Ernesto
De Martino, i condannati a morte della Resistenza, nel finale
convoca e rievoca mio fratello morto, la nostra infanzia, la mia
prima scrittura documentata, e rileggerlo mi da la stessa
La felicità della verità
Incontri e descrizioni, scritture e osservazioni interagiscono
costantemente con pensieri, idee, poetiche. Ne sollecitano di
nuove e al tempo stesso le nuove aprono altre visibilità nelle
etnografie.
E’ curioso che, avendo cominciato con una critica
all’innamorarsi dell’informatore senza accorgermi della
contraddizione, mi sia trovato a citare nel mio primo scritto di
analisi dell’autobiografia orale dedicato a Dina Mugnaini
9
ACHAB
(morta alcuni anni fa, ricordata in Lares) un passo di Adorno,
tratto da Minima moralia dedicato al tema dell’amore e della
violenza:
“lo sguardo lungo e contemplativo, a cui solo si dischiudono gli
uomini e le cose, è sempre quello in cui l’impulso verso
l’oggetto è spezzato, riflesso. La contemplazione senza
violenza, da cui viene tutta la felicità della verità, impone
all’osservatore di non incorporarsi l’oggetto: prossimità nella
distanza”7.
Di questo tipo di testi fa parte ancora un saggio-lettera di J. F.
Lyotard da Il postmoderno spiegato ai bambini (Milano,
Feltrinelli, 1987) che si intitola Glossa sulla resistenza.
Un testo che connette la scrittura, il corpo e l’amore in una idea
di resistenza alla semplificazione del mondo e della vita in una
dimensione da Grande fratello (il testo è dedicato a Orwell),
qui ho incontrato una interpretazione di Benjamin (Infanzie
berlinesi) sull’evento, lo stupore, l’infanzia che ho usato molto
sia in museografia che in autobiografia. E la nozione di
‘cicatrici’ anch’essa tratta da Benjamin, una nozione strana ma
interessante, per cui l’individuo nella sua diversità si forma
delle cicatrici nella sensibilità, e queste lo aiutano a essere
diverso, si riaprono nel tempo come sensori aperti all’evento.
Per finire questa prima puntata di una archeologia della mia
immaginazione etnografica potrei dire che L’intervista a Maria
e in particolare la nozione di ‘innamoramento
dell’informatrice/tore’ avevano funzionato per me, in un codice
mio, un po’ rigido e non sempre autoconsapevole come apertura
di una cicatrice nella sensibilità. Cicatrice che più volte si è
riaperta.
Anche le etnografie altrui, e le letture filosofiche, gli
arricchimenti della immaginazione antropologica del
ricercatore, insieme alla sua vita, la sua età, si fanno scrittura
etnografica, scrittura e descrizione densa.
(fine della prima puntata)
Note
1. Questo testo è stato scritto per l’incontro di Bassano 2006,
promosso da Clara Gallini e dal centro Studi Ernesto De Martino.
Ringrazio Clara Gallini di avermi consentito di usarlo per Achab, e la
redazione di Achab di averlo considerato degno di attenzione. Lo
considero una prima puntata anche se non ho ancora scritto la seconda
e non so quante saranno in tutto. Nell’inviarlo alla redazione ho sentito
il bisogno di aggiornarlo con una breve dedica a caldo a Clifford
Geertz, morto poche ore fa.
2. G. Bosio, Elogio del magnetofono. Chiarimento alla descrizione dei
materiali su nastro del fondo Ida Pellegrini, sta in G. Bosio,
L’intellettuale rovesciato, a cura di Cesare Bermani. Sulla mia
convinzione che Bosio sia un riferimento vivo per la tradizione
dell’antropologia italiana vedi P. Clemente, Temps, mémoire et récits.
Antropologie et histoire in Ethnologie française, XXV, 3, 1994.
3. Facendo didattica in Primapersona I, 1, 1998.
4. Gli antropologi e i racconti della vita in Pedagogika, III, 11, 1999.
5. in Q. Antonelli, A. Iuso ( a cura) Vite di carta, Napoli, L’Ancora,
2001.
6. Facendo didattica in Primapersona I, 1, 1998.
7. Per l’edizione critica di testi biografici orali in Fonti orali. Studi e
ricerche, IV, 1, 1984 una data non tanto lontana da quella di
pubblicazione del testo di Clara Gallini.
10
ACHAB
Un contributo al dibattito sulle politiche attinenti alle
manifestazioni culturali nello stato brasiliano di Maranhão*
di Arinaldo Martins1
Le politiche culturali avviate dai governi dello Stato del
Maranhão2, in particolare quelle relative al bumba-meu-boi3,
sono state l'argomento dei miei primi interessi accademici. Il
bumba-meu-boi è stato oggetto di uno studio da me realizzato
durante circa tre anni di ricerca sul campo nella città di São
Luís, capitale del Maranhão, e in parte minore nell'interno dello
Stato4.
Verso la fine del mio lavoro, ha preso forma una certa visione
di ciò che ho chiamato campo del bumba-meu-boi, usando qui
la nozione di campo cognata dal sociologo francese Pierre
Bourdieu5. L’analisi di una manifestazione culturale di questo
genere non può prescindere dal campo di relazioni sociali di cui
essa è al medesimo tempo agente determinato e determinante.
Per pensare questo particolare universo della vita sociale, il
campo delle manifestazioni culturali, è necessario tenere in
mente che vi è una specifica configurazione di relazioni
pubbliche nella quale gli attori sociali6 orientano le proprie
azioni secondo un insieme soggettivamente percepito di
interessi. Nel parlare di ciò, mi baso soprattutto sulle idee del
sociologo Max Weber, secondo il quale le relazioni umane sono
relazioni dotate di significato.
Quale interesse hanno queste relazioni? In primo luogo, voglio
chiarire che nel bumba-meu-boi - oggetto approfondito nel mio
lavoro, le cui caratteristiche illuminano però anche altre
manifestazioni e, chiaramente, la politica culturale
maranhence, nella misura in cui ha preso il bumba-meu-boi
come suo bersaglio privilegiato -, si può percepire una chiara
interrelazione tra, per lo meno, tre campi specifici della vita
sociale del Maranhão: il culturale (che comprende anche altre
manifestazioni folcloriche, come il tambor de crioula7 ecc., ma
che, per motivi di spazio, ho preferito ridurre ai gruppi del
bumba-meu-boi), il burocratico-politico8 (dove sono inclusi i
funzionari statali) e il campo degli intellettuali9 (i produttori di
ideologie e forme di comprensione delle culture popolari).
L'interrelazione tra questi campi fa si che il bumba-meu-boi sia
un prodotto ibrido, fabbricato tanto dai brincanti, quanto dagli
agenti dello stato e dagli intellettuali. La produzione del
bumba-meu-boi si inscrive al livello discorsivo. Vi è un
discorso egemonico che dice quali siano le manifestazioni che
devono essere "incentivate" (le virgolette sono qui opportune,
poiché ciò che si fa non può essere considerato un vero
incentivo), quali le caratteristiche di tali manifestazioni, e
quali, addirittura, siano quelle degne di esistere. Vorrei che
fosse esplicito, infine, che ciò che si intende con l'espressione
bumba-meu-boi del Maranhão é un artefatto, qualcosa creato
arbitrariamente, imposto sulla realtà, e frutto della negazione di
certi aspetti della cultura popolare e dell'enfatizzazione di altri.
La pratica di concedere incentivi finanziari ai gruppi del
bumba-meu-boi si è sviluppato come pratica sistematica delle
politiche statali all'inizio degli anni '60. È in questi anni che un
organo specifico del Governo dello Stato, il FURINTUR
(Fundo de Incentivo ao Turismo e ao Artesanato do Maranhão),
in seguito chiamato MARATUR (Empresa Maranhense de
Turismo), sotto il controllo dell'orientamento nazionale del
governo autoritario post-6410, si rivolge a ciò che all'epoca
erano chiamati "folguedos folclóricos"11, nel tentativo di usarli
come espressione della identità brasiliana e maranhense12, con
il fine ultimo di promuovere il turismo. A partire da questo
momento possiamo vedere come una serie di politiche siano
state implementate per attrarre i turisti ad assistere alle
presentazioni del bumba-meu-boi, del tambor de crioula, ecc.,
considerate legittime manifestazioni di una supposta identità
maranhense.
Il Parco Folclorico di Villa Palmeira, conosciuto nella decade
del 1970 come Parco del Maratur, è stato costruito e
amministrato da questo ente statale al fine di promuovere i
gruppi, e incentivare l'affluenza di pubblico locale e di turisti.
Rimase punto di riferimento per queste rappresentazioni fino al
1982, quando, a causa di alcuni problemi, la massa del
pubblico, vale a dire i maranhensi stessi, smisero di andarci
cominciando a frequentare gli arraiais13.
È importante evidenziare che solo in seguito all'inaugurazione
dell'uso di tali manifestazioni con obiettivi principalmente
turistici (il fatto stesso che l'amministrazione di tutte le feste sia
stata realizzata dal MARATUR attesta di ciò), il bumba-meuboi, il quale in precedenza non aveva per la popolazione un
significato equivalente a quello esistente dopo tale periodo, ha
attraversato un processo culminato nello sviluppo del fenomeno
che oggi conosciamo. È in questi anni che cominciano ad
emergere i gruppi più significativi, alcuni registrano i primi LP,
sono messi in scena spettacoli teatrali sulla commedia del boi14,
nascono i primi gruppi d'orchestra15 e la necessità di registrare
le varie associazioni, i primi programmi radiofonici e televisivi
iniziano a trattare i temi del folclore.
Pertanto, ciò che si è sviluppato, nel ventre di tutto ciò, è una
concezione utilitaristica della manifestazione che perdura fino
ad oggi. Non è stato considerato importante il sentimento dei
gruppi in relazione alla sua espressione, né una politica della
cultura che privilegiasse la valorizzazione della loro
singolarità, così da evitare che nello sviluppo accelerato di
11
ACHAB
questa nuova configurazione, i meno preparati a tale processo contraddizione rivela il contesto utilitario in cui s'incontrano i
soccombessero o perdessero molti aspetti del proprio gruppi, contesto nel quale, per poter continuare ad esistere,
patrimonio immateriale (nel dire ciò non mi riferisco a nessuna hanno la necessità di rispondere ai bisogni del proprio pubblico
nozione di tradizione). In questa discussione, vorrei portare e dei propri acquirenti. Nonostante il discorso sia quello di
come esempio la vicenda del Boi di Madre Deus16, vicenda che promozione delle manifestazioni, le istituzioni pubbliche
ritengo particolarmente efficace nel mostrare ciò che è esercitano, in realtà, una forma di controllo. I gruppi
avvenuto. Chi conosce la traiettoria del Boi di Madre Deus sa s'inquadrano in un gioco dove, per ricevere vantaggi, hanno la
che, fino alla decade degli anni '80, questo gruppo esercitò necessità di sottomettersi a norme create esternamente.
un'influenza molto grande, comparabile, rispettando le debite Un'altra faccia dell'interrelazione tra questi ambiti si dà a
proporzioni e l'evoluzione tecnologica avvenuta, a ciò che è partire dal ruolo occupato dal campo degli intellettuali.
percepito oggi in relazione al Boi di Maioba. Fu il primo Boi a Quest'ultimo è stato il responsabile dell'effetto più perverso e
registrare un LP; era il più richiesto e il più recensito dai più distruttivo delle pratiche culturali nel Maranhão. Grazie ad
notiziari, possedeva una relazione con il potere statale. Ma, una serie di autori, i quali hanno riprodotto, uno dopo l'altro, la
come per magia, a partire dal 1981 cominciò a presentare stessa ideologia, centinaia di gruppi dell'interno dello Stato
segnali di decadenza. Questo fatto è documentato nei giornali sono stati relegati all'inesistenza. Ciò è dovuto al fatto che nel
della capitale. Ciò che sembra più interessante è che le Maranhão le associazioni folcloriche, per essere considerate
gruppi del bumba-meu-boi,
cronache
dell'anno
devono essere incluse in una
immediatamente precedente lo
classificazione che è stata
mostravano come il gruppo più
prodotta, fin dalla decade del
espressivo di ciò che era intesa
1960, da autori che, aspirando
"la
manifestazione
per
a conferire legittimità alla
eccellenza
della
cultura
categoria degli intellettuali,
popolare del Maranhão". Come
registravano
come
possiamo pensare questa
caratteristiche originali della
mutazione
improvvisa?
manifestazione solo i caratteri
Indubbiamente, come il frutto
delle associazioni che si
di una politica che si è servita
presentavano nella regione di
delle manifestazioni culturali
São Luís, generalizzandoli
con l'unico scopo di realizzare i
all'interno dello Stato.
suoi obiettivi immediati, vale a
Prendendo la mappa del
dire la promozione del turismo.
Maranhão, i gruppi inquadrati
Non importa cosa può
Boi di Zabumba in un Arraial di São Luís
nei così detti sotaques18 sono
succedere ad alcuni di questi
(Foto di José A Gálvez - http://www.pbase.com/capercaillie/bumba)
presenti nella zona che
gruppi.
I
rimanenti
comprende l'isola di São Luís e la fascia che immediatamente
garantiscono il mantenimento della festa.
L'unica cosa che sono in grado di affermare sia mutata, dagli la circonda. Secondo questa ideologia è come se il sud del
anni '60 ad oggi, è l'inclusione nella lista degli interessi di Maranhão non avesse prodotto alcun tipo di bumba-meu-boi.
coloro che dicono promuovere le manifestazioni culturali, di La cosa più indisponente è che la transumanza del bestiame,
una forma di marketing politico. Da alcuni anni a questa parte, che si dice abbia dato origine alla manifestazione, si è affermata
l'essere legati a manifestazioni culturali è inteso come una a partire dal sud dello Stato. Siamo qui in presenza di un
moneta da spendere nella conquista di voti o di uno status discorso contraddittorio, ma tuttavia efficace.
politico. Uno dei pilastri della popolarità della ex-Governatrice Il discorso che ha attribuito queste caratteristiche al bumbadel Maranhão Roseana Sarney, consiste nella sua connessione meu-boi del Maranhão, riduce la manifestazione ad aspetti che
con la così chiamata cultura popolare17. Un altro aspetto da costituiscono appena una piccola parte della sua ricchezza
considerare è la modalità con cui sono stati concessi gli culturale. Nell'interno dello Stato, il bumba-boi è presente per
incentivi, offerti per via di pagamenti in danaro, incentivi che l'intero anno nella vita delle persone, nei discorsi, nei ritrovi dei
trasformano lo stato in un acquirente, quando invece dovrebbe bar, nelle feste (solo per fare un esempio, esiste una festa,
essere un facilitatore. Ciò ha creato una concorrenza nociva tra messa in scena nel mese di Ottobre a Bacurituba, che raduna
i gruppi. Gli effetti di tale rapporto si fanno sentire in molte centinaio di gruppi del bumba-meu-boi; vi sono gruppi
associazioni che sono, per certi aspetti, marginalizzate.
dell'interno che si presentano al pubblico a Natale, e vi è indizio
Per sfuggire all’isolamento, i gruppi del bumba-meu-boi hanno di altri che fanno lo stesso durante il carnevale). La varietà del
adottato varie strategie. Tra di esse vi è la produzione di bumba-meu-boi è maggiore di quella delle associazioni che si
discorsi sui valori di una supposta tradizione, combinati con presentano in São Luís.
pratiche che valorizzano elementi moderni. Questa Pertanto, a causa di un discorso egemonico che consacra
12
ACHAB
determinate caratteristiche, qualsiasi tentativo dei gruppi che vi
differiscono di affermare la propria esistenza è inteso come
innovazione. Questa prospettiva interpretativa è stata messa in
pratica con i buma-meu-boi di baixada e costa de mão durante
la decade degli anni '70, quando apparvero per la prima volta
nella capitale. Vi sono testimonianze giornalistiche di un
intellettuale, all'epoca funzionario di stato, che dichiarò
esplicitamente questi gruppi essere "innovazioni".
La questione che vorrei proporre, affinché tali problematiche
possano essere pensate, è la seguente: cosa si può fare per
impedire che le politiche del turismo mascherate con le fattezze
delle politiche culturali aggrediscano ancora di più
distruttivamente il patrimonio immateriale delle manifestazioni
culturali, patrimonio che è del popolo, e che è necessario
preservare? Come possiamo modificare il clima di
competizione creato a partire dagli anni '60 in São Luís di
Maranhão, clima che ha obbligato le associazioni del bumbameu-boi a trasformare radicalmente i propri modi di
presentarsi, collocando certi gruppi in posizione inferiore
rispetto ad altri? Che politiche è possibile attivare nel tentativo
di apprezzare e riconoscere il valore dei gruppi dell'interno
dello Stato non ancora totalmente contaminati dall'azione
predatoria delle politiche implementate dai governi attuali?
Forse sarebbe necessario che il Governo Federale creasse
un'opportuna legislazione che proibisca le pratiche abusive
degli Stati Federali, cercando di garantire la proprietà
intellettuale dei gruppi e una più democratica distribuzione
delle risorse. Lo Stato Autoritario del Brasile, già da alcuni
decenni, ha ceduto lo spazio ad una democratizzazione delle
politiche federali. In molti aspetti, il Maranhão sembra però, a
volte, vivere ancora sotto il precedente regime militare.
collocato al suo interno. Per una lettura introduttiva sul bumba-meuboi vedi Antônio Azevedo Neto, Bumba-meu-boi no Maranhão. 2a ed.,
Alumar, São Luís, 1997 (1983) [N.d.T.].
4
La ricerca è stata realizzata tra il 2000 e il 2003.
5
Per Bourdieu (2002, p. 27), "La nozione di campo è, in un certo
senso, una stenografia concettuale della modalità di costruzione
dell'oggetto, che guida - o orienta - tutte le opzioni pratiche della
ricerca. Funziona come un segnale che ricorda o che riguarda, che fa
sapere e verifica, il fatto che l'oggetto in questione non è isolato da un
insieme di relazioni dal quale ritaglia l'essenziale delle sue proprietà.
Per suo mezzo, si fa presente il primo precetto del metodo, che
richiede che si lotti con tutti i mezzi contro la primitiva inclinazione di
pensare il mondo sociale in maniera realista o, per dirla come
Cassirer, sostanzialista" [versione dal portoghese a cura del
traduttore].
6
Quando parlo di attori sociali mi riferisco a persone dotate di uno
specifico potere di azione e capacità di influire in un determinato
campo (siano giornalisti, politici, funzionari pubblici o gli stessi
partecipanti del bumba-meu-boi, chiamati brincanti).
7
Danza tradizionale maranhence caratterizata dalle percussioni ritmate
di 3 tamburi di diverse dimensioni. Mentre i musicisti sono sempre
uomini, le danzanti sono solo donne e formano una roda al cui centro,
di fronte ai tamburi, danza, di volta in volta, una sola di esse. Per una
descrizione sintetica, anche se datata, del folclore maranhence vedi
Domingos Viera Filho, Folclore brasileiro: Maranhão, MEC/DAC/
FUNARTE/ Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, 1977
[N.d.T.].
8
La connessione del burocratico con il politico è fondamentale in
quanto è usata come una stenografia convenzionale dell'agire politico,
nella misura in cui suppone che il campo della rappresentazione
politica nel Maranhão poggi su una burocrazia statale che, per
mantenere i suoi incarichi all'interno del governo, riproduce
l'ideologia dei governanti. Bisogna dire che, nel Maranhão, gli alti
funzionari pubblici non operano a vantaggio della popolazione, ma, al
contrario, sono la base di sostentamento di coloro che stanno al potere.
Si tratta di un sistema molto efficiente di appropriazione del pubblico,
considerato in questo contesto come alcunché di privato. Ciò avviene
anche al livello degli impiegati pubblici. Penso che questa situazione
dipenda molto anche dai loro comportamenti.
9
Si potrebbe forse legare più strettamente il campo degli intellettuali a
ciò che ho chiamato campo burocratico-politico, poiché alcuni dei suoi
attori sono allo stesso tempo funzionari di stato, o per lo meno lo sono
stati, o comunque sono ad essi legati in qualche modo. Inoltre, sono
questi attori sociali che possiedono il maggior capitale relazionale che
consente loro di parlare in pubblico, fare interviste, pubblicare libri e
in tal modo accedere ad una vasta platea. È chiaramente a loro che mi
riferisco quando parlo degli intellettuali. È opportuno mettere in
evidenzia che per essere intellettuali nel Maranhão, è necessario
legarsi a qualche agenzia di legittimazione, come la AML - Academia
Maranhense de Letras -, lo IHGM - Instituto Histórico e Geográfico do
Maranhão - la CMF - Comissão Maranhense de Folclore -, le
istituzioni universitrie. In relazione a queste ultime, le monografie di
Note
*
Il presente articolo è l’adattamento di un intervento presentato
dall’autore ad una conferenza organizzata in São Luís dal Partido dos
Trabalhadores sul tema delle politiche culturali nel Brasile. La
versione originale portoghese sarà resa disponobile sul sito della
rivista. La traduzione qui proposta è di Michele Parodi [N.d.T.].
1
Università Federale del Maranhão.
2
Il Maranhão è uno dei 26 stati della Repubblica Federale del Brasile.
3
La festa del Bumba-meu-boi è una delle manifestazioni folcloriche
più importanti per diffusione e partecipazione popolare della regione
del nord-est del Brasile. A partire dagli anni '80 la festa si è
notevolmente sviluppato nelle aree urbane dello Stato del Maranhão e
in particolare nella sua capitale São Luís. Il Bumba-meu-boi di São
Luís è un'opera popolare, o danza drammatica, messa in scena da varie
associazioni (brincadere) all' "aria aperta", nelle strade e nelle piazze
della città. Per mezzo di balli, canti, declamazioni, sono rappresentati
gli avvenimenti della vita di un bue. Riprodotto con un'armatura di
legno ricoperta di velluto, il bue danza manovrato da un attore
13
ACHAB
fine corso di laurea, e anche i lavori più consistenti come le
dissertazioni di specializzazione e le tesi di dottorato, che riguardano
le manifestazioni culturali, hanno riprodotto sostanzialmente
l'ideologia dominante.
10
Nel 1964 un colpo di stato militare prende il potere in Brasile. Solo
a partire dal 1974 è stata avviata una graduale transizione democratica.
Nel 1988 è stata promulgata la nuova costituzione che istituisce un
federalismo decentralizzato e ristabilisce l'elezione del capo dello stato
a suffragio universale diretto [N.d.T.].
11
Vocabolo portoghese che significato divertimento, gioco, passatempo
[N.d.T.].
12
L'ideologia propagandata dai governi autoritari post-64 affermava il
Brasile costituire una unità nella diversità, con distinte manifestazioni
caratterizzanti il modo di essere del popolo brasiliano. Per una
discussione a riguardo, cfr. Ortiz 1994.
13
Gli arraiais sono arene pubbliche, organizzate con gradinate per gli
spettatori e un ampio palco, localizzate nei principali quartieri della
città, dove nel periodo delle feste junine (dalla metà alla fine di
Giugno) i vari gruppi folclorici si presentano al loro pubblico [N.d.T.].
14
La commedia del buma-meu-boi, nella sua struttura più
convenzionale, narra le vicende di Pai Chico e mae Caterina, una
coppia di sposi alle dipendenze di un fazendeiro. Caterina è gravida e
desidera la lingua del boi preferito dal padrone. Chico ruba il boi che
nasconde nella foresta dove gli taglia la lingua. Il fazendeiro con
l'aiuto degli indios riesce però a catturare Chico. Infine, un paije
(guaritore tradizionale), o un medico, resuscitano e curano il boi, il
fazendeiro perdona Chico e tutto termina con danze e canti [N.d.T.].
15
Le brincadere del bumba-meu-boi sono classificate in tipologie o
stili (sotaques) che dipendono dal tipo di strumenti, ritmi e indumenti
usati nelle rappresentazioni della festa. I bumba-meu-boi d'orchestra si
caratterizzano soprattutto per l'utilizzo di strumenti a corda (banjo) e a
fiato [N.d.T.].
16
Madre Deus è uno dei bairros più antichi di São Luíz [N.d.T.].
17
Nel 2006, mentre aggiorno questo articolo, la ex-Governatrice e exSenatrice, Roseana Sarney, é candidata nel secondo turno delle
elezioni per il Governo dello Stato del Maranhão.
18
Il campo intellettuale maranhense registra attualmente l'esistenza di
5 sotaques: matraca, zabumba, orquestra, baixada e costa de mão.
Riferimenti Bibliografici
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paul: Brasiliense, 1994.
14
ACHAB
Welcome to Armenia
Etnografia dell’Ararat nell’identità diasporica armena
di Fiammetta Martegani
secondo la storiografia armena, infatti, la Magna Armenia, nel
massimo del suo splendore, come durante il regno di Tigran il
Grande, fra il 95 e il 56 a.C., era detta addirittura "Armenia da
mare a mare" poiché occupava il vasto spazio geografico
compreso tra Mar Nero, Mar Caspio e Mar Mediterraneo, uno
spazio dieci volte maggiore rispetto ai confini dell'attuale
Repubblica Armena.
A causa delle diverse dominazioni che si sono succedute nel
territorio compreso tra l'altopiano anatolico e quello caucasico,
ciò che si è verificato nel corso della storia è stato un continuo
spostamento e rimescolamento di popolazioni, ragion per cui
riuscire a stabilire i confini di una presunta Armenia delle
"origini" risulterebbe non solo pretenzioso, ma addirittura
arbitrario.
Se dunque risulta già di per sé tutt'altro che scontato riuscire a
definire le "origini" dell'Armenia, si rivela ancor più complesso il
tentativo di risalire alle "origini" della diaspora del popolo
armeno.
Quando ha "inizio" la diaspora di un popolo? Quale definizione
può essere considerata esaustiva per esprimere il concetto stesso
di diaspora? Quante persone è necessario che lascino il proprio
Paese perché si possa effettivamente parlare dell'esistenza di una
"comunità diasporica"? Quando lasciare il proprio Paese significa
compiere una "scelta" e quando invece significa subire
un'"imposizione"? Esiste poi un limite netto tra "scelta" e
"imposizione"? E dopo quanti anni un popolo "smette" di essere
in una situazione di diaspora? Se non è possibile stabilire
l'"inizio", è possibile stabilire la "conclusione" di una diaspora?
Lorenzo Rocci, nel suo Vocabolario greco/italiano (la cui prima
edizione risale al 1943), traduce il sostantivo diasporà con
"dispersione", poiché derivato dal composto dia-speiro, costituito
dalla preposizione dià, utilizzata per esprimere il complemento di
moto per luogo, solitamente tradotto con "attraverso", e dal verbo
speiro che a seconda dei contesti in cui viene utilizzato può
significare sia "spargere", "seminare", che "generare", "produrre"
(Rocci, 1943, pp. 465, 438, 1691 nell'ed. del 1995).
Pur largamente usato, il termine diaspora sembrerebbe mancare
di una definizione univoca; tuttavia, nei suoi diversi utilizzi, porta
con sé molto più spesso la sola accezione di "dispersione"
trascurando invece la dimensione di "produzione" e
"costruzione", che pur risultano fortemente appropriati ai processi
di costruzione identitaria peculiari alle comunità di tipo
diasporico.
Decostruendo il concetto di diaspora
Non appena atterrato all'aeroporto di Erevan, una volta superata la
dogana, il passeggero è inevitabilmente costretto ad imbattersi in
un suggestivo poster di benvenuto, che recita: "Welcome to
Armenia" (Fig. 1).
Ciò che colpisce in questo poster è la presenza di un monte, più
precisamente del monte Ararat, che non si trova affatto in
territorio armeno, bensì in territorio turco.
Se può sembrare apparentemente insolito che il poster di
benvenuto di un Paese rappresenti come simbolo del proprio
paesaggio nazionale un luogo "fisico" che, quanto meno stando ai
parametri dei confini politici, non appartiene affatto al proprio
territorio, ancor più insolito è venire a scoprire che la produzione
e la messa in commercio di mouse-pad raffiguranti il monte
Ararat, non soltanto non avvengono in Turchia, ma neppure nella
Repubblica Armena, bensì in Canada.
In Canada, infatti, si trova attualmente una numerosa nonché
consolidata
comunità
armena che, assieme a tutte
le altre comunità armene
disseminate per il globo,
dall'Argentina all'Australia,
fa sì che il numero di
armeni
che
vivono
l'esperienza della diaspora
sia attualmente più del
doppio
degli
armeni
residenti nella Repubblica
Armena.
Una delle cause principali
di
questa
insolita
"sproporzione" tra armeni
residenti in patria e armeni
residenti all'estero sta nel
fatto
che
l'attuale
Repubblica
Armena
corrisponde soltanto ad
Fig. 1 Manifesto all'areoporto di
Erevan (Foto dell'autrice)
un'esigua porzione del
territorio che un tempo
apparteneva alla cosiddetta Armenia antica.
Stabilire quale fosse l'estensione dell'antica Armenia è impresa
tutt'altro che semplice, poiché la superficie della regione è
cambiata nel corso della storia e soprattutto della storiografia:
15
ACHAB
Secondo Meinig, una regione culturale si compone, oltre che di
una parte nodale, caratterizzata dalla contiguità fisica, anche da
emanazioni territorialmente separate, appendici culturali che
costituiscono una diaspora intimamente interconnessa con il
mondo esterno (Meinig, 1965, p.220).
Di conseguenza, il fatto che una cultura sia deterritorializzata non
significa necessariamente che sia dispersa, frantumata e che
quindi basterebbe reinserire coloro che la condividono nel
territorio d'origine per riprodurla come era una volta. Le culture,
osserva Fabietti, deterritorializzandosi, si reinventano a contatto
con le altre, dando vita a nuove forme di produzione di identità
(Fabietti, 2004, p.45).
L'analisi del caso armeno in quanto esperienza diasporica risulta
in tal senso paradigmatica, come afferma Ferrari, proprio in virtù
della secolare capacità del popolo armeno di elaborare un'identità
multidimensionale, ponendosi sempre in una relazione di
integrazione differenziata con le diverse realtà sociali con cui è
entrata in contatto (Ferrari, 2000, p.10).
Condicio sine qua non per cui possa essere rilevata una
"differenza" è l'esistenza di una "relazione". Ma ogni relazione
porta evidentemente con sé uno scambio, un'osmosi,
'concatenazioni che si determinano a vicenda in particolari
situazioni storiche ed attraverso specifiche relazioni di forza,
queste ultime pensate non tanto come dualità di dominanti e
dominati ma piuttosto come reti in tensione' (Manoukian, 2005, p.
2).
Accade così che all'interno di queste "reti"
spesso si sviluppino identità di tipo "ibrido",
come nel caso di un movimento di resistenza
paramilitare appartenente alla comunità
armena
libanese
che,
rielaborando
un'immagine (coniata dal movimento di
resistenza palestinese, a sua volta in esilio in
Fig. 2 ( tratto dal
Libano) in cui un pugno chiuso si erige periodico di Beirut
fieramente al di sopra dei Territori occupati, Spurk, n.16, 1988)
la renderà propria attraverso la sostituzione
dei Territori occupati con l'immagine dell'Ararat (Fig. 2).
Una volta codificato in quanto elemento identitario facilmente
riconoscibile, l'Ararat potrà dunque essere riutilizzato, di volta in
volta, come simbolo per i movimenti di resistenza paramilitare in
Libano, come insegna per una bottega di alimentari specializzati
in prodotti armeni (ammesso che possano esistere prodotti
alimentari "esclusivamente" armeni) nel sobborgo parigino di
Alfortville (Fig. 3) come titolo, con cui assicurarsi quasi
automaticamente un'ampia fascia di pubblico, per la locandina di
un film del regista armeno, appartenente alla diaspora egiziana e
attualmente residente a Toronto, Atom Egoyan. I concetti di
"codifica" e di "decodifica" elaborati da Hall, in uno dei suoi più
celebri saggi, Encoding and Decoding (1980), risulterebbero
dunque particolarmente funzionali nell'analisi delle riproduzioni
delle identità (nazionali o diasporiche che siano), proprio in virtù
del forte legame esistente tra produzione di identità e ruolo
rivestito dai media in tale processo produttivo. Anderson, in
Imagined Communites, individua il rilevante nesso tra
Fig. 3 Alimentari nel sobborgo parigino di Alfortville
(Foto dell'autrice)
comunicazioni di massa e migrazioni di massa nel generare
fenomeni di nazionalismo ed eticità (Anderson, 1983, p. 240,
nell'ed.it.).
L'obiettivo di quest'analisi è quello di cercare di esplorare le
diverse rappresentazioni dell'Ararat in quanto prodotto mediatico
peculiare alla riproduzione dell'identità armena contemporanea.
Tra i paradigmi teorici dominanti nello studio dei media uno degli
approcci di riferimento è senz'altro quello "decodificativo" di
Hall, che emerge grazie a una specifica attività di ricerca,
sviluppatasi all'interno del CCCS (Centre for Contemporary
Cultural Studies) fondato a Birmingham da Hoggart nel 1964.
Tuttavia, l'attenzione rivolta ai media, come analisi dello sviluppo
di nuove identità comunitarie sorte in seguito alla diffusione di
pratiche mediatiche, ha cominciato a consolidarsi
significativamente, nell'ambito di studi sociali interdisciplinari,
solo a partire dagli anni '90, in contesti accademici
prevalentemente britannici e nordamericani.
E' all'interno di questo particolare contesto interdisciplinare che si
sviluppa, soprattutto grazie al contributo di Dalby e Toal, la
Critical geopolitics, i cui principali riferimenti teorici sono:
l'approccio alla semiotica proposto da Barthes; la necessità di
esplorare le relazioni tra potere e conoscenza attraverso l'analisi
del discorso, portata avanti da Foucault; il riferimento al concetto
di egemonia popolare sviluppato da Gramsci; la prassi di tipo
decostruzionista stimolata da Deridda (dell'Agnese, 2003a, p.37).
In tal senso, poichè il discorso geopolitico appare pervasivamente
legittimato anche dalla cultura geopolitica popolare, obiettivo
della geopolitica critica sarà cercare di decostruire le identità
nazionali e gli immaginari geografici codificati dalle produzioni
di tipo mediatico.
A partire da questo tipo di prospettive di ricerca verrà dunque
portata avanti un'etnografia dell'Ararat, in quanto veicolo
mediatico privilegiato per la riproduzione dell'identità armena
contemporanea.
L'approccio utilizzato farà riferimento alla pratica etnografica,
intesa come metodologia di ricerca radicalmente contestuale,
16
ACHAB
peculiare all'analisi dei media (Fagioli e Zambotti, 2005, p. 11).
E' necessario tuttavia precisare che le analisi effettuate attraverso
tale pratica etnografica non sarebbero state possibili senza il
supporto delle "interpretazioni" rilevate da una serie di colloqui
svoltisi, nei mesi compresi tra giugno ed ottobre del 2005,
all'interno di diverse comunità appartenenti alla diaspora armena.
In particolare, le principali comunità di armeni in cui si è svolto
questo processo di dialogo sono state: in Italia, le comunità di
Milano e Venezia; in Francia, le comunità di Parigi e del sobborgo
parigino di Alfortville; nella Repubblica Armena, le diverse
comunità in soggiorno estivo presso la capitale Erevan, e nella
zona limitrofa al Monastero di Marmashen, nella regione dello
Shirak.
Per usare le parole di Geertz, questo tipo di analisi si è dunque
svolta nella consapevolezza che "fare etnografia significa
intrattenere rapporti. (…) Nella stesura finale degli scritti
antropologici, compreso quello raccolto qui, ciò che chiamiamo i
nostri dati sono in realtà le nostre ricostruzioni di ricostruzioni di
altri su ciò che fanno loro ed i loro compatrioti. (…) In breve, gli
scritti antropologici sono essi stessi interpretazioni, e per di più di
secondo o di terzo ordine" (Geertz, 1973, pp. 12, 16, 24,
nell'ed.it.).
armena, allora fortemente influenzata dalle istanze nazionaliste di
matrice europea: 'when Armenia began to participate in the
political scenes of Europe and Russia from the XIX century'
sostiene Petrosyan 'Masis-Ararat became the nation's symbol'
(Petrosyan, 2001, p.37).
Sarà dunque agli inizi del XIX secolo, quando (come risultato del
conflitto russo-persiano) un vasto territorio appartenente
all'Impero persiano, abitato da una popolazione a maggioranza
armena, verrà annesso all'Impero Russo, che il monte Ararat
(allora situato all'interno di questo territorio) diventerà per gli
armeni il simbolo della lotta per la liberazione.
Nel 1827 il monte Ararat, incoronato dall'arca1, viene così
riportato sugli stendardi dei battaglioni dei volontari armeni che
combattevano all'interno dell'esercito russo.
Il tema dell'Ararat incoronato dall'arca verrà ripreso nello stemma
dell'esercito della Repubblica Armena indipendente, costituitasi
nel 1918, al termine della Prima Guerra Mondiale, e scomparsa
nel 1920, a causa della sconfitta subita da parte della Turchia, che
acquisterà la parte di territorio armeno all'interno del quale si
trovava il monte Ararat, mentre la parte restante del territorio
verrà assorbita dall'Unione Sovietica. Ciò nonostante, il monte
Ararat (questa secolarizzato attraverso l'espulsione dell'Arca!)
verrà ripreso come stemma anche dell'esercito dalla Repubblica
dell'Armenia Socialista Sovietica).
Sono dunque questi gli anni in cui, come mette in luce Petrosyan:
'the mountain loom before the eyes of those living in the capital
of Erevan and for miles around, inspiring artisans and painters to
constantly reproduce its image' (Petrosyan, 2001, p. 38).
Apertosi la strada dunque nel corso del Romanticismo anche dal
punto di vista dell'arte figurativa, come nel celebre caso di
Ayvazovsky che nel 1889 dipingerà la Descent of Noah from
Mount Ararat, il tema dell'Ararat riuscirà infatti a trovare il suo
spazio anche nel corso delle varie correnti artistiche del XX
secolo: celebre, a titolo esemplificativo, il caso dell'espressionista
di Martiros Saroyan.
Lo stesso Arshile Gorki (1904-1946), armeno dell'Anatolia
immigrato negli Stati Uniti dopo il genocidio, pittore
d'avanguardia precursore dell'action painting, pur non ritraendo
mai l'Ararat, scriverà nelle sue memorie: 'Essendo un figlio
dell'Ararat la mia mente è impregnata dei profumi delle
albicocche d'Armenia. Ce ne sono molte nel mio giardino, ed io
le sento col cervello. Ora esse riemergono nel mio lavoro. (…)
Alcune volte riesco ad ottenere i colori dell'Armenia, altre proprio
no. Io tento continuamente di riportare i colori dell'Armenia nei
miei colori' (Baghoomian, 1978, pp.63,64).
L'invenzione della montagna come paesaggio nazionale
Il monte Ararat, di fatto sempre conosciuto in quanto rilievo
montuoso, verrà riscoperto, o meglio ancora "riletto" e
"codificato" in quanto paesaggio nazionale, soltanto in un preciso
momento storico, ovvero, per usare le parole di Chabod, quando
l'idea di "nazione" sorge e trionfa con il sorgere e il trionfare del
Romanticismo (Chabod, 1961, p.17).
Pur rifiutando l'arbitraria cesura tra "assolutismo illuminato"
settecentesco e "risorgimento" ottocentesco, Chabod sottolinea
infatti come soltanto nel XIX secolo si sviluppi un'idea di nazione
fino ad allora inedita: 'Passione trascinante e fanatizzante
com'erano state un tempo le passioni religiose, la nazione diventa
patria, e la patria diviene la nuova divinità del mondo moderno.
(…) Patria, sacra; sangue versato per essa, santo. Ed ecco che da
allora, effettivamente, voi sentite parlare di martiri per
l'indipendenza, la libertà, l'unità della patria' (Chabod, 1961,
pp.58, 61,62).
Sono del 1827 queste parole con cui l'arcivescovo Nerses
d'Ashtarak incitava le milizie armene a riprendere i combattimenti
nel corso del conflitto russo-persiano (1826-1828) : 'Ecco
giungere per noi l'ora di vedere la liberazione della terra
dell'Ararat e della nazione armena. (…) In piedi! Prodi armeni!
Rovesciate il giogo persiano, raggiungete il Masis dalla testa
canuta, tingete una sola volta del vostro sangue il suolo della
vostra patria e vivrete liberi!' (Ter Minassian, in Dedeyan, 1982,
p.349 nell'ed.it.).
Il Masis di cui si sta parlando è la cima maggiore delle due
inconfondibili cime che caratterizzano il monte Ararat. E' dunque
all'interno dello specifico contesto storico e culturale peculiare al
Romanticismo che il monte Ararat diverrà simbolo dell'identità
Territorializzare la deterritorializzazione
I pittori sinora citati hanno tutti vissuto l'esperienza della
diaspora, esperienza in cui l'Ararat, sembrerebbe quasi risultare
l'anello mancante in grado di saldare le "vite spezzate", per usare
le parole di Said, di chi vive l'esperienza della diaspora (Said,
2000, p.177).
E' in questo contesto che l'Ararat inizierà a diventare un tema
17
ACHAB
ricorrente anche nella diversa letteratura della diaspora:
I'm an Armenian, as old as Ararat;
My shoes were wetted by the waters of the Flood.
Beside these shining peaks were Noah sat
My sword once drew the dread Bel's evil Blood.
I'm an Armenian, opera di Gevorg Emin, nato nel 1919
nell'Armenia Sovietica e trasferitosi in seguito a Mosca, è una
delle numerose opere in versi contenute all'interno della raccolta
di autori appartenenti alla diaspora armena, dal significativo titolo
Sojourn at Ararat (1987), a cura di Gerald Papasian, editore
armeno di Los Angeles.
Anche Michael Arlen, figlio di armeni della Bulgaria, nato e
cresciuto nel Regno Unito e trasferitosi in seguito negli Stati
Uniti, scriverà nel 1975 Passage to Ararat, romanzo
autobiografico che descrive il tentativo da parte dell'autore di
ricostruire le proprie origini armene provando tutta
quell'esperienza di straniamento peculiare a chi vive una
situazione di diaspora.
Si chiama Ararat Quarterly la rivista trimestrale inizialmente
specializzata in articoli dedicati alla letteratura e alle belle arti e
che attualmente si occupa della diffusione di diverse produzioni
mediatiche realizzate dalla diaspora armena, pubblicata a New
York, ormai dal 1959, con i fondi dell'Armenian General
Benevolent Union (AGBU).
Dopo essere stato rappresentato dagli artisti della diaspora nella
letteratura e sulla tela, l'Ararat non poteva assolutamente essere
trascurato dal cinema. Anzi, come afferma Naficy: 'Rural
landscapes and mountains, particularly Mount Ararat, figure large
in Armenian accented films' (Naficy, 2001, p. 164).
L'Ararat compare per la prima volta sullo schermo nel 1973 col
film di Verneuil Le serpent. Girato e ambientato negli anni della
Guerra Fredda, il film racconta le vita di una spia sovietica,
consigliere dell'ambasciata russa a Parigi, che chiede asilo
politico agli Stati Uniti. Per provare la sua buona fede il
protagonista si trova costretto a ricorrere a rivelazioni sulla rete di
spionaggio che coinvolgono personaggi insospettabili. A
testimoniare la verità di una di queste scottanti rivelazioni, che
implicava la collaborazione di una spia americana con il KGB,
sarà una foto che raffigura il personaggio coinvolto con alle spalle
il monte Ararat, visto dal punto di vista di chi si fosse trovato in
territorio sovietico.
Tuttavia nel film di Verneuil l'Ararat compare soltanto attraverso
una foto, mentre, come osserva Naficy: 'the fascination with he
Ararat chronotope is encoded in Ara Madzounian's twenty minute
film The Pink Elephant, 1988. (…) With this image, Madzounian
poses the possibility of Ararat losing its hold on the Armenians in
diaspora as a unifying chronotope. When he was growing up in
Lebanon and the United States, the image of Ararat was found on
nearly every wall in every Armenian home' (Naficy, 2001, p.
165).
Il chronotope dell'Ararat verrà riutilizzato nel 1991 da Verneuil
come sfondo ai titoli di inizio di Myrig e nel 1993 da Egoyan in
una delle prime sequenze di Calendar, fino a diventare, nel 2002,
il protagonista indiscusso dell'ultima sua opera: Ararat.
Come in un gioco a scatole cinesi, in Ararat di Egoyan troviamo
infatti l'Ararat rappresentato attraverso più livelli semantici:
Ararat è infatti prima di tutto un film-within-film, il colossal girato
dal regista Edward Saroyan, alter-ego dello stesso Egoyan, e
interpretato per l'altro dal Charles Aznavour, personaggio icona
della diaspora armena. All'interno del colossal compare a sua
volta l'Ararat, o meglio la riproduzione paesaggistica dell'Ararat,
preso volontariamente in prestito, per quanto non verosimilmente,
come fondale ai massacri del genocidio descritti da colossal.
Ani: Da Van sarebbe stato impossibile vedere il monte Ararat?
Saroyan: Lo so, però mi sembrava un elemento importante nella
storia
Ani: Ma è una falsificazione
Saroyan: Sul piano simbolico non lo è. Rubens, Ani manifestava
un certo disagio sul monte Ararat, mi ha fatto giustamente notare
che da Van era impossibile vederlo
Rubens: Abbiamo deciso di forzare un po' la realtà, si tratta di
un'icona così identificabile…
Egoyan è dunque assolutamente consapevole dell'operazione che
sta compiendo. Del resto, in un'intervista rilasciata a Naficy, già
nel 1997, dunque prima di girare Ararat, alla domanda 'If you
were to think of Armenia, what landscape comes to mind?'
Egoyan risponde: 'Well, the most obvious one, the most fetishized
symbol is mount Ararat. It's incredible because Ararat is not even
within the Armenian territory. (…) And yet if you go up to
Erevan, on a clear day, it has an almost surreal presence. It is quite
strange. It's as though it's pasted to the city. It's so large. And yet
it's in the forbidden territory' (Naficy, 2001, pp.164-165).
Tanto che a completare l'opera di Egoyan non poteva mancare il
viaggio alle pendici dell'Ararat, questa volta "reale", addirittura
rappresentato sotto forma di film-documentario, quasi a volerne
sottolineare l'autenticità.
Come emerge dalla dichiarazione di Egoyan, l'immagine
dell'Ararat sembra quasi irrinunciabile poiché in grado di
rispondere a un bisogno di territorializzazione, da parte di coloro
che invece hanno vissuto l'esperienza della deterritorializzazione:
'Spesso subentra il bisogno di avere un'immagine di riferimento,
che nel nostro caso diventa l'Ararat' afferma il direttore della
Biblioteca parigina Nubar, specializzata in armenistica (Intervista
a Raimond Kievorkian, svoltasi a Parigi il 27.10.2005).
E' infatti grazie all'immagine dell'Ararat che un armeno, per
utilizzare le parole di Anderson, riesce ad "immaginarsi" come
tale, tanto a Beirut quanto a Los Angeles, così come nel caso
della 'famosa fotografia del Gastarbeiter del Peloponneso seduto
abbacchiato nella sua stanzetta in un'anonima città industriale
tedesca - Stoccarda forse? La stanzetta è spoglia, tranne che per
un poster del Partenone prodotto dalla Lufthansa, con una scritta,
in tedesco, che invita chi guarda ad andare in vacanza in Grecia.
Evidentemente il Partenone della Lufthansa non è una memoria
reale per il malinconico lavoratore. Lui l'ha messo sulla parete
18
ACHAB
come segno della "Grecia" e di un'etnicità che solo Stoccarda lo
ha incoraggiato ad immaginare' (Anderson, 1992, appendice ad
Anderson, 1983, p.243 nell'ed.it).
Secondo Clifford coloro che vivono l'esperienza della diaspora
'una volta che si siano sistemati in un determinato luogo hanno
L'Ararat come simbolo di resistenza
Sinora si è visto come a partire dall'Ottocento l'Ararat abbia
iniziato a essere "riletto" in quanto specifico veicolo di identità
nazionale, assieme a una progressiva espropriazione di luoghi
precedentemente lasciati nel dimenticatoio, come il fiume Arax,
l'antica capitale della Cilicia Ani e l'isola di Achtamar sul lago
Van.
Ma se, come sottolinea dell'Agnese, l'imitazione ripetitiva di
quanto si ritiene caratteristico del proprio passato, e cioè di quello
che si ritiene essere il proprio heritage, non può che essere
selettiva, portando così ad estremizzare solo alcuni tratti culturali
(dell'Agnese, 2003b, p.226), caratteristica principale dell'icona
Ararat è soprattutto quella di essere stata "codificata" secondo
specifiche modalità di editing: l'Ararat verrà infatti sempre
rappresentato con la cima minore (Sis, alta 3896) a sinistra e
quella maggiore (Masis, alta 5137) a destra, ovvero come appare
a chi si accinge a guardarlo dall'altopiano caucasico, e non
dall'altopiano anatolico (Fig. 5). La scelta di rappresentare il
monte Ararat dal punto di vista "caucasico" sembrerebbe infatti
sottolineare l'impossibilità di poterlo rappresentare dal punto di
vista "anatolico" per via della pulizia etnica subita dal popolo
armeno nei territori dell'Anatolia durante la Prima Guerra
Mondiale, per mano dell'esercito turco.
Quando si domanda ad un armeno della diaspora cos'è "la cosa
più bella" da vedere a Erevan la risposta sarà sempre: 'L'Ararat.
Anche se ce l'hanno tolto non ci possono impedire di guardarlo, e
dalle colline di Erevan, quando non c'è foschia, si possono
scorgere le cime innevate.2
In tal senso Traina sottolinea come persino l'urbanistica della
moderna Erevan si sia sviluppata pressoché in funzione di questa
suggestiva presenza (Traina, 2001, p. 217).
Accade così che armeni della diaspora, foschia o non, si
connettano alla webcam di www.arminco.com per poter sempre
avere l'Ararat "sotto controllo".
Collante extraterritoriale, fin da prima del genocidio, per una
popolazione "deterritorializzata", l'Ararat, dopo il genocidio,
risulterebbe essere diventato una sorta di simbolo di resistenza,
Fig. 4 Ristorante armeno a Chicago -USA (Foto di Irene Falc)
anche bisogno - può quasi dirsi che ne vada della loro
sopravvivenza - di fissare certi simboli' (Clifford, 1997, p.58
nell'ed.it.).
Accade così che i proprietari di un ristorante armeno di Chicago,
i cui antenati provenivano probabilmente da una città
dell'Anatolia distante migliaia di chilometri dal monte Ararat,
scelgano di appendere all'ingresso del proprio ristorante un arazzo
con raffigurato l'Ararat (Fig. 4).
Non sorprende dunque che Ararat diventi la marca di "tipiche"
confetture armene, provenienti dalla Repubblica Armena, e in
vendita presso un bookshop di New York specializzato in
armenistica.
Il vignettista Hoviv (nome d'arte di Renè Hovivan) nato nel 1929
a Vienna, dove i genitori erano riusciti a scappare dal genocidio,
ma francese di adozione, nella sua raccolta di vignette del 2001
Les Armenienens (in cui ovviamente l'Ararat non poteva non
comparire in copertina) si spinge a disegnare una sorta di autoparodia sull'ossessione del suo popolo nei confronti dell'Ararat.
In effetti si potrebbe affermare che l'attaccamento da parte della
comunità armena nei confronti dell'Ararat è tale da aver
provocato una sorta di "mercificazione" o "turisticizzazione"
dell'Ararat.
Come messo in luce da Petrosyan: 'Shops, stalls, and fairs in
Erevan are full of its likeness captured, for better or worse, in
various media, techniques and styles. Images of Masis-Ararat are
presented to visitors and taken as a gift to friends in foreign
countries. The mountain has become, for all intents and purposes,
the calling card of Armenia' (Petrosyan, 2001, p. 38).
Succede così che al vernissage che si tiene ogni fine settimana a
Erevan non manchi uno specifico merchandising in cui l'Ararat
viene puntualmente riprodotto su magliette, quadri, piuttosto che
francobolli pre e post sovietici.
Fig. 5 Veduta dell'Ararat dall'altopiano caucasico di Erevan
(Foto di Sam Sweezy)
19
ACHAB
proprio perché assorbito all'interno del "corpo" del cosiddetto Europeo approverà una risoluzione affinché il governo turco,
nemico: la Turchia.
come condizione necessaria per l'ingresso della Turchia
Per coloro che hanno vissuto l'esperienza della diaspora l'Ararat nell'Unione Europea, riconosca pubblicamente la propria
sarebbe infatti stato "rubato", rappresentando in tal modo il responsabilità nei confronti del genocidio operato sul popolo
simbolo per definizione del torto subito: 1.500.000 di morti a armeno.
causa di un genocidio che non viene ancora riconosciuto come Accade così che alla vigilia dei negoziati per l'ingresso della
tale. Non è un caso che nel film Ararat il regista Saroyan, alter- Turchia nell'Unione Europea, che si sono tenuti il 3 ottobre del
ego di Egoyan, pronunci, con alle spalle proprio il fondale che 2005, un nutrito team di professori e intellettuali turchi organizza
ritrae l'Ararat, queste parole: 'Qual è ancora oggi la causa di tutto a Istanbul il primo dibattito accademico nazionale volto ad
questo dolore? Non è di aver perso delle persone care, o la nostra affrontare la spinosa questione del negazionismo turco. Lo
terra. E' la consapevolezza di poter essere odiati così tanto. Che svolgimento del ciclo di conferenze, che si sarebbe dovuto tenere
razza di umanità è che ci odia così tanto? E con che coraggio alla Bospohrus University dal 23 al 25 settembre, viene però
insiste nel negare il suo odio, finendo così per farci ancora più interrotto sotto richiesta ufficiale del tribunale turco. Ciò non ha
male?'
tuttavia impedito agli organizzatori di spostare la conferenza, se
Nella costruzione dell'identità armena contemporanea l'Ararat pur sotto assedio, nella piccola università di Bilgi.
risulterebbe dunque, per usare le parole
Il caso è emblematico in quanto
di Fabietti, uno di quei 'punti dello
assediati e assedianti sembrano
spazio che fungono da "tracce della
addirittura condividere gli stessi valori
memoria" e che, ripercorsi fisicamente
e utilizzare le stesse parole, pur
o
con
l'immaginazione,
sono
piegandole a diversi significati. Infatti
suscettibili di sostenere ed assicurare
il Rettore dell'Università di Bilgi apre i
continuità ad una rappresentazione
lavori della conferenza con un nobile
condivisa del sé collettivo, ossia
appello: "Siamo qui per la democrazia e
dell'identità di un gruppo' (Fabietti,
la libertà del popolo turco" Dalla siepe
1999, p. 10).
degli ultranazionalisti, che per strada
'Chiamare il proprio negozio di
sventolano la bandiera turca, si alzano
alimentari Ararat' afferma un
voci: "Siamo qui per la democrazia e la
commerciante del sobborgo parigino di
libertà del popolo turco!". La scena in
Alfortville 'diventa dunque un modo
qualche modo riassume e amplifica le
per essere riconoscibili tra noi armeni,
contraddizioni di un paese che da una
ma soprattutto per chiedere di essere
parte attende i negoziati per la futura
riconosciuti, dagli altri, come popolo
adesione all'Europa, e dall'altra è
che ha subito un genocidio' (Intervista a
ancora irriducibilmente prigioniero
Yetò Derderian, svoltasi ad Alfortville,
delle proprie paure (Antonio Ferrari,
il 28.10.2005).
Corriere della Sera, 25 settembre 2005,
Lo stesso Tsitsernakaberd, monumento
p. 15).
per la memoria dei martiri del
Mutafian ha in tal senso cercato di
genocidio, costruito a Erevan nel 1967
mettere in luce come il riconoscimento
Fig. 6 Tsitsernakaberd a Erevan (Foto dell'autrice)
dall'architetto Arthur Tarkhanian, venne
del genocidio da parte della Turchia
infatti appositamente progettato in modo da evocare le due cime implicherebbe un capovolgimento totale della lenta e fragile
del monte Ararat (Fig. 6).
costruzione storiografica turca, poiché il riconoscimento, e
Riscoperto nell'Ottocento come simbolo di identità nazionale e dunque la condanna, del genocidio, chiamerebbe in causa ben tre
rielaborato nel Novecento come irrinunciabile heritage di regimi politici turchi: il "sultanato rosso", i Giovani Turchi, ma
riferimento per la comunità diasporica, nel XXI secolo, alla soprattutto la Repubblica Turca fondata da Kemal Atatürk, la cui
vigilia dell'ingresso di Ankara nell'Unione Europea, il monte messa in discussione in Turchia risulta non soltanto
Ararat sembrerebbe questa volta essersi trasformato in veicolo di inimmaginabile ma addirittura perseguibile per legge (Mutafian,
resistenza per ottenere il riconoscimento del genocidio del popolo 1995, pp. 58-60).
armeno, non soltanto da parte del Governo Turco ma soprattutto Tanto è vero che lo scrittore Orhan Pamuk, nato a Istanbul nel
da parte dell'intera comunità internazionale.
1952, vincitore del premio Nobel 2006 per la letteratura, per aver
Infatti il genocidio del popolo armeno, consumatosi negli anni messo in discussione le tesi negazioniste riguardo al genocidio del
della Prima Guerra Mondiale, verrà riconosciuto ufficialmente in popolo armeno, ha rischiato tre anni di carcere essendo stato
quanto tale dall'ONU soltanto nel 1985.
accusato dal tribunale turco di "aver denigrato pubblicamente
Come diretta conseguenza, soltanto nel 1987, il Parlamento l'identità turca" (Marco Ansaldo, La Repubblica, 27 settembre
20
ACHAB
2005, p. 19).
Altro esempio paradigmatico in tal senso risulta Tanger Akcam,
arrestato nel 1976 e condannato a dieci anni di reclusione, che
dopo aver trovato asilo politico in Germania attualmente insegna
alla University of Minnesota.
Oltre ad essere uno dei più acuti e soprattutto più coraggiosi
studiosi della questione armena, Ackam è stato uno dei primi
intellettuali turchi a lavorare intensamente per un progetto di
dialogo tra il popolo turco e il popolo armeno.
Nella sua ultima opera, pubblicata nel 2004, Nazionalismo turco
e genocidio armeno Akcam cerca in particolare di tracciare i
principali ostacoli nei processi di riconciliazione tra popolo
armeno e popolo turco.
Secondo Ackam infatti quando un turco e un armeno si
incontrano, l'armeno vede nel turco, riemerso dal passato, un
assassino della sua gente e il turco vede nell'armeno un traditore
della patria del 1915. Non sono più individui ma si sentono i
rappresentanti dei loro popoli; dunque, ogni critica viene
percepita come un attacco sia nei confronti dell'individuo che del
gruppo. Oggi, nell'interagire l'uno con l'altro, entrambi sono
incapaci di vedersi come persone nel presente. Secondo Ackam,
entrambe le parti dovrebbero invece mobilitare risorse politiche
e culturali per promuovere una commissione d'indagine che
esamini e metta in comune la diversa documentazione storica:
secondo Ackam 'E' necessario passare a un paradigma che ponga
entrambe le società al centro dell'analisi, uno spazio culturale in
cui entrambe le parti abbiano la possibilità di imparare le une
dalle altre' (Ackam, 2004, pp. 256, 257, 261).
Un simile cambio di paradigma potrebbe inoltre essere uno
stimolo nell'attuale mondo della ricerca volta allo studio dei
fenomeni genocidiari, poiché, pur rispettando l'unicità di ogni
fenomeno genocidiario, la caratteristica universale di ogni
genocidio consiste proprio nel fatto di perpetrare un crimine
contro l'umanità intera.
Il tentativo di dialogo tra popolo armeno e turco, finalizzato al
riconoscimento del genocidio da parte dei carnefici nonché alla
compassione e al perdono da parte delle vittime, risulta infatti
necessario per il risarcimento morale e giuridico non soltanto del
popolo armeno in quanto tale, ma soprattutto del popolo armeno
in quanto parte della comunità umana.
Note
1
Il monte Ararat, o meglio, il risultato della sua vocalizzazione
masoretica errata dall'ebraico 'l hary'rarat al greco epi tà orè tà araràt
(Traina, 2001, p.217 ), viene citato nella Genesi come il monte su cui si
arenò l'Arca terminato il diluvio universale: 'Dopo 150 giorni di pioggia,
nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca di Noè si posò sui monti
dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese.
Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti'
(Genesi, cap.8, vv. 4-5).
Aldilà dei vari tentativi di identificazione precisa e aldilà delle fantasiose
spedizioni alla ricerca dell'arca, avendo Noè, secondo i parametri biblici,
portato in salvo l'umanità, resta il fatto che per l'identità armena,
fortemente fondata sulla millenaria conversione alla religione cristiana,
l'Armenia, col "suo" Ararat, rappresenterebbe, per usare le parole di
Cohen, 'the epicentre of the rebirth, if not the birth, of the earth' (Cohen,
1997, p. 43).
2
Si è scelta questa risposta, rilasciata da un gruppo di commercianti di
una drogheria del sobborgo parigino di Alfortville, in quanto
paradigmatica rispetto a un sentimento comune alla maggioranza degli
armeni della diaspora che sono stati intervistati in merito al significato
simbolico dell'Ararat, come dimostrato anche precedentemente dalla
dichiarazione di Egoyan.
Bibliografia
Akcam T., 2004, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and Armenian Genocide, Zed Books, London-NY (trad.it.
Nazionalismo turco e genocidio armeno, Guerini e Associati, Milano, 2005)
Anderson B., 1983, Imagined Communites, Verso, London (trad.it Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma, 1996)
Baghoomian Z., 1978, Armenia o Hayastan?, Tesi in Storia dell'Arte presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano
Chabod F., 1961, L'idea di nazione, Laterza, Roma-Bari
Clifford J., 1997, Routes, Harvard UP, Cambridge, Ma. (trad.it Strade, Bollati Boringhieri, Torino, 1999)
Cohen R., 1997, Global diasporas, Routledge, London -NY
Dedeyan G., 1982, Histoire des armeniens, Toulose (trad.it, Storia degli armeni, Guerini Associati, Milano, 2002)
dell'Agnese E.,
2003, Geografia politica. Appunti Critici, CUEM, Milano
2003, Identità meticce: deriva etnica e nazionalismo della diaspora nell'esperienza del contatto con l'Altro, in Ciclopi e
Sirene. Geografie del contatto culturale, a cura di Girolamo Cusimano, Annali della Facoltà di Lettere e filosofia
dell'università di Palermo
Fabietti U. e Matera V., 1999, Memorie e identità, Meltemi, Roma
Fabietti U., 2004, Il destino della "cultura" nel "traffico delle culture" in Rassegna Italiana di Sociologia, 1/2004, Il Mulino, Bologna
Fagioli M. e Zambotti S., 2005, Antropologia e media, Ibis, Como-Pavia
Ferrari A., 2000, Alla frontiera dell'impero, Mimesis, Milano
21
ACHAB
Geertz C., 1973, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books (trad.it. Interpretazione di culture, il Mulino, Bologna, 1988)
Manoukian S., 2005, Armeni in Iran, all'interno di Alpaghian, Scriptaweb, Napoli
Meinig D.V., 1965, The Mormon Culture Region: Strategies and Patterns in the Geography of the American West, 1847-1964, Annals
of the Association of American Geographers, vol.55, n.2
Mutafian C., 1995, Metz Yeghérn, Sevog press, Paris (trad.it. Metz Yeghérn, Guerini e Associati, Milano, 1995)
Naficy, 2001, An accented cinema, Princeton UP, Princeton
Petrosyan H., 2001, The Sacred Mountain in Armenian Folk Arts, Culture and Identity, a cura di Abrahamian L. e Sweezy N., Indiana
UP, Bloomington and Indianapolis
Rocci L., 1943, Vocabolario greco/italiano, Dante Alighieri, Perugia (ed. aggiornata al 1995)
Said E., 2000, Reflexions on Exile and Other Essays, Harward UP, Cambridge, Ma.
Traina G., 2001, Note sulla montagna nell'Armenia antica, in Giorcelli Bersani, Gli antichi e la montagna, atti del convegno (Aosta,
settembre 1999), Celid, Torino, 213-21.
Filmografia
Egoyan A., 1993, Calendar, Canada
2002, Ararat, Canada-Francia
Madzounin's A., 1988, The Pink Elephant, USA
Verneuil H., 1973, Le Serpent, Francia- Italia-RF
1991, Myrig e 588, Rue Paradis, Francia
Vignetta di Hoviv (da Les Armenienses, 2001)
22
ACHAB
Rappresentazioni del dolore
I profughi della guerra del Kosovo nella stampa italiana
di Federico Boni e Oscar Ricci1
individuare in Slobodan Milosevic un nemico palese, con tutti i
tratti del dittatore violento. Il vero problema per i media italiani di
fronte all'opinione pubblica riguardano, semmai, la posizione da
assumere in generale di fronte alla guerra: in Italia, come in
numerosi altri paesi europei, l'intervento militare della Nato è
deciso da un governo guidato dalle forze di centro-sinistra,
sostenuto peraltro da partiti di ispirazione pacifista. Questo
imbarazzo spiega, in parte, la cautela dei quotidiani più vicini al
governo. Altrettanto comprensibile, peraltro, risulta a questo
punto il continuo ricorso da parte dei media italiani al discutibile
concetto di "intervento umanitario".
Tuttavia, rispetto ad altri conflitti che hanno preceduto quello del
Kosovo - e secondo una costante che caratterizzerà i conflitti
futuri, come quelli più recenti -, avviene a pochi giorni dall'inizio
della guerra un fatto che probabilmente non era stato previsto del
tutto dalle istituzioni mediatiche: la notevole disponibilità di
immagini e storie delle fiumane di profughi che appaiono ai
confini serbi. I giornali italiani (ma anche la televisione, che pure
non consideriamo nell'analisi presentata in questo articolo) si
valgono immediatamente di quello che funziona come un simbolo
potentissimo per mostrare e descrivere la guerra del Kosovo: i
profughi e le loro sofferenze. Perché, naturalmente, la
personalizzazione riguarda non solo il nemico (come abbiamo
visto prima), ma anche le vittime: di qui la presenza di storie
singole e paradigmatiche, che diano nomi e volti alle folle di
profughi mostrati dalle immagini della televisione e dalle
fotografie dei giornali. Di nuovo, la formula drammaticonarrativa dell'amplificazione di storie individuali risponde a
logiche puramente mediatiche, mutuate spesso tout court da
formati televisivi come i reality shows e i programmi di "storie di
vita".
Da questo punto di vista, il presente articolo si propone di
analizzare la copertura da parte della stampa italiana della guerra
in Kosovo, per verificare il contributo dei media a stampa italiani
alla definizione e alla "creazione" di un particolare aspetto
dell'evento bellico, e cioè gli "esiti" dei bombardamenti
"invisibili" e delle azioni di guerriglia civile sul territorio
kosovaro. Il processo di definizione della realtà da parte dei media
non consiste solo nell'azione di incorniciamento (framing) degli
eventi, ma anche in una sostanziale legittimazione dell'evento
bellico. L'analisi qui presentata si è concentrata su quelle marche
discorsive che definiscono le cornici principali della narrazione
mediatica della guerra nel Kosovo, sulla base delle logiche della
1. La personalizzazione del dolore
Il nesso inevitabilmente strutturale tra guerra e media si manifesta
secondo forme e modelli differenti a seconda del conflitto e degli
attori coinvolti. Nondimeno, un dato teorico comune a tutte le
guerre dell'era mediatica - e che le recenti guerre post-11
settembre in Afghanistan e nel Golfo hanno largamente
confermato - è quello della mediatizzazione della guerra. Parlare
di mediatizzazione della guerra non significa sostenere che oggi i
media ci mostrano tutto ciò che è necessario per l'opinione
pubblica; al contrario, un tratto comune a tutte le guerre
cosiddette "mediatiche" è semmai quello del fallimento della
previsione di McLuhan, espressa più di trent'anni fa, secondo cui
con la guerra del Vietnam saremmo entrati nell'età della "guerra
televisiva", dove il pubblico, da casa, "partecipa" a ogni fase del
conflitto (McLuhan e Fiore 1995). Con mediatizzazione della
guerra intendiamo riferirci, da una parte, al rapporto tra guerra,
sistema politico e sistema dei media, ma soprattutto - ed è questa
l'accezione che useremo in questo articolo - il ricorso a
determinati linguaggi e codici mediatici per definire e
incorniciare la guerra.
La qualità visiva e narrativa delle descrizioni dei media rientra
spesso tra quelle strategie discorsive mediatiche che tendono a
minimizzare i costi in termini di vite umane della guerra, tramite
una definizione e una rappresentazione asettica dell'evento
bellico. Asettica, e quindi chirurgica: appunto come viene spesso
definita l'attività bellica dei paesi occidentali, con il ricorso a
riferimenti connotativi che rimandano alla "precisione" e
all'astrazione. Ancora, proprio l'astrazione e la stilizzazione
costituiscono un fattore di quella mediatizzazione che stiamo qui
definendo: secondo una logica mediatica tra le più consolidate, le
retoriche del conflitto vertono intorno ad alcune immaginisimbolo, che sterilizzano e stilizzano la guerra in corso. Se si può
indubbiamente parlare di strategia discorsiva mirata, va anche
detto che tali retoriche fanno parte di una consolidata pratica di
routine tipica del linguaggio mediatico.
Un aspetto importante della mediatizzazione della guerra è quello
legato ai fenomeni della personalizzazione e della
narrativizzazione. Come già Saddam nella Prima Guerra del
Golfo ("nuovo Hitler", secondo "la Repubblica" del 9 agosto
1990), anche Slobodan Milosevic viene presentato come il villain
di turno. In questo senso, per i media italiani (che facevano
comunque parte della coalizione Nato) la giustificazione di un
intervento armato in Kosovo si è valsa della possibilità di
23
ACHAB
mediatizzazione della guerra che abbiamo visto precedentemente.
Si tratta, cioè, di indagare i testi della stampa italiana e le loro
strategie discorsive, i cosiddetti media frames. La ricerca è basata
sull'analisi di quattro testate giornalistiche nazionali della stampa
("Corriere della Sera", "la Repubblica", "La Stampa" e "Il
Giornale"). Gli articoli raccolti sono stati sottoposti a due tipi di
analisi. Dapprima è stata predisposta una analisi qualitativa del
contenuto, fondata sull'individuazione di una serie di parolechiave e di concetti alla base delle diverse retoriche utilizzate per
la "fabbricazione" e la caratterizzazione dei profughi kosovari. Ci
si è concentrati sull'analisi delle definizioni ricorrenti, sulle
strategie di sovra- e sotto-rappresentazione degli attori coinvolti
(universalizzazione della vittima, personalizzazione degli attori
coinvolti, animalizzazione degli individui, ecc.), del genere di
avvenimenti in corso (per esempio, "massacro", "genocidio",
"pulizia etnica", "Olocausto") e dei nessi causali alla base delle
spiegazioni offerte per gli eventi stessi. Ha fatto seguito una
analisi del discorso mediale (Bell e Garrett [eds.] 1998;
Fairclough 1995), non solo per individuare con più precisione le
strategie discorsive in atto nei testi, ma anche per poter analizzare
gli aspetti grafici e le immagini, che fanno parte integrante
dell'attività di framing dei giornali.
bambini nati durante l'esodo o in un campo di accoglienza.
L'identità di profugo viene generalmente applicata loro in maniera
automatica, e soprattutto i giornali sviluppano numerose storie
intorno al nesso "attribuzione del nome"/"attribuzione di
identità". Mai come in questo caso, nei racconti mediatici della
guerra del Kosovo, l'essere profugo sembra divenire un'essenza.
Infine, un frame interessante che riguarda il costituirsi
dell'identità di profugo è la procedura di "disumanizzazione" alla
quale il profugo viene più volte sottoposto. Le descrizioni
dell'esodo, con tutti i particolari più ripugnanti che questo ha
comportato, tendono a definire i kosovari con termini e modi che
di umano non hanno più nulla. L'essere profugo tende così a
scomparire senza però confluire nuovamente in una definizione
generica di "essere umano", bensì verso il suo opposto: la
completa realizzazione dell'identità di profugo è quella, inumana,
di una "non-persona" (Dal Lago 1999).
Profughi o militanti? Il problema del rapporto tra profughi in
fuga e militanti dell'Uck fa la sua prima comparsa sul "Corriere
della Sera" il 30 marzo, quando la narrazione della tragedia
kosovara era iniziata da poco:
“Villaggio dopo villaggio il Kosovo si svuota. La guerriglia
implora: "Non fuggite, fate il gioco dei Serbi, restate e combattete
per la nostra terra"”
2. Il labile confine dell'essere profugo
La "conquista" dell'identità di profugo è uno dei frames più
frequentemente utilizzati dalla stampa durante il conflitto
balcanico. Cosa sia o cosa non sia un profugo è argomento che, a
seconda dei diversi livelli di interpretazione, può sembrare di
facile risoluzione o frutto di una complicata osservazione. Il
"grado zero" dell'essere profugo, almeno al livello del senso
comune, sembra essere quello costituito dall'equazione "kosovaro
in fuga dalla guerra = profugo". In questo caso sono considerati
profughi tutti gli abitanti del Kosovo che, in seguito alle
persecuzioni di Milosevic o ai bombardamenti Nato, si trovano a
fuggire dalle loro terre in via provvisoria o definitiva.
Questo primo livello di interpretazione è però destinato a
complicarsi quando sulla scena fanno la loro comparsa i
guerriglieri dell'Uck: sono profughi o no? I membri dell'Uck
condividono con l'interpretazione che abbiamo definito primaria
del profugo il loro essere abitanti del Kosovo e l'agire in
conseguenza della guerra in corso, tuttavia non cercano di
scappare, bensì si armano e provano a scacciare i Serbi mediante
azioni di guerriglia. Inoltre essi non osservano passivamente la
fuga dei loro concittadini ma provano in vari modi ad arruolarli
nelle loro file, secondo alcuni articoli anche in modo violento.
Un altro aspetto connesso al frame della costruzione dell'identità
del profugo è la questione se tutti possano diventare profughi
oppure no, se qualsiasi individuo, indipendentemente dalla
propria collocazione socio-professionale, sia a rischio di
degradazione. Saranno pubblicati vari articoli che mostreranno,
con un certo stupore, come anche i membri di alcune rispettabili
professioni (medici, studenti, avvocati) possano avere o abbiano
di fatto subito la degradazione a profugo.
Questione ancora connessa con l'identità di profugo è quella dei
La presentazione dei profughi come una massa compatta di
persone che non possono avere la forza di combattere subisce
qualche modifica con un articolo comparso sempre sul "Corriere
della Sera" il 3 aprile:
“E i profughi sognano la "bella Italia" ma qualcuno vuole tornare
a combattere”
L'articolo che segue è una lista di varie storie raccolte tra i
profughi che attendono di raggiungere l'Italia, ma, a differenza del
quadro delineato dall'articolo precedente, si stacca qui una voce
dal coro: qualcuno ha ancora la forza e la rabbia per tornare a
combattere:
“Ma non tutti pensano all'Italia. Angelina ha 30 anni, è
magrissima e nervosissima: "L'Italia? Macché. Io tra 10 giorni
torno in Kosovo. Quelli ci hanno tolto tutto: case, uomini, soldi,
identità. Se davvero tutto è perduto, allora tanto vale imbracciare
il mitra e spendere la vita per la patria. Anche se io sono una
donna. Qui siamo già un centinaio pronti a farlo."” (corsivo
nostro)
Il "Corriere della Sera" si occupa dell'Uck anche il giorno
successivo al precedente articolo, e anche questa volta qualcosa
cambia nella definizione e nella connotazione dell'attività dei
guerriglieri kosovari:
“Applaude anche la strana, piccola folla di guerriglieri Uck
24
ACHAB
[Esercito di Liberazione del Kosovo] che si danno un gran da fare
a istituire posti di blocco sulla strada che scende da Kukes
(l'appello: "Che fate? Non scappate, arruolatevi nel nostro
esercito di liberazione"), a controllare che non si infiltrino Serbi
tra i profughi, ma non muovono un dito per aiutare i compatrioti
rimasti senza nulla.”
("Il Corriere della Sera", 4 aprile).
dalla "Stampa" del 7 aprile, con il seguente titolo:"Ero avvocato a
Pristina, in 36 ore ho perso tutto".
L'articolo è una descrizione dettagliata della vita di questo
avvocato, prima e dopo l'inizio delle ostilità. La differenza che
passa tra un avvocato kosovaro e un altro proveniente, per
esempio, dall'Unione Europea, è messa subito in evidenza
all'interno dell'articolo:
Qui la definizione dell'attività dei membri dell'Uck subisce una
netta inversione di rotta. Innanzitutto i membri dell'Esercito di
Liberazione del Kosovo sono definiti una "strana, piccola folla"
come se si trattasse di uno sparuto gruppo di saltimbanchi, poi
però il paragrafo finisce con una precisa accusa nei loro confronti:
essi non farebbero nulla per aiutare i loro compatrioti. Da quello
che viene detto in questo articolo sembra quasi che i membri
dell'Uck godano di uno status nettamente superiore a quello dei
loro concittadini in fuga; quantomeno se essi non aiutano "i loro
compatrioti rimasti senza nulla" si può supporre che ai guerriglieri
qualcosa sia rimasto.
La questione della bontà o meno dell'Uck ritorna da protagonista
sulle pagine del "Corriere" il 27 aprile. All'interno del giornale
troviamo un breve articolo dove si discute della liceità del tipo di
arruolamento tenuto dai membri dell'Esercito di Liberazione.
L'articolo è interessante anche perché è centrato sull'analisi delle
modalità con cui i media statunitensi stanno diffondendo
l'immagine dei guerriglieri:
“I sette anni trascorsi in Gran Bretagna, a partire dal '90, l'avevano
convinto di non essere tanto diverso dagli altri europei della sua
generazione.” (ibidem)
Dallo stralcio sopra riportato sembra non esserci nulla da fare: se
nasci in un paese debole anche la tua identità è destinata a essere
debole, la pelle dello stato è la tua pelle:
“Nel giro di 36 ore Besnik era diventato un profugo. I suoi beni
si riducono a quello che ha sulle spalle, più un sacchetto di
plastica.” (ibidem, corsivo nostro)
La disavventura occorsa a Besnik è presentata con i caratteri
dell'inesorabilità: in sole 36 ore egli ha cambiato identità, è
diventato un profugo.
Un articolo che presenta la storia di un professionista che ha
subito il processo di degradazione a profugo è pubblicato anche
da "Repubblica"; questa volta si tratta di un dentista. L'articolo
riproduce sostanzialmente gli argomenti e i toni di quello riportato
precedentemente. L'attenzione verso l'origine socio-economica
dell'intervistato è però forse qui addirittura maggiore, soprattutto
quando viene descritta la moglie del dentista:
“Arruolamenti forzati, critiche ai kosovari. Un alleato scomodo. I
media americani stanno cambiando rapidamente il tenore degli
articoli dedicati ai guerriglieri dell'Uck. Dopo un generale
sostegno agli insorti kosovari, sono cominciate critiche e
segnalazioni sui lati oscuri della resistenza antiserba. Ieri il
Washington Post ha dato ampio spazio agli arruolamenti forzati
che l'Uck effettua tra i profughi, costringendo tutti gli uomini tra
i 18 e i 30 anni a raggiungere i campi di addestramento.”
("Il Corriere della Sera", 27 aprile)
“La moglie di Ekrem ascolta, ha un bel viso, anche lei è laureata,
porta piccoli orecchini, veste una felpa color arancio con una
scritta enorme: Versace. È la mia felpa, precisa con orgoglio.
Frammenti di un passato sereno. La macchina, lo studio
dentistico, una bella casa al centro di Mitrovica, i vestiti, gli
orecchini” (ibidem)
L'articolo riflette perfettamente l'immagine data all'Uck da tutti i
media durante il conflitto: dopo una iniziale presentazione
favorevole (i membri dell'Uck vengono spesso presentati come
emuli dei partigiani italiani) subentra un periodo dove iniziano i
dubbi sulla reale "bontà" dell'Esercito di Liberazione del Kosovo,
dubbi che verso la fine delle ostilità si tramuteranno quasi in
certezze sulla sua natura negativa.
Questo passaggio suggerisce un'osservazione che vale anche per
l'articolo precedente. Per quanto sembri non esserci nessuna
difesa contro la perdita dell'identità precedente e l'acquisizione
dello status di profugo, vi è qualche piccola differenza se a
perderla è una persona dalla provenienza sociale elevata. La
moglie del dentista è, nel momento in cui è intervistata, a tutti gli
effetti una profuga, ma la sua descrizione non coincide con quella
in genere riservata a tutte le sue "colleghe" di provenienza sociale
inferiore. Nella descrizione di queste ultime in genere si sprecano
gli aggettivi denigratori: le donne profughe stanno per diventare
animali e ne hanno tutte le caratteristiche. La moglie del dentista
riesce invece ad avere ancora un bel viso, e continua a vestirsi
bene (ricordiamo che la moglie del dentista è in questo momento
in una colonna di profughi, e ha un maglione Versace). Sembra
quasi che, se su un piano generale la pelle dello stato è anche la
tua pelle, e quindi la tua identità avrà la stessa sorte politica della
Profughi di classe. Il secondo frame preso in considerazione
riguardo all'identità del profugo è quello che concerne la
presentazione della possibilità di diventare profugo
indipendentemente dallo stile di vita precedente al conflitto.
Come si vedrà, la stampa tende spesso a sottolineare con un certo
stupore come anche persone dalla collocazione socioprofessionale molto rispettabile abbiano subito questo processo di
degradazione senza riuscire a opporre a esso molte resistenze.
Il primo articolo che si incentra su questo argomento è presentato
25
ACHAB
tua nazione, su un piano più particolare una componente
essenziale nella formazione dell'identità sia costituita dall'origine
socio-economica, e quindi anche se la tua pelle seguirà quella
dello stato parte di essa continuerà a differenziarsi da quella di
quelli meno fortunati di te. Secondo questo frame, l'origine
sociale è una sorta di crema antirughe per la pelle della
personalità.
neonati profughi lo dimostra un articolo de "Il Giornale" del 15
maggio. Addirittura qui il problema conduce a una decisione del
parlamento federale americano:
Nomi e identità. Durante tutto il corso dell'esodo dei profughi vi
è stata notevole attenzione alla diffusione di notizie riguardanti
nascite durante la fuga o mentre la madre era assistita in un campo
profughi. Al di là del fatto - ascrivibile alla "logica dei media" che avvenimenti come nascite o altro riguardanti i bambini
attirano generalmente l'attenzione dei media, possiamo notare
come in questo caso parlare del parto di una profuga kosovara
rappresenti l'occasione per i giornali analizzati di effettuare
digressioni sulla questione dell'identità di profugo.
Quanto sia labile il confine che definisce l'identità di una persona
in una situazione complessa come quella dell'esodo kosovaro
emerge già analizzando un articolo pubblicato dal "Corriere della
Sera" il 10 aprile:
L'articolo presenta numerosi suggerimenti che utilizzeremo per
provare a trarre le conclusioni sull'argomento dei nascituri
kosovari, per cui vale la pena di riportarlo quasi per intero. La
vicenda prende spunto, come si evince fin dal titolo, dalla nascita
del primo profugo kosovaro nato sul territorio americano. Non è
difficile intuire come questo bambino si possa chiamare:
“Frontiere Usa chiuse alle partorienti. Dopo la nascita del primo
kosovaro-americano, gli Stati Uniti temono l'"invasione" dei
neonati profughi.”
“America ce l'ha fatta. Il problema ora sono i suoi fratelli, tanti,
una fila lunghissima, tutti pronti a partire. America ha un paio di
giorni; concepito in Kosovo, è venuto al modo a Fort Dix, New
Jersey, Stati Uniti. America, appunto. Proprio come vorrebbe
chiamarlo suo papà […]. Nemmeno il tempo di respirare che
America, come vuole la legge degli Stati Uniti per chi là nasce, è
diventato cittadino americano, col passaporto quello vero, l'aquila
stampata, iunaitidstatsofamerica […]. La mamma ha mentito sui
tempi della gravidanza: ai funzionari americani che a Scopje
reclutavano i profughi da imbarcare verso la vita, ha giurato di
essere al sesto mese. Mai l'avrebbero presa a bordo se avessero
saputo che i mesi invece erano nove […]. Certo, da portare per
tutta la vita America è impegnativo come nome, in ospedale sono
impazziti tutti provando a indovinare il futuro del nascituro: "chi
lo sa che cosa accadrà a questo bambino, magari potrà diventare
il futuro presidente degli Stati Uniti" […]. Ma per chi sta ancora
nella pancia delle mamme profughe la vita (nel senso più puro del
termine) si fa dura perché l'amministrazione Clinton, temendo
l'invasione delle partorienti, ha limitato e limato gli ingressi: d'ora
in poi nessuna donna oltre al sesto mese di gravidanza potrà
partire dai Balcani con direzione Stati Uniti […]. A sentire la
portavoce dei "centri per il controllo delle malattie" di Atlanta, la
limitazione non è dovuta al timore di un invasione di kosovaroamericani, ma alla necessità di prevenire rischi per le donne e per
i feti: "Dobbiamo partire dal presupposto che quando dicono di
essere al sesto mese di gravidanza sono in realtà al nono, d'ora in
poi le inseriremo quindi nella categoria di chi ha bisogno di
assistenza immediata e dunque non potranno affrontare il
viaggio". Sono problemi che riguardano solo i fratelli di America,
lui ormai ce l'ha fatta. Proprio uno nato con la camicia. Anzi col
passaporto.” (ibidem)
“Dopo la fuga è nato Italo, sotto una tenda ma senza culla”.
L'articolo si apre quasi subito indicando come la sorte giuridica
del nascituro sia dovuta ad una serie di fortunose circostanze:
“Il neonato ha sangue kosovaro, è nato in territorio albanese, ma
è italiano di diritto. E anche nel suo fortunato tempismo. Se
avesse tentato di venire al mondo 24 ore prima, sarebbe
probabilmente morto con la mamma durante il parto. Se ci avesse
provato una settimana prima, difficilmente sarebbe sfuggito alla
strage degli innocenti. Ma Italo Bajgore, un giorno di vita, tutto
questo lo saprà solo fra qualche anno.” (ibidem)
Quanto Italo sia stato fortunato lo si può maggiormente
apprezzare confrontando la sua storia con quella di Atdhetare,
raccontata dal "Corriere della Sera" appena due giorni dopo quella
di Italo, il 12 aprile:
“Atdhetare è rimasta sola. È il simbolo della tragedia. Una bimba
di 18 mesi è stata trovata nei pressi del campo di Kukes ed è stata
adottata da una famiglia di rifugiati. L'hanno chiamata Atdhetare
Kosova, che significa "nazione Kosovo". Le autorità stanno
cercando i suoi parenti.”
Nel racconto del "Corriere", Atdhetare non ha avuto la fortuna di
Italo. Lei non è riuscita a nascere in un qualche campo allestito da
un paese membro dell'alleanza. A lei non tocca nessun diritto, per
lei niente "Itala", ma un nome che tenderà a costringerla ad
assumere il più profondamente possibile l'identità che
rappresenterà per lei la prima causa di emarginazione e di
esclusione.
Quanto sia importante per la stampa italiana l'argomento dei
In questo articolo sono presenti alcuni dei "panici morali" più
diffusi riguardo a immigrazione e possibili invasioni dall'esterno.
Per descrivere il possibile arrivo in America di donne kosovare
incinte vengono usati termini degni dei film di fantascienza anni
'50, come "l'invasione delle partorienti" o "l'invasione dei neonati
profughi". Nell'ondata di paranoia che sembra colpire
l'amministrazione Clinton, così come ci viene raccontata quasi
26
ACHAB
che, se su un piano generale la pelle dello stato è anche la tua
pelle, e quindi la tua identità avrà la stessa sorte politica della tua
nazione, su un piano più particolare una componente essenziale
nella formazione dell'identità sia costituita dall'origine socioeconomica, e quindi anche se la tua pelle seguirà quella dello stato
parte di essa continuerà a differenziarsi da quella di quelli meno
fortunati di te. Secondo questo frame, l'origine sociale è una sorta
di crema antirughe per la pelle della personalità.
"Stampa" vi è il primo piano di una mano che ha già ricevuto il
timbro, sul "Corriere della Sera" la foto ritrae proprio
l'apposizione del timbro. Questa la didascalia:
Disumani. Passiamo ora ad analizzare l'ultimo dei frames che
incorniciano la definizione mediatica dell'identità dei kosovari in
fuga; esso riguarda la procedura di disumanizzazione alla quale
essi vengono sottoposti dai media. Il kosovaro in fuga rischia
seriamente di perdere l'identità umana sia per una questione
giuridica - egli infatti viene spesso privato dei documenti che
attestino la sua identità e questo lo fa automaticamente diventare
un clandestino, una persona che per definizione non gode degli
stessi diritti degli altri esseri umani (Dal Lago 1999) - sia per la
difficoltà a rispettare i parametri culturali, tra i quali potremmo
inserire la pulizia, un aspetto curato, un contegno, tutti aspetti che
definiscono una persona come civile.
L'esodo dei profughi ha l'aspetto di una tragedia umana fin dai
primi giorni in cui viene riportato dai giornali. L'accento sulle
condizioni bestiali in cui i kosovari sono costretti a vivere viene
messo maggiormente in luce però verso la fine di marzo, quando
in pochi giorni su quasi tutti i quotidiani presi in considerazione
compaiono foto che ritraggono profughi ammassati in una calca
infernale per cercare di ottenere qualche pezzo di pane ("La
Stampa", 3 aprile; "Il Corriere della Sera", 31 marzo e 3 aprile; "la
Repubblica", 3 aprile). La rappresentazione di queste persone in
una lotta serratissima per la conquista del cibo induce
immediatamente a pensare che queste abbiano perso gran parte
delle caratteristiche che connotano in genere una vita civile.
L'attività della ricerca del cibo è infatti comune sia agli uomini sia
agli animali, e vedere i profughi concentrati in branchi come degli
avvoltoi per la conquista del cibo più semplice e più antico
dell'umanità dà un colpo decisivo alla dignità degli esuli. Articoli
incentrati sulla nutrizione dei profughi faranno infatti più volte la
comparsa nei quotidiani da noi analizzati, come quando "Il
Corriere della Sera" del 18 aprile titola:
"La Stampa" ha una didascalia più lunga, con un titolo
riassuntivo, e che tenta già nel suo esiguo spazio di trarre alcune
conclusioni dalla vicenda mostrata:
“un bimbo kosovaro la mano della madre segnata con un timbro
da un militare tedesco prima della partenza dal campo profughi di
Stenkovac per la Germania. Molti rifugiati sono stati trasferiti in
altri paesi.”
“Il timbro per la salvezza. Questo marchio impresso sul dorso
della mano di una profuga kosovara vale un passaggio aereo per
la Germania, cioè per la libertà. Nel campo di Petrovic,
Macedonia, i tedeschi hanno aperto un posto di raccolta con un
cartello che dice: "Se volete andare in Germania venite qua". Una
via di uscita, sia pure momentanea, dall'inferno della precarietà,
dalla coda per il rancio, dalla scabbia, dal tutto che si è perso. Ma
il significato di quel timbro resta: è un passaporto per la salvezza,
però certifica la condizione disperata di un deportato. Una
diaspora che sarà difficile curare.”
"La Stampa" mostra quindi come la procedura della timbratura
"certifichi" la condizione di un deportato. La didascalia mette
però anche in evidenza come il profugo vivesse già in una
condizione prossima all'animalità: i rifugiati fanno la coda per "il
rancio", sfuggono dalla scabbia, e hanno perso tutto. È curioso
che l'unica condizione indicata che permetta loro di riacquistare la
dignità di persona debba passare attraverso una certificazione
della perdita della stessa: solo attraverso l'infamante timbro essi
potranno ottenere il lasciapassare per la Germania, dove è la loro
identità umana potrà essere riguadagnata.
Se le testate considerate si pongono in antitesi rispetto a questo
processo di disumanizzazione, in alcuni casi è tuttavia possibile
osservare come il discorso mediatico ricorra a retoriche che
sortiscono lo stesso effetto. È il caso, ad esempio, di questo titolo
di "Repubblica" del 31 marzo, che introduce la notizia del
tentativo da parte dei serbi di eliminare sistematicamente le tracce
dell'identità dei kosovari distruggendone i documenti:
“Otto giorni per aiutare dei bimbi che mangiano foglie.”
“Tra i disperati di Kukes senza più patria né nome. Un fiume di
profughi continua a riversarsi in Albania. Al confine i serbi
sequestrano i documenti (corsivo nostro).”
Un'altra modalità con cui i profughi subiscono un trattamento di
disumanizzazione che sconfina nell'animalizzazione è quello
della marchiatura. Tanto "La Stampa" (il 9 aprile, in prima
pagina) quanto il "Corriere della Sera" (l'11 aprile, sempre in
prima pagina) pubblicano una foto emblematica: l'apposizione di
timbri sulle mani dei profughi, con marchiata una cifra che servirà
come garanzia di riconoscimento per poter lasciare il Kosovo. La
procedura di assegnare una cifra a ogni uomo e di timbrargliela
addosso non può non far venire alla mente i tatuaggi effettuati dai
nazisti sugli internati nei campi di concentramento. Le foto
riportate dai due giornali sono lievemente diverse: mentre sulla
I serbi quindi, sequestrando i documenti, tolgono "patria e nome"
ai kosovari, i quali si trovano sottoposti a un processo di
spersonalizzazione che rende anche ai giornalisti molto più facile
trattarli come cose indistinte. Non è un caso che proprio
nell'articolo (scritto peraltro con tono drammatico e con una forte
empatia nei confronti dei kosovari) i profughi vengano comunque
definiti un "fiume", trasformando cosi dei singoli esseri umani in
un unico e indistinto fenomeno naturale. Non è certo questa
27
ACHAB
l'unica occasione in cui l'esodo dei profughi è stato paragonato a
un "fenomeno della natura": durante il corso del conflitto l'esodo
è stato descritto usando paragoni con tutti i più noti fenomeni
naturali, di terra, di cielo e di mare. Il ricorso a metafore "naturali"
per descrivere tragedie così drammaticamente umane nasconde
un uso del linguaggio tipicamente ideologico: le tragedie naturali
non hanno responsabilità, e spesso non è possibile neanche porvi
rimedio.
Concludiamo l'analisi del frame della disumanizzazione dei
profughi riportando alcuni casi che comprendono descrizioni di
avvenimenti che, per la loro stravaganza, sembrano tragicamente
surreali. Il caso più eclatante in questo senso è quello presentato
dal "Corriere della Sera" del 30 marzo. In un articolo dedicato alla
descrizione dei kosovari in fuga si legge:
della stessa), porta con sé un bicchiere, naturalmente del colore
più degradante e ridicolo per un uomo, e non si dimentica di
portare con sé un'autoradio (forse il particolare più ridicolo;
l'oggetto più caro ma di scarsa utilità) di una marca
completamente sconosciuta. Anche l'articolo di Giuseppe
Zaccaria pubblicato da "La Stampa" del 4 aprile contiene
osservazioni degradanti nei confronti dei profughi:
“Un ragazzo, che ieri mattina abbiamo intercettato a Geziq sui
primi convogli della lunga colonna, pur di andarsene si è messo le
scarpe della sorella, qualche centimetro di tacco.”
I rifugiati sono qui dei "disgraziati che continuano a fare oscena
mostra di sé"; il giornalista così riesce a dare sia l'idea di quanto
debbano essere ridotti come bestie i kosovari, e inoltre suggerisce
una sorta di colpa degli stessi nel fatto che essi non nascondano la
loro miseria; essi, appunto, "continuano a fare oscena mostra di
sé". Che queste persone non abbiano ormai nessuna delle
caratteristiche dell'umanità è sottolineato anche dal fatto che essi
hanno dei "padroni", come se fossero merci o animali da pascolo.
Inoltre la loro odissea è completamente inquadrata dal nostro
punto di vista: la loro tragedia è anche un po' la nostra tragedia;
essi con la loro "oscena mostra di sé" tendono fastidiosamente a
ricordarci che la guerra non è "un gioco né un film". In
conclusione, poi, la più grande ammissione della loro riduzione a
uno stato infantile: saremo infatti noi capaci di "prendercene
cura"?
Anche "la Repubblica" si segnala per un framing improntato sulla
degradazione simbolica degli esuli kosovari. Si veda questo titolo,
apparso il 7 aprile:
“I disgraziati che continuano a fare oscena mostra di sé nella valle
del Blace stanno per cambiare un'altra volta padrone. Prima
ostaggi dei serbi, poi dell'Uck, adesso questi sventurati della
storia ci piombano addosso, quasi a ricordarci come la guerra non
sia un gioco né un film. Volevamo proteggerli, in teoria: invece li
abbiamo devastati. Adesso siamo in grado di prendercene cura?”
La descrizione dei profughi è tanto più inverosimile quanto più si
consideri il seguente articolo, pubblicato dal "Corriere" l'8 aprile:
“Le valige dei rifugiati: un tappeto, la sveglia, due orecchini
Chi si è salvato è riuscito a portare con sé poche cose. Un uomo
è arrivato calzando le scarpe col tacco della figlia. Sevdir Rudaj,
43 anni, di Zur, che lunedì 29 marzo era nella prima ondata scesa
dal nord, non ha avuto neanche il tempo di infilare qualcosa ai
piedi: su un camion verde e senza targa la strada l'ha fatta tutta
con cinque centimetri di tacco, le scarpe blu di sua figlia. Sevdir
possiede solo la giacca nera che indossa, la camicia marrone, i
pantaloni a righe e quel paio di scarpe, ridicole e tragiche.”
È quasi incredibile che nello spazio di otto giorni si siano
presentati agli occhi di due giornalisti italiani due profughi, prima
un bambino e poi un adulto, calzando le scarpe col tacco di una
piccola bimba. Va aggiunto che l'articolo è pieno di termini
degradanti per i rifugiati. Solo nel pezzo citato, infatti, il
particolare del camion senza targa viene aggiunto apparentemente
solo per aumentare il senso di precarietà della fuga; e, come se
questo non si notasse già da sé, il giornalista ha attribuito una
qualità illuminante alle scarpe calzate dall'uomo in fuga:
"ridicole". Ma anche nel prosieguo dello stesso articolo troviamo
altre descrizioni ambigue: i profughi sembrano aver compiuto
l'esodo portando con sé gli oggetti più inutili e disparati, quasi
disponessero di una borsa alla Mary Poppins riempita con lo
spirito di un Peter Pan. Il caso più vistoso è forse quello di
“L'Europa in soccorso dei più deboli”.
La cornice generale è ben delineata: non vi è dubbio su chi siano
i più deboli. All'interno dell'articolo si possono trovare i già visti
paragoni tra persone e merci:
“Gli elicotteri e gli aerei […] torneranno indietro carichi di
persone dopo aver scaricato viveri, medicinali e attrezzature di
accoglienza. Centinaia di tonnellate all'andata, centinaia di
persone al ritorno.”
Nella totale equiparazione tra le persone e le merci si consuma la
totale espropriazione delle qualità umane dei profughi.
“Kak Aslani, 40 anni, di Suhareka: due pentole di stagno ancora
incrostate di cibo, una sveglietta al quarzo, un bicchiere di
plastica rosa, l'autoradio Xherdet.”
3. Profughi kosovari e profughi serbi
Il problema riguardante l'attribuzione delle responsabilità
dell'esplodere del conflitto è stato molto dibattuto. Connessa con
questo argomento è la discussione su chi siano le vere vittime del
conflitto. Se infatti a prima vista le vittime parrebbero essere
facilmente individuabili negli esuli kosovari, la situazione viene
Questo signore, secondo il giornalista, sarebbe in fuga con due
pentole "ancora incrostate di cibo", una "sveglietta" (il poveretto
non potrà permettersi neanche una sveglia ma solo il diminutivo
28
ACHAB
presto definita in maniera più problematica; le vittime del
conflitto potrebbero anche essere i civili serbi, vittime incolpevoli
dei bombardamenti Nato. In realtà questo tipo di argomento viene
soprattutto proposto verso la fine del conflitto, quando sembra
essere ormai chiara la vittoria alleata e il ritorno dei profughi in
Kosovo rende più visibile il problema dei serbi che erano rimasti
a vivere là, e che ora si trovano ad aver perso una guerra e a essere
in minoranza nei confronti dei kosovari di ritorno.
Connessa con questa problematica vi è anche la già vista
ambiguità del ruolo dell'Uck che verso la fine del conflitto viene
ad assumere, almeno sulla stampa italiana, una connotazione
nettamente più negativa. L'Uck, divenuto il villain della
narrazione dei media, sembra poter ripercorrere tutte le
nefandezze compiute dai miliziani serbi nei confronti dei kosovari
albanesi sui civili serbi, rischiando di farli diventare profughi.
Il problema della possibilità del "divenire profugo" anche per i
cittadini serbi inizia a delinearsi sulle pagine del "Corriere" il 9
aprile. Fa qui la comparsa il primo articolo, seppure breve,
interamente dedicato alle possibili conseguenze della guerra per i
cittadini serbi. È sempre in questo articolo che troviamo per la
prima volta l'espressione "profughi serbi", destinata a diventare
più frequente con il trascorrere del conflitto.
profughi albanesi. Interessante è anche notare come, nell'ultima
considerazione del giornalista, sembra che lo status di profugo
possa agire talmente in profondità da cancellare altri tipi di status
comunitari, come quelli di etnia e nazionalità. L'essere profugo
fornisce una nuova identità comunitaria che riesce, almeno in
periodi eccezionali come quello di una guerra, a soppiantare
completamente identità comunitarie più stabili e istituzionali
come appunto quelle di nazionalità ed etnia.
Più passa il tempo e più il fenomeno dei profughi serbi diventa
una indiscutibile realtà mediatica; ancora "Il Corriere della Sera"
del 24 aprile torna sull'argomento, iniziando però qui a tracciare
alcune sensibili differenze tra la condizione dei profughi kosovari
e quella dei serbi:
“I cinquanta disperati serbi tornano a Sarajevo tra i nemici”.
All'interno dell'articolo, che parla appunto del rientro di un
gruppo di profughi serbi nella regione di Sarajevo, si trovano
alcuni aggettivi usati per la descrizione dei serbi che non fanno
mai la loro comparsa negli articoli dedicati ai loro "colleghi"
kosovari:
“Saranno una cinquantina i serbi, nella mattinata nuvolosa di
Vraca, dignitosi nei loro cappotti scoloriti, coi loro capelli grigi,
troppo vecchi e stanchi per sorridere. In fila ordinata lungo la
staccionata di ferro che costeggia il viottolo.” (ibidem, corsivo
nostro)
“"Anche noi, serbi, in fuga per paura delle bombe". "Non
capiamo Milosevic ma anche la Nato che lancia missili sui civili
è colpevole."”
L'articolo mette più volte in risalto la sorpresa di trovarsi per la
prima volta ad avere che fare con dei profughi non albanesi:
Dunque i profughi serbi riescono ancora a essere "dignitosi" e si
dispongono in "fila ordinata" per ricevere i documenti. Negli
articoli che abbiamo più volte citato, dedicati ai profughi
kosovari, difficilmente abbiamo trovato termini come questi: i
kosovari in fuga sembravano essere nettamente più sporchi e più
a rischio di animalizzazione. Nell'articolo è presente anche una
foto che ritrae una fila di serbi che attende il rilascio dei
documenti, e in effetti i profughi serbi sembrano essere molto più
composti di quelli kosovari; quello che non è ancora dato di
sapere è se questa differenza segna una diversa provenienza
sociale dei due popoli oppure una marcata differenza culturale.
Alla fine di aprile la situazione è ormai molto chiara; si capisce
che anche i civili serbi stanno vivendo la loro tragedia e che anche
loro sono spesso diventati profughi. Questo nuovo frame viene
esemplarmente definito dal "Giornale", che il 30 aprile titola:
“Sono scappati dalle bombe, ma non sono kosovari. Sono serbi
[...]. Vengono da Belgrado e, come gli altri serbi, vengono
guardati un po' come i "diversi" del centro di accoglienza, che
ospita quasi cinquecento persone: kosovari, ma anche curdi,
montenegrini, rom, asiatici [...]. L'arrivo dei profughi serbi ha
anche creato qualche attenzione in più da parte dei nostri ministeri
dell'interno e della difesa, per i quali i cittadini della Repubblica
guidata da Slobodan Milosevic devono essere, in questo
momento, "osservati speciali" [...]. "La nostra tragedia è uguale a
quella kosovara. Ci chiediamo perché, se il problema è Saddam
Hussein, si bombardano gli iracheni. E, se il problema è
Milosevic, si bombardano i serbi". Per un momento, etnie e
nazionalità non se le ricorda più nessuno.” (ibidem)
Da quanto si evince dall'articolo i serbi corrono il rischio di
diventare non solo profughi, ma addirittura profughi di seconda
categoria. Se, infatti, gli altri tipi di profughi presenti nel centro di
accoglienza provengono da "etnie" considerate come
"perseguitate", i serbi sono l'unico popolo che arriva nei campi
con lo statuto di aggressore, e infatti vengono guardati come i
"diversi" del campo. Inoltre essi, come viene precisato
nell'articolo, verranno trattati dalle nostre autorità come dei
"sorvegliati speciali", e quindi difficilmente godranno di quella
presunta simpatia di cui nello stesso momento stanno godendo i
“Serbi e albanesi profughi assieme. In un campo ungherese
rifugiati kosovari e disertori jugoslavi convivono senza problemi.
"Non c'è astio tra noi, la colpa è di Milosevic". Soltanto in bagno
e davanti alla televisione si litiga. E i bambini giocano alla
guerra.”
L'articolo che segue è pieno di considerazioni molto interessanti
per la definizione di questo frame:
“Vivono assieme in armonia. Sono serbi di Serbia, albanesi del
29
ACHAB
Kosovo, ungheresi della Vojvodina, afghani e armeni. Ma prima
di tutto sono profughi, e i profughi sono tutti uguali [...]. Alla
toilette gli albanesi non usano carta igienica ma l'acqua di una
bottiglia appoggiata di fianco al water. Serbi e ungheresi
protestano. Il direttore del campo, Bela Szekeli, non ci fa caso:
"Sono problemi marginali, dipendono da differenze culturali e
non da cattiveria od odio. Gli albanesi sono generalmente meno
esigenti sull'igiene, anche dei bambini".”
("Il Giornale", 30 aprile, corsivo nostro)
Troviamo qui nuovamente formulata l'idea che la "cittadinanza
profuga" riesca a cancellare e soppiantare gli altri tipi di
cittadinanze. I profughi sono appunto prima di tutto profughi e
questa loro nuova identità cancella il loro essere precedentemente
serbi, albanesi o ungheresi. Secondo questo articolo inoltre vi
sarebbe una differenza sostanzialmente culturale tra l'essere
profughi albanesi oppure serbi e ungheresi: gli albanesi sono
culturalmente predisposti a essere più sporchi e quindi potrebbe
essere questo il motivo per cui le descrizioni delle carovane di
profughi kosovari tendono a essere più denigranti di quelle serbe.
Questa ipotesi si integra e può anche soppiantare quella della
differenza di provenienza socio-economica, che avevamo visto
nelle pagine precedenti.
Tuttavia, come si è detto, è con il finire delle ostilità che il
dramma delle popolazioni civili serbe si rende chiaramente
visibile. Con il ritorno dei kosovari nelle loro terre il problema di
come verranno trattati i serbi rimasti risulta evidente, soprattutto
tenendo conto che insieme ai profughi kosovari torneranno anche
i miliziani dell'Uck, che sono ora rappresentati dai media in
maniera molto più ambigua. Tra i motivi che fanno sì che ora al
dramma dei serbi venga data più pubblicità c'è anche la ragione
che, a guerra ormai vinta, non si rendono più necessarie quelle
forme retoriche che prima venivano quotidianamente usate per
definire i serbi, militari e non. Ora, infatti, non c'è più bisogno di
censurare le sofferenze che il popolo serbo è stato costretto a
subire dai bombardamenti Nato, e l'attenzione si può anche
spostare sull'apertura di un nuovo fronte della sofferenza.
Il primo articolo che inaugura questo nuovo frame compare su "la
Repubblica" l'11 giugno:
“Kosovo, serbi in fuga dalla città fantasma. Il ritiro comincia da
Podujevo, partono più di duemila soldati. Anche i civili preparano
le valigie: "Senza l'esercito e la polizia, in poche ore ritornano gli
uomini dell'Uck. Sono già sopra le colline".”
Inizia quindi la fuga anche per i serbi; e, anche per i serbi iniziano
a comparire espressioni prima usate solo per i kosovari: la città
dalla quale fuggono è ormai una città fantasma, come "fantasmi"
erano stati definiti talvolta i kosovari dalla stampa italiana.
Nell'articolo compare anche una foto che ritrae una carovana di
serbi in fuga, a imitazione delle carovane di profughi kosovari che
si vedevano solo pochi giorni prima.
Il giorno dopo "la Repubblica" torna ancora sull'argomento,
dedicandogli questa volta un'intera pagina, la dodicesima:
“Nella culla del mito serbo il terrore degli sconfitti. Il luogo
simbolo del nazionalismo aspetta "l'invasore". Ma il vero incubo
è l'Uck.” (12 giugno)
Il testo dell'articolo riproduce poi sostanzialmente quello
dell'articolo pubblicato il giorno prima, e anche qui compare una
foto che ritrae una carovana di serbi in fuga. Ma
l'esemplificazione più evidente del passaggio di consegne tra
l'essere profugo kosovaro e l'essere profugo serbo viene fornita
sempre dalla "Repubblica" dello stesso giorno, due pagine dopo.
Nella pagina campeggiano due foto che mostrano due colonne di
profughi in fuga. Le fotografie sono quasi completamente
identiche: stessa angolazione per l'inquadratura, stessi mezzi di
trasporto usati per l'esodo. In questo modo si rende evidente
l'unica differenza sostanziale tra le due foto: la prima ritrae
profughi kosovari e la seconda profughi serbi. Il parallelismo è
evidenziato anche dalla precisa scansione temporale che compare
nelle relative didascalie:
“Gli albanesi: 30 marzo 1999. Quasi tre mesi fa iniziava la fuga
dei kosovari di origine albanese. Una fuga che via via assumeva
le dimensioni di un esodo: il terrore della pulizia etnica aveva la
meglio sull'angoscia di abbandonare la propria casa.”
“I serbi: 12 giugno 1999. Sui trattori, ieri, c'erano i serbi: eccoli
su una strada vicino a Pristina, stanno lasciando il Kosovo.
Abbandonano le loro case, non vogliono aspettare l'arrivo delle
truppe Nato.”
L'articolo tenta di descrivere lo stato di estrema confusione che
sembra dominare ora in Kosovo:
“L'ultima vendetta dei serbi: in fuga bruciando i villaggi. Il
giorno del grande caos: il giorno in cui nessuno sa più chi
comanda; il giorno in cui mentre la Nato ammonisce l'Uck a
mantenere la tregua, l'Uck avvisa i serbi via internet: finalmente
saprete cosa è la pulizia etnica [...]. Insieme ai militari se ne vanno
molti civili serbi - inconsueto spettacolo balcanico di macchine e
trattori gremiti di persone e di masserizie.”
La situazione è quindi ormai molto precisa: in uno scenario di
grandissima confusione i serbi hanno ormai acquistato tutte le
caratteristiche tipiche dell'essere profugo: fuggono gremiti su
trattori, portando con sé delle masserizie che tanto ricordano le
pentole ancora incrostate di cibo che già avevamo visto portarsi
dietro gli esuli albanesi. Una differenza tra le due fughe viene
invece rimarcata nell'ultimo articolo che verrà da noi preso in
considerazione riguardo a questo frame. Compare su "la
Repubblica" del 14 giugno:
“L'esodo dei civili serbi: "L'Uck ci da la caccia". Almeno 10000
profughi attraversano il confine con Serbia e Montenegro, fra
loro anche i soldati. A differenza degli albanesi, viaggiano in
grandi gruppi con le auto cariche di mobili, elettrodomestici,
30
ACHAB
alcuni portano addosso anche armi. La scena della fuga non
commuove i profughi albanesi ancora in Montenegro in attesa di
rientrare in Kosovo: "Noi siamo stati costretti a uscire valicando
le montagne, con metri di neve e l'esercito che ci sparava addosso
- racconta Enver Balaj, profugo a Rozaje - nessuno spara a questa
gente, nessuno stupra le loro donne, nessuno li sta spingendo
via".”
È soprattutto nel processo di "disumanizzazione" che si può
osservare l'aspetto più caratteristico del framing della stampa
italiana relativamente ai profughi del conflitto in Kosovo:
privando questi individui dello status di persone, e trasformandoli
in non-persone (da aiutare - da preservare), si ottengono
contemporaneamente l'effetto di legittimazione dell'intervento
"umanitario" da una parte e quello di "allontanamento" dall'altro,
per cui sarà più facile negare l'accesso entro i nostri confini a
quelle che, dopotutto, non sono neanche "persone". Va notato,
peraltro, come anche la televisione abbia insistito su questo frame
della degradazione dei profughi: una ricerca condotta sulla
copertura televisiva del conflitto in Kosovo (Pozzato [ed.] 2000)
mostra come la maggior parte dei telegiornali italiani abbiano
usato un framing del tutto simile, e straordinariamente uniforme.
Il discorso vale per quasi tutte le testate telegiornalistiche: "in
generale, il Tg2 racconta moltissime storie di profughi, in rapida
successione: anche questo è un modo sottile di degradare le
persone, annullando le loro sofferenze e le loro esperienze in una
serialità distratta. Il Tg5 sottolinea il degrado con toni allarmistici,
paventando epidemie, osservando che i bambini kosovari che
arrivano ai campi non sono mai stati vaccinati in vita loro […].
Anche il Tg3, che sottolinea sempre lo sforzo umanitario, non
tralascia di mandare in onda servizi in cui i profughi sono ritratti
in condizioni di vita miserevoli" (ibidem, 133). L'aspetto
problematico che viene posto dagli autori della ricerca, e che può
essere posto in relazione alle narrazioni e alle immagini che
abbiamo visto essere riportate anche dai giornali italiani, è questo:
In conclusione, sembra dunque che tra la rappresentazione
mediatica dell'esodo degli albanesi e quella dell'esodo dei serbi
siano presenti analogie e differenze. Sono analoghe le modalità
della fuga, e analoghi sono i rischi di perdita di identità ai quali i
profughi vanno incontro. La maggiore differenza viene invece
presentata come una diversità nel contegno che riescono a
mantenere le due "etnie" in fuga. I serbi sembrano riuscire a
mantenere caratteristiche più umane mentre gli albanesi le
avevano perse pressoché totalmente. I motivi suggeriti dalla
stampa sono fondamentalmente tre. Il primo motivo si concentra
sulla differenza culturale: i serbi sarebbero tendenzialmente più
portati a mantenere condizioni di pulizia e igiene personale più
alte; il secondo motivo si rifà alla diversa provenienza sociale: i
serbi in fuga non proverrebbero dalle stesse categorie socioeconomiche degli albanesi, i serbi sono più ricchi, più colti e
quindi mantengono un più alto standard di dignità; il terzo motivo
infine porta alla luce la diversità strutturale del contesto in cui si
verifica la fuga: mentre gli albanesi erano pressati da ogni parte,
la fuga dei serbi avviene in condizioni nettamente migliori, senza
eserciti che corrano loro dietro e senza il reale rischio di manovre
di pulizia etnica attuate nei loro confronti.
“il problema, in tutti questi casi, non è quello di raccontare il vero
o il falso. È senz'altro vero che i bambini che vivono nelle
campagne kosovare non vengono regolarmente vaccinati, che la
malavita è molto forte in Albania e in tutti i paesi dell'est europeo,
che i campi profughi erano maleodoranti, che la gente arrivava
sporca, stracciata e forse anche incapace, per la stanchezza e i
traumi subiti, a collaborare con gli operatori per l'organizzazione
e la pulizia dei campi. Il problema è semmai questo: le televisioni
di tutto il mondo, in nome di un malinteso diritto di cronaca,
avevano il diritto di mostrare al mondo intero queste persone in
condizioni di degrado così estreme? La telecamera che
pretendeva di additare alla pietà non avrà in realtà finito di
compiere un'opera di spoliazione della dignità?” (ibidem, 134).
4. Le cornici della sofferenza
L'analisi dei processi di framing da parte della stampa italiana che
abbiamo presentato in questo articolo mostra con una certa
evidenza come il frame primario che ha incorniciato tutte le varie
cornici secondarie sia quello legato all'identità dei profughi,
soprattutto nel senso di una sua sostanziale indeterminatezza - nel
migliore dei casi - e degradazione - nel peggiore. È sufficiente
ripercorrere i diversi frameworks incontrati nelle pagine
precedenti per vedere come nella stampa italiana si sia assistito a
un significativo, ma non così paradossale, fenomeno di
schizofrenia nella definizione dei soggetti provenienti dalle zone
del conflitto: sono profughi o militanti? Sono tutti dalla parte
della ragione? È evidente come tali ambiguità nella definizione e
nell'incorniciamento dei principali attori della narrazione
mediatica del conflitto in Kosovo si leghino allo stretto rapporto
tra le istituzioni mediali e quelle politico-militari: nel momento in
cui le ragioni della "guerra umanitaria" prevalevano su quelle,
interne, del controllo dei flussi migratori, la maggior parte dei
giornali si è mostrata propensa a una definizione "umanitaria" dei
profughi, mentre quando, verso la fine del conflitto, è stata
l'"emergenza immigrazione" a dominare l'agenda politica,
l'ambiguità e l'ambivalenza con cui si definiva lo status
individuale, sociale e politico delle persone provenienti dalle zone
del conflitto erano maggiormente evidenti.
Si potrebbe aggiungere che il problema, in questo caso - e
naturalmente nel caso delle immagini e delle storie della stampa
italiana -, è che tale framing mediatico è del tutto funzionale alla
legittimazione delle "definizioni della situazione" fornite dalle
istituzioni politico-militari, e che le istituzioni mediatiche hanno
sostenuto con le loro "messe in chiave" che abbiamo visto nelle
pagine precedenti. Siamo in presenza, in questo caso, di quello
che Boltanski chiama "lo spettacolo del dolore", o, meglio ancora,
la "politica della pietà". Nelle parole di Boltanski (1993; trad. it.
2000, 17),
“una politica della pietà deve affrontare una doppia esigenza. In
31
ACHAB
quanto politica, mira alla generalità. Il suo ruolo è sottrarsi al
locale e, di conseguenza, alle situazioni, necessariamente locali,
nelle quali avvenimenti che suscitano compassione possono
prodursi. La politica può basarsi, per questo compito, su strumenti
d'equivalenza e, in particolare, su strumenti statistici. Ma nel suo
riferimento alla pietà non può affrancarsi completamente dal
presentarsi dei casi singoli. La generalità non ispira pietà.”
giornali, dei problemi di identità dei profughi), e che per questo
motivo vanno riportati entro categorie comunque conosciute,
anche se magari - al limite - non umane (si pensi alla
disumanizzazione).
In questo modo poco importa che la logica dei media persegua
questa "politica della pietà" mediante l'una o l'altra delle topiche
individuate da Boltanski, che siano quella della denuncia, quella
del sentimento o quella estetica: capita spesso che siano in
funzione, insieme o separatamente, tutte e tre, a incorniciare lo
spettacolo di una "sofferenza a distanza" (ibidem) che lega e
legittima reciprocamente le istanze umanitarie, le istituzioni
politico-militari e, in definitiva, anche quelle mediatiche.
Da questo punto di vista può essere utile, in conclusione, il ricorso
all'ipotesi dell'"effetto CNN" (Robinson 2002), ovvero l'ipotesi
secondo cui la copertura mediatica dello "spettacolo del dolore"
possa influire sulle decisioni di "intervento umanitario", o possa
quantomeno legittimarle. Tra i case studies presentati da
Robinson per discutere la propria ipotesi teorica compare anche la
guerra nel Kosovo, per la quale i dati parlano di una limitazione
dell'"effetto CNN": forse le immagini mostrate dai media non
hanno pienamente legittimato l'intervento bellico, ma sicuramente
hanno rappresentato un esempio di "manifattura del consenso"
(Herman e Chomsky 1988; Chomsky 1999), al cui interno le
narrazioni e le immagini della stampa hanno fornito un notevole
framework di empatia e di sostegno ai vari interventi legati alla
guerra nel Kosovo.
La "politica della pietà" non può realizzarsi che con la messa in
mostra - la messa in scena - di "corpi sofferenti e miserabili",
"trasportati in modo da colpire i sensi delle persone felici"
(ibidem); deve insomma mostrare la "sofferenza del corpo"
(Scarry 1985; trad. it. 1990) facendo di questi corpi sofferenti (e
del loro spettacolo) delle immagini e delle storie paradigmatiche.
In questo modo, quella che abbiamo definito nel primo paragrafo
come la "personalizzazione del dolore" diviene anche
"incorporazione del dolore"; e tuttavia, il rischio a cui si espone la
personificazione della sofferenza di un popolo è quello di un
effetto ambivalente: da una parte le "storie di vita" dei singoli
(come gran parte di quelle che abbiamo visto nei paragrafi
precedenti) "devono far risaltare la singolarità in modo da dare
corpo alla sofferenza"; dall'altra, scendere troppo nei dettagli
"rischia sempre di far precipitare nel locale. Ora, una politica
della pietà non sa che farsene di un infelice; di una situazione"
(Boltanski 1993; trad. it. 2000, 17-18). Di fronte a tale
ambivalenza si dipanano le logiche narrative e rappresentative
che abbiamo visto in opera in questo articolo: i corpi - più che
persone - sono quelli di individui di cui si mostra e si racconta la
storia, ma costituiscono anche degli exempla di tutte quelle storie
che non è possibile raccontare e mostrare. Di più: sono corpi che
vanno comunque definiti, non foss'altro che nella loro
indefinibilità (si è visto come spesso si pongano di fatto, per i
Note
1. I’articolo è frutto di una riflessione comune dei due autori. Tuttavia,
per questioni accademiche, devono essere attribuiti a Federico Boni i
paragrafi 1 e 4, e a Oscar Ricci i paragrafi 2 e 3.
Bibliografia
Bell, A. e Garrett, P. (eds.), 1998, Approaches to Media Discourse, Oxford, Blackwell.
Boltanski, L., 1993, La Souffrance à distance, Paris, Métailié; trad. it. Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica,
Milano, Cortina, 2000.
Chomsky, N., 1999, The New Military Humanism: Lessons from Kosovo, Monroe, ME, Common Courage Press.
Dal Lago, A., 1999, Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale, Milano, Feltrinelli.
Fairclough, N., 1995, Media Discourse, London-New York, Edward Arnold.
Herman, E. e Chomsky, N., 1988, Manufacturing Consent, New York, Pantheon.
McLuhan, M. e Fiore, Q., 1995, Guerra e pace nel villaggio globale, Milano, Apogeo.
Pozzato, M.P. (ed.), 2000, Linea a Belgrado. La comunicazione giornalistica in tv durante la guerra per il Kosovo, Roma, Rai-Eri,
Vqpt.
Robinson, P., 2002, The CNN Effect: The myth of news, foreign policy and intervention, London, New York, Routledge.
Scarry, E., 1985, The body in Pain. The Making and Unmaking of the World, Oxford University Press.
32
ACHAB
Fieldwork between Distance and Intimacy
Reflections on a Photo Exhibition on the Street
di Giovanni Picker
Gli elementi surrealisti dell'etnografia moderna tendono a essere misconosciuti da
una scienza che si considera impegnata a ridurre l'incongruità piuttosto che,
contemporaneamente, a produrla. Ma non ha forse ogni etnografo qualcosa del
surrealista, del reinventore e del rimaneggiatore di realtà? L'etnografia, scienza del
rischio culturale, presuppone una costante disponibilità a lasciarsi sorprendere, a
disfare sintesi interpretative e a valorizzare - quando si presenta - l'altro non cercato,
non classificato.1
Insomma la ricerca è una cosa troppo seria e troppo difficile perché ci si possa
permettere di confondere la rigidità, che è il contrario dell'intelligenza e
dell'invenzione, con il rigore, privandosi così delle svariate risorse che l'insieme
delle tradizioni intellettuali della disciplina [la sociologia] - e delle discipline vicine,
etnologia, economia, storia - può offrire.2
The bridge is beautiful with all those blue lights! But it is also
useless, or almost useless.
These words come from a Serbian girl. They can stimulate a study
about a research technique I adopted during my fieldwork in
northern Kosovo on the construction of ethnicity from the point of
view of the symbolic ties between two urban groups - the Serbian
and the Albanian communities in the city of Mitrovica - to the
urban space, cut off by a river.
The words of the girl refer to the new central bridge,
reconstructed by the Nato forces at the end of the war3, and which
has been since then the ecological ethnic border. The two
sentences she expressed are articulated on two different time
locations, or, more precisely, on an isochrony and on an
allochrony. With these two terms I refer to the verbal construction
of a time location where the object of the sentence is put in: in the
case of isochrony the time location coincides with that one of the
object enounced, while in the case of allochrony it does not4.
The heuristic validity of both propositions, concerning the study
at hand, comes from two analytical elements: first, the location of
the girl at the moment of speaking, and second, the relevant
relationship between isochrony and allochrony generally
perceived among the population, about the same object (the
bridge) at the moment in which the propositions have been said.
Regarding the first element, the girl was in front of a small photo
exhibition (later referred to as the Photo Exhibition) about the
history of the city, set up on the streets and close to an important
crossroad, not far from the bridge. The relevance generally
perceived of the relationship between isochrony and allochrony
generally perceived has been amplified during the last few years,
when the city changed from a situation of complete mixité social,
to another one of ecological division, managed by administrative
and military dispositives, of which one of the main one is the new
bridge "with all those blue lights".
Consequently, if "the river is beautiful with all those blue lights"
refers to the present, "But it's useless, or almost useless" implies
that it does not answer - in the speaker's eyes - to the functions it
is supposed to have (i.e. to be crossed) and which, in her
contemporary historical context, belong to future and stable
conditions of ethnic cooperation and cohabitation, or, of course,
to a past in which those conditions were part of the everyday life.
Thus, we can presume a symbolic tie between the bridge and her
history/future, and, in addition to other opinions about the same
issue, we can build up a picture of the ethnic "sense" of belonging
to the urban territory/space.
Keeping together these two elements, isochrony and allochrony,
seems to be the condition sine qua non of any ethnography on the
construction of memory.
In this paper I attempt to do a reflexive exercise about the
experience of the Photo Exhibition, considering "reflexivity" as
an "empirical" mean, as described by Michael Herzfeld: "The
most useful kind of reflexivity is not that of pure selfexamination, but the kind that places the cultural assumption of
the ethnographer in question - that clarifies the ethnographic
encounter and its limitations as predicated upon the imperfect
meshing of two different codes, with its multiplicity of divergent
identities and presuppositions. This kind of reflexivity is
genuinely empirical (but not empiricist), and it is deployed to a
specific purpose, that of intensifying […] the analysis"5. Thus, I
will mostly not concentrate on my stereotypes, my "feelings" or
"emotions" - although I will start from a self-examination - but
33
ACHAB
rather on the social and theoretical conditions laying at the base of
my practical decisions and of my assessments.
I will proceed step by step, following a gradual construction of
increasing specificity until the bottom (or what seems to me to be
the most problematic aspect) of the issue at hand.
Setting up a Photo Exhibition
What did I want to know during my fieldwork? The
epistemological assumptions behind my research moved from the
recent turns in the anthropological debates, where the matter of
the "native point of view" has been critically questioned, and the
issue of the ethnographer's position has become central in each
ethnographical activity6. The need to adopt such a perspective
came also from the political need, in modern anthropology, to
deconstruct the discourse about the "Other", which historically
gave birth not only to falsifications and to historical mistakes, but
also to real myths and "truths", such as, in my case, the
"Balkanism", as described by Maria Todorova7. In this
perspective, since identity is a multifaceted concept, in which
local, regional and religious elements are at stake, to give voice to
the social actors about their own local past could be a reflexive
activity for the researcher "to do a theoretical elaboration that,
through the experience of a third world made by dialogues, raises
with the name of culture"8, and at the same time, to see "identity
ethnographically, [which] must always be mixed, relational, and
inventive. […] [To see that] identity is conjunctural, not
essential"9. Moreover, another political need in modern
anthropology, is to consider as central the role of the relations
between the state (and other local or supra-national political
powers) and the "production of localities" and identities10. Thus,
ties between people's memories and their own connections with
political powers were as much noteworthy in my research. In that
specific topographical context, moreover, I would have searched
a connection between three main elements: first the urban space,
second the military, political and administrative local powers, and
third, identity - all of these through the construction of a shared
memory on the urban space.
During the first weeks of my fieldwork, I started to have
conversations with citizens, sharing time sitting in coffee bars, in
their homes, or in their offices. I was often invited to feel myself
at ease, knowing that what I was doing was a very interesting
thing for me, since Mitrovica is a city full of fascinating aspects,
not least its past. Especially with people of a certain age, seeing
their city nowadays divided and full of international
administrators and militaries, I was often told, with deep feelings
and emotions, "how it once was beautiful". With people of my
age, young workers or students, I was surprised when they
pointed their finger to a photographic book about Mitrovica's
history I was carrying in my hands, saying: "I never saw this
building at that time!" "Here is my home now, I didn't know how
my block looked like at that time!"
From these spontaneous comments, I asked my informants to help
me let people look at their past. I was persuaded that in so doing,
I would have stimulated a less accessible area of their minds:
memories of their past in the city. Since I was starting from the
identitarian association between people and territory - here
between people and urban space - collecting memories about this
association as remembered from the past, could have offered me
a diachronical view of the ethnicity process.
Without concentrating myself on specific topics, I would have
paid attention, through a participant observation with my
translator/informant, to the comments of people, trying to conduct
them to speak about the group living on the other side of the river,
and of the bridge, and more generally to pay attention to
expressions underlying a "We", or "The Serbs"/ "The Albanians",
a "They"11. The two wooden panels were tied together, so that four
screens were set on, seventeen photos were put on them (photos
of buildings and churches/mosques, but not chosen ad hoc) and
on the upper side a little label with the title "Old Mitrovica". One
of the screens was dedicated to the central bridge, and simply
entitled "Bridge", with four photos - in this case chosen ad hoc of the different bridges since the end of the XIX century. On the
screen aside I provided a little note book on which people were
invited to answer to a question written above: "Which are the
meanings you attribute to the river and to the bridge?"
Once my collaborator and me finished assembling the exhibition,
we put it in the middle of two main crossroads of the city, one in
the southern side, and one in the northern one. Each setting lasted
one week, comprising of three types of research: participant
observation, semi-structured interviews, and auto-writing
opinions; all with "casual" pedestrians interested in the exhibition.
I started by concentrating on participant observation: all day long
out on the streets waiting, observing, and when possible, talking
with whoever was looking at the exhibition. But always with a
little copybook and a pen in my hands, long hair, clearly being a
western stranger, I was not following Erving Goffman's idea of
"getting data by subjecting yourself, your own body and your own
personality, and your own social situation, to the set of
contingences that play upon a set of individuals, so that you can
physically and ecologically penetrate their circle of response to
their social situation, or their ethnic situation, or whatever. So that
you are close to them while they are responding to what life does
to them"12. Moreover, the questions I asked were mainly generic
and very "journalistic": "What do you think about the new
bridge?" "How have the topographic alterations within the city
changed your everyday life?".
This did not allow me to deeply participate in their sights and
comments concerning the photos; on the contrary, I remained
"outside" in a difficult position: attempting to catch discourses
and observing practices in a public space of intense pedestrian
traffic. I only collected general impressions:
Before the construction of Gazi Voda [a dam built up in the early '70s]
the river was wonderful. Citizens of Mitrovica didn't go to the seaside,
because they could swim into the river. The water had much more
phosphorus; today I'm scared to swim in it. (Southern part)
It was at this level that urban history entered people's answers: an
34
ACHAB
everyday space of living, cast into a past which was being
constructed without any strong feeling of belonging, nor an accent
on cultural difference or identity. One could have argued that the
everyday people's needs and priorities were different, that the
attention was much more focused on local contingencies, rather
than on general structures of senses, and thus, that the two
ecological elements were part of a material representation, rather
than a symbolic one13.
But even with these differences, my problem still remains:
opposite to the spontaneous comments about the urban history I
had collected by going along with my photographic book, in front
of the exhibition my informants expressed "public" opinions, and
not "private" feelings connected to the past. What does that
"everything" of the last sentence mean?
Two aspects of this problem need to be analysed: first, myself (I
appeared more as a journalist than as an ethnographer15), and
second, the practices of the pedestrians, and the impact of that
Exhibition in the public space, on the everyday walks of people,
in terms of shared cognitive perceptions and spatial practices.
The bridge is the same as it was before. Anyway, I use the footbridge [a
little one, build up close to the central bridge]. (Southern part)
Distance
I will start with Michael Herzfeld's idea of "the formative
character of the field". He explains that the ethnographer has to
learn from the field, and to take into account the "local
understanding"; thus, "To acknowledge the formative character of
the field with respect to anthropological knowledge [...] is to
realize that one works not with informants, but with cointerpreters"16. In order to set up the exhibition I started my social
relations with my two "collaborators", one in each side of the city,
asking them for logistic support and help, both in translating and
doing interviews. "The social intimacy of the field situation Herzfeld argues later on - the source of anthropologist's earliest
and most fundamental reflexivity - permits a critical investigation
of the cultural intimacy of the State and other supra-local
entities"17.
This lack of intimacy came from the fact that I did not consider
my informants as co-interpreters, but merely as supportive
helpers, or subjects whose voice and practices were to be
recorded. Practical reasons were at the base of this "missing": lack
of time, troubles with the author's rights of the photos,
and the fact that the street was an extremely "cold"
setting, which did not allow me to let people stop for a
long time, and thus to create together an adequate
situation in order to "penetrate the circle of responses" in
the Goffmanian sense.
All in all, what I was doing was neither a simple
classical sit-down interview, or a "nosing around" - as
urban ethnography, since the "beginning", seems to keep
on doing18, - or a "going-along"19.
I was searching closeness while receiving only distance.
How can this problem be further critically faced?
Trying to go deeper in the analysis, I will refer to Pierre
Bourdieu's idea of "distance" in terms of "representations", or
"perceptions". In his words, "it is in effect only through measuring
the extent and the character of the distance between the objective
of the enquiry as perceived by the respondent and as viewed by
the investigator, that the latter can attempt to reduce the resulting
distortions"20.
The particular setting of the exhibition generated a break in the
normal walks of citizens along their city. More explicitly in the
southern part, the little show was an attraction (the local Albanian
TV channel - TV Mitrovica - dedicated a program to that!) that
I am a fisherman. The river is important for me. I am still fishing. There
are more fishes in the river now, because Trepca [a mine at the periphery
of the city] closed. I feel very good when I go near to the river. I do not
care about the bridge. I'm not interested to go to the south. I'd like less
people in the south. If we try with some mixing they will be violent again.
And they will success to have a Kosovo without Serbs. (Northern part)
The general impression was that in the north side the two
ecological elements had a function (barrier, and often a national
barrier), thus that the meanings related to them were been
transfigured from a material level to a symbolic one, representing
security, national borders, and thus territorial belonging.
Even by analyse the discursive constructions of isochrony and
allochrony in both communities, it is evident that those locations
do not have a relevant qualitative meaning, since the contents of
those answers are mainly generic and not intimate. The only
Time locations of the river and of the bridge14
North
Blue: Past & Present
Red: Past
Green: Present
South
Violet: Past, Present and Future
Yellow: Present & Future
Bright Blue: Future
significant element is the perception of contingency much more
present in the northern part.
I left my house in the other side 15 years ago. The bridge means
everything for me. (Southern part).
35
ACHAB
was always, in the case of the viewers, a cause of deep feelings of
nostalgia and curiosity. Sometimes it brought up disputes around
historical events, or different opinions about an actual topic.
Viewers were thus interested at different levels, but always
watching at the photos with a visible attempt to recall a forgotten
past.
The urban landscape that constituted the ecological framework
within which the Exhibition took place was characterized, in both
parts, by a fast growth of new buildings, together with a radical
renovation of the streets21. This evident element contributed to
underline the exceptional character of an exhibition about urban
history in that place, and thus to increase the "break" in the normal
walks along the city.
If I consider this particular physical and cognitive setting of the
exhibition, I can isolate a decisive attribute of my behaviour
during the exhibition: I was not watching the photos; thus, I was
not doing the same thing as my
informants were doing, as it
happens in each interview (where
both the interviewer and the
interviewee speak and listen to each
other), but also in a "classical"
Photo Elicitation study. We were not
looking together at the same thing,
but, rather, I was "watching them
watching", and, after that, I asked
them their opinions, thoughts and
memories. In this sense, the photos
were explicitly offered to their
vision. Moreover, the subjects of the Photo 1. The notebook hanging
on one of the screens
photos were regarding only them:
their history. This was the most explicit and important distance
between our two different representations, or definitions, of the
situations. This was as truer as in the particular case of the
notebook, on which people were invited to express themselves
and to answer to the question written above (See Photo 1).
first used by John Collier in 195724, during a research within an
interdisciplinary project on the relation of environment to mental
health. The experiment resulted in very useful terms of
stimulation of emotional statements about informants' lives. This
text, re-published in 1967, and 1986, has become the "basic" text
about photo-elicitation.
From Collier's experiment, many others followed (see Table. 1)
and there are stories similar to my experience of "spontaneous
comments" from which the researcher decided to adopt such
method25. But, generally, what all these studies share is precisely
the deep conviction that "photo elicitation [can] be regarded as a
postmodern dialogue based on the authority of the subject rather
than the researcher"26. Furthermore Harper explains, "This
procedure is fuelled by the radical but simple idea that two people
standing side by side, looking at identical objects, see different
things. When a photo is made of that shared view, the differences
in perception can be defined, compared and eventually
understood to be socially constructed by both parties"27.
Thus, it can be said that this method has a potential as long as used
for sharing photos with informants. And this was, as we saw, not
my case.
And, in the case of memory and identity - as Sarah Pink
underlines, describing a researcher visiting a photo exhibition
together with her informant - the use, in terms of material setting
and decisions taken by the researcher, is as fundamental as "a
collaborative research [that] allowed her [the researcher] and her
informant to work together to create a particular version of the
past that extended beyond the limitations set by linearity of a
verbal or textual narrative"28.
Some empirical final reflections on the exhibition can now be
made. The first is related both to the pictures themselves I chose,
and to the issue of asymmetry: in that social and political
situation, putting old photos of the buildings together with those
of the bridge (and even four of the bridge) has probably been too
rash; and maybe too ambiguous. I imposed a discourse not only
showing photos, but also selecting specific photos (in the case of
the bridge), and putting them together with photos not chosen ad
hoc. In the case of photo elicitation studies this fact never
happens. Eventually, it would have been better to make an
exhibition only about the bridge, or another about the urban space,
but without any emphasis to the bridge. This would have
improved a bit the reciprocity between the informants and myself.
A second consideration can be related to my behaviour, far from
being, as we saw, an attempt to penetrate the circle of responses.
Living my interpreters alone in front of the exhibition, asking
them to do what they thought the best way IN ORDER to go in
deep with the dialogues. Then talking with them, in order to
discuss together the quality of the work, could have also been an
interesting way to build up together, as co-interpreters, a final
account.
About Photo Elicitation
This observation makes the issue of asymmetry arise. Indeed,
when I "started the game" I was in a higher place within the social
hierarchy of different types of "capital", especially of cultural
capital in terms of non-involvement in the practical and economic
needs22. Thus, I aimed "to reduce as much as possible the
symbolic violence which is exerted through the effects [of this
asymmetry]"23 by using photographs. I showed them photographs
from the archives (this was my assumption - their own
photographs, not taken by me) in order to create a common
platform, were asymmetry would have been reduced. But this
asymmetry did not leave the context, of course, since there was
almost no social intimacy between my informants and me.
This is a crucial point. In fact, if we look at the literature about
"photo-elicitation", we discover exactly the potential to give
authority to the informants and not to the researcher.
There is a large literature about this research technique. It was
Towards a critic of the sight as the main research sense
Attempting to follow the initial definition of reflexivity adopted
by Herzfeld, if I look at the "cultural assumptions" behind my
36
ACHAB
Photo Exhibition, I would formulate one of them - probably the
most critical - as follows: Photography is the closest form of
representation to reality, that allows the researcher to stay out of
the construction of opinions and meanings. Following Bourdieu,
comme des choses?"33.
Following the concern of "distance", my research activity was a
peculiar type of this objectifying, that Herzfeld comments on as
"a strong sense of inequality of us studying them, that objectifies
"natives" as specimens rather than as colleagues in a negotiation
of potentially shared understandings. This, obviously, does not
mean that "we" should stop looking at "them", but that we should
use our understanding of how this came to be viewed as a simple,
commonsensical operation in order to trace its limitations [...]"34.
As discussed previously, the "visual" sense was the guiding one in
my Photo Exhibition, since no deep dialogue was present, and
since participant observation did not work out. If we follow
Herzfeld again,
"[...] Because the social use of photography makes a selection from the
field of the possible uses of photography, structured according to the
ordinary vision of the world, the photographic image can be seen as the
precise and objective reproduction of reality. But, in a deeper level, only
in the name of a naive realism can one see as realistic a representation of
the real which owes its objective appearance not to its agreement with the
very reality of things (since this is only ever conveyed through socially
conditioned forms of perception) but rather to conformity with rules
which define its syntax within its social use, to the social definition of the
objective vision of the world; in conferring upon photography a
guarantee of realism, society is merely confirming itself in the
tautological certainty that an image of the real which is true to its
representation of objectivity is really objective"29.
"Because visual idioms of representation have become quite literally the
common sense of the modern, industrial world, they have also become
relatively invisible - a revealing metaphor in itself. Resemblance is
usually constructed as a resemblance of visible form. Anthropologists
have not proved immune to this normalization of the visual. It is
noteworthy that even thought - or, indeed, because - visualism has so
fully displaced other sensory preoccupation in the representational
practices of anthropology, however, the discipline has only recently
produced a correspondingly intense analytical concern with visual media,
although the situation is now beginning to change"35.
I could remain outside of the context; I could simply record
opinions and images, as much as those pictures simply recorded
reality, and old realities, thus memories. Memories, in my eyes,
were cast into the pictures.
This assumption deals not only with the photos themselves, but
also with a more general approach of fieldwork, which has its
roots in the history of anthropology, as a product of "western"
intellectual tradition.
Anthropological discourse in the last decades has proceeded not
only to put light on the construction of myths and historical
rhetoric, but it has also denounced, "How anthropology makes its
object". The work of Johannes Fabian Time and the Other30 can
be seen as one of the major contributions to the deconstruction of
this "objectifying" of the other. His deep analysis of the
assumptions that since the 17th century are at the base of
reflections on the nature of knowledge (since Descartes' res
cogitans versus res extensa, throughout the empiricist
philosophers), shows how "the visual sense" historically imposed
itself as the primary means of knowledge. This "nobility" of the
"sight" was directly connected to the emphasis put on "geometry",
intended as spatial-graphic conceptualisation, as the best method
to communicate knowledge. Anthropology has inherited - and
revitalised - this tradition with the result of putting the cultural
"other" in another, old time - what Fabian calls allochrony,
denying him/her the contemporaneousness with the ethnographer
and his society.
Thus, we can say that distance in terms of this anthropological
reflection directly deals with the "visualist" methods researchers
adopt during their fieldwork31, and becomes natural: Fabian writes
in this light about visualism as an "ideological predisposition"32.
The result, in many ethnographical accounts is the objectifying of
the other, because "at the moment in which the origin of
knowledge is thought to be firstly a visual perception of objects in
space, why should it be a scandal to approach the other - an other
society, an other culture or other classes within the society itself -
In my understanding, this does not imply that we must refuse
visual tools or methods, but that we profoundly need to be aware
of the origins of our ideas and epistemologies laying at the base
of the "discursive truths" we keep on producing.
And, again, this issue - distance - cannot be reduced to a simple
critic of visualism as an ideology. Bourdieu, for instance, sees
distance not as a problem, but as a necessary balance between the
engagement of the researcher and the need to be reflexive during
an observation or an interview36.
My distance, in terms of representations of the situation, was
mainly due to the epistemological and cultural assumptions
behind my use of photography. Deep and thin, centred in the
visual sense, a distance which no thick description at the moment
of "being there" - immediately, or soon after, during my evenings
at home in Mitrovica - would have been able to disclose.
Acknowledgement
Helpful revisions and comments of this paper have been provided
by Hanna Harris, from the University of Helsinki, and Fabio
Quassoli, from the University of Milan Bicocca. I want to thank
them.
Notes
1
J. Clifford, The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography,
Literature, and Art, Cambridge, Cambridge University Press 1988 (quotation
from the Italian translation, 1999, 176).
37
ACHAB
2
P. Bourdieu, L. J. D. Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie
réflexive, Paris, Editions du Seuil 1992 (quotation from the italian translation,
1992, 179). In this paper I will take suggestions from authors coming from
different disciplinary traditions (as proposed by Bourdieu), such as
anthropology, sociology and ethnology, and create a dialogue among them on
their most significant common point, "fieldwork".
3
By "war" I refer to the Nato bombing against the Federation of Yugoslavia
in spring 1999.
4
I refer here to the essay by Johannes Fabian, Time and the Other. How
Anthropology makes its Object, New York, Columbia University Press 1983,
where the author speaks about allochrony in another sense. I will follow later
his proposal of considering allochrony as a critical procedure within the
anthropological literature.
5
M. Herzfeld, Epistemologies, in Id, Anthropology. Theoretical Practice in
Culture and Society, Malden-Oxford, Blackwell 2001, 45-46.
6
For a general (but deep) description of such turns, see F. Rahola, Pratiche
etnografiche e sapere antropologico, in A. Dal Lago, R. De Biasi (eds), Un
certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale, Roma-Bari, Laterza 2002,
27-53.
7
M. Todorova, Imagining the Balkans, New York, Oxford Univesity Press
1997.
8
U. Fabietti, Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione, RomaBari, Laterza 1999, 45 (my translation).
9
J. Clifford, The Predicament of Culture, 10-11. As commented by Ger
Duijzings, in Kosovo, as in many of the adjacent areas, identity and ethnicity
are not only contested imagined realities, politically constructed during the
past, and continuously in the present, but also recently subjected to
simplifications, reductionist interpretations, and used as mediatic and
political tools to describe and explain the acts of violence. See G. Duijzings,
Religion and the Politics of Identity in Kosovo, New York, Columbia
University Press 2000, 18 and further.
10
See A. Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimension of
Globalization, Minneapolis-London, University of Minnesota 1996; M.
Herzfeld, Orientations: Anthropology as a Practice of Theory. In Id,
Anthropology, esp. 10-15. These relations are central in studies on
nationalism and ethnicity: see for instance the case of Macedonia in the
recent works by K. Brown, The Past in Question. Modern Macedonia and
the Uncertainties of Nation, Princeton, Princeton University Press 2003, and
P. Vereni, Vite di confine. Etnicità e nazionalismo nella Macedonia
occidentale greca, Roma, Meltemi 2004.
11
I was inspired by a European study on "border identities" carried out in
2002 on divided cities at the border of Europe: A. Galasinski, C. Rollo, H. U.
Meinhoff, Urban Space and the Construction of Identity on German-Polish
Border, in Meinhof U. H. (ed), Living (with) Borders. Identity Discourses on
East-West Borders in Europe, Sydney, Ashgate 2002, 120-145.
12
E. Goffman, On Fieldwork, in "Journal of Contemporary Ethnography",
July 1989, 125.
13
This was in fact the most critical point in the comparison between the local
(rather material) and the international (symbolic) representations of the river
and of the bridge. Significant to this point is the film by Danis Tanovic, No
Man's Land (Bosnia 2001).
14
Results from the discursive analysis of all the answers recorded.
15
Who is the ethnographer? This question cannot have an automatic answer.
His identity during the fieldwork is always a result of a dialectic of
representations. See U. Fabietti, Antropologia culturale, 65-66.
16
The idea of "intimacy" has been underlined by Jenkins in order to go
beyond the dualist positions of anthropologist vs. indigenous subject of
anthropology: "[They] are engaged in the same kind of project, exploring and
constructing that world; and, most importantly, language and understanding
are equally features of this world, participating in these projects as they shape
behaviour and receive impressions.", T. Jenkins, Fieldwork and the
Perception of Everyday Life, in "Man", 29, 2, 1994, 434. Jenkins starts from
Bourdieu's idea of "A Theory of Practice" and goes beyond it, approaching
Herzfeld's conception of "A Practice of Theory".
17
M. Herzfeld, Epistemologies, 49.
18
See G. Semi, Nosing Around. L'etnografia urbana tra costruzione di un
mito sociologico e l'istituzionalizzazione di una pratica di ricerca. Working
Paper, Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Università degli studi di
M i l a n o : h t t p : / / w w w. s o c i o l . u n i m i . i t / p a p e r s / 2 0 0 6 - 0 2 22_Giovanni%20Semi.pdf.
19
See M. Kusenbach, Street phenomenology. The go-along as ethnographic
research tool, in "Ethnography", 4, 3, 2003, 455-485. She proposes a "goalong" with informants in their everyday walks along the city as a good
research tool in order to analyse some issues, such as spatial practices and
biographies.
20
P. Bourdieu, Understanding, in "Theory, Culture and Society", 13, 2, 1996,
19.
21
In the north part the exhibition was at a crossroad generally considered the
" centre " of Northern Mitrovica . There, the UN Administration painted two
building facades with fluorescent colours. Due to this fact, I was frequently
told "welcome to Disneyland".
22
See P. Bourdieu, Réponses, Italian translation, 60 and passim.
23
P. Bourdieu, Understanding, 19.
24
See J. Collier, Photography in Anthropology: A Report on Two
Experiments, in "American Journal of Anthropology", 59, 5, 1957, 843-859.
25
D. Harper, Talking About Pictures: A Case for Photo Elicitation, in "Visual
Studies", 17, 1, 2002, 15.
26
Ibid.
27
D. Harper, Talking About Pictures, 22.
28
S. Pink, Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in
Research. London, Sage 2001, 73.
29
P. Bourdieu, The Social Definition of Photography, in J. Evans, S. Hall
(eds), Visual Culture: a Reader, Sage, London 1999, 164 (my italic). Here
Bourdieu refers to the voice Photography in the Encyclopédie française,
where it is said that "The photographic plate does not interpret. It records. Its
precision and fidelity cannot be questioned".
30
See note 4.
31
Not only during fieldwork, since writing has as much this potential of
reification.
32
J. Fabian Time and the Other (quotation from the italian translation, 2000,
134). By the way, I see here a direct connection with an actual topic. The
event of the graphics about Mohammed published in September 2005 on a
Danish newspaper, and the protests that followed some months later
generating a global shock, have been commented, from this critical
perspective, by Federico Rahola, La serialità sfocata della guerra
permanente, in "il manifesto", 1.3.2006. His reflections about the way we
("Westerns") "look at" the war in Iraq (starting from a comparison between
the graphics of Mohammed and the photos of the tortures at Abu Ghraib)
reflects a racist logic, since racism is - also and mostly - a matter of "sight"
and "position". "We" took those pictures, and drew those graphics in a so
incommensurable, asymmetrical high, that we lost any sense of reality (and
of humanity), falling into the paranoia of speeches about human rights like
"the freedom of the press", or of our scandalized eye in front of tortured
victims.
33
Ibid, 144.
34
M. Herzfeld, Epistemologies, 35.
35
M. Herzfeld, Orientation, 16-17.
36
See P. Bourdieu, Understanding, 19. Here, it must be said, Bourdieu
merely speaks of interviews, and not of participant observation.
37
From D. Harper, Talking about Pictures, 16.
38
ACHAB
Appendix
Photo 2. The screen dedicated to the central bridge
("most" means "bridge" in serbo-croatian)
Photo 3. Another screen
Table 1. Photo Elicitation: forms and topics37.
Dissertations
Social class/social
2 (Guschker 2000;
Organization/family Sustik 1999)
Community
historical
ethnography
Identity/biography/
autobiography
1 (Sampson-Cordle
2001)
Books
Articles, reflections
larger studies
3 (Barndt 1980, 1990;
Bunster B. 1989)
2 (Collier 1957;
Guindi 1998)
2 (Calderola 1985; Steiger
1995)
2 (Harper 2001;
Schwartz 1992)
2 (Chiozzi 1989;
Rusted 1995)
6 (Orellana 1999; Suchar
1988, 1992; Suchar and
Rotenberg 1994; van der
Does et al. 1992; Wagner
1978)
3 (Harper 1987b, 1994;
Spence 1986)
7 (Blinn and Harrist
Clark 1999; Gold
Hethorn and Kaiser
Jansen 1991; Kenney
Smith 1999)
1 (Faccioli and
Zuccheri 1998)
Culture/cultural
studies
39
on Articles, research
described
ACHAB
fully
1991;
1991;
1999;
1993;
8 (Craig et al. 1997; Curry
and Strauss 1986; Harper
2000; Kretsedemas 1993;
Messaris and Gross 1977;
Snyder 1990; Snyder and
Ammons 1993; Stiebling
1999)
A. Social Organization /Social Class/Family
1. Sustik, Anne. 1999. "An auto-photographic, naturalistic investigation of the adjustment of refugees from the former Soviet Union
to Life in the United States" (dissertation).
2. Guindi, Fadwa El. 1998. "From pictorializing to visual anthropology" (report of completed research).
3. Steiger, Ricabeth. 1995. "First children and family dynamics" (article, first step of longitudinal study).
4. Calderola, Victor. 1985. "Visual contexts: a photographic research method in anthropology" (article; report of larger study).
5. Barndt, Deborah. 1980. Education and Social Change: A Photographic Study of Peru (book).
6. Bunster, Ximena. 1978. "Talking pictures: a study of proletarian mothers in Lima, Peru" (article; expanded and published as:
Bunster, Ximena, E. Chaney and E. Young. 1989. Sellers and Servants: Working Women in Lima, Peru, book).
7. Collier, John Jr, 1957. "Photography in anthropology: a report on two experiments" (reports on completed research).
B. Community
1. Sampson-Cordle, Alice Vera. 2001. "Exploring the relationship between a small rural school in Northeast Georgia and its
community: an image based study using participant-produced photographs" (dissertation) .
2. Orellana, Marjorie Faulstich. 1999. "Space and place in an urban landscape: learning from children's views of their social worlds"
(article).
3. Rusted, Brian. 1995. "Framing a house: photography and the performance of heritage" (article).
4. Suchar, Charles S. and Robert Rotenberg. 1994. "Judging the adequacy of shelter: a case from Lincoln Park" (article).
5. van der Does, Patricia, Sonja Edelaar, Imke Gooskens, Margreet Liefting and Marije van Mierlo. 1992. "Reading images: a study
of a Dutch neighborhood" (article).
6. Suchar, Charles S. 1992. "Icons and images of gentrification: the changed material culture of an urban community" (article).
7. Schwartz, Dona. 1992. Waucoma Twilight: Generations of the Farm (book).
8. Suchar, Charles S. 1988. "Photographing the changing material culture of a gentrified community" (article).
9. Wagner, Jon. 1978. "Perceiving a planned community" (chapter).
C. Historical Ethnography
1. Harper, Douglas. 2001. Changing Works: Visions of a Lost Agriculture (book).
2. Chiozzi, Paolo. 1989. "Photography and anthropological research: three case studies" (article).
D. Identity/Biography
1. Guschker, Stefan. 2000. "Picture world and reality of life - a sociological study about the role of private photos for the
meaningfulness of identity" (Ph.D. dissertation; in German).
2. Clark, Cindy Dell. 1999. "The autodriven interview: a photographic viewfinder into children's experience" (article).
3. Hethorn, Janet and Susan Kaiser. 1999. "Youth style: articulating cultural anxiety" (article).
4. Smith, C. Zoe and Anne-Marie Woodward. 1999. "Photo-elicitation method gives voice and reactions of subjects" (article).
5. Harper, Douglas, ed. 1994. Cape Breton, 1952: The Anthropological Vision of Timothy Asch (book).
6. Kenney, Keith. 1993. "Using self-portrait photographs to understand self-concepts of Chinese and American university students"
(article).
7. Gold, Steven J. 1991. "Ethnic boundaries and ethnic entrepreneurship: a photo-elicitation study" (article).
8. Jansen, Margriet. 1991. "Better little than too much" (article).
9. Harper, Douglas. 1987. Working Knowledge: Skill and Community in a Small Shop (book).
10. Spence, Jo. 1986. Putting Myself in the Picture: A Political Personal and Photographic Autobiography (book).
E. Popular Culture/Cultural Studies
1. Stiebling, Megan T. 1999. "Practicing gender in youth sports" (article).
2. Faccioli, Patrizia and Nicoletta Zuccheri. 1998. "The double vision of alcohol" (article).
3. Snyder, Eldon E. and Ronald Ammons. 1993. "Baseball's emotion work: getting psyched to play" (article).
4. Snyder, Eldon E. 1990. "Emotion and sport: a case study of collegiate women gymnasts" (article).
5. Curry, Timothy Jon and Richard Strauss. 1986. "A little pain never hurt anybody: a photo-essay on the normalization of sports
injuries" (article).
6. Messaris, Paul and Larry Gross. 1977. "Interpretations of a photographic narrative by viewers in four age groups" (article).
40
ACHAB
F. Cultural Studies: Reading Advertising Texts
1. Harper, Douglas and Patrizia Faccioli. 2000. "'Small silly insults', mutual seduction and misogyny: the interpretation of Italian
advertising signs" (article).
2. Craig, Robert, Philip Kretsedemas and Bruce Gryniewski. 1997. "Picturing African-Americans: readers reading magazine
advertisements" (article).
3. Kretsedemas, Philip. 1993. "Reading advertisements: race vs ethnicity?" (article).
G. Evaluation Studies
1. Tucker, Susan A. and John V. Dempsey. 1991. "Photo-interviewing: a tool for evaluating technological innovations" (article).
2. Dempsey, John V. and Susan A. Tucker. 1994. "Using photo-interviewing as a tool for research and evaluation" (article).
H. Institutional Culture
1. Buchanan, D. 1998. "Representing process: the contribution of a re-engineering frame" (article).
References
Appadurai A., Modernity at Large. Cultural Dimension of Globalization, Minneapolis-London, University of Minnesota 1996.
Bourdieu P., Understanding, in "Theory, Culture and Society", 13, 2, 1996.
- The Social Definition of Photography, in J. Evans, S. Hall (eds), Visual Culture: a Reader, Sage, London 1999.
- L. J. D. Wacquant, Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Paris, Editions du Seuil 1992.
Brown K., The Past in Question. Modern Macedonia and the Uncertainties of Nation, Princeton, Princeton University Press 2003.
Clifford J., The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge, Cambridge University Press
1988.
Duijzings G., Religion and the Politics of Identity in Kosovo, New York, Columbia University Press 2000.
Collier J., Photography in Anthropology: A Report on Two Experiments, in "American Journal of Anthropology", 59, 5, 1957, 843859.
Galasinski A., Rollo C., Meinhoff H. U.,Urban Space and the Construction of Identity on German-Polish Border, in Meinhof U. H.
(ed), Living (with) Borders. Identity Discourses on East-West Borders in Europe, Sydney, Ashgate 2002, 120-145.
Jenkins T., Fieldwork and the Perception of Everyday Life, in "Man", 29, 2, 1994, 433-455.
Fabian J., Time and the Other. How Anthropology makes its Object, New York, Columbia University Press 1983.
Fabietti U., Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione, Roma-Bari, Laterza 1999.
Geertz C., The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books 1973.
Goffman E., On Fieldwork, in "Journal of Contemporary Ethnography", July 1989, 122-132.
Harper D., Talking About Pictures: A Case for Photo Elicitation, in "Visual Studies", 17, 1, 2002, 13-26.
Herzfeld M., Epistemologies, in Id, Anthropology. Theoretical Practice in Culture and Society, Malden-Oxford, Blackwell 2001.
- Orientations: Anthropology as a Practice of Theory. In Id, Anthropology.
Kusenbach M., Street phenomenology. The go-along as ethnographic research tool, in "Ethnography", 4, 3, 2003, 455-485.
Pink S., Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research. London, Sage 2001.
Rahola F., Pratiche etnografiche e sapere antropologico, in Dal Lago A., De Biasi R. (eds), Un certo sguardo. Introduzione
all'etnografia sociale, Roma-Bari, Laterza 2002, 27-53.
- La serialità sfocata della guerra permanente, in "il manifesto", 1.3.2006.
Semi G., Nosing Around. L'etnografia urbana tra costruzione di un mito sociologico e l'istituzionalizzazione di una pratica di ricerca.
Working Paper presentato al Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Università degli studi di Milano, 2006.
Todorova M., Imagining the Balkans, New York, Oxford Univesity Press 1997.
Vereni P., Vite di confine. Etnicità e nazionalismo nella Macedonia occidentale Greca, Roma, Meltemi 2004.
41
ACHAB
Tre preghiere collettive dei musulmani milanesi
Spunti di riflessione sulla fotografia etnografica
testo e foto di Lorenzo Ferrarini
Le fotografie presentate in questo reportage sono state
scattate a Milano, in occasione di tre diverse festività del
calendario musulmano. L’id al-fitr (festa di rottura del
digiuno, conclusiva del mese di ramadan, si svolge il
primo giorno del mese successivo, šawwal) del 1426
dell'egira (03/11/2005), l’id al-kebir (grande festa,
decimo giorno del mese di du ‘l-hiğğa, coincide con i riti
di sacrificio durante il periodo del pellegrinaggio alla
Mecca, quindi si chiama anche id al-adha) dello stesso
anno (10/01/2006) e infine l’id al-fitr dell'anno 1427
(23/10/2006). Le foto mostrano delle preghiere collettive
di larga partecipazione, nelle prime due occasioni presso
il Palalido di piazzale Stuparich e nella terza al
velodromo Vigorelli di via Arona.
In tutte e tre le occasioni sono stato accompagnato da
Osama, ventiseienne egiziano di Sharqiyya, sobborgo del
Cairo. Ci siamo conosciuti in una scuola di italiano per
stranieri anni fa e lui ha apprezzato il mio interesse per la
sua cultura, religione e modo di vita qui in Italia, così mi
ha invitato alla “nostra festa”, anticipandomi che ci
sarebbe stata molta gente e che sarebbe stato molto bello.
Osama partecipa a queste preghiere senza essere legato a
particolari associazioni religiose, semplicemente
considera importante vivere la preghiera del giorno di
festa con il maggior numero di correligionari possibile. Al
punto che, sebbene quest’anno in Egitto l’id al-fitr sia
stato celebrato con un giorno di ritardo rispetto alla data
della preghiera organizzata in Italia, dove sono stati
seguiti i mullah sauditi (spesso sorgono controversie
anche per questioni di fuso orario e di visibilità della
luna), lui e i suoi amici hanno comunque partecipato alla
preghiera comunitaria. L’accesso al luogo di preghiera è
assolutamente libero, dentro si trovano soprattutto due
tipologie di persone: musulmani che pregano, si
ritrovano, festeggiano, ascoltano la predica dell’imam, e
qualche giornalista che fotografa e fa riprese: la politica
degli organizzatori (legati all’UCOII e al Centro
Culturale Islamico di viale Jenner) per queste occasioni,
infatti, è di apertura ai mezzi di informazione, sebbene gli
eventi non siano per nulla pubblicizzati. Ero in
compagnia di Osama, e a volte anche di amici o colleghi
Foto 1: 10/1/2006, id al-kebir, si prende posto per la preghiera
del Leav (Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia Visuale
dell’Università degli Studi di Milano), tra cui donne, che avevano
accesso alla zona riservata al genere femminile, coi quali abbiamo anche
realizzato riprese video, interviste e registrazioni sonore.
La prima scelta significativa che mi si è presentata è stata quella di dove
42
ACHAB
Foto 2: 3/11/2005, id al-fitr, la prosternazione, suğud
un possibile supporto visivo a rappresentazioni minacciose, di
un’alterità impenetrabile e inconoscibile (sul genere di foto 2).
Dovendo decidere quali aspetti dell’evento rappresentare, se porre
l’accento sulla celebrazione religiosa ristretta al momento topico
della preghiera, o se estendere lo sguardo alla festività come
momento di socialità ed incontro (foto 8 e 9), nonché di scambi
commerciali che coinvolgono anche i simboli religiosi (foto 5),
mi sono reso conto che una selezione di fotografie del primo tipo
poteva accompagnare e supportare un discorso essenzialista,
sostenendo la tesi dello scontro di civiltà soprattutto come scontro
di tradizioni religiose. Un’analisi antropologica dovrebbe invece
basarsi su una visione più ampia, includendo anche i processi di
cambiamento quali i tentativi di evangelizzazione in corso poco
lontano dal luogo di preghiera (foto 6).
Solitamente coinvolgo nel lavoro di revisione dei materiali anche
chi ha partecipato all’evento: sapere cosa Osama pensi delle
fotografie, quali apprezzi maggiormente, quali situazioni avrebbe
sottolineato al mio posto e che uso faccia delle copie che gli
stampo, fornisce utili informazioni sui significati che attribuisce a
queste feste (magari da inserire in una ricerca più ampia
sull’immigrazione dell’area urbana milanese). Un'altra
posizionarmi: al Palalido mi sono potuto sistemare sugli spalti in
mezzo ai fedeli, mentre nel caso del velodromo Vigorelli, essendo
arrivato a preghiera già iniziata, non ho potuto scegliere la visuale
migliore: mi sono trovato su una scalinata vuota e ho usato il
teleobiettivo per riempire l’inquadratura. Essere vicini ai soggetti
da fotografare influenza la scelta dell’obiettivo e l’impressione di
partecipazione che si vuole dare a chi guarderà le immagini: le
focali corte, infatti, si accompagnano al cosiddetto “effetto
presenza”, dato dalla dilatazione dei piani e dall’accentuazione
del primo piano rispetto allo sfondo. Il teleobiettivo, viceversa,
comprime i piani dando l’impressione di osservare da lontano una
scena ingrandita. Questo ha ovviamente delle conseguenze sul
piano ideologico, quando si voglia sottolineare un’affinità o
un’estraneità rispetto all’individuo o al gruppo di persone ritratto
(si confrontino ad esempio le immagini 3 e 7).
Esiste anche un modo per esprimere dei veri e propri giudizi sui
propri soggetti, che agisce o attraverso la selezione di
atteggiamenti individuali (ad es. foto 1 e 4), comunicando
un’impressione di umanità e familiarità, oppure al contrario
mostrando le persone come una massa omogenea, ottenendo un
effetto magari esteticamente piacevole ma fornendo nel contempo
43
ACHAB
Foto 3, a sinistra:
10/1/2006, id al-kebir,
l’inizio della preghiera,
la pronuncia della
niyya
Foto 4, a destra:
3/11/2005, id al-fitr,
durante la preghiera, due
bambini salutano una
bambina dall’altro lato del
palazzetto, nella parte
riservata alle donne
44
ACHAB
Foto 5, a sinistra:
10/1/2006, id al-kebir,
bancarella che espone
souvenir e poster
raffiguranti i luoghi santi
Foto 6, in basso:
3/11/2005, id al-fitr,
un uomo regala bibbie in
francese e arabo poco
lontano dal Palalido
prospettiva di ricerca che ho trovato interessante,
sviluppabile con la pratica del feedback, riguarda la
cosiddetta cultura visuale, ovvero l’estetica, i significati e
le modalità di fruizione delle immagini di una specifica
cultura.
Sto costruendo un mio modo di fotografare attraverso i
miei studi, le esperienze con la macchina fotografica sul
campo e i contatti con altri fotografi. Sia le letture teoriche,
sia la pratica, stanno facendo crescere in me la convinzione
che l’utilizzo di fotografie e materiali audio-video in
antropologia debba partire dal fondamentale presupposto
per il quale le attrezzature di volta in volta usate non
raccolgono dati grezzi, generando un sapere neutro, ma
sono invece un mezzo di creazione di conoscenza
interpretativa influenzata, oltre che dalle caratteristiche
tecniche del medium utilizzato, soprattutto dallo sguardo e
dalle idee del ricercatore, che ne è a tutti gli effetti autore.
Per questo motivo ho deciso di accompagnare le immagini
con un breve testo che, oltre a contestualizzare, mostrasse
anche quali significati si possono far emergere da una serie
di foto. Scopo secondario è anche illustrare le mie modalità
di lavoro. In questo modo vorrei sottolineare l’importanza
di un’analisi critica dei materiali e della riflessività
(espressione dopotutto presa dall’ambito semantico del
visuale) anche in fotografia etnografica.
*
Portfolio on-line dell’autore sul sito:
www.flickr.com/photos/lorenzoferrarini
45
ACHAB
Foto 7, in alto a sinistra: 23/10/2006, id al-fitr, la pronuncia del takbir
Foto 8, in alto a destra:
10/1/2006, id al-kebir, la
preghiera dei ritardatari e
giochi di bambini
Foto 9, in basso a sinistra:
10/1/2006, id al-kebir, i
bambini sparano petardi per
festeggiare
Foto 10, in basso a destra: 23/10/2006, id al-fitr, la preghiera dei ritardatari
al centro del velodromo Vigorelli
46
ACHAB
Sostenere il mondo
Osservazioni sul concetto di dharma nel brahmanesimo
di Viola Gambarini
Il concetto di dharma è senza dubbio uno dei punti focali della
cultura hindu. Il campo semantico di questo termine è molto vasto:
nella costituzione indiana è usato sia come parola ufficiale per
'religione', sia nella definizione della Repubblica Indiana come 'stato
laico'. Nelle lingue indiane moderne, soprattutto nel sanscrito
moderno e nelle lingue del nord dell'India, ha comunemente assunto
il significato di 'religione'.
La centralità del termine dharma nella tradizione, e la complessità e
la ricchezza delle sue implicazioni, sono tali da richiedere un'analisi
più approfondita di questo concetto, i cui tentativi di traduzione con
una singola parola o definizione continuano a presentare delle
difficoltà.
L'etimologia fa derivare il termine dalla radice dhri-, che ha il
significato primario di 'supportare', 'sostenere', 'mantenere'. Il
dharma è la 'forma' delle cose come esse sono e il potere che le
conserva tali.
Le fonti della tradizione che insegnano che cosa è dharma sono tre:
il Veda (i sacri testi rivelati)1, la Smriti (i trattati della tradizione)2, la
'buona consuetudine' (ovvero la condotta dei buoni e dei sapienti)3.
mantenere. Paul Hacker arriva a sostenere che proprio il carattere
empirico del dharma abbia permesso di mantenere un'unità
all'interno del mondo complesso dell’hinduismo: il concetto di
dharma "è stato, in tutta la sua indeterminatezza e nel suo
empirismo, il filo unificatore dell'arianesimo, il solo fattore che in un
modo o nell'altro ha tenuto insieme l’hinduismo nella sua
multiformità"8.
Nel Rigveda troviamo il termine dharman, neutro, indicante l'atto di
'sostenere', usato spesso in riferimento all'azione degli dèi di
supportare il creato, separare cielo e terra e differenziare gli esseri
l'uno dall'altro. Emerge l'importanza, nella cosmogonia vedica,
dell'idea di una primigenia azione che dà inizio al cosmo
separandone e differenziandone le parti.
Dharma è quindi originariamente un'azione, l'azione di mantenere il
cosmo nella sua articolazione tramite il rituale di riattualizzazione
della creazione primigenia. Questo è il compito dell'uomo, che
realizza il dharma attraverso l'esecuzione dei riti vedici e dei doveri
tradizionali.
Bisogna sottolineare che il significato di dharma è da intendere
principalmente in senso prescrittivo: ciò che è 'giusto e proprio' è ciò
la cui realizzazione è data come compito a ogni creatura, che solo in
tal modo diventa ciò che essa propriamente è. Dharma non è un dato
di fatto, bensì un orizzonte normativo.
Questa analisi evidenzia il carattere attivo del concetto di dharma,
che nel suo uso più antico indica non tanto un ordine stabilito quanto
una continua esecuzione9.
Nell'antico uso di dharma l'idea di un ordine naturale effettivo nel
mondo trova poco spazio, poiché nella visione vedica della realtà
non c'è un mondo oggettivo in cui il dharma si inserisce e 'funziona',
bensì l'uomo vive in relazione di reciprocità con il cosmo, per cui
l'agire dharmico rituale e il corso della natura sono coimplicati.
Risulta dunque fondamentale il ruolo dell'operatività umana, in
quanto dharma è il continuo mantenimento dell'ordine e della norma
sociale e cosmica.
C'è quindi un profondo nesso nella cultura hindu tra l'andamento del
cosmo nel suo complesso e l'agire del singolo, concepito come parte
esistente, non di per sé, ma solo in riferimento a un tutto organico, a
una struttura di relazioni complementari e inscindibili10. Per questo,
dharma può appropriatamente essere definito come "l'ordine sociocosmico, del quale si può dire che è buono semplicemente in quanto
è necessario al mantenimento dell'esistenza felice del tutto costituito
dal 'trimundio' - trailokya (terra, cielo e spazio intermedio, o, più
tardi, terra, cielo e regioni infere)"11.
Come l'uomo è essenzialmente in relazione con il cosmo, così legge
morale e legge 'naturale' non si distinguono: il bene dell'uomo è il
1. Una cornice di corrispondenza
Il dharma si colloca dunque fra rivelazione, tradizione e
consuetudine.
La legge dharmica è norma immutabile ed eterna. In che misura è
giustificabile l'interpretazione che vede in essa un elemento di
immobilismo per la realtà sociale hindu? Il rispetto del dharma è
realmente un ostacolo al cambiamento e alla valorizzazione
dell'iniziativa umana nel mondo? E, ancora, qual è il rapporto tra tale
norma, che descrive 'ciò che è giusto', e il mondo reale,
inevitabilmente imperfetto? Nel termine dharma si esprime infatti
una tensione tra due significati: dharma descrittivo, presa d'atto di
ciò che è, e dharma prescrittivo, enunciazione di ciò che dovrebbe
essere.
Alcune interpretazioni, come quella di Kumarila4 e della Mimamsa5,
considerate le voci della 'ortodossia' (l'uso di questo termine
richiede, in ambito hindu, particolare accortezza), indicano nel Veda
la fonte esclusiva del dharma, negando il ruolo del consenso umano,
delle convenzioni e del comportamento etico; sottolineano in tal
modo la natura trascendente del dharma. Altre linee di pensiero
considerano invece il dharma un concetto radicalmente empirico; a
questo proposito si parla, in relazione all’hinduismo, non tanto di
un'ortodossia, quanto di una 'ortoprassia'6. Viene in tal modo stabilito
un forte nesso tra dharma e comportamento concreto, che sottolinea
il significato di dharma come Ordnung im Vollzug7, ordine in
esecuzione, che è compito dell'agire umano nel mondo realizzare e
47
ACHAB
bene dell'universo, l'agire dharmico è proprio di chi comprende e
concretizza nella propria esistenza tale relazione che, sola, dà senso
all'operare umano.
La visione dharmica del mondo è dunque una 'cornice di
corrispondenza' tra quelli che noi consideriamo i due poli dell'uomo
e della natura. L'agire umano supporta l'ordine naturale, incarna la
realizzazione del dharma, e viceversa il dharma sostiene tutte le
creature, mantenendole nella loro propria 'forma' e permettendo
all'uomo un'esistenza giusta.
Appare chiaro il rapporto di reciprocità che lega la legge del dharma
e l'operare dell'uomo, cosmologia ed etica, secondo un rapporto che
Halbfass chiama di 'ambivalenza causale' per il quale "il dharma
stesso è questo sostenere che tocca all'uomo competente; ma è anche
la condizione alla quale tale sostenere è possibile. Esso protegge i
suoi protettori. […] In questo senso, dharma è 'ciò che sostiene'
come anche ciò che 'deve essere sostenuto'"12.
Indagare il concetto di dharma e le sue sfaccettature significa
dunque riflettere sul rapporto tra l'agire umano e il mondo in cui esso
si trova inscritto, rapporto che sembra configurarsi non come terzo
che verrebbe ad aggiungersi ai due poli 'primari', dati, dell'uomo e
del mondo, ma come punto di scaturigine, apertura di senso che
inscrive il mondo e l'uomo, che informa l'uomo-con-il-suo-mondo.
considerare le indicazioni del dharma generale, comune a tutti,
come un aspetto secondario rispetto alle ingiunzioni dharmiche
specifiche. Il dharma risulta così essenzialmente una pluralità di
innumerevoli regole singolari.
3. Identità multiforme
Per renderci conto di come il dharma orienta e tiene insieme il
mondo multiforme dell’hinduismo, possiamo riferirci a uno dei testi
fondamentali della tradizione, le Leggi di Manu, che si ipotizza
abbia raggiunto la forma in cui la conosciamo verso la fine del II
secolo d.C.
L'opera affronta una grande varietà di argomenti, che sono però
strettamente interconnessi nel pensiero hindu in quanto
costituiscono i diversi aspetti della vita umana attinenti al dharma.
La gamma molto ampia di ambiti considerati e la casistica
estremamente
dettagliata
mostrano la volontà di
estendere le norme del dharma
alla realtà in tutte le sue
sfaccettature, rendendola un
sistema ordinato che è possibile
comprendere
e
perciò
padroneggiare.
Le Leggi di Manu si collocano
in modo molto particolare nella
tradizione
sacerdotale
ortodossa. L'opera è stata infatti
interpretata come l'espressione
della reazione brahmanica
all'ideologia dei rinuncianti,
Vishnu addormentato sul serpente
diffusasi con l'opera di
Ananta - Tempio di Deogarh
Mahavira e di Siddharta
Gautama il Buddha nei secoli V-VI a.C. La trasformazione
fondamentale è data dall'affermarsi, nel mondo indiano, del valore
dell'ahimsa (non-violenza, in-nocuità, in-nocenza) e della pratica del
vegetarianismo, e dunque di un ideale di purezza di fronte a cui le
competenze sacrificali perdono supremazia.
La reazione brahmanica consiste allora nel tentativo di appropriarsi
dei nuovi valori. Manu e segna un momento critico nella tradizione
sacerdotale ortodossa. È un tentativo sia di riconsolidare un retaggio
già antico, sia di riorientarlo secondo i nuovi principi; nelle Leggi di
Manu è visibile la volontà di unificare la cultura arya in un quadro
di valori coerente, che permetta di riaffermare la supremazia
brahmanica secondo i nuovi criteri prevalenti.
Il testo accosta diverse regole di vita; giudica ogni situazione che
presenta, ma non per questo un comportamento valutato
positivamente ne esclude un altro, diverso, se altrettanto corretto.
Quello che dobbiamo cercare di capire è se questi principi siano in
contrasto gli uni con gli altri, se siano inconciliabili oppure
semplicemente diversificati.
La frammentarietà dell'opera non impedisce infatti che in essa si
esprima una compiuta e precisa visione del mondo. Manu mira ad
abbracciare la totalità delle situazioni possibili, e avanza la pretesa
di enunciare le regole del dharma in un trattato valido per tutti. Ma
2. Un elemento di identità
Accanto al significato di dharma riferito all'ambito propriamente
rituale e normativo, per cui l'azione dharmica contribuisce a
realizzare e mantenere l'ordine del cosmo tramite l'adempimento dei
rituali, troviamo un uso di questo termine nel senso più generale di
'qualità essenziale' o 'attributo'. Questo aspetto è spiegato dall'uso
passivo del verbo dhri-, in riferimento a ciò che viene supportato
dall'essere al quale inerisce come attributo qualificatore.
Tale accezione di dharma ne mette in evidenza la funzione di
elemento distintivo, che, secondo le interpretazioni 'ortodosse' già
nominate, impedisce di farne un principio etico e universalistico
(tendenza osservabile invece in alcune parti della letteratura hindu,
come il Mahabharata, e negli editti di Ashoka).
Dharma, nella visione ortodossa, è infatti principio di
differenziazione, che traccia i confini tra chi è hindu e chi non lo è,
distingue i saggi dagli altri uomini, detta le regole della separazione
castale e ordina gerarchicamente la società. L'accento posto
dall'ortodossia brahmanica sul valore distintivo del dharma e sulla
impossibilità di derivarne le regole da principi razionalizzabili e
universalizzabili (come l'ahimsa, la non-violenza, per esempio),
esprime la volontà di mantenere la specificità della cultura hindu di
fronte alla commistione culturale che si verifica nel corso della storia
(che invece viene incoraggiata da altre voci della cultura indiana,
primo fra tutti l'imperatore Ashoka). In particolare, l'avversario e
l'interlocutore dell'ortodossia è il buddhismo, che si diffonde
enormemente nel subcontinente nei primi secoli dell'era volgare.
Grazie a questi mutamenti culturali gli 'ortodossi' elaborano
posizioni teoriche che si vogliono in opposizione agli 'eretici' con cui
si confrontano, ma che inevitabilmente subiscono l'influenza degli
avversari e ne assumono concetti e problemi.
Porre l'accento sulla funzione distintiva del dharma significa
48
ACHAB
le norme etiche non sono dedotte dall'esistenza di una natura umana
universale. L'attenzione delle Leggi di Manu è puntata sul
particolare, sulla considerazione delle circostanze in cui un atto è
compiuto. L'opera determina con rigore il modo corretto di
comportarsi in ogni circostanza, a seconda della situazione specifica
in cui chi agisce si trova. Questo modo di procedere permette al
sistema di norme dharmiche di essere valido per tutti, poiché le
circostanze considerate sono tante da permettere a ognuno di
ritrovare il proprio caso specifico. Il testo prevede sempre una serie
di alternative, mantenendosi in bilico tra l'enunciazione della
condizione ideale e il confronto con una realtà contraddittoria.
L'ipotesi sostenuta da Smith e Doniger è che il testo faccia fronte a
questa realtà prestando maggior attenzione ai dharma specifici
piuttosto che al dharma comune: "Ogni aggiunta rappresenta in
realtà una sottrazione rispetto a qualunque legge universale. Non
resta molto del dharma assoluto o comune, di cui i testi parlano, se
mai ne parlano, come di un'ultima, e non di una prima istanza"13.
4. Universale polifonico
Il dharma universale consiste proprio in questa pluralità coerente di
dharma specifici (svadharma), tramite i quali la norma eterna
'sostiene' il mondo.
Questa dottrina dello svadharma implica la consapevolezza della
molteplicità che caratterizza l'azione umana; essa si basa sull'idea
che il cosmo necessiti di un'articolazione, della differenziazione
interna di cui ci parlano i miti cosmogonici hindu. Il mantenimento
di questa varietà è la condizione di esistenza del cosmo e della
società umana: nella società hindu "tutti i ruoli sono ugualmente
validi e necessari (benché non ugualmente buoni). L'azione e la
varietà sono i valori di questo sistema"15.
L'idea fondamentale è quella di una stretta complementarità fra le
parti, che formano un sistema di relazioni definite dal criterio della
purezza. "La dottrina dello svadharma nell'induismo ortodosso è un
sistema etico fondato sul pluralismo inerente al sistema sociale delle
caste (il cui fine è il mantenimento dell'equilibrio sociale e
morale)"16.
Il pluralismo e la diversificazione sono dunque il fondamento
dell'ordine dharmico, che trova la sua unità nell'articolazione interna
delle differenze.
Le Leggi di Manu, la maggiore opera sul dharma, dedicano grande
attenzione alla specificità delle situazioni umane concrete. Questo ci
dà un'indicazione preziosa per intendere un concetto complesso
come quello di dharma: Manu rappresenta infatti il tentativo di
rendere la norma eterna applicabile in questo mondo, ci mostra il
nesso profondo che intercorre tra il carattere di eternità, di
trascendenza del dharma e il suo significato attivo, l'ordine che
sostiene il mondo e che nel mondo, dalle creature di questo mondo,
è mantenuto grazie a un continuo operare dal carattere
necessariamente plurale e concreto.
"La carne non si può mai avere senza usare violenza a creature con
il soffio della vita, e l'uccisione di creature con il soffio della vita non
porta in cielo, quindi non si deve mangiare carne. […] Si può
mangiare la carne che è stata consacrata con l'aspersione di acqua, o
quando i sacerdoti lo desiderano, o quando si è correttamente
impegnati in un rituale, o quando il soffio vitale è in pericolo"
(Manu, V, 48, 27).
La realtà ci mette di fronte a situazioni in cui non esistono soluzioni
soddisfacenti, poiché in alcuni casi non è possibile seguire la norma
di comportamento ideale. Questi sono i punti in cui il testo di Manu
sembra contraddirsi: esso permette un comportamento e subito dopo
enuncia la norma secondo la quale quello stesso comportamento è
da evitare. Entrambe le affermazioni sono però giustificate: Manu
procede spiegando come ci si dovrebbe comportare idealmente, poi
considera anche i 'casi estremi', situazioni cioè in cui non è possibile
seguire tale regola ideale, ne prende atto, e sottopone anche questi a
norme precise. Il testo mostra in questo modo di accettare la
fallibilità umana come dato ineliminabile: "non fare questo, dice
Manu, ma, se lo fai, ecco cosa devi fare per riparare.[…] La
relatività dei dharma - diversi non solo per persone diverse, ma
anche per la stessa persona in tempi e luoghi diversi - rende possibile
affermare una serie di ideali differenti, uno dopo l'altro, tutti veri (per
qualcuno, in un dato momento, in un certo luogo)"14.
La forza del sistema normativo di Manu sta nella 'sensibilità al
contesto', che gli permette di declinare il dharma nelle sue molteplici
forme, operazione che consiste non nel modificare la norma eterna
a seconda delle circostanze, ma nel trovare la regola corretta per
ogni singola situazione.
L'attenzione ai casi singoli, agli specifici dharma, non conduce, ma
anzi preserva Manu dal relativismo: il testo non lascia libertà di
scelta, è fortemente teso a fornire un sistema normativo completo, e
indica, per ciascuna circostanza data, una cosa sola da fare. La
determinazione del comportamento da seguire non è mai lasciata al
singolo: la norma dharmica, grazie alle sue articolazioni interne, sa
prescrivere la regola corretta in ogni circostanza.
Note
1. Il Veda è costituito da quattro raccolte di inni: Rigvedasamhita,
Samavedasamhita, Yajurvedasamhita, Atharvavedasamhita. Poiché
costituisce la rivelazione raccolta direttamente dai veggenti (i rishi), il Veda
si identifica pienamente con la conoscenza, contiene in sé la fonte e la
giustificazione di ogni sapere: "Veda ha la stessa radice di video, che indica
la visione in quanto strumento di conoscenza. Il perfetto, che esprime un
risultato acquisito, ha il senso di sapere" (Ernout - Meillet 1959, s. v. viso;
cfr. anche il greco oida, perfetto di oraw, con valore di presente nel senso di
'so'). Il Veda è indicato unanimemente come la fonte primaria del dharma. I
testi vedici però contengono pochissime norme esplicite riferite al dharma,
e quando si afferma che essi ne sono il fondamento non ci si riferisce
propriamente ai testi, bensì alla conoscenza nel suo complesso, nota agli
uomini o meno: che sia stata rivelata o no, che sia stata tramandata o sia
andata perduta.
2. La Smriti, 'memoria', indica l'insieme dei testi che costituiscono la
tradizione hindu, il sapere tradito grazie alla memoria umana e che ha per
fonte autori umani. Nella sua accezione più ampia, la Smriti comprende
trattati dottrinali, le due grandi opere dell'epica hindu (Mahabharata e
Ramayana) e i Purana, di carattere principalmente mitologico. In senso
49
ACHAB
7. Hacker 1978 II, p. 512.
8. Hacker 1978 I, pp. 508-509.
9. "Ci sono due forme dell'agire pratico, come ha indicato Aristotele: una
forma di tale agire è esemplificata dalla costruzione di navi, che termina
quando l'obiettivo è raggiunto, ovvero quando una nave è costruita, mentre
l'altra forma è come una vita virtuosa o suonare il violino, qualcosa che non
finisce poiché non ha di mira un prodotto, e ricerca la soddisfazione
nell'esercizio di un certo tipo di attività. […] Il dharma è [un agire pratico]
del secondo tipo". J. N. Mohanty, La razionalità pratica nel pensiero
indiano, in Squarcini 2002, pp. 173-181. Ibidem, p. 180.
10. Sulla stretta interdipendenza delle 'parti' rispetto al 'tutto' nella visione
del mondo hindu, cfr. Dumont 1991. L'analisi di Dumont, pur
concentrandosi principalmente sul rapporto tra le parti e l'insieme nel
mondo sociale, propone una lettura del concetto di 'individuo' utile alla
comprensione dei rapporti tra singolo e cosmo nella cultura hindu.
11. Biardeau 1985, pp. 61-62.
12. Halbfass 1988, p. 318.
13. Ramanujan, cit. in Doniger 1996.
14. Doniger, 1996, pp. 60, 63. Halbfass riporta la seguente interpretazione
dei passi vedici riguardanti il sacrificio cruento: "Such rituals […] are not
put forth as something that ought to be done. They are taught only in the
following sense: 'If someone wants to hurt, then this is an effective method'",
Halbfass 1988, p. 89.
15. Doniger 2002, p. 525. Scrive Halbfass: "Their system tried to
accommodate both ritual slaughter and a certain respect for the life of the
sacrificial victims. There was a place for himsa and for ahimsa, just as there
was a place for vegetarianism and for meat-eating within the complex
patterns of ritual behavior", Halbfass 1991, p. 114.
16. Doniger 2002, p. 526.
stretto si allude invece, con il termine Smriti, all'insieme di testi denominati
Dharmasutra e Dharmashastra; si pensa che questi testi siano stati redatti
tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C. A essi è attribuita un'origine mitica,
come nel caso dell'autore della più importante opera di questo genere, le
Leggi di Manu.
3. La terza fonte del dharma è la buona consuetudine: da non confondere
con la consuetudine comunemente intesa, vale a dire un insieme di pratiche
osservate da tutti e rese abituali da un uso immemorabile, essa indica un
modo di vivere ideale: la condotta dei buoni o dei sapienti. Consiste nella
vita orientata secondo la religione e tesa al conseguimento di meriti
esclusivamente spirituali, propria di chi non soltanto è istruito nel Veda, ma
sa anche trarne tutte le conseguenze relative alla condotta e metterle in atto.
4. Filosofo indiano vissuto nell'ottavo secolo. Interprete del Mimamsasutras di Jaimini e del sistema Purva-mimamsa.
5. Termine sanscrito avente il significato di 'investigazione'. Scuola
filosofica induista i cui studi si sono dedicati ad indagare la natura del
dharma. La scuola Mimamsa è meglio conosciuta con il nome di Purva
Mimamsa in quanto si occupa del Purva, la porzione più antica dei Veda. Il
testo fondamentale della scuola è il Purva Mimamsa Sutras di Jaimini (IV
sec. a.C.).
6. In riferimento al significato di dharma come scienza del rituale B. K.
Smith osserva: "Ritual is not to be classified as part of religion because
religion (says Staal) deals with doctrines and belief (orthodoxy) rather than
practice (orthopraxy) which is 'independent from the doctrinal component
of religion'", Smith 1991, pp. 141-143. L'assenza di un criterio strettamente
teorico per determinare l'appartenenza del singolo allo hinduismo è
sottolineata dall'analisi di Louis Dumont dei concetti di tolleranza e
integrazione in India: "Più che una ortodossia, l'induismo conosce una
'ortoprassia' (Staal)", Dumont 1991, p. 335.
Bibliografia
M. Biardeau, L'induismo. Antropologia di una civiltà, Mondadori, Milano 1985.
W. Doniger (a cura di, con la collaborazione di B.K. Smith), Le leggi di Manu, Adelphi, Milano 1996.
W. Doniger, Le origini del male nella mitologia indù, Adelphi, Milano 2002.
L. Dumont, Homo hierarchicus. Il sistema delle caste e le sue implicazioni, Adelphi, Milano 1991.
A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, Paris 1959.
P. Hacker, "Dharma im Hinduismus", in Id., Kleine Schriften, Steiner, Wiesbaden 1978, pp. 496-509.
Id., "Der Dharma-Begriff des Neuhinduismus", in Id., Kleine Schriften, Steiner, Wiesbaden 1978, pp. 510-524.
W. Halbfass, India and Europe, State University of New York Press, Albany 1988.
Id., Tradiction and Reflection, State University of New York Press, Albany 1991.
P. V. Kane, History of Dharmashastra, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona 1968-1977.
R. Lingat, La tradizione giuridica dell'India, Giuffrè, Milano 2003.
Id., "Dharma et temps. À propos de Manu, I, 85-86", Journal Asiatique, CCLIX, 1961, pp. 487-495.
C. Malamoud, Cuocere il mondo. Rito e pensiero nell'India antica, Adelphi, Milano 1994.
S. Piano, Sanatana dharma. Un incontro con l'induismo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996.
A.K. Ramanujan, "Is There an Indian Way of Thinking? An Informal Essay", Contributions to Indian Sociology, N. S., XXIII, 1,
1989.
B.K. Smith, recensione a Frits Staal, Rules Without Meaning: Ritual, Mantras and the Human Sciences, Journal of Ritual Studies, 5,
2, 1991, pp. 141-143.
F. Squarcini (a cura di), Verso l'India oltre l'India, Mimesis, Milano 2002.
50
ACHAB
Silamo Malagasy
Uno sguardo sui musulmani del Madagascar
di Maura Parazzoli
The variety of traditional Islamic practices in different
times, places, and populations indicates the different
Islamic reasonings that different social and historical
conditions can or cannot sustain.
The idea that traditions are essentially homogeneous
has a powerful intellectual appeal, but it is mistaken.
Indeed, widespread homogeneity is a function not of
tradition, but of the development and control of
communication techniques that are a part of modern
industrial societies
(Talal Asad )
All'inizio del mese di luglio del 2005 ero appena arrivata in
Madagascar per un viaggio che sarebbe durato due mesi e stavo
percorrendo in taxi-brousse (i furgoni collettivi che
costituiscono il mezzo di trasporto pubblico più usato nel
paese), la strada che collega Antsirabe con Fianarantsoa, verso
sud, lungo gli altipiani centrali. Durante una sosta in un piccolo
villaggio rimasi colpita da un'abitazione dove si trovavano due
ristoranti adiacenti, in entrambi i muri di entrata erano disegnati
due maiali: nel ristorante gestito da malgasci non musulmani
l'animale disegnato indicava che in quel luogo si poteva
consumare quel tipo di carne. Nel secondo il maiale disegnato
era sbarrato con una "X", ad indicare che il ristorante era
musulmano, ed a rafforzare l'indicazione stava una scritta che
assicurava che in quel luogo la carne di maiale era fady.
Il concetto di fady è nato all'interno dell'antico culto degli
antenati: indica qualcosa che non è consentito fare per ordine
degli antenati (più raramente di parenti ancora vivi), ed è un
concetto che investe le azioni quotidiane dei malgasci. Si tratta
di divieti alimentari (per esempio frutti e verdure da non
mangiare, ma anche da non piantare), oppure di divieti di
contrarre il matrimonio con gruppi considerati inferiori, o di
vendere appezzamenti di terra a persone estranee al gruppo
familiare. Tutte queste regole dovrebbero mantenere l'integrità
del gruppo (Middleton, 1999, pag. 17).
Graeber (1995) sottolinea come il concetto di fady, pur essendo
traducibile con taboo costituisca, proprio a causa di questo
legame con l'azione quotidiana, qualcosa di diverso rispetto al
taboo Polinesiano, più legato alla dimensione del sacro.
Naturalmente il culto degli antenati è estraneo all'Islam.
L'esempio del ristorante ci mostra come un concetto legato alla
religione tradizionale malgascia sia stato ri-declinato in termini
islamici da parte della minoranza musulmana presente
sull'isola.1
I musulmani (Silamo, in malgascio) sono in Madagascar meno
del 10% della popolazione totale: una comunità relativamente
piccola e caratterizzata da un elevato grado di eterogeneità
interna, dovuta alle diverse ondate di arrivi di musulmani nei
secoli.
L'altro aspetto interessante riguarda la "malgascizzazione"
dell'Islam avvenuta in seguito all'incontro con il culto locale
degli antenati. Come nel resto del continente africano, anche in
Madagascar sono nati riti e usanze spesso fortemente criticati
dai musulmani "ortodossi" (Blanchy, 1995).
Per chi si è convertito quindi non si è trattato di una rottura
totale con la religione tradizionale, ma della nascita di
sincretismi che hanno rappresentato una sorta di mediazione
rispetto a tradizioni così radicate da non potere essere
facilmente abbandonate.
Per esempio, il Madagascar è famoso per la "seconda sepoltura
dei morti", il famadihana che avviene alcuni anni dopo la prima
sepoltura. Si tratta di una cerimonia eseguita in particolare delle
popolazioni Merina e Betsileo, sull'Altipiano Centrale, nella
quale il morto viene riesumato, e gli vengono cambiate le
lenzuola che lo avvolgono. Soprattutto tra i Merina, si
organizzano Famadihana quando il corpo di una persona morta
da tempo e in luoghi lontani viene collocato nella tomba degli
antenati (razana). In questa occasione, tutti gli altri corpi
contenuti nella tomba vengono estratti per il cambio del
lenzuolo (lamba mena). Tra i Betsileo si organizza quando una
nuova tomba è inaugurata ed i corpi dei parenti sono trasportati
51
ACHAB
dalle sepolture temporanee alla tomba definitiva (Mack, 1986).
In generale, la cerimonia avviene all'interno di una grande festa
con elevato consumo di alcool e in un clima che sembra riunire
i morti ed i vivi. Il morto torna a fare parte del mondo dei vivi
con la sua presenza fisica che si riunisce con il gruppo dei
parenti. Nell'Islam questo non è accettabile in quanto il morto
va sepolto il più velocemente possibile, senza celebrazioni
sfarzose, e non va più rimosso e non esiste (o meglio, non
dovrebbe esistere) il culto degli antenati, né l'intercessione dei
parenti morti.
In alcune zone islamizzate del Madagascar, l'unione tra queste
due religioni così apparentemente inconciliabili ha dato vita a
un nuovo rituale: quaranta giorni dopo la sepoltura (che
avviene immediatamente dopo la morte), viene organizzata una
festa in onore del defunto, che possa riunire anche tutti coloro
che non hanno potuto partecipare al funerale perché venivano
da lontano.
Il culto degli antenati, vietato dall'Islam, è quindi rivisitato, e
nelle preghiere i parenti morti sono solo "onorati" dai loro
discendenti, cosa non vietata dall'Islam "ortodosso".
precedenza, ma riguardava comunque un numero limitato di
adepti. Inoltre, durante il periodo coloniale francese, ebbe un
grande successo nella zona la confraternita Shadhuli, di origine
comoriana e ci furono sia nuove conversioni che avvicinamenti
da parte dei già musulmani. I convertiti della confraternita si
considerano moridy, cioè discepoli e si distinguono dai primi
convertiti.
Sulla costa a nord ovest, tra gli Antalaotsy ("Gente che arriva
dal largo"), si trova una piccola comunità di musulmani,
discendenti dei commercianti Swaili che a partire dal XII
secolo arrivarono attraverso il Canale del Mozambico, e che
rappresenterebbero la comunità musulmana più antica del quale
si abbiano testimonianze in Madagascar. Qui avvennero delle
conversioni all'Islam che, più che basate su veri e propri
proselitismi, sarebbero state causate da un gioco di alleanze
commerciali e politiche. Questa comunità, pur non avendo
legami con gli Arabi, si è a lungo auto-definita come Araba, con
il fine di rivendicare radici prestigiose. Questo conferma il fatto
che in Madagascar (e non solo, naturalmente), il concetto di
musulmano serva a definirsi non solo come comunità di
credenti, ma anche come gruppo etnico.
Oggi i discendenti degli Antalaotsy sono poco numerosi, ma
nell'unica città importante della costa ovest, Majunga, esistono
altre comunità musulmane sunnite, in particolare quella
proveniente dalle Isole Comore, ma anche dallo Yemen, da
Gibuti e dalla Somalia. Tra i sunniti sono frequenti i matrimoni
fra persone appartenenti a due gruppi diversi, inclusi quelli tra
musulmani malgasci e stranieri.
Alla parte opposta del paese, nella costa sud-est, si trova una
comunità musulmana presso gli Antemoro. Gli aristocratici
della costa affermano tuttora di essere discendenti di Arabi che
sarebbero arrivati sull'isola tra il XII ed il XV secolo, o
addirittura ai tempi di Maometto, Gueunier sottolinea che più
probabilmente sono di origine indonesiana, e che: "comme
souvent dans le monde musulman, le lignées prestigeuses se
devaient de revendiquer pour origine la patrie du Prophète"
(Guenier, 1994, pag. 58).
Oggi i musulmani in questa zona sono in numero molto ridotto,
per lo più tra gli aristocratici, che non cercarono mai di fare
proselitismi tra la popolazione. A causa dell'isolamento in cui si
è sempre trovata (e continua in parte anche oggi, con le
comunicazioni stradali quasi impraticabili in alcune stagioni
dell'anno), questa parte del paese, le usanze islamiche si sono
più che altrove unite a quelle locali. Alcuni usi musulmani sono
rimasti, ma totalmente slegati rispetto all'uso originario. Per
esempio, la recita del Corano, che avviene in una lingua ai più
misteriosa (si tratta di arabo pronunciato alla maniera
malgascia), si utilizza anche all'interno delle cerimonie che
riguardano il culto degli antenati. E questo non è un fenomeno
recente: già lo studio degli antichi testi arabico-malgasci degli
Antemoro, del XVI secolo, i Sorabe, parlano di un Islam
lontano dall'ortodossia che contempla la divinazione
astrologica, la figura del guaritore, fino ad arrivare alla vera e
propria stregoneria.
Una minoranza eterogenea
Il termine Silamo nel linguaggio corrente malgascio sembra
assumere una connotazione etnica prima che religiosa.
I malgasci musulmani (parlerò in seguito dei musulmani
provenienti dall'estero), pur facendo parte di un gruppo etnico
definito (i Sakalava, gli Antemoro, ecc...), sono spesso percepiti
(e si auto-percepiscono) come se non potessero essere
contemporaneamente Sakalava e Silamo.
Le conversioni all'Islam sono avvenute nel corso dei secoli in
seguito a contatti di tipo commerciale. Non si può parlare di
vere e proprie ondate di islamizzazione, perché non si è mai
trattato di conversioni sistematiche di ampie fette di
popolazione, né di invasioni, ma piuttosto di fenomeni
contingenti. Blanchy (1995) sottolinea l'esistenza di testi del
XIV secolo che attestano la frequentazione delle coste
malgasce da parte di navi mercantili musulmane (les "Maures")
che trasportavano merci dall'India al Madagascar. Secondo
l'autrice è difficile stabilire se questi mercanti fossero Arabi
stabilitesi in India o Indiani Musulmani. Di certo questi
mercanti costruivano delle "basi" (echelles) di partenza per i
loro commerci con l'interno. Rimangono alcuni interessanti
reperti archeologici del XV e XVI secolo: sono cimiteri e senza
dubbio musulmani.
Probabilmente alcuni di questi commercianti si stabilirono in
Madagascar, dando via a fenomeni di meticciamento. Oggi ne
rimangono alcune piccole comunità di malgasci che ne hanno
conservato la religione.
Sulla costa nord, nella zona di Antsiranana (Diego Suarez),
sono diffusi tra gli Antankarana, dove in alcuni villaggi (caso
unico in Madagascar), i Musulmani rappresentano la
maggioranza della popolazione. Secondo la leggenda fu il loro
re, Tsimiaro, che a metà del XIX secolo si convertì all'Islam per
voto. In realtà l'influenza musulmana era già presente in
52
ACHAB
Oggi, attraverso l'aiuto finanziario degli indiani e dei comoriani
sunniti della zona, alcuni giovani malgasci musulmani sono
stati mandati in India a studiare il Corano, spesso scontrandosi
al loro ritorno con le loro radici musulmane Antemoro, così
diverse rispetto agli insegnamenti più ortodossi ricevuti
all'estero.
un inevitabile scollamento tra gli insegnamenti impartiti dal
leader religioso, il dai al mutlaq, che risiede a Bombay (e ha
come compito principale quello di tenere collegati tra loro i
Bohra sparsi nel mondo), e la comunità residente in
Madagascar.
Fino al 1992 il dai al mutlaq non si era interessato alla
comunità residente in Madagascar, che, in poche generazioni,
pur rimanendo ai margini della società malgascia, aveva nel
frattempo "malgascizzato" le abitudini riguardo il velo delle
donne (prima obbligatorio), l'uso di alcolici, il prestito con
interesse.
Oggi gli Amil Saheb, i predicatori inviati dal Gujarat, cercano
di ristabilire l'ortodossia, e sarà interessante vedere nel medio
termine la reazione della comunità di fronte all'obbligo di
"riallacciarsi alle tradizioni" di un popolo con il quale
continuano si ad identificarsi, (e una prova di questo potrebbero
essere i matrimoni che si mantengono strettamente endogamici,
ed il fatto che quasi nessuno di loro goda tuttora della
nazionalità malgascia) ma del quale hanno rielaborato gli usi
assorbendo quelli del paese ospitante.
Pur partendo dallo stesso punto, il Gujarat, e nello stesso
periodo, un altro gruppo, i Sourti studiati da Claudine Bavoux
(1990), hanno avuto una storia completamente diversa.
La comunità sourti (circa 550 persone all'epoca degli studi
dell'autrice), composta per la maggioranza da musulmani
sunniti, si è stabilita a Toamasina, porto principale della costa
nord-est del paese.
I Sourti partirono alla metà del XIX secolo dal Gujarat e si
stabilirono a Mauritius. Dopo alcune generazioni una piccola
minoranza di loro si trasferì in Madagascar, avendo ormai
acquisito la lingua creola, che continuano a mantenere anche
oggi, formando un esempio forse unico di comunità indiana che
parla il creolo. E' proprio questa lingua che distingue i Sourti
dalle altre comunità indiane presenti nella città, (che hanno di
gran lunga avuto un successo economico superiore), tra i quali
gli stessi Bohra, che arrivarono nell'isola direttamente
dall'India.
I matrimoni tra Sourti e gli altri indiani sono molto rari, mentre
sono frequenti quelli con creoli e malgasci. Di conseguenza, i
Sourti sono percepiti dagli altri indiani di Toamasina come
Karana Very, (Karana persi): "Bohra et Hindous s'entendent
pour comdamner les Sourti et leur refuser la qualité de purs
indiens. (…). Ils leurs reprochent en même temps d'épouser des
Malgasches, des Chinoises, des Créoles e de refuser l'union
avec les Hindous et les Bohra. (...) Les pratiques langagières
des Sourti sont connues et vivement critiquées: ils ne cherchent
même pas à enseigner le gujerati à leurs infants" (Bavoux,
1990, pag. 41)
L'autrice ipotizza che sia stata proprio la lingua creola a
mantenere la coesione all'interno del gruppo ma allo stesso
tempo a separarli dagli altri connazionali, mentre il loro status,
non elevato come quello degli altri indiani, li ha avvicinati alla
popolazione locale. I Sourti, che si considerano una comunità
creolizzata e musulmana, sono visti dai malgasci (che
I musulmani emigrati in Madagascar sono in prevalenza indiani
e comoriani.
Quelli provenienti dall'India2, iniziarono ad arrivare sull'isola a
partire dalla metà del XIX secolo, e sono dispersi nelle
principali città. Il termine malgascio per indicarli, Karana, è un
termine generalmente percepito come peggiorativo e
designante un alterità sospetta (Blanchi 1995, pag 191). Anche
il termine francese indo-pakistanaises è poco preciso perché
provengono per la maggioranza dal Gujarat, (stato centro
occidentale del sub-continente) e non hanno nulla a che fare
con i Pakistani, anche se alcuni di loro dopo l'indipendenza del
Pakistan, scelsero la nazionalità pakistana pur essendo indiani.
I Karana godono di un certo benessere perché sono proprietari
di molti negozi ed industrie. A questo benessere economico non
corrisponde però un'effettiva integrazione nella società
malgascia: spesso continuano a parlare la loro lingua d'origine
anche dopo molte generazioni ed è forte la tendenza a sposarsi
solo con membri dello stesso gruppo. E' chiaro che in alcuni
momenti gli indiani sono stati visti con invidia e si è generata
un'insofferenza per questo gruppo. Queste tensioni si sono
materializzate nel 1987 quando in alcune città, in particolare a
Toliary (sulla costa sud-ovest), sono avvenuti gravi moti antiindiani, con saccheggi ed incendi dei negozi, che per molti
testimoni sono stati possibili grazie alla complicità dei militari.
Questo rimane comunque un episodio a sé stante, dato che la
convivenza quotidiana è in generale pacifica.
Se è vero che la comunità Indiana sciita è sempre rimasta
distante dalla popolazione locale, va però segnalato che dal
1982 esiste a Morondava una missione islamica sciita indiana
che ha avuto un buon successo, registrando conversioni
soprattutto tra ex cristiani.
Due studi sui karana: i bohra ed i sourti
Tra i Karana si trovano diverse comunità, che, pur
condividendo il luogo di origine (il Gujarat), si sono ormai
caratterizzate a seconda della città dove si sono insediate e per
la divisione in diverse sette musulmane.
A titolo dimostrativo sintetizzo di seguito due studi, uno
attuale, e uno dell'inizio degli anni novanta, su due di questi
gruppi, che hanno avuto vicende molto diverse.
Lo studio che sta compiendo Denis Gay (2005), sulla comunità
Bohra (una delle tre comunità indiane sciite presenti sull'isola)
di Toliary riguarda una comunità di circa 6500 persone quasi
totalmente dedite al commercio. I Bohra sono caratterizzati da
una forte dispersione: dal Gujarat sono emigrati negli ultimi
secoli in 40 diversi paesi. Questo interessante studio mostra
come all'interno di questa piccola comunità si stia manifestando
53
ACHAB
raramente conoscono la loro storia), prima di tutto come
musulmani, mentre gli altri indiani li vedono essenzialmente
come risultato di un fenomeno di métissage.
Non ho rintracciato studi successivi sui Sourti, e credo sia
molto interessante vedere se ad oggi questo piccolo gruppo si
stia definitivamente disperdendo nella comunità locale o se
continua a mantenere una propria identità.
Quali sono le ragioni dei moti anti-islamici? Prendiamo come
caso paradigmatico i moti di Majunga del 1976, uno dei
momenti più drammatici nella storia recente del paese.
Durante il periodo coloniale le isole Comore (un paese a
maggioranza musulmana) facevano parte della stessa
amministrazione del Madagascar ed era quindi facile spostarsi
da uno stato all'altro, e molti comoriani poveri partirono per il
Madagascar in cerca di fortuna. A Majunga si formò una
comunità così numerosa che il termine Silamo in quella zona
venne utilizzato come sinonimo di comoriano.
A metà degli anni '70 cominciarono, anche causati dalla
situazione politica del momento, alcuni scontri con i locali, in
particolare con gli emigrati Bestirebaka, di fede cristiana,
arrivati dal sud del Madagascar dopo i comoriani, e che per
questo svolgevano lavori ancora più umili. Nel dicembre del
1976 dopo una serie di provocazioni, come il lancio di pezzi di
carne di maiale dentro la moschea di Majunga, i Bestirebaka
bruciarono e saccheggiarono molte abitazioni di comoriani.
Dopo 3 giorni di scontri, senza l'intervento della polizia, da
alcuni considerata complice (così come per i moti anti-indiani
del 1987), la città di Majunga, semi distrutta, si vedeva quasi
svuotata della popolazione musulmana di origine comoriana: il
bilancio era di 1000 morti, mentre circa 16.000 comoriani
"furono invitati" a ritornare al loro paese d'origine, che la
maggioranza non aveva mai nemmeno visitato. Quasi tutti i
beni di proprietà dei comoriani erano stati distrutti. Molti di
loro dopo alcuni anni ritornarono in Madagascar. E' proprio
dopo questi eventi che aumentarono le rivendicazioni da parte
dell'intera comunità religiosa musulmana per essere considerata
al pari delle altre comunità religiose del paese, e non è un caso
se pochi anni dopo, nel 1980, proprio a Majunga si tenne il
primo congresso dell'associazione musulmana nazionale, la
Silamo Malagasy.
Gli scontri di Majunga non sono avvenuti tanto per motivi
etnici o religiosi, quanto per motivi economici: i malgasci ed in
particolare gli emigranti Bestirebaka sono insorti contro i
comoriani perchè non potevano accettare che gli stranieri con i
quali condividevano i quartieri vivessero in condizioni (seppur
leggermente) più agiate di loro. E le stesse motivazioni di
ordine economico e non religioso, furono come abbiamo visto,
la causa degli scontri tra indiani e malgasci a Toliary, prova ne
è il fatto che subirono danni anche i Karana induisti.
In conclusione, quando parliamo di "minoranza islamica" in
Madagascar, ci riferiamo a una realtà varia ed in evoluzione.
Dietro a questa categoria apparentemente univoca si dipanano
tutta una serie di realtà culturali ed economiche spesso in
contrasto tra loro: un mondo che per essere compreso deve
essere colto nella sua complessità.
Quello del Madagascar è solo un esempio limitato, ma
comunque utile. Viviamo infatti in un periodo storico nel quale
molti e drammatici eventi vengono ricondotti, a causa di una
sorta di riduzionismo, alle sole differenze religiose. Si
La richiesta di un posto nella società malgascia
Gli studi etnografici classici del Madagascar, considerate la
collocazione geografica non omogenea, le diverse ondate di
arrivi, le diverse nazionalità dei credenti, hanno analizzato i
diversi gruppi musulmani come comunità a sé stanti. Ma c'è
qualcosa che unisce tutti questi gruppi? Quanti Islam ci sono in
Madagascar?
Noël Gueunier, (autore di "Les chemins de l'Islam à
Madagascar"), sostiene che, eterogeneità a parte, tra i Silamo vi
sia la consapevolezza dell'appartenenza alla Umma.
Questo senso di unità sarebbe emerso soprattutto a partire dagli
anni ottanta, dopo alcune sommosse avvenute nel paese (come
quella di Majunga sulla quale mi soffermerò brevemente). Si
tratterebbe quindi una forma di reazione a momenti in cui la
comunità intera si è sentita minacciata.
Circa venti anni fa è nata l'Associazione Nazionale Musulmani,
che ha organizzato vari convegni, ed è nato anche un giornale,
Feon'ny Silamo-La voix de l'Islam, realizzato grazie ai fondi di
un'associazione libica. Inoltre, molte associazioni di stati
musulmani, tramite le Ambasciate ad Antananarivo mandano
aiuti economici, Imam, ed offrono possibilità di borse di studio
all'estero. Sebbene ridotti, questi aiuti contribuiscono a
rafforzare il senso di appartenenza di tutti i Silamo. Sarebbe
sicuramente molto interessante monitorare la situazione attuale
per capire come cambia la percezione di sé in quanto
musulmano dei giovani malgasci che vanno a studiare all'estero
in paesi a maggioranza islamica e in quale forma stiano
arrivando nel paese questi aiuti in questo particolare momento
storico.
La comunità islamica sarebbe quindi cosciente che la religione
che li accomuna costituisca una matrice di identità, pur nella
grande eterogeneità che li caratterizza, ed è alla ricerca di un
suo spazio all'interno della società malgascia. In una recente
intervista, apparsa sull'"Express de Madagascar", l'Imam della
moschea di Antananarivo, Chaaban Léon, sottolinea:
"Bien que minoritaires, nous pouvons, quand même, dire que
nous avons notre place dans la société. Nous y sommes bien
intégrés. Après tout, nous sommes malgaches avant d'être
musulmans. Au départ, la majorité d'entre nous étaient installés
sur les côtes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le nombre de
la communauté musulmane sur les Hautes terres suit une
courbe ascendante"
54
ACHAB
dimentica (o si vuole dimenticare), che i vari fondamentalismi
e integralismi religiosi, sono mossi spesso da cause di matrice
economica e politica, cause che vanno tutte prese in
considerazione per avere una visione globale degli avvenimenti
storici.
Note
della popolazione, divisi tra cattolici e protestanti, sebbene i
missionari protestanti siano stati molto più intransigenti rispetto alle
pratiche di culto tradizionali. I musulmani costituiscono circa il 7%
della popolazione totale. (Fonte: US Department of State, Bureau of
African Affairs)
2
Gli indiani in Madagascar sono circa 20.000 (0.2% della
popolazione totale), per la maggior parte musulmani sciiti (Khodjia e
Bohra), un gruppo sunnita (Surti) e una ristretta minoranza Hindu,
(in malgascio Banians). Arrivano quasi tutti dal distretto indiano del
Gujarat. (Blanchy, 1995)
1
Attualmente il 47% della popolazione professa il culto degli
antenati. Le credenze legate alla religione tradizionale continuano ad
avere forti influenze anche fra i cristiani che costituiscono il 45%
Bibliografia
Asad, T. (1986), The Idea of an Anthropology of Islam, Occasional Papers, Georgetown University, Washington.
Bavoux, C. (1990), Islam et métissage, des Musulmans Créolophones à Madagascar, les Indien Sourti de Tamatave, l'Harmattan,
Parigi.
Blanchy, S. (1995), Karana et Banians, les communautés commerçantes d'origine indienne à Madagascar, l'Harmattan, Paris.
Bloch, M. (1971), Placing the Dead, Tombs, Ancestral Villages and Kinship organisation in Madagascar, Seminar Press, London.
Delval, R, (1978), “Les Musulmans à Madagascar en 1977”. in L'Afrique et l'Asie Moderne, 115.
Gay, D. (2005), “The policy of the religious centre in Bombay. Toward a Gujarati community of Madagascar”, in I quaderni del
CREAM 2005-III.
Graeber, G.(1995), “Dancing with corpses reconsidered: an interpretation of famadihana”, in American Ethnologist 22(2).
Gueunier, N.J. (1994), Les Chemins de l'Islam à Madagascar, l'Harmattan, Parigi.
Lambek, M. (1993), Knowledge and Practice in Mayotte: Local discourses of Islam, Sorcery and Spirit Possession, University of
Toronto Press, Toronto.
Mack, J. (1986), Madagascar, Island of the ancestors, The Trustees of the British Museum, London.
Middleton, K., (a cura di) (1999), Ancestors, power and history in Madagascar, Brill, Leiden.
Rakotomalala, M., Blanchy, S., (2001), Madagascar: les ancêtres au quotidien. Usage sociaux du religieux sur les Hautes-Terres
Malgasces, l'Harmattan, Paris .
55
ACHAB
La Verifica Incerta
Note a margine di una missione in Angola
di Michele Parodi
Lavorato ieri alla redazione di un progetto di "Prefazione" per l'eventuale
pubblicazione di queste note. Tesi: è attraverso la soggettività (portata al
parossismo) che si raggiunge l'oggettività. Più semplicemente: scrivendo
soggettivamente aumento il lavoro della mia testimonianza, mostrando che
ad ogni istante sono in grado di giudicarne la validità.
Michel Leiris, L'Afrique fantôme1
Sommario
Partendo da un'analisi critica delle recenti iniziative di solidarietà internazionale a favore dei paesi africani - dalle domande irrisolte
che pongono - per mezzo di una riflessione "incerta" e altrettanto critica, cerco qui di tirare le somme delle mie esperienze di
insegnante e cooperante in Africa. Il mio percorso di ricerca si sviluppa nelle trame di un viaggio, al medesimo tempo, teorico e
pratico. Un percorso che tenta d'indagare le ragioni e gli scopi della ricerca etnografica, all'interno di un'analisi riflessiva delle mie
motivazioni di studente di antropologia e di apprendista etnografo. Da un lato provo ad affrontare una serie di questioni legate al
ruolo dell'antropologia applicata: il problema etnografico delle pratiche di campo e dell'utilizzo dei "testi" raccolti durante la ricerca,
il problema della reciproca opacità, conflittualità delle motivazioni del ricercatore e dei suoi interlocutori. Dall'altro, ampliando la
mia riflessione in termini più filosofici, cerco di sondare le origini del mio impegno, provando a formularne una "genealogia morale".
In questo percorso le problematiche affrontate prospettano l'adozione di un impianto epistemologico e di una metodologia etnografica,
in grado di configurare l'antropologia come pratica sociale, luogo d'incontro e di comunicazione che dis-pone, disloca, destruttura il
soggetto-assoggettato, attivando processi interpretativi che organizzano una peculiare esperienza estetica.
ricchi ai drammatici problemi dell'Africa, si è svolto il 2 luglio 2005 a
Londra, Roma, Berlino, Parigi, Mosca, Filadelfia, Barrie (Canada),
Tokio, Johannesburg, in concomitanza con il G8 riunitosi in Scozia tra
il 6 e 8 luglio6; Bill Clinton ha convocato la sua Global Initiative a New
York tra il 15 e il 17 di settembre in coincidenza con l'apertura
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Possiamo chiederci se questa serie di recenti iniziative rappresenta
qualcosa di nuovo, se suggerisce una metamorfosi originale dei
rapporti tra Nord-Sud, tra paesi ricchi e paesi poveri. Oppure, se
riproduce e nasconde, tra le righe, le usuali formazioni discorsive dello
sviluppo, il sistema di potere che regola le sue pratiche, le forme di
soggettività attraverso le quali le persone giungono a riconoscersi come
sviluppate o sottosviluppate (Escobar 1995)7.
Ancora - apparentemente per la prima volta -, si tratta di promuovere
un altro sviluppo, uno sviluppo libero dagli errori e dai pregiudizi del
passato, in grado di mutare la sorte dei popoli indigenti dell'Africa. In
base a questi propositi, lo sviluppo, di fronte ai poco brillanti risultati
del suo corso precedente, deve essere rinnovato, ma al medesimo
tempo rimane la certezza indiscutibile dell'immaginario sociale, una
forma di "colonizzazione della realtà" prodotta da pratiche storiche che
combinano conoscenza e potere. Vi è qui una carenza di pensiero che
Introduzione: c'è un'altra Africa?
Si parla spesso della tragedia africana, "dell'agonia di un continente che
muore di fame, di malattie, di mancanza d'acqua, d'ingiustizie"2.
Secondo i più recenti rapporti delle istituzioni internazionali "la povertà
e la stagnazione in Africa sono la più grande tragedia dei nostri tempi.
Una povertà di dimensioni così vaste esige una risposta energica"3.
Dal 1975 ad oggi le prospettive di vita nell'Africa sub-Sahariana sono
progressivamente peggiorate. Attualmente la vita media alla nascita è
di solo 49 anni. Il 10% degli africani tra i 15 e i 45 anni sono HIV
positivi e la tubercolosi e la malaria sono endemiche in molte aree. Dal
1987 a 1998 la percentuale della popolazione che vive con meno di un
dollaro al giorno è passata dal 46.6% al 46.3% raggiungendo un picco
del 49.7% nel 19934. Nonostante i ripetuti e ciclici proclami, colmi di
buone intenzioni, la cooperazione internazionale non è riuscita ad
invertire questa tendenza. Così ancora una volta possiamo formulare la
ricorrente domanda: "Che fare per aiutare l'Africa?"
Nel 2005 abbiamo assistito al lancio di nuove campagne di solidarietà
internazionale: la Commission for Africa promossa dal primo ministro
britannico Tony Blair ha pubblicato il suo primo rapporto l'11 Marzo
20055; il Live 8, il grande concerto benefico "globale" organizzato da
Bob Geldof per sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi dei paesi
56
ACHAB
manifesta la rigidità di costruzioni retoriche pervasive, sostanzialmente
autoreferenziali, la cui decostruzione sociale può avvenire solo
attraverso complessi processi di smontaggio e ricomposizione
culturale.
Queste recenti iniziative non riconoscono la singolare e multiforme
creatività dei molteplici contesti africani. Non riconoscono pienamente
le ragioni strutturali del sottosviluppo, le relazioni di dipendenza che
legano i PVS ai PSV, limitandosi a proporre "più commercio e
commercio più equo"8.
L'idea che il nuovo fermento d'iniziative per l'Africa non esca da una
logica di tipo postcoloniale, nasce proprio dalla ripetitività quasi
parossistica dei discorsi messi in campo da queste proposte:
un'eccezionale moltiplicarsi di conferenze, dibattiti, pubblicazioni,
appelli ad un rinnovato impegno "concreto" a favore dei meno fortunati
del mondo9, come se fosse avvenuto un cortocircuito tra assoluto e
immediato e finalmente fosse giunto il giorno decisivo dove "ciò che
prima era interno alla coscienza esplode fuori improvvisamente,
s'impossessa del mondo esterno e lo trasforma"10. Nella loro
autoreferenzialità, nella loro proliferazione mimetica, tali discorsi - e le
ritualità caricaturali, i dispositivi, ad essi associati - ricordano
sensibilmente le pratiche discorsive coloniali. Un linguaggio che
"avanza sordo alle silenziose vibrazioni che emana, ripetendo se stesso
senza fine […] prigioniero di questo meccanismo linguistico"
(Mbembe 2005: 207), consumandosi nella sua iterazione:
soggiorno a Port Harcourt sul delta del Niger, dove ho insegnato fisica
e matematica in una scuola internazionale italiana, ha rappresentato per
me soprattutto una sfida esistenziale - l'iniziazione ad un altro mondo,
il primo impatto con una realtà spaesante totalmente "altra" -, l'attività
di cooperazione e mediazione culturale in Angola (parte di un progetto
di gemellaggio tra una scuola elementare di Roma e una scuola
elementare di Luanda) ha fornito lo scenario delle mie prime
esperienze di campo dove confrontarmi con i paradigmi teorici e gli
strumenti metodologici acquisiti durante la specializzazione in
antropologia12.
Questa fusione di teoria e pratiche di campo, di vita e attività
professionale, sperimentata soprattutto nel mio ultimo viaggio in
Angola, mi è servita per superare sin dall'inizio le dicotomie di una
scienza oggettivante ritenuta neutrale, accogliendo una visione
dell'antropologia come pratica sociale e culturale, come prassi
inevitabilmente compromessa con il proprio essere politico ed
esistenziale. Pratica, quindi, eminentemente etica e perciò
continuamente chiamata a rispondere della propria responsabilità di
fronte agli effetti del suo agire. Operare autobiografico, che,
parafrasando le ultime righe di Thick Description (Geertz 1987: 71),
svolgendosi nel mondo pubblico della vita ordinaria osserva le
dimensioni simboliche dell'azione sociale - l'arte, la religione,
l'ideologia, la scienza, il diritto, la moralità, il senso comune -, senza
allontanarsi dai dilemmi esistenziali della vita alla ricerca di qualche
empireo di forme desensibilizzate, volendo invece immergersi in
mezzo ad esse.
In questa prospettiva la conoscenza etnografica tende a radicarsi negli
atti che, dischiudendo i suoi orizzonti, al contempo invalidano ogni
possibile presa di stampo meramente speculativo. Si apre qui
quell'eccesso pratico che precipita il dire teorico verso il suo
rovesciamento autobiografico, nel luogo dove l'incontro mancato dal
logos si rovescia nell'incontro sempre riuscito nel reale.
Auto-bio-grafia, significa, allora, vita che scrive se stessa giocando
sull'apertura di una mancanza, questione di un incontro contingente, di
avventura.
Tuttavia, la scoperta di tale mancanza, si manifesta anche in processi di
incorporazione e oggettivazione: riduzione narcisistica dell'altro a mera
differenza, addomesticamento e neutralizzazione di alterità ambivalenza tra l'enfatizzazione del simile e del diverso che blocca la
sua comprensione. In questa portata violenta o conflittuale la
dimensione comunicativa di un incontro vis à vis sembra sposarsi, in
strane corrispondenze, con la dimensione culturale. Il particolare e il
generale, il locale e il globale, l'esistenziale e il politico si
sovrappongono in forme molteplici di risonanza: lo "specchio
coloniale" (Taussig 1984)13, o post-coloniale, si duplica nel rapporto
speculare con il prossimo a cui ci accostiamo, le proiezioni culturali si
sovrappongono ed entrano in vibrazione con le simbolizzazioni
dell'altro che l'inconscio personale elabora nel tentativo di afferrarlo.
A partire da queste considerazioni, la responsabilità a cui siamo
chiamati nel momento in cui ci accostiamo all'altro14, nelle pratiche
dello sviluppo come nelle pratiche della ricerca etnografica, muove,
dalla confusione tra rappresentazione e reale15, verso una comprensione
della loro differenziazione (ontologica), fino a scorgere in tale
differenza l'eco operoso di se stessi, della propria identità personale e
«discorso d'incantamento [che] raccogliendo voci e pettegolezzi,
amplificandoli col raccontare, aspira a chiarire cose che lo tormentano e lo
ossessionano - cose di cui non sa, in realtà, assolutamente nulla» (ibidem: 208).
Discorso che "in questo modo non fa che rincorrere la propria ombra"
(ibidem), melanconia o nostalgia imperialista sagomata dalla storia
coloniale, storia ampiamente disconosciuta ma sotterraneamente
capace di continuare a plasmare la vita politica delle ex potenze
imperiali (Gilroy 2004). Colpi di cannone sparati a intervalli regolari,
ingoiati da una giungla immobile, nera e silenziosa (Conrad 1978: p.
51)11.
A fronte di tali complesse problematiche, la mia avventura parte forse
da qui, dalla domanda irrisolta che le varie iniziative promosse dagli
agenti e dagli apparati dello sviluppo, chiusi nei circoli viziosi di
discorsi incapaci di trovare parole nuove per riflettere su se stessi, non
sanno soddisfare.
1. Una verifica incerta
Partire per l'Africa. Cooperazione in un progetto di educazione allo
sviluppo in Angola. Verificare sul campo una serie di questioni legate
al ruolo dell'antropologia applicata. Il mio percorso di ricerca si
sviluppa nelle trame di un viaggio, al medesimo tempo, teorico e
pratico. Un percorso che cerca di indagare le ragioni e gli scopi della
disciplina all'interno di un'analisi riflessiva delle mie motivazioni di
apprendista antropologo e delle esperienze di cooperante-educatore
maturate recentemente, in una breve missione in Angola (MarzoAprile 2005) e, in un passato ormai sfuggente, durante una permanenza
di circa 2 anni in Nigeria (tra il 2000 e il 2002). Se il prolungato
57
ACHAB
culturale in cammino. L'Altro, allora, può assumere le forme di un
interrogativo, di una domanda che ci seduce e che ci invita a parlare e
stabilire un dialogo. Un rapporto non pacificato né da un'empatia
caritatevole, né da un relativismo radicale, entrambi sempre disponibili
a trasformarsi in prospettive oggettivistiche universalizzanti16.
L'altro, come opacità limite, mantiene un potere di iniziazione a quella
dimensione singolare che è preclusa al soggetto. Ciò da cui il soggetto
rimane escluso è ciò che è agli occhi dell'altro, il suo essere "altro" per
l'altro17. Da qui, la funzione di distanziamento del soggetto dai suoi
condizionamenti, operata da tale rapporto di alterità. Il sistema di
precomprensioni del soggetto si riflette nell'altro, risultando così
visibile al soggetto medesimo, sebbene solo come traccia o resto.
l'alterità dell'altro, il suo resto, eliminato dalla scena, è obliato come
epifenomeno irrilevante all'analisi antropologica.18 Invece è proprio il
dialogo, nella sua duplice forma di insieme di enunciati dotati di
contenuto (il "detto"), e di specifici e pragmatici atti di parola
pronunciati in un incontro (il "dire"), che permette lo stabilirsi di una
produzione di senso dove la mancanza, l'indicibile dell'altro, diventa
efficace: nel rapporto di reciprocità e di asimmetria che un dialogo di
alterità accorda (ibidem: 176-177).19
Dunque il campo e il dialogo: viaggiare, oggettivare l'altro e aprirsi
all'altro cercando di conservarne la diversità. Ma, come ci ricorda
Silvana Borutti, citando Roberto Esposito (Esposito 1993), questo
doppio legame irresolubile è forse il problema stesso dell'Occidente
(Borutti 1999: 201). La sua medesima forma: perenne "volontà […] di
sapere sé attraverso l'altro senza riuscire mai a trovare altro che se
stesso" (ibidem).
L'antropologia si pone qui al centro di un difficile problema eticopolitico: "l'impossibilità di tenere separate la volontà di sapere
occidentale, dal rapporto di potere che l'Occidente è" (ibidem). Ciò che
emerge non è più solo una questione di ordine epistemologico. Si tratta
invece di un problema che invita a riflettere sugli scopi della ricerca
etnografica. Se questa relazione di potere é stata ed é ancora, per molte
ragioni (economiche, politiche, culturali), la "precondizione strutturale
per l'antropologia" (Asad 1973; Gough 1968), siamo invitati a pensare
in che modi l'antropologia, anche oggi, resti parte delle "narrative"
dell'egemonia occidentale e delle forme di occultamento della propria
culturalità (Malighetti 2005).
In ambito accademico, ha prevalso la volontà di considerare prioritari
l'impresa scientifica e gli interessi teorici dei ricercatori, rispetto alle
esigenze locali degli interlocutori e degli informatori con cui gli
etnografi sono venuti a contatto. Tale visione dell'antropologia non è
però mai stata del tutto unanime. La questione della responsabilità
dell'antropologia nei confronti delle persone studiate, dai pionieristici
scritti di Malinowski di antropologia applicata all'amministrazione
coloniale (Malinowski 1929, 1930), ai testi di Hymes (1972), fino ai
recenti dibattiti sull'etica della disciplina (Caplan 2003; Fluer-Lobban
1991), ha percorso il dibattito accademico, con cicliche fasi di più
acceso confronto interno20, segnando il tentativo degli antropologi di
costituirsi come "moral comunity" (Caplan 2003: 5).
Stavenhagen individuava già agli inizi degli anni settanta due
prospettive da cui guardare la questione: un punto di vista attento agli
usi e all'applicazione del sapere scientifico sociale e uno sguardo
riflessivo sulle modalità e gli effetti della pratica professionale della
scienza sociale applicata. Due aspetti intimamente collegati e
reciprocamente condizionati: la natura e la qualità della ricerca e la
diffusione dell'informazione a potenziali utilizzatori. Stavenhagen
proponeva di praticare una "de-elitizzazione" del sapere scientifico:
Se queste idee mostrano le ragioni del mio agire etnografico interne ad
una speculazione più filosofica, ve ne sono altre specifiche di una
riflessione propriamente antropologica.
2. Antropologia applicata
I miei primi studi teorici, durante la specializzazione in antropologia
culturale, hanno avuto come punto d'inizio l'analisi e la valutazione
critica dei testi di Clifford Geertz.
Superando la frattura della pratica etnografia Malinowskiana, tra "il
fuori testo", il diario, il racconto aneddotico, e la monografia
scientifica, Clifford Geertz è stato tra i primi a proporre "una
sospensione dell'elaborazione teorica sistematica in favore della
sperimentazione etnografica" (Malighetti 2000b: 139; cfr. 1991). Nei
suoi lavori la pratica etnografica "diventa luogo di vitalità del pensiero
[…], la stessa definizione della disciplina" (ibidem: 140). Il campo con il suo carattere di esperienza quotidiana processuale, spaesante,
dialogica -, come afferma Silvana Borutti, diventa
«l'operatore epistemologico privilegiato, capace di decostruire l'immagine
positivista della conoscenza come rapporto neutro di rappresentazione tra un
soggetto teoreticamente e metodologicamente attrezzato, e un oggetto separato
e passivo» (Borutti 1999: 171).
La comparazione, tradizionale principio metodologico
dell'antropologia "classica", in Geertz, si sviluppa a partire dalla
costruzione di concetti integrati con il livello etnografico, nozioni
aperte frutto di un processo dialettico tra concetti vicini e lontani
dall'esperienza del nativo (Geertz 1988: cap. 3). In questo contesto
epistemologico, la comparazione non agisce più su un sistema
predefinito di tassonomie inclusive, ma diviene modalità fluida di
attraversamento traduttivo dell'altro, in grado di svelarne le strutture
relazionali, le somiglianze di famiglia.
In Geertz, permane, però, un residuo d'interpretativismo che continua
ad occultare la complessità delle procedure di oggettivazione che
accadono sul campo. Nonostante la dichiarata volontà di svelare il
punto di vista nativo, i suoi interlocutori "sono di fatto lasciati in
silenzio, o meglio, sono trasformati (loro che sono soggetti enuncianti),
in testi, in sistemi […]; si mantengono i significanti, ma si cancella
l'enunciazione" (Borutti 1999: 172). "La qualità di esperienza
epistemica del campo risulta in questo modo depotenziata" (ibidem), e
«Credo che parte del problema sia dovuto alla diffusione del prodotto della
ricerca ad un determinato pubblico. Tuttavia non è solo questione della
trasmissione dell'informazione in sé: perché la natura e le caratteristiche di
questa trasmissione (se inserita nella stessa ricerca, attraverso un dialogo
creativo fra ricercatore e l'oggetto-soggetto della ricerca) la trasformerebbero in
un processo di apprendimento reciproco e cambierebbe, dunque, la stessa
58
ACHAB
ammettere, come osserva James Clifford, che
natura dell'attività scientifica. Questo - trasposto nell'area problematica della
ricerca - è ciò che Paulo Freire chiama dialogia nella Pedagogia degli
Oppressi» (Stavenhagen in Malighetti 2001: 242).
«I pochi esperimenti recenti di lavori con più autori sembrano richiedere, come
forza istigatrice, l'interesse di ricerca di un etnografo, il quale in definitiva si
assume una responsabilità direttiva, redazionale» (1999: 69).
Al centro della sua analisi è il problema etnografico delle pratiche di
campo e dell'utilizzo dei testi raccolti durante la ricerca, trascritti,
manipolati, e pubblicati infine in veste monografica.
Da un lato affrontare questo problema implica un serio coinvolgimento
nella traduzione del linguaggio professionale in concetti quotidiani che
i propri interlocutori possano comprendere, facendo si che il dialogo
iniziato sul campo possa continuare nel reciproco confronto sui testi
pubblicati21. È necessario riflettere sul proprio ruolo di "esperti", sul
ruolo che hanno i codici di comunicazione nel reprimere la possibilità
dell'"altro" di esprimersi. A questo proposito l'antropologia dialogica
contemporanea si è spinta fino a proporre la rinuncia da parte
dell'etnografo-antropologo di una parte della sua autorità (nella scelta
dello stile espositivo e degli argomenti da considerare rilevanti, nel
produrre ed autorizzare interpretazioni), a favore di una sua
condivisione problematica con gli interlocutori del campo,
promuovendo forme di polifonia dove "l'etnografia è invasa
dall'eteroglossia" (Clifford 1999: p. 68).
In secondo luogo, significa indirizzare l'attenzione del ricercatore verso
la questione delle relazioni che egli mantiene con la società più vasta in
cui agisce (Stavenhagen in Malighetti 2001: 242), comprendendo nelle
proprie indagini una riflessione sul funzionamento delle burocrazie,
delle élite politiche ed economiche, delle agenzie dello sviluppo, delle
gerarchie ecclesiastiche, dei mass media, dei sistemi educativi (ibidem:
244) di cui è testimone o partecipe, includendo quindi il sistema della
ricerca scientifica e l'università, così sviluppando la capacità di
riflettere sul ruolo che il potere assume anche all'interno dei contesti
sociali dove l'antropologo produce il suo sapere.22
Mettere insieme questi due atteggiamenti comporta l'esercizio di un
complicato strabismo, o di una difficile bifocalità, significa abituare il
proprio sguardo ad espandersi e ritrarsi secondo un movimento in
grado di rendere dinamiche le forme e i confini del campo, così da
rivolgersi sia al locale che al globale, al contingente e all'uniforme, ai
luoghi tradizionali del campo, dell'incontro, del dialogo - arena in cui
una molteplicità di attori interagiscono mescolandosi o confliggendo a
partire da una varietà di pratiche e strategie -, e ai luoghi retorici della
scrittura, della messa in forma e infine della pubblicazione e diffusione
dei risultati della ricerca. Parafrasando la concezione dei tre corpi
dell'antropologia medica teorizzata da Nancy Scheper-Hughes e
Margaret Lock (1987), significa concepire lo studio dell'uomo in una
prospettiva al medesimo tempo fenomenologica e intersoggettiva (il
corpo personale), simbolica interpretativa (il corpo sociale e le sue
rappresentazioni), attenta infine ai dispositivi e alle forze esercitate dal
biopotere politico (il corpo politico). Una prospettiva quindi
necessariamente multivocale e multisituata (Malighetti 2005: 37;
Marcus 1995) che tenta di cogliere nella quotidianità la rete dei poteri
globali, trasversali e "mobili", che attraversano le frontiere spaziali e
temporali dei panorami del presente (Pandolfi 2005).
Se queste ipotesi operative invitano l'antropologia ad assumere il carico
delle sue responsabilità senza pretendere, in nome della scienza, di
potersi muovere alla cieca, disinteressandosi dei suoi effetti, bisogna
Il problema delle motivazioni del ricercatore, dei suoi interlocutori e
della loro reciproca opacità e conflittualità, emerge qui sostanzialmente
irrisolto: infatti non può essere sbrogliato teoricamente prescindendo
dalle esperienze personali e dai differenti interessi che l'incontro sul
campo svela e produce, né può essere evitato cercando di coinvolgere
i "nativi" con doni e promesse, cioè con la violenza e la forza della
propria autorità. Come sostiene Roberto Malighetti, l'operazione
conoscitiva non può neppure fondarsi unicamente sulla "complicità
ontologica" e sui vincoli di "affinità" o di "co-appartenenza" che legano
interprete e interpretato, sullo sforzo di incrociare le interpretazioni dei
nativi con quelle dell'antropologo, gli aspetti emici con quelli etici, i
concetti vicini all'esperienza con i concetti distanti (Malighetti 2004:
56-57). Malighetti nella ricostruzione della sua esperienza di ricerca
etnografica in Brasile, così racconta le difficoltà incontrate nella
comunità di Frechal23:
«Nel corso del lavoro mi resi conto che era proprio il modello epistemologico
a non funzionare. L'opacità dei miei interlocutori e le difficoltà del lavoro
mettevano in crisi l'ottimismo cognitivo su cui si basava. [...] Il mio approccio
interpretativo non arrivava, cioè, a concepire il sottile gioco d'interferenza fra
le componenti personali e autobiografiche e le componenti disciplinari della
ricerca» (Malighetti 2000a).
Malighetti ha quindi operato una traslazione metodologica decisa a
riconsiderare la pratica etnografica in quanto pratica sociale e il lavoro
sul campo come il fondamento distintivo della disciplina (cfr. Parodi
2004).
In conclusione, se la ricerca per essere dialogica deve coinvolgere e
essere coinvolta dai suoi interlocutori, allora deve essere in grado di
accogliere le motivazioni che da essi provengono orientandosi in tal
senso. A mio avviso, fare propria questa prospettiva significa spingersi
fino a negoziare sul campo anche l'oggetto d'indagine, il punto di
partenza così cruciale nel definire il destino di una ricerca. Un simile
atteggiamento è in grado di non compromettere sin dall'inizio la pratica
etnografica in una logica coloniale di spogliazione e "deculturazione",
una logica ancora intrappolata dal desiderio di rappresentare,
controllare, dirigere l'altro secondo presupposti "etnocentrici"24. É
importante provare a rispondere alla domanda che Gayatri
Chakravorty Spivak formulava a metà degli anni ottanta: "Can the
Subaltern Speak?" (Spivak 1985), capire in che modo le pratiche di
campo rendano possibile o difficile costruire relazioni dialogiche. Si
tratta, come ci ricorda Kilani, di "re-inventare" un'antropologia "come
disciplina attenta a parlare all'altro, non più a parlare dell'altro"(Kilani
1997: 68).
Compiuto un primo giro su noi stessi, che potrebbe sembrare un girare
a vuoto, possiamo tornare a chiederci: chi favorisce la ricerca nei suoi
vari momenti? Quali vincoli e quali dispositivi crea o subisce? Quali
59
ACHAB
motivazioni agevolano un suo esito positivo, e quali produce? Quale
fine può inseguire l'indagine etnografica?
inter-soggettività umana ha modo di esprimersi in un dialogo: atto di
creazione, atto di amore per la vita e per gli uomini (ibidem).
Non si tratta qui di raggiungere un'impossibile empatia con i propri
interlocutori (nel senso di una completa immedesimazione con il
sentire di un altro26), ma di evitare che il proprio lavoro sia confinato ad
un'azione strumentale, mera messa in atto di un macchinario
metodologico, azione deprivata da una dimensione riflessiva.
Se le motivazioni delle persone coinvolte nella ricerca, il loro
coinvolgimento collaborativo, sono importanti, altrettanto importanti
sono le motivazioni e il coinvolgimento dell'antropologo. La ricerca sul
campo si svolge lontano dai propri affetti, esclusi per lunghi periodi di
tempo da molte delle abitudini quotidiane che costruiscono le nostre
identità. Si può resistere anche per anni a questa condizione spaesante,
guidati da una forza di volontà allenata ad una lotta senza fine per non
perdersi d'animo. Come osserva James Clifford27, i diari di Malinowski
(1992) testimoniano di questa possibilità, costituiscono anzi il supporto
stesso, complementare alla finzione salvifica degli Argonauti
(Malinowski 2004), su cui l'autore fonda un'identità unificata
concepibile ai "confini della civiltà occidentale" (Clifford 1999: 120).
Nel campo si manifestano tutti i dispositivi di controllo e
disciplinamento del sé. Il lavoro metodico e sistematico consente di
resistere alla pericolosa attrazione della frontiera disintegratrice. La
personalità etica, sorvegliata, viene realizzata incessantemente
mediante il lavoro: "un credo deliberato, una fedeltà assoluta a certi
aspetti delle convenzioni" (ibidem: 130)28.
Vi sono, però, altri esempi che mostrano altre direzioni. Possiamo
menzionare il missionario e antropologo francese Maurice Leenhardt,
i suoi lavori etnografici frutto di un soggiorno protrattosi per circa 25
anni in Nuova Caledonia. Michel Leiris, nella sua recensione (Leiris
2005) a Gens de la Grande Terre (1937), ricorda il suo modo
straordinariamente familiare di parlare delle genti kanak. Conosceva
perfettamente la lingua vernacolare e le abitudini della vita quotidiana,
i miti e la visione del mondo kanak. Nonostante i suoi lavori non siano
indenni dall'influenza della sua vocazione missionaria, - che costituisce
però anche la motivazione e la ragione di una permanenza sul "campo"
così prolungata -, come evidenzia Clifford, rappresentano il tentativo di
afferrare secondo una "percettività estetica e gestaltica" (Clifford 1999:
52) l'altro nella sua totalità, attraverso un contatto sensoriale e
simpatetico con la "sua gente", e una conoscenza cumulativa sempre
più approfondita.
Andando indietro nel tempo incontriamo Frank Hamilton Cushing e i
suoi studi sugli indiani Zuni tra cui visse tra il 1879 e il 1884. Cushing
era intenzionato a calarsi completamente nel mondo indiano, allo
stesso tempo proponendosi di stabilire un rapporto di reciprocità con
coloro che lo avevano iniziato ai segreti della loro religione. Nel 1882
girò gli Stati Uniti con un piccolo gruppo di Zuni a cui cercò di
mostrare la propria cultura.29
Certo, la ricerca antropologica mantiene una specificità che la distingue
da un generico attivismo. È anzi proprio la sua singolarità, la messa in
questione dei propri ed altrui pregiudizi, a far si che una prassi
antropologica critica, riflessiva, dialogica sia in grado di sfuggire alla
chiusura di una militanza politica ideologicamente schierata.
L'ideologia, citando le osservazioni di Ricoeur a Conoscenza ed
interesse, non è un accidente, ma la sistematica deformazione della
3. Ideologia, prassi e decostruzione etnografica
Ogni domanda nasconde una doppia faccia. Se da un lato, come
interrogativo enigmatico è sempre legittima - apertura alla prassi di
fronte ad un domandarsi indecifrabile - dall'altra, ipotizzando
implicitamente una risposta che scioglie l'inquietudine che sosteneva il
suo principio poietico, risolvendosi allora in una speculazione
fondamentalmente sterile, costituisce e costruisce il presupposto
ideologico di un pensiero reificante.
Così ogni domandare sulle motivazioni, le aspettative, i desideri che
anche un incontro di campo alimenta, non sfugge a questa ambiguità.
Ogni spiegare presenta una doppiezza, tra reificazione e utopia. Si tratta
allora di non fare della domanda un pensiero alienato, inscrivendola
invece in una prassi creativa.
Possiamo ripartire allora da qui, dal riconsiderare la dinamica dei
processi di oggettivazione e il loro ambiguo situarsi tra ideologia e
invenzione, tra la realizzazione di ciò che era già stabilito e previsto e
il virtuale, l'emergere di un complesso problematico, di un nodo di
forze generativo e vitale (Deleuze 1972; Levy 1997: cap. 1).
Come già sosteneva Habermas in Conoscenza e interesse, il processo
sintetico si caratterizza e si inscrive in una prassi:
«Soggetto della costituzione del mondo non è una coscienza trascendentale in
generale, bensì il concreto genere umano che […] riproduce la sua vita. […] Il
sistema delle attività oggettive crea le condizioni di fatto della possibile
riproduzione della vita sociale e contemporaneamente le condizioni
trascendentali della possibile oggettività di oggetti dell'esperienza» (cit. in
Ricoeur 1994: 239-240).
La sintesi non è oggettivazione di una coscienza, ma quella di
un'attività. È la prassi sociale, materiale e simbolica ad essere supporto
e ragione della sintesi. Un'economia, intesa come accordo di rapporti di
scambio e di produzione, prende il posto di una logica fondata su una
pura appercezione del mondo.
Seguendo l'idea proposta da Ricoeur nelle Conferenze su ideologia e
utopia, la comprensione del lavoro sociale come sintesi permette di
riconsiderare il concetto di Lebenswelt, di mondo della vita - formulato
da Husserl nella Critica delle scienze europee - in termini storici, come
caratterizzazione contingente del divenire-uomo dell'uomo (Ricoeur
1994: 240). Ogni finzione in questa prospettiva assume un carattere
generativo e dinamico. Citando Lukacs, possiamo pensare la storia
come il luogo dell'ininterrotto "sovvertimento delle forme di
oggettualità che plasmano l'esistenza dell'uomo" (Lukacs 1967: 245),
espressione di una umanità come compito infinito, fine verso cui siamo
diretti e che incessantemente tentiamo di portare alla vita25. La
dicotomia tra conoscenza e agire pratico è così superata nel concetto di
prassi, attività al contempo produttiva e riflessiva.
Anche la ricerca etnografica, può configurarsi come praxis, attività
umana globale - conoscitiva, politica, personale e collettiva -, incontro
in cui, come nella proposta pedagogica di Paulo Freire, "si fanno
solidali il riflettere e l'agire […][di] soggetti orientati verso un mondo
da trasformare e umanizzare" (Freire 1971: 107), dove l'essenziale
60
ACHAB
globalizzazione ha generato effetti particolarmente nocivi dove la
destrutturazione-ristrutturazione culturale, di per sé implicita in ogni
situazione di "contatto", si è accompagnata alla distruzione forzata
delle forme di autorità e reciprocità sociale locali. Se la sfera pubblica
è annichilita, la fase di liminarità rischia di perdurare indefinitamente.
Una carenza politica strutturale impedisce la riorganizzazione, di per sé
sempre ibrida e meticcia, delle culture, trasformandole in deformi e
vaghi fantasmi, ombre sbiadite ed inefficaci con cui gli individui, nella
loro singolarità, affrontano un mondo sempre più enigmatico.
Potremmo pensare qui ad una irrisolta "crisi della presenza" (de
Martino 1975), ad una "liminarità congelata" e sospesa dove le persone
abitano territori a cui non appartengono più33. Per queste ragioni la
pratica antropologica non può scindersi da un radicale atteggiamento
dialogico e da una difficile e contraddittoria militanza politica che
aspiri all'emancipazione dei suoi interlocutori e dei gruppi organizzati
che li rappresentano.
relazione dialogica, un disagio della comunicazione (Ricoeur 1994:
250). L'ideologia è il sistema di resistenza al ripristino della relazione
dialogica che un sistema di potere mette in atto per conservare un
dominio e riprodursi nell'assoggettamento del subalterno (ibidem)30.
L'occultamento della complessità relazionale della ricerca etnografica,
la negazione della prossimità e coevità implicata dai vincoli conoscitivi
di campo, l'allocronia, la creazione di un tempo altro dove collocare il
nativo (Fabian 2000) - tempo altro rispetto il luogo del testo, dove la
sincronia tra l'autore e il pubblico a cui parla definisce il nativo come
persona assente31 - tutto ciò, costituisce la rimozione della situazione
dialogica.
All'interno di una prospettiva critica, l'antropologia può svolgere un
ruolo significativo nel decostruire forme ideologiche di
assoggettamento, quando fa prevalere ad un interesse cognitivo
incentrato sulla rappresentazione dell'altro e alle metodologie
oggettivanti costruite sul dato, un interesse comunicativo fondato su
pratiche dialogiche in grado di innescare una reciproca riflessione:
sommovimento che lascerà vedere crepe, incrinature, varchi, passaggi
attraverso i quali altro può avvenire. Riflessione non solo teoricodiscorsiva, ma anche pratica in quanto partecipe di una prassi sociale.
L'antropologia si trasforma in un pensiero della relazione, rivolto verso
l'esterno, attirato dall'aria aperta (Laplantine 2004: 29). È allora
evidente, come già osservato nel primo paragrafo, che il ruolo
dell'antropologia non può essere quello di assimilare l'altro,
riconducendolo ad una relativa differenza quantitativa, ma è invece
quello di conservare la sua Alterità, mostrandone la presenza utopica,
all'interno di una processo di trasformazione e umanizzazione della
natura32. L'antropologo e suoi interlocutori, sul campo, determinano
una relazione comunicativa "artificiale" in cui lo stabilirsi di una specie
di transfert, di una fase esplicativa "neutrale", permette il formularsi di
una critica riflessiva non astratta, ma immediata ed esperienziale.
Come stranieri, si condivide una sorta di obbiettività che consente di
accedere a "confessioni e rivelazioni tenute nascoste alle persone più
intime" (Simmel in Crapanzano 1995: 176). Il ruolo di "indigeno
marginale" (Freilich 1970) dell'antropologo, il mantenimento di un
margine di dissidenza, la sua alterità mancante, rappresenta il
simmetrico dell'assenza, del vuoto ermetico ma prolifico che egli
cercherà di portare a casa, al ritorno dal suo viaggio.
Victor Segalen, nel Saggio sull'esotismo, scriveva: "L'esotismo non è
dunque un adattamento; non è la perfetta comprensione di un fuori-disé che si rinchiuderebbe in sé, ma l'acuta ed immediata percezione di
un'eterna incomprensibilità […]. Non illudiamoci d'assimilare gli usi,
le razze, le nazioni, gli altri; al contrario rallegriamoci di non poterlo
mai fare; ci riserviamo così il perdurare del piacere di sentire il
Diverso" (Segalen 1983). Questo "piacere" non è il frutto di un
atteggiamento estetizzante, ma invece il momento cruciale
dell'incontro etnografico. Lo spaesamento prodotto dall'impatto con
un'alterità "incomprensibile" determina uno spazio di elaborazione e
negoziazione reciproca, in cui gli idiomi di una cultura possono venir
parzialmente destrutturati e quindi ristrutturarsi su un nuovo piano. Qui
ci troviamo di fronte ad un nodo teorico e pratico molto delicato:
smontare le forme culturali è un operazione assai pericolosa quando
non vi è alcun insieme sociale organizzato in grado di superare questa
fase di "liminarità". La deculturazione prodotta dal colonialismo e dalla
La distanza che divide antropologia generale, antropologia applicata e
cooperazione allo sviluppo, nella prospettiva fin qui tracciata può forse
essere riconsiderata. Nella seconda parte di questo lavoro, a partire
dalle mie esperienze di cooperante in Angola, cercherò di pensare le
questioni di ordine teorico, epistemologico e politico che spingono ad
una convergenza di queste attività verso una comune prassi aperta ai
rispettivi contributi.
(Fine della Prima Parte).
Note
*
La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata nel prossimo numero di Achab.
Leiris 1984, p. 222.
2
Famiglia Cristiana n. 28, luglio 2005.
3
Rapporto della Commission for Africa, 11 Marzo 2005, Sintesi Conclusiva.
4
Banca Mondiale, Word Development Report, 2000/2001.
5
Il Rapporto della Commission for Africa contiene "un pacchetto coerente per
l'Africa", un insieme di raccomandazioni che affrontano problemi fra loro
strettamente connessi, "circoli viziosi che si rafforzano a vicenda". I
provvedimenti studiati dalla commissione propongono tra l'altro di aumentare
la somma destinata agli aiuti all'Africa, con l'obiettivo di raggiungere la soglia
dello 0,7% del rapporto tra il totale degli aiuti e il totale del PNL dei paesi
donatori - soglia proposta già nel 1969 dal Rapporto Pearson, Partners in
Development, e accolta dalle Nazioni Unite.
6
Il Live 8, simbolicamente rappresentato dal logo di una chitarra con la sagoma
dell'Africa, replica, a distanza di vent'anni, il Live Aid dello stadio di Wembley,
il primo grande concerto filantropico, organizzato il 13 luglio 1985 per aiutare
l'Etiopia che moriva di siccità e carestia.
7
Traduzione parziale italiana in Malighetti 2001, pp. 296-308. Cfr. Apthorpe
(in Malighetti 2005). Per un confronto con le pratiche discorsive della retorica
coloniale vedi anche i testi di Asad (1973) e Said (2001) a cui Escobar si ispira.
8
Cfr. Rapporto della Commission for Africa, 11-3-2005, Sintesi Conclusiva.
9
Appelli insistenti, come ad esempio lo slogan della Commission for Africa:
«Making it happen». Ancora più incalzanti e ostinati sono i richiami di Make
Poverty History (coalizione di associazioni caritatevoli e religiose, sindacati,
1
61
ACHAB
celebri personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, che
si propone durante il 2005 di mobilitare l’opinione pubblica mondiale e
accrescere la pressione sui governi nazionali e sulle organizzazioni
internazionali affinché prendano provvedimenti concreti per combattere la
povertà endemica in molti paesi del Sud del mondo): «act now», «take action»,
«If not our generation, who? If not in 2005, when? Please join us».
10
K. Mannheim, Ideologia e utopia, 1929. Cit. in Ricoeur 1994, p. 303.
11
In un altro passo del romanzo ispirato al suo viaggio sul fiume Congo,
Conrad descrive le impressioni del protagonista, il suo sguardo sulle sponde
enigmatiche del fiume: "Eravamo uomini erranti su una terra preistorica, su
una terra che assumeva l'aspetto di un pianeta sconosciuto. […] L'uomo
preistorico imprecava contro di noi, c'implorava, ci dava il benvenuto - chi
poteva dirlo? Noi eravamo tagliati fuori da poter comprendere l'ambiente che
ci circondava; scivolavamo oltre come fantasmi, stupiti e segretamente
sgomenti, come dei sani di mente dinanzi a un'esplosione di entusiasmo in un
manicomio" (Conrad 1978: p. 109). Conrad era chiaramente cosciente
dell'incapacità sua e degli amministratori coloniali di comprendere il mondo
africano.
12
Presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
13
Michael Taussig allude ad una forma di mimesi, fondamento epistemico della
cultura coloniale. Lo specchio coloniale riflette sui colonizzatori la barbarie
delle loro medesime relazioni sociali, barbarie imputate alle "selvagge" figure
che vorrebbero assimilare. Ogni dominazione per essere praticabile produce
una violenza che proietta sul proprio oggetto, così nascondendone l'origine.
Ciò che l'ideologia coloniale attribuisce all'altro è così il riflesso degli atti che
essa consente e genera.
Nel contesto del mondo contemporaneo, tale retorica prende forme inedite: è
la povertà, l'indigenza, piuttosto che la selvatichezza e le barbarie, a funzionare
da elemento mobilitante l'intervento occidentale negli stati sorti alla fine del
colonialismo. Dove nello schema coloniale è la violenza ad essere attribuita
all'altro, qui sono le origini della povertà, origini in verità rintracciabili nel
processo di espansione del sistema capitalistico mondiale. Se la retorica
coloniale legittima "un sistema che produce inevitabilmente impoverimento,
malnutrizione, dsorganizzazione, demoralizzazione e graduale decadimento
demografico, […] spedizioni punitive […], massacri di massa dei nativi […][e]
strane rappresaglie nel nome della giustizia, del prestigio e dell'onore dell'uomo
bianco" (Malinowski in Malighetti 2005: 9), l'apparato dello sviluppo si iscrive
nel medesimo sistema della modernità occidentale, legittimando azioni
ingiustificabili, occultate per mezzo di eufemismi e tautologie. "Pazzie
tropicali" usate per difendere "la condotta così come la mentalità dell'uomo
bianco in Africa" (Malinowski in Malighetti 2001: 89).
Come osserva Kilani: "in quanto padroneggiata, la differenza dell'altro rafforza
o restituisce vigore al proprio sistema di significazione e alla propria identità"
(Kilani 1997: 81). Si chiude così il cerchio: un potere capace di manipolare
l'altro produce un sistema di discorsi che consente la messa in opera di una
dominazione inizialmente solo potenziale. Il discorso coloniale e postcoloniale
- profezia che si auto avvera provocando ciò che attribuisce (per il caso dello
sviluppo cfr. Rist 1997) - può essere rappresentato, allora, alla stregua delle
istituzioni totali studiate da Goffman: "dove l'esistenza è scarnificata fino
all'osso, possiamo vedere ciò che le persone fanno per sopravvivere" (Goffman
1968: 322). Comportamenti "anomali", "cattiva condotta", "persistere
dell'individuo nel manifestare i propri sintomi, […] tendenza a sviluppare altri
sintomi attraverso le sue risposte reattive" (ibidem: 323). Si tratta qui di un
circolo vizioso: gli atti di ostilità contro l'istituzione coloniale devono fondarsi
su strumenti limitati (insolenza, silenzio, mancata collaborazione, distruzione
di beni), ma più questi strumenti sono inadeguati a rappresentare un rifiuto
consapevole del dominio, più appaiono come sintomi di inferiorità, brutalità,
selvatichezza, irresponsabilità, irrazionalità, sintomi su cui si legittima
l'intervento coloniale (ibidem). Così, la necessità del potere di riprodursi
controllando ciò che potrebbe sfuggirgli, l'evento, l'individuo nella sua
singolarità, si manifesta qui non solo nella riduzione dell'alterità dell'individuo
a se medesimo, ma nella cortocircuitazione di tale mancanza destabilizzante a
strumento di repressione.
14
L'altro nelle sue molteplici forme: "l'altro esotico, definito rispetto ad un noi
che si suppone identico; […] l'altro sociale, l'altro interno in riferimento al
quale si istituisce un sistema di differenze […]. L'altro intimo, infine, […]
presente nel cuore di tutti i sistemi di pensiero, la cui rappresentazione,
universale, risponde al fatto che l'individualità assoluta è impossibile" (Augé
1993: 22).
15
Nella terminologia di Lacan il reale si mostra come estraneità che resiste ad
ogni tentativo di significazione.
16
La presunzione di avere finalmente visto in faccia l'altro, di averlo
riconosciuto come differenza o somiglianza, si accompagna alla convinzione
del superamento dei propri pregiudizi. Pregiudizi che in questo modo si
raddoppiano, nascondendosi al nostro sguardo. Le forme di relativismo
radicale, implicando distanziamento e segregazione culturale, sono incapaci di
concepire la dinamica dei fenomeni di negoziazione, dialogo, conflitto che la
coevità delle culture comporta (cfr. Borutti 1999: 168-169).
17
Accolgo qui la meditazione di Lacan sul compito del linguaggio, fenomeno
evocativo più che informativo, dove cercare nella parola dell'altro ciò che ci
costituisce come soggetto (cfr. Funzione e campo della parola e del linguaggio
in psicoanalisi, in Lacan 2002; in particolare pp. 292-93). Gli scritti di Lacan
degli anni settanta, come ci ricorda Massimo Recalcati, prendono distanza
dalla logica ermeneutica di decifrazione del simbolico, "mettendo l'accento non
sul movimento del senso ma sul suo arresto, sul punto di eclissi del senso. […]
L'interpretazione deve isolare nel soggetto un 'cuore di nonsenso', deve,
anziché decifrare il senso, dare rilievo ad un reale che resiste ad ogni
significazione. […][La verità] non è allora ciò che l'interpretazione decifra
sottraendo dal velo, ma piuttosto qualcosa che sorprende, che colpisce il
soggetto, che colpisce nella forma di un incontro. E in questo incontro [sempre
mancato] qualcosa cede nella superficie levigata, liscia dei discorsi e si produce
un effetto di spiazzamento" (Recalcati 2001: 116-17).
18
Per una critica a Geertz, in particolare del suo saggio sul combattimento dei
galli nell'isola di Bali (Geertz 1987), vedi anche Clifford (1999: 57), Tedlock
(2002: 295, 306); per una critica dell'antropologia simbolica vedi Fabian (2000:
158-168).
19
Paul Rabinow, sviluppando le idee di Frederic Jameson in Postmodernism
and Consumer Society (1983), osserva come la prospettiva postmodernista
interpretativa, caratterizzata da un approccio testuale che sconnette i
significanti in pastiche fluidi e discontinui, finisca per ignorare i rapporti tra
forme di rappresentazione e pratiche sociali. L'etnografia postmodernista
avendo come unico riferimento se stessa implica il necessario "fallimento del
nuovo e la reclusione nel passato": "la ribellione dei moderni diverrebbe sterile
e non le rimarrebbe altro che 'imitare stili morti'", assemblaggio di maschere in
un 'fantastico da biblioteca' in cui i soli referenti del testo sono altri testi, altre
immagini, allusivo ed elusivo plagiare precedenti intrecci e proliferare di metariferimenti (Rabinow 2001: 333-335). Secondo Rabinow, lo stesso Clifford,
preso ad esempio di questa meta-posizione intellettuale, non parla
specificatamente di relazioni con l'altro, se non quando mediano il suo
principale interesse analitico: i tropi discorsivi. Il "ricercatore" postmoderno
rimane così cieco rispetto alla sua medesima condizione (ibidem: 336). Questo
ripiegamento sul testo e su una riflessività sconnessa dalle pratiche sociali é il
principale rischio di un'antropologia postmodernista.
20
Possiamo ricordare le polemiche suscitate dalla pubblicazione di Darkness in
El Dorado (Tierney 2000), o gli scandali successivi alla scoperta del
coinvolgimento di antropologi in progetti di contro-insurrezione in Cile
(Progetto Camelot, 1965) e in Thailandia (1970). Cfr. Fluer-Lobban 1991.
21
James Clifford parla del problema del "rimpatrio", dei modi in cui consentire
il riappropriarsi delle etnografie da parte delle popolazioni indigene. Vedi ad
esempio Clifford 2004, p. 96.
62
ACHAB
22
secondo il suo informatore Andrew Peynetsa riguardava probabilmente
Cushing. Il racconto parla di un bianco sacerdote dell'Arco, pitturato con righe
nere che leggeva le preghiere su un pezzo di carta (ibidem: 298).
30
Habermas cerca di sfuggire in tal modo ai circoli viziosi che produce la
contrapposizione tra ideologia, come falsa rappresentazione, e verità come
oggettività. Il discorso ideologico, seguendo qui Foucault, non è in se stesso né
falso né vero. È uno specifico "sistema di procedure ordinate per la produzione,
la distribuzione e il funzionamento di enunciati" (Rabinow 2001: 323).
31
Fabian in Il tempo e gli altri (1983), dedica un paragrafo del suo libro (pp.
107-115), alla funzione retorica del presente etnografico. L'uso del presente e
di un soggetto alla terza persona (ad esempio: "I Nuer non hanno governo")
testimonia l'essere stato là dell'etnografo (uso del presente), e ne oscura, al
medesimo tempo, la presenza (uso della terza persona), così fondando la sua
autorità di osservatore distaccato, neutrale e oggettivo. "Egli", il nativo, diventa
una persona assente, una non-persona, oggetto di contemplazione estetica. De
Certeau, commentando le "strategie teoriche" di Bourdieu (cfr. de Certeau
2001: 95-104) parla di una "etnicizzazione" del nativo: la coerenza di una
società, per divenire il postulato del sapere antropologico, deve essere messa a
distanza dai suoi membri, diventando quel sapere "occulto", inconscio, mistico,
superiore al sapere che il nativo ha di se stesso, che per rendersi visibile implica
la presenza di un etnografo (ibidem: 99).
32
La natura, in quanto parlata, non può che essere già umanizzata dal
linguaggio. Se si mantiene come qualcosa di autonomo non riducibile alla
prassi, questa priorità vale solo all'interno di una prassi che ne fornisce un senso
configurandola come possibilità, come materia e strumento di un lavoro
umano. Così, la natura non può essere "assolutizzata in modo da giungere ad
un principio metafisico; solo all'interno della prassi può essere evidenziato quel
momento della prassi stessa che ne costituisce un presupposto autonomo"
(Cingoli 2000: 114). Ciò che deve essere spiegato storicamente non è allora
"l'unità degli uomini viventi e attivi con le condizioni naturali inorganiche del
loro ricambio materiale con la natura […], ma la separazione di queste
condizioni inorganiche dell'esistenza umana da questa esistenza attiva" (Marx
1968: vol. II, p. 114). Una concezione dualistica del rapporto tra uomo e natura
anziché pensare la natura come limite che circonda e penetra continuamente
l'uomo e il suo fare, veicola un'idea di natura come ente radicalmente altro
dall'uomo, concezione in cui la natura si riduce ad oggetto manipolabile dalle
tecniche, bene di consumo, oppure ad una realtà lontana, incontaminata,
vergine, e per questo ancora politicamente neutrale, priva di ogni legame con
le pratiche quotidiane della vita, discorso di incantamento che occulta le reali
operazioni di sfruttamento a cui sono sottoposte le risorse naturali (cfr. Escobar
1999; Vedi anche la voce Ambiente in Sachs 2004).
33
Tale situazione di anomia ricorda quella dei moderni campi profughi (cfr.
Bauman 2004, pp. 188-203; Vedi anche Agier 2001; Floris 2005).
L'importanza del ruolo pubblico dell'antropologia, già evidenziato nei
Principles of Professional Responsability (PPR) dell'American
Anthropological Association (AAA 1971, cit. in Caplan 2003: 20-21), tra gli
antropologi americani é recentemente tornato al centro del dibattito
accademico (cfr. 99-esimo incontro annuale dell'AAA, The Public Face of
Anthropology, San Francisco, 15-19 Novembre, 2000; vedi anche Borofsky
2002).
23
Comunità di discendenti di schiavi del Nord-Est del Brasile.
24
Certo da qualche parte bisogna partire e da qualche parte bisogna arrivare.
Assumere la responsabilità che un incontro tra alterità coinvolge significa
allora aprirsi all'evento, lasciare venire l'altro verso di noi concedendogli la
nostra ospitalità. Cfr. Resta 2003. Vedi in particolare il cap. 3, Politiche
dell'ospitalità.
25
Cfr. Ricoeur 1994, p. 276. Di Ricoeur vedi anche: Dal testo all'azione, 1989
[1986], in particolare la parte terza: Ideologia, utopia, politica. Come afferma
il filosofo e antropologo tedesco Arnold Gehlen nel suo opus maius: L'uomo.
La sua natura e il suo posto nel mondo (1983 [1940, ed. rivista nel 1950 e
1978]), l'esigenza dell'uomo di interpretare se stesso non è solo teoretica.
Questa necessità di progettarsi nasce dal carattere essenzialmente incompiuto
dell'uomo, ente non costituito una volta per tutte, "che deve fare di sé qualcosa"
(ibidem: 36), divenendo quindi agente e creatore di cultura.
26
Essendo invece sempre possibile un "sentire con", un "sentire per", una
simpatia che non implica una condivisione totalizzante, ma un orientamento
cognitivo ed emotivo verso l'altro. Non si tratta di simulare il sentire altrui, ma
di comprenderlo nel proprio specifico "essere con" l'altro. Per una proposta
riguardo all'importanza del concetto heideggeriano di "essere-con" [mitsein]
nelle pratiche etnografiche, vedi D'angelo 2006.
27
J. Clifford, Sul modellamento etnografico dell'io: Conrad e Malinowski
(Clifford 1999: 115-139).
28
Clifford confronta le finzioni retoriche dell'autore degli Argonauti e dei Diary
con le parole del protagonista di Cuore di tenebra: "Marlow, nel cuore
dell'Africa, si aggrappa come se ne andasse della vita, al suo battello, alle
incombenze di routine della manutenzione e della navigazione" (Clifford 1999:
120): "Dovevo vigilare sul governo, e aggirare quei tronchi sommersi, e far
procedere quel barattolo di latta per amore o per forza. C'era tanta verità alla
superficie di tali cose da salvare anche un uomo più savio" (Conrad 1978: 111).
29
Per una rassegna storica della collaborazione tra etnografi, informatori e
comunità, da Morgan e Boas agli esperimenti dialogici post-moderni di
Dweyer e Crapanzano, fino alle più recenti strategie partecipative, vedi Lassiter
2005. Sulla paradossale posizione di Cushing e sui residui moralistici contenuti
nelle sue traduzioni dei testi Zuni - "bizzarrie vittoriane" che violano
apertamente i principi boasiani del buon interprete, testimoniando così
l'impossibilità di una indigenizzazione totale dell'etnografo -, vedi le analisi di
Dennis Tedlock (2002: 63-66, 298-299). Tedlock riferisce una storia Zuni che
Bibliografia
Agier M., Aux bords du monde, le réfugiés, Paris, Flammarion, 2001.
Apthorpe R., Il discorso delle politiche dello sviluppo, in Malighetti, 2005.
Asad T. (a cura), Anthropology and the colonial encounter, Ithaca & Humanities Press, 1973.
Augé M., Nonluoghi, Elèuthera, 1993 [1992].
Bauman Z., Amore liquido, Laterza, Roma-Bari, 2004 [2003].
Borofsky R., Conceptualizing public anthropology, www.publicanthropology.org, 2002.
Borutti S., Filosofia delle scienze umane, Mondadori, Milano, 1999.
Caplan P. (a cura), The Ethics of Anthropology, Routledge, New York, 2003.
Conrad J., Cuore di tenebra, Feltrinelli, Milano, 1995 [1902].
Cingoli M., Marxismo, empirismo, materialismo, Edizioni Ghibli, Milano, 2000.
Clifford J., I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Bollati Boringhieri, Torino, 1999 [1988].
- Ai margini dell'antropologia, Meltemi, Roma, 2004 [2003].
63
ACHAB
Clifford J., Marcus G., Scrivere le culture, poetiche e politiche in etnografia, Meltemi, Roma, 2001 [1986].
Crapanzano V., Tuhami, Meltemi, Roma, 1995 [1980].
D'angelo, L., Ismaele, il testimone. Per un'etica della testimonianza in antropologia, "Achab", N. 7, 2006.
De Certeau M., L'invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001 [1990].
Deleuze J., Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna, 1972 [1968].
de Martino E., Morte e pianto rituale, Boringhieri, Torino, 1975 [1958].
Escobar A., Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton, 1995.
- After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology, "Current Anthropology", Vol. 40, N. 1, Feb. 1999.
Esposito R., Nove pensieri sulla politica, Il Mulino, Bologna, 1993.
Fabian J., Il tempo e gli altri, l'ancora s.r.l., 2000 [1983].
Floris F., Non-luoghi, città e ville nue, Quaderni del CREAM, Trauben, Torino, 2005.
Fluer-Lobban C. (a cura), Ethics and the profession of Anthropology: Dialogue for a New Era, University of Pennsilvania Press, 1991.
Freilich M. (a cura), Marginal Natives, Mouton, New York, 1970.
Freire P., La pedagogia degli oppressi, Mondadori, 1971 [1970].
Geertz C., Interpretazione di culture, Il Mulino Bologna, 1987 [1973].
- Antropologia interpretativa, Il Mulino Bologna, 1988 [1983].
Gehlen A., L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano, 1983 [1940].
Gilroy P., After Empire. Melancholia or Convivial Culture?, Routledge, London, 2004.
Goffman E., Asylums, Einaudi, Torino, 1968 [1961].
Gough K., Anthropology, child of imperialism, Monthly Review, Aprile , vol. 19, n. 11, 1968.
Habermas J., Conoscenza e interesse, Laterza, Bari, 1990 [1968].
Hymes D. (a cura), Reinventing Anthropology, Random House, New york, 1972.
Kilani M., L'invenzione dell'altro, Dedalo, Bari, 1997 [1994].
Lacan J., Scritti, Einaudi, Torino, 2002 [1966].
Laplantine F., Identità e métissage, Elèuthera, 2004 [1999].
Lassiter L. E., Collaborative Ethnography and Public Anthropology, "Current Anthropology", vol. 46, n. 1, Feb. 2005.
Latouche S., L'altra Africa. Tra dono e mercato, Bollati Boringhieri, Torino, 2000 [1997].
Leiris M., L'Africa fantasma, Rizzoli, Milano, 1984 [1934].
- Carabattole (titolo orig. Fourbis seconda parte di La Règle du jeu), Einaudi, Torino, 1998 [1955].
- L'occhio dell'etnografo, Boringhieri, Torino, 2005.
Levy P., Il virtuale, Cortina, Milano, 1997 [1995].
Malighetti R., Il filosofo e il confessore. Antropologia ed ermeneutica in Clifford Geertz, Unicopli, Milano, 1991.
- Identità e lavoro sul campo nel Quilombo Frechal, "La ricerca Folklorica", n. 41, 2000a.
- Il lavoro etnografico, in U. Fabietti, R. Malighetti, V. Matera, Dal tribale al globale, 2000b.
- Antropologia Applicata (a cura), Unicopli, Milano, 2001.
- il Quilombo di Frechal, Cortina, Milano, 2004.
- Oltre lo sviluppo (a cura), Meltemi, Roma, 2005.
Malinowski B., Argonauti del Pacifico occidentale, Bollati Boringhieri, Torino, 2004 [1922].
- Practical Anthropology, "Africa", vol. 2, n. 1, 1929; trad. it. parziale in Malighetti 2001.
- The Rationalization of Anthropology and Administration, "Africa", vol. 3, n. 4, 1930; trad. it. parziale in Malighetti 2001.
- Giornale di un antropologo, Armando, Roma, 1992 [1967].
Marcus G. E., Ethnography in/of the world system, "Annual Review of Anthropology", n. 24, 1995.
Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, a cura di Enzo Grillo, La Nuova Italia, Firenze, 1968.
Mbembe A., Postcolonialismo, Meltemi, Roma, 2005 [2000].
Pandolfi, M., Sovranità mobile e derive umanitarie: emergenza, urgenza, ingerenza, in Malighetti 2005.
Parodi M., Una recensione riflessiva di un'etnografia dialogica: il Quilombo di Frechal, "Achab", N. 3, 2004.
Rabinow P., Le rappresentazioni sono fatti sociali. Modernità e postmodernità in antropologia, in Clifford, Marcus 2001.
Recalcati M., Il vuoto e il resto. Il problema del reale in J. Lacan, CUEM, Milano, 2001.
Ricoeur P., Dal testo all'azione, Jaca Book, Milano, 1989 [1986].
- Conferenze su ideologia e utopia, Jaca Book, Milano, 1994 [1986].
Rist G., Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Boringhieri, Torino, 1997 [1996].
Sachs W., Dizionario dello sviluppo, EGA Editore, Torino, 2004 [1992].
Said E., Orientalismo, Feltrinelli, Milano, 2001 [1978].
Scheper-Hughes N., Lock M., The Maindful Body, "Medical Anthropology Quarterly", vol. 1, n. 1, 1987.
Spivak G. C., Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow-Sacrifice, "Wedge", 7/8, 1985.
Segalen V., Saggio sull'esotismo. Un'estetica del diverso. Pensieri pagani, Il cavaliere azzurro, 1983.
Stavenhagen R., Decolonizing Applied Social Sciences, Human Organization, v. 30, n. 4, 1971.
Tedlock D., Verba manent. L'interpretazione del parlato, l'ancora s.r.l, 2002 [1983].
Taussig M., Culture of Terror - Space of Death, "Comparative Studies in Society and History" 26, Cambridge, 1984.
64
ACHAB
Visitate il nuovo sito di Achab
www.achabrivista.it
La rivista è interamente scaricabile in formato .pdf
Pubblichiamo di seguito l’indice del n. 11,
settembre-dicembre 2006, della rivista:
Zapruder Storie in movimento
Rivista di storia della conflittualità sociale
Posta elettronica: [email protected] (redazione)
[email protected] (progetto Storie in movimento)
Sito Web del progetto: www.storieinmovimento.org
Quadrimestrale - euro 10,00
Abbonamento ordinario 3 numeri: euro 25,00
www.storieinmovimento.org/zapruder/abbonamenti.html
Editoriale
Paola Ghione, Quando si rompe la comunità si rompe il mondo?
Zoom
Municipalismi e resistenze (articoli e Dietro le quinte)
Riccardo Rao, Lo spazio del conflitto. I beni comunali nel Piemonte
del basso medioevo
Nicolangelo D'Acunto, Il santo conteso. Tensioni politico-religiose
fra Assisi e il papato nel medioevo
Patrizia Quattrocchi, Donne, riproduzione e salute comunitaria in un
villaggio maya dello Yucatán (Messico)
Le immagini
Danilo De Marco, Fiori di fango. Polvere del suolo del
Latinoamerica
Margherita Becchetti, Ritratti ribelli. Guerra e vita quotidiana nei
disegni di una pittrice partigiana
Schegge
Armando Cutolo, Stranieri in casa propria. La guerra civile in Costa
d'Avorio
Marco Adorni, La via del benessere. Storia della superstrada E45
In cantiere
Giovanni Campolo, Il genere dimenticato. Piccolo viaggio intorno
agli studi sugli uomini
Voci
Marilena Moretti, La rivoluzione non è una cosa seria
Altre narrazioni
Mario Monicelli, Insoliti eroi. Intervista tra cinema e storia (a cura di
Andrea Palazzino)
Luoghi
Rodolfo Taiani, Carte d'identità. Tradizioni comunitarie e usi civici
negli archivi della Val di Fiemme
Gianmario Leoni, Orgosolo paese dei murales
La storia al lavoro
Luca Fanelli, Il contadino e il ladro di terre. Espropriazioni e
resistenze nel Brasile
Storie di classe
Davide Montino, Il regime nel registro. Fascismo e missione
magistrale nella storia di Ernesta F.
Interventi
Stefano Agnoletto, Declinare il declino. A proposito di una categoria
ambigua
Franco Milanesi, Il Novecento tra storia e filosofia
Davide Spagnoli Cruciverbone sul comunismo
Recensioni
Andrea Cavazzini (Antonella Cutro, Biopolitica. Storia e attualità di
un concetto); Maria Beatrice Di Castri (Luciano Canfora, Il papiro di
Dongo); Fabrizio Billi (John Dos Passos, Davanti alla sedia
elettrica); Marco Fincardi (Dorena Caroli, Ideali, ideologie e modelli
formativi); Eric Gobetti (Arthur J. Evans, A piedi per la Bosnia
durante la rivolta); Silvia Boffelli (Giovanni Giacopuzzi, Angelo
Miotto, Roberta Gozzi, Storie basche).
Note per la consegna e la stesura degli articoli.
Gli articoli dvono essere in formato Word o Rich Text Format (.rtf). Si consiglia di usare il carattere times
o times new roman corpo 12.
L'articolo deve avere di norma una lunghezza minima di 3 cartelle e massima di 15 (interlinea 1,5; corpo
12). Si consiglia di ridurre al minimo le note che non dovranno essere inserite in automatico ma digitate
come testo alla fine dell'articolo. Nel testo il numero della nota deve essere inserito mettendolo tra parentesi.
Gli articoli devono essere spediti al seguente indirzzo: [email protected]. La redazione provvederà
a contattare gli autori.
ACHAB
Foto di Jim Richter - Filippine, 2004
www.gotouring.com/razzledazle/articles/cockphoto013.html