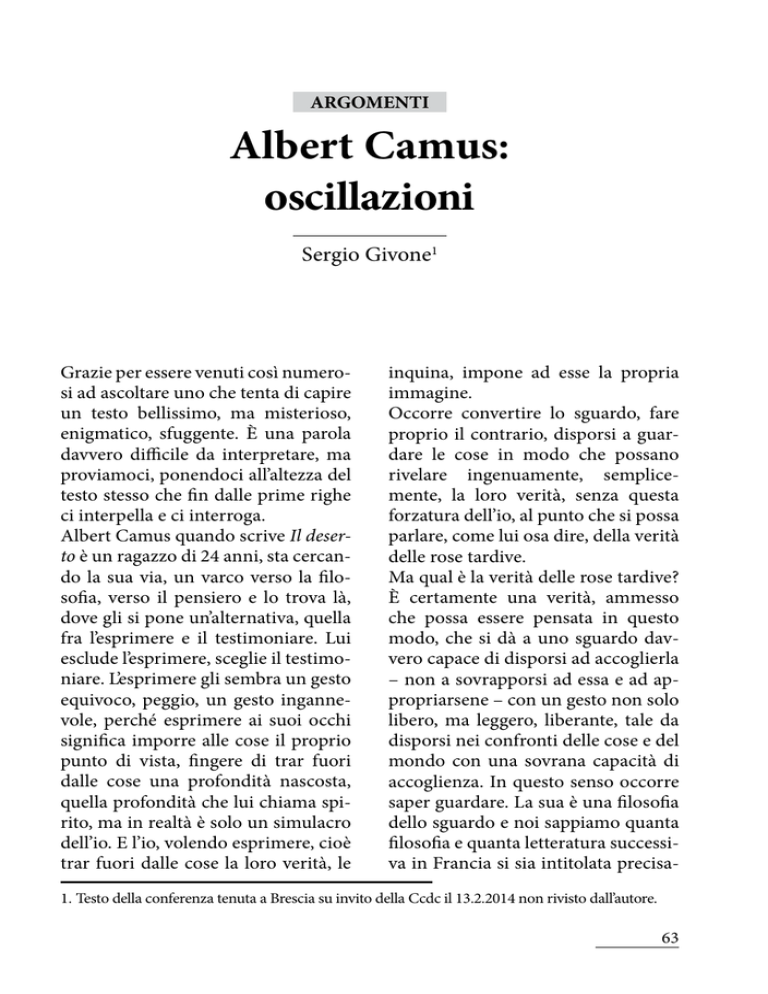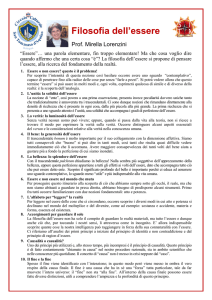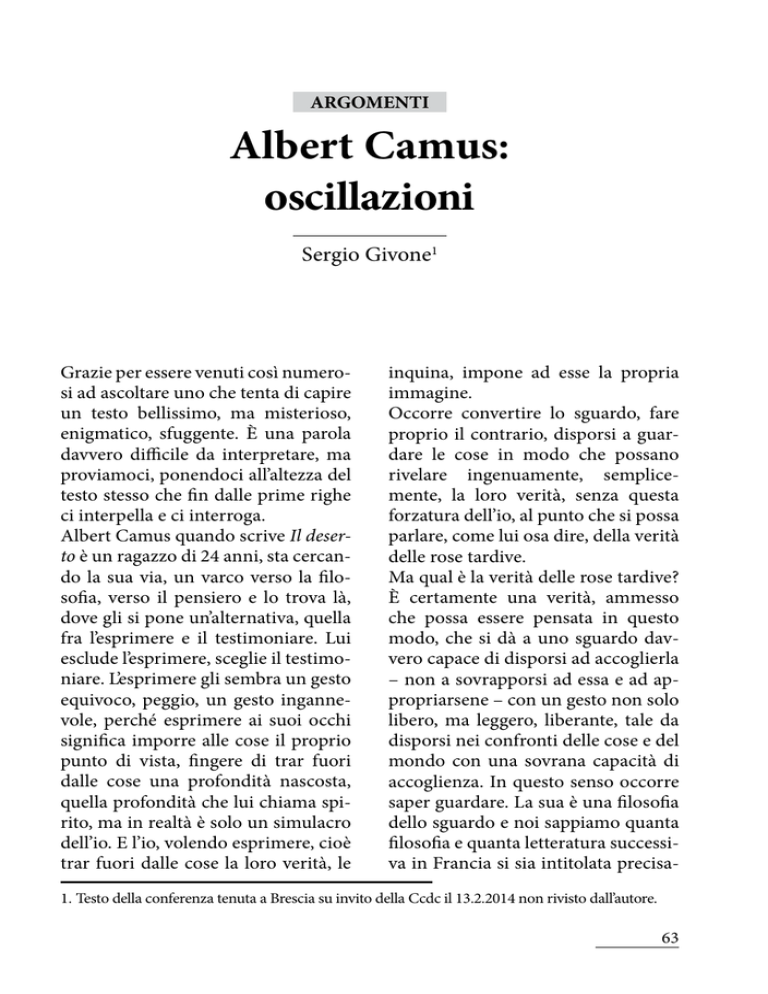
ARGOMENTI
Albert Camus:
oscillazioni
Sergio Givone1
Grazie per essere venuti così numerosi ad ascoltare uno che tenta di capire
un testo bellissimo, ma misterioso,
enigmatico, sfuggente. È una parola
davvero difficile da interpretare, ma
proviamoci, ponendoci all’altezza del
testo stesso che fin dalle prime righe
ci interpella e ci interroga.
Albert Camus quando scrive Il deserto è un ragazzo di 24 anni, sta cercando la sua via, un varco verso la filosofia, verso il pensiero e lo trova là,
dove gli si pone un’alternativa, quella
fra l’esprimere e il testimoniare. Lui
esclude l’esprimere, sceglie il testimoniare. L’esprimere gli sembra un gesto
equivoco, peggio, un gesto ingannevole, perché esprimere ai suoi occhi
significa imporre alle cose il proprio
punto di vista, fingere di trar fuori
dalle cose una profondità nascosta,
quella profondità che lui chiama spirito, ma in realtà è solo un simulacro
dell’io. E l’io, volendo esprimere, cioè
trar fuori dalle cose la loro verità, le
inquina, impone ad esse la propria
immagine.
Occorre convertire lo sguardo, fare
proprio il contrario, disporsi a guardare le cose in modo che possano
rivelare ingenuamente, semplicemente, la loro verità, senza questa
forzatura dell’io, al punto che si possa
parlare, come lui osa dire, della verità
delle rose tardive.
Ma qual è la verità delle rose tardive?
È certamente una verità, ammesso
che possa essere pensata in questo
modo, che si dà a uno sguardo davvero capace di disporsi ad accoglierla
– non a sovrapporsi ad essa e ad appropriarsene – con un gesto non solo
libero, ma leggero, liberante, tale da
disporsi nei confronti delle cose e del
mondo con una sovrana capacità di
accoglienza. In questo senso occorre
saper guardare. La sua è una filosofia
dello sguardo e noi sappiamo quanta
filosofia e quanta letteratura successiva in Francia si sia intitolata precisa-
1. Testo della conferenza tenuta a Brescia su invito della Ccdc il 13.2.2014 non rivisto dall’autore.
63
mente allo sguardo.
Questo testo è pieno di lampeggiamenti, più che di ragionamenti, e
questi lampeggiamenti sono per l’appunto le immagini del mondo che si
danno a uno sguardo capace di coglierne la verità, non lo spirito nascosto nelle pieghe delle cose, non il cuore che non sappiamo bene cosa sia,
ma la superficie, ciò che solo l’occhio
può guardare. Da questo punto di vista il suo è, anche se non dichiarato,
un tentativo di ritornare alle origini
della filosofia greca, che è una filosofia dello sguardo. Theorèin, questa
parola che è tutt’uno con la filosofia,
da cui teorema, significa per l’appunto guardare, con uno sguardo come
i greci chiamavano euparàdektos, che
sa cogliere le cose secondo una verità
tutta piena, una verità che non viene
tradita, che non è prospettica.
Quello che Camus cerca a Firenze
nel 1937 è appunto una filosofia dello
sguardo. Noi sappiamo che lo scritto
Il deserto è certamente del 1938, ma
ci sono delle tracce che ci fanno pensare che probabilmente la redazione,
quella così piena, densa e bella di
cui noi disponiamo, è stata costruita
sulla base di appunti che aveva preso dopo una passeggiata al Giardino
del Cavaliere. Tutto denota una visita
appena fatta, con particolari che possono essere riprodotti solo su un taccuino che un viaggiatore si porta con
sé. Quei cachi, per esempio. Io sono
stato al Giardino del Cavaliere, è un
giardino che sta a cavallo fra la città
e la campagna, la sommità di Bo64
boli. È così chiamato perché si vede
da una parte la distesa di colline che
diradano e declinano verso Siena e
dall’altra parte invece la città. Camus
parla di cachi. Questi cachi lo hanno
colpito. Il succo che sembra quasi di
percepire, lui lo vuole rendere. Non
ci sono cachi nel Giardino del Cavaliere e poi è strano che ci siano cachi
in quel giardino, anche perché Boboli
è un giardino che è stato ricostruito
nell’800 come giardino all’italiana
e quindi tenendo separati – come si
usava fare nell’800 – le verdure commestibili e i frutti dai fiori. Ma nel
‘700 si faceva proprio il contrario,
si intrecciavano fiori e frutti e allora
il sospetto è che magari ci fosse una
traccia di questa antica abitudine a
intrecciare fiori e frutti in un giardino all’italiana. E così è. Grazie al direttore del Giardino di Boboli, siamo
riusciti a trovare una fotografia che
denota la presenza negli anni ‘30 di
un caco che era rimasto lì: infatti il
Giardino del Cavaliere è un po’ dimesso e appartato.
Mi trattengo un po’ a lungo su questo particolare, perché è davvero rivelatore di quello che sto cercando
di dire: noi abbiamo di fronte una
filosofia dello sguardo. Se vogliamo
parlare della verità delle rose tardive, della verità del succo di un frutto così gustoso come un caco, dobbiamo parlare di qualcosa che esiste
veramente, che è lì, davanti ai nostri
occhi, che si offre a noi e di cui noi
dobbiamo appunto farci interpreti,
ma prima ancora custodi.
Ma torniamo al nostro testo. Camus
lo redige nel 1938, sarà pubblicato
separatamente nei Taccuini, come testo d’occasione, e poi nel libro Nozze,
come parte integrante di esso. Questi
taccuini che riproducono gli appunti di viaggio sono importantissimi,
perché ci dicono qualche cosa che il
testo, una volta che è stato riprodotto nella raccolta Nozze, non dice più.
Innanzitutto che è dedicato a Jean
Grenier e questo davvero ci avvicina
al nostro sunto di base, perché Jean
Grenier è stato il suo professore più
amato, è stato il professore con cui ha
discusso una tesi in filosofia dedicata
a metafisica cristiana e neo-platonismo, dedicata dunque a quello scontro, che è anche un odi et amo, dove
uno si sposa sempre con due, uno
scontro tra due grandi, grandissimi,
che sono stati Plotino e Agostino. Lo
scontro considerato dal punto di vista di Agostino, perché Plotino non
ha conosciuto Agostino, ma Agostino
ha conosciuto Plotino, si è confrontato con lui e ha capito che lì era in
gioco davvero qualcosa di essenziale.
Due mondi si contrapponevano: il
mondo pagano oramai al tramonto
e il mondo cristiano che cercava di
dare una risposta a questo naufragio,
o quantomeno a questo tramonto del
paganesimo.
Jean Grenier gli aveva suggerito di
studiare il rapporto tra Agostino e
Plotino e l’interpretazione che Agostino aveva dato di Plotino, ponendo alla radice di una questione che
affascinerà Camus per tutta la vita:
la questione dell’uno e del due, che è
– come Plotino sapeva bene – quella
che ci invita a ritrovare l’unicità nelle cose, che sono tante, conflittuali e
contraddittorie e che ci invitano ad
una dispersione, cioè a non vedere
l’essenziale che è in esse. La filosofia dell’uno dice di stare attento, che
tutto il molteplice sta nel segno di
una cattiva infinità. Tutto è uno ed
è a quell’uno che tu ti devi riportare,
spogliandoti di ogni cosa. Non preoccuparti di essere quello che sei o
quello che credi di essere, rendi il tuo
sguardo puro, cioè capace di accogliere la cosa secondo verità e quindi
non per come tu la vorresti, non nella
prospettiva che tu imponi alla cosa,
ma lasciando che la cosa sia. La grande parola di Plotino, forse la sua parola più enigmatica e anche la sua più
profonda: impara a lasciar essere le
cose, come esse vogliono essere, non
come tu le vorresti. E quando avrai
imparato questo, avrai imparato tutto. Ma in che segno sta questo tutto?
Nel segno dell’uno, di quell’uno che
è sorgivo, perché è la sorgente stessa. Quell’uno che è in tutte le cose,
ma che prima ancora che nelle cose
è in te, ma non in te come prospettiva sul mondo, in te come puro occhio, come puro sguardo gettato sul
mondo. In te come sguardo al tempo
stesso luminoso e umile, perché capace di lasciare che le cose siano quali
sono veramente.
Ma cosa credete che sia la verità delle
rose tardive, se non quella che è colta
da uno sguardo capace di spogliarsi
65
della propria presunzione e di abbandonarsi al mondo, non lasciandosi
sedurre ma, al contrario, accogliendolo, accettandolo, inchinandosi di
fronte ad esso. Tutta la grande mistica nascerà da qui. Certo che sarà
filtrata da Agostino lettore di Plotino,
Agostino che in Plotino aveva colto
proprio questo: una filosofia dell’uno
nel cuore del due. Tutto è dualità nel
mondo, tutto è contrapposizione tra
l’uno e il due, tra l’io e l’infinità degli
altri. Tutto è opposizione, ma questa
opposizione, l’alterità di questa opposizione è la cosa che riposa in se
stessa, sono le rose tardive che sono
quello che sono.
Dirà Angelus Silesius, un grande lettore sia di Plotino che di Agostino,
molti anni dopo in un celeberrimo
distico: “La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce; non pensa a sé,
non si chiede se la si veda oppure no”.
Ma perché fiorisce? È una domanda filosofica, ma ci si può porre una
domanda del genere di fronte ad una
rosa? Forse che una rosa fiorisce perché tu ne possa godere il profumo?
Forse perché possa rendere più bello
il mondo? No. Chi nella rosa vedesse questo non vedrebbe nulla, ma chi
non vede nulla vede tutto. Chi non
vede il nulla che è alla radice delle
cose, vede tutto, perché vede le cose
nel loro essere, così come sono, quali
sono, liberamente e quindi veramente. La verità delle rose tardive, questo
va ricercando Camus.
Ma va cercando anche un’altra cosa,
che sembrerebbe essere il contrario
66
di questa. Se questa è una filosofia
dell’uno, Camus è al tempo stesso
tentato da un’altra filosofia, quella
che per l’appunto potremmo chiamare una filosofia del due, una filosofia
intimamente dualistica, fondata sulla
contraddizione. Camus cerca una filosofia che lo porti a dire “sì” nel momento stesso in cui è più forte la rivolta, la negazione, il bisogno di dire
“no”. Una filosofia che gli permetta di
cogliere di nuovo la verità delle cose
nella contraddizione. Una filosofia
che di fronte al male, al dolore, a tutto ciò che fa scandalo (lo scandalo
del male è il grande tema di Camus),
proprio momento in cui la sola cosa
da fare è rivoltarsi (la rivolta sarà un
altro grande tema di Camus) riconosca che la ragione della rivolta poggia
su un più profondo consenso, su un
“sì”.
Non è forse l’amore per la vita una
passione sconfinata per l’essere, non
per l’essere come vorrei che fosse, ma
per l’essere così com’è? Non è forse
questa dedizione all’essere quella che
fa sì che io mi scandalizzi quando l’essere, la vita, è offesa, negata, conculcata o addirittura annientata? Guardate che una malattia, anche la più
banale delle malattie, è una forma di
annientamento della vita, appartiene
alla vita. E invece anche una malattia – a maggior ragione quando colpisce un innocente, un bambino – fa
scandalo. Tutto fa scandalo. Tutto si
oppone a se stesso. Ma io mi posso
scandalizzare solo se il presupposto
di questo scandalo è l’amore per la
vita, è un “sì” incondizionato dato
alla vita.
Non c’è invece nessuno scandalo per
uno che non ama la vita perché sa
da sempre che la vita è sgradevole e
umiliante come spesso è, dolorosa e
contraddittoria. Se la vita è sofferenza, un venir fuori dal nulla e un finire
dal nulla, dov’è lo scandalo se interviene in questo nostro passaggio la
malattia, il male e la morte?
Ma se la vita ti appare infinitamente
altro da questo, e cioè come la stessa
gloria di Dio (come dirà Camus), sia
pure quel Dio che non esiste, allora
la non esistenza di Dio, cioè il male,
la malattia, la morte, tutti i segni che
sembrano denunciare la non esistenza di Dio (il fatto che gli innocenti
soffrano ecc.), tutto ciò scandalizza,
obbliga a provare scandalo.
Vi è una duplicità, la ricerca dell’uno
di fronte a un mondo pieno di contraddizioni e questa ricerca del due a
partire da una fede nella vita, da un
sì alla vita che suona come se io lo
traducessi: amo la vita non perché è
meravigliosa, ma amo la vita proprio
perché è piena di contraddizioni,
perché questo è il suo fondamento.
Ecco, la filosofia dell’uno (Plotino),
tenuta insieme con una filosofia del
due (Nietzsche), gli era stata suggerita proprio da Jean Grenier, il suo professore di filosofia. Quando era poco
più che studente – oggi diremmo studente della magistrale – Grenier gli
aveva suggerito di leggere Agostino
e Plotino, ma al tempo stesso anche
Nietzsche, che di fatto va in una dire-
zione contraria.
Altro che spogliazione, altro che liberarsi di se stesso e gettare sul mondo
e sulle cose uno sguardo pieno d’amore, quindi uno sguardo unificante, che abbraccia tutte le cose in uno;
liberarsi di se stesso e risalire a quella
sorgente, a quell’unità dove tutte le
cose sono uno. Nietzsche sostiene invece la profonda, ineliminabile contraddittorietà dell’essere. La contraddizione più grande consiste in quello
che lui chiamava ja sagen, il dire sì al
no, il dire sì al negativo, il dire sì alla
contraddizione stessa, scoprire la felicità nella più acuta sofferenza, dire
sì al mondo non perché il mondo potrebbe essere quale non è, ma proprio
perché è com’è, contradditorio, in un
intreccio di bene e male, dove non c’è
più il bene e non c’è più il male perché
c’è l’essere così com’è, c’è la vita che
chiede soltanto di essere fatta nostra,
appropriata.
Da una parte Plotino che invita a spogliarsi di sé, a dimenticare se stessi,
con un gesto profondamente ascetico, di svuotamento di sé; dall’altra un
gesto di segno contrario, un gesto di
appropriazione: io mi approprio anche di ciò che mi ripugna, io dico sì
anche a ciò che fa scandalo. Lo scandalo non esiste, tutto merita il mio sì,
perché tutto è mio.
A questo punto rileggiamo il passo
che è stato letto: “Afferravo – dice
Camus – l’oscillazione che conduce
certi uomini dall’ascesi al godimento e dalla spogliazione a profondersi
nella voluttà”. C’è un’oscillazione che
67
ciascuno di noi può sperimentare,
un’oscillazione data dal gesto attraverso cui ci spogliamo di noi stessi,
ci dimentichiamo di noi stessi e allora finalmente la vita ci appare nella
sua verità, nella sua bellezza, nel suo
splendore, al gesto solo apparentemente contrario, che consiste nell’afferrare la vita, nel farla propria, nel
riconoscerla come la cosa più mia.
Questo balancement, questa oscillazione, questo passaggio da Agostino-Plotino (la spogliazione di sé, la
purezza dello sguardo) a Nietzsche
(uno sguardo vorace, assorbente,
appropriante). Ecco, questo balancement Camus lo ha scoperto proprio
nella città dove si era prefigurato di
fare esattamente le esperienze che poi
avrebbe fatto, Firenze. “Firenze! Uno
dei pochi luoghi d’Europa in cui ho
capito – attenzione, questa è la frase
forse più importante – che nel cuore
della mia rivolta dormiva un consenso”.
Ecco il senso vero del balancement,
dell’oscillazione.
Firenze rivela a Camus che è possibile rivoltarsi: il rivoltoso è colui che
dice no al mondo con il suo carico
di male, sofferenza, morte. Badate,
rivoltarsi non è una cosa da tutti,
come potrebbe sembrare. Sono molti
di meno di quelli che noi crediamo
coloro che sono davvero capaci di rivoltarsi, di provare scandalo di fronte a queste realtà negative. Sono solo
coloro nei quali dorme un consenso,
che hanno preventivamente detto sì
alla vita, cioè hanno saputo gettare
68
sulla vita uno sguardo tale che ne ha
afferrata la verità più profonda, quella in cui la vita è la gloria di Dio, è la
sua manifestazione.
In quegli stessi anni Georges Bernanos ha terminato il celebre Diario
di un curato di campagna con quella
frase sconcertante che sembra ricalcata su queste righe: “Tutto è grazia”.
Attenzione, come sapeva bene Bernanos, “tutto è grazia” non va interpretata nel senso che non c’è il male,
che il male è solo apparente e dunque
non c’è la sofferenza. È esattamente il
contrario. “Tutto è grazia” lo dice appunto quel povero parroco di campagna, che ha un senso fortissimo del
male e che lo prova sulla sua stessa
pelle. Proprio perché nel mondo tutto
è male, si può dire che tutto è grazia.
Lui non dice: “Tutto è bene”. Lui dice
che tutto è grazia, quindi è più che
bene. Il bene, in fondo, agli occhi
del curato di campagna, è l’opposto
del male. Il bene è là dove non c’è il
male. Non così la grazia: la grazia, a
differenza del bene, è là proprio dove
c’è il male. È una sorta di liberazione
da ciò di cui non si vede liberazione
possibile. La grazia è quel gesto, non
so come chiamarlo altrimenti, quel
movimento dello spirito che, per
l’appunto, ci trasporta al di là di ciò
che tuttavia resta, al di là del male che
non può essere puramente cancellato,
perché se lo cancello allora mi limito
a sostituirlo con il bene.
Aveva 24 anni Albert Camus quando arriva per la prima volta in Italia.
Era stato in Savoia a curarsi da una
malattia ai polmoni che lo avrebbe
tormentato tutta la vita e che lo aveva
colpito a 16 anni. Dopo il soggiorno in una clinica in alta montagna,
le sue condizioni erano visibilmente
migliorate, non era guarito, ma stava
molto meglio. Allora si concesse un
viaggio in Italia e volle andare a Firenze. È quello che altri celebri viaggiatori prima di lui avevano fatto, ma
con un atteggiamento molto diverso.
Goethe, per esempio, passa a Firenze
e dà ordine al cocchiere di mettere le
valige sul calesse per proseguire il suo
viaggio verso sud. A Goethe non importava nulla di Firenze, era convinto che fosse la copia di un momento
classico, che solo nel mondo greco e
successivamente nel mondo romano,
si era realizzato in tutta la sua pienezza. Firenze era dunque la copia di una
copia: già i romani avevano copiato
i greci, figuriamoci i fiorentini che
avevano riportato il classico in auge
attraverso i romani, quindi copiando
una copia.
Camus invece vuole andare proprio
a Firenze, dove era accaduta la rinascita del mondo classico e addirittura
la possibilità, secondo Nietzsche, di
riportare in auge la religione pagana.
In questa grande operazione culturale decisivi erano stati i neo-platonici
fiorentini, che avevano tradotto Platone e lo avevano letto e interpretato
alla luce di quello che conoscevano –
non tantissimo – di Plotino. Camus
aveva appena redatto la tesi di Laurea, il suo maestro gli aveva consigliato di leggere Plotino, Agostino (ma
Camus si era soffermato soprattutto
su Plotino e sul neo platonismo) e
Nietzsche. Dietro i grandi maestri del
Rinascimento fiorentino c’è Marsilio,
il fondatore dell’accademia platonica,
prima nella Villa medicea di Careggi, poi a Santo Spirito. E alla scuola
di Marsilio c’è un ragazzo che avrebbe
segnato in profondità, come nessun
altro, il Rinascimento fiorentino,
Michelangelo. Michelangelo a 16-17
anni era a scuola di Marsilio, questa
è una cosa che fa venire i brividi solo
a pensarci. E possiamo pensare il
Rinascimento senza pensare a Michelangelo e alle influenze che su Michelangelo ha avuto Marsilio, il grande
interprete di Plotino? Noi non sappiamo come e quanto, ma certamente
lo ha influenzato, soprattutto se pensiamo all’ultimo Michelangelo. Infatti il suo percorso artistico va in quella
direzione: Michelangelo è alla ricerca
di quell’unità nella contraddizione, di
quel senso che tiene in uno ciò che
è scisso, lacerato, drammaticamente
conflittuale. Nella Sagrestia Nuova
vediamo l’espressione di un pensiero
tragico, che è appunto l’uno per così
dire spezzato, ma che resta uno, anche se porta dentro di sé la contraddizione, la lotta, il conflitto di luce e
tenebra, di forma informe, di caos e
cosmo. Il passaggio dalla Sagrestia
Vecchia realizzata dal Brunelleschi e
decorata da Donatello – dove tutto è
armonia, unità, perfezione – alla Sagrestia Nuova è non altro che il passaggio alla dimensione in cui l’uno si
spezza in un conflitto con se stesso,
69
conosce il dramma della vita e della
morte, l’agonia. Tutto è agonico nella Sagrestia Nuova. E cos’è agonia se
non la lotta tragica, se non l’emblema
di quella tragicità che Michelangelo ha incarnato meglio di chiunque
altro? Di nuovo: filosofia dell’uno,
dove filosofia dell’uno significa unità,
armonia, perfezione, compostezza,
e filosofia del due, filosofia tragica,
filosofia della contraddizione, della
tensione, della lotta, dell’agonia, della
ferita che non si rimargina.
Camus è stato messo su quella strada che sarebbe stata la sua da Jean
Grenier, che gli aveva fatto studiare
Plotino, il filosofo che getta sul mondo uno sguardo come solo i pagani
sapevano fare, per cui tutto è meraviglioso e bello e, dall’altra parte, gli
aveva fatto studiare il filosofo tragico
per eccellenza, Nietzsche: il sì lo devi
dire in presenza del male, dentro
il male, in forza del male. Il tragico
Nietzsche e il pagano Plotino accompagnano fin da allora Camus in questo suo viaggio a Firenze, dove queste
due figure si trovano esemplificate,
si può dire, in ogni passaggio e lui
va proprio dove non solo ritiene che
questa esperienza possa essere fatta,
ma dove ritiene di poter quasi toccare con mano questa oscillazione.
Camus ha trovato questa oscillazione
al Giardino del Cavaliere, al Colle di
Belvedere, dove ha avuto la possibilità sperimentare il passaggio da una
ascesi più totale, da una purificazione
dello sguardo così piena da implicare lo spogliarsi di sé completo, a una
70
jouissance, a un godimento e un’appropriazione altrettanto totale delle
cose. Va al Giardino del Cavaliere e
lì scrive queste pagine che ci danno
da pensare e che sono cariche di un’esperienza tanto complessa, ma profondamente filosofica, perché i due
poli che la compongono rimandano a
due tradizioni di pensiero che Camus
non mette insieme facendo pasticci,
sovrapponendole una all’altra; due
tradizioni di pensiero di cui egli tiene
conto, comprendendone la lezione,
accettandole e adottandole entrambe.
Sembra che una escluda l’altra, ma
sia la filosofia di Plotino che quella
Nietzsche sono a loro volta contraddittorie, per cui Camus interpreta la
filosofia dell’uno di Plotino come se
lo sbocco naturale di questa filosofia
fosse un’ascesi gioiosa.
Mi spoglio di tutto, non esisto più,
lascio parlare le cose, ma le cose mi
parlano e parlandomi mi appaiono
nel loro splendore e mi colgono a
verità. Quindi, la sua filosofia dell’uno è ascesi, ma c’è anche una dualità
dentro questo uno, perché le cose a
cui ho rinunciato, rinunciando a me
stesso, mi vengono restituite nella
loro pienezza, tanto che mi si rivelano
come non le ho mai viste, e le amo
come non ho mai amato il succo di
quel caco e la meraviglia, la dolcezza,
la delicatezza, la tenerezza di quella
rosa, proprio in forza del mio essermi
fatto come nulla. Mi sono fatto come
nulla, mi sono spogliato e proprio
perché mi sono fatto come il nulla,
incontro il tutto.
E la stessa cosa vale per Nietzsche. La
vita vuole il mio sì, e io glielo do. In
Plotino l’origine è il no, l’ascesi e alla
fine c’è il sì. In Nietzsche all’origine
c’è il sì. La vita è infinitamente più
forte di ciò che io voglio e non voglio, del fatto che io debba soffrire,
per esempio, o che le cose non vadano come io credo. Ma proprio perché
originario è il sì, proprio perché mi
sono consegnato totalmente ad essa,
senza riserve, proprio perché il mio
sì alla vita è amore pieno e totale,
allora tutto mi disturba. Tutto ciò
che fa scandalo, fa davvero scandalo,
proprio perché amo la vita. Avendo
detto sì originariamente alla vita,
l’ho abbracciata con tutte le forze di
cui dispongo e allora non sopporto
più che la gente soffra, che i bambini muoiano ecc. Camus non poteva
dire meglio: “Ho capito che nel cuore
della mia rivolta dormiva un consenso – e continua – nel suo cielo misto
di lacrime e di sole, imparavo a dir
sì alla terra e ad ardere nella fiamma
cupa delle sue feste”. Lui vuole testimoniare, non esprimere (ricordate
la frase iniziale, quella da cui siamo
partiti). Esprimere implica un gesto
prevaricatore, il gesto di chi si impone alle cose. Testimoniare vuole invece gentilezza, umiltà, mitezza. Ma il
testimone è davvero tale nel silenzio,
nella fiamma, nell’immobilità. Tutto
questo lo trova al Giardino di Boboli.
Camus ci va, compra il suo biglietto, attraversa il giardino storico che
sembra interessargli fino a un certo punto, sale sul colle, il cosiddetto
Giardino del Cavaliere, che effettivamente è il solo punto da dove si vede
la città e la collina come la si vede dal
Forte Belvedere, al quale non poteva
andare, perché nel 1937 era ancora
occupato dai militari e lo è stato fino
al 1968-69. E cosa si vede da quel
punto? Questo: “Nel suo cielo misto
di lacrime e di sole imparavo a dire
sì alla terra”. Ma come lo si impara?
In una filosofia dello sguardo, attraverso la spogliazione. La spogliazione
ci porta a trovare la testimonianza e
a contrapporre la testimonianza all’espressione del mio io, la testimonianza che la vita merita il mio sì: “imparavo a dir di sì alla terra e ad ardere
nella fiamma cupa delle sue feste”.
Credo che Camus facesse allusione a
una festa fiorentina. In questo i fiorentini sono stati davvero speciali.
Qui andrebbe citato Nietzsche, per il
quale Firenze sembra essere un luogo
deputato alla rinascita di quel paganesimo tragico dove la festa ha una
sua profonda tragicità. Le feste dei
fiorentini sono state per lunghi secoli questo: “feste che ardono in una
fiamma cupa”.
Vi racconto una di queste feste.
Quando il Vescovo di Firenze arrivava dalla Porta di San Pier Maggiore
su un cavallo bianco per prendere
possesso della città, la piccola piazza
era occupata da tutti coloro che volevano gareggiare per la conquista del
cavallo (questa tradizione è durata
secoli, è stata proibita soltanto nel
‘600). Sotto un rumore assordante di
cembali, tamburi, trombe e altro, il
71
cavallo veniva liberato dai finimenti
e alcuni ardimentosi si sfidavano per
la sua conquista, sotto gli occhi del
Vescovo. Tutto era permesso e, salvo
qualche caso fortunato, faceva parte
del gioco che qualcuno ci lasciasse la
pelle. Questa era, tutto sommato, una
delle feste fiorentine meno cruente.
Questa è una festa tipicamente tragica e drammatica: i contendenti si
tagliavano la gola per conquistare un
cavallo. Mi pare che in quegli anni
un cavallo valesse la paga di un anno
intero di 7-8 operai. Voi capite bene
come un proletario, che non aveva
nulla, fosse disposto a giocarsi la vita
per appropriarsi del cavallo.
Dal Giardino del Cavaliere Camus
getta uno sguardo su Firenze e vede la
festosità della tragedia, che si situa in
un luogo di festa e ha un suo splendore. Fa questo mettendo insieme due
percorsi, due vie filosofiche, quella
di Plotino e quella di Nietzsche, che
noi siamo abituati a pensare come
due vie separate, che portano (come
spesso accade in filosofia) in direzioni opposte e questo ci rivela davvero
la grandezza del filosofo, che consiste
nell’aver costruito un pensiero dove
le due vie contribuiscono a creare
davvero una prospettiva di rara profondità, per arrivare al punto in cui si
può gettare uno sguardo sulla terra, il
cui splendore e la cui luce gli parlano
senza sosta di un Dio che non esiste.
Perché viene da dire che Dio non esiste là, dove i disgraziati si tagliano la
gola per impossessarsi di un cavallo.
Eppure questo avviene dopo che è
stato conquistato un sì in forza di un
no, ma un sì che permette di accettare
di riconoscere un senso anche a ciò
che richiederebbe soltanto la nostra
rivolta. E, viceversa, la nostra rivolta
è per così dire rafforzata e resa ancora
più urgente proprio da questo sì.
È una filosofia coraggiosa, che sfiora
in continuazione la contraddizione,
il paradosso, ma proprio per questo
è una filosofia che merita di essere
ripresa.
Il deserto di Albert Camus
Vivere, certo, è un po’ il contrario di esprimere. Secondo i grandi maestri toscani, è testimoniare
tre volte, nel silenzio, nella fiamma e nell’immobilità.
Ci vuole molto tempo per capire che i personaggi dei loro quadri si incontrano ogni giorno
nelle vie di Firenze o di Pisa. Ma, allo stesso modo, non sappiamo più vedere il vero viso di
coloro che ci circondano. Non guardiamo più i nostri contemporanei, avidi soltanto di ciò che
in essi serve ad orientarsi o a dar norma alla nostra condotta. Al volto preferiamo la sua poesia
più volgare. Ma Giotto o Piero della Francesca sanno benissimo che la sensibilità di un uomo
non è nulla. E cuore, ne hanno tutti. Ma i grandi sentimenti semplici ed eterni attorno ai quali
gravita l’amore di vivere, odio, amore, lacrime e gioie crescono a profondità d’uomo e modellano
la fisionomia del suo destino – come nella deposizione del Giottino, il dolore che fa stringere i
denti a Maria. Nelle immense maestà delle chiese toscane, vedo certamente una folla di angeli
dai visi indefinitamente ricalcati, ma in ognuna di queste facce mute ed appassionate riconosco
una solitudine. […]
72
Vorrei distinguere un po’ più da vicino una verità che sentivo allora nel cuore stesso della mia
rivolta, della quale essa non era che il prolungamento, una verità che andava dalle piccole rose
tardive del chiostro di Santa Maria Novella alle donne di quella domenica mattina a Firenze, coi
seni liberi negli abiti leggeri e le labbra umide. All’angolo di ogni chiesa, quella domenica, c’erano banchi di fiori, rigogliosi e brillanti, imperlati di gocce. Ci trovavo allora una specie di “ingenuità” e nello stesso tempo una ricompensa. In quei fiori come in quelle donne, c’era un’opulenza
generosa ed io non vedevo come desiderare gli uni differisse molto dall’appetire le altre. Bastava
lo stesso cuore puro. Non avviene molto spesso che un uomo si senta il cuore puro. Ma almeno,
in quel momento, suo dovere è di chiamare verità ciò che l’ha singolarmente purificato, anche se
questa libertà può ad altri sembrare bestemmia, come nel caso di ciò che pensavo quel giorno:
avevo trascorso la mattinata in un convento di francescani, a Fiesole, pieno dell’odore dei lauri.
Ero rimasto a lungo in un cortiletto gonfio di fiori rossi, di sole, di api gialle e nere. In un angolo
c’era un annaffiatoio verde. Prima avevo visitato le celle dei monaci, e visto i loro tavoli guarniti
d’un teschio. Ora questo giardino testimoniava le loro ispirazioni. Ero ritornato verso Firenze,
lungo la collina che scendeva verso la città offerta con tutti i suoi cipressi. Quello splendore del
mondo, le donne e i fiori, mi sembravano come la giustificazione di quegli uomini. Non ero
sicuro che non fosse anche quella di tutti gli uomini che sanno che un punto estremo di povertà
è sempre vicino al lusso e alla ricchezza del mondo. Fra la vita di questi francescani, chiusi fra
colonne e fiori, e quella dei giovani della spiaggia Padovani ad Algeri che passano tutto l’anno al
sole, sentivo una risonanza comune. Se si spogliano, è per una vita più grande (e non per un’altra
vita). È almeno il solo uso valido della parola “spogliazione”. Essere spoglio conserva sempre un
senso di libertà fisica e questo accordo della mano e dei fiori – questa amorosa intesa della terra
e dell’uomo staccato dall’umano – ah! mi ci convertirei se non fosse già la mia religione. No, non
può essere una bestemmia – e nemmeno se dico che il sorriso interiore dei san Francesco di
Giotto giustifica quelli che hanno il gusto della felicità. Perché i miti stanno alla religione come
la poesia sta alla verità, maschere ridicole poste sulla passione di vivere.
Debbo dire di più? Gli stessi uomini che, a Fiesole, vivono davanti ai fiori rossi hanno nella cella
il teschio che alimenta le loro meditazioni. Firenze alla finestra e la morte sul tavolo. Una certa
continuità nella disperazione può generare la gioia. E ad una certa temperatura di vita, l’anima
e il sangue mescolati vivono comodamente su delle contraddizioni, indifferenti tanto al dovere
che alla fede. […]
A Firenze fui felice e tanti altri prima di me. Ma che altro è la felicità se non il semplice accordo
fra un essere e l’esistenza che conduce? E quale più legittimo accordo può unire l’uomo alla vita
se non la duplice coscienza del suo desiderio di durare e del suo destino di morte? Almeno
s’impara a non contare su nulla e a considerare il presente come la sola verità che ci venga data
“in sovrappiù”. Sento quelli che mi dicono: l’Italia, il Mediterraneo, terre antiche in cui tutto è
a misura dell’uomo. Ma dove mai? mi si indichi la via. Lasciate che apra gli occhi per cercare la
mia misura e la mia soddisfazione! O meglio, sì, io vedo Fiesole, Djemila e i porti nel sole. La
misura dell’uomo? Silenzio e pietre morte. Tutto il resto appartiene alla storia. Eppure non bisognerebbe fermarsi qui. Perché non è detto che la felicità sia ad ogni costo inseparabile dall’ottimismo. È legata all’amore – che non è la stessa cosa. E io conosco ore e luoghi in cui la felicità
può apparire cosi amara che se ne preferisce la promessa. Ma in quelle ore e in quei luoghi non
avevo abbastanza cuore per amare, cioè per non rinunziare. Qui invece bisogna dire questo
entrare dell’uomo nelle feste della terra e della bellezza. Perché in quell’istante egli abbandona
al cospetto del dio gli spiccioli della propria personalità, come il neofita gli ultimi veli. Sì, esiste
una felicità più alta in cui la felicità sembra futile. A Firenze salivo nel punto più alto del giardino di Boboli, fino ad una terrazza di cui si scopriva il Monte Oliveto e le colline della città fino
all’orizzonte. Gli olivi erano pallidi su ogni collina come minuscole fumate e nella loro foschia
leggera si stagliavano le vette più dure dei cipressi, verdi quelli più vicini e neri in lontananza.
Grosse nuvole macchiavano il cielo di cui si vedeva l’azzurra profondità. Verso la fine del pomeriggio cadeva una luce argentea in cui tutto diventava silenzio. Ma s’era levata una brezza che
73
mi sentivo soffiare in viso. Con quella, le nuvole si separarono dietro le colline come un sipario
che si apre. Al tempo stesso sembrò che i cipressi della cima salissero con un balzo nell’azzurro
improvvisamente scoperto. Insieme salirono lentamente tutta la collina e il paesaggio di olivi e
di pietre. Vennero altre nuvole. Il sipario si chiuse. E la collina ridiscese insieme ai cipressi e alle
case. Poi di nuovo – e in lontananza su altre colline sempre più sbiadite – la stessa brezza che qui
e là apriva o chiudeva le spesse pieghe delle nuvole. In quel grande respiro del mondo, lo stesso
soffio finiva a pochi secondi di distanza e riprendeva di tanto in tanto il tema di pietra e d’aria di
una fuga a misura del mondo. Ogni volta il tema s’abbassava di un tono: seguendolo un po’ più
lontano, mi calmavo un po’ di più. E giunto al termine di quella prospettiva sensibile al cuore,
con un’occhiata abbracciavo quella fuga di colline che respiravano tutte insieme e con essa come
il canto di tutta la terra. Sapevo che milioni d’occhi hanno contemplato quel paesaggio e per me
era come il primo sorriso del cielo. Mi metteva fuori di me nel senso profondo del termine. Mi
assicurava che tutto era inutile senza il mio amore e quel bel grido di pietra. Il mondo è bello, e
fuor d’esso non c’è salvezza. La grande verità che pazientemente quel paesaggio mi insegnava è
che lo spirito non è nulla, e il cuore neppure. La pietra scaldata dal sole o il cipresso che il cielo
scoprendosi fa più alto limitano il solo universo in cui abbia un senso “aver ragione”: la natura
senza uomini. E questo mondo mi annulla. Mi porta sino in fondo. Mi nega senza collera. Nella
sera che cadeva sulla campagna fiorentina mi sarei avviato verso una saggezza in cui tutto era
già conquistato, se non mi fossero venute le lacrime agli occhi e il grosso singhiozzo di poesia
che mi empiva non m’avesse fatto dimenticare la verità del mondo. […]
Bisognerebbe fermarsi su questa oscillazione: istante singolare in cui la spiritualità ripudia la
morale, la felicità nasce dall’assenza di speranza, lo spirito trova nel corpo la propria ragione. Se
è vero che ogni verità porta la propria amarezza in sé, è anche vero che ogni negazione contiene
una fioritura del “si”. E il canto d’amore senza speranza che nasce dalla contemplazione può
anche rappresentare la più efficace regola d’azione. Uscendo dal sepolcro, il Cristo risorgente di
Piero della Francesca non ha uno sguardo umano. Non ha dipinto in viso nulla di felice – ma
solo una selvaggia grandezza senza anima che non posso fare a meno di intendere come un decisione di vivere. Perché il saggio esprime poco, come l’idiota. Ed è una reciprocità che mi manda in estasi. Ma debbo questo insegnamento all’Italia o me la sono estratto dal cuore? Certo è là
che mi è apparso. Perché l’Italia, come altri luoghi privilegiati, mi offre lo spettacolo di una bellezza in cui gli uomini muoiono ugualmente. Anche qui la verità deve corrompersi, e che cosa vi
è di più esaltante? Anche se la desidero, che farei d’una verità che non debba corrompersi? Non
è alla misura. E sarebbe finzione amarla. Non tutti capiscono che un uomo non abbandona mai
per disperazione quel che costituiva la sua vita. Disperazione e colpi di testa portano ad altre
vite ed indicano soltanto un fremente attaccamento alle lezioni della terra. Ma a un certo grado
di lucidità può accadere che un uomo si senta il cuore chiuso e volti le spalle, senza rivolta né
rivendicazione, a quello che fino allora scambiava per la propria vita, cioè la propria agitazione.
[…] Ma questo particolare deserto è sensibile solo a coloro che son capaci di vivervi senza mai
ingannare la propria sete. Allora, e allora soltanto, esso si popola delle acque vive della felicità.
A Boboli pendevano a portata di mano degli enormi cachi dorati la cui polpa spaccata lasciava
uscire un denso sciroppo. Da quella collina lieve a quei frutti succosi, dalla segreta fraternità
che mi metteva in accordo col mondo alla fame che mi spingeva verso la polpa arancione al di
sopra della mia mano, afferravo l’oscillazione che conduce certi uomini dall’ascesi al godimento
e dalla spogliazione a profondersi nella voluttà. Ammiravo, ammiro questo legame che unisce
l’uomo al mondo, il doppio riflesso nel quale può intervenire il mio cuore e dettare la sua felicità
fino a un preciso limite dove il mondo può completarla o distruggerla. Firenze! Uno dei pochi
luoghi d’Europa in cui ho capito che nel cuore della mia rivolta dormiva un consenso. Nel suo
cielo misto di lacrime e di sole imparavo a dir di sì alla terra e ad ardere nella fiamma cupa delle
sue feste. Provavo… ma quale parola? Quale dismisura? Come consacrare l’accordo dell’amore
e della rivolta? La terra! In questo gran tempio disertato dagli dei, tutti i miei idoli hanno piedi
d’argilla.
74