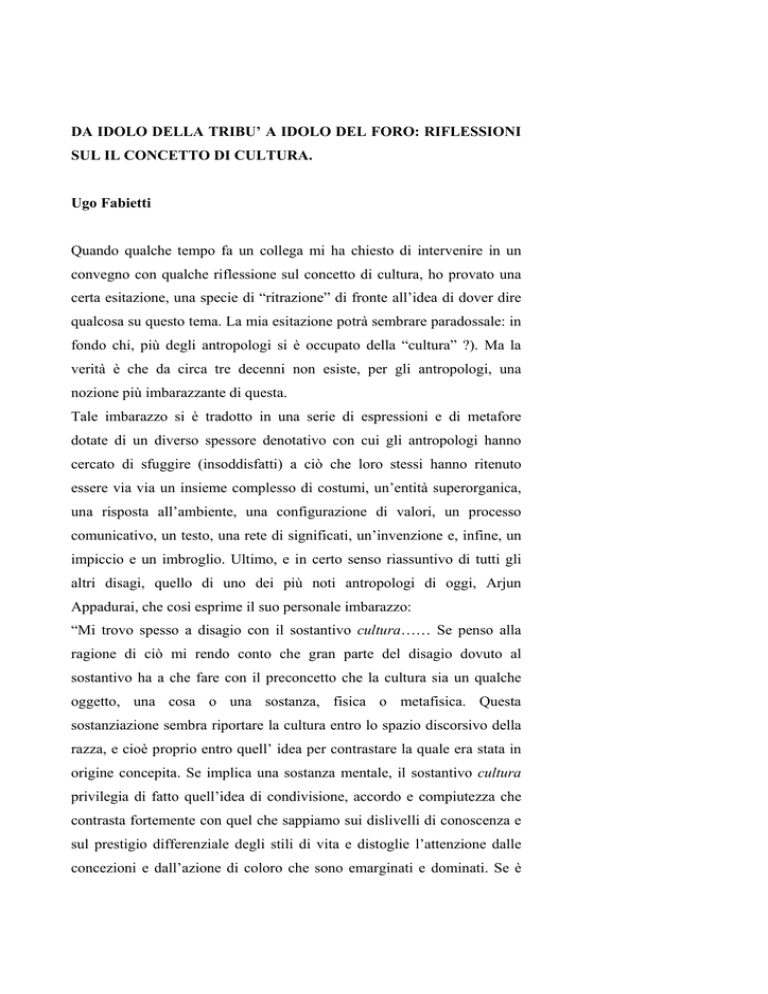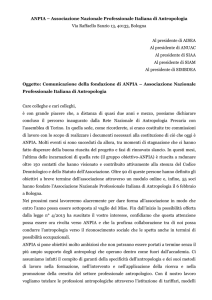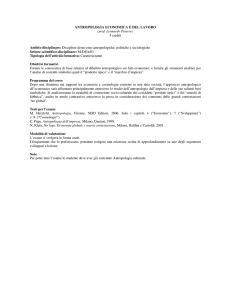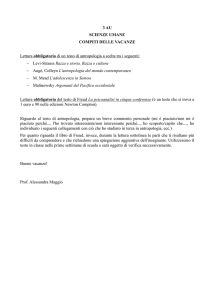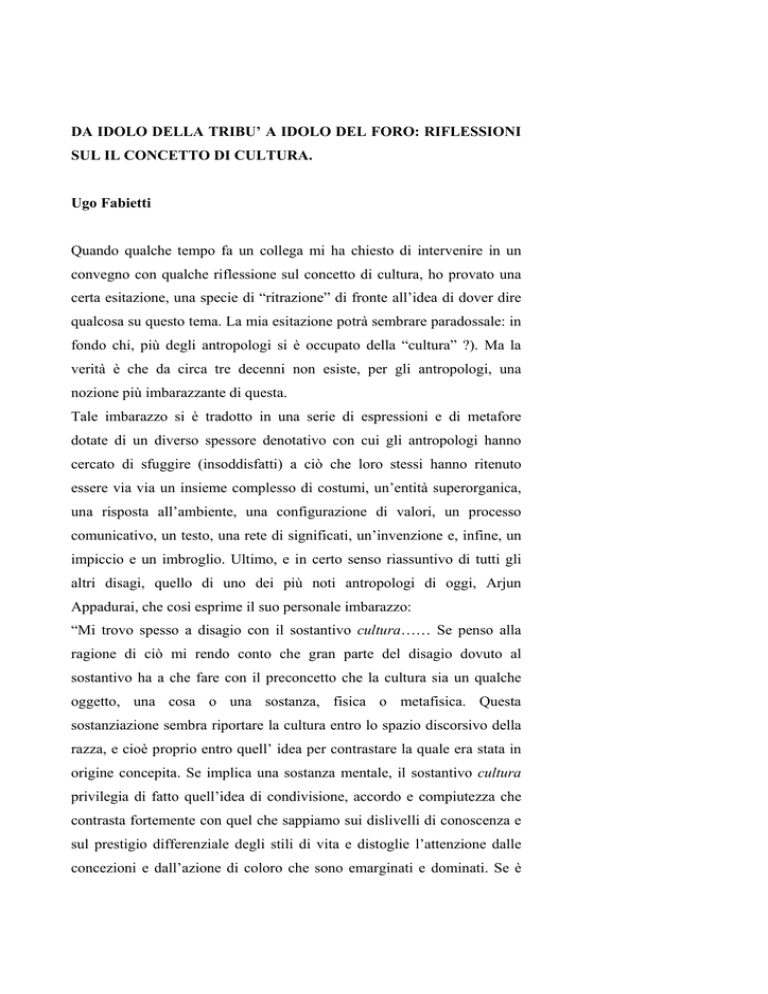
DA IDOLO DELLA TRIBU’ A IDOLO DEL FORO: RIFLESSIONI
SUL IL CONCETTO DI CULTURA.
Ugo Fabietti
Quando qualche tempo fa un collega mi ha chiesto di intervenire in un
convegno con qualche riflessione sul concetto di cultura, ho provato una
certa esitazione, una specie di “ritrazione” di fronte all’idea di dover dire
qualcosa su questo tema. La mia esitazione potrà sembrare paradossale: in
fondo chi, più degli antropologi si è occupato della “cultura” ?). Ma la
verità è che da circa tre decenni non esiste, per gli antropologi, una
nozione più imbarazzante di questa.
Tale imbarazzo si è tradotto in una serie di espressioni e di metafore
dotate di un diverso spessore denotativo con cui gli antropologi hanno
cercato di sfuggire (insoddisfatti) a ciò che loro stessi hanno ritenuto
essere via via un insieme complesso di costumi, un’entità superorganica,
una risposta all’ambiente, una configurazione di valori, un processo
comunicativo, un testo, una rete di significati, un’invenzione e, infine, un
impiccio e un imbroglio. Ultimo, e in certo senso riassuntivo di tutti gli
altri disagi, quello di uno dei più noti antropologi di oggi, Arjun
Appadurai, che così esprime il suo personale imbarazzo:
“Mi trovo spesso a disagio con il sostantivo cultura…… Se penso alla
ragione di ciò mi rendo conto che gran parte del disagio dovuto al
sostantivo ha a che fare con il preconcetto che la cultura sia un qualche
oggetto, una cosa o una sostanza, fisica o metafisica. Questa
sostanziazione sembra riportare la cultura entro lo spazio discorsivo della
razza, e cioè proprio entro quell’ idea per contrastare la quale era stata in
origine concepita. Se implica una sostanza mentale, il sostantivo cultura
privilegia di fatto quell’idea di condivisione, accordo e compiutezza che
contrasta fortemente con quel che sappiamo sui dislivelli di conoscenza e
sul prestigio differenziale degli stili di vita e distoglie l’attenzione dalle
concezioni e dall’azione di coloro che sono emarginati e dominati. Se è
invece vista come una sostanza fisica, la cultura comincia allora a puzzare
di qualche varietà di biologismo, inclusa la razza, che abbiamo
sicuramente superato come categorie scientifiche”.
E’ da un disagio di questo tipo che deriva il mio timore a dire qualcosa
sulla cultura, ma anche la necessità, credo, di “ripensare la cultura”.
Partiamo da una statistica, frutto di una rapida ricerca su internet condotta
un paio di anni fa negli Stati Uniti: il termine “cultura” rinviava a più di
cinque milioni di pagine web (tolte tutte quelle che facevano capo a
pratiche agricole - in inglese agricoltura suona “agri-culture”).
Ma in riferimento alle discipline antropologiche, il numero delle pagine
crollava a sessantamila, mentre il sito di Amazon, la più grande libreria
on-line del mondo, riportava oltre ventimila titoli con il temine cultura di
cui però solo milletrecento erano testi di antropologia (culturale).
Questa statistica è sicuramente congruente al disagio degli antropologi
perché significa chiaramente che oggi il termine cultura lo si ritrova per lo
più “fuori” dell’antropologia.
A prima vista gli antropologi sembrerebbero doversene rallegrare. In
fondo hanno sudato sette camicie, e almeno sette decenni, per imporre
questo concetto all’attenzione delle scienze sociali e del pensiero
occidentale. Certamente in parte è così. Ma se guardiamo che cosa ha
davvero significato, per il concetto di cultura, questo ritrovarsi fuori
dall’antropologia, scopriremo che gli antropologi hanno molte meno
ragioni di sentirsi soddisfatti.
Sia chiaro che il concetto di cultura, così come è stato elaborato e
utilizzato dall’antropologia ha avuto (ed ha) alcuni meriti che nessuno
potrebbe negare. Senza farne una genealogia, si può dire che il concetto di
cultura consentì di pensare il genere umano come capace di esprimere
ovunque, in ogni epoca e luogo, una creatività materiale, comunicativa e
simbolica che, per quanto diversa da luogo a luogo, da epoca a epoca,
presentava caratteristiche di assoluta commensurabilità.
Concettualizzata come cultura umana, questa creatività ricevette letture e
specificazioni particolari, legate a contesti storici, sociali, linguistici
individuali (le “culture umane”). Il concetto, usato in maniera estensiva o
universalista (la cultura umana) consentì infatti di ricomprendere, stavolta
usato in maniera intensiva (o particolaristica), le forme locali che questa
cultura umana assumeva in punti diversi del pianeta (le culture umane).
Sorvolando
sulle
implicazioni epistemologiche di questa
mossa
intellettuale che fu l’elaborazione del concetto antropologico di cultura,
possiamo dire che si trattò di una mossa politicamente importante, perché
in questo modo si cominciarono a prendere seriamente in conto delle
realtà umane distribuite nello spazio che una visione eurocentrica aveva
praticamente ignorato come elementi utili per una migliore comprensione
della storia complessiva del genere umano.
Dalla elaborazione del concetto di cultura l’antropologia, da parte sua,
trasse un vantaggio: quella di presentarsi come la prima forma di
riflessione socialmente riconosciuta, e accademicamente autorizzata a
trattare di forme di vita culturali e sociali “altre”.
Così come è stato impiegato dagli antropologi anche in relazione alla
pratica etnografica, il concetto di cultura è venuto a significare un
comportamento umano strutturato in modelli appresi. Proprio l’idea che la
cultura consista di modelli mentali e comportamentali strutturati e appresi
costituisce oggi il caposaldo ultimo dell’idea antropologica di cultura.
Così definita, però, la cultura deve essere “spiegata”, e questo non può
avvenire se non grazie ad analisi particolari e circostanziate, cioè grazie
all’etnografia (senza la quale l’antropologia, è bene ricordarlo, non
avrebbe senso).
Come ci dice la statistica però, i contesti d’uso extra-antropologici del
termine cultura sono di gran lunga più numerosi rispetto di quelli in cui il
concetto è impiegato dagli antropologici. I concetti non sono le parole che
li evocano, e infatti il loro significato cambia a seconda del contesto in cui
vengono usati. Se nel contesto antropologico cultura rinvia a un
complesso di comportamenti mentali e pratici strutturati e appresi, che
deve essere sempre spiegato, cioè descritto e reso coerente, “fuori
dall’antropologia” cultura è venuta a significare qualcosa di diverso, non
di completamente diverso, ma diverso quel tanto che basta per rovesciarne
a volte le finalità con cui gli antropologi lo hanno da sempre usato.
Nel contesto non-antropologico la cultura non deve ad esempio essere
spiegata, ma è qualcosa che “spiega”: spiega il comportamento, i gusti, le
idee politiche, quelle relative al rapporto trai sessi, e naturalmente
l’economia, l’organizzazione sociale e le visioni del mondo, sia del
mondo sensibile che di quello ultrasensibile. Spiega le guerre etniche in
Africa e nei Balcani, spiega le difficoltà di inserimento degli immigrati dei
paesi poveri nelle megalopoli europee e nordamericane, spiega le tensioni
tra bianchi e neri e ispanici nelle città degli Stati Uniti, spiega tanto i
“miracoli economici” di alcuni paesi asiatici quanto le loro crisi ricorrenti.
Spiega l’11 settembre e, naturalmente, lo “scontro delle civiltà”.
Com’è allora che un concetto elaborato dall’antropologia come guida per
la pratica etnografica, cioè per descrizioni e spiegazioni localmente
circostanziate di comportamenti e di disposizioni umane socialmente
apprese, al di fuori dell’antropologia è diventato un “concetto-spiegatutto”?
L’elaborazione del concetto di cultura da parte degli antropologi
rappresentò, ho detto prima, non solo un’importante mossa intellettuale,
ma anche una mossa politica significativa, il concetto ebbe altri risvolti
“politici”, e non solo nel senso che mediante esso una cultura (quella
europea) si aprì alla comprensione delle culture “altre”. Formulato per la
prima volta in Inghilterra nel 1871, divenne particolarmente centrale
nell’antropologia americana dei primi del Novecento, per poi dispiegarsi
nuovamente nell’antropologia europea successivamente alla II guerra
mondiale. Senza stare a dire i perché e i percome di questo “giro”, fu in
America che il concetto di cultura sviluppò le caratteristiche di un “anticoncetto”, che erano già contenute nella sua formulazione originaria del
1871.
Quello di cultura infatti un concetto con forti valenze anti-. Per gli
antropologi “cultura” non indica solo tutto ciò che non è natura, ma anche,
e soprattutto, tutto ciò che non può essere descritto e spiegato mediante
nozioni e discorsi che fanno capo a una idea di eredità culturale
biologicamente trasmessa.
Negli anni di formazione di questo concetto l’idea in voga era quella di
“razza” la quale veniva usata per distinguere indifferentemente delle
diversità, tanto di carattere culturale e che somatico.
Il carattere peculiare del contesto in cui tutto ciò avvenne (l’antropologia
culturale e le scienze sociali americane della prima metà del Novecento)
ebbe un impatto decisivo sullo stile intellettuale degli antropologi. Se la
cultura era ciò che doveva difendere le scienze sociali americane dalla
razziologia e la società americana dal razzismo, gli antropologi si
guardarono di fatto dall’esportare questa loro posizione nella sfera
pubblica, e preferirono, per una serie di ragioni anche comprensibili,
mantenere questo discorso entro i limiti del campo disciplinare. Queste
ragioni sono da ricondurre all’uso del concetto di “cultura” come concetto
simbolo dell’antropologia, il portabandiera della lotta contro i darwinisti
sociali, i razziologi e i razzisti; ma la cultura anche ma anche un’opzionerifugio, un bastione dietro al quale trincerarsi per distinguersi dalle
discipline che proprio in quel periodo riuscivano, attraverso l’adozione e
l’applicazione di metodi quantitativi, a presentarsi come “più scientifiche”
dell’antropologia culturale.
L’effetto lungo di questo “arrocco” (tanto per usare una metafora
scacchistica) fu che cultura non indicò più soltanto ciò che non era natura
o razza, ma anche ciò che avrebbe potuto essere concettualizzato in
termini di “storia” e di “classe sociale”. Diventò una specie di punto di
vista auto-legittimato da cui osservare un campo distinto dell’attività
umana. Diventò un modo per guardare ai popoli in una loro astratta
“totalità”, senza specificare quelle differenze e disomogeneità di
prospettive, di potere e di interessi che sempre esistono all’interno di “una
cultura”.
E’ vero che non fu sempre così, soprattutto in Europa. Se però
consideriamo il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto, nella seconda metà
del Novecento, nella diffusione in Europa e nel mondo di idee e di modelli
di consumo, compreso il consumo delle idee, non dobbiamo stupirci se tra
queste idee esportate troviamo anche il concetto antropologico di cultura
(o almeno una lettura particolare di esso).
Diventato un punto di riferimento irrinunciabile per l’antropologia, e
assunte le caratteristiche di un vero e proprio paradigma scientifico, il
concetto di cultura, si trasformò, una volta messo in circolazione fuori
dell’accademia, in un concetto rigido, autoesplicativo e capace di denotare
qualcosa di molto concreto, proprio come il mercato, l’arte, lo stato,
l’economia ecc. della cui esistenza nessuno poteva dubitare.
Reificata, la cultura da concetto descrittivo divenne esplicativo, mentre
più spiegava più si irrigidiva, e più si irrigidiva più spiegava, come altre
idee reificate: da idolo della tribù (la comunità antropologica) si trasformò
in idolo del foro (lo spazio pubblico).
Una volta reificata, la cultura è diventata non solo ciò che spiega tutto:
conflitti, differenze, interessi, atteggiamenti ecc. ma anche un appiglio per
giustificare tutto e tutti, secondo una malintesa idea di relatività culturale.
Sul versante opposto la cultura viene oggi chiamata in causa per sostenere
la tesi dello scontro di civiltà, per promuovere politiche educative spesso
retrive, per riproporre in chiave debiologizzata nuove forme di razzismo,
per progettare nuove forme di segregazione sociale, così come per
sostenere le tesi di quegli ambienti iperliberisti che fanno una missione di
civiltà del loro desiderio di esportare ovunque, e con qualsiasi mezzo, le
proprie vedute in materia di politica economica.
E’ sconfortante, per chi frequenta le discipline antropologiche, assistere
oggi a un simile utilizzazione del concetto di cultura quando si credeva
che il suo destino fosse invece quello di liberarci dal biologismo e dal
razzismo, di promuovere il pluralismo e affermare una disposizione etica
ed intellettuale all’ascolto della diversità.
Esportato al di fuori dell’antropologia, il concetto di cultura non ha certo
contribuito a eliminare il biologismo dalle scienze sociali, né il razzismo
dal discorso comune e della politica. Piuttosto li ha trasformati. Il
biologismo si è abbarbicato all’idea di cultura, dal momento che non si
vede come certe dinamiche biologiche potrebbero sostanzializzarsi se non
in comportamenti culturali; il razzismo invece, ne è uscito debiologizzato, dal momento che non si presenta più come una teoria che
pretende di fondarsi su dati biologici. Il neo-razzismo si avvale dell’idea
antropologica di relatività culturale per estremizzarla al punto da sostenere
che le culture umane sono tra loro radicalmente diverse, incommensurabili
e per questo incomunicanti.
Questo razzismo infatti fa leva, rovesciandone il senso, su due assunti
emersi, guarda caso, proprio dal discorso antropologico: il primo è quello
per cui le culture umane, per quanto diverse e per quanto diversamente
organizzate, hanno tutte diritto a considerazione e riconoscimento. Il
secondo afferma che se alle diverse culture è riconosciuta una pari dignità
di esistenza, allora deve essere anche riconosciuto, a chi lo rivendica, il
diritto alla differenza e alla propria identità. È dal «bricolage ideologico»
tra questi due assunti e l’idea che le culture umane sono incommensurabili
che il neorazzismo trae le proprie argomentazioni per proporre
l’esclusione e la segregazione delle culture.
Nel contesto esterno all’antropologia il concetto di cultura è diventato
infatti un modo per impacchettare velocemente razza, etnia, lingua,
religione e utilizzarle come marcatori della differenza.
Preoccupa il fatto che questo modo di maneggiare il concetto stia
diventando una merce d’esportazione in tutto il mondo. Samuel
Huntington, già noto anche da noi per il suo libro Scontro di civiltà
(1995), ha curato nel 2000 un libro intitolato Culture Matters, (“Questione
di cultura”). La tesi di fondo degli autori che hanno contribuito a questo
libro è che i divari e gli squilibri socio-economici tra differenti regioni del
pianeta, sarebbero il prodotto di eredità e disposizioni culturali, il tutto in
barba alle teorie dello scambio ineguale e delle strutture della dipendenza.
Su altri versanti la cultura la cultura è spesso invocata per rivendicare un
proprio diritto alla differenza, ma anche per affermare la propria supposta
superiorità nei confronti di altri. Anche quando si presta a un uso
relativistico, la cultura propria e degli altri è oggetto di discorsi che
evocano una scala graduale di importanza e di valore, come avviene ad
esempio nei discorsi sullo sviluppo.
In questo li antropologi hanno, come ho detto, le loro responsabilità.
Sorvolo su quelle teorico-epistemologiche più complesse. Una di queste
responsabilità è però senz’altro quella di aver utilizzato il termine cultura
in riferimento a unità d’analisi sempre più piccole e al tempo stesso
estremamente generiche: non solo la cultura trobriandese o balinese, ma
anche la cultura dei contadini, dei pescatori, del cibo, del turista e
dell’impresa. Se con il termine cultura si vuole indicare una entità
circoscritta, localizzata e descrivibile nella totalità dei suoi elementi
componenti, è evidente che oggi tale concetto è destituito di fondamento.
Qualcuno ha parlato di “esagerazione della cultura”, qualcun altro di
“eccesso”. Questa “esagerazione” fu il frutto di intenzioni originariamente
non del tutto disprezzabili, perché corrispose al tentativo di presentare ai
lettori occidentali i popoli altri come capaci di elaborare esperienze umane
ampiamente condivise e dotate di senso. Ma questa “esagerazione” ebbe
effetti di reificazione e, trasportata nella sfera pubblica, andò ad
alimentare il culturalismo. Il fatto è che non furono più solo gli
antropologi a “esagerare” le culture, ma anche, e soprattutto, coloro che si
sentirono, grazie a questo concetto, in grado di perseguire finalità e
interessi propri.
Un problema connesso all’uso indiscriminato del concetto di cultura
consiste proprio nel fatto che le stesse nuove forme di soggettività che
emergono oggi nei vari luoghi del pianeta (soggettività religiose, etniche,
politiche, sessuali, giuridiche, di genere ecc.) sono le prime a fare
riferimento alla “cultura” come ad un parametro di legittimazione del
diritto alla differenza, autonomia, indipendenza, riconoscimento ecc.
La risposta dell’antropologia, di fronte a queste utilizzazioni del concetto
è ovviamente critica, ed è consistita nel sottolineare come tali soggettività
siano non solo delle costruzioni, ma addirittura delle invenzioni spesso
finalizzate a produrre nuove e scandalose esclusioni. Ma cosa si è
guadagnato col dire che queste soggettività sono delle invenzioni e delle
costruzioni?
Spesso, quello che gli antropologi hanno guadagnato da questa critica è
nientemeno che l’accusa di….razzismo o, nel migliore dei casi, quella di
voler negare agli altri il diritto di rivendicare la propria autenticità. Meglio
sarebbe allora analizzare come queste soggettività si producono nella
dialettica della vita reale e nell’immaginario che, grazie alla diffusione
planetaria dei media, sta diventando una delle più potenti risorse nella
costruzione di queste soggettività.
Forse la principale ingenuità da parte degli antropologi è stata quella di
pensare che, operando nello spazio neutro dell’accademia, avrebbero
potuto influenzare positivamente la società politica e civile, mentre invece
mettendo in circolazione un concetto come quello di cultura, hanno
soltanto contribuito, in maniera del tutto paradossale, a rafforzare i
pregiudizi della società o a ridicolizzare la stessa idea di cultura, come nel
caso di una pubblicità che mi è capitato di vedere di recente, e in cui una
ditta di sanitari magnificava la propria….. “cultura del bagno”.
Sono infatti ben pochi coloro che ormai si prendono la briga di chiedere
agli antropologi cosa sia la cultura (e tra questi vi è il collega che mi ha
sollecitato a compiere qualche riflessione in merito). Ma non è questo il
punto.
Mi sembra importante infatti far notare come al di fuori dell’accademia gli
antropologi abbiano reso un miglior servizio alla società e all’antropologia
tutte le volte che non si sono accontentati di arzigogolare sul concetto di
cultura, ma quando hanno invece investito teoricamente alcune categorie
culturali politicamente significative. Non nel senso che si sarebbero dati
alla politica, ma nel senso che hanno analizzato le pratiche e i discorsi del
culturalismo, del razzismo e dell’etnicità senza limitarsi a dire che in
fondo la cultura, la razza e l’etnia sono soltanto delle invenzioni.
Se si pensa alla frequenza con cui la cultura è tirata in ballo per spiegare
ciò che accade nel mondo, dovremmo forse chiederci se non sia il caso di
cominciare a mettere tra parentesi il concetto stesso di cultura. E’ un
concetto a cui gli antropologi (me compreso) sono particolarmente
affezionati proprio per le ragioni che ne hanno promosso l’elaborazione e
l’utilizzazione e che prima ho cercato di riassumere brevemente. Tuttavia
bisogna chiedersi se il fatto di perseverare nella sua utilizzazione non
generi una sorta di legittimazione, di assuefazione o addirittura, dell’uso
del concetto in contesti extra-accademici.
Cosa voglio dire quando mi azzardo (e non sono certo il solo) a dire che
forse il concetto di cultura dovrebbe essere messo tra parentesi? Infatti
non vorrei essere frainteso.
Spiegare le recenti diatribe sul crocifisso nelle scuole italiane, o
sull’opportunità di evocare Babbo Natale ai giovani studenti musulmani
invocando la diversa “cultura” delle parti in causa, appare altrettanto
inadeguato che riferirsi alla cultura per spiegare le diverse concezioni
giuridiche presenti nelle diverse aree del pianeta. Abbiamo bisogno della
“cultura” per spiegare le sevizie sui prigionieri iracheni? O per
comprendere i motivi che un paio d’anni fa spinsero delle donne cecene a
cercare di farsi saltare per aria con gli ostaggi in un teatro di Mosca,
oppure quando una ventina di anni fa centinaia di adepti di una setta
guidata da un predicatore americano scelsero di compiere un suicidio di
massa? Tutto questo ha forse a che vedere con cose come “la cultura”
occidentale e quella orientale, quella cristiana e quella musulmana?
Prendiamo un esempio concreto: la distruzione delle statue del Budda
avvenuta nel 2000 nella Valle di Bamyan, in Afghanistan per opera dei
taleban. Certo possiamo rifarci alla “iconofobia” della “cultura”
musulmana… Ma a parte il fatto che anche il cristianesimo ha una lunga
tradizione iconofobica che va dall’VIII al XIX secolo, i veri motivi per cui
i taliban fecero saltare le statue è perché queste rientravano nel patrimonio
dell’umanità stilato dall’UNESCO, una categoria costruita, a giudizio dai
talebani, da una cultura, quella occidentale, coi cui principi i talibani non
avevano nessuna intenzione di identificarsi. Se i talibani non sono gli
unici musulmani a non riconoscersi in questa “cultura”, tuttavia non a tutti
i musulmani sarebbe venuto in mente di distruggere le statue. Se
dovessimo applicare il modello culturalista, cosa dovremmo dire dei
movimenti estremisti ebraici che vorrebbero radere al suolo il Tempio
della Roccia costruito a Gerusalemme dal califfo Omar e poi ricoperto
d’oro dai crociati per sostituirlo con un nuovo Tempio? Se non
affrontiamo analisi puntuali e articolate delle motivazioni sociali,
politiche, psicologiche che muovono e gli esseri umani, e ci rifugiamo
nella “cultura” avremo fatto il gioco solo di quanti lo scontro delle civiltà
lo vogliono davvero.
Allo stesso modo, non è sufficiente dire che i film che vediamo alla
televisione, la diffusione della coca-cola e dei MacDonald nel mondo
sono il segno dell’esportazione della cultura americana su scala planetaria:
forse sarebbe meglio interrogarsi sugli interessi che muovono questi
fenomeni, sui discorsi che li promuovono, sui modelli di accettazione o di
rifiuto nei loro confronti e sulle motivazioni e sull’immaginario che
stanno alla base di questi opposti atteggiamenti…..
Poiché il valore d’uso dei concetti dipende dal contesto storico-politico
del loro impiego, del concetto di cultura vanno certamente mantenuti i
suoi significati di base, cioè quelli che fanno capo all’idea di modelli di
comportamento e di ragionamento strutturati e appresi. Questa idea va
declinata però attraverso descrizioni di come questi modelli siano
costruiti, selezionati, utilizzati per produrre progetti che si confrontano
tanto con la dimensione della vita locale quanto con le forze della
globalizzazione (tecnologie, media, modelli di consumo, rappresentazioni
del mondo); e su come queste forze vengano utilizzate, manipolate e
reinterpretate localmente in funzione delle esperienze, delle aspettative,
degli interessi, dell’immaginario e dei progetti egemonici o di resistenza
degli interessati.
Concludo queste mie riflessioni con una domanda retorica. Perché gli
antropologi (ma non solo loro) dovrebbero affidare la propria
comprensione del mondo a una parola che l’uso extra-antropologico ha
trasformato in un idolo del foro e in un feticcio?