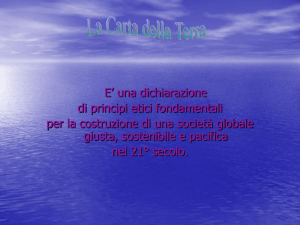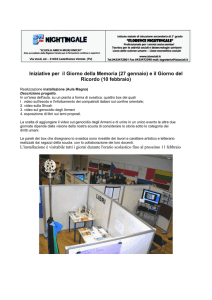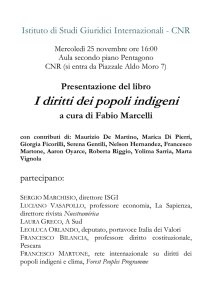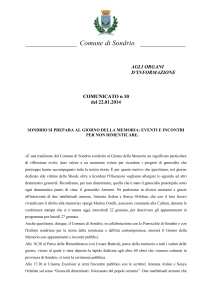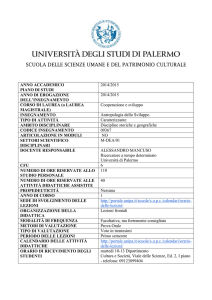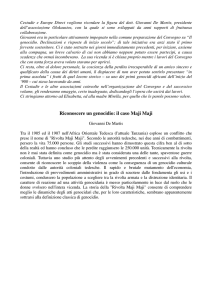la causa dei popoli
anno II/nuova serie
numero 3
gennaio-aprile 2017
la causa dei popoli
problemi delle minoranze, dei popoli indigeni
e delle nazioni senza stato
anno II/nuova serie
numero 3
Direttore: Alessandro Michelucci
Redazione: Katerina Sestakova Novotna, Marco Stolfo,
Maurizio Torretti, Davide Torri
Via Trieste 11, 50139 Firenze, 055-485927, 327-0453975
E-mail: [email protected]
Direttore responsabile: Riccardo Michelucci
Comitato scientifico
gennaio-aprile 2017
EDITORIALE
Per ricordare tutti i genocidi
Thomas Benedikter e Alessandro Michelucci
3
DOSSIER
(D)istruzione scolastica
Andrew Woolford
4
La guerra nera
Runoko Rashidi
Valerie Alia Leeds Metropolitan University, José Luis Alonso Marchante storico indipendente, James Anaya
University of Arizona, Aureli Argemí CIEMEN, Laurent
Aubert Archives internationales de musique populaire,
Claus Biegert Nuclear Free Future Award, Guglielmo
Cevolin Università di Udine, Duane Champagne UCLA,
Naila Clerici Università di Genova, Walker Connor
Middlebury College (†), Alain de Benoist Krisis, Jacques
Fusina Università di Corsica Pasquale Paoli, Edward
Goldsmith The Ecologist (†), Barbara Glowczewski Collège de France, Ted Robert Gurr Center for International
Development and Conflict Management, Debra Harry
Indigenous Peoples Council on Biocolonialism, Ursula Hemetek Universität Wien, Alan Heusaff Celtic League (†),
Zohl dé Ishtar Kapululangu Aboriginal Women's Association, Amjad Jaimoukha International Centre for Circassian Studies, Asafa Jalata University of Tennessee, René Kuppe Universität Wien, Robert Lafont Université
Paul Valéry (†), Colin Mackerras Griffith University, Luisa Maffi Terralingua, Saleha Mahmood Institute of Muslim
Minority Affairs, David Maybury-Lewis Harvard University (†), Matthew McDaniel Akha Heritage Foundation, Antonio Melis Università di Siena (†), Fadila Memisevic Gesellschaft für bedrohte Völker, Garth Nettheim
University of New South Wales, Kendal Nezan Institut
Kurde, Helena Nyberg Incomindios, Nicholas Ostler
Foundation for Endangered Languages, Anna Paini Università di Verona, Alessandro Pelizzon Southern Cross
University, Norbert Rouland Universitè d'Aix-Marseille
III, Rudolph Ryser Center for World Indigenous Studies,
Parshuram Tamang Nepal Tamang Ghedung, Colin Tatz
Australian Institute of Holocaust and Genocide Studies,
Victoria Tauli-Corpuz Tebtebba Foundation, Ned Thomas Mercator Media, Fernand de Varennes Murdoch
University, Michael van Walt van Praag Kreddha, Joseph Yacoub Université catholique de Lyon, Antonina
Zhelyazkova International Centre for Minority Studies
and Intercultural Relations
8
Il genocidio polinesiano
Maui Solomon
10
An Gorta Mór, genocidio per fame
Riccardo Michelucci
12
L'olocausto ai confini del mondo
Alessandro Michelucci
15
Per il riconoscimento del genocidio dei Selk'nam 18
L'architetto del genocidio australe
Intervista a José Luis Alonso Marchante
19
Il primo genocidio del ventesimo secolo
George Steinmetz
22
Holodomor
Giovanna Siedina
26
Suoni, immagini e parole
29
INTERVENTI
Mezzo secolo per l'autonomia della Corsica
Alessandro Michelucci
30
LO SCAFFALE
Biblioteca
Nuvole di carta
Cineteca
Autori
2
31
37
39
40
Per ricordare tutti i genocidi
Il termine genocidio fu coniato nel 1943 dall'avvocato polacco Raphael Lemkin, che lo utilizzò per la
prima volta nell'introduzione del suo libro Axis Rule in Occupied Europe, datata 15 novembre 1943.
L'opera uscì l'anno successivo. Erano i tempi bui della Shoah, quindi fu naturale che la tragedia ebraica fosse il primo caso al quale veniva applicata la nuova definizione. Poi, per circa mezzo secolo, lo sterminio della minoranza israelita è stato considerato una tragedia unica e irripetibile, il
crimine contro l'umanità per eccellenza. Ogni confronto con altri genocidi era considerato un sacrilegio. Purtroppo Lemkin era morto nel 1959, quindi non poteva contestare questa falsificazione del
suo pensiero. Il giurista di religione ebraica era stato il primo a studiare la materia approfondendo
una grande varietà di casi, dal Metz Yeghern (genocidio armeno) a quello degli aborigeni della Tasmania. Grazie a questi studi aveva elaborato la Convenzione sul genocidio, approvata dall'ONU il
9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951. L'umanità ha un debito sconfinato nei suoi
confronti. Nonostante questo, purtroppo, nessuno dei suoi libri è stato ancora tradotto in italiano.
Ma non è bastato che il genocidio fosse dichiarato un crimine di diritto internazionale: dalla Cambogia al Ruanda, dalla Bosnia al Biafra, l'ultimo mezzo secolo è stato costellato di tragedie epocali
che hanno riaperto le ferite della Seconda guerra mondiale. Molti avevano detto Mai più, ma non è
bastato per evitare che certi orrori si ripetessero. Stavolta, inoltre, i genocidi sono stati documentati in tempo reale dai media. Hanno ispirato il cinema, come ci ricordano Jonathan Friedman e
William Hewitt in The History of Genocide in Cinema: Atrocities on Screen (I. B. Tauris, 2016).
Di conseguenza il dibattito sul tema è stato inquadrato in un'ottica nuova. Il termine genocidio è stato
applicato anche ad altri casi. Sono usciti molti libri sul genocidio armeno, su quello degli Indiani americani e di altri popoli indigeni sterminati dai colonialisti europei. Come gli Herero e i Nama, vittime del primo genocidio del Novecento, quasi completamente cancellati dal potere coloniale tedesco.
Inserire la tragedia ebraica in un contesto più ampio, accanto ad altri genocidi, non significa diminuirne il rilievo storico. Al contrario, significa toglierla da una terra di nessuno dove resterebbe un
fenomeno incomprensibile. Oggi l'unicità della Shoah è rifiutata anche da molti studiosi ebrei: basti pensare a Israel Charny, fondatore e direttore dell'Istituto di studi sul genocidio di Gerusalemme, curatore della Encyclopedia of Genocide (ABC-CLIO, 2000).
La risposta ideale a questo nuovo contesto è una giornata della memoria dedicata a tutti i genocidi.
Inclusi quelli di tante comunità piccole e remote che non hanno canali diplomatici per far sentire la
propria voce. Del resto, se ci sono giornate internazionali per temi che riguardano tutti - l'infanzia,
i diritti umani, la pace - perché non può esisterne una dedicata al genocidio?
Gli studi di Lemkin, come abbiamo visto, avevano preso in considerazione anche eventi dei secoli
scorsi. Proprio perciò abbiamo voluto dedicare un numero ad alcuni genocidi avvenuti prima della
Shoah. Nessuno di questi ha ottenuto un riconoscimento ufficiale, ma molte iniziative politiche che
si prefiggono questo obiettivo sono in corso proprio in questi anni.
Thomas Benedikter
Alessandro Michelucci
Un esempio da seguire
Anche se non si tratta di un'iniziativa ufficiale, una giornata dedicata al ricordo di tutti i genocidi esiste già:
alludiamo al Genocide Memorial Day, che viene organizzato a Londra dalla Islamic Human Rights Commission (IHRC), un'ONG riconosciuta dalle Nazioni Unite. Questo progetto rifiuta che i genocidi siano sottoposti a una classificazione gerarchica. Lanciata nel 2008, la giornata si svolge in una data variabile, ma
generalmente in gennaio. Ogni anno è dedicata a un tema specifico, come Steps leading to genocide (2015),
Genocidal weapons (2016) e Lessons from the cultural genocide of Muslims and Jews in Europe (2017). La
parte principale dell'evento è una conferenza alla quale partecipano relatori qualificati provenienti da tutto il
mondo. Negli ultimi anni iniziative analoghe collegate a questa si sono tenute in altre città, fra le quali
Amsterdam, Barcellona e Parigi. La prossima edizione si svolgerà il 21 gennaio 2018.
3
(D)istruzione scolastica
Andrew Woolford
Non è facile fornire un quadro generale della politica assimilazionista che il Canada e gli Stati Uniti hanno realizzato attraverso le scuole per indiani. Anzitutto perché non si può parlare di un'esperienza omogenea. Nonostante l'obiettivo fosse lo stesso, le scuole si svilupparono in modi diversi a causa di vari fattori, fra i quali il potere delle comunità indigene locali e il comportamento
delle autorità scolastiche. La pratica assimilazionalista fu quindi un'esperienza disuguale che causò
effetti più o meno devastanti a seconda del tempo e del luogo. Inoltre, perché i convitti per indiani
erano situati in agglomerati coloniali articolati che comprendevano altre strutture educative, come
le scuole pubbliche, insieme a chiese, ospedali, tribunali e tutto quello che era stato predisposto per
realizzare l'assimilazione della minoranza indigena. Ma i convitti erano soltanto una parte del vasto corredo sociale e giuridico concepito per sradicare le culture indiane. Accanto a questi c'erano
le leggi che vietavano le pratiche spirituali, che imponevano la logica della proprietà privata, che
cercavano di distruggere le forme di autogoverno tribale. Concentrarsi unicamente sui convitti sarebbe quindi un grave errore.
Detto questo, si possono comunque individuare diversi tratti comuni all'esperienza canadese e
a quella statunitense. In entrambi i paesi le scuole concepite per l'assimilazione, che erano attive a
livello sperimentale dal diciassettesimo secolo, divennero pratica corrente soltanto nella seconda
metà dell'Ottocento. All'epoca si pensò che il cosiddetto "problema indiano", cioè il fatto che gli indigeni fossero considerati un ostacolo all'occupazione delle terre, potesse essere risolto con l'assimilazione e con l'americanizzazione. Le guerre indiane e i trasferimenti coatti realizzati negli Stati
Uniti segnarono un precedente prezioso per i due paesi nordamericani. Poi si fece strada la convinzione che "educare" gli Indiani fosse meno costoso che combatterli. Inoltre i difensori dei loro
diritti, denunciando le atrocità che l'esercito americano compiva contro di loro, spinsero il governo
a fermare queste violenze e a imboccare un'altra strada.
Fu così che l'educazione divenne il sistema privilegiato per la soluzione del problema indiano.
La strategia presa a modello fu quella dei missionari: come questi se ne servivano per convertire
gli Indiani al cristianesimo, il governo avrebbe usato l'istruzione per trasformarli in americani.
Quindi i missionari avrebbero svolto un ruolo centrale in questa opera di sradicamento culturale. Il
primo a mettere in pratica la nuova strategia fu un tenente dell'esercito statunitense, Richard
Henry Pratt (1840-1924). L'esperimento ebbe inizio nella prigione di Fort Marion, dove il militare era responsabile di 72 guerrieri indiani che erano stati catturati. Pratt ne fece trasferire alcuni allo
Hampton Normal and Agricultural Institute, un istituto per ex schiavi situato in Virginia. Infine, nel
1879 fondò la prima scuola vera e propria a Carlisle, in Pennsylvania.
Il modello ideato da Pratt prevedeva che i giovani indigeni venissero tenuti a contatto con la "civiltà", cioè vicino a luoghi abitati dai coloni europei. Questo veniva considerato un mezzo necessario per staccarli dai genitori e per avvicinarli alla cultura europea. La disciplina imposta ai ragazzi
era una sintesi di regole militari, avviamento professionale e istruzione di base. Gli alunni si alzavano presto tutti i giorni per fare esercizi fisici, quindi venivano sottoposti all'ispezione, dopodiché
trascorrevano il resto della girnata fra il lavoro e la scuola.
Le idee di Pratt vennero accolte in Canada, dove fornirono il modello per realizzare l'assimilazione degli indigeni. La federazione confinante aveva combattuto meno guerre contro di loro e aveva cercato a lungo un modo per assimilarli. Nel 1879 il governo conservatore di John Alexander
MacDonald incaricò Nicholas Flood Davin di studiare la questione. Il giovane avvocato di origine
irlandese scrisse il Report on Industrial Schools for Indians and Half-Breeds, meglio noto come The Da4
vin Report, dove consigliava al governo di istituire convitti analoghi a quelli già attivi negli Stati Uniti. Rispetto alle scuole ideate da Pratt c'era una sola differenza. Davin era convinto che un sistema gestito direttamente dallo stato non fosse praticabile e che il governo dovesse amministrarlo attraverso le missioni che erano già state impiantate nei pressi delle comunità indigene. In un primo
momento il Canada fece costruire grandi scuole secondo il modello statunitense, ma poi questa soluzione si rivelò troppo costosa e il governo federale optò per piccoli edifici situati in zone più vicine alle comunità indigene.
La differenza fra i convitti canadesi e quelli statunitensi derivò anche dal diverso ruolo delle istituzioni cattoliche e di quelle protestanti. Negli Stati Uniti il numero delle scuole religiose per ragazzi indigeni cominciò a diminuire alla fine del diciottesimo secolo, quando il governo smise di
finanziarle. In Canada, al contrario, il fatto che le scuole fossero gestite dai misionari ebbe effetti
negativi per i ragazzi, perché permise alle strutture religiose di conservare un rigido controllo dei
programmi didattici. Di conseguenza le scuole canadesi rimasero più impermeabili ai cambiamenti
rispetto a quelle statunitensi. Il Bureau of Indian Affairs, per esempio, abbandonò l'originaria impostazione militaresca per sostituirla con una che dava una certa autonomia agli studenti. In Canada,
invece, le scuole rimasero sotto una disciplina monastica che aveva come obiettivo primario l'indottrinamento religioso. Oltre a questo, il rapporto fra il governo canadese e le strutture religiose
fu tutt'altro che felice. Il primo garantiva i finanziamenti minimi e i religiosi riempivano le scuole
per ottenere sovvenzioni maggiori. Le scuole statunitensi, in genere, potevano far conto su finanziamenti più generosi, anche se non sempre sufficienti. In entrambi i paesi i ragazzi erano costretti
a vivere in ambienti sovrappopolati, erano malnutriti, avevano pochi vestiti e strutture sanitarie inefficienti.
I convitti statunitensi erano inquadrati in un contesto legislativo più chiaro e definito di quelli
canadesi. Le leggi federali prevedevano che l'istruzione dei ragazzi cominciasse nelle scuole delle
riserve; il livello intermedio doveva poi essere svolto nei convitti situati negli stessi luoghi; infine i
ragazzi, che ormai avevano almeno 13 anni, dovevano completare gli studi in convitti esterni. In
Canada il criterio che determinava chi dovesse studiare in un luogo o in un altro era molto più
vago. Dopo il 1920, quando un emendamento dell'Indian Act (approvato originariamente nel 1876,
ndt) stabilì che i giovani indigeni appartenessero alla confessione imposta alla propria comunità di
origine, questi furono costretti a frequentare convitti diretti da sacerdoti della stessa confessione.
Così venivano spesso rinchiusi nei convitti esterni all'età di cinque o sei anni.
Infine, il sistema canadese conobbe mutamenti meno traumatici rispetto a quello statunitense.
Nel primo caso i responsabili delle scuole furono sostituiti poche volte. Uno di loro, Duncan
Campbell Scott, conservò la carica per quasi venti anni (1913-1932), analogamente a quelli che lo avevano preceduto e a quelli che vennero dopo di lui. Negli Stati Uniti, invece, il Bureau of Indian
Affairs sperimentò numerosi mutamenti, talvolta radicali, soprattutto quando fu guidato da John
Collier, un sincero sostenitore degli Indiani (1933-1945). Sotto la sua direzione l'organismo federale
cercò di risolvere i problemi evidenziati dal Meriam Report, che nel 1928 aveva criticato duramente
la gestione dei convitti.
Molti studiosi e attivisti sostengono che attraverso il sistema dei convitti per indigeni sia stato
realizzato un genocidio. Questa tesi impone una riflessione. Raphael Lemkin (1900-59) ha ideato il
termine genocidio quando ha concepito un corpus giuridico che colmava un vuoto: all'epoca esistevano molte leggi che tutelavano gli individui, ma nessuna che proteggesse le collettività. Per
Lemkin il genocidio è il tentativo deliberato di distruggere le "basi essenziali del gruppo". Questo
può realizzarsi con la soppressione fisica, ma anche con la distruzione delle istituzioni culturali (famiglia, religione, etc.). Il giurista polacco difese strenuamente questo concetto. Dopo essere
scampato alla Shoah riparò negli Stati Uniti, dove svolse un ruolo decisivo nell'elaborazione della
Convenzione dell'ONU sul genocidio. Nei dibattiti dell'Assembea Generale il concetto di genocidio
guadagnò dignità giuridica, ma le implicazioni culturali della materia vennero sostanzialmente escluse dal testo finale. Lemkin dovette accettare questo compromesso, seppure a malincuore: per
lui l'aspetto culturale era fondamentale, in quanto costituiva un legame comunitario fatto di lin5
gue, tradizioni e pratiche. Il giurista sperava comunque che in un secondo tempo il testo della Convenzione avrebbe potuto includere il concetto di genocidio culturale.
L'articolo III della Convenzione, relativo al tema in questione, venne osteggiato da molti membri dell'Assemblea Generale che lo ritenevano troppo vago e quindi inapplicabile. Inoltre sostenevano che le sue garanzie erano già contenute in altre leggi per la tutela delle minoranze. Secondo altri era insensato proteggere culture arretrate e primitive. Il Canada e gli Stati Uniti furono
fra i più decisi avversari dell'articolo III. Il governo di Ottawa inviò alla delegazione canadese istruzioni molto chiare: "Dovete fare tutto il possibile perché l'articolo III venga cancellato. Se
questo non basta, dovete votare contro l'articolo III, e se necessario contro l'intera Convenzione".
La delegazione canadese fu anche esortata a fare fronte comune con quella statunitense. Alla fine
26 paesi votarono contro l'articolo, 16 si espressero a favore e 4 si astennero.
Le ragioni politiche che condizionarono l'approvazione della Convenzione hanno determinato
un contrasto fra gli storici, i giuristi e tutti gli altri che studiano il genocidio: non è chiaro cosa si
voglia proteggere. I diritti individuali o quelli di un gruppo? E se si tratta dei secondi, cos'è un
gruppo? Come si può proteggere una struttura sociale dinamica e soggetta al cambiamento?
Le vittime dimenticate del terrorismo biologico
I popoli indigeni delle Americhe non avevano sviluppato alcuna difesa immunitaria contro le malattie infettive provenienti dall'Europa, come il tifo, la difterite e il vaiolo. Fu proprio quest'ultima che li colpì con
particolare violenza. Ma il morbo non si diffuse in maniera naturale: fu un caso di quello che oggi chiameremmo "terrorismo biologico".
Lord Jeffrey Amherst comandava le forze britanniche nella fase finale delle guerre franco-indiane (17581763). Secondo quello che viene attestato da molti studiosi, Amherst ebbe l’idea di sterminare gli Indiani
distribuendo loro delle coperte infette di vaiolo. In una lettera indirizzata al colonello Henry Bouquet, datata 13 luglio 1763, Amherst propose esplicitamente di "ammorbare gli Indiani" (to inocculate the Indians) diffondendo le coperte contaminate.
In una lettera di pochi giorni dopo il generale inglese suggerì di "utilizzare ogni mezzo che possa servire
per estirpare questa razza maledetta". In queste missive si parlava anche di altri mezzi, come l'uso di cani
per cacciare gli Indiani (il cosiddetto "metodo spagnolo"). La diffusione del vaiolo è confermata da alcune
lettere successive. Ad Amherst fu intitolata la città omonima, situata nel Massachusetts, che venne fondata nel 1818.
Questa pratica genocida divenne di uso comune e continuò anche nei decenni successivi. Le vittime furono tante, ma il peggio doveva ancora venire. Nel 1832, con l'invenzione del battello a vapore, la diffusione delle coperte contaminate divenne ancora più facile. Neanche i più remoti villaggi indiani si salvarono.
Qualche anno dopo si diffuse una nuova epidemia di vaiolo, inizialmente limitata a coloro che vivevano
vicino alle stazioni commerciali dell'alto Mississippi. L'epidemia sterminò il 98% delle persone infette; i
più colpiti furono i Blackfeet, gli Assiniboine e i Mandan. Di questi ultimi, che in origine erano 1600, sopravvissero soltanto trentuno persone.
Giovanna Marconi
Tornando al tema che ci interessa, val la pena di soffermarsi su due motivi per i quali lo sradicamento culturale operato dai convitti può definirsi genocidio. Il primo è il loro tentativo, spesso riuscito, di spezzare il legame fra i ragazzi e le loro famiglie. Appena arrivati nelle scuole, gli alunni
venivano privati dei nomi indigeni che evidenziavano il loro legame col territorio e con la comunità. I loro vestiti venivano distrutti. Fratelli e sorelle erano alloggiati in luoghi separati e potevano
vedersi di rado. I sopravvissuti raccontano che i ragazzi non dovevano chiamare i genitori "mamma" e "papà", mentre gli insegnanti e le altre autorità dovevano rimpiazzare la famiglia. Oltre a
questo, la distanza fra le comunità e le scuole, tutte recintate, limitava al minimo il contatto con i
parenti. Tutto questo distruggeva i legami sociali dei ragazzi e delle loro comunità. Gli alunni non
venivano privati soltanto della propria identità collettiva, ma anche dei legami familiari, comunitari e territoriali.
6
Le scuole svolgevano una funzione distruttiva anche nei confronti della cultura. L'uso delle lingue indigene era proibito. Questi idiomi basati sul verbo venivano sostituiti da lingue basate sul
sostantivo (in genere inglese o francese). La distruzione delle lingue indigene si intrecciava col tentativo di scardinare il legame con la terra. Ai ragazzi si insegnava che la terra non era una materia
viva e ricca di significati culturali, ma qualcosa da possedere, recintare e trasformare in fonte di
reddito individuale. Allo stesso modo, gli animali venivano considerati una risorsa economica, anziché esseri viventi con i quali vivere in armonia. Intanto, giorno dopo, l'insegnamento di materie
estranee cancellava culture antiche fatte di canzoni, cerimonie, giochi, leggende e altre tradizioni.
Quando lasciavano le scuole i ragazzi erano ormai privi dei legami culturali con la comunità
originaria.
A tutto questo devono aggiungersi le violenze fisiche e sessuali che erano pratica corrente. I pesanti traumi che ne derivavano avevano un effetto devastante, non soltanto a livello individuale,
ma anche nei rapporti con la comunità originaria. Come un veleno che uccide le radici di una pianta, i convitti canadesi e statunitensi distruggevano le "basi essenziali" delle comunità indigene.
La via canadese alla riconciliazione
La pratica dei convitti per indiani rientra perfettamente nella definizione di genocidio approvata dalle Nazioni Unite nel 1948, che prevede fra l’altro: (b) cagionare seri danni fisici o mentali ai membri del
gruppo; (e) trasferire forzatamente i bambini del gruppo a un altro gruppo. Canada e Stati Uniti sono
colpevoli allo stesso modo, ma soltanto il primo stato ha manifestato l’intenzione di riparare.
A tale scopo è nata la Truth and Reconciliation Commission (TRC), concepita sulla falsariga delle commissioni analoghe che erano già state create in Cile (1990) e in Sudafrica (2001). L'organismo, istituito ufficialmente il 2 giugno 2008, ha terminato i lavori alla fine del 2015. In questi sei anni ha raccolto le testimonianze di circa 6000 persone che erano state strappate alle rispettive famiglie e rinchiuse nei famigerati
convitti.
Nel suo documento finale la TRC afferma fra l'altro che "la riconciliazione deve aiutare gli indigeni a cancellare gli effetti della colonizzazione che ha avuto un impatto così devastante sulle loro vite" e che "i soli
responsabili della riconciliazione sono gli indigeni stessi: sono loro che devono superare il trauma". Questa formula esclude quindi ogni responsabilità della maggioranza di origine europea.
Antonella Visconti
Bibliografia
AA. VV., Honouring the Truth, Reconciling for the Future - Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada, The Truth and Reconciliation Commission of Canada, Ottawa (ON) 2015.
Sellars B., They Called Me Number One: Secrets andSurvival at an Indian Residential School, Talonbooks, Vancouver
(BC) 2013.
Starblanket T., Suffer the Little Children: Genocide, Indigenous Nations and the Canadian State, Clarity Press,
Atlanta (GA) 2017.
Woolford A., "This "This Benevolent Experiment": Indigenous Boarding Schools, Genocide and Redress in North
America, University of Nebraska Press - University of Manitoba Press, 2015.
7
La guerra nera
Runoko Rashidi
Per una larga maggioranza di persone la Tasmania è soltanto un'isola remota e sconosciuta. L'unica
associazione d'idee che può stimolare è quella col diavolo della Tasmania, il vorace marsupiale
popolarizzato dai cartoni animati della Warner Bros. e dai fumetti della Marvel. Ma dietro il nome
di quest'isola si nasconde una storia tragica e dimenticata.
La Tasmania, poco più grande della Lituania (68.400 kmq), è situata circa 300 km a sudovest
dell'Australia continentale. Il suo popolo aborigeno, i Palawa, ha caratteristiche fisiche ben definite: pelle e occhi scuri, capelli crespi, naso camuso, altezza contenuta e corporatura poco grassa.
Probabilmente è originario dell'Australia continentale, che avrebbe lasciato 35.000 anni fa per stabilirsi in Tasmania. All'epoca le due isole erano unite da una lunga striscia di terra, ma col passare
del tempo il livello del mare la sommerse e gli aborigeni della Tasmania si ritrovarono isolati dal
resto del mondo.
L'arrivo degli europei
Questo isolamento finì con l'arrivo di Abel Janszoon Tasman, il navigatore olandese che raggiunse
l'isola negli ultimi giorni del 1642. La chiamò Terra di Van Diemen in onore di Antonio Van Diemen, governatore generale della Vereenigde Oostindische Compagnie (Compagnia Olandese delle Indie Orientali), la compagnia commerciale nata nel 1602 per gestire le attività commerciali delle colonie asiatiche. L'isola avrebbe conservato questo nome fino al 1855. Nel 1777 arrivarono i britannici, che all'inizio del secolo successivo la trasformarono in una colonia penale come avevano già
fatto con l'Australia. In poco tempo l'isola fu invasa da 65000 persone: galeotti, missionari, soldati e
funzionari con le loro famiglie.
Uno sterminio lento
Il governo coloniale manifestò subito il massimo disprezzo per la popolazione autoctona, che fu
sottoposta a violenze di ogni tipo. Massacrati o ridotti in schiavitù, i Palawa non venivano considerati esseri umani, mentre la scienza dell'epoca teorizzava la superiorità dell'uomo bianco, europeo e cristiano. Le donne venivano rapite, incatenate e violentate. I coloni si divertivano a torturare
gli indigeni e a cacciarli come se fossero animali.
Poi cominciò la cosidetta guerra nera (Black War), il genocidio vero e proprio. Fra il 1803 e il 1830
gli aborigeni della Tasmania, che erano circa 5000, furono ridotti a poche decine. La legge marziale
che venne dichiarata nel novembre 1828 autorizzava i bianchi a sparare a vista sugli indigeni. La
resistenza di questi ultimi fu eroica, ma le loro lance non poterono competere con i fucili e con la
spietatezza dei coloni. Successivamente furono messe delle taglie sui neri: 5 sterline per un adulto,
2 per un bambino. Alcuni proposero di catturarli per venderli come schiavi, di avvelenarli o di imprigionarli, ma il governo preferì continuare con le taglie e con l'uso della polizia a cavallo.
Dopo il genocidio gli aborigeni cessarono di essere percepiti come un pericolo per diventare un
semplice fastidio. Così si fece strada un atteggiamento paternalistico: i coloni rinchiusero i pochi
neri sopravvissuti in campi di concentramento, dicendo che questo veniva fatto nel loro stesso interesse. Al tempo stesso i Palawa divennero oggetto di un interesse pseudoscientifico, dato che i
bianchi videro in loro "l'anello mancante fra l'uomo e la scimmia".
Nel 1859 Charles Darwin pubblicò On the Origin of Species, diffondendo la teoria dell'evoluzione
biologica e sociale che metteva i bianchi all'inizio e i neri alla fine della scala evolutiva. Così gli aborigeni australiani vennero considerati un gruppo di persone "destinate a estinguersi secondo una legge naturale, come il dodo e il dinosauro". Nello stesso periodo, negli Stati Uniti, la legge sta8
bilì che i neri non avevano alcun diritto che i bianchi dovessero rispettare. William Lanney, che
quando era vivo veniva deriso, una volta morto divenne un oggetto ambito. Due persone si contesero le sue ossa: dicevano di essere stati inviati dalla Royal Society of Tasmania. Il 6 marzo 1868,
quando Lanney fu sepolto, l'ospedale era affollato da una cinquantina di persone interessate al suo
cadavere. Si sparse la voce che il corpo fosse stato mutilato, così la bara venne aperta per dimostrare ai presenti che non era vero. Poi fu chiusa e sigillata.
Nel frattempo si venne a sapere che la notte prima un chirurgo era entrato nella stanza dove si
trovava il cadavere di Lanney e aveva portato via il suo teschio dopo aver asportato il cuoio
capelluto. Sembra che poi questo sia stato incollato sul teschio di un paziente deceduto lo stesso
giorno. I membri della Royal Society si mostrarono "molto irritati" quando seppero che qualcuno li
aveva preceduti. Così fu deciso che gli venissero asportati i piedi e le mani per evitare che il corpo
fosse ulteriormente mutilato da estranei. Come sempre, nessuno venne perseguito. Fu questa la
fine di William Lanney, l'ultimo aborigeno della Tasmania.
Truganini, l'ultima palawa
Truganini, l'ultima palawa di sangue puro, morì il 7 maggio 1876, all'età di 73 anni. Sua madre era
stata uccisa da un europeo. Sua sorella fu rapita da altri europei. L'uomo che avrebbe dovuto sposarla fu annegato annegato davanti a lei da due coloni che poi la violentarono. La sua tragedia personale riassume quella del suo popolo. "Non lasciate che mi taglino a pezzi" disse implorando il
dottore mentre stava per morire. Dopo la sepoltura il corpo di Truganini fu riesumato, e il suo
scheletro, legato con delle corde e sistemato in posizione verticale dentro una cassa, venne esposto
al Tasmanian Museum, dove rimase fino al 1947. Nel 1976, in occasione del centenario della morte,
nonostante il parere contrario del museo, i resti di Truganini sono stati cremati e le sue ceneri sono
state sparse nell'oceano.
Tasmania aborigena
Cronologia recente
6 maggio 1967 Un referendum conferisce agli Aborigeni australiani il diritto di voto.
1973 Nasce il Tasmanian Information Centre, poi ribattezzato Tasmanian Aboriginal Centre (TAC).
1976 Michael Mansell, direttore del TAC, si rivolge alla Regina Elisabetta per rivendicare i diritti territoriali.
1983 Nasce il Tasmanian Aboriginal Land Council, che negozierà col governo le questioni territoriali e
culturali.
1985 Il Parlamento della Tasmania dispone che tutti i resti umani custoditi nei musei statali vengano consegnati alla comunità aborigena.
1995 Il governo della Tasmania, guidato dal liberale Ray Groom, restituisce alla comunità aborigena un'area di 3800 ettari.
1997 La Tasmania è il primo stato australiano che presenta scuse ufficiali per le Stolen Generations, i
piccoli aborigeni strappati alle rispettive famiglie durante il ventesimo secolo per "farne dei bianchi".
2006 La Tasmania è il primo stato australiano che fissa un risarcimento per le Stolen Generations.
15 dicembre 2016 La Costituzione della Tasmania riconosce i Palawa come abitanti originari dell'isola.
Bibliografia
Chauncy N., Hunted in Their Own Land, Seabury Press, New York (NY) 1973.
Flanagan R., Solo per desiderio, Frassinelli, Milano 2011 [romanzo].
Lawson T., The Last Man: A British Genocide in Tasmania, I. B. Tauris, London 2015.
Lore T. (McPherson K.), The Genocide of Tasmania's Lia Pootah Aboriginal People: A Living Death, Manuta
Tunapee Puggaluggalia, Lindisfarne (TAS) 2005.
Reynolds H., Forgotten War, University of New South Wales Press, Sydney (NSW) 2013.
Ryan L., Tasmanian Aborigines: A History since 1803, Allen & Unwin, Sydney (NSW) 2012.
9
Il genocidio polinesiano
Maui Solomon
I Moriori discendono dai popoli della Polinesia orientale che si stabilirono nell'arcipelago delle isole Chatham (in moriori Rēkohu, "terra dei cieli nebbiosi"), situato 800 km a est della Nuova Zelanda, all'inizio del sedicesimo secolo. La loro società si basa sulla legge di Nunuku, introdotta dal
capo tribale che vietò la guerra, il cannibalismo e l'omicidio.
Il primo contatto dei Moriori con gli europei risale al 1791, quando la nave britannica Chatham
raggiunse l'arcipelago. L'incontro degenerò presto in uno scontro dove un indigeno perse la vita.
Negli anni successivi arrivarono anche molti cacciatori di foche e di balene: nel 1830 i Moriori erano ormai diminuiti da 2500 a 2000 in seguito alle malattie introdotte dai coloni. Pochi anni dopo,
nel 1835, due tribù maori provenienti dalla Nuova Zelanda raggiunsero l'arcipelago su una nave di
mercenari europei e lo invasero approfittando dell'accoglienza pacifica che avevano ricevuto.
Quindi uccisero 230 moriori adulti e ridussero in schiavitù gli altri. Nel 1865 la popolazione autoctona era ormai ridotta a 101 persone.
I sopravvissuti chiesero aiuto al governo neozelandese. Nel 1862 Hirawanu Tapu, che aveva 11
anni al tempo dell'invasione, compilò una lista di 1662 nomi con l'aiuto dei moriori più anziani.
L'elenco evidenziava che 118 uomini e 108 donne erano stati uccisi e mangiati, mentre gli altri 1336
erano deceduti in seguito alle condizioni disumane alle quali erano stati sottoposti. Molti erano
morti di disperazione e di stenti. La lista non includeva i nomi di molti bambini che erano stati uccisi perché i loro nomi erano ignoti.
Tapu, d'accordo con i 33 anziani sopravvissuti, scrisse alcune lettere a George Grey, governatore della Nuova Zelanda, chiedendogli di liberarli e di restituire loro la terra:
Amico Grey, ascolta quello che ho da dirti... I Maori non hanno diritti sulla nostra terra, ma ce la stanno rubando. Questa terra è nostra. Siamo noi i suoi abitanti originari... Questa è la nostra parola... la legge dice
che la terra sottratta ingiustamente deve essere restituita a chi la possedeva. Siamo esausti, ti preghiamo di
risolvere questo problema... tutto questo è contro la legge.
Quello che è accaduto negli ultimi due secoli ha lasciato un grande trauma nella società moriori.
Nonostante questo, i discendenti dei sopravvissutisi si sono dimostrati capaci di reagire. Oggi sono almeno 1500 coloro che si autodefiniscono ufficialmente moriori, anche se si calcola che le persone imparentate con quelli delle generazioni passate siano circa 8000. Ma dato che la loro cultura
è stata a lungo oggetto di disprezzo, molti esitano a manifestarla apertamente o non riescono a ritessere i legami col passato.
Un popolo che rinasce
L'interesse per i Moriori è rinato nel 1980 grazie a un documentario televisivo sulla loro cultura.
Nel 1986 è stata realizzata una statua in onore di Tame Horomona Rehe, meglio noto col nome
anglicizzato di Tommy Solomon (1884–1933), che viene considerato l’ultimo moriori purosangue.
L'attenzione per questa cultura è cresciuto notevolmente dopo l'uscita del libro di Michael King
Moriori: A People Rediscovered, (Viking, 1989). Negli anni successivi sono nate varie iniziative culturali alle quali ha contribuito il governo.
Nel frattempo chi scrive si era rivolto al Tribunale di Waitangi (l'organo consultivo creato
per esaminare le rivendicazioni indigene, ndt) reclamando il riconoscimento dei propri diritti territoriali. Nel 2001 l'azione è stata accolta e gli indigeni hanno cominciato a negoziare con la Corona
10
britannica una soluzione della vertenza. Nello stesso contesto è nato lo Hokotehi Moriori Trust
(HMT), l'organismo ufficiale che rappresenta questo popolo a livello giuridico e politico. Nel 2005,
dopo lunghi contrasti, ha ottenuto il riconoscimento dei diritti di pesca. Negli ultimi anni lo HMT
ha avviato varie iniziative per sviluppare il turismo e ha acquistato due fattorie. Al tempo stesso
ha cercato di tutelare il poco che resta della cultura materiale, come gli intarsi su legno, e di conservare il patrimonio naturale. Alcune di queste attività, come abbiamo detto, vengono realizzate
col sostegno del governo.
I discendenti di Ngati Mutunga, una delle tribù che invasero le isole Chatham nel 1835, vivono
ancora su Rehoku. Anche loro stanno negoziando con la Corona un accordo relativo alle proprie
rivendicazioni, ma queste sono molto diverse da quelle dei Moriori, dato che nel 1870 hanno ricevuto il 98% delle nostre terre dalla Corona stessa. I due popoli indigeni hanno cercato insieme di
mettere ordine in questa situazione confusa e di gettare le basi di una convivenza pacifica. Questa
è stata favorita anche da molti matrimoni misti, ma i rispettivi legami identitari sono rimasti molto
forti. La cultura moriori si basa sulla convivenza pacifica e sulla condivisione delle risorse naturali.
La saggezza del passato deve essere la stessa che guida la nostra comunità insulare verso un futuro
armonioso e pacifico:
Ta tiro atu to kanohi ki tairawhiti ana tera whiti ta ra kite ataata ka hinga ki muri kia ko
(Volta il viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te)
Secondo uno studio recente, fra il 1835 e 1863 la popolazione moriori aveva subito un collasso demografico del 77%. Il solo fenomeno paragonabile in termini percentuali è lo sterminio degli ebrei
europei realizzato dalla Germania nazionalsocialista. Nel 1933, dopo la morte di Tommy Solomon, il popolo era stato considerato estinto. Oggi, grazie alla rinascita culturale degli ultimi trent'anni, i Moriori hanno riacquistato una certa visibilità e sono riconosciuti ufficialmente dal governo neozelandese.
Il valore della pace
Pace non è soltanto una bella parola, ma la fedeltà concreta ad un principio. I Moriori lo hanno dimostrato nel 1836, quando le loro isole furono invase dai Maori. Alcuni secoli prima avevano volonariamente abbandonato la pratica bellica e l'omicidio vivendo in pace per 500 anni. Erano così
convinti di questo patto con gli dei che non l'hanno potuto rinnegare neanche per evitare la distruzione fisica e culturale. Naturalmente molti non condividono questo comportamento, ma loro sono
fieri di essere rimasti fedeli alla scelta di pace che avevavo fatto alcuni secoli prima. Hanno mantenuto il patto che avevano stretto con i loro dei: non rubare mai una vita umana con mezzi violenti.
Quindi il valore fondamentale della cultura moriori è la pace. Negli ultimi due secoli, però, questi
indigeni polinesiani sono stati costretti a lottare per sopravvivere e per mantenere viva la propria
cultura. Per essere riconosciuti gli abitanti originari di queste piccole ma preziose isole sperdute
nel Pacifico.
Bibliografia
Blank J., Imagining Moriori: A History of Ideas of a People in the Twentieth Century, tesi universitaria, University
of Canterbury, 2007.
King M., Moriori: A People Rediscovered, Viking, Auckland 1989.
Meade R., Pool I., Estimates of the Surviving 2013 Moriori Population and Deficit in that Population due to the
Moriori People's post 1842 Enslavement (Missing Voices Report), Hokotehi Moriori Trust, Rehoku 2016.
11
An Gorta Mór, genocidio per fame
Riccardo Michelucci
Patate puzzolenti insozzarono la terra
fosse di pus che si trasformarono in sudici tumuli
e dove sono gli scavatori di patate
si può ancora sentir l’odore della ferita purulenta
(Seamus Heaney, "At a Potato Digging", 1966)
C'è chi la chiama Great Famine (Grande Carestia), chi invece ritiene più corretto definirla Great
Hunger (Grande Fame), oppure usa la variante gaelica di quest'ultima, An Gorta Mór. Quello che a
prima vista può apparire poco più di un sottile gioco lessicale sancisce in realtà una differenza sostanziale, capace di riaccendere rancori antichi e persino di innescare richieste di risarcimento. Ciò
che è fuori di dubbio è che quella che si verificò in Irlanda tra il 1845 e il 1850 fu la più immane tragedia avvenuta in epoca moderna nel Vecchio Continente prima dell'Olocausto. In poco meno di
cinque anni circa un milione di irlandesi furono uccisi dalla fame, dal tifo e dal colera, mentre altri
due milioni furono costretti all'emigrazione. Ma l'incerta contabilità di questa ecatombe non basta,
da sola, a raccontare i paradossi che aggravarono ulteriormente le sue dimensioni epocali.
Quasi mezzo secolo prima l'Irlanda era stata costretta all'unione politica con la Gran Bretagna e
privata del proprio parlamento. Era dunque parte integrante dell'impero britannico, la più grande,
ricca e moderna potenza mondiale dell'epoca: gli Irlandesi erano a tutti gli effetti sudditi della regina Vittoria e soggetti alle leggi del parlamento di Londra. Le prospettive di sviluppo per l'economia irlandese erano così favorevoli da spingere le classi industriali britanniche a opporsi fermamente al libero scambio tra le due isole. Gli inglesi temevano di vedere il mercato inondato da
merci a basso prezzo con una conseguente emigrazione massiccia di manodopera e di capitali. L'Irlanda era il paese più sovrappopolato d'Europa: oltre otto milioni e mezzo di abitanti rappresentavano la più consistente densità media per chilometro quadrato. Il paese aveva anche enormi
squilibri sociali: il 20% della popolazione era composto da ricche famiglie immigrate protestanti di
origine inglese o scozzese, mentre il restante 80% era costituito da autoctoni di religione cattolica
divisi in due categorie, gli affittuari e gli operai agricoli. Le fattorie erano di dimensioni molto ridotte e divise in subaffittanze. A causa della concorrenza provocata dalla sovrappopolazione gli
affitti erano particolarmente alti e gli affittuari vivevano una condizione miserabile che li costringeva a lavorare quasi esclusivamente per pagare l'affitto e le decime alla chiesa anglicana.
Nella seconda metà del secolo precedente, per favorire gli interessi dell'Impero, l'Irlanda era
stata trasformata in un'enorme fattoria capace di rifornire di prodotti alimentari a basso costo le
classi industriali britanniche. Per farlo era stato concepito un apparato legislativo che impedise ai
contadini irlandesi di elevare il proprio tenore di vita. Anche negli anni di An Gorta Mór l'Irlanda
continuò a essere un'importante produttrice di grano e di altre materie prime, ma queste vennero
quasi interamente esportate in Inghilterra. Il cibo prodotto in Irlanda sarebbe stato più che sufficiente per sfamare la popolazione autoctona, ma i contadini erano costretti a venderlo per pagare
i debiti fondiari ai proprietari terrieri. La patata era rimasta l'unico alimento che garantiva la loro
sussistenza. Nell'estate del 1845, però, la rapida diffusione della Phytophtora infestans, un fungo
proveniente dall’America del nord, causò la completa distruzione del raccolto e creò le premesse di
una delle più gravi carestie dell'Europa contemporanea. Quando la gente cominciò a morire i grandi latifondisti inglesi si preoccuparono soltanto di salvare i propri beni facendo espellere migliaia
di contadini dalle terre e creando i presupposti di un gigantesco esodo. In assenza di stime ufficiali
12
è praticamente impossibile calcolare con precisione quante persone morirono di fame e malattie in
quegli anni, ma secondo gran parte degli storici e dei demografi furono almeno un milione. Per
quanto riguarda gli emigrati, si calcola che nello stesso quinquennio circa tre quarti delle persone
che lasciarono l'Irlanda siano sbarcate negli Stati Uniti e in Canada. Questi viaggi transoceanici,
compiuti in condizioni disumane che rimangono ancora ben impresse nella memoria popolare,
hanno dato vita alla grande diaspora irlandese. Nell'arco di una sola generazione il paese celtico
conobbe un declino demografico senza paragoni in Europa, perdendo circa un terzo della popolazione. Una tragedia di tali dimensioni non poteva non segnare la storia recente del popolo irlandese, aprendo una ferita che avrebbe lasciato segni profondi.
Oggi molti considerano riduttivo imputare questa tragedia soltanto alla malattia delle patate, ed
è proprio dalle differenti interpretazioni di quei fatti che si è sviluppato un ampio dibattito. L'interrogativo principale è questo: in un paese ricco di materie prime può verificarsi una carestia soltanto perché "mancano le patate"? Non è forse più corretto affermare che il popolo irlandese fu volutamente ridotto alla fame? È innegabile che le catastrofiche conseguenze della perdita dei raccolti
dipesero dal contesto socio-economico di stampo coloniale e dall'atteggiamento del governo britannico, che decise di non aiutare i propri cittadini. Per evitare la tragedia sarebbe bastato interrompere le massicce esportazioni di generi alimentari che proseguirono regolarmente anche negli
anni della carestia. Enormi quantitativi di avena, burro, carne, grano e uova continuarono a uscire
dall'Irlanda diretti in Inghilterra a causa degli esosi affitti imposti a fittavoli poverissimi. Soltanto
nel cosiddetto Black ’47, l'anno peggiore della carestia, circa quattromila navi cariche di generi alimentari lasciarono l'isola dirette a Bristol, Glasgow, Liverpool e Londra. È evidente che gli inglesi
non pianificarono lo sterminio per fame della popolazione irlandese, ma di sicuro non fecero
niente per prevenirla o per ridurne le tragiche conseguenze. Gran parte della classe politica e dell'opinione pubblica inglese continuava a credere che la miseria e la povertà dell'Irlanda fossero le
conseguenze dell'arretratezza e dell'inferiorità socio-culturale del suo popolo.
Di fronte alle dimensioni dell'ecatombe il governo britannico decise di prendere alcuni provvedimenti per salvare almeno le apparenze, ma questi si rivelarono del tutto inefficaci. Nel 1846 abolì
i dazi sulle importazioni di grano fissati a difesa della produzione interna e avviò un programma
di lavori pubblici a beneficio di chi era ancora in grado di lavorare. Poi introdusse gli aiuti stabiliti
dal Poor Relief Act, ma li accompagnò a una crudele speculazione: chi possedesse "sotto qualsiasi
forma" oltre un quarto di acro inglese di terra non avrebbe potuto ottenere aiuti. Ciò significava
che per non morire di fame gli affittuari avrebbero dovuto abbandonare le terre e le case.
In quegli anni, inoltre, gli inglesi mostrarono un atteggiamento ostile, razzista e carico di pregiudizi, arrivando a considerare la carestia come un modo efficace per risolvere il "problema irlandese". La crisi del raccolto delle patate offriva infatti all'impero britannico l’occasione propizia per
una profonda riorganizzazione dell'economia attraverso il controllo della popolazione e il consolidamento della proprietà con vari metodi, tra i quali cui l'emigrazione. Ed è proprio qui che rispunta fuori il problema lessicale evocato in precedenza: secondo molti studiosi contemporanei il
fatto che gli inglesi abbiano sfruttato quell'ecatombe per eliminare i contadini irlandesi può essere
senza dubbio definito genocidio. La tesi è confermata da alcuni giuristi americani che hanno analizzato la questione sulla base del moderno diritto internazionale. Se il governo inglese avesse voluto
limitare gli effetti della carestia avrebbe avuto i mezzi per farlo, mentre preferì usare la situazione
che si era venuta a creare per fingere una riforma agraria a lunga scadenza al costo di morti, malattie ed emigrazione. In quegli anni la "peste della patata" colpì anche altri paesi europei, ma soltanto
in Irlanda ebbe conseguenze così devastanti. Per tutti questi motivi, e basandosi anche sulla semplice considerazione che non si può morire per mancanza di patate, in Irlanda e negli Stati Uniti
molti preferiscono parlare di "fame", piuttosto che di "carestia".
In tempi recenti alcuni studiosi della Shoah hanno affermato che An Gorta Mór è stato il primo
caso di genocidio europeo, arrivando a paragonare l'operato del Ministro del Tesoro britannico
Charles Trevelyan a quello di Adolf Eichmann durante lo sterminio ebraico. Eppure, a quasi due
13
secoli da quell'immane tragedia, l'establishment britannico non manifesta la minima intenzione di
assumersi la responsabilità della tragedia. I motivi non sono solo di carattere simbolico: esiste infatti il rischio concreto che il governo britannico, come accadde ai nazionalsocialisti con gli ebrei,
vengano sommersi da un'infinità di richieste di risarcimento da parte dei discendenti delle vittime.
Alan John Percivale Taylor, uno dei più prestigiosi storici britannici contemporanei, è arrivato a
paragonare le condizioni degli irlandesi ai tempi della Grande Fame a quelle dei disperati rinchiusi nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda guerra mondiale:
appena un secolo fa, tutta l’Irlanda si trovava nelle condizioni del campo di concentramento di Bergen
Belsen. Circa due milioni di irlandesi morirono di fame e di malattie in soli cinque anni [...]. La popolazione
venne cacciata dalle proprie terre, fu affamata e trattata peggio degli animali.
Quello che stupisce, semmai, è l'atteggiamento di molti accademici irlandesi, assai cauti nell'affermare le responsabilità di Londra. Non è un caso che la svolta sia arrivata solo quattro anni fa per
opera di uno storico inviso al mondo universitario: Tim Pat Coogan. L'anziano studioso – già autore di opere importanti sull'IRA, sulla guerra civile e sulla diaspora irlandese – si è mosso con
tutta la sua autorevolezza per rimuovere il velo di ipocrisia che cercava di nascondere una verità
così scomoda. Nel suo libro The Famine Plot: England's Role In Ireland's Greatest Tragedy (Palgrave
Macmillan, 2012) sostiene che quanto accadde in Irlanda può essere paragonato ai recenti fatti del
Darfur, perché rientra perfettamente nella definizione di genocidio approvata dalle Nazioni Unite.
Lungi dal demonizzare il popolo inglese o la politica britannica nel suo insieme, Coogan mette
sul banco degli accusati il governo dell'epoca, guidato dal liberale Lord John Russell, sostenitore di
un liberismo sfrenato basato sulla dottrina del laissez-faire, e concentra le proprie accuse sul Ministro del Tesoro Charles Trevelyan, che gestì la crisi da plenipotenziario. Il libro dello studioso riproduce integralmente una lettera inedita di Trevelyan, dalla quale emerge che fece di tutto per far
morire o costringere all'emigrazione i contadini, consentendo ai latifondisti di convertire la produzione in modo più redditizio. Questo prova in modo definitivo che Londra non solo non volle alleviare le sofferenze della popolazione irlandese, ma che si adoperò deliberatamente per esacerbarle.
Solidarietà transatlantica
La carestia irlandese non fu dimenticata da tutti. Numerose raccolte di fondi furono organizzate in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti. Anche l'impero ottomano inviò degli aiuti. Ma il contributo più inatteso venne
dagli indiani Choctaw dell'Oklahoma. Nella primavera del 1847, nonostante le loro scarse possibilità, questi raccolsero 170 dollari e li inviarono a un'associazione umanitaria americana. Questo avvenne perché i
Choctaw si sentivano idealmente legati alla tragedia del popolo irlandese. Sedici anni prima, nel 1831, gli
indiani erano stati deportati dalle proprie terre divise fra Alabama, Louisiana e Mississippi e costretti a stabilirsi in Oklahoma. Molti erano morti per la fame e per il freddo nelle 500 miglia di marcia. Questa
solidarietà transatlantica fra popoli oppressi ha creato un legame ancora vivo. Nel 1990 una delegazione
choctaw è stata invitata a Mayo dall'associazione Action from Ireland (AFRI). Due anni dopo un gruppo di
irlandesi ha ripercorso le 500 miglia che i Choctaw avevano fatto nel 1831. Nello stesso anno gli indiani
hanno conferito il titolo di capo onorario a Mary Robinson, allora presidente dell'isola verde.
Giovanna Marconi
Bibliografia
Cahill T., Come gli irlandesi salvarono la civiltà, Fazi, Roma 1997.
Coogan T. P., The Famine Plot: England's Role In Ireland's Greatest Tragedy, Palgrave Macmillan, London 2012.
Keneally T., The Great Shame, Vintage, London 1998.
Kinealy C., This Great Calamity: The Irish Famine 1845-1852, Boulder, Roberts Rinehard, 1995
Laxton E., The Famine Ships: Irish Exodus to America 1846-1851, Bloomsbury, London 1996.
Mitchel J., Giornale di prigionia, Lubrina, Bergamo 1991.
Ó Grada C., The Great Irish Famine, MacMillan, London 1989.
14
L'olocausto ai confini del mondo
Alessandro Michelucci
Il continente americano è l'unico che abbia assunto la fisionomia attuale in seguito ai genocidi che
hanno colpito, seppure con diversa intensità, tutti i suoi popoli indigeni. La sola eccezione riguarda quelli dell'estremo nord (Aleuti, Innu, Inuit, etc.), stanziati in terre inospitali che non erano
adatte ad accogliere i coloni europei. Per molto tempo i mezzi di comunicazione – soprattutto cinema e letteratura – hanno diffuso una storia falsa e distorta, minimizzando questi genocidi ed esaltando il "nuovo mondo" che era stato costruito grazie a loro. Basti pensare alla pletora di film
western e di romanzi avventurosi che hanno segnato l'adolescenza delle prime generazioni postbelliche. Dietro quella che veniva proposta come innocua "avventura per ragazzi" si nascondeva,
spesso anche inconsciamente, l'esaltazione del genocidio. Poi, fortunatamente, questo castello di falsità ha cominciato a mostrare delle crepe.
Le prime si sono manifestate nel paese più importante, gli Stati Uniti. Gli Indiani del Nordamerica sono stati infatti i primi a godere di un'attenzione diversa. Nei tardi anni Sessanta del secolo
scorso, mentre emergevano le atrocità realizzate dai regimi comunisti, gli europei cresciuti nel
culto dell'American way of life hanno cominciato a prendere coscienza del genocidio che era stato
realizzato nei secoli precedenti. In tempi più recenti i popoli indigeni dell'America centrale hanno
guadagnato un forte rilievo mediatico grazie al Premio Nobel per la pace che era stato conferito a
Rigoberta Menchú (1992). Negli stessi anni i problemi ambientali dell'Amazzonia hanno messo in
evidenza quelli dei popoli indigeni stanziati nella sconfinata regione sudamericana. A questo si è
aggiunto il cinquecentenario colombiano, che ha stimolato ovunque un'intensa attività documentata da centinaia di conferenze, libri e altre iniziative.
Poi è stata la volta dei Mapuche, protagonisti di una rinascita politica che ha ottenuto un forte
sostegno da parte delle associazioni indigeniste europee. Come si vede, questo risveglio d'interesse si è sviluppato secondo un criterio geografico preciso, cioè da nord a sud, ma ora sembra essersi interrotto: i popoli indigeni della Terra del Fuoco aspettano ancora di uscire dal buio della
memoria collettiva. Eredi dei pochi superstiti di un genocidio sostanzialmente ignorato in tutto il
mondo, sono penalizzati dalla posizione geografica remota e dai pochissimi mezzi che hanno per
far sentire la propria voce. L'attenzione mediatica nei loro confronti è praticamente nulla. Ma la loro storia tragica deve essere conosciuta.
La Terra del Fuoco è la penisola che costituisce l'estremità meridionale del continente americano. Attualmente divisa in parti quasi uguali fra Cile e Argentina, fa parte della Patagonia e occupa
un'area leggermente superiore a quella della Danimarca (48.000 kmq). La città più importante, Ushuaia, capoluogo della parte argentina (ufficialmente Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur), viene generalmente considerata la località più meridionale del pianeta.
I primi europei a raggiungere il territorio sono i marinai della spedizione di Fernão de Magalhães (Ferdinando Magellano), che arrivano nel 1520. Nessun europeo vi stabilisce la propria residenza fino alla seconda metà del XIX secolo, quando alcuni pionieri vengono attratti dalle prospettive dell'ovinicoltura e della corsa all'oro. Nella prima metà del diciannovesimo secolo nasce
gran parte degli stati sudamericani, fra i quali il Venezuela (1811), l'Argentina (1816), il Perù (1821),
la Bolivia e l'Uruguay (1825).
Negli stessi anni comincia a svilupparsi l'interesse per i popoli indigeni della Terra del Fuoco.
Questa attenzione si manifesta in forme diverse, ma sempre nell'ambito di una logica colonialista,
quindi caratterizzata da un profondo disprezzo nei confronti degli autoctoni. Cercatori di ricchezza o di anime, migliaia di persone si mobilitano per annientarli culturalmente o fisicamente.
L'attività missionaria comincia a svilupparsi tardivamente: è solo nel 1869 che il sacerdote angli15
cano Thomas Bridges fonda la prima missione nei territori argentini abitati dai popoli fuegini. Ma
il vero artefice dell'evangelizzazione è Don Giovanni Bosco, fondatore della Congregazione dei salesiani. Nel 1875, dopo alcuni sogni premonitori, il sacerdote decide di dedicare un impegno
particolarmente intenso alle regioni meridionali dell'Argentina. Nascono così le prime missioni che
dovranno cristianizzare i popoli autoctoni. Successivamente i salesiani estenderanno le proprie
attività in altri paesi sudamericani, fra i quali la Bolivia, la Colombia e il Paraguay.
Cacciatori di uomini
Julius Popper, un ingegnere di origine romena emigrato in Argentina per sfruttare i ricchi giacimenti auriferi scoperti nella Terra del Fuoco, inizia la propria attività nella seconda metà degli
anni Ottanta. Popper guida una specie di impero personale che batte moneta e dispone di un
piccolo esercito. Nel 1893 nasce la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, una grande industria per
l'allevamento delle pecore da lana. La struttura, situata sulla principale isola dell'arcipelago (Isla
Grande) occupa 1.300.000 di ettari ottenuti in concessione dal governo cileno. I principali azionisti,
José Menéndez e Mauricio Braun, sono entrambi di origine europea: il primo è spagnolo, mentre il
secondo è un ebreo tedesco nato in Lettonia.
Gli indigeni sono già oggetto di un forte razzismo: i latifondisti li considerano degli esseri subumani che non hanno il diritto di vivere. Inoltre la loro presenza entra in conflitto con le nuove
attività economiche. L'industria aurifera vuole impadronirsi delle loro terre per poter ampliare le
proprie esplorazioni. Gli allevatori uccidono i guanachi, che costituiscono la prima risorsa alimentare degli indigeni, perché mangiano l’erba che deve nutrire anche migliaia di pecore. Gli altri
reagiscono uccidendo le pecore.
Il genocidio dei popoli fuegini viene realizzato in vari modi, come se molte tenaglie li stritolassero simultaneamente. Le malattie di origine europea, la persecuzione dei coloni e lo sradicamento
culturale indotto dall'evangelizzazione giocano un ruolo primario. Ma questo non basta: in certi
casi la resistenza degli indigeni, per quanto debole e disperata, viene contrastata con frequenti
"battute di caccia" dove i latifondisti li abbattono a colpi di fucile. Per ogni indigeno eliminato viene corrisposta una sterlina. Un altro modo per uccidere gli indigeni è quello di lasciare delle pecore
avvelenate vicino ai loro villaggi in modo che le raccolgano e le mangino.
I missionari reagiscono a questa mattanza in vari modi: alcuni restano inerti, mentre altri cercano di difendere gli indigeni. Ma non possono mettersi in aperto contrasto con i latifondisti, dato
che in un modo o nell'altro stanno dalla stessa parte. Se da una parte non si può sostenere la totale
coincidenza fra l'azione dei missionari e quella dei proprietari terrieri, dall'altra non si può negare
che esistano stretti punti di contatto e di sinergia fra le due esperienze.
Ormai stremati e ridotti a poche centinaia, gli aborigeni vengono raccolti sull'isola Dawson, situata nella parte cilena della Terra del Fuoco (nel frattempo la regione era stata divisa fra Argentina e Cile). I salesiani hanno ottenuto il territorio grazie a una concessione governativa ventennale. Qui è stato allestito allestito un campo di concentramento diretto dai missionari salesiani, che
si dedicano alla cristianizzaione dei prigionieri. Negli stessi anni (1878-1885), nella regione desertica della Patagonia situata a nord della Terra del Fuoco, l’esercito argentino guidato da Julio Argentino Roca massacra i Mapuche per impadronirsi delle loro terre.
Negli ultimi anni del secolo laici e religiosi manifestano il proprio disprezzo per i popoli autoctoni esibendoli come rarità esotiche – legati o ingabbiati – in Europa. L’impresario belga Maurice
Maitre rapisce 11 selk’nam per mostrarli alle persone che visitano l'Esposizione universale di Parigi (6 maggio - 31 ottobre 1889). Nel 1892 alcuni salesiani organizzano uno "zoo umano" analogo: in
occasione dell'esposizione genovese per il quarto centenario della "scoperta" delle Americhe, un
gruppo di indigeni (aónikenk, kawésqar, mapuche e selk'nam) viene esibito in gabbia. Questo avviene dopo una lunga traversata atlantica piena di sofferenze e di stenti.
Nel 1911 i missionari chiedono il rinnovo della concessione dell'isola Dawson, ma il governo la
nega: ormai i sopravvissuti sono soltanto una ventina, quindi non ha più senso mantenere in piedi
la struttura. Perciò questa viene chiusa e gli indigeni vengono trasferiti in un'altra missione.
16
Testimoni del genocidio
Il genocidio dei popoli fuegini (Aónikenk, Kawésqar, Selk'nam e Yagán) comincia a essere documentato mentre è ancora in corso. Nils Otto Gustav Nordenskjöld, esploratore svedese, visita la
Terra del Fuoco nel 1895: "Questo popolo ormai ridotto a poche persone si estinguerà velocemente
se non si fa niente per impedirlo. I Selk'nam vengono perseguitati dai colonizzatori ovunque" scrive nel suo diario di viaggio.
Una delle testimonianze più autorevoli è quella di Martin Gusinde, un sacerdote tedesco che
durante gli anni Venti del Novecento trascorre alcuni anni con varie comunità indigene. Molto interessato alle loro culture, Gusinde raccoglie una documentazione imponente: appunti, fotografie,
testimonianze. Un altro religioso, il missionario salesiano Alberto Maria De Agostini, ha compiuto
vari viaggi in Patagonia e nella Terra del Fuoco, dove ha potuto parlare con alcuni sopravvissuti.
Sinceramente impressionato dagli effetti culturali e ambientali del genocidio, ha raccolto le proprie
impressioni nel documentario Terre magellaniche (1933).
Una questione attuale
Il 13 dicembre 2016 è stato presentato al Senato cileno il progetto di legge che riconosce come genocidio lo sterminio degli abitanti della Patagonia e della Terra del Fuoco realizzato fra la fine del
diciannovesimo secolo e l'inizio del secolo successivo. Il progetto di legge ha tre obiettivi:
1. Il riconoscimento ufficiale del genocidio dei popoli selk'nam, aónikenk, yagán e kawésqar.
2. La costruzione di un monumento che perpetui la memoria delle vittime dello sterminio.
3. L’introduzione delle denominazioni corrette kawésqar e yagán secondo la Legge 19.253, che fissa
le norme sulla protezione e lo sviluppo dei popoli indigeni e istituisce la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, rispettando il loro diritto all'identità culturale.
I popoli indigeni della Terra del Fuoco
Aónikenk
28000 (Argentina)
Kawésqar
2600 (Cile)
Selk'nam
2800 (Argentina); 500 (Cile)
Yagán
1700 (Cile) #
Noti anche con altri nomi, dall'alto in basso: Tehuelches; Alakaluf; Ona; Yamana.
Fonti: censimento cileno 2002 e censimento argentino 2010.
Bibliografia
Alonso Marchante J. L., Menéndez, rey de la Patagonia, Catalonia, Santiago de Chile 2014.
Baez C., Mason P., Zoológicos humanos. Fotografías de fueguinos y mapuche en el Jardin d’acclimatation de París,
Siglo XIX, Pehuén, Santiago de Chile 2006.
Bridges E. L., Ultimo confine del mondo. Viaggio nella Terra del Fuoco, Einaudi, Torino 2009.
Chapman A., End of a World: The Selknam of Tierra del Fuego, Zagier & Urruty, Ushuaia 2008.
Coloane F., Cacciatori di indios, Guanda, Parma 2003.
Gusinde M. et alii, The Lost Tribes of Tierra del Fuego: Selk'nam, Yamana, Kawésqar, Thames and Hudson, London 2015.
Ianniciello R., I Fuegini della Terra del Fuoco, Quattroventi, Firenze 2010.
Maldonado M., Entre dos mundos. Pasado y presente de los habitantes Selk'nam-Haus de Tierra del Fuego, Editora Cultural Tierra del Fuego, Ushuaia 2014.
Nicoletti M. A., "El modelo reduccional salesiano en Tierra del Fuego: educar a los 'infieles'", in Ossanna E., Pierini M. de los Milagros (a cura di), Docentes y alumnos. Protagonistas, organización y conflictos en las experiencias
educativas patagónicas, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Buenos Aires 2008, pp. 137-166.
Penazzo de Penazzo N. I., Tercero Penazzo G., Wot'n. Documentos del genocidio Ona, Ediciones Arlequín de
San Telmo, Buenos Aires 1995.
Raspail J., I nomadi del mare, Sugarco Milano 1987 [romanzo].
17
Per il riconoscimento del genocidio dei Selk'nam
Nel 1885 l’Argentina e il Cile cominciarono a colonizzare la Terra del Fuoco grazie alle concessioni per lo
sfruttamento di un territorio ancora indipendente. I due stati disconobbero la sovranità dei Selk'nam basandosi
sulle finzioni giuridiche dell'impero spagnolo e favorirono gli interessi dei capitali tedeschi e britannici per incrementare l'allevamento delle pecore che era già stato avviato nelle Malvine e nella Patagonia continentale. I
Selk'nam cercarono di resistere alla colonizzazione attaccando le greggi e distruggendo i reticolati che cominciavano a dividere il loro territorio. I coloni e i funzionari organizzarono gruppi di uomini armati per catturare e
uccidere gli indigeni, come conferma un'ampia documentazione storica. La maggioranza dei superstiti fu deportata nelle missioni salesiane di Río Grande e dell’isola Dawson, dove fu sottoposta a uno sradicamento culturale che ne provocò la morte. Alcuni superstiti, soprattutto i bambini, furono costretti a svolgere lavori domestici, trasformati in schiavi sessuali o adibiti alla cura del bestiame. Anche questo è documentato, seppure in
modo frammentario. In meno di vent'anni l'azione congiunta di imprenditori e missionari, spesso aiutati dalle
autorità cilene e argentine, riempì il territorio fuegino di milioni di pecore, mentre la popolazione originaria era
ormai scomparsa. In questo modo il Cile e l’Argentina divennero padroni dell'isola.
Secondo la Convenzione sul genocidio, approvata dall'ONU nel 1948, "per genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi con l'intenzione di distruggere in modo totale o parziale un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso", fra i quali "uccidere i membri del gruppo; recare una grave lesione alla sua integrità fisica o mentale; sottoporlo a condizioni che ne causino la distruzione fisica totale o parziale; imporgli misure
che limitino il suo sviluppo demografico; trasferire forzatamente i bambini del gruppo a un altro gruppo".
Dato che nel caso dei Selk'nam sono stati compiuti tutti questi atti, è imperativo che il genocidio sia riconosciuto ufficialmente, in quanto siamo davanti alla "distruzione fisica intenzionale di un intero gruppo sociale
o di una sua parte così consistente per cui risulta compromessa la sua capacità di riproduzione biologica e
culturale". Infine, occorre sottolineare che si trattò di un progetto pianificato durante riunioni delle quali è rimasta una documentazione precisa e che fu poi realizzato in modo sistematico.
Il riconoscimento del genocidio selk'nam e aonikenk (tehuelche del sud) da parte del Cile è stato proposto nel
2007, quando il senatore Pedro Muñoz presentò una mozione che fu discussa nelle commissioni culturali dei
due rami del Parlamento. Nella prima il tema fu dibattuto facendo riferimento all'Informe de la Comisión de
Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003, 2008), che definisce "genocida" l'occupazione della Patagonia australe e della Terra del Fuoco. Tuttavia, i senatori Andrés Chadwick e Mariano
Ruiz-Esquide proposero di sostituire il termine "genocidio" con "estinzione" per evitare che "lo stato andasse
incontro ad eventuali conseguenze negative". La loro proposta fu sostenuta dal senatore Cantero. Senza discutere la sostanza della questione, fu approvato all'unanimità il riconoscimento della "estinzione delle etnie". Il progetto di legge fu quindi passato all'esame della Commisione dell'Educazione della Camera, dove
si decise di utilizzare il concetto di genocidio. Ma i deputati Giovanni Calderón (UDI) e Jorge Sabag (DC) si
opposero al riconoscimento del genocidio, perché "trattandosi di un crimine imprescrittibile avrebbe potuto
derivarne il dovere di indennizzare le vittime". Da allora il progetto di legge è fermo.
Considerato tutto questo, riteniamo imprescindibile che lo stato e i governi locali riconoscano il genocidio e
pro-poniamo la costruzione di un memoriale dove siano sepolte le vittime della deportazione e dello sterminio.
La Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni, firmata dal Cile nel 2007, afferma che "i popoli indigeni hanno il diritto di […] ottenere il rimpatrio dei propri resti umani" e che "gli stati dovranno facilitare il
recupero e/o il rimpatrio degli oggetti di culto e dei resti umani in modo equo, trasparente ed efficace". Perciò le
autorità cilene devono fornire i mezzi necessari affinché i corpi esposti nei musei o in ogni altro luogo possano
riposare degnamente in quella che fu la loro terra. Inoltre, dato che la Dichiarazione stabilisce che "le culture e le
tradizioni indigene devono essere divulgate attraverso l'istruzione e gli organi d'informazione", si dovrà stimolare
una riflessione che rifiuti il concetto di uno sterminio compiuto in nome del "progresso", senza dimenticare un
ampio dibattito sugli avvenimenti storici della regione. Speriamo che questo appello sia accolto, rispondendo alla
necessità di fare un minimo di giustizia, restituire alle vittime la memoria, garantire una riparazione seppur parziale agli eredi e inserire la loro storia nei libri di testo e nelle iniziative politiche riguardanti i popoli indigeni.
Solo così potremo realizzare una vera riconciliazione con un passato diverso e complesso, costruendo un presente
più giusto per i popoli che sono stati annientati, emarginati o ridotti al silenzio per costruire le società odierne.
Promotori:
José Luis Alonso Marchante, scrittore. Madrid, Spagna.
Nicolás Gómez Baeza, docente di Storia e storico. Punta Arenas e Santiago, Cile.
Alberto Harambour Ross, storico. Punta Arenas e Santiago, Cile.
18
L'architetto del genocidio australe
Intervista a José Luis Alonso Marchante
Pochi popoli indigeni sono stati dimenticati (o per meglio dire, ignorati) come quelli della Terra del Fuoco,
che furono massacrati dai coloni cileni e argentini fra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del secolo successivo. Sono stati quasi completamente cancellati da un genocidio che molto raramente è stato oggetto di discussione: perfino in Cile e in Argentina se ne è parlato pochissimo, sebbene alcuni l'avessero denunciato e
documentato. Negli ultimi anni, però, la loro tragedia dimenticata ha guadagnato un certo spazio nel dibattito politico cileno. Ma questo, nel migliore dei casi, produrrebbe un riconoscimento limitato ai due paesi
sudamericani coinvolti nella questione. La possibilità che questo genocidio venga riconosciuto a livello internazionale rimane quanto mai remota. Fra coloro che si stanno impegnando per raggiungere questo obiettivo spicca José Luis Alonso Marchante, che ha scritto il libro fondamentale sul tema (Menéndez, rey de la
Patagonia, Catalonia, 2014). L'opera ricostruisce la vita di José Menéndez, immigrato spagnolo, che insieme
ad altri coloni si impadronì in modo fraudolento di vasti territori situati nella Patagonia cilena e argentina.
Inoltre sottolinea il ruolo centrale che Menéndez svolse nello sterminio dei popoli fuegini.
Alonso Marchante, spagnolo di Gijón, è uno dei promotori dell'appello che chiede al governo cileno di riconoscere il genocidio dei Selk’nam (vedi pagina 18). La questione viene attualmente dibattuta dal Parlamento
cileno, in seguito a un progetto di legge che chiede il riconoscimento del genocidio allargandolo a tutti i popoli fuegini: Aóni-kenk, Selk'nam, Kawésqar e Yagán. L’intervista che segue, tratta dalla rivista cilena Punto final (811, 22 a-gosto 2014), è stata realizzata dallo scrittore Alejandro Lavquén. Lo ringraziamo per averci permesso di riprodurla.
Come nasce il tuo interesse per la storia della Patagonia?
Sono sempre stato interessato ai temi legati all'immigrazione. Io sono originario delle Asturie, mia
moglie è argentina. La prima volta che sono andato a Buenos Aires ho visitato il Centro Asturiano, dove si trova un busto di José Menéndez con una targa che lo definisce "pioniere del progresso
economico della Patagonia". Questo personaggio mi interessava moltissimo. Mi chiedevo come
fosse possibile che un contadino asturiano senza arte né parte potesse essere diventato un uomo
così potente. Così ho cominciato a fare ricerche sulla sua vita.
Che idea avevi della Patagonia?
Per noi europei la Patagonia è un luogo leggendario con un paesaggio affascinante situato alla fine
del mondo. Un luogo mitico, direi. Io pensavo agli esploratori, per esempio a Magellano, che percorrendo per la prima volta lo stretto che oggi porta il suo nome aveva visto i fuochi coi quali i
Selk'nam comunicavano fra loro. Questa l'idea che avevo della Patagonia.
Il genocidio degli indigeni era conosciuto in Europa?
Tutti sanno che i popoli indigeni delle Americhe sono stati vittime della colonizzazione fin dall'inizio. Ma quello che mi ha colpito è che in Patagonia lo sterminio era avvenuto in tempi molto recenti. Non parliamo del 1500 o del 1600, ma di un periodo che va dalla fine del diciannovesimo secolo all'inizio del ventesimo. In termini storici è come dire ieri. È stata un brutta sorpresa, soprattutto dopo che avevo cominciato a studiare la vita di Menéndez e la sua partecipazione al massacro dei popoli indigeni.
Il tuo libro contiene testimonianze o documenti inediti?
Certamente. Per me era molto importante raccogliere le testimonianze dei contemporanei. Per
quanto riguarda lo sterminio dei Selk'nam, per esempio, ho riportato le testimonianze dei salesiani,
19
che avevano una missione situata vicino alle fattorie di José Menéndez. Quando uscivano trovavano spesso dei cadaveri di selk'nam che erano stati uccisi col fucile. Si tratta di testimonianze autorevoli. Per quanto riguarda le condizioni degli uomini che lavoravano nelle fattorie – un altro tema che mi interessa molto – ho utilizzato le testimonianze dei militari e della polizia. Questi non
avevano nessuna simpatia per loro, ma restavano a bocca aperta quando vedevano in quali condizioni dovevano lavorare.
Hai potuto parlare con i discendenti di Menéndez o di altri allevatori?
Sono entrato in contatto con i suoi eredi che vivono in Spagna. Mi hanno fornito delle testimonianze molto preziose. Nella fattoria che José Menéndez aveva nella Terra del Fuoco, Primera Argentina, c'era un capetto scozzese che si chiamava Alexander Mac Lennan, detto "Chanco Colorado".
Fra la gente di Punta Arenas era tristemente noto come cacciatore di indigeni, cosa di cui si vantava. Sono riuscito a parlare con un suo pronipote. Mi ha lasciato di sasso quando mi ha detto che
oggi, grazie a quello che avevano fatto Menendez e gli altri latifondisti, nella Terra del Fuoco non
ci sono rivendicazioni indigene come in altre regioni del Cile o dell'Argentina. Parole ripugnanti.
Quindi nessuno dei discendenti cerca di ristabilire la verità storica?
Purtroppo no. Qualche anno fa Osvaldo Bayer, il celebre storico argentino, ha incontrato Federico
Braun, il proprietario de La Anónima, la compagnia fondata da José Menéndez e Mauricio Braun.
Quando Bayer gli ha detto che avrebbe potuto almeno rivolgere delle scuse per lo ster-minio, gli ha
risposto che lui era nato negli anni Quaranta e che non aveva niente a che fare con quella storia. Un
comportamento ben diverso da quello di ditte tedesche come Mercedes o Bayer, che impiegarono
degli schiavi, ma oggi finanziano musei e fondazioni per far conoscere quelle pagine tragiche della
propria storia. Esiste una responsabilità, una memoria storica da recuperare.
Per quanto riguarda i salesiani, sembra che abbiano avuto un ruolo piuttosto controverso. Quali
furono loro rapporti con gli indigeni?
I salesiani gestivano una segheria sull'isola Dawson ed esportavano il legno nelle Malvine. Per
questa attività si servivano degli indigeni. I primi salesiani impiantarono delle missioni nella Terra
del Fuoco e mantennero un atteggiamento molto critico nei confronti dei latifondisti. Volevano
davvero proteggerli e al tempo stesso evangelizzarli, perché credevano che questo fosse un modo
per aiutarli. Ma poi la situazione mutò radicalmente: i missionari si arresero al potere economico
degli allevatori, tanto che la seconda generazione di salesiani fu completamente sottomessa alla
loro volontà. Fu allora che si cominciò a scrivere una storia dove gli allevatori venivano dipinti come alfieri del progresso. I salesiani hanno dato un contributo decisivo a questa falsificazione storica.
Secondo le tue ricerche, quanta colpa può essere addebitata ai governi dell'epoca?
Molta, senza dubbio. Le leggi cilene e argentine per la colonizzazione, che ho studiato a fondo, fissavano un limite di 30.000 ettari per le terre da affittare ai coloni, perché si voleva che le fattorie
per l'allevamento del bestiame impiantate dagli immigrati europei fossero piuttosto piccole, come
in Australia. Ma Menéndez, Braun e gli altri corruppero il governo argentino e quello cileno in
modo da poter ottenere terre più grandi, che ovviamente appartenevano ai loro abitanti originari.
José Menéndez era un uomo potente che si muoveva con estrema disinvoltura negli ambienti politici di Santiago e Buenos Aires, arrivando a tenere a libro paga i governatori della Patagonia. In
Cile Mariano Guerrero Bascuñan, che quando lasciò la vita politica si stabilì a Santiago per lavorare con gli allevatori. In Argentina Carlos Moyano, governatore di Santa Cruz, che fece lo
stesso. Erano procacciatori di terre. I governi dell'epoca hanno responsabilità ben precise, perché
permisero ogni tipo di abuso.
Quindi i governi erano a conoscenza di questi crimini?
I governatori che arrivavano a Punta Arenas erano in buona fede. Si trovavano davanti due tipi di
ingiustizie: l'accaparramento di terre e lo sterminio degli indigeni. Dopo le prime proteste, però, si
20
schieravano dalla parte dei latifondisti, grazie al potere politico ed economico di Menéndez. Quando vedevano i soldi cambiavano subito idea.
Se ho capito bene fu praticata anche la schiavitù…
Sì, gli indigeni venivano catturati e venduti all'asta nel centro di Punta Arenas, proprio come in un
un mercato de schiavi. Questo accadeva nel 1895, quando in Cile la schiavitù era già stata abolita
da molto tempo. Una pagina vergognosa per questa città. La cosa fu denunciata anche all'epoca:
quello che racconto nel libro deriva da testimonianze contemporanee. Infatti la questione finì in
tribunale, ma poi, grazie al potere politico dei latifondisti, fu archiviata.
E gli abitanti di oggi, in che modo si pongono davanti a questa storia?
Nel 2009 e nel 2011 sono stato là, nella zona di Punta Arenas (Patagonia cilena, ndt) . Ho visitato anche la Patagonia argentina. Secondo me esiste una grande differenza fra i due paesi. In Argentina
nessuno penserebbe mai di intitolare una strada a José Menéndez o a Mauricio Braun. A Punta Arenas, invece, il centro della città canta le lodi di questi pionieri. Ci sono ancora i loro palazzi. In realtà
le loro famiglie non abitano più a Punta Arenas da molto tempo: si sono trasferite a Buenos Aires o a
Santiago, dove possono gestire molto meglio le proprie attività. Mi ha sorpreso che la città fosse
piena di riferimenti alla storia ufficiale, perché questo contrasta con l'opinione del cittadino comune,
che sa bene quanto sia stata falsificata la storia. Gli allevatori non si limitarono a sterminare gli indigeni e a rubare le loro terre, ma stravolsero anche l'equilibrio ecologico della regione.
Per un amico
Anche in Italia, seppur meno che in altri paesi, il mondo accademico italiano ha espresso numerosi docenti che hanno saputo coniugare il rigore scientifico con un interesse sincero per i problemi dei popoli
indigeni. Pensiamo a Gerardo Bamonte, che dopo molti anni dedicati ai popoli amazzonici aveva spostato
il proprio interesse su quelli del Sudest asiatico. Recentemente un altro studioso di grande spessore accademico e umano ci ha lasciato: stiamo parlando di Antonio Melis, specialista delle culture andine e di letteratura ispanoamericana.
Siamo particolarmente legati a lui: non soltanto per il suo valore scientifico, sempre manifestato con modestia, ma anche perché Antonio aveva seguito e sostenuto la nostra attività fin dall'inizio. Nel 1993 aveva partecipato alla prima conferenza che avevamo dedicato ai popoli indigeni dell'America "latina"
(Figli del sole e della terra, 5 settembre-1o ottobre 1993, Villa Renatico Martini, Monsummano Terme).
Alcuni anni dopo, nel 1998, aveva presentato il nostro volume Popoli indigeni popoli minacciati, pubblicato dal Comune di Firenze. Negli anni successivi ci aveva accolto al CISAI, il Centro di studi sull'America indigena che aveva fondato con due colleghi dell'Università di Siena, Luciano Giannelli e Massimo Squillacciotti, anch'essi americanisti prestigiosi. Antonio rimane legato a noi da una profonda comunione ideale che la morte non potrà mai spezzare. Il suo sorriso, ma soprattutto la sua lezione umana e culturale, ci accompagnerà sempre.
Alessandro Michelucci
21
Il primo genocidio del ventesimo secolo
George Steinmetz
Il primo genocidio del ventesimo secolo non è avvenuto in Europa, ma nell'Africa di Sud-Ovest
(oggi Namibia) , che era diventata una colonia tedesca nei primi anni Ottanta del diciannovesimo
secolo. Fra il 1904 e il 1907 l'esercito tedesco cercò di sterminare due popoli indigeni, gli Herero e i
Nama. Non riuscì a ucciderli tutti, ma data la sua chiara intenzione di farlo possiamo parlare di genocidio.
Per molti anni gli esponenti del governo tedesco che avevano visitato la Namibia avevano rifiutato di incontrare i rappresentanti del popolo herero. Ma nell'agosto del 2014 il Ministro per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, ha partecipato alla commemorazione del centenario del genocidio che era stata organizzata in Namibia e ha riconosciuto "le atrocità commesse dalle potenze coloniali tedesche nei confronti dei vostri antentati, in particolare
gli Herero e i Nama". Il Ministro ha anche annesso che "dopo le rivolte gli herero, i nama e i damara sopravvissuti furono rinchiusi in campi di concentramento e sottoposti a lavori forzati così pesanti che molti non poterono sopravvivere". Il Ministro ha concluso con parole ambigue: "Oggi simili atrocità verrebbero definite genocidio".
Questo uso cauto del termine genocidio da parte di un governo progressista si spiega facilmente.
La Chief Hosea Kutako Foundation, diretta da Kuaima Riruako, aveva promosso un'azione legale
contro il governo tedesco e alcune imprese (inclusa la Deutsche Bank e la Safmarine), che fra il
1904 e il 1907 avevano costretto degli herero ai lavori forzati. Inoltre, altri paesi europei come la
Gran Bretagna e la Francia non avrebbero gradito che la Germania si fosse dichiarata responsabile
di un genocidio coloniale, date le implicazioni di questo aggettivo. La definizione di genocidio approvata dalle Nazioni Unite comprende l'ipotesi di "cagionare seri danni fisici o mentali ai membri del gruppo". Secondo Raphael Lemkin, che coniò il termine genocidio e approfondì la materia,
… questo non presuppone l'immediata distruzione di un popolo, a meno che non venga realizzato con stragi
di massa che colpiscono tutti i suoi componenti. Deve essere inteso invece come un piano coordinato che include varie azioni tese a distruggere le basi essenziali della sua vita per cancellarlo. Questo piano deve avere
come obiettivo la disintegrazione delle sue istituzioni politiche, sociali, culturali, linguitiche, religiose ed economiche. Al tempo stesso, la distruzione di valori come la sicurezza, la libertà, la salute, la dignità e la vita
stessa degli individui che appartengono a questi gruppi (Axis Rule in Occupied Europe, p. 79).
Tutti i moderni paesi coloniali, a partire dalla Spagna dei conquistadores, potrebbero essere accusati di genocidio. Ma nella Germania odierna e fra i discendenti dei colonialisti che vivono in Namibia è difficile trovare qualcuno che ammetta il genocidio in questione. Il fatto che non esistano
cifre precise sulla popolazione herero precedente al 1904 e sul numero di persone morte nel genocidio viene sottolineato da coloro che lo negano, anche se il criterio distintivo del genocidio è
l'intenzione e non la realizzazione pratica. L'esercito tedesco voleva sterminare gli Herero, e questo
obiettivo fu appoggiato dai massimi esponenti del governo di Berlino. Infine, è probabile che molti
tedeschi rifiutino di riconoscerlo per non dover portare il peso di un secondo genocidio, tanto più
se si tratta di uno che certi storici ritengono il brodo di coltura della Shoah. Nel romanzo V. Thomas Pynchon descrive l'Africa di Sud-Ovest come un luogo dove si gettano le basi del nazismo,
mentre in Gravity's Rainbow fa riemergere gli Herero nella Germania hitleriana come lo Schwarzkommando che cura un programma missilistico e indossa uniformi simili a quelle "della vecchia
Wehrmacht e delle SS". Anche se si tratta di invenzioni romanzesche, queste ci permettono di capire la continuità che viene percepita fra l'Africa di Sud-Ovest e la Germania nazionalsocialista.
22
Gli Herero avevano resistito alla cristianizzazione per oltre mezzo secolo, ma dopo esser stati
rinchiusi nei campi di concentramento molti si convertirono. Altri cominciarono a indossare delle
uniformi tedesche. Fu dopo la sconfitta che si manifestarono queste forme di identificazione col nemico, come anche l'assimilazione che trasformò gli herero sopravvissuti in proletari. A loro vennero dati dei nomi tedeschi o semplici numeri, la loro terra venne frazionata e venduta ai coloni,
mentre la loro struttura politica fu distrutta. Venne vietato il possesso di bestiame, che per loro aveva anche un preciso significato religioso.
Dopo la fine della Prima guerra mondiale alcuni herero dettero vita alle oturupa (termine derivato dal tedesco truppe, ndt), gruppi con una struttura di tipo militare analoga a quella tedesca.
Facevano delle esercitazioni simili a quelle dell'esercito coloniale e comunicavano fra loro in tedesco. Le oturupa e la Chiesa evangelica divennero poi strutture di mutuo soccorso e di resistenza anticolonialista, continuando ad ampliare le proprie funzioni. Nel 2004, come avevano già fatto prima, le oturupa hanno organizzato un pellegrinaggio alle tombe degli antenati morti in guerra.
Uno sterminio volontario
Come abbiamo detto, fra il 1904 e il 1907 il governo tedesco manifestò il chiaro intento di sterminare gli Herero. Il 12 gennaio 1904, a Okahandja, gli indigeni vennero attaccati dai soldati coloniali. Questa non era soltanto la città dove si trovavano le maggiori autorità herero, ma anche la sede
di una delle prime chiese missionarie. Inoltre c'erano molti coloni e una base militare. Nella fase
successiva della guerra gli indigeni uccisero 126 coloni, in larga parte uomini adulti. Le ostilità proseguirono con alterne vicende fino all'11 giugno, quando il generale Lothar von Trotha arrivò dalla
Germania per prendere il posto del governatore Theodor Leutwein. Ai primi di agosto gran parte
degli Herero si riunì sull'altipiano del Waterberg col loro bestiame. La battaglia decisiva ebbe luogo l'11 agosto 1904, quando circa 5000 indigeni male armati vennero circondati da 1500 fanti dotati
di fucili, pistole e cannoni. Gli herero furono costretti a fuggire verso est, in direzione del deserto
di Omaheke, completamente privo di acqua.
Il fatto che von Trotha avesse fatto costruire dei campi di concentramento prima della battaglia
farebbe pensare che non avesse già programmato lo sterminio. Ma questo obiettivo divenne chiaro
nelle settimane successive. Il 13 settembre von Trotha ordinò ai soldati di respingere chiunque fosse venuto a chiedere acqua, e alcuni giorni dopo rifiutò il suggerimento del maggiore Ludwig von
Estorff, che gli aveva proposto di aprire delle trattative con i nemici. Von Trotha espresse la volontà di spingere la guerra alle estreme conseguenze nella lettera del 2 ottobre 1904:
Io, generale dell'esercito tedesco, invio questa lettera al popolo herero. Gli Herero non sono più sudditi tedeschi. . . . Gli Herero devono... lasciare il paese. Se non lo lasciano, li costringerò a farlo con il Groot Rohr
(cannone). Ogni herero, armato o disarmato… sarà abbattutto se verrà trovato all'interno dei confini tedeschi. Donne e bambini saranno costretti a riunirsi al proprio popolo o uccisi.
I tedeschi sapevano bene che nel deserto non c'era acqua: impedire ai nemici di tornare verso ovest
significava condannarli a morte. Per essere ancora più chiaro, von Trotha specificò le proprie intenzioni nella lettera datata 5 novembre che inviò al governatore Theodor Leutwein. Questo stava
per tornare in Germania dopo essere stato sollevato dall'incarico civile e militare per essersi opposto al genocidio:
Conosco bene queste tribù africane. Sono tutte uguali, capiscono soltanto la violenza. Io ho sempre usato
questa violenza nel modo più crudele. Ho i mezzi per affogare queste tribù ribelli in un lago di sangue.
Comunque quello che von Trotha stava facendo non era una sua iniziativa personale. Il conte von
Schlieffen, l'alto funzionario dell'esercito che aveva caldeggiato la sua nomina, non si oppose alle
intenzioni che il generale aveva espresso nella lettera del 2 ottobre. Il 23 novembre von Schlieffen
scrisse al Cancelliere von Bülow che il Generale von Trotha "aveva ragione" quando diceva che il
popolo herero doveva essere "annientato o cacciato dal paese". Von Bülow manifestò il proprio disaccordo, così von Schlieffen propose in alternativa uno "stato permanente di lavoro forzato, vale a
23
dire una forma di schiavitù". Soltanto il 9 dicembre, dopo che decine di migliaia di herero erano
morti di sete nel deserto, von Schlieffen ordinò a von Trotha di graziare tutti i nemici tranne
"quelli direttamente colpevoli e i capi". Molti altri tedeschi avevano contribuito al genocidio
sparando agli Herero, dando loro la caccia, avvelenando i pozzi e chiudendo il confine orientale
del deserto. Esistono molte fotografie e cartoline che ritraggono orgogliosi soldati tedeschi accanto
ai cadaveri di indigeni linciati: scene che richiamano l'America schiavista dell'Ottocento.
L'altra Germania davanti al genocidio coloniale
I primi studi sul colonialismo tedesco sono stati fatti nella Repubblica Democratica Tedesca. Questo non
deve stupire, dato che lo stato socialista si professava anticolonialista e avversava il regime di apartheid
che era stato introdotto in Sudafrica nel 1949. L'attenzione accademica per la questione cominciò nella seconda metà degli anni Cinquanta, dopo che gli archivi coloniali erano stati trasferiti a Potdsam. Il primo libro sul tema fu pubblicato nel 1966 da Horst Drechsler, all'epoca docente all'Università di Rostock, che fu
anche il primo storico a definire genocidio la guerra del 1904-1908 fra l’esercito tedesco e quelli dei popoli indigeni (Herero e Nama). L'opera, intitolata Südwestafrika unter deutscher Kolonialberrschaft (Akademie-Verlag, 1966) sarebbe stata poi tradotta in inglese (Let us Die Fighting, Zed Press, 1980).
Autore di altre opere sul tema, Drechsler fu condizionato dai dogmi marxisti-leninisti, secondo i quali colonialismo e fascismo erano due fenomeni strettamente collegati. La Germania federale veniva considerata
l'unica erede della Germania imperiale e del regime nazionalsocialista, mentre la Repubblica Democratica
Tedesca (RDT) si riteneva estranea alla storia precedente. Quindi la RDT aveva bisogno di costruirsi un'identità collettiva basata su un passato antifascista e anticolonialista. La classe operaia veniva quindi presentata come l'antesisgnana della lotta contro le atrocità del colonialismo. Questa eredità costruita ex-post
divenne così la pietra angolare della sua politica estera. Lo conferma l'appoggio che dette ai movimenti di
liberazione marxisti attivi nell'Africa di Sud-Ovest (poi Namibia). La RDT non si presentava soltanto
come un alleato, ma anche come un modello socialista da seguire.
Il lavoro pionieristico di Drechsler, pur essendo condizionato da queste forzature ideologiche, mise in evidenza la necessità di inquadrare il colonialismo tedesco in modo nuovo e ricevette un notevole successo
internazionale. Oggi, dopo mezzo secolo, resta un punto di riferimento fondamentale per gli studiosi.
Christiane Bürger
Nel marzo del 1905, mentre cominciava la stagione delle piogge, il tenente Schweinitz percorse un
ampio sentiero attraverso il deserto "che poteva essere stato tracciato soltanto dagli herero in fuga,"
trovandoci "un numero enorme di cadaveri: uomini, donne e bambini, uno accanto all'altro". Il sentiero, scrisse, era coperto di "teschi e scheletri umani".
Le immani sofferenze degli Herero e degli altri ribelli non finivano con la cattura o con la resa.
Come chiarì von Trotha nel 1905, gli Herero avrebbero dovuto passare un "periodo di sofferenza"
(Leidenszeit) nei campi di concentramento affinché i tedeschi fossero certi che "non si sarebbero più
ribellati per molte generazioni.". Nel campo di Shark Island la mortalità dei prigionieri rimase superiore al 90% fino all'aprile del 1907, quando venne sostituito il comandante. Anche in altri campi
i prigionieri morivano spesso per le condizioni disumane.
Probabilmente l'idea di mettere i prigionieri ai lavori forzati fu suggerita da una società diamantifera privata che faceva parte della Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwest-Afrika (Società coloniale
tedesca per l'Africa di Sud-Ovest, una compagnia concessionaria privata creata per volontà di Bismarck). Nell'agosto del 1904 i dirigenti della società chiesero al governo che fornisse una cinquantina di lavoratori. La Deutsche Bank e la compagnia d spedizioni Woerman (oggi Safmarine) erano
i principali azionisti della Otavi Mining e della Railway Society, che utilizzavano I prigionieri per costruire la ferrovia che portava alle miniere di rame di Tsumeb.
La Germania conservò il dominio dell'Africa di Sud-Ovest fino al 1915. Dopo la Prima guerra
mondiale la Società delle Nazioni assegnò la colonia al Sudafrica con un mandato di classe A: questo significava che la popolazione veniva considerata troppo primitiva per autogovernarsi. Nel
1990 il territorio è diventato l'ultimo stato indipendente africano col nome di Namibia. Ma il passato coloniale è ancora ben visibile. Il monumento equestre (Reiterdenkmal) che domina Windhoek,
24
la capitale, celebra i tedeschi caduti nella guerra del 1904-1907. La vicina chiesa è stata costruita
nel 1910 per ricordare le vittime della guerra: sulle sue mura si leggono soltanto nomi di europei,
mentre mancano quelli delle vittime africane. Quasi la metà delle terre migliori appartiene ai discendenti di coloro che le hanno espropriate con la forza.
Non è ancora chiaro quale sarà la risposta del governo tedesco alle richieste di risarcimento avanzate dagli Herero e dagli altri popoli della Namibia. Ma in ogni caso la Germania non potrà
mai dichiararsi estranea alla storia recente di questo paese africano, anche se molti tedeschi ignorano dove si trovi e che sia stata una "loro" colonia.
Bibliografia
Drechsler H., Südwestafrika unter deutscher Kolonialberrschaft, Akademie-Verlag, Berlin 1966 (ed.
ingl. Let us Die Fighting, Zed Press, London 1980).
Fontenaille-N'Diaye E., Blue book, Calmann-Lévy, Paris 2015.
Kössler R., Namibia and Germany: Negotiating the Past, University of Namibia Press, Windhoek 2015.
Lamendola F., Il genocidio dimenticato, Stavolta, Pordenone 1988.
Olusoga D., Erichsen C. W., The Kaiser's Holocaust: Germany's Forgotten Genocide and the Colonial
Roots of Nazism, Faber & Faber, London 2011.
Pynchon T., L'arcobaleno della gravità, Rizzoli, Milano 1973.
Sarkin J., Germany's Genocide of the Herero: Kaiser Wilhelm II, His General, His Settlers, His Soldiers,
James Currey, Woodbridge 2011.
Silvester J., Gewald J-.B. (a cura di), Words Cannot Be Found: German Colonial Rule in Namibia. An
Annotated Reprint of the 1918 Blue Book, Brill, Leiden 2003.
la causa dei popoli
ora è su Internet:
https://issuu.com/lacausadeipopoli/docs/la_causa_dei_popoli_1e2
Presto sarà disponibile anche il sito della rivista, con tutti i numeri pubblicati
(inclusi quelle delle vecchie serie)
25
Holodomor
Giovanna Siedina
Il termine Holodomor (derivato dall’ucraino moryty holodom, "infliggere la morte per fame") indica
la carestia che colpì l'Ucraina fra il 1932 e il 1933, causando un numero di vittime impressionante,
stimato fra i 3 e i 4 milioni, anche se secondo alcuni storici la cifra sarebbe maggiore. La carestia fu
provocata dal governo sovietico per stroncare la resistenza alla collettivizzazione dei contadini ucraini, che volevano mantenere la proprietà della terra e non diventare dipendenti delle nascenti
cooperative agricole (kolchoz) e delle aziende agricole di stato (sovchoz) di stampo socialista. La carestia fu diretta a colpire anche il Caucaso settentrionale, la regione meridionale del Volga e le
steppe del Kazachstan.
Dal momento che la collettivizzazione volontaria non aveva avuto il successo sperato, il regime
studiò misure coercitive più dure per accelerare questo processo. Così, fra il 1929 e il 1930, nelle
campagne vennero mandati decine di migliaia di funzionari governativi insieme a circa 25.000
lavoratori delle fabbriche, in gran parte di comprovata fede bolscevica, per combattere le forme di
resistenza attiva e passiva. Questa lotta, che fu definita dekulakizzazione, consistette nell'eliminazione fisica o nella deportazione dei kulaki: con questo termine la propaganda comunista etichettava in modo spregiativo i contadini ucraini come presunta classe sociale privilegiata. In realtà
in questa categoria venivano compresi anche coloro che possedevano i soli beni (terre e animali)
necessari al proprio sostentamento e in pratica chiunque si opponesse alla collettivizzazione.
Questa opposizione assunse forme di resistenza attiva e passiva, fra le quali la distruzione del bestiame e il rifiuto di seminare e raccogliere. Per questa resistenza migliaia di kulaki furono arrestati
e deportati nei campi di lavoro forzato della Siberia.
La carestia fu causata dall'effetto congiunto di varie azioni: dall'aumento delle quote per
l'ammasso al rastrellamento capillare di tutto il grano, delle sementi e perfino del cibo che serviva
al sostentamento degli abitanti, dalla destituzione e sostituzione dei funzionari locali incapaci di
portare avanti le spietate misure nei confronti dei contadini decise dal centro fino alla famigerata
'legge delle 5 spighe" emanata nell'estate del 1932. Questa prevedeva la fucilazione o la detenzione
per almeno 10 anni di coloro che fossero stati sorpresi a rubare beni dei kolchoz, e alla legge sui passaporti interni del 27 dicembre 1932, che esponeva i contadini all'arbitrio delle autorità del kolchoz,
privandoli del documento d'identità. La chiusura delle frontiere interne per fermare l’esodo massiccio dei contadini affamati dalle campagne, decretata il 22 gennaio 1933 da Stalin e Molotov,
sancì la definitiva condanna per fame di milioni di contadini.
Allo stesso tempo venivano destinati all'esportazione grossi quantitativi di cereali per incamerare valuta pregiata da destinare all’industrializzazione, mentre si continuava ad approvvigionare
le grandi città e l'Armata Rossa. Come confermano gli studi e i documenti apparsi nell'ultimo ventennio, si può parlare senza dubbio di una carestia creata ad arte dall'alto. Le riserve statali di grano, anche se non erano abbondanti, erano comunque sufficienti a evitare i milioni di morti in Ucraina, nel Caucaso settentrionale e nella regione meridionale del Volga, ma il regime preferì utilizzarle per altri scopi, in primis per l’esportazione, e impedì ogni forma di soccorso, decretando la
morte per fame della popolazione di intere aree rurali.
Le informazioni sulla carestia, sulle sue cause, modalità e dimensioni sono state taciute per decenni da Mosca. Il governo sovietico, sfruttando la propria posizione di membro permanente del
Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha impedito che la questione venissa dibattuta in quella sede.
In realtà, nei primi anni Trenta la circolazione di informazioni sulla tragedia fu più ampia di quanto si creda, a partire dai paesi confinanti. L'esodo di contadini russi, ucraini e bielorussi che durò
fino al 1932 costituì una fonte di informazione primaria su quanto succedeva nelle campagne, si26
milmente alle accorate richieste di aiuto rivolte alle comunità di ucraini emigrati negli altri paesi
europei, negli Stati Uniti e in Canada da parte dei parenti rimasti in patria. Appelli alla Società delle Nazioni e a governi europei e americani giunsero tanto dalla Chiesa greco-cattolica ucraina
quanto da organizzazioni di ucraini in Europa. Tuttavia, nell'ambito giornalistico l’informazione fu
assai più modesta e spesso non sostenuta dal necessario rigore documentario. In altri casi, alcuni
giornalisti occidentali che avevano piena conoscenza della carestia la nascosero: il caso più clamoroso e più noto fu quello del giornalista Walter Duranty, corrispondente del New York Times da
Mosca (1922-1936), che nel 1932 vinse il Premio Pulitzer grazie ai suoi articoli che tessevano le lodi
di Stalin e del governo sovietico. Altri giornalisti, invece, ebbero il coraggio di denunciare la
carestia. Fra di essi spicca la figura di Gareth Jones (1905-1935), il giornalista gallese che per primo
parlò in Occidente della tragedia: resta famoso il suo comunicato stampa su questo argomento
pubblicato nel 1933 da molti giornali, fra i quali il Manchester Guardian e il New York Evening Post.
Al contrario, la ricerca storica cominciò a svilupparsi in Occidente soltanto dopo la guerra. La
prima opera di rilievo a trattare delle carestie sovietiche fu Harvest of Sorrow di Robert Conquest: il
libro uscì nel 1986, ma la sua traduzione italiana vide la luce solo nel 2004 (con il titolo Raccolto di
dolore). Questa rimane un'opera fondamentale per capire le ragioni, le dimensioni e i fini della
grande carestia, che Conquest definisce correttamente "terroristica". L'interessante postfazione di
Ettore Cinnella ricostruisce in modo dettagliato il clima accademico nordamericano in cui sono
fioriti gli studi di sovietologia, che per lo più riproducevano acriticamente le informazioni fornite
dalle fonti sovietiche ufficiali continuando a negare o a minimizzare la carestia ucraina anche dopo
l'uscita del libro di Conquest. Al tempo stesso Cinnella ripercorre il clima politico-culturale italiano, dove era ancora ben vivo il mito dell'URSS, nonostante il disgelo di Chruščëv e l'intervista di
Togliatti alla rivista Nuovi argomenti con le sue severe critiche allo stalinismo.
Il giornalista che denunciò la carestia ucraina
Molti genocidi sarebbero rimasti ignoti o sarebbero stati conosciuti più tardi se non fossero stati documentati dagli scritti e dalle fotografie dei testimoni oculari. Pensiamo al diplomatico irlandese Roger Casement, che denunciò le stragi di indigeni congolesi compiute dall’esercito belga all'inizio del Novecento.
Oppure ad Armin Wegner, che documentò il genocidio armeno con fotografie e testimonianze dirette.
Meno famoso, ma altrettanto importante, è stato Gareth Jones, il giornalista gallese che denunciò la carestia ucraina. Jones nacque a Barry nel 1905. Il padre era il preside di una scuola, mentre la madre aveva
vissuto per alcuni anni in Ucraina come tutrice dei nipoti di John Hughes, un industriale gallese che aveva
fondato la città di Yuzovka (oggi Donetsk). Fu quindi in seguito ai racconti della madre che il giovane
Gareth sviluppò il desiderio di visitare l'Ucraina.
Successivamente acquisì la conoscenza di tre lingue (francese, russo e tedesco) con gli studi universitari.
Fra il 1932 e il 1935 Jones denunciò il genocidio per fame su vari giornali, fra i quali il London Evening
Standard, il Financial Times e il Berliner Tageblatt. Per questo venne duramente attaccato da Walter Duranty, un potente giornalista filocomunista del New York Times che aveva ricevuto il Premio Pulitzer per i
suoi articoli sul piano quinquennale sovietico. Grazie a questi articoli il Presidente statunitense Franklin
Roosevelt decise di riconoscere ufficialmente l’URSS. Questo avvenne il 16 novembre 1933, pochi mesi
dopo che la carestia aveva raggiunto la fase più acuta, con circa 28.000 persone che morivano ogni giorno.
Antonella Visconti
Un'importante raccolta di fonti documentarie di prima mano sulla carestia ucraina è il libro di Andrea Graziosi Lettere da Kharkov, pubblicato nel 1991. Il volume raccoglie lettere e documenti inviati
negli anni della carestia dai rappresentanti diplomatici italiani dei consolati di Kharkov, Batum e
Novorossijsk e dell’ambasciata di Mosca, che testimoniano, se ce ne fosse bisogno, che il governo
fascista italiano era perfettamente a conoscenza della catastrofe umanitaria in corso.
La morte della terra è un'opera miscellanea che raccoglie gli atti del congresso omonimo, tenutosi
a Vicenza dal 16 al 18 ottobre 2003. L'opera ha il pregio di pubblicare articoli dei maggiori storici
ucraini, russi e occidentali. In particolare, Ivnickij approfondisce il ruolo di Stalin sulla base di una
dettagliata disamina della corrispondenza fra lui e i suoi più vicini collaboratori (Molotov per l'U27
craina e Kaganovič per il Caucaso del nord). Nel dettaglio vengono esaminate le direttive per i piani di ammasso, fissati sempre a partire dalla produttività biologica del terreno e non dal raccolto
effettivo lordo, che era di gran lunga più basso. Lo storico parla anche delle disposizioni date in
materia di registrazione dei decessi: in primo luogo una disposizione del 16 febbraio 1933 vieta-va
a qualunque organizzazione di tenere la registrazione dei casi di gonfiore e di morte per fame,
tranne che agli organi del OGPU. Ai soviet di villaggio veniva data disposizione affinché la registrazione della morte non ne indicasse la causa.
Tutti i libri degli uffici di registrazione dello stato civile per la registrazione delle morti degli
anni 1932-1933 dovevano essere spediti ai reparti speciali, dove molto probabilmente furono distrutti. Questi sono i dati forniti da Ivnickij: circa 7 milioni di persone morte, di cui 3,5 in Ucraina,
1,2 nel Caucaso del nord, da 1,2 a 1,5 in Kazachstan e circa un milione di persone in Povolia, nella
regione centrale delle Terre Nere, in Siberia occidentale e negli Urali meridionali. Dall'autunno del
1932 all'estate del 1933 la popolazione sovietica diminuì di 7,7 milioni di persone.
Se la carestia ucraina ha già stimolato un notevole interesse accademico, lo stesso non è accaduto a livello politico e diplomatico. Com'era prevedibile, il primo paese a riconoscere il genocidio
è stata l'Ucraina (15 maggio 2003), che nel 2006 ha istituito una commemorazione ufficiale che si
tiene il quarto sabato di novembre. Poi sono venuti altri paesi, fra i quali la Lituania (2005), il Canada e l'Australia (2008) e recentemente il Portogallo (2017).
Bibliografia
Cinnella E., Ucraina. Il genocidio dimenticato, Della Porta, Pisa 2015.
Conquest R., Raccolto di dolore. Collettivizzazione sovietica e carestia terroristica, Fondazione Liberal, Roma 2004
De Rosa G., Lomastro F. (a cura di), La morte della terra. La grande «carestia» in Ucraina nel 1932-33. Atti del convegno (Vicenza, 16-18 ottobre
2003), Viella, 2005
Graziosi A., Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del nord nei rapporti diplomatici italiani 1932-33, Einaudi, Torino 1991.
Klid B., Motyl A. J. (a cura di), The Holodomor Reader: A Sourcebook on the Famine of 1932-1933 in Ukraine, University of Alberta Press,
Edmonton (AB) 2012.
Lemkin R., "Soviet genocide in Ukraine", Holodomor Studies, I, 1, 2009, pp. 3-8.
28
Suoni, immagini e parole
Materiali sui genocidi
Trovare film, romanzi e fumetti sui genocidi dimenticati è meno diffile di quanto sembri. Anche in Italia sono facilmente reperibili numerose opere dedicate agli eventi storici trattati in questo numero.
Film e documentari
Romanzi e fumetti
Aborigeni della Tasmania
The Last Tasmanian, Tom Haydon, Australia, 1978.
Manganinnie, John Honey, Australia, 1980.
Aborigeni della Tasmania
Flanagan R., Solo per desiderio, Frassinelli, Milano 2011.
Kneale M., Il passeggero inglese, Bompiani, Milano 2002.
Wilson R., The Roving Party, Allen & Unwin, Sydney
(NSW) 2011.
Herero e Nama
Les Héréros, le génocide oublié, Tristan Mendès France, Francia, 2000 [documentario].
Herero e Nama
Kubuitsile L., The Scattering, Penguin South Africa, Johannesburg 2016.
Seyfried G., Herero, Eichborn, Berlin 2003.
Indiani del Nordamerica
Segreti dal passato, Georgina Lightning, Stati Uniti,
2008.
The Only Good Indian, Kevin Willmott, Stati Uniti, 2009.
Our Spirits Don't Speak English, Chip Richie, Stati Uniti, 2008 [documentario].
Indiani del Nordamerica
Robertson D. A., Henderson S. B., Sugar Falls: A Residential School Story, Winnipeg (MB) 2012 [fumetto].
Wagamese R., Indian Horse, Douglas & McIntyre, Madeira Park (BC) 2012.
Irlandesi (An Gorta Mór)
Famine, Omer Sarikaya, Gran Bretagna-Irlanda-Turchia, 2016.
Famine in Ireland: Remember Skibbereen, Pat Collins,
Irlanda, 2009 [documentario].
Irlandesi (An Gorta Mór)
Kinealy C., Walsh J., The Bad Times: An Drochshaol,
Quinnipiac University Press, Hamden (CT); XanEdu,
Ann Arbor (MI) 2015 [fumetto].
Moore A., Terra perduta, Beat, Milano 2001.
Moriori
The Feathers of Peace, Barry Barclay, Nuova Zelanda,
2000 [documentario].
Moriori
Makereti T., Where the Rekohu Bone Sings, Random
House, Auckland 2014.
Popoli indigeni della Terra del Fuoco
The Human Zoo: The Story of Calafate, Hans Mülchi,
Cile, 2011 [documentario].
La memoria dell'acqua, Patricio Guzmán, Cile-Francia-Spagna, 2015 [documentario].
Terra del fuoco, Miguel Littin, Italia-Spagna, 2000.
Yamana: i nomadi del fuoco, Tullio Bernabei, Italia, 2004
[documentario].
Ucraini (Holodomor)
Bitter Harvest, George Mendeluk, Canada, 2016.
Holodomor, Fabio Ferrando, Manuel Baldini, Italia-Ucraina, 2013 [documentario].
Holodomor, le génocide oublié, Bénédicte Banet, Francia, 2014 [documentario].
Holodomor: Ukraine's Genocide of 1932-33, Bobby Leigh, Stati Uniti, 2012 [documentario].
Popoli indigeni della Terra del Fuoco
Chemineau L., Julio Popper, le dernier roi de Terre de
Feu, Rue de Sèvres, Paris 2015 [fumetto].
Coloane F., Cacciatori di indios, Guanda, Milano 2003.
Díaz A., Campos O., Raptados, Ocho Libros, Santiago de
Chile 2012 [fumetto].
Iparraguirre S., La terra del fuoco, Einaudi, Torino 2001.
Raspail J., I nomadi del mare, SugarCo, Milano 1987.
Ucraini (Holodomor)
Barka V., Il principe giallo. Lo sterminio per fame dei
contadini in Ucraina, Pentagora, Savona 2016.
Igort, Quaderni ucraini. Memorie dai tempi dell'URSS,
Mondadori, Milano 2010 [fumetto].
Szpuk A., Sliding on the Snow Stone, CreateSpace, Seattle (WA) 2011.
29
Mezzo secolo
per l'autonomia della Corsica
Alessandro Michelucci
Le riviste realizzate dai popoli minoritari hanno spesso vita dura. I motivi sono tanti: problemi economici, mancato ricambio generazionale, contrasti politici all'interno della redazione. Ma fortunatamente ci sono anche delle eccezioni. Una delle più evidenti è il settimanale autonomista corso
Arritti, che ha raggiunto il traguardo invidiabile di cinquant'anni.
Il giornale è stato fondato nel 1966 da Max Simeoni, figura centrale dell'autonomismo isolano
come il fratello minore Edmond. Alla fine degli anni Cinquanta la Corsica è afflitta da un pesante
degrado amministrativo e urbanistico. Le strade sono poche e trascurate, l'assistenza sanitaria è
scarsa, non ci sono università. Il movimento autonomista rinasce attorno ai fratelli Simeoni, entrambi medici, originari della regione montagnosa del Niolu. La loro lotta politica presenta anche
un marcato impegno ambientalista. Prima contro il proposito di realizzare in Corsica gli esperimenti che non possono più essere fatti nel Sahara in seguito all’indipendenza algerina, poi contro
i "fanghi rossi" coi quali la Montedison inquina la zona di Capo Corso.
Questo impegno viene poi confermato a livello politico: nel 1989 Max Simeoni viene eletto parlamentare europeo nella lista dei Verdi francesi. Nei cinque anni del suo mandato Simeoni svol-ge
un'intensa azione parlamentare in difesa delle minoranze europee e dei Kurdi.
La solidarietà con le altre minoranze dà vita all'Alliance Libre Européenne (ALE), la federazione
dei partiti autonomisti europei, che vede Max fra i fondatori.
Intanto, con regolarità ammirevole, Arritti compare in edicola ogni settimana. Le sue pagine
non parlano soltanto della realtà isolana, ma rivolgono anche un'attenzione costante ai popoli minoritari di tutto il mondo: dai Baschi ai Kanak, dai Gallesi ai Tuareg.
Le giornate di Arritti, che vengono organizzate ogni anno a Bastia, ospitano personaggi di rilievo, come José Bové, David Hume ed esponenti politici delle regioni autonome europee.
Oggi, superato il numero 2500, Arritti continua la sua battaglia democratica e nonviolenta per
costruire una Corsica moderna, libera dai limiti che il centralismo parigino le impone da oltre due
secoli.
Edmond Simeoni, una vita militante
Anche Edmond Simeoni, fratello minore di Max, ha dedicato la propria vita alla lotta per l' autonomia della Corsica. Contrario alla violenza, da circa cinquant'anni porta avanti un impegno politico e ambientalista esemplare. La sua storia, ormai quasi leggendaria, è stata
raccontata da Pierre-Antoine Beretti nel recente documentario Edmond
Simeoni, l'esprit militant. Insieme al fratello Max ha costituito e animato vari movimenti politici, fra i quali l’ARC (Azzione Regionalista
Corsa) e l’UPC (Unione di u Populu Corsu). Inoltre è stato fra i fondatori del Collettivo antirazzista Avá Basta. Oggi dirige l’associazione
Corsica Diaspora e Amici della Corsica.
Ha scritto Le piège d’Aleria (Lattès, 1975), La volonté d’être (Albiana,
1995), Un combat pour la Corse (Le Cherche Midi, 2003) e Lettre aux
femmes corses (DCL, 2008). Cura il blog www.edmondsimeoni.com
30
Biblioteca
Rodolfo Calpini, Colonialismo missionario, Aracne, Roma 2014, pp. 496, € 24.
In Italia, se si eccettuano rare eccezioni, il risveglio d'interesse per i problemi dei popoli indigeni
non ha ancora stimolato una riflessione critica sugli effetti devastanti che le missioni cristiane
hanno avuto nei confronti delle loro culture durante i secoli scorsi. Non solo, ma la maggior parte delle associazioni indigeniste ha individuato nei missionari odierni degli alleati. Questa non è
una posizione insensata, perché è innegabile che esistano dei religiosi sinceramente votati alla
difesa dei popoli autoctoni. Al tempo stesso, però, ci sembra sbagliato che l'analisi di un tema
così articolato venga operata limitando la visuale a una parte della sua manifestazione attuale. In
questo modo si dimentica che l'edificio missionario è stato costruito sul presupposto di una superiorità che ha legittimato crimini orrendi, oltre al persistente sostegno del colonialismo. Quindi è inaccettabile che i meriti di alcuni missionari odierni oscurino le gravi colpe dei secoli scorsi.
Detto questo, è doveroso salutare con sincero entusiasmo il libro Colonialismo missionario, che
porta una salutare ventata d'aria fresca nel dibattito sulla materia. Fin dal titolo appare chiaro
che l'opera di Rodolfo Calpini coglie nel segno. Il volume manifesta un coraggio che non si era
mai visto in Italia, dove la sudditanza psicologica nei confronti della Chiesa cattolica è un fenomeno trasversale che risparmia soltanto pochissimi spiriti veramente liberi.
Profondo conoscitore della materia, inclusi i suoi aspetti dottrinari più articolati, Calpini
traccia un ampio panorama dove si intrecciano temi storici, religiosi e giuridici. La sua posizione è molto chiara, ma l'autore è lontano anni luce dai toni barricaderi e dalla rivendicazione rabbiosa. Del resto, questi non sono neanche necessario: basta un'analisi attenta della storia perché i
crimini delle missioni appaiano in tutta la loro gravità.
L'autore non si limita a dimostrare che le Chiese cristiane, e in particolare quella cattolica,
hanno sostenuto in modo teorico e pratico il colonialismo europeo. Non ci sono mai stati invasori europei che non fossero accompagnati da uomini con la croce. Questo ormai rappresenta un
dato di solare evidenza che viene contestato da pochi storici. Al tempo stesso, però, Calpini dimostra che sarebbe sbagliato pensare, come spesso accade, che la Chiesa cattolica avesse svolto
una semplice funzione di supporto religioso nei confronti della struttura coloniale. L'autore sottolinea che questo rapporto si è manifestato anche in senso inverso, perché il colonialismo si è
nutrito delle argomentazioni elaborate dalla Chiesa cattolica.
Prima di concludere, un rilievo necessario. Fino a qualche tempo fa un libro come questo avrebbe faticato a trovare un editore. Anche quando ci fosse riuscito, sarebbe stato accolto da critiche pesanti. Forse certi fondamentalisti cattolici lo avrebbero bruciato nelle piazze o avrebbero in31
vitato le librerie a non venderlo. Oggi, fortunatamente, tutto questo non accade. Non è molto, ma è
comunque un passo avanti.
Spetterà poi a chi avrà letto questo libro valutare se certi crimini debbano essere dimenticati soltanto perché a compierli sono stati dei religiosi anziché dei laici.
Alessandro Michelucci
Cathie Carmichael e Richard C. Maguire (a cura di), The Routledge History of Genocide, Routledge, London 2015, pp. XIV + 348, $240.
Il genocidio è un tema che gode di un interesse accademico sempre più diffuso. Gran parte degli studiosi, però, si concentra su casi specifici del secolo scorso, mentre pochi ne tracciano un panorama
storico più ampio che includa anche casi dei secoli precedenti.
Fra i secondi vanno inclusi Cathie Carmichael e Richard C. Maguire, curatori di questo volume
che analizza il tema con una ricca varietà di opinioni e di prospettive. Cathie Carmichael introduce il
tema col doveroso riferimento a Raphael Lemkin (1900-1959), il giurista polacco che per primo analizzò il tema e coniò lo stesso termine genocidio. Simone Gigliotti esamina la questione dei "bambini
rubati", i piccoli aborigeni australiani che furono sottratti alle rispettive famiglie durante il secolo
scorso per "farne dei bianchi". Kate Ferguson analizza il genocidio dei musulmani bosniaci, mentre
Mike Bowker si concentra sulla guerra russo-cecena.
A casi più remoti sono dedicati i saggi di Fernando Quesada-Sanz ("Genocide and mass-murder
in Second Iron Age Europe: Methodological issues and case studies in the Iberian Peninsula") e David Edwards ("Tudor Ireland: Anglicisation, mass killing, and security"). Gli altri interventi spaziano
dalla Shoah alla tragedia ruandese, dalle stragi degli Ustascia croati allo Holodomor, il genocidio per
fame con il quale Stalin causò la morte di almeno sette milioni di ucraini.
Un volume di notevole interesse che arricchisce ulteriormente la letteratura sul tema.
Giovanna Marconi
Paloma Otaola e Stéphanie Bory (a cura di), Autonomies et indépendances: Le nationalisme au
XXIe siècle, Connaissance et Savoirs, Saint-Denis 2016, pp. 340 pages, € 20,95, E-book 6,49.
Le rivendicazioni di autonomia e/o indipendenza che costellano il pianeta sono espressioni di un fenomeno multiforme che non deve essere liquidato in modo frettoloso. Per capirlo davvero occorre
accantonare una logica manichea che preveda soltanto il pieno sostegno e la condanna acritica. Si
tratta di casi eterogenei, quindi ognuno deve essere esaminato tenendo conto del contesto sociale e
politico nel quale si sviluppa. L'autonomia della Groenlandia, per esempio, è completamente diversa
da quella della Palestina. Allo stesso modo, poco o nulla accomuna l'indipendenza rivendicata dalla
Scozia a quella che viene dibattuta in Nuova Caledonia.
Per quanto riguarda in particolare l'Europa, il fenomeno è diventato parte integrante del dibattito
politico, soprattutto grazie al caso catalano. Altrove stanno riemergendo rivendicazioni che sembravano archiviate per sempre: basti pensare alla questione del Biafra. Il libro, che contiene gli atti di
un convegno tenutosi a Lione nel 2015, offre un valido aggiornamento su questo tema di grande attualità. Partendo dal referendum scozzese del 2014, i relatori esaminano le rivendicazioni identitarie
di vari paesi: dalla Catalogna alla Nuova Zelanda, dalla Crimea all'Irlanda del Nord.
Il volume affronta anche temi d'interesse generale, come l'identità nazionale e le basi sociali, economiche e linguistiche dei nazionalismi odierni. Ormai anche gli osservatori più prevenuti devono
ammettere che questi temi sono destinati a incidere sul nostro futuro. Conoscerli senza cadere nelle
semplificazioni della stampa quotidiana ci sembra perciò imperativo.
Alessandro Michelucci
32
Léo Battesti, La vie dessous tout, Corsica Flash, Bastia 2017, pp. 287, € 17.
Jean-Guy Talamoni, Avanzà! La Corse que nous voulons, Flammarion, Paris 2016, pp. 195, € 17.
I principali esponenti del nazionalismo corso – sia autonomisti che indipendentisti – si distinguono per un'attività pubblicistica intensa. Dopo i libri di Alain Orsoni, Pierre Poggioli, Jean-Pierre
Santini ed Edmond Simeoni, ecco quelli di Léo Battesti e Jean-Guy Talamoni, figure centrali del separatismo isolano.
Battesti, che è stato fra i fondatori del Front de Libération Nationale de la Corse (FLNC), ne critica
l'approccio terzomondista e anticolonialista: la stessa sigla era ispirata al FLN algerino. In questo
individua "l'inizio di una lenta ma irreversibile deriva" (p. 58). Non si tratta di una convinzione recente, perché già nel 1992 aveva auspicato la dissoluzione dell'organizzazione clandestina. Negli
anni del carcere Battesti ha riflettuto a lungo sulla propria esperienza e ha sviluppato una passione
che avrebbe inciso profondamente sulla sua vita: gli scacchi. Tanto è vero che oggi è un campione
affermato e organizza gare di livello internazionale. L'intento autobiografico del libro viene ulteriormente sottolineato dall'uso della prima persona.
Il percorso politico di Talamoni è stato diverso. Più giovane di Battesti, l'avvocato di Bastia ha aderito al movimento separatista alla fine degli anni Novanta, ma senza partecipare direttamente alle azioni terroristiche del FLNC, che all'epoca si era già diviso in varie fazioni rivali. Figura centrale di Corsica Libera, oggi è presidente dell'Assemblea regionale isolana (analoga al nostro Consiglio
regionale).
Avanzà! La Corse que nous voulons segna un precedente, perché è il primo libro di un nazionalista
corso che viene pubblicato da uno dei principali editori francesi. Non solo, ma è stato lo stesso editore che ha contattato Talamoni dopo la sua vittoria alle elezioni regionali del dicembre 2015. Le
stesse dove Gilles Simeoni, sindaco autonomista di Bastia, era stato eletto Presidente della Collettività Territoriale (la Regione).
Il libro dimostra che la situazione politica dell'isola sta cambiando profondamente. Archiviata la
stagione del separatismo armato, le due componenti del movimento nazionalista (autonomisti e separatisti) hanno deciso di mettere da parte le differenze per dedicarsi alla costruzione di un futuro
diverso. I temi in questione sono tanti: dal bilinguismo all'autonomia politica, dalla trasformazione
dell'isola in dipartimento unico allo sviluppo del turismo, settore vitale dell'economia locaale.
Talamoni non si limita a esporre il proprio progetto per la Corsica di domani, che presuppone
un mutamento profondo del rapporto con la Francia. Al tempo stesso, infatti, analizza temi che riguardano l'intera repubblica, come la laicità e il rapporto con la religione islamica. Merita particolare attenzione lo spazio dedicato alla necessità di superare la vecchia logica destra-sinistra.
Un libro indispensabile per chi voglia capire la Corsica di oggi e come potrebbe/dovrebbe essere quella di domani.
Antonella Visconti
Sebastiano Vassalli, Il confine. I cento anni del Sud Tirolo in Italia, Rizzoli, Milano 2015, pp. 148,
€ 16,50.
Trent'anni dopo Sangue e suolo. Viaggio fra gli italiani trasparenti (Einaudi, 1985) Vassalli ha sentito il
bisogno di ritornare sulla questione sudtirolese temperando i toni aspri del libro precedente, talvolta confinanti con la germanofobia.
In toni giornalistici, lontani dal suo stile colorato e intenso, lo scrittore ripercorre i momenti più
significativi della vicenda: dal trattato di Saint Germain, che sancì l'annessione alla penisola, all'italianizzazione violenta del ventennio fascista, dagli attentati degli anni Sessanta-Settanta ai nostri giorni. Lo scrittore tratteggia i protagonisti di questa storia travagliata: Ettore Tolomei, voce del pensiero
fascista e suo braccio esecutivo in loco; Silvius Magnago, figura carismatica dell’autonomismo; Alexander Langer, punto di contatto fra la realtà locale e i fermenti del Sessantotto.
33
L'autore evidenzia in modo lucido e tagliente gli snodi essenziali di un secolo di storia, purtroppo ignorato dalla maggior parte degli italiani, ricco di contrasti, di antinomie, di "fandonie storiche", di follie politiche e di stagioni oscure dove si sono inabissate molte vite. Un lungo tempo in
cui "i torti sono stati corretti con altri torti; i vecchi errori con nuovi errori" (Langer).
Con accenti retorici, seppure più formali che sostanziali, il libro esprime i principi che possono
condurre gli abitanti del Sudtirolo a una condizione di serena e pacifica convivenza. Un accorato
appello a separare il passato dal presente e a trovare un percorso comune che rispetti le reciproche
identità, rifuggendo da ogni tentazione assimilazionista.
Vincenzo Durante
Michel Bruneau, De l'Asie Mineure à la Turquie: Minorités, homogénéisation ethno-nationale, diasporas, CNRS, Paris 2015, pp. 412, € 26.
Il termine "Asia minore" evoca un complesso intreccio di riferimenti storici, culturali e religiosi.
Dall'impero bizantino a quello ottomano, per poi approdare alla Turchia, questa regione ha perduto una buona parte della sua ricchezza culturale proprio in seguito alla nascita della repubblica.
Lo sradicamento delle minoranze cristiane - Armeni, Assiri e Greci - è stato portato avanti in tutti i
modi, incluso il genocidio. Poi il nuovo potere ha dovuto fare i conti con una minoranza molto più
consistente, quella kurda. Il centralismo violento di Ankara ha generato così varie diaspore, alle
quali si è aggiunta in tempi più recenti quella turca.
Geografo ed ellenista, Bruneau ci permette di conoscere in modo dettagliato il romanzo tragico
che è stata la storia della grande penisola eurasiatica. L'approccio multidisciplinare dell'autore si
rivela particolarmente utile per comprendere le numerose implicazioni geopolitiche della regione,
che conserva un ruolo centrale nella politica odierna. Un'opera indispensabile per capire il nostro
tempo, un libro di storia che si legge come un romanzo.
Giovanna Marconi
Simone Zoppellaro, Armenia oggi. Drammi e sfide di una nazione vivente, Guerini e Associati, Milano 2016, pp. 88, € 9,50.
Tra i genocidi che hanno segnato la storia recente, quello armeno è il più noto dopo la Shoah. Ma
mentre Israele, nato dopo la tragedia ebraica, ha un ruolo centrale nella scena internazionale, l'Armenia, nata dopo il Metz Yeghern e inglobata nell'URSS fino al 1991, non occupa le pagine dei
giornali. La "pacificazione" dell'area caucasica, che ha toccato Armenia, Azerbaigian, Cecenia e
Georgia, è un fenomeno complesso noto solo agli specialisti. Pochi ricordano la guerra cecena degli
anni Novanta, quella del Nagorno Karabakh, la secessione dell'Ossezia del sud e dell'Abcasia.
Ecco perché risulta utile questo libro di Zoppellaro, corrispondente dall'Armenia per l'Osservatorio Balcani e Caucaso e collaboratore di varie testate. Il volume, introdotto da Antonia Arslan,
ci aiuta a conoscere un paese che vive nel ricordo del genocidio, tuttora negato dal governo turco.
L'autore non propone un altro libro sul Metz Yeghern, ma in sette capitoli, con agile linguaggio giornalistico, ci presenta l'Armenia di oggi "piegata da una crescente miseria, approdo di migliaia di profughi provenienti dalla Siria e stremata infine da una guerra —quella del Nagorno Karabakh— che a oltre vent'anni dal suo inizio pare sempre più lontana dal trovare una soluzione"
che lotta per la sua sopravvivenza.
Le conclusioni invitano a guardare al futuro mettendo in primo piano la cultura della convivenza, perché, come afferma l'autore, "armeni e azeri, turchi e armeni hanno vissuto insieme fianco
a fianco fino a un passato recente".
Diego Corraine
34
Gerard Russell, Regni dimenticati. Viaggio nelle religioni minacciate del Medio Oriente, Adelphi, Milano 2016, pp. 385, € 25.
"Gerard Russell è una delle poche persone in grado di scrivere un libro come questo" scrive Rory
Stewart nella prefazione. Non è possibile dargli torto, dato che l'autore, ex diplomatico britannico
con una profonda conoscenza della lingua e della cultura araba, ha trascorso molti anni in Medio
Oriente. Ha viaggiato a lungo in questa regione, frequentando zone inaccessibili e pericolose, presentandosi “come un semplice turista disorientato, che se ne va in giro su scalcagnati autobus locali”. In
realtà egli “è uno studioso competente, paziente, di pronta intelligenza (…), con un vero talento nel
conquistare la fiducia dei suoi interlocutori”.
Nel libro, frutto di quattro anni di viaggi in otto paesi, Russell guida il lettore alla scoperta di religioni minoritarie, culti millenari, ordini esoterici, sincretismi e fedi misteriose spesso aperte solo
agli iniziati, raccontando con rigore storico e con un'incredibile abbondanza di notizie l'eterogeneità spirituale di luoghi spesso riuniti sotto un'assoluta egida islamica. Un viaggio nello spazio e
nel tempo, un affascinante affresco di realtà sommerse, regni dimenticati, fedi antichissime che animano la vita misteriosa e segreta di minoranze oggi in fuga da guerre e persecuzioni, minacciate
dai monoteismi preponderanti, ma soprattutto bersaglio della violenza cieca dell'ISIS che nella sua
interpretazione distorta e spietata le considera eresie non tollerate. Una per tutte, quella degli Yazidi, che fino a qualche anno fa vivevano nel nord dell’Iraq, mentre oggi sono costretti a fuggire e
a riparare in altri Stati per non essere sterminati.
Cacciate dalle proprie terre, queste comunità devono affrontare nuove sfide per salvare dall'oblio credenze e tradizioni che rischiano di scomparire per sempre.
Maurizio Torretti
Chudi Offodile, The Politics of Biafra and the Future of Nigeria, Safari Books, Ibadan 2016, pp.
279, £ 30.
Negli ultimi 15 anni la rivendicazione di uno stato biafrano è riemersa, prima in sordina, poi in
maniera sempre più evidente. Il fatto che la questione sia tornata d'attualità è confermato dalla grande quantità di libri sul tema che sono usciti negli ultimi anni: romanzi, memorie, analisi storiche e
politiche. Attenzione però: non si tratta soltanto di libri per pochi cultori. Il romanzo di Chimamanda Ngozi Adichie Half of a Yellow Sun (ed. it. Metà di un sole giallo), per esempio, è stato tradotto in trenta lingue, ha venduto oltre un milione di copie e ne è stato tratto un film.
A confermare questo rinnovato interesse arriva il libro di Chudi Offodile, avvocato ed ex parlamentare nigeriano. L'opera offre un ampio panorama dei gravi problemi che affliggono la Nigeria,
come le continue tensioni etniche delle regioni petrolifere, il flagello di Boko Haram e il faticoso
tentativo di trasformare il paese in una vera federazione. In tale contesto la rinascita della questione biafrana rischia di avere l'effetto di un fiammifero sulla benzina. Ma diversamente da quello che hanno fatto molti altri saggisti africani, Offodile non demonizza la questione biafrana. Al
contrario, la affronta seriamente sottolineando che la sua soluzione rappresenta un banco di prova.
L'autore disegna un quadro storico che parte dal 1966 e arriva fino a oggi. Ricompone accuratamente gli eventi che hanno determinato la nascita degli odierni movimenti separatisti biafrani, vale
a dire il MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra), l'IPOB (Indigenous
People of Biafra) e la BILIE Human Rights Initiative.
Nell'ultimo capitolo Offodile ribadisce che il futuro della Nigeria e quello del Biafra sono
strettamente legati, ma non azzarda previsioni sulle conseguenze di una vera riforma federalista. Il
nodo principale rimane proprio questo: nata come federazione, la Nigeria non è mai riuscita a tradurre in realtà questo proposito. Se non ci riuscirà, sostiene l'autore, continuerà a vivere sviluppi
epilettici, piagato da rivendicazioni di autonomia e/o indipendenza con esiti imprevedibili.
Giovanna Marconi
35
Tracey Banivanua Mar, Decolonisation and the Pacific: Indigenous Globalisation and the Ends of
Empire, Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 268, £64.99.
L'Oceania è stata l'ultimo continente a vivere l'esperienza controversa della decolonizzazione. Molti dei suoi territori sono diventati indipendenti dopo la Seconda Guerra Mondiale: Samoa (1962),
Tonga (1970), Papua Nuova Guinea (1975), Tuvalu (1978), isole Salomone (1978), Kiribati (1979),
Palau (1994), etc. Per inciso, ricordiamo che molti altri (Guam, Nuova Caledonia, Polinesia "francese", Samoa "Americane", etc.) conservano lo status coloniale, seppure mascherato dietro eufemismi verbali come "territori d'oltre mare" e simili.
L'autrice sottolinea che questo processo internazionale ha avuto un forte impatto sui popoli indigeni, che qui si trovano ovunque: basti pensare ai Maori della Nuova Zelanda, ai popoli di Papua, ai Samoani, etc. Secondo la studiosa, i limiti strutturali della decolonizzazione hanno messo a
nudo le peculiarità storiche del colonialismo che si era affermato in questa regione, dove le potenze
coloniali hanno concepito la decolonizzazione come una nuova forma di imperialismo.
Il libro dimostra che i popoli indigeni hanno saputo fronteggiare questa situazione sviluppando
una serie di legami politici e culturali che trascendevano i limiti nazionali. La decolonizzazione
non appare quindi un evento storico, ma un processo fragile che continua tuttora.
Alessandro Michelucci
Bobby Sands
Un'utopia irlandese
a cura di Riccardo Michelucci
Un'opera fondamentale per
conoscere una figura centrale della
resistenza anticolonialista moderna
www.edizioniclichy.it
36
Nuvole di carta
Eddy Simon, Matthieu Berthod, Adivasis meurtris. L’agonie d’un peuple autochtone en Inde, La
Boite à Bulles, Saint Avertin 2016, pp. 85, € 16.
Viene dalla Francia, patria indiscussa del fumetto, un album che conferma l'interesse della nona arte per le questioni indigene. Il fenomeno è ancora più interessante se si considera che questa attenzione non è limitata ai popoli più noti, come gli Indiani del Nordamerica o i Tuareg, ma tocca anche quelli generalmente trascurati dai media. Come i popoli aborigeni dell'India, che vengono indicati collettivamente col termine hindi Adivasi. Discriminati dalla maggioranza hindu, che ha usurpato le loro terre, vivono da sempre ai margini della società.
Adivasis meurtris. L’agonie d’un peuple autochtone en Inde, sostenuto da Amnesty International,
porta in primo piano una delle questioni indigene più ignote e al tempo stesso più tragiche dei
nostri tempi. Trattandosi di uno stato grande e popoloso come l'India non si parla di comunità poco numerose: gli Adivasi, considerati complessivamente, sono almeno 100 milioni. Ma l'efficienza
della repressione operata dal governo centrale li ha messi con le spalle al muro. La deforestazione
e il pericolo rappresentato dai guerriglieri naxaliti aggravano ulteriormente la loro condizione.
I disegni in bianco e nero di Matthieu Berthod e i testi di Eddy Simon, che ha fatto varie ricerche
sul luogo raccogliendo testimonianze dirette, descrivono in modo efficace una situazione grave che
per il momento non sembra destinata a cambiare.
Alessandro Michelucci
AA. VV., Arctic Comics, Renegade Arts, Canmore (AB), 2016, pp. 88, $17.99.
La creatività artistica degli Inuit è ormai nota anche a chi non si occupa di questioni indigene. Pensiamo alle loro sculture in basalto, serpentino e steatite; al film Atanarjuat: The Fast Runner, premiato al Festival di Cannes nel 2001; alla cantante Tanya Tagaq, capace di fondere il canto difonico
con stimoli moderni per realizzare una proposta originale di vera avanguardia. Dati questi pre-cedenti non stupisce che il loro estro creativo si manifesti anche nella nona arte. Lo dimostra Arctic
Comics, una raccolta che comprende cinque storie di vario tipo - avventurose, mitiche e umoristiche – realizzate da artisti inuit e canadesi anglofoni.
Gli autori sono ignoti in Italia, ma non in Canada e negli Stati Uniti. Michael Kusugak ha scritto
storie per bambini che sono state premiate e tradotte in varie lingue. Nicholas Burns, scrittore di
Winnipeg, firma tre storie. Fra queste spicca Blizzard House, un'avventura fantascientifica disegnata
37
da George Freeman. Ma quella che conferma la versalità degli Inuit è Kiiviuq versus Big Bee, scritta
da Jose Kusugak. Fratello di Michael, questo ha svolto un ruo-lo centrale nel processo che ha portato all'autonomia di Nunavut, la provincia canadese a maggioranza inuit. La sua storia, disegnata
da Germaine Arnaktauyok, attinge a un'antica leggenda, confermando come questo popolo sia
riuscito a confrontarsi con la modernità senza dimenticare le proprie tradizioni.
Antonella Visconti
Ethan Hawke, Greg Ruth, Indeh: A Story of the Apache Wars, Grand Central Publishing, New
York (NY) 2016, pp. 231, $25.00.
Da Robert Redford a Leonardo DiCaprio, senza dimenticare Marlon Brando, sono molti gli attori
statunitensi che hanno sposato la causa dei popoli amerindiani. Ma il primo che ha espresso questa
solidarietà attraverso il fumetto è stato Ethan Hawke. In realtà il protagonista di Gattaca aveva
scritto il soggetto per un film, ma non trovando il finanziamento necessario ha deciso di trasformarlo in un fumetto. A questo scopo ha coinvolto Greg Ruth, disegnatore noto per la collaborazione con molte case editrici, fra le quali Dark Horse Comics, DC Comics e Hyperion. Il risultato è
stato un successo editoriale immediato.
Interessato alle culture amerindiane fin da bambino, Hawke ha realizzato una storia carica di
violenza che si sposa perfettamente con la sensibilità pittorica di Ruth. "La storia [delle guerre apache] deve essere raccontata fino a quando di Geronimo e Cochise suoneranno familiari ai giovani
americani come quelli di Washington e Lincoln" scrive l'attore nella postafazione. Per ora si tratta
di un'utopia, ma la storia ci insegna che alcune utopie possono trasformarsi in realtà. Considerata
l'immagine falsa e distorta degli Indiani nordamericani che il cinema americano ha diffuso per lungo tempo, il fatto che questo ambiente sia in grado di produrre anche degli anticorpi deve essere
accolto positivamente.
Giovanna Marconi
Chiude il museo europeo dedicato all'arte aborigena
Il 15 giugno 2017 chiuderà l'Aboriginal Art Museum di Utrecht, l’unico museo europeo interamente dedicato all’arte aborigena australiana contemporanea (www.aamu.nl).
La ragione, ancora una volta, è la mancanza di fondi. Il museo, inaugurato il 3 marzo 2001, ha potuto
continuare la propria attività (due mostre all'anno) grazie a varie sovvenzioni di privati, che recentemente
sono cessate.
Fra le mostre organizzate ricordiamo Nomads in Art (2008), Theme Park (2008), Be My Guest (2011)
e Mapping Australia (2016). Quella in corso, Tracking Memories, terminerà in coincidenza con la chiusura. Ci auguriamo che questa bella esperienza possa riprendere in futuro.
38
Cineteca
Faeryland, regia, soggetto e sceneggiatura di Magà Ettori, Francia, 2015, 106’. Con Yves Duteil, Ariakina Ettori, Magà Ettori, Candice Ford.
Scritto e realizzato dal regista corso Magà Ettori, Faeryland viene proposto come il primo film di
fantascienza vegana. La definizione può sembrare bizzarra, ma è perfetta. Non soltanto per la tematica trattata, ma anche per la responsabilità ecologista che ha caratterizzato l'intera lavorazione
del film, dai tessuti utilizzati all'alimentazione degli attori. Questo spiega il sostegno che il film ha
ricevuto da molte associazioni (non soltanto vegane e vegetariane, ma anche ecologiste).
A metà fra fantasy celtica e fantascienza catastrofista, il film è ambientato in un futuro prossimo,
dove un virus minaccia di uccidere ogni forma di vita. Sotto accusa è lo sfruttamento degli animali,
che viene denunciato in tutte le sue forme. Il film adatta ai tempi la sensibilità ecologista che ha caratterizzato la storia recente della Corsica. Basti pensare all'imponente protesta popolare che si scatenò quando la Francia, avendo perduto l'Algeria, cercò di utilizzare l'isola per gli esperimenti nucleari. Oppure quando la Montedison inquinò la zona di Capo Corso con i propri scarichi tossici.
Giovanna Marconi
Jilel (The Calling of the Shell), regia di Jack Niedenthal e Suzanne Chutaro, soggetto di Jack Niedenthal, Isole Marshall, 2014, 78’. Con Tolfina Fakatou, Juko Niedenthal, Niten Anni, Netha Gideon, Naiko Jashua.
Da oltre trent'anni Jack Niedenthal, originario della Pennsylvania, vive sulle isole Marshall. Devastato dagli esperimenti nucleari americani fra il 1946 e il 1958, questo arcipelago micronesiano resta parte inabitabile in seguito alle radiazioni. Niedenthal ha fatto tutto quello che era possibile per
alleviare le sofferenze degli indigeni, alcuni dei quali continuano a ereditare malattie e disfunzioni
di vario tipo. Fra l'altro, ha gestito i fondi erogati dagli Stati Uniti per risarcire la popolazione e per
bonificare la zona. Ma non si è limitato a svolgere un lavoro amministrativo. Ha scritto un libro che
ricostruisce la tragedia di Bikini, immane ma dimenticata (For the Good of Mankind: A History of the
People of Bikini and their Islands, 2001); ha insegnato l'inglese; ha fondato una casa di produzione cinematografica e ha realizzato numerosi film in lingua marshallese.
Questo è il più recente. La protagonista è Jilel, una ragazza locale che prende coscienza del
pericolo in cui versa il suo arcipelago, dove il mare si innalza in seguito al riscaldamento globale.
39
Una favola delicata e poetica ma anche amara, dato che si tratta di un problema reale. Il film ci
stimola a ricordare che i popoli indigeni sono le prime vittime dei mutamenti climatici in corso.
Alessandro Michelucci
Minoranze e popoli indigeni sullo schermo
VIII Middle East Now
Firenze 4-9 aprile 2017
VI Asinabka Film Festival
Ottawa (Ontario/Canada) 9-13 agosto 2017
www.middleastnow.it
www.asinabkafestival.org
XXXVIII Celtic Media Festival
Douglas (Isola di Man/Gran Bretagna) 3-5 maggio 2017
XXXX Festival de cinéma de Douarnenez
Douarnenez (Bretagna/Francia) 18-26 agosto 2017
www.celticmediafestival.co.uk
www.festival-douarnenez.com
III Amazigh/Berber Film Festival
New York (Stati Uniti) 4-5 maggio 2017
1st Tribal Film Festival
Tahlequah (Oklahoma/Stati Uniti) 1-2 settembre 2017
www.lpac.nyc
www.tribalfilmfestival.com
XII Wairoa Maori Film Festival
Kahungunu Marae, Nuhaka (Nuova Zelanda) 2-5 giugno 2017
1st Faroe Islands' International Minority Film Festival
Torshavn (Faroe/Danimarca) 7-10 settembre 2017
www.facebook.com/wairoafilm
www.fimff.fo
V Origins
Londra (Gran Bretagna) 13-25 giugno 2017
II Indigenous Khoesan Film And Story Festival
Città del Capo (Sudafrica) 7-8 ottobre 2017
http://originsfestival.bordercrossings.org.uk
www.facebook.com/iffsouthafrica
XXVII Présence autochtone
Montreal (Quebec/Canada) 2-9 agosto 2017
XXXXII American Indian Film Festival
San Francisco (California/Stati Uniti) 3-11 novembre 2017
www.presenceautochtone.ca
www.aifisf.com
VI Cine Kurumin
Salvador de Bahia (Brasile) 6-19 agosto 2017
VI Babel Film Festival
Cagliari 4-9 dicembre 2017
https://cinekurumin.com
www.babelfilmfestival.com
Gli autori di questo numero
Christiane Bürger si è laureata in Storia alla Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg. Ha pubblicato Kolonialgeschichte(n). Das koloniale Namibia in der Geschichtsschreibung der DDR und BRD (Transcript Verlag, 2017).
Diego Corraine Presidente della Soziedade pro sa limba sarda e fondatore della casa editrice Papiros.
Riccardo Michelucci Giornalista e scrittore, esperto di storia e cultura irlandese. Ha pubblicato numerosi libri, fra i quali Storia del conflitto anglo-irlandese. Otto secoli di persecuzione inglese (Odoya, 2009) e il recente Bobby Sands. Un'utopia irlandese (Clichy, 2017). Cura il blog www.riccardomichelucci.it
Runoko Rashidi Storico e saggista, si concentra sullo studio delle culture africane. Autore di molti libri e
saggi, fa parte del comitato editoriale di Africology: The Journal of Pan African Studies.
Giovanna Siedina Ricercatrice di Slavistica all'Università di Verona. Ha pubblicato fra l'altro Joasaf Krokovs’kyj nella poesia latina dei suoi contemporanei (Odoya, 2012).
Maui Solomon Avvocato moriori, esperto di tutela legale dei popoli indigeni, presidente dello Hokotehi Moriori Trust.
George Steinmetz Docente di Sociologia alla University of Michigan (Ann Arbor). Esperto di questioni coloniali, ha pubblicato vari saggi e libri sul tema, fra i quali The Devil's Handwriting: Precoloniality and the
German Colonial State in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa (University of Chicago Press, 2007).
Maurizio Torretti Giornalista, esperto di culture indigene, collaboratore di varie testate.
Andrew Woolford Direttore del Dipartimento di Sociologia della University of Manitoba, studioso del genocidio, con particolare attenzione per i popoli indigeni nordamericani. Su questo tema ha pubblicato "This
Benevolent Experiment": Indigenous Boarding Schools, Genocide and Redress in North America (University of Nebraska Press - University of Manitoba Press, 2015).
Degli altri autori è stata data notizia nel numero precedente.
40