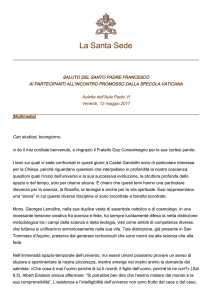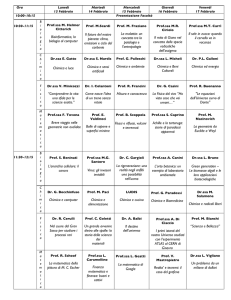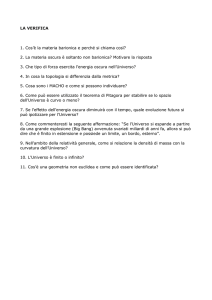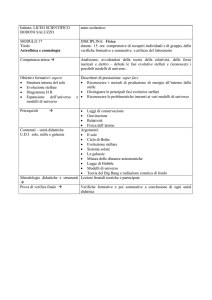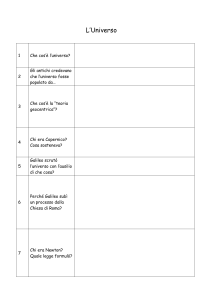Carlo Maria Martini
ORIZZONTI E LIMITI DELLA
SCIENZA
Raffaello Cortina Editore, Milano 1999
(SCIENZA E IDEE - Collana diretta da Giulio Giorello)
NOTA DI COPERTINA.
La gloria di Dio splende «non in uno, ma in soli innumerabili» e la
scienza trascorre «di mondo in mondo, di spazio in spazio» senza che
mai possa venir «imprigionata» da qualsiasi «circolo d'orizzonte», che
altro non è che «menzogna» dei sensi e «illusione» della fantasia. Così
nel 1584 Giordano Bruno, bruciato sul rogo in Campo di Fiori (Roma) il
17 febbraio 1600. A quattro secoli di distanza, mentre auspica che la
vicenda dell'«eretico di Nola» possa diventare oggetto di
«ripensamento critico» da parte della Chiesa cattolica, Carlo Maria
Martini s'interroga sui (presunti) "limiti" della scienza e sui sempre
mobili "orizzonti" della ricerca. Lo fa con l'aiuto di un cosmologo
(Francesco Bertola) e di un astrofisico (George Coyne), di un
astrobiologo (Julian Chela-Flores) e di un biologo dell'evoluzione
(Edoardo Boncinelli), di un neurofisiologo (Giuliano Avanzini) e di uno
psicobiologo (Alberto Oliverio), di un filosofo (Giulio Giorello) e di un
teologo (Bruno Forte).Abbiamo a che fare con un solo Universo o più di
uno, forse infiniti? Ci sono negli «immensi spazi» forme di vita diverse
o simili alla nostra? E' possibile separare la «mente» dal «cervello», e
delineare davvero una intelligenza «artificiale»? Come esplorare il
mistero della coscienza? E nell'epoca del trionfo della tecnologia - dalla
riproduzione del vivente alla telematica - c'è ancora posto per un
«riconoscimento del volto» dell'Altro?
Dal 1987 l'iniziativa del Cardinale Arcivescovo di Milano, Carlo Maria
Martini, battezzata provocatoriamente «Cattedra dei non credenti», si
rivolge a tutti coloro che vogliono «pensare», invitandoli a una
riflessione sulla condizione umana.
INDICE.
Preludio (Carlo Maria Martini).
1. L'UNIVERSO E IL TEMPO.
La pluralità dei mondi (Francesco Bertola).
Riciclati dalle stelle (George V. Coyne).
Dialogo (Carlo Maria Martini e Francesco Bertola).
Dialogo (Carlo Maria Martini e George V. Coyne)
2. LE ORIGINI DELLA VITA.
Gli alberi della vita (Julian Chela-Flores).
L'evoluzione del vivente (Edoardo Boncinelli).
Dialogo (Carlo Maria Martini e Julian Chela-Flores).
Dialogo (Carlo Maria Martini ed Edoardo Boncinelli).
3. INTELLIGENZA E SCIENZE COGNITIVE.
Le basi biologiche della conoscenza (Giuliano Avanzini).
Mente e cervello (Alberto Oliverio).
Dialogo (Carlo Maria Martini e Giuliano Avanzini).
Dialogo (Carlo Maria Martini e Alberto Oliverio).
4. FILOSOFIA E TEOLOGIA: ANCELLE DELLA SCIENZA?
Nelle pieghe della scienza (Giulio Giorello).
Per una eteronomia fondatrice (Bruno Forte).
Dialogo (Carlo Marta Martini e Giulio Giorello).
Dialogo (Carlo Maria Martini e Bruno Forte).
5. SCRITTURE DELL'UOMO E SCRITTURA DI DIO.
Una riflessione (Carlo Maria Martini).
PRELUDIO
(Carlo Maria Martini).
E' con particolare trepidazione che presento il tema della Decima
Cattedra dei non credenti: "Orizzonti e limiti della scienza".
Si tratta di argomenti affascinanti e invitanti, per me in gran parte nuovi.
E' possibile, però, non solo intendere le parole di illustri scienziati, ma
anche lasciarsi coinvolgere personalmente - secondo lo stile della
Cattedra - e divenire così più pensanti, cogliendo sia le dinamiche
operanti nell'Universo sia il loro riflesso sull'intelligenza che le scruta e
ne trae certezze e dubbi, sentimenti di potenza e senso del limite.
Sono domande queste che porto con me. Il lettore che abbia una
qualche conoscenza delle sessioni precedenti della Cattedra sa qual è
la caratteristica che la contraddistingue: non si tratta dell'occasione per
semplici aggiornamenti culturali o discussioni specialistiche, ma dello
stimolo per riflettere su se stessi e sul proprio cammino, con il coraggio
di mettere in questione sicurezze troppo superficiali o troppo facili; e di
far esperienza di visuali inusitate, lontane dal quotidiano, eppure
realissime, che molto fanno pensare e suscitano non pochi
interrogativi. L'intento è quello di dar voce al credente e al non credente
che sono in noi e che, mossi dalla meraviglia di fronte ai tanti misteri
dell'Universo, permettono di emergere alle domande profonde che
spesso restano silenziosamente inerti nel fondo della coscienza. Da qui
l'importanza dello stupore di fronte alla realtà in cui viviamo, del
prenderne atto con timore e trepidazione, e insieme con ammirazione.
Il volume si apre con una sezione dedicata all'"Universo e il tempo" che
comprende gli interventi di Francesco Bertola e di George V. Coyne.
Edoardo Boncinelli e Julian Chela-Flores ci condurranno nella seconda
sezione alle "Origini della vita", mentre Giuliano Avanzini e Alberto
Oliverio ci inviteranno nella terza a riflettere su "Intelligenza e scienze
cognitive". La quarta sezione, grazie ai contributi di Giulio Giorello e di
Bruno Forte, dovrà farci compiere un passo verso una riflessione di
tipo sintetico, offrendo stimoli di riflessione a partire non più
dall'esperienza diretta degli uomini di scienza, ma da una visuale dei
problemi «dall'alto». Sotto il titolo "Filosofia e teologia: ancelle della
scienza?" viene, infatti, esplorato il rapporto tra i diversi modi di sapere
e di conoscere - tra scienza, filosofia e teologia.
Mi sono riservato la quinta sezione per un ultimo intervento, in modo da
poter ripercorrere l'itinerario compiuto e contribuire a una sintesi
riflettendo su "Scritture dell'uomo e Scrittura di Dio", non certo per
imporre risposte preconfezionate - non sarebbero nello stile della
Cattedra - bensì per indicare vie lungo cui proseguire il cammino
dell'approfondimento. Nelle sezioni precedenti il mio ruolo è solo quello
di chi «si pone in ascolto» per poi proporre ai vari autori, in forma di
domande, le suggestioni e le risonanze che il fascino della materia
trattata possono suscitare in ognuno di noi.
Desidero rivolgere, infine, un vivo ringraziamento a Giulio Giorello
perché è stato il primo a cui, quasi due anni fa, ho comunicato l'ipotesi
di una Cattedra sulla scienza, trovando comprensione, sostegno e
ricevendo utili suggerimenti. Un grazie vivissimo anche a Elio Sindoni
che insieme con Giorello ha curato l'organizzazione, la struttura e
l'inserimento dei temi. A entrambi si deve pure la designazione dei
relatori.
AVVERTENZA DEI CURATORI.
Il presente volume contiene gli interventi della Decima Cattedra dei non
credenti promossa dal Cardinale Arcivescovo di Milano Carlo Maria
Martini sul tema «Orizzonti e limiti della scienza». Gli incontri si sono
svolti nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano nei giorni 29
ottobre, 5, 12, 19 e 26 novembre 1998. Si è mantenuta la scansione degli
argomenti e degli interventi.
I curatori desiderano ringraziare per la fattiva collaborazione il
Magnifico Rettore, il personale docente e non docente dell'Università
degli Studi, nonché tutti coloro che hanno assistito agli incontri, alcuni
dei quali hanno contribuito con lettere indirizzate a sua Eminenza a
offrire spunti di riflessione di cui si è tenuto conto nella stesura finale.
Un grazie particolare per la collaborazione e l'aiuto viene, infine, rivolto
a Marcello D'Agostino, Michele Di Francesco, Marco Motto, Fabrizio
Palombi, Roberto Spreafico.
E.S. C.S.
1.
L'UNIVERSO E IL TEMPO.
LA PLURALITA' DEI MONDI
(Francesco Bertola).
L'immagine del mondo secondo la Bibbia riprende la concezione
babilonese della Terra piatta. Questa non solo è di dimensioni finite
perché «il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità fino
all'altra» della Terra (Dt 28, 64), ma anche di forma quadrangolare visto
che:
"Egli alzerà un vessillo per le nazioni
e raccoglierà i cacciati di Israele,
radunerà i dispersi di Giuda
dai quattro angoli della Terra". (Is 11,12)
Si potrebbero ricordare qui le varie tesi dei Padri della Chiesa, da chi
cercava con grande sforzo di riconciliare le Scritture con la filosofia
greca, come per esempio Ambrogio (354-430), vescovo di Milano, che
affermava che una casa può essere sferica all'interno e quadrata vista
dall'esterno, a chi considerava il modello biblico come un'allegoria, e
infine a chi accettava questo modello come vero. Uno dei punti più
discussi era, senza dubbio, quello della presenza degli «antipodi» nel
caso di una Terra sferica. Come potevano esserci luoghi abitati da
uomini con i piedi sopra la testa? Come potevano esserci regioni in cui
la pioggia e la grandine, anziché cadere, «salgono» verso l'alto?
Interrogativi del genere sono sollevati, per esempio, da Lattanzio (ca
250-310) che nei suoi scritti certo non cela la sua ostilità per la cultura
greca ed ellenistica.
Invece di limitarsi a criticare i sostenitori della sfericità della Terra, chi
tenta addirittura di proporre una nuova cosmologia, basata su
un'interpretazione fin troppo letterale dei testi Sacri, è Cosma
Indicopleuste, un monaco vissuto nel sesto secolo d.C. Nella sua
imponente "Topographia Christiana", ispirata alle idee dei Padri della
Chiesa che lo avevano preceduto, ci offre una descrizione fantastica
dell'Universo concepito come un tabernacolo, analogo a quello
costruito da Mosè nel deserto.
Verso la fine del primo millennio dell'era cristiana sale al soglio di
Pietro Gerberto di Aurillac (930-1003), con il nome di Silvestro Secondo:
eminente studioso, autore di un trattato di geometria e di uno sull'uso
dell'astrolabio, pone simbolicamente fine all'era dell'Universo
tabernacolare e segna l'inizio di una pressoché generale accettazione,
tra le persone colte almeno, del sistema codificato circa ottocento anni
prima da Claudio Tolomeo (ca 100-170 d.C.), con le "sfere" del Sole,
della Luna, dei pianeti e delle stelle fisse.
Si compie così sul finire del primo millennio dell'era cristiana una
profonda rivoluzione in campo cosmologico: dall'Universo di
ispirazione biblica si torna a quello di ispirazione greca, ovvero
dall'Universo a tabernacolo si passa a quello delle sfere cristalline. E
tutto ciò avviene senza particolare turbamento da parte della Chiesa,
anzi questa rivoluzione ha luogo all'"interno" della Chiesa stessa, che
era l'interprete della cultura del tempo.
Una volta ripreso il geostaticismo tolemaico, si trattava di adattare il
sistema alla visione religiosa propria del cristianesimo. La distinzione
aristotelica tra l'incorruttibile mondo celeste "sopralunare" e il caduco
mondo "sublunare" ben si confaceva, in quanto nel primo era
ragionevole collocare la divinità mentre il secondo appariva appropriato
all'uomo, soggetto al peccato. Di contro, è l'idea dell'eternità del mondo
- cara ad Aristotele (384-322 a.C.) - che viene lasciata cadere per far
posto a un Universo con un'età finita, come appunto richiede la Bibbia,
secondo cui la creazione da parte di Dio avrebbe dato inizio a tutto.
Infine, proprio per enfatizzare maggiormente la trascendenza del
Creatore e il suo controllo sull'intera «fabbrica dei cieli», il sistema
tolemaico viene ritoccato in modo che, oltre al Primo Mobile, venga
introdotto un decimo cielo, l'Empireo, un cielo di fuoco celeste, dove
trova posto il trono di Dio. Le sfere planetarie si popolano di angeli, e
ciascuna è abitata da esseri con grado di beatitudine sempre più
elevato man Ma mentre Dante celebra nella sua alta poesia il sistema
che potremmo chiamare "tolemaico-cristiano", cominciano a sorgere i
primi dubbi sulla validità di una simile costruzione che ospita oltre alla
Terra, alle stelle e ai pianeti la stessa divinità. Le prime perplessità
vengono dai teologi, che trovano non del tutto proprio che a Dio venga
assegnato il decimo cielo: Dio non "può" essere ovunque, cioè in
"ogni" luogo? L'assegnazione dell'Empireo non finisce per essere
troppo limitativa? Ma quel sistema così magistralmente cantato nei
versi danteschi vacilla non solo per le considerazioni teologiche circa
onnipresenza e onnipotenza divine: sono gli astronomi a rendersi conto
che per «salvare i fenomeni» il sistema solo apparentemente
geocentrico ricorre ad artifici come epicicli, eccentrici ed equanti (vedi
figure 2, 3, 4).
Comincia quella lenta erosione della concezione «aristotelicotolemaica» che due secoli più tardi porterà al cambiamento del sistema
del mondo operato da Copernico, la celebre «rivoluzione copernicana».
In realtà, nonostante la sua grande idea che il Sole occupi (più o meno)
il centro del mondo e la Terra sia solo uno dei pianeti, Niccolò
Copernico (1473-1543) resta uomo legato alla concezione medioevale
dell'Universo. Crede ancora all'esistenza delle sfere cristalline
("orbes"), come è indicato dal titolo stesso della sua opera maggiore
("De Revolutionibus Orbium Coelestium", 1543), e nella sfericità
dell'Universo «perché questa forma è la più perfetta di tutte». E'
convinto che i moti dell'Universo siano circolari uniformi come si
conviene alla sua natura eterna. Ritiene l'Universo finito, racchiuso
entro la volta delle stelle fisse.
Quando parliamo di «rivoluzione copernicana» dovremmo distinguere
sempre
due
aspetti,
uno
scientifico
e
uno
ideologico.
"Scientificamente" l'opera di Copernico è ricca di novità, ma al tempo
stesso ha profondi legami con il passato. Da un punto di vista
strettamente astronomico, lo scambio di due corpi celesti (Terra e Sole)
al fine di render meglio conto dei fenomeni osservati non è poi così
traumatico. Lo diventa, però, sul piano "ideologico", poiché uno di
questi due corpi celesti, la Terra, è quello abitato da noi. L'operazione
compiuta da Copernico toglie all'uomo la sua centralità nell'Universo, e
mette in discussione le Sacre Scritture sulla rilevanza cosmica degli
esseri umani. E mentre per la Chiesa, depositaria delle Scritture, era
stato abbastanza facile accettare il passaggio dall'Universo babilonese,
con la Terra piatta, all'Universo tolemaico, in quanto la centralità umana
non veniva toccata, la reazione al sistema copernicano non poteva che
essere drammatica.
Figura emblematica di questo travaglio è Galileo Galilei (1564-1642),
tenace assertore della «opinione di Copernico». Con le sue scoperte
astronomiche, dovute all'utilizzo del cannocchiale da lui messo a punto
a Padova nel 1609, Galileo ritiene di poter inferire un duro colpo alla
concezione aristotelica del mondo e al contempo di portare argomenti
in favore di Copernico. La scoperta della rugosità della superficie
lunare rivela che il satellite della Terra non è una perfetta, liscia sfera di
etere. I satelliti di Giove mostrano che nell'Universo c'è un altro centro
del moto oltre a quello tolemaico costituito dalla Terra. Le fasi di Venere
ben si spiegano se il pianeta ruota attorno al Sole (vedi figura 5).
La perorazione di Galileo in favore del sistema copernicano troverà
piena espressione nel "Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo", apparso nel febbraio del 1632 e già sequestrato dalle autorità
nel luglio dello stesso anno. Per quest'opera Galileo verrà processato,
condannato e costretto all'abiura nel 1633. La vicenda è ben nota.
Meno conosciuta è, forse, la storia di chi, tra i protagonisti della
rivoluzione copernicana, per primo infranse la barriera delle stelle fisse,
considerandole come oggetti non tutti alla medesima distanza, ma
uniformemente distribuiti nello spazio: Thomas Digges (ca 1546-1595),
matematico e astronomo inglese che aveva appreso i rudimenti di
queste discipline dal padre Leonard Digges of Wotten (ca 1520-1559),
nonché dal matematico-mago John Dee (1527-1608), ammiratore
anch'egli del sistema copernicano. Leonard Digges era stato coinvolto
nella ribellione di Sir Thomas Wyatt (1554); catturato e condannato a
morte, era stato graziato per intercessione del suo protettore lord
Clinton, poi conte di Lincoln - e a lui aveva dedicato la prima versione
del suo almanacco di matematica pratica, dal titolo "A Prognostication
Everlasting" (1555). Se il padre dava prova di notevoli capacità nelle
tecniche matematiche utili a naviganti e artiglieri, il figlio, pur attento ai
problemi suggeriti da nautica, tecnica delle fortificazioni e balistica, non
disdegnava la frequentazione della geometria platonica dei cinque
poliedri regolari; nel 1573 aveva pubblicato un "Alae seu Scalae
Mathematicae" che conteneva osservazioni della «nuova stella» del
1572 giudicate all'epoca inferiori in precisione solo a quelle di Tyge
(Tycho) Brahe (1546-1601) in persona. Già in quell'occasione Thomas
aveva proposto di sfruttare le «novità celesti», ossia le più recenti
osservazioni, per rivedere e aggiornare la cosmologia copernicana. Nel
1576 doveva aggiungere a una nuova edizione della "Prognostication"
del padre un supplemento intitolato "A Perfit Description of the
Caelestiall Orbes", che conteneva peraltro una parafrasi, per molti versi
fedele, del libro primo del "De Revolutionibus" di Copernico e che
divenne una delle opere scientifiche più popolari nell'Inghilterra
dell'epoca, tanto che se ne conoscono almeno sette edizioni dal 1576 al
1605. Più di ogni sua affermazione, è un'immagine (vedi figura 6) a
evidenziare la visione dell'Universo di Thomas Digges: si tratta
dell'illustrazione del sistema copernicano, con il Sole al centro e i
pianeti che gli ruotano intorno, in cui però viene rimossa la sfera delle
fisse e le stelle risultano distribuite fino agli angoli della pagina, a
indicare che non sono tutte alla stessa distanza dal Sole, ma sparse
nello spazio infinito. Una concezione rivoluzionaria che ci porta
dall'Universo medioevale e copernicano finito a un Universo infinito e
uniformemente popolato di stelle! Riemerge così l'idea di un Universo
infinito, assai apprezzata da quei filosofi dell'Islam che non accettavano
la dimostrazione aristotelica dell'impossibilità del vuoto. Costoro
solevano incorporare «come un seme» la fabbrica dei cieli aristotelicotolemaica entro uno spazio infinito ma privo di materia, eventuale
dimora di Dio e dei suoi angeli. Una raffigurazione, questa, destinata a
diffondersi anche nell'Europa cristiana, dalla fine del tredicesimo
secolo in poi, in quanto sembrava aggirare il conflitto tra il Mondo
chiuso di Aristotele e l'infinita potenza del Creatore che meglio si
sarebbe manifestata in una creazione "infinita" (vedi del resto quanto
osservato in T. Kuhn, "La rivoluzione copernicana", trad. it. Einaudi,
Torino 1972, p.p. 297-298).
A distanza di appena trent'anni dalla pubblicazione del "De
Revolutionibus" si compie dunque un'altra rivoluzione, che apre la
strada alle moderne concezioni dell'Universo. Il pensiero di Thomas
Digges è tuttavia ancora impregnato di teologismo: egli non riesce a
delineare una rappresentazione puramente astronomica del sistema del
mondo, preoccupato com'è di trovare un posto in cui collocare la
divinità. E così, mentre nei sistemi precedenti tutto quello che è
teologico è posto nell'Empireo, oltre la sfera delle fisse, per Digges è
«l'orbe delle stelle fisse infinitamente eccelso [che] si estende
sfericamente in altezza» a costituire lo spazio teologico, «la vera corte
degli angeli celesti; priva di dolore; colma di assoluta ed eterna gioia;
dimora degli eletti».
Ma le ambiguità della rappresentazione di Digges sono oltrepassate
nella grandiosa visione dell'Universo di Giordano Bruno (1548-1600).
Durante il suo continuo peregrinare da una città all'altra dell'Europa,
Bruno soggiornò a Londra dal 1583 al 1585 e certamente ebbe modo di
conoscere l'opera di Digges. Tuttavia, la vastità e l'audacia del suo
pensiero sono tali che egli può a buon diritto essere considerato uno
dei «padri fondatori» della cosmologia moderna. Entusiasta del sistema
copernicano (vedi figura 7), profondamente influenzato dalla lettura del
"De Rerum Natura" di Lucrezio (ca 98-54 a.C.) dove si sostiene tra l'altro
la pluralità dei mondi abitati (in particolare, nel libro primo si dichiara
come l'Universo non abbia centro, v.v. 1052-1113; e nel libro secondo si
argomenta a favore della infinità dei mondi, v.v. 1023-1047, ipotizzando
che nello spazio si trovino anche pianeti abitati da varie stirpi di
«uomini» e specie animali), Bruno fece propria anche la lezione di
Nicola Cusano (1401-1464), autore del "De Docta Ignorantia" (1440), cui
si deve la celebre tesi per cui l'Universo «ha il centro dappertutto e la
circonferenza in nessun luogo» ("De Docta Ignorantia", II, 12).
Ecco un esempio di come l'intuizione cusaniana viene sottoposta a
tensione nell'argomentazione bruniana: «ditemi: che cosa è più
dissimile alla linea retta, che il circolo? che cosa è più contrario al retto
che il curvo? Pure nel principio e minimo concordano, atteso che (come
divinamente notò il Cusano [nel "De Mathematica Perfectione"],
inventor di più bei secreti di geometria) qual differenza trovarai tra il
minimo arco e la minima corda? Oltre, nel massimo, che differenza
trovarai tra il circolo infinito e la linea retta? Non vedete come il circolo,
quanto è più grande, tanto più con il suo arco si va approssimando alla
rettitudine? Chi è sí cieco, che non veda qualmente l'arco BB, per esser
più grande che l'arco AA, e l'arco CC più grande che l'arco BB, e l'arco
DD più che gli altri tre, riguardano ad esser parte di maggior circolo; e
con questo più e più avicinarsi alla rettitudine della linea infinita del
circolo infinito, significata per IK? Quivi certamente bisogna dire e
credere che, sí come quella linea che è più grande, secondo la raggione
di maggior grandezza, è anco più retta; similmente la massima di tutte
deve essere in superlativo più di tutte retta; tanto che al fine la linea
retta infinita venga ad esser circolo infinito. Ecco dunque come non
solamente il massimo e il minimo convengono in uno essere, come
altre volte abbiamo dimostrato, ma ancora nel massimo e nel minimo
vegnono ad essere uno e indifferente gli contrari» (G. Bruno, "De la
causa, principio e uno", in "Dialoghi italiani", nuovamente ristampati
con note di G. Gentile, terza edizione a cura di G. Aquilecchia, Sansoni,
Firenze 1958, p.p. 335-336) (vedi figura 8).
Un passo come questo mostra bene come in Bruno si intreccino
intuizioni matematiche di larga portata, metafore geometriche, temi
tratti dall'atomismo antico e l'immagine cusaniana della "coincidentia
oppositorum". Col fanatismo di un rivoluzionario, pieno di «eroico
furore», Bruno si spinge a sostenere che il Sistema solare non è l'unico
sistema planetario, ma che l'Universo è costituito da «innumerevoli»
sistemi solari uniformemente distribuiti nello spazio infinito - negando
così non solo ogni geocentrismo, ma anche l'eliocentrismo. E, come se
ciò non bastasse, spazza via anche ogni concetto antropocentrico,
supponendo che gli infiniti mondi siano popolati da esseri viventi.
Ho delineato fin qui, naturalmente per sommi capi, due svolte cruciali in
quella che potremmo chiamare, almeno in senso lato, cosmologia.
L'abbandono della Terra piatta e lo sfondamento di ogni barriera
celeste, così evidente nell'enfasi di Bruno, hanno avuto incidenza
diversa nei rapporti tra scienza e religione. Vi è, però, almeno una terza
svolta di cui vorrei trattare, dando naturalmente per scontato il
cammino che la scienza ha compiuto dai tempi di Galileo a quelli di
Einstein passando attraverso la mirabile sintesi di fisica terrestre e
celeste operata nei "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica"
(1687) di Isaac Newton (1642-1727). Alludo alla transizione da un
Universo "statico" a uno "dinamico", in evoluzione. La figura chiave è
quella dell'astronomo statunitense Edwin Powell Hubble (1889-1953).
All'epoca del suo dottorato si era interessato delle chiazze luminescenti
nel cielo notturno, che abitualmente chiamiamo «nebulose», giungendo
alla conclusione che mentre alcune di esse non erano che nubi di gas
all'interno della nostra Galassia, altre erano oggetti più lontani, esterni
al nostro "sistema stellare". Nel 1610 Galileo, invocando la «virtù del
cannocchiale», aveva «dichiarato» che la Via Lattea (cioè la nostra
Galassia), quel «candore latteo come di nube albeggiante», era
«nient'altro che una congerie di innumerevoli stelle, disseminate a
mucchi ("Opere", III/l, p. 78) - e aveva sostenuto che ciò vale per altre
nebulose. All'inizio degli anni Venti del Novecento, servendosi del
nuovo telescopio che aveva a disposizione a Mount Wilson (California),
Hubble giunse alla conclusione che anche la «nebulosa» di Andromeda
era un sistema stellare analogo alla Via Lattea. Inoltre, riuscì a
identificare varie stelle della "galassia di Andromeda" come "variabili
cefeidi" (stelle la cui luce varia in modo regolare, con un rapporto
preciso tra periodo e luminosità media, sicché la misurazione del
periodo ne rivela lo splendore "intrinseco", in modo che la misurazione
della loro magnitudine "apparente" consente di calcolarne la
"distanza"). Fra il 1925 e il 1929 Hubble scoprì che le cosiddette
«nebulose spirali» sono altrettante galassie (dunque, la nostra Via
Lattea è solo una delle molte galassie spirali nell'Universo). E nel 1929
fu proprio Hubble a formulare la legge che reca il suo nome secondo
cui la velocità di recessione (indicata dallo spostamento delle righe
spettrali verso il rosso) di una galassia lontana è direttamente
proporzionale alla sua "distanza" da noi. Tale legge, dunque, indicava
che l'Universo stava attraversando la fase di espansione predetta dai
modelli relativistici dinamici. L'idea era già implicita nelle equazioni
della relatività generale (1915), ma lo stesso Albert Einstein (1879-1955)
si era mostrato reticente ad accettarla, preferendole un modello di
universo ancora «statico». Nel 1922 il sovietico Aleksandr Fridman
(1888-1925), che pare alternasse alla militanza in campo bolscevico lo
studio delle concezioni einsteiniane, aveva trovato delle soluzioni alle
equazioni di Einstein, cioè dei modelli cosmologici, in cui l'Universo si
espandeva. Più precisamente, se si concepiva al modo della relatività
generale lo spazio-tempo dell'Universo come curvo (così come è una
bolla di sapone), i calcoli di Fridman mostravano che la curvatura
poteva cambiare nel corso del tempo. In alcuni dei suoi modelli la
«bolla» si espande indefinitamente, in altri fino a una certa soglia dopo
la quale, per così dire, «ricade» su se stessa, quando la gravità ha la
meglio sull'espansione. Insomma, tutti questi modelli di Fridman
contemplano comunque una fase in cui il nostro Universo si espande in
modo tale da produrre una velocità di recessione proporzionale alla
distanza - il che è appunto la legge trovata da Hubble e dai suoi colleghi
(probabilmente non al corrente dei risultati di Fridman) studiando gli
spostamenti verso il rosso della luce delle galassie "qualche anno
dopo". (Per il complesso rapporto tra Einstein e Fridman vedi A. Pais,
"«Sottile è il Signore...». La scienza e la vita di Albert Einstein", trad. it.
Bollati Boringhieri, Torino 1991, in particolare p.p. 287-289 e p.p. 310311).
Ancora oggi sono in discussione, con sorti alterne, le due possibilità
che Fridman aveva intravisto per l'Universo espandersi indefinitamente
o collassare su se stesso dopo l'arresto dell'espansione. Resta aperta,
inoltre, la questione dell'"origine". Da un punto di vista strettamente
matematico l'Universo sarebbe nato in un preciso momento, il "tempo
zero" ossia il tempo del Big Bang, e non avrebbe senso chiedersi cosa
c'era prima, poiché spazio e tempo cominciano a «esistere» da
quell'«istante». Negli anni Cinquanta tutto ciò fu letto come una
conferma della dottrina biblica della creazione e della possibilità di
trarre dai risultati scientifici argomenti a favore dell'esistenza di un Dio
creatore. Ma la descrizione matematica non basta, in quanto non
possiamo estrapolare da essa alla conoscenza della «realtà» fisica.
Considerando infatti i fenomeni fisici che avvengono durante
l'evoluzione dell'Universo, quando si cerca di dare una descrizione a
ritroso nel tempo, ci si trova di fronte a una barriera, situata a una
distanza incredibilmente piccola dall'inizio matematico, 10-43 secondi.
Oggi ci mancano le leggi fisiche per descrivere ciò che è avvenuto oltre
quel tempo (detto "tempo di Planck"). Nella cosmologia quantistica,
cioè in quella cosmologia che studia la fase iniziale dell'Universo,
quando meccanica quantistica e relatività generale dovevano essere
unificate, lo stato originale dell'Universo non è necessariamente un
punto, non è la "singolarità" iniziale «classica» ove la densità della
materia è infinita, come si pensava qualche decennio fa. L'origine
potrebbe essere dislocata addirittura a un tempo infinito nel passato, o
ci potrebbe persino essere una mancanza di origine, come
nell'Universo autocontenuto di Stephen Hawking (vedi, per esempio, il
suo "Dal Big Bang ai buchi neri. Breve storia del tempo", trad. it.
Rizzoli, Milano 1988, in particolare p.p. 156-165).
La caratteristica più saliente del nostro Universo è, dunque, quella di
essere in continua evoluzione, evoluzione che la cosmologia
contemporanea è in grado di descrivere dagli istanti «prossimi» al Big
Bang fin quasi agli scenari terminali. Questo è dovuto al fatto che
all'origine le condizioni del nostro Universo erano semplici e non
caotiche, come ci è rivelato dalla uniformità della radiazione di fondo
che oggi osserviamo (si tratta della radiazione residua dello splendore
del caldissimo Universo primordiale, oggi talmente spostata verso il
rosso che non ci appare più sotto forma di luce, ma di microonde, cioè
di onde radio della lunghezza di alcuni centimetri. La scoperta di tale
radiazione «fossile» risale al 1965 ed è dovuta ad Arno Allan Penzias e
Robert Wilson che ricevettero per questo il Nobel nel 1978. Le loro
ricerche non erano minimamente indirizzate a cercare «conferme» del
modello del Big Bang - e furono Robert Dicke e i suoi colleghi della
Princeton University a interpretare quella radiazione come l'eco del
«grande scoppio»). Il modo in cui evolve l'Universo è così determinato
da una serie di dipendenze e parametri come le condizioni presenti
all'inizio, la forma delle leggi fisiche e il valore delle costanti
fondamentali della natura. Ebbene, studiando le trasformazioni
dell'Universo è emersa l'idea della «perfetta sintonia». Ci si è resi conto,
cioè, che per poter avere proprio l'Universo in cui viviamo le condizioni
iniziali la forma delle leggi fisiche e il valore delle costanti fondamentali
devono essere in una perfetta sintonia tra loro, nel senso che anche un
sia pur minimo scostamento dalla loro forma e dai loro valori avrebbe
portato a un universo completamente diverso dal nostro.
Esempi di perfetta sintonia ("fine tuning") se ne possono dare a decine,
per cui alla fine si arriva alla conclusione che il nostro Universo è
dovuto a un'unica, precisa, ben determinata combinazione. Ma esso ha
una particolarità che non è per nulla da sottovalutare. Nel nostro
Universo, in particolare sulla Terra, è presente la vita, anche vita
intelligente, anche un tipo di vivente capace di osservare il cosmo e
interrogarsi su di esso. Un universo minimamente differente dal nostro,
senza stelle e pianeti, non contemplerebbe la nostra presenza. Perché
la vita, così come noi la conosciamo, apparisse, c'era bisogno di un
universo grande, esteso e in espansione proprio come il nostro.
Da tale punto di vista, quell'angoscia che secondo molti ci assalirebbe
quando constatiamo di essere piccoli grani di sabbia nell'immensità
dello spazio, non ha ragione d'essere, perché la nostra esistenza esige
questa immensità. Un universo di dimensioni diverse sarebbe
incompatibile con la nostra esistenza. L'insieme di queste
considerazioni, che altro non sono che una constatazione che le cose
sono in questo modo e non altrimenti, prende il nome di «principio
antropico» nella formulazione «debole». In quella detta «forte» si va
oltre, in quanto si sostiene un condizionamento nei parametri
dell'Universo al fine di rendere possibile la presenza dell'uomo: un
Universo "sintonizzato" per l'apparizione dell'"Homo sapiens"!
Ora, l'affermazione del sistema copernicano ci ha condotto alla
formulazione di un «principio copernicano» che nega in generale
qualsiasi centralità. Ma, con il modo di ragionare «antropico», non si
assiste a un ritorno della centralità perduta, basata non più su una
semplice proprietà geometrica, bensì su un processo evolutivo che
sembra essere l'unico in grado di produrre la nostra presenza? Il
principio antropico non potrebbe indurre a domande che esulano
dall'ambito strettamente scientifico? Anche per evitare tali
sconfinamenti, è stata recentemente proposta la concezione degli
infiniti universi per cui il "nostro Universo" sarebbe meramente
accidentale.
L'idea che possano esistere molti o addirittura infiniti universi allarga
enormemente la nostra prospettiva cosmica, e se un giorno quella che
è attualmente solo una pura speculazione troverà qualche riscontro,
saremo di fronte a un ampliamento di orizzonti paragonabile appunto a
quello che alla fine del Cinquecento portò dalla concezione aristotelica
del Mondo "chiuso" entro la sfera delle stelle fisse a quella di un
Universo "infinito" propugnata da Giordano Bruno. L'insieme dei
molteplici universi viene indicato con il termine di «Multiverso», usato
in contrapposizione a «Universo», che indicherebbe così una
particolare sottocomponente, come è, per esempio, quella in cui noi
viviamo. L'idea di innumerevoli universi non è nuova; ma il tratto
caratteristico della concezione attuale è la sua natura scientifica, basata
sulle fluttuazioni quantistiche del vuoto.
Con i molti, anzi infiniti universi si ritorna a un modello di tipo
stazionario di durata eterna, entro cui nascono, si sviluppano e
muoiono gli universi (un po' su larga scala come capita in piccola scala
per noi «nei più comuni Accidenti della Vita», come già diceva Thomas
Wright of Durham (1711-1786) vedi M. Rees, "Prima dell'inizio. Il nostro
universo e gli altri", trad. it. Cortina, Milano 1998, p. 261).
Un'ultima considerazione viene suggerita dalla storia delle idee. La
concezione dei molti universi è rintracciabile già negli atomisti antichi,
Leucippo (seconda metà del quinto secolo a.C.) e Democrito (ca 460370 a.C.). Diogene Laerzio nelle "Vite dei filosofi" attesta che «Leucippo
sostiene che il tutto è infinito ed è in parte "pieno" in parte "vuoto" [...].
Da questi si formano mondi infiniti e in essi si risolvono» (Libro nono,
30, trad. it. di M. Gigante, Laterza, Bari 1962, p. 437). Quanto a
Democrito, come riporta Ippolito nella "Confutazione di tutte le eresie",
«si esprime come Leucippo riguardo agli elementi, che sono il pieno e il
vuoto, ritenendo come essere il pieno, non essere il vuoto; per lui, le
sostanze sono in eterno movimento nel vuoto. I mondi sono infiniti e
sono differenti per grandezza: in taluni non vi è né Sole né Luna, in altri
invece sono più grandi che nel nostro mondo, in altri ancora ci sono più
soli e più lune. Le distanze tra i mondi sono disuguali, sicché in una
parte ci sono più mondi, in un'altra meno, alcuni sono in via di
accrescimento, altri al culmine del loro sviluppo, altri ancora in via di
disfacimento, e in una parte nascono mondi, in un'altra ne scompaiono.
La distruzione di un mondo avviene per opera di un altro che si abbatte
su di esso. Alcuni mondi sono privi di esseri viventi e di piante e di ogni
umidità» ("I Presocratici", Laterza, Bari 1969, vol. 2, p. 685). Peraltro
Epicuro (ca 341-271 a.C.) nell'"Epistola a Erodoto" scrive: «E ancora, i
mondi sono infiniti, sia quelli simili al nostro, sia quelli dal nostro
dissimili. Perché gli atomi, che abbiamo testé dimostrato essere infiniti,
percorrono anche i più lontani spazi. E in verità quelli opportuni a dare
origine a un mondo o a costituirlo, non possono essere esauriti né da
un solo mondo, né da un numero finito di mondi, né da quanti mondi
sono simili, né da quanti sono a essi diversi. Nulla dunque s'opporrà a
che i mondi siano infiniti» (trad. it. di E. Bignone in "Opere, frammenti e
testimonianze", Laterza, Roma-Bari 1986, p. 46).
E comunque in pieno Medioevo cristiano non si opposero le grandi
autorità della teologia. Mentre la tendenza prevalente dei filosofi era
quella di considerare l'Universo come unico, sotto l'influenza di
Aristotele nel cui sistema non c'era spazio per altri mondi, nel 1277 il
vescovo di Parigi Etienne Tempier condannava 219 proposizioni
filosofiche che non dovevano essere insegnate sotto pena di
scomunica, tra cui la numero 34 «Quod prima causa non posset plures
mundos facere». Sebbene con la condanna di Tempier si volesse
soprattutto sostenere che non c'è limitazione alla potenza di Dio, essa
finì forse con l'aprire le menti all'idea che l'esistenza di innumerevoli
mondi sia "in principio" possibile. Anzi, per il celebre fisico,
epistemologo e storico della scienza Pierre Duhem (1861-1916)
risalirebbe paradossalmente a questa condanna l'origine della scienza
moderna (P. Duhem, "Le Système du Monde", 10 voll., Hermann, Paris
1914, 1958, in particolare vol. 6, p. 66; vedi anche S. J. Dick, "Plurality of
Worlds", Cambridge University Press, Cambridge 1982, p. 28 e p.p. 195-
196; ma per una valutazione critica di questa tesi di Duhem si veda la
ricostruzione di L. Bianchi, "Il Vescovo e i filosofi", Lubrina, Bergamo
1990). Pertanto, anche quella che è (finora) l'ultima proposta della
cosmologia contemporanea non va scartata "a priori", ma vagliata con
la dovuta attenzione.
In conclusione mi auguro che, alla luce dei punti di contatto tra ricerca
scientifica e speculazione teologica, si possa evitare quello che
chiamerei l'«abuso della cosmologia». Abuso da parte degli uomini di
scienza, che troppo spesso e a sproposito, soprattutto nei loro scritti
divulgativi, ricorrono a parole come «Dio» e «creazione»; ma anche
abuso da parte di chi pensa di trovare nella cosmologia una risposta a
problemi che non le sono propri. Un percorso parallelo tra scienza e
teologia, con una costante attenzione di quest'ultima agli aspetti
mutevoli della prima, è quello che produrrà i frutti migliori.
RICICLATI DALLE STELLE
(George V. Coyne).
Anche per l'Universo si può parlare di evoluzione. Cosa sappiamo
dell'origine e della storia dell'universo fisico, inteso come la matrice da
cui è nata e si è sviluppata la vita? La cosmologia contemporanea ci
insegna che nella prima generazione di stelle ebbe luogo la sintesi degli
elementi che compongono la Terra e i pianeti a essa simili: questi,
infatti, data la loro composizione chimica, non si sarebbero potuti
formare nei primi stadi dell'evoluzione dell'Universo, quando vi erano
solo idrogeno ed elio. Il Sole, che esiste già da quasi cinque miliardi di
anni, continuerà a brillare per altri cinque miliardi, durante i quali fornirà
costantemente l'energia che si libera nella fusione dell'idrogeno in elio.
Alla fine, quando l'idrogeno sarà esaurito, il Sole si trasformerà in una
stella gigante rossa che invaderà gran parte del Sistema solare. Ma
l'Universo continuerà a espandersi e raffreddarsi indefinitamente o
cesserà di espandersi per dare inizio al processo inverso di contrazione
e di riscaldamento (vedi "questo volume", p.p. 20-21)? Per quanto oggi
ne sappiamo, possiamo solo dire che le condizioni dell'Universo
sembrano abbastanza vicine a entrambe le alternative, ma non siamo
ancora in grado di dire quale si realizzerà.
Tale quadro costituisce oggi un'acquisizione conoscitiva ben
consolidata, grazie alla convergenza delle conquiste della cosmologia,
sia teorica sia osservativa, con quelle della fisica delle particelle e delle
alte energie. L'evoluzione è un tratto caratteristico dell'Universo da cui
non possiamo prescindere se miriamo a una spiegazione sia del suo
insieme, sia delle sue parti.
Ora, di fronte all'età dell'Universo, la comparsa della vita sulla Terra
appare evento relativamente recente. In questi ultimi anni è
enormemente cresciuto l'interesse per questa domanda: c'è vita
«altrove»? In modo particolare, dopo l'annuncio di una probabile
scoperta di materiale organico su una meteorite appartenuta una volta
al pianeta Marte. Tuttavia, quel che veramente deve sorprenderci non è
tanto scoprire che la vita si trovi nell'Universo anche fuori della Terra,
quanto che "nell'Universo vi sia vita". Ci sono voluti dodici miliardi di
anni perché nell'evoluzione dell'Universo in espansione si realizzassero
le condizioni necessarie a che la vita potesse cominciare a essere. Tali
condizioni, in questa lunga evoluzione, non avrebbero potuto attuarsi
senza l'incessante concorso di circostanze fisiche particolari ritenute
indispensabili per l'esistenza stessa della vita. Davanti a ciò possiamo
ragionare in due modi: la vita non ha altro significato che di essere lo
stadio finale del lungo processo di evoluzione dell'Universo, oppure, è
il culmine dello svolgersi estremamente lungo e delicato di un
programma rappresentato dalle leggi fisiche insite nell'Universo. In
ambedue i casi la meraviglia è più che giustificata, ed è legata non tanto
alla spazio quanto al "tempo".
Cerchiamo ora di localizzare in questo scenario l'emergenza della vita e
di discutere qualche punto essenziale. Oggi si ritiene che la vita sia
comparsa, nelle sue prime forme microscopiche, intorno a tre miliardi
di anni fa, ovvero circa dodici miliardi di anni dopo il Big Bang e sette
miliardi di anni dopo la formazione delle prime stelle. Perché ci ha
messo così tanto? Si ritiene che per produrre le quantità di elementi
chimici indispensabili alla vita siano state necessarie tre generazioni di
stelle. Infatti, gli elementi pesanti si creano per nucleosintesi solo
all'interno delle stelle e solo quando queste muoiono essi vengono
diffusi nello spazio per dare origine a una nuova generazione di stelle.
La durata della vita di una stella dipende dalla sua massa e può variare
da parecchi milioni di anni per stelle di grande massa, a diversi miliardi
di anni per stelle di piccola massa. Sono stati, comunque, necessari
circa dieci miliardi di anni di evoluzione stellare per produrre carbonio,
azoto, ossigeno, eccetera. Lo ripeto: l'Universo è per natura evolutivo
ed è per così dire diventato grande e vecchio "prima" che "noi"
potessimo esistere. Sarei tentato di dire: "perché noi potessimo
esistere". Ma, così facendo, introdurrei la categoria filosofica di
"finalità" che, come tale, esula dal campo della scienza.
La comparsa della vita nell'Universo pone, ovviamente, una serie di
problemi scientifici ai quali, a mio parere, non è stata ancora data
soluzione adeguata. Tenendo conto che per l'emergenza della vita
occorreva una particolarissima sintonia ("fine tuning", vedi p. 22) delle
costanti e delle leggi fisiche della natura, potremmo chiederci come
essa sia potuta apparire. La vita sarebbe stata impossibile, se anche
una sola di queste costanti avesse avuto valore (anche di poco)
differente.
Facciamo un esempio. Nel processo della nucleosintesi che si attua
nelle stelle, uno dei passi essenziali è la formazione del carbonio 12 a
partire dall'elio. Due atomi di elio formano un atomo instabile di berillio
8. Tuttavia, alcuni atomi di berillio 8, prima di decadere, catturano un
altro atomo di elio per formare atomi di carbonio 12 in uno stato
eccitato: questi ultimi passano allo stato fondamentale emettendo
ciascuno un fotone. Ma la cattura di un atomo di elio da parte del
berillio 8 è un processo di "risonanza", nel senso che se il livello di
energia del carbonio 12 eccitato fosse anche di poco differente, la
quantità di carbonio 12 prodotta in tale processo sarebbe molto minore.
Ciò avrebbe come conseguenza non solo la riduzione del carbonio 12,
ma anche quella degli elementi più pesanti indispensabili alla vita,
come ossigeno, azoto, eccetera che si formano negli stadi successivi
del processo di nucleosintesi stellare. A quanto mi risulta non esiste
una teoria che spieghi perché il livello eccitato del carbonio 12 debba
avere quel determinato valore. E' certo, però, che se non avesse quel
preciso valore, noi non esisteremmo.
Ma "noi ci siamo", e la nostra esistenza è intimamente legata alla
materia e all'energia dell'Universo di cui siamo parte. I nostri atomi si
scambiano continuamente con quelli dell'Universo, al punto che ogni
anno il 98% del nostro corpo si rinnova. Ogni nostro respiro mette in
circolo miliardi e miliardi di atomi già riciclati nelle ultime settimane dal
respiro di altri viventi. Nulla di ciò che ora forma i miei geni esisteva un
anno fa. Tutto viene rinnovato, rigenerato ogni momento, attingendo a
quella fonte di materia e di energia che è l'Universo. La mia pelle si
rinnova ogni mese e il mio fegato ogni sei settimane. Possiamo dire
che, tra tutti gli esseri dell'Universo, noi siamo tra i più riciclati!
Siamo così ricondotti alle interrogazioni di fondo. Primo: la vita, nel
quadro dell'evoluzione dell'universo fisico, doveva necessariamente
apparire? O apparve per caso? Tale comparsa può essere "spiegata"?
Secondo: la vita esiste solo sul nostro pianeta? Terzo: la vita, a livello
dell'intelligenza e dell'autocoscienza, rappresenta un fattore importante
per la futura evoluzione dell'Universo? Sono domande che, forse, ci
portano fuori del campo delle scienze della natura. Preferisco, tuttavia,
correre questo rischio riassumendole in un'unica questione
tendenziosa: esistiamo "solo" per riciclare l'energia nella forma in cui ci
viene fornita dall'Universo, oppure siamo esseri speciali, nei quali
l'Universo trova la possibilità di passare dalla materia allo spirito?
In questo quadro generale dell'Universo in evoluzione in cui si colloca
la vita, e noi con essa, vorrei presentare alcune considerazioni di natura
metascientifica, più che scientifica in senso stretto.
La ricerca da parte dei cosmologi di una teoria unitaria che includa tutte
le forze fondamentali conosciute (cioè gravità, forza nucleare forte,
forza «debole» e forza elettromagnetica - queste ultime due sono state
unificate nella forza «elettrodebole») è essenzialmente un tentativo di
trovare la struttura matematica ideale alla base di tutta la realtà creata.
Di fatto, i risultati sperimentali mettono in evidenza l'urgenza di questa
ricerca, ma si ha pure l'impressione che essa si situi in una visione
alquanto platonica della fisica matematica e che il controllo
sperimentale di una teoria unificata, nel nostro mondo di ombre, sia di
interesse secondario. Tuttavia, va tenuto presente che tale ricerca ha
avuto inizio ed è stata sostenuta in relazione ai modelli di cosmologia
evolutiva accennati sopra e sorti in seguito alle osservazioni e alle
misure dei parametri caratteristici dell'Universo, come la dipendenza
temporale della temperatura e della densità di un universo in
evoluzione.
La cosiddetta dinamica dei sistemi non lineari ha dato origine a due
nuovi campi di studio: la teoria del caos e quella della complessità.
L'immensa varietà di forme e strutture esistenti sia nel mondo
inorganico sia in quello organico mette alla prova qualunque teoria che
ponga a fondamento della fisica una serie di leggi deterministiche.
Tuttavia, applicando alle leggi della fisica l'analisi matematica dei
sistemi non lineari, si ottengono modelli che permettono una
conoscenza delle strutture dei cambiamenti: cambiamenti, però, di cui
non è possibile "predire" il risultato finale in quanto non si è in grado di
prevedere l'effetto prodotto da piccole perturbazioni che si accumulano
con legge non lineare (nel senso già indicato da Henri Poincaré (1908),
per cui «piccole differenze nelle condizioni iniziali generano differenze
grandissime nei fenomeni finali», vedi "Scienza e metodo", trad. it.
Einaudi, Torino 1997, p. 56). In definitiva, il mondo sensibile ha una
ricchezza tale da eludere il potere predittivo di modelli matematici
anche molto sofisticati.
Il che ci riporta alle nostre considerazioni sulla comparsa della vita
nell'Universo. Se possedessimo una teoria unitaria, e conoscessimo
tutte le condizioni fisiche dell'Universo in espansione, in un istante
molto vicino al Big Bang (qualche unità di Planck, vedi p. 21), potremmo
predire l'apparizione della vita? A mio parere, chi è alla ricerca
«onestamente» di una teoria unificata dovrebbe rispondere che
saremmo in grado di predire l'emergere, l'esatta natura e intensità delle
quattro forze fondamentali, insomma la fisica che conosciamo. Ma
possiamo dire che la vita è il risultato di tante biforcazioni avvenute in
obbedienza a una «termodinamica non lineare», tale che noi non
saremmo mai stati in grado di prevederla, anche nel caso che avessimo
posseduto la Teoria del Tutto e la conoscenza di tutte le leggi della
fisica macroscopica e microscopica?
Uno dei concetti caratteristici della nuova cosmologia è quello della
«mente di Dio». Ritengo che nella maggior parte dei casi con questo
termine si voglia intendere la struttura matematica ideale alla quale
corrisponde, secondo Platone, il mondo delle ombre nel quale viviamo.
La mente di Dio sarebbe una teoria unificata che ci permetterebbe di
comprendere tutte le leggi fisiche e le condizioni iniziali dell'Universo.
Nel caso di siffatta teoria, avremmo anche una comprensione adeguata
della vita? A mio giudizio, il concetto di «mente di Dio» nella
cosmologia non implica alcun carattere di intenzionalità. Ma può la vita
essere spiegata senza far ricorso all'intenzionalità? Riconosco la natura
piuttosto pretenziosa di queste domande; esse, infatti, vanno al di là del
campo di competenza proprio dello scienziato, che è quello di un
approccio puramente razionale alle questioni che riguardano il mondo
in cui viviamo. Esse pertanto m'inducono a ulteriori riflessioni.
Benché possa sembrare un giudizio alquanto sbrigativo, ritengo
corretto sottolineare come, da Platone a Newton, la disputa circa il
ruolo della matematica nella comprensione scientifica dell'Universo si
sia svolta quasi per intero entro una cornice religiosa. Ancora oggi
sentiamo ripetere dagli scienziati il ritornello della scoperta della
«mente di Dio». Ci tocca, allora, il compito di fare un serio tentativo, sia
di valutare questa lunga storia, sia di dare senso all'eco che ancora ne
risuona al giorno d'oggi.
La conoscenza razionale di Dio è analogica; perciò, è giusto che nella
ricerca della comprensione di Dio si faccia ricorso anche ai concetti
della cosmologia. Dobbiamo tentare di comprendere Dio come creatore
di un Universo dove il fine e il progetto non sono i soli, e neanche i più
importanti, fattori, ma dove la spontaneità e l'indeterminismo
nell'Universo (anche, secondo la teoria di sistemi dinamici non lineari, a
livello macroscopico) hanno contribuito in modo significativo
all'evoluzione di un Universo in cui è apparsa la vita.
Dobbiamo, però, anche guardarci dall'insidiosa tentazione della
cosmologia contemporanea dove Dio viene visto essenzialmente, se
non esclusivamente, come una spiegazione e non come una persona.
Dio rappresenta la struttura matematica ideale, la Teoria del Tutto.
Secondo questa cultura Dio è Spiegazione. Ma l'uomo di fede sa bene
che Dio è molto di più, e che la rivelazione nella quale Dio si è
manifestato nel tempo è più che una comunicazione di un'informazione.
Anche se scopriremo la «mente di Dio», non per questo avremo
necessariamente trovato Dio.
DIALOGO
(Carlo Maria Martini e Francesco Bertola).
CARLO MARIA MARTINI: Ho trovato opportuno che Lei abbia ricordato
il valore di Giordano Bruno anche «scienziato». Lo conoscevo nella sua
veste di teologo, trattato come eretico: sarei lieto se la sua figura
potesse diventare oggetto di uno di quei «ripensamenti critici» che la
Chiesa si è ripromessa per la fine del secondo millennio. Bruno riteneva
che l'eccellenza di Dio si manifestasse «non in uno, ma in Soli
innumerabili». La cosmologia contemporanea non esita a prospettare lo
scenario di molti universi, il Multiverso, anche se questa congettura
non pare allo stato attuale empiricamente controllabile. Allora, non c'è
forse contraddizione tra lo spirito delle scienze osservative e
sperimentali e un'ipotesi come questa, che letteralmente toglie il fiato?
Di per sé l'idea dei molti universi non contrasta con alcuna verità di
fede, anzi Lei stesso ha ricordato come fosse previsto il contrario nella
sentenza del 1277. Tuttavia, mi domando come possano degli scienziati
formularla senza adeguato sostegno empirico.
FRANCESCO BERTOLA: La questione dei molti, forse infiniti universi si
ripropone ora nel contesto del cosiddetto principio antropico, spesso
per non cadere in forme troppo spinte di finalismo. Resta un dovere
dell'uomo di scienza indicare, prima o poi, un controllo empirico, se
non una prova di laboratorio che ci consenta di dire: qui è nato un
nuovo universo. Ma siamo ancora agli inizi. Inoltre, l'impresa potrebbe
addirittura apparire contraddittoria, perché per definizione Universo
dice il tutto, mentre noi parliamo di "molti" universi. Comunque il
problema resta e lo sforzo attuale della comunità scientifica potrà dare i
suoi frutti... forse solo alla fine del prossimo millennio.
MARTINI: E allora come vive uno scienziato le incertezze dell'attuale
cosmologia circa l'origine dell'Universo, e forse la fine? Nella speranza
che un giorno saranno dissolte? Oppure con il presentimento che
appena trovate le «risposte» saranno cambiate le «domande»? Mobile è
l'orizzonte, sempre al di là della nostra presa?
BERTOLA. Di incertezze ne avremo sempre, poiché la scienza si
conquista. Ma le vittorie in questa impresa non sono altro che la
rimessa in discussione di quello che, prima, si teneva per certo. Proprio
quando crediamo di essere giunti a un punto indubitabile, ci
accorgiamo che la verità è diversa, e per questo siamo costretti ad
andare oltre. E' un processo continuo. Per esempio, a proposito del
problema dell'origine del nostro Universo, val la pena di ricordare che
negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento si era individuato il
famoso "tempo zero" - come risultava dalle equazioni - e si pensava che
fosse quella l'origine dell'Universo, laddove si trattava solo di una
soluzione matematica. In seguito, ci si è accorti che questo non basta
alla fisica. Personalmente dubito che si possa pervenire a una risposta
definitiva... e forse la natura stessa della scienza è quella di una
crescita continua che mai perviene a qualcosa di assoluto.
Tuttavia, il carattere fallibile dell'impresa scientifica non esime i fisici
dal compito di indicare possibili controlli e di cercare delle prove. Ciò
vale per un'eventuale fine del nostro Universo e persino per la già citata
ipotesi del Multiverso. La scienza come insieme di acquisizioni incontra
di continuo degli ostacoli, ma non porrei un limite ai desideri e agli
sforzi degli scienziati, pur riservandomi di vederne i risultati - anche se,
lo ribadisco, nel caso di ipotesi molto ardite e speculative, questi
verranno magari tra secoli.
DIALOGO
(Carlo Maria Martini e George V. Coyne).
CARLO MARIA MARTINI: Dalla sua esposizione appare chiaro che
sappiamo stabilire l'età dell'Universo in cui viviamo (più o meno
quindici miliardi di anni) e che, anzi, si possono individuare delle
«pietre miliari»: per esempio, a dodici miliardi di anni dall'«inizio», cioè
tre miliardi di anni fa, è comparsa la vita. Ora, come si conciliano tali
stime con le ipotesi ricordate da Bertola circa un'eventuale origine
dell'Universo in un tempo infinitamente lontano, o addirittura con
l'ipotesi di mancanza dell'origine?
GEORGE V. COYNE: Parlando della durata dell'Universo intendo
riferirmi a una durata dall'"inizio" dell'Universo in cui vivo ed entro cui,
come scienziato, raccolgo dati e cerco di arrivare a una descrizione
fisica o almeno a un modello matematico che renda conto di tali dati.
Una durata, dunque, empirica, misurabile. Sorge, però, il quesito:
durata sì, ma "da che punto"? Le stesse leggi della fisica erigono per
così dire un muro. Il vero e proprio Big Bang - quello che i matematici
chiamano singolarità iniziale - nonché gli eventi immediatamente
successivi, compresi nel cosiddetto "tempo di Planck" (da zero a 10
alla meno 43esima secondi), non possono nemmeno inviarci alcun
messaggio. Di fatto, possiamo "vedere indietro nel tempo" solo fino al
momento in cui l'Universo divenne trasparente (a circa trecentomila
anni dal Big Bang). Prima di quest'epoca, caratterizzata da una
temperatura maggiore di 6000 gradi, l'energia radiante non poteva
liberarsi dalle particelle materiali con cui interagiva. Va quindi precisato
che non è possibile riprodurre le condizioni estreme verificatesi
nell'Universo primordiale. Ma, almeno in una certa misura, dalle
osservazioni che facciamo oggi delle "conseguenze" di ciò che
avvenne in quel "laboratorio unico" possiamo tentare di risalire alle
grandezze che lo caratterizzavano.
MARTINI: Diceva Tommaso d Aquino: «Novitas mundi non potest
demonstrationem recipere ex parte ipsius mundi». E' inutile, cioè,
ricercare all'interno del mondo qualcosa che ne riguarda l'origine.
Secondo Lei ciò coincide con le moderne intuizioni oppure Tommaso
voleva dire altro?
COYNE: La ringrazio per la citazione. Anche alla luce della scienza dei
nostri giorni penso che Tommaso abbia avuto buone ragioni per
affermare che è vano cercare all'interno del mondo qualcosa che ne
riguardi l'origine. Bisogna cioè trascendere l'Universo per vederne le
origini. L'Universo, anche assumendo che sia finito, non può essere
osservato nella sua totalità. Di esso, infatti, vediamo solo quella parte (il
cosiddetto "Universo visibile") compresa nella distanza percorsa dalla
luce in un tempo eguale alla sua età. Dato che la luce ha una velocità
finita, non osserviamo mai gli oggetti dell'Universo "come sono", ma
unicamente "come erano". I nostri telescopi non sono solo puntati sullo
spazio lontano, ma anche sul tempo remoto. Oggetti molto lontani
potrebbero essersi evoluti enormemente, e il segnale di questa
evoluzione potrebbe non esserci ancora pervenuto. Poiché conosciamo
un solo universo, non possiamo procedere come di consueto
confrontando oggetti simili per scoprire le leggi comuni che ne
determinano il comportamento. Ci sono, è vero, cosmologie che
postulano molti universi; ma qui le cose si fanno ancora più difficili,
dato che le distanze che li separano superano quella percorsa dalla
luce nel tempo corrispondente all'età del nostro Universo. Sono
universi che non possono comunicare tra loro e nemmeno con il
nostro. E allora mi sembra legittimo asserire che la teoria dei molti
universi sia più speculazione che scienza. Infine, la citazione di
Tommaso mi sollecita a un'ulteriore riflessione. Applicando la
meccanica quantistica alla cosmologia, facendo cioè della cosmologia
quantistica, possiamo avere anche un modello dell'Universo che
scaturisca da una sorta di nulla ("ex nihilo"). In tal caso potremmo dar
ragione dell'Universo senza trascendere l'Universo stesso. Verrebbe
allora smentita quella tesi di Tommaso... Peraltro, da un siffatto modello
cosmologico, in cui l'Universo è concepito in modo da non aver
bisogno di condizioni al limite, non bisogna affrettatamente concludere
alla non esistenza di Dio. Il Dio dei teologi non è una condizione al
limite imposta all'Universo, ma il creatore, in qualunque senso
possiamo scientificamente esplicitare l'idea di un'origine dal nulla.
MARTINI: Dai limiti della cosmologia scientifica siamo così ricondotti
alle difficoltà stesse del teologo o del filosofo (e Tommaso era
entrambe le cose) che non possono non porsi la questione del senso
del nostro Universo.
COYNE: Come mostra il caso della battuta di Tommaso, anche la
ricerca teologica può incontrare dei limiti. Limiti che, in qualche
occasione almeno, si definiscono proprio nel confronto con la scienza.
In tutte le sue procedure la teologia muove sempre dalle verità di fede
per giungere a un'intelligenza della fede stessa: "fides quaerens
intellectum". In questo senso, proprio perché si sforza di giungere a
una comprensione razionale della rivelazione, essa è soggetta a tutte le
evoluzioni del pensiero umano. Pur riconoscendo che la verità rivelata
ci è stata data in tempi determinati e attraverso persone particolari, il
suo approfondimento richiede un cammino continuo. Inoltre, poiché la
conoscenza razionale di Dio è analogica, è opportuno che nell'impresa
si ricorra anche ai concetti via via dispiegati dalla scienza, in particolare
dalla cosmologia. I criteri che abitualmente si richiedono per una buona
teoria sono che essa sia semplice, elegante, controllabile e che abbia
un grande potere di unificazione. Non sempre nella pratica tutti questi
requisiti vengono soddisfatti insieme. Ma restano ideali regolativi della
«nuova fisica». Non potrebbero esserlo anche di una «nuova teologia»
che cooperi con l'impresa scientifica nell'avvicinarci a quelle verità che
ancora non possediamo?
2.
LE ORIGINI DELLA VITA.
GLI ALBERI DELLA VITA
(Julian Chela-Flores).
Quanto la scienza ci insegna sull'origine della vita ha un'indubbia
risonanza filosofica e ne possiamo trarre un insegnamento etico. Per
ragioni di onestà intellettuale mi pare opportuno esporre in primo luogo
le ragioni che mi inducono a negare che sussista un conflitto tra
impegno religioso e ricerca scientifica. Ciò premesso vorrei trattare, in
secondo luogo, il problema dell'origine, dell'evoluzione e della
distribuzione della vita nell'Universo, insistendo su quella che a mio
avviso è la questione principale: la relazione vita-Universo. Ma, poiché
non abbiamo ancora una risposta sull'origine della vita in termini di
teoria dell'evoluzione, cercherò in terzo luogo di delineare una possibile
via alternativa: la mia tesi sarà che l'esplorazione del Sistema solare,
alla ricerca di altre forme di vita, sia prima o poi in grado di fornire un
considerevole aiuto per risolvere il "mistero dell'origine" tramite il
confronto fra differenti forme di vita.
Prendo dunque le mosse da quello che, a mio parere, dovrebbe
costituire il punto di partenza di qualsiasi «Cattedra dei non credenti»:
l'esortazione a prendere in esame il dialogo tra fede e non fede, che si
svolge all'interno di ognuno di noi, qualunque "credo" professi, magari
quello dell'ateismo più radicale. In particolare, penso che chiunque si
dedichi alla scienza debba interrogarsi sul senso e le possibilità di
coesistenza tra fede e ragione. E, per quanto mi riguarda, non trovo
alcuna contraddizione tra ricerca scientifica ed esperienza di fede,
poiché entrambe hanno di mira la verità - anche se, nel caso della
scienza, non nelle forme della tradizione religiosa ebraica, cristiana,
islamica, eccetera. Nella scienza si cerca la verità tramite il confronto
tra teorie ed esperimenti, oppure tra teorie e osservazioni ripetibili. In
nessuno dei due casi dovrebbero, a mio avviso, prodursi contraddizioni
con la fede.
La scienza, infatti, è di per sé limitata - come suggerisce anche il titolo
di questa stessa Cattedra. Essa è rivolta unicamente allo studio di
fenomeni osservabili e soggetti a esperimenti, e quindi non coinvolge
direttamente la fede. Al contrario, nel "De Genesi ad Litteram" Agostino
(354-430) ha indicato un modo di porre l'interazione fede-ragione oggi
quanto mai attuale. Allorché la scienza approda a una qualche
conclusione che suoni in contrasto con la narrazione biblica, Agostino
non respinge il resoconto scientifico e pone il problema
dell'interpretazione allegorica delle parole della Bibbia. Personalmente,
non smarrisco la fede poiché mi appello da un lato alla distinzione e
dall'altro alla graduale convergenza tra le scritture dell'uomo - le
discipline scientifiche, e la Scrittura di Dio - la rivelazione.
A questo proposito, vorrei menzionare anche un non credente,
addirittura desideroso di spiegare "perché" non era "cristiano", il
filosofo inglese Bertrand Russell (1872-1970). Nel suo "Scienza e
religione" (1935) questi evidenzia come filosofia e teologia
rappresentino altrettante frontiere della scienza. A suo dire, infatti, le
procedure della scienza non contemplerebbero, tra i problemi di cui si
occupano, alcune questioni essenziali per l'esistenza, mentre
quest'ultimo è l'aspetto della vita religiosa «forse più desiderabile» che comunque «può sopravvivere quali che vengano a essere le nostre
convinzioni sulla natura dell'Universo» (trad. it. Longanesi, Milano 1974,
p. 18). L'impresa scientifica sarebbe dunque limitata dal suo stesso
rigore. Insomma, restando entro i confini della scienza ammette
Russell, non possiamo giungere a dare tutte le risposte di cui l'uomo
sente il bisogno: a queste provvedono, invece, filosofia e teologia.
Da parte mia, ritengo che molti dei problemi che sorgono nel dialogo tra
scienza, filosofia e teologia siano dovuti non tanto alla pratica
scientifica in sé, quanto all'assunzione di certe posizioni filosofiche. E'
il caso del positivismo logico, una corrente che esclude come puro
«non senso» quello che non può essere affrontato con una metodologia
scientifica. Io sono tra coloro che limitano la pratica della scienza al
dialogo tra teoria ed esperimento: è con esso che è nata la conoscenza
scientifica. Una ipostatizzazione in chiave filosofica del dialogo tra
teoria ed esperimento può rappresentare un'indebita interferenza nel
convergere di diverse manifestazioni della cultura umana.
A questo punto, passiamo a trattare l'argomento dell'origine e
dell'evoluzione della vita, fino alla comparsa dell'uomo sulla Terra. Tale
ricerca rappresenta il frutto del lavoro di un gran numero di scienziati
per oltre settant'anni. Ma, per essere sinceri, è ancora lontana
dall'offrire risultati soddisfacenti. Come ha ricordato George Coyne
(vedi "questo volume", p.p. 28-30), dopo tre generazioni di stelle,
l'abbondanza di elementi è sufficiente per la cosiddetta evoluzione
chimica, ossia l'auto-organizzazione dei mattoni della cellula vivente. E'
a questo punto dello sviluppo che possiamo parlare di una nuova
scienza delle origini. Tale ricerca non ha ancora un nome definito,
anche se il termine «astrobiologia» sembra godere oggi di largo favore.
Il presupposto è che l'evoluzione biologica sia apparsa dopo
l'evoluzione cosmica e quella chimica. Il processo evolutivo ha fornito
all'uomo notevoli proprietà, uniche nel Regno Animale, quelle stesse
che sono state analizzate da Charles Darwin (1809-1882) nelle opere in
cui ha gettato le basi della sua teoria dell'evoluzione.
Non va dimenticato che, nel 1996, durante una sessione dell'Accademia
Pontificia, Giovanni Paolo Secondo ha dichiarato che «la teoria
dell'evoluzione è più che una ipotesi». Possiamo interpretare questo
riconoscimento come un incoraggiamento al processo di convergenza
della scienza con la filosofia e la teologia. Ma, al di là dell'importanza
della teoria darwiniana, non si può tacere del fallimento, almeno sino a
oggi, della ricerca mirante a esplorare il meccanismo chimico che
sarebbe alla base dell'origine della vita. Un'alternativa praticabile per
dissiparne il mistero può essere quella di cercare vita fuori dalla Terra,
poiché ciò ci permetterebbe di confrontare forme di vita indipendenti,
giungendo così a una comprensione più ampia e più profonda
dell'origine della vita. Tale ricerca dovrebbe estendersi anche oltre i
confini del Sistema solare. E' mia personale convinzione che ciò possa
portare a risultati positivi nei prossimi decenni.
Oggi sappiamo che su alcuni pianeti orbitanti attorno a stelle della
nostra Galassia, abbastanza vicine a noi, sussiste la possibilità di
trovare nuovi organismi. Ma anche senza spostarci così lontano,
l'esplorazione del nostro Sistema solare, grazie al lavoro di molti
ricercatori, potrebbe offrirci una visione più chiara di come sono andate
le cose all'origine, e quindi, dell'evoluzione della vita sulla Terra.
Per meglio intendere l'obiettivo principale dell'astrobiologia, possiamo
servirci di una metafora. L'insieme del vivente può essere
rappresentato come un albero, con pochi rami e tante foglie; ognuna di
queste rappresenta una specie diversa; per esempio la nostra, "Homo
sapiens", sarebbe, in questa visione simbolica, una foglia. A livello
molecolare il nostro albero della vita appare semplice (vedi figura 9): ci
sono tre rami fondamentali, che corrispondono a tre gruppi di cellule ossia, usando la terminologia della biologia cellulare, tre «domini». Il
primo ramo corrisponde alle cellule eucariotiche: sono le cellule di cui
siamo composti e hanno il materiale genetico racchiuso entro una
membrana di lipidi. Tali cellule sono tipiche di tutti gli organismi
pluricellulari, dalle alghe fino agli animali superiori, compreso l'uomo.
Al secondo dominio appartengono i batteri, o «procarioti»; il terzo ramo
dell'albero della vita è infine il dominio degli «archeobatteri». Una delle
principali differenze tra batteri e archeobatteri consiste nella natura
stessa della membrana cellulare. Gli archeobatteri sono organismi
unicellulari estremofili: possono sopravvivere sul fondo degli oceani
nonostante le elevatissime pressioni esistenti (sono cioè «barofili»),
così come al bordo delle sorgenti idrotermali, al limite delle temperature
di denaturazione delle proteine (sono cioè «termofili»). Sono questi tre
domini filogenetici che hanno colonizzato il nostro pianeta.
La biologia ci permette di capire quale collocazione abbia l'uomo
nell'albero della vita "terrestre". Nella pianificazione delle future
missioni di esplorazione entro il Sistema solare, a mio parere,
dovremmo avere come obiettivo il reperimento di eventuale
"eucariogenesi", cioè di cellule con un certo grado di complessità.
Inoltre, ritengo che la ricerca della vita fuori dalla Terra ci ponga di
fronte a una nuova domanda fondamentale: qual è la nostra
collocazione nella "foresta della vita"? Tale domanda ci porta
direttamente al cuore dell'astrobiologia, poiché potremmo essere ben
presto in grado di identificare "altri" alberi della vita, localizzati in corpi
celesti diversi dal nostro. In altre parole, infatti, in futuro potremmo
avere esperienza di evoluzioni parallele, in ambienti differenti da quello
terrestre.
Con le potenzialità tecniche di cui disponiamo, saremmo comunque in
grado di continuare il fecondo dialogo fra teoria ed esperimento iniziato
con Galileo Galilei (1564-1642). Restiamo all'immagine della foresta: la
ricerca della vita nel sistema solare ci permetterà di scoprire se alcuni
alberi siano abbastanza vicini tra loro. Il sistema gioviano sembra per
ora il luogo più probabile dove cercare un «secondo albero della vita».
Con il suo «occhiale» (1610) Galileo scoprì quattro «lune» di Giove, i
«pianeti medicei» (vedi p. 12). Tra questi, il satellite più vicino a Giove è
Io, le cui dimensioni sono di poco maggiori di quelle della nostra Luna.
Mentre sulla Luna non si ha alcuna attività vulcanica, Io è invece il
corpo di tutto il sistema solare in cui tale attività è più intensa. Il
secondo satellite galileiano è Europa, di dimensioni minori della Luna e
con la caratteristica principale d'essere ricoperto da una crosta di
ghiaccio. Proprio Europa è oggi il candidato principale, fra i corpi
celesti diversi dalla Terra, per ospitare forme di vita; il primo, dunque,
che potrebbe rivelare un "secondo albero della vita". Europa è
relativamente vicino a Io e potrebbe avere attività vulcanica, cioè una
possibile fonte di calore atta a sciogliere il ghiaccio sovrapposto al
nucleo di silicato.
Nella comunità scientifica si discute anche della possibilità che vi sia
su Europa un oceano di acqua liquida. E' pure probabile la presenza di
carbonio e composti organici. Vi sarebbero quindi su Europa i tre
ingredienti indispensabili per lo sviluppo di forme di vita, del tipo di
quelle che noi conosciamo sulla Terra: una fonte di energia, acqua
liquida e carbonio. Per i prossimi dieci anni vi sono diverse proposte
per l'esplorazione di Europa, che, attualmente, è «scrutato» dalla
missione "Galileo" (lanciata nel 1989 ed entrata in orbita attorno a
Giove nel 1995), grazie alla quale ci sono pervenute nitidissime
immagini del satellite.
Una delle missioni in discussione, proposta da un gruppo di ricercatori
degli Stati Uniti, con la collaborazione del Centro Abdus Salam di
Trieste, prevede la discesa di una sonda sulla superficie ghiacciata di
Europa, dove potrebbe essere trovato materiale biologico. E'
interessante notare che quel satellite avrebbe al suo interno un
nocciolo, ricoperto da un mantello di rocce e infine da uno strato di
ghiaccio: configurazioni simili sono presenti in diverse località della
Terra. Un primo esempio è l'Oceano Artico, caratterizzato da profondi
bacini: pur non essendo presenti fonti idrotermali sul fondo
dell'Oceano, la temperatura dell'acqua, sino a una profondità di circa
500 metri, è superiore a quattro gradi centigradi. Conosciamo anche
molto bene i tipi di microorganismi che si trovano al Polo Sud, dove
l'habitat è abbastanza simile a quello di Europa: nelle valli secche, al di
sotto di un mantello di ghiaccio permanente, si trovano laghi in cui
sono presenti batteri (cianobatteri) e diatomee (cellule eucariotiche).
Non si può escludere che questi tipi di organismi, presenti in Antartide,
possano sopravvivere in condizioni simili a quelle presenti in un
eventuale oceano di Europa. E' per questo che sarebbe interessante
poter inviare un sommergibile capace di penetrare lo strato di ghiaccio
di quel satellite di Giove. Un tale mezzo scenderebbe sotto il ghiaccio di
Europa grazie a un «penetratore» realizzato con tecniche molto
avanzate. Questa missione potrebbe essere pronta nel 2010, ma non vi
è ancora la certezza di poter reperire i fondi necessari.
Tuttavia, anche se la ricerca di un altro "albero della vita" fallisse sia su
Europa sia su ogni altro corpo del Sistema solare, altri alberi della vita
potrebbero comunque esistere abbastanza vicini al nostro "villaggio
cosmico", accanto a quelle stelle prossime al Sole attorno alle quali
oggi sappiamo che orbitano sistemi planetari. Forse, solo così si potrà
far luce sul meccanismo dell'origine della vita.
In ogni caso, mi sembra importante riflettere sulle implicazioni che la
scoperta di vita extraterrestre avrebbe sulla nostra cultura, e in
particolare sulla scienza, sulla filosofia e sulla teologia. Basti solo
ricordare quale impatto ebbe sulla società e sulla cultura del Vecchio
Continente la scoperta dell'America, in particolare l'incontro con i nativi
americani. Con Cristoforo Colombo si è meglio compreso anche l'uomo
europeo! L'arte del confronto tra civiltà diverse ha creato l'antropologia
moderna. Ma, nello studio della vita, questa «arte» potrà avere un ruolo
anche maggiore. Infatti, nella discussione circa la possibile esistenza di
altre forme di vita, possiamo oggi avvalerci delle conquiste della
biologia molecolare. Questa studia a livello microscopico le foglie dei
tre rami dell'albero della vita terrestre.
La sfida che ci attende nel Terzo millennio avrà quasi certamente un
impatto maggiore di quello che ebbe la scoperta dell'America alla fine
del quindicesimo secolo. Si tratterà di confrontare la massima
espressione dell'evoluzione cellulare terrestre (l'eucariogenesi) con i
microorganismi che potrebbero esistere nel nostro Sistema solare, od
oltre. L'allargamento dell'orizzonte scientifico che ne conseguirà potrà
rivelarsi forza motrice di un'impetuosa crescita della cultura umana.
Non potrebbero qui fede e ragione avvicinarsi ulteriormente?
L'EVOLUZIONE DEL VIVENTE
(Edoardo Boncinelli).
L'origine della vita, ossia quello che è successo prima degli ultimi tre
miliardi e ottocento milioni di anni, è tutt'altro che chiara. Possiamo
certo immaginare che vi sia stato un periodo in cui la vita era assente.
Sappiamo, ovviamente, che vi è stato un periodo in cui la vita è
comparsa: infatti, "noi ci siamo". Ma cosa sia successo in quel
frangente non lo sappiamo; e non è facile neppure definire cosa sia
vita. Da sempre l'uomo si è interrogato sul vivente e gli è parso
abbastanza facile distinguerlo dal non vivente. Tuttavia, cerchereste
invano una definizione adeguata di vita in qualsiasi manuale di biologia.
Non mancano tentativi che vi si avvicinano: per esempio, la vita è una
quantità di materia organizzata in maniera particolare. Il segreto della
vita sarebbe allora l'organizzazione - ma parlando di organizzazione,
dato che l'organizzazione viene considerata tratto caratteristico della
vita, non si fa altro che ribadire che il segreto della vita è la vita.
Che dire allora del grande tema della comparsa del vivente in un
Universo in evoluzione? Uno scienziato può immaginare, ipotizzare,
congetturare, discutere con entusiasmo e passione in convegni e
congressi quello che è successo "prima" di tre miliardi e ottocento
milioni di anni fa, ma di fatto non lo sa. Invece, quello che è accaduto
dalla comparsa della prima cellula fino all'apparizione dei primi
organismi, nel lasso di tempo che va quindi da tre miliardi e ottocento
milioni sino a seicento milioni di anni fa, si può ricostruire con un certo
grado di attendibilità, pur restando ancora semplice materia di
osservazione più che di riflessione e di spiegazione. Quello che è poi
successo da seicento milioni sino a quaranta-cinquantamila anni fa
costituisce il campo vero e proprio del biologo, che può dire molte
cose, può spiegarne molte altre, e persino sperare di avere spiegato
"quasi" tutto. Infine, c'è l'ultimo periodo, quello che porta dai primi
esseri simili all'uomo all'uomo stesso. Qui, di nuovo, lo scienziato come
scienziato vacilla. Attenzione: non sto minimamente contrapponendo
«scienziato» a «uomo di fede». Voglio, invece, ribadire che lo
scienziato, se onesto, deve riconoscere di comprendere piuttosto bene
quanto è successo tra seicento milioni e quaranta-cinquantamila anni
fa, ma deve anche confessare che gli sfuggono il "prima" e il "dopo".
Accontentiamoci: un vivente è una certa quantità di materia organica,
fisicamente separata dal resto del mondo, dotata della capacità di
metabolizzare materia ed energia, nonché di quella di instaurare e
sostenere una propria organizzazione interna. Sono queste le proprietà
essenziali della "cellula", l'unità fondamentale di tutti gli esseri viventi.
Per mantenere e trasmettere questa organizzazione interna la cellula
necessita di una continua "attività"; essa presenta, però, anche una
reattività, cioè la capacità di avvertire le sollecitazioni dell'ambiente
circostante e di regolare su di esse il proprio assetto e comportamento.
Anche un organismo elementare come un batterio può dirigersi verso
una fonte di materiale nutritizio o allontanarsi da una sorgente di
sostanze nocive; un'alga verde unicellulare può andarsi a posizionare
in una zona dell'ambiente che offra opportune condizioni di luminosità,
eccetera. Anzi, un batterio o un'alga possono fare molto di più: collocati
improvvisamente in un ambiente privo di certe sostanze, possono
cominciare a sintetizzare loro stessi quelle che sono ora indispensabili
alla loro sopravvivenza. Le cellule del nostro corpo non sono da meno.
Per esempio, quando una cellula avverte nel sangue la presenza
dell'ormone tiroideo, impartisce automaticamente un'accelerazione al
proprio metabolismo, mentre se avverte una carenza di zuccheri, tende
a ridurne il consumo.
Le cellule posseggono, dunque, tre caratteristiche essenziali:
sensibilità, capacità di far corrispondere alla ricezione di certi segnali
l'approntamento di certe risposte, capacità di mettere in atto queste
stesse risposte. All'interno degli organismi "pluricellulari" vige, per così
dire, una stretta divisione del lavoro, e la proprietà di rispondere alle
sollecitazioni esterne risulta maggiormente articolata. Essa è
concentrata, anche se non confinata, in alcune particolari cellule dette
cellule nervose o neuroni. Il loro complesso costituisce il cosiddetto
sistema nervoso: la sua funzione è quella di mettere l'organismo in
relazione con l'ambiente circostante e di guidarne la risposta alle
sollecitazioni che da quello provengono. Allo scopo occorrono dei
sensori specializzati che captino cosa sta succedendo all'intorno (in un
organismo superiore come l'"Homo sapiens" tali sensori sono
rappresentati dalle cellule degli organi di senso); e ancora, delle linee di
trasmissione ascendenti che trasportino il segnale nervoso dai sensori
periferici all'unità decisionale centralizzata (nel caso dell'uomo, le vie
nervose "afferenti", cioè che afferiscono al cervello); inoltre, delle linee
di trasmissione discendenti che dall'unità decisionale centralizzata
portino alla superficie del corpo la decisione di un'eventuale strategia
di risposta (nel nostro esempio, le vie nervose "efferenti" che scendono
dal cervello alla periferia); infine, degli organi e delle strutture capaci di
mettere in atto la risposta (nel caso degli animali superiori e dell'uomo,
l'apparato motorio deputato a mettere in atto le decisioni centrali è così
articolato da consentire quelle risposte comportamentali che tanto
affascinano gli etologi).
Seicento milioni di anni fa, quasi improvvisamente, si è formata la
maggior parte delle grandi divisioni degli animali che osserviamo oggi:
vertebrati, insetti, platelminti, e così via. E questi individui piuttosto
«primitivi» o «antichi» si sono andati adattando alle condizioni
ambientali, si sono cioè «evoluti». Ma quando si arriva all'origine
dell'uomo e alla comparsa della mente, del linguaggio e della
coscienza, lo scienziato esita. Che cosa abbiamo imparato in questi
ultimi centocinquant'anni circa l'evoluzione dei grandi "phyla" o tipi
animali?
Come è noto, la teoria dominante in ambito scientifico è quella di
Darwin. Anche se non mancano i detrattori: non c'è giorno o quasi in
cui non si dica che il "darwinismo" è morto e sepolto (e sappiamo bene
come ai giornali piaccia gridare allo scandalo o andare a caccia del
sensazionale). In realtà, esso gode di ottima salute, anzi non è mai stato
bene come oggi.
Per essere più precisi, la teoria vigente è piuttosto una sorta di
"neodarwinismo": l'idea originaria di Charles Darwin (1809-1882), che
ormai ha più di un secolo, è stata raffinata e perfezionata grazie alle
conquiste della genetica e della biologia molecolare del Novecento.
Darwin aveva intuito come si potesse spiegare l'evoluzione dei viventi
sulla base di una serie di meccanismi che, se dal punto di vista
razionale sono soddisfacenti, da quello psicologico lasciano l'amaro in
bocca, perché puramente casuali. E l'essere umano non ama troppo le
spiegazioni di tipo casuale: preferisce quelle in cui si enfatizza un fine,
uno scopo; è affascinato dall'idea di progetto, ama contemplare la
realizzazione di un disegno.
Da scienziato, però, devo dire che buona parte di quanto è accaduto nel
processo evolutivo durante il periodo di cui sto parlando è spiegabile
razionalmente, e la spiegazione non è nemmeno troppo complicata.
Consideriamo una popolazione di granchi, molto simili l'uno all'altro.
Ogni tanto, per caso nasce un granchio che ha, poniamo, le zampe più
lunghe. La ragione è che nel suo patrimonio genetico si è prodotta
casualmente un'alterazione o, meglio, una mutazione. In genere questo
mutante sarebbe uno svantaggiato: del resto, in qualsiasi popolazione
un diverso è svantaggiato, perché se la popolazione è abituata a vivere
con un certo stile sia materiale sia comportamentale (anche lo stile
comportamentale è importante nel mondo animale), il diverso non può
che venire penalizzato. Insomma, nella stragrande maggioranza delle
situazioni questo granchio con le gambe più lunghe (o più corte, potete
fare l'ipotesi che vi aggrada) verrà eliminato dalla lotta per la vita.
Tuttavia, può anche darsi che nasca un granchio con caratteristiche tali
da recargli un minimo vantaggio su tutti gli altri: o perché
effettivamente nell'ambiente dove vive quelle caratteristiche sono più
vantaggiose, oppure perché nel frattempo è cambiato qualcosa, per
esempio le maree, il mare si è ritirato, o si è affermato un certo tipo di
alghe che prima non esisteva. Allora, il mutante può riuscire a imporsi:
quel granchio disadattato potrà venire favorito a discapito degli altri
granchi, i «normali» di una volta. Anzi, se le condizioni ambientali non
cambieranno ulteriormente, i nuovi individui potranno lasciare una
progenie più abbondante di quanto facciano i «normali», e i loro
discendenti finiranno per costituire il grosso dell'intera popolazione.
Nel grande calderone della vita in cui (soprattutto nel mare) si mettono
in circolazione milioni di uova - e di queste solo poche decine arrivano
all'adulto -, nella grande competizione biologica, potrà capitare che
dopo un certo lasso di tempo tutta la popolazione avrà le caratteristiche
di questa "bizzarria originaria", oppure (molto più probabilmente) la
popolazione finirà con il dividersi in due: per ritornare al nostro
esempio, granchi con le gambe corte e granchi con le gambe lunghe.
Quelli con le gambe corte si sistemeranno un pochino più a riva, quelli
con le gambe lunghe un pochino più al largo. Ecco come avviene la
creazione di una nuova specie, oppure lo sdoppiamento di una specie
già esistente.
Questo semplice meccanismo ci permette di rendere conto di molti
aspetti di quella che appare la caratteristica della vita: la tremenda
variabilità, la tremenda diversità biologica. Chiunque si accinga a
studiare la vita, non può non essere immediatamente colpito
dall'enorme varietà di specie. Ve ne sono davvero moltissime, con
esattezza non sappiamo nemmeno quante. Solo di animali sembrano
esservene quasi dieci milioni, e solo di insetti quasi due milioni! E'
chiaro, quindi, che in questa gigantesca lotta per la vita, per usare le
parole di Darwin, non c'è un solo vincitore, e nemmeno due o tre, ma ve
ne è un numero enorme: tutti sono vincitori o, meglio, lo sono tutti
quelli che si trovano al momento attuale sulla crosta terrestre. Solo che
sono diversi dai loro antenati di cinquanta, sessanta o cento milioni di
anni fa.
Mentre si diversificano, in molti casi infatti si adattano. Dai libri di
divulgazione o dai documentari scientifici veniamo bombardati con la
parola «adattamento», anzi «mirabile adattamento»: il muso e la lingua
del formichiere sembrano progettati "ad hoc" per catturare le formiche
dentro i formicai, la coda del castoro serve in modo eccellente a
piazzare la malta dei muriccioli negli stagni, eccetera. Quello che ci
colpisce, al di là della varietà, è l'adattamento - anzi, si è tentato di
spiegare "tutta" l'evoluzione in termini di adattamento. Ma se si
considera non la singola specie, bensì la totalità delle specie, si vede
che tutte si sono adattate. Non vi è quindi una "sola" forma di
adattamento. Ora, se "tutte" sono adattate, diventa vuota la categoria di
adattamento; utilizzarla significa semplicemente asserire che "ogni"
specie trova il "suo" modo di perpetuarsi. Pertanto, la teoria di Lamarck
(ben dura a morire, soprattutto tra certi intellettuali), rivale di quella
darwiniana, nell'enfatizzare l'adattamento finisce per privilegiare un
"unico" aspetto: secondo Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), infatti,
o meglio secondo i suoi epigoni, i mutanti non nascono per caso, come
vuole la teoria darwiniana, ma per il fatto che di generazione in
generazione sono trasmissibili particolari "caratteri acquisiti".
Si tratta di una spiegazione affascinante, brillante, che risolverebbe non
pochi problemi - peccato non sia quella vera. I caratteri acquisiti
durante la vita non si «ereditano». Succede spesso che teorie molto
affascinanti non siano vere: la Natura fa quello che le pare, non quello
che vorremmo noi.
Dunque, il meccanismo darwiniano, che appare così frustrante per la
nostra psicologia e per il nostro desiderio di comprendere, invoca
pesantemente l'azione del caso. E' il caso e solo il caso quello che
presuppone i nuovi mutanti ed è solo su quegli individui varianti che
effettivamente compaiono nelle varie popolazioni che può intervenire la
selezione naturale operata dall'ambiente. In questa circostanza il
ricorso al termine «caso» non significa che non potremmo, volendo,
analizzare i meccanismi che portano alla comparsa di nuovi varianti.
Significa soltanto che la comparsa di questi varianti non è in alcun
modo correlata alle esigenze degli individui della specie in questione,
né a qualche cosa che sia successo precedentemente, né alla direzione
che prenderanno successivamente gli eventi. Non si tratta, quindi, di
una casualità incondizionata, ma di una casualità specifica rispetto a
un'eventuale direzionalità degli eventi evolutivi.
Perciò, più che di "casualità" si dovrebbe parlare di "non direzionalità"
o di "non intenzionalità". Insomma, giusto il contrario di quello che ogni
teoria ingenua dell'adattamento o lo stesso lamarckismo danno per
scontato - cioè che i cambiamenti abbiano luogo sempre in una
determinata direzione. Questa direzione sarebbe quella di un sempre
maggiore adattamento degli individui delle varie specie alle condizioni
ambientali nelle quali vivono, il che comporterebbe a sua volta un
miglioramento delle varie specie e a lungo andare la comparsa di
organismi sempre più complessi. E' interessante notare che la scienza
non riesce ancora, qui come altrove, a dirci esattamente come stanno le
cose - anche se può dirci con sicurezza come le cose non stanno.
Anche l'Universo in cui noi oggi viviamo ha avuto una sua
«evoluzione». Agli «inizi» vi era una sola forza, cioè un solo principio
attivo che controllava il comportamento di tutte le entità allora esistenti.
Dopo un'infima frazione di secondo tale unica forza ha cominciato a
esprimersi in due forme diverse: la forza gravitazionale da una parte, e
quella comprendente le altre tre forze oggi note dall'altra. La
diminuzione di temperatura - che resta sempre dell'ordine di 103 gradi ha causato la prima rottura della perfetta simmetria originaria. Dopo
un'altra frazione di secondo si è separata dal resto della compagnia la
forza nucleare forte e infine, quando la temperatura è ulteriormente
scesa - a 10 alla quindicesima gradi - si sono separate l'una dall'altra
anche la forza nucleare debole e quella elettromagnetica (vedi figura
10).
Oggi la temperatura media dell'Universo è di circa 270 gradi sotto zero,
corrispondente ad appena 3 gradi sopra lo zero assoluto (gradi Kelvin):
ovviamente, qua e là si possono avere situazioni locali molto più
confortevoli, come quelle della superficie del nostro pianeta dove noi
viviamo al tepore del Sole...
Via via che l'Universo si andava raffreddando, si sono prodotte
innumerevoli altre rotture di simmetria - con la comparsa di oggetti
fisici sempre più complessi, dalle galassie alle stelle, da queste ai
pianeti e, infine, agli organismi viventi. Ritengo molto opportuno
concettualizzare come una (ennesima) rottura di simmetria la
separazione degli esseri animati da quelli inanimati.
Per comprendere qualcosa della vita bisogna, dunque, avere una
disposizione per la storia. Consideriamo, per esempio, un organismo
pluricellulare come l'uomo. Esso deriva dalla combinazione di due
gameti, la cellula-uovo femminile e lo spermatozoo maschile, i quali
derivano da due organismi adulti, i quali, a loro volta, derivano dalla
combinazione di altri gameti, e così via, fino ad arrivare ai primi
individui appartenenti a quella specie. Questi si saranno originati dai
gameti di altri organismi un po' diversi, e questi da altri gameti derivanti
da altri organismi pluricellulari. Il primo organismo pluricellulare sarà
stato originato dall'aggregazione di alcuni organismi unicellulari, i quali
saranno a loro volta derivati da altri organismi unicellulari e via
discorrendo, fino a risalire al «primo oggetto vivente» comparso sulla
Terra...
A questo punto la catena si interrompe. Il cammino a ritroso che
abbiamo tracciato è pieno di «lacune». Non sappiamo come si siano
formate le prime macromolecole capaci di autoreplicarsi, come si siano
associate ad altre macromolecole capaci di metabolizzare
efficacemente materia ed energia, come tutte queste si siano poi
autosegregate in una membrana cellulare dotata di certe caratteristiche,
e come, dopo centinaia di milioni di anni, un certo numero di tali cellule
primitive si sia aggregato e associato per dare luogo a un organismo
complesso.
Così, come abbiamo detto, la teoria darwiniana dell'evoluzione spiega
molte cose, ma non tutte. Per esempio, non dà ragione dei grandi salti.
Darwin, uomo riflessivo e critico quanto altri mai, ne era consapevole.
Come è possibile che l'occhio, strumento perfetto, compiuto e raffinato,
sia il frutto di una serie di eventi casuali quali la creazione di certi
«mutanti» e la loro affermazione? In una fondamentale pagina del
capitolo sesto dell'"Evoluzione delle specie" - ove poco dopo paragona
la teoria dell'evoluzione alla concezione copernicana non foss'altro che
per la maniera in cui entrambe stravolgono il senso comune - Charles
scrive: «Io confesso liberamente che mi pare il più alto assurdo
possibile supporre che l'occhio sia stato formato, per mezzo
dell'elezione naturale, con tutte le sue inimitabili disposizioni ad
aggiustare il suo fuoco alle varie distanze, ad ammettere diverse
quantità di luce e a correggere l'aberrazione sferica e cromatica» (cito
volutamente dalla prima traduzione italiana, 1864 - reprint Zanichelli,
Bologna 1982, p. 147 -, dove è significativa la scelta di «elezione
naturale» per rendere quella che è oggi per noi «selezione naturale»,
"natural selection"). E ancora, qualche anno dopo, in una lettera:
«L'occhio mi fa venire ancor oggi un brivido freddo, ma [...] la ragione
mi dice che dovrei superare questo brivido» (citato in R. Dawkins, "La
conquista del monte impossibile", trad. it. Mondadori, Milano 1997, p.
132). Non è facile rispondere a queste domande neppure oggi, anche se
si è convinti di aver compreso almeno per l'essenziale i meccanismi
che hanno condotto a tutto ciò e di sapere qualcosina di più circa i
grandi salti.
Abbiamo già enfatizzato il concetto di organizzazione a proposito del
vivente. Nel caso degli oggetti inanimati, la loro permanenza nel tempo
richiede necessariamente una continuità della loro base materiale. Nel
caso degli oggetti viventi, invece, è sufficiente una continuità della loro
organizzazione formale (per esempio, mentre la roccia di oggi è la
stessa di ieri, la mia mano di oggi non è la medesima di ieri: molte
molecole che compongono la mia mano di oggi non sono fisicamente
quelle che facevano parte della mia mano di ieri o che faranno parte
della mia mano di domani). Sappiamo ora che questa particolare forma
di organizzazione che interessa le molecole della materia vivente altro
non è che il frutto della continua consultazione di una serie di istruzioni
che ogni cellula porta racchiusa nel suo nucleo e che prende il nome di
patrimonio genetico o "genoma". Le istruzioni sono scritte in un
linguaggio particolare e si trovano registrate su di un particolare
supporto materiale, chiamato D.N.A. Quest'ultimo consta di un'enorme
macromolecola costituita da una successione, non casuale e non
monotona, di quattro tipi di nucleotidi, A, G, C e T, che vengono letti a
gruppi di tre - per esempio, A.A.T., oppure G.C.T., oppure G.G.G.,
oppure T.T.C. e così via - chiamati "triplette nucleotidiche" o "codoni".
Ciascuna tripletta codifica uno specifico amminoacido, secondo una
tabella di corrispondenze di validità universale, chiamata codice
genetico (vedi figura 11). Le quattrocento-cinquecento triplette che
costituiscono un singolo gene codificano i quattrocento-cinquecento
amminoacidi che costituiscono la proteina corrispondente. Ogni cellula
di un organismo consulta in continuazione la propria lista di istruzioni
biologiche e da queste apprende di volta in volta quali proteine deve
sintetizzare e quindi cosa deve fare e come si deve comportare, sia
autonomamente sia in risposta ai segnali e ai messaggi che le vengano
da altre cellule o direttamente dal mondo esterno. Molte delle molecole
di una data cellula possono essere distrutte con il passare del tempo e
altre subentrano, ma tutte, vecchie e nuove, si conformano a uno
stesso schema organizzativo, sia sul piano strutturale sia su quello
funzionale, perché unico e costante rimane il patrimonio genetico di
questa cellula.
I geni, elementi del patrimonio genetico che trasmettono per così dire le
«istruzioni per l'uso» da genitori a figli, sono di due categorie: quelli
"strutturali", preposti alla formazione del nostro corpo, e quelli
"regolatori", che controllano l'azione dei primi. Esiste, per esempio, un
gene regolatore che controlla contemporaneamente la formazione della
corteccia, della laringe e certe caratteristiche dei reni. Una variazione
casuale su un gene di questo tipo può portare allora a un ampio
sconvolgimento. Per anni ci si è chiesto se nell'evoluzione umana sia
comparso prima il linguaggio o lo sviluppo della corteccia cerebrale:
una questione non risolta, un po' come quella se sia nato prima l'uovo o
la gallina. Si tratta di una domanda, forse, mal posta: può darsi che un
singolo evento genetico abbia prodotto delle alterazioni, così che di
fatto, in un sol colpo, molte sono state le modificazioni intervenute
nell'organismo.
Questa è un'ipotesi particolarmente interessante e, oserei dire,
stimolante, emersa nell'ultimo ventennio. Molto c'è da imparare dalla
lezione dell'evoluzione, anche se non bisogna arrischiarsi in
estrapolazioni eccessive. Essa appare soddisfacente nei limiti
cronologici che si sono specificati sopra. E', infatti, molto arduo
spiegare scientificamente quanto è avvenuto "prima": pur sapendo che
vi è continuità, è difficile rendere conto di come sia stato possibile
passare da un antenato comune a un mammifero da una parte, e a un
insetto, dall'altra. Per esempio, i geni che controllano lo sviluppo della
testa di una mosca sono gli stessi che controllano lo sviluppo della
testa di un essere umano: non c'è dubbio che vi sia continuità, e che i
due rami derivino dallo stesso tronco. Tuttavia, non sappiamo spiegare
perché, da un lato, siano comparsi insetti, che nonostante la loro
perizia e la loro evoluzione sociale, non sono mai riusciti a sviluppare
uno scheletro interno, e dall'altra i vertebrati che, avendolo, possono
raggiungere grandi dimensioni, come le balene. Non c'è altra via per
spiegare tutto ciò se non invocare il caso. Ma questo può offrire
davvero una spiegazione? A volte, ma non sempre.
Se integriamo la teoria dell'evoluzione darwiniana con vere e proprie
"contingenze", quali la caduta di una gigantesca meteorite, un'enorme
eruzione vulcanica, una tempesta solare, o altre catastrofi di cui forse
quasi nulla sappiamo, riusciamo a estendere la spiegazione a qualche
decina di milioni di anni prima - ma non di più.
Infine, pare ancor più difficile spiegare in questi termini gli eventi di
quell'ultimo periodo che ha visto la comparsa e l'affermazione
dell'uomo. E' indubbio che vi sia stata un'evoluzione biologica delle
diverse parti dell'organismo, del cervello, e una crescita dello spessore
della corteccia. Quindi, non è nemmeno esatto dire che non sappiamo
niente. Tra una corteccia cerebrale grossa e una piccola c'è una
differenza di complessità - anche se questo non garantisce
automaticamente la nascita di un'intelligenza, di un linguaggio o di una
coscienza.
Accostandosi alla complessità dell'essere umano, ancora oggi la
scienza arranca, per così dire. Eppure, sono abbastanza sicuro che nei
prossimi dieci o vent'anni comprenderemo molte più cose (come mi
pare aver mostrato in queste poche righe, sono un inguaribile
ottimista). Possiamo imparare qualcosa anche dal fallimento di certi
programmi. Alludo, per esempio, alla cosiddetta Intelligenza Artificiale
(I.A.). La caratteristica principale di un computer, quella di essere un
elaboratore di "informazione", è stata assunta da molti esperti di I.A.
come elemento fondamentale (anche se non unico) delle funzioni
mentali: per costoro la realizzazione di calcolatori sempre più potenti ha
rappresentato, come minimo, qualcosa di molto simile a quello che i
matematici chiamano un «teorema di esistenza», vale a dire la prova del
fatto che mediante semplici elaborazioni di dati e simboli è possibile
portare a termine un numero non trascurabile di «operazioni mentali».
Personalmente, ho una certa simpatia per l'approccio che ricorre al
computer per tentare di capire come la «mente» funzioni, ma credo che
non vada dimenticato quel particolare insegnamento del computer che
ci indica come la «mente» "non funzioni", che ci fa cioè capire come
essa non viva soltanto di ragionamenti e processi logici. Qualunque sia
la definizione di mente, essa deve comprendere anche il quotidiano di
una vita interiore scandita da non pochi aspetti affettivi. Del resto, la
mente non si comporta come un computer convenzionale, nemmeno
nei processi che ci paiono più razionali: troppo spesso le nostre
classificazioni sono approssimate, le nostre valutazioni arrischiate, le
nostre convinzioni scarsamente controllabili - inoltre, la passione si
mescola indissolubilmente alla conoscenza, mentre aspetti cognitivi
modellano i nostri atteggiamenti e comportamenti più passionali. Infine,
un computer per funzionare dipende da un "programma", il nostro
cervello invece da una "storia", anzi vorrei dire che la storia è la cifra
stessa della «mente»: una storia di vincoli fisici e biologici, ma anche di
orizzonti personali e sociali. Quindi, proprio là dove sono in gioco le
caratteristiche più pregnanti del nostro io, mi sembra giusto procedere
con ancor maggior prudenza e cautela. Vorrei definirmi un «illuminista
romantico» che accoglie la lezione scientifica e cerca di «guardar
lontano», sapendo che c'è sempre qualcosa di «ancor più lontano». Mi
piace qui ricordare una celebre immagine di Kant per cui la conoscenza
sarebbe un processo asintotico. Pensiamo a una curva che si avvicini
sempre più a un determinato asse, ma non lo incontri mai o, come
dicono i matematici, solo all'infinito. Ecco, l'investigazione scientifica è
un processo del genere: ci avvicineremo sempre più a un complesso
coerente di spiegazioni... per degli esseri umani, è già tanto.
DIALOGO
(Carlo Maria Martini e Julian Chela-Flores).
CARLO MARIA MARTINI: Quali sono le conoscenze consolidate e quali,
invece, i problemi aperti relativamente all'origine della vita sulla Terra, e
gli indizi a favore dell'origine extraterrestre della vita?
JULIAN CHELA-FLORES: Ciò che conosciamo abbastanza bene è come
la chimica organica abbia fatto i primi passi verso la vita, là dove si
parla di «evoluzione chimica». Ciò che resta ancora insoluto è il
passaggio dall'evoluzione chimica a quella biologica. Per quanto
riguarda gli indizi di vita extraterrestre possiamo solo dire che per ora
si basano esclusivamente sull'universalità delle leggi della natura.
L'oggetto principale di quella nuova disciplina indicata come
"astrobiologia" o anche "esobiologia" è proprio lo studio dell'origine,
evoluzione e distribuzione della vita nell'Universo. Le risposte, che si
dovrebbero ottenere nei prossimi decenni, potranno aprire nuove
prospettive anche sulla comparsa e sull'evoluzione della vita sulla
Terra.
MARTINI: Lei ha parlato, come di cosa ovvia, dell'albero della vita, che
avrebbe tre rami. Potrebbe spiegare che cosa intende con questi
«rami»?
CHELA-FLORES: Una volta alle scuole elementari ci parlavano dei
cinque regni del vivente (animali, piante, funghi, eucarioti e procarioti; o
anche: animali, piante, funghi, protozoi e batteri). Oggi i biologi hanno
raggiunto la convinzione che tutti gli organismi presenti sulla Terra
vadano ripartiti in tre raggruppamenti fondamentali caratterizzati dalla
loro struttura cellulare. E si parla di domini invece che di regni. Con
l'immagine dell'albero a tre rami enfatizzavo, dunque, come la biologia
si servisse di una classificazione a tre grandi tipi, a seconda del tipo di
cellula. Così noi finiamo nello stesso gruppo dei microorganismi, per
così dire siamo degli eucarioti! Tutto ciò è davvero profondo, perché
semplifica le cose. Per esempio, Edoardo Boncinelli ha parlato di vari
milioni di specie viventi - dieci milioni più, dieci milioni meno (vedi p.
55). Ma se ci riferiamo al livello molecolare, ci sono unicamente tre tipi
distinti di vita.
MARTINI: Lei ha anche ventilato la possibilità che in qualche parte
dell'Universo si scopra la presenza di un secondo albero, o addirittura
di una foresta di alberi della vita. Quali conseguenze ne verrebbero per
la consapevolezza che l'uomo ha di sé e per la coscienza del credente,
se emergesse una foresta di alberi della vita con cui doversi
confrontare?
CHELA-FLORES: E' noto come sia in atto una missione per cercare vita
sotto il ghiaccio di Europa e le grandi agenzie a livello mondiale
sponsorizzino il programma di ricerca della vita fuori della Terra. Credo
che prima o poi verrà il momento del confronto a cui Lei allude. E a
questo punto, come ha già sottolineato George Coyne (vedi p.p. 39-40),
l'onere sarà del teologo. Da parte mia spero che un'eventuale scoperta
di forme di vita in un qualche senso intelligenti, se mai vi sarà, possa
svolgersi da entrambe le parti in un quadro di ben minore aggressività
di quello che ha visto i coloni europei impadronirsi delle risorse del
Nuovo mondo.
MARTINI: Ma come un'evenienza del genere, secondo Lei, potrebbe
influire sul delicato equilibrio tra spregiudicatezza scientifica e apertura
alla fede?
CHELA-FLORES: E' già stato ricordato come l'eventuale scoperta di
altre specie di animali e di altre stirpi di «uomini» (cioè di "esseri
intelligenti") in mondi lontani possa venir invocata contro l'idea di una
provvidenza divina (era così in Lucrezio, "De Rerum Natura", II, v.v.
1067-1076 e 1090-1104, vedi del resto "questo volume", p. 16). Se
«tutto» si replica, seppur in «luoghi» e «tempi» diversi, che senso può
avere l'argomento del Progetto o Disegno di Dio?
Eppure, io non sono disposto a trarre questa conclusione Vorrei
ricordare che Lucrezio, nei passi sopra richiamati, dalla pluralità dei
mondi e dalla considerazione di una eventuale «foresta della vita»
perviene alla celebrazione di una «natura libera», anzi «priva di padroni
superbi» ("dominis privata superbis", "De Rerum Natura", II, v. 1091) ma il Dio in cui io personalmente credo, il Dio "cristiano" è tutto tranne
che «un padrone superbo»! Come dice bene John Polkinghorne, il
fisico britannico che si è fatto pastore anglicano, l'Universo in cui
viviamo è un universo «cui Dio ha concesso di essere sé stesso»
("Quark, caos e Cristianesimo", trad. it. Claudiana, Torino 1997, p. 99):
dunque, in esso la vita (e l'intelligenza) può «comparire» secondo le
modalità che sono "ammesse" dalla struttura di tale universo (cioè dalle
sue «leggi»). Certo, la scoperta di una «foresta» della vita o
l'individuazione di qualche «intelligenza» cosmica, ben lontano dalla
nostra «piccola» Terra, darebbe ai teologi non pochi problemi su cui
misurare la "loro" intelligenza! Ma sarebbe un male? Ancora con
Polkinghorne, penso che la teologia più attenta già da tempo abbia
compreso come «le nostre immagini di Dio [siano] inadeguate
all'infinita ricchezza della sua natura» (op. cit., p. 104), sicché la
necessità della "revisione" è sempre presente... Per questo continuo a
ritenere che uno scienziato "possa" essere credente.
MARTINI: Lei torna così a quel «dialogo tra fede e non fede» da cui
aveva preso le mosse, citando all'inizio anche un "non credente come
Bertrand Russell...
CHELA-FLORES: In un certo senso, è così. Ma ogni volta che si sia
realizzato almeno un frammento di tale dialogo, in modo onesto - si
tratti del dialogo pubblico tra due diversi interlocutori o del dialogo
tutto interiore tra il credente e il non credente in cui «si sdoppia»
ciascuno di noi - non ci si ritrova semplicemente al punto di partenza,
perché «qualcosa» ha lavorato dentro di noi, scavando nelle nostre
«convinzioni» (o «non convinzioni»). Così, all'argomento (invero
alquanto tradizionale) che in caso di vita «altrove» abbastanza
sviluppata (tale, per esempio, da includere l'intelligenza o forse
l'autocoscienza) chiedeva (spesso non senza sarcasmo) se si sarebbe
«replicato» l'intero dramma del peccato originale e della redenzione, mi
piacerebbe rispondere con un passo del Vangelo di Marco (12,18-27)
che anche Polkinghorne ama citare, sebbene in un contesto alquanto
diverso (op. cit., p. 96). Dei Sadducei espongono a Gesù l'ipotetico caso
di una donna che era stata sposata a una serie di fratelli deceduti l'uno
dopo l'altro, chiedendogli: «Quando risorgeranno, a chi di loro
apparterrà la donna?» (12, 23) - solo per sentirsi rispondere che il Dio
davanti cui si troveranno i risorti «come angeli nel cielo» senza che più
sussistano «moglie né marito» (12, 25), quel Dio che Gesù annuncia,
«non è un Dio dei morti ma dei viventi! Voi siete in grande errore» (12,
27).
Così "ovunque" Dio resta il Dio della vita.
DIALOGO
(Carlo Maria Martini ed Edoardo Boncinelli).
CARLO MARIA MARTINI: Qualche precisazione sui «grandi salti» della
storia del vivente. Ha davvero senso guardare all'intero cosmo per
comprendere la vita - o anche qui dobbiamo riconoscere che sappiamo
troppo poco?
EDOARDO BONCINELLI: Riprenderei alcuni spunti di Chela-Flores.
Incontreremo mai quei «marziani» o quegli «andromediani» di cui tanto
ha favoleggiato la fantascienza, di oggi come di secoli fa? E se ciò
avvenisse, come cambierebbero le nostre concezioni del cosmo, della
vita e della stessa intelligenza? Personalmente, sono abbastanza
scettico circa l'esistenza di altre forme di vita nell'Universo - anche se
entro la comunità scientifica non mancano coloro che sono pronti a
scommettere qualsiasi cifra sul fatto che esista «qualcosa di vivente»
fuori dalla Terra. Tuttavia, non sono affezionato all'idea dell'unicità del
fenomeno vita: ammetto volentieri che prima di morire mi piacerebbe
constatare se esistano veramente altre forme di vita, di conoscenza, di
civiltà. Il fatto è che la vita ci appare così particolare, così peculiare che
ci chiediamo se poteva essere realizzata in modo unico oppure no.
D'altra parte, l'idea di un'ipotetica vita intelligente al di fuori del nostro
pianeta solleva un tema affascinante. Penso, per esempio, alla celebre
battuta di Wittgenstein: «Vedo un quadro: rappresenta un vecchio che
avanza per un erto sentiero appoggiato a un bastone - Ma come? Non
potrebbe darsi che il quadro rappresenti un vecchio che, in quella
posizione, sta scivolando indietro lungo il sentiero? Forse un abitante
di Marte descriverebbe quel quadro così. Non è necessario che io
spieghi perché "noi" non lo descriviamo nel modo anzidetto»
("Ricerche filosofiche", trad. it. Einaudi, Torino 1967 e 1983, p. 75). Nel
momento in cui arrivasse il marziano di Wittgenstein o un
andromediano, non si potrebbe affrontare sperimentalmente il
problema della relazione tra conoscenza o immagine del mondo e
costituzione fisica del cervello e degli organi di sensazione, e osservare
i vari gradi di dipendenza?
MARTINI: Nel suo intervento Chela-Flores ha ricordato le parole di
Giovanni Paolo Secondo: «La teoria dell'evoluzione è più che
un'ipotesi» (vedi p. 45). Da quanto Lei dice ho l'impressione che essa
possa essere considerata una spiegazione scientificamente
soddisfacente per un'ampia gamma di fenomeni...
BONCINELLI: La biologia di oggi è letteralmente dominata dall'idea di
evoluzione biologica del vivente. Questa concezione trova la migliore
articolazione nel quadro della teoria dell'evoluzione per selezione
naturale, la cosiddetta teoria "neodarwiniana" (vedi p. 54). Essa si basa
su due tesi fondamentali: la prima, per cui tutti i viventi hanno avuto
origine da antichissimi antenati comuni; la seconda, per cui le varie
categorie di organismi si sono evolute e differenziate tra di loro
soprattutto a opera della «selezione naturale». Non ha molto senso
applicare la teoria ai "primissimi eventi" all'origine della vita sulla Terra,
e nemmeno, probabilmente, agli eventi che hanno portato alla
formazione delle prime grandi suddivisioni del regno animale e di
quello vegetale. Ma da quel momento in poi, vale a dire per tutti gli
ultimi cinquecento o seicento milioni di anni, è stata la selezione
naturale a creare, modellare e rimodellare le varie specie. Dunque, per
una vasta gamma di fenomeni la teoria dell'evoluzione è una
spiegazione altamente soddisfacente. Certo, non lo è per tutto: proprio
quei grandi salti che tanto ci appassionano restano materia di rischiosa
congettura. Il problema della macroevoluzione rappresenta ancor oggi
una sfida aperta: come si è formata la prima cellula? Come si è formato
il primo organismo pluricellulare? Il darwinismo non sa spiegarlo. Del
resto, Charles Darwin disperava che mai, per esempio, si sarebbe
riusciti a spiegare l'origine dell'occhio in termini di piccoli cambiamenti.
L'impresa scientifica è davvero un "work in progress" in cui è
importante evitare di fare «un passo avanti, due indietro». Molte cose
non siamo oggi in grado di spiegare, ma questo non vuol dire
rinunciare a cercare.
MARTINI: Se l'evoluzione biologica forgia tutto il vivente, l'"Homo
sapiens" è andato affiancandole e sovrapponendole nel corso del
tempo un altro tipo di evoluzione, quella "culturale". Che cosa significa
per gli individui della nostra specie restare esseri biologici e insieme
acquisire la dimensione di esseri culturali?
BONCINELLI: Amo dire che è proprio grazie alla sua cultura e alla sua
storia che ogni essere umano si trova ad avere a disposizione qualcosa
come il patrimonio di cento o mille cervelli affacciati sul mondo e
aggregati al suo. L'evoluzione culturale consente a ogni individuo di
non dover sempre ricominciare da capo. Ogni essere umano, almeno in
linea di principio, è in grado di avvalersi dei contributi portati alla
cultura umana da innumerevoli altri individui che sono esistiti o che
esistono in altri luoghi o in altri tempi. Ricordiamo l'elogio della
scrittura che conclude la Prima Giornata del "Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo" (1632) di Galileo Galilei: «sopra tutte le
invenzioni stupende» la scrittura consente di «parlare con quelli che
son nell'Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se
non di qua a mille e diecimila anni», e inoltre «con qual facilità? con i
vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta ("Opere", VII,
p.p. 130-131). Dalla scrittura al computer: la crescita tecnologica è al
contempo parte integrante e condizione dell'evoluzione culturale. In
generale, tale evoluzione è costellata da una serie di retroazioni: il
cervello dei primi uomini li ha messi in condizione di approntare e
utilizzare strumenti che non esistevano in natura o non venivano
percepiti come tali da altre specie. L'impiego di questi «artifici» ha
iniziato a cambiare materialmente l'ambiente in cui gli uomini si
trovavano a vivere, creando nuove esigenze e nuove opportunità. Ogni
tecnologia, per quanto primitiva, ha condotto alla necessità di
sviluppare tecnologie ulteriori, rinsaldando la cooperazione tra individui
diversi del medesimo insediamento. A loro volta, gli aspetti etici e
politici di questa convivenza hanno modellato i lineamenti della stessa
cultura materiale, eccetera.
MARTINI: Quale relazione, dunque, tra evoluzione biologica ed
evoluzione culturale? E come si ridefiniscono alla luce di essa nozioni
come «mente», «pensiero» e «spirito»?
BONCINELLI: Non pochi animali sono sociali, ma l'animale uomo si è
trovato a vivere in condizioni e situazioni "sempre più sociali": ciò si è
riflesso sulla sua stessa evoluzione biologica. Questa ha i suoi propri
ritmi, dettati dalla biologia delle specie implicate. Al contrario,
l'evoluzione della cultura, anche di quella materiale, può avere un ritmo
molto più accelerato, mettendoci in condizione di tener conto delle
mutate esigenze dell'ambiente in pochi decenni o addirittura in pochi
anni. Un ambiente diverso crea esigenze differenti e sviluppa talenti
differenti. Le doti biologiche di un singolo uomo e la varietà delle
articolazioni dell'organizzazione sociale di cui fa parte non possono
andare oltre un certo "limite", ma l'"orizzonte" della sua capacità di
immaginazione e di astrazione è ben più ampio. Quando il cervello
dell'uomo non si è più potuto materialmente espandere, perché ciò
avrebbe messo a repentaglio la sua sopravvivenza e la sua capacità di
riprodursi, si sono espansi i suoi correlati astratti, vale a dire la mente e
il pensiero. Qui l'individuale rimanda al collettivo, e viceversa. Il motore
dell'evoluzione culturale (nell'accezione più ampia del termine) resta
l'interazione tra gli individui - così anche il «pensiero» andrà inteso
come un'attività collettiva destinata a sedimentarsi, stratificarsi e a
costituire una sorta di impalcatura del modo di ognuno di vedere e
vivere il mondo. E il complesso delle attività che l'uomo promuove nel
suo tentativo di orientarsi nel mondo diviene veramente la
manifestazione di quello che i filosofi più diversi - da Hegel a Popper hanno chiamato «spirito». Non credo che sia lo spirito a «produrre» la
realtà, bensì che sia dallo scontro con questa che lo spirito riesca ad
arricchirsi e a migliorarsi. Comunque, del mondo dello spirito fa parte
l'avventura della scienza. In particolare, quella della biologia, cioè la
scienza del vivente, e di quel particolare vivente che è l'uomo. E' vero
che la nostra mente non è nata per comprendere se stessa, ma per far
fronte alle sfide poste dall'ambiente e ai problemi sempre più complessi
sollevati dalla convivenza umana. Tuttavia, essa si è imbattuta nel
problema della propria comprensione, magari a causa di quegli strani
individui cui diamo il nome di filosofi: considero questa la «follia delle
follie»..., ma penso pure che senza un pizzico di tale follia la vita non sia
degna di essere vissuta.
3.
INTELLIGENZA E SCIENZE COGNITIVE.
LE BASI BIOLOGICHE DELLA CONOSCENZA
(Giuliano Avanzini).
L'orizzonte in cui si colloca il presente contributo è quello delineato
dalla speciale relazione tra noi e il mondo che chiamiamo
"conoscenza". Tale relazione è il presupposto stesso di qualunque tipo
di indagine. Non si può parlare, infatti, di ricerca scientifica senza
presupporre la possibilità di una conoscenza - d'altra parte, il valore di
qualsiasi metodologia scientifica viene misurato dall'avanzamento di
conoscenza che essa produce. La biologia è investita da un ulteriore
problema. Qui, oggetto e soggetto della ricerca coincidono: l'uno come
l'altro rientrano nel dominio del vivente. Sotto il profilo strettamente
biologico, è sufficiente assumere che una forma di conoscenza sia
implicita nel rapporto attivo che l'essere vivente istituisce con il mondo.
L'insieme delle azioni e delle reazioni che il vivente intrattiene con il
proprio ambiente sarebbe infatti impossibile, se non esistesse un
qualche grado di conoscenza. Ciò fornisce una chiave biologica per
l'interpretazione della conoscenza in termini di interazione tra vivente e
ambiente.
Data, dunque, per accettata la possibilità della conoscenza, iniziamo il
nostro discorso dai modi della percezione, con una particolare
attenzione alle basi biologiche, anzi neurobiologiche, dei nostri
processi percettivi.
La neurobiologia è una scienza relativamente giovane: il significato di
questo ammasso di materia grigia e biancastra che costituisce il nostro
sistema nervoso è rimasto enigmatico per secoli, se non per millenni.
Neppure il fiorire degli studi naturalistici del Rinascimento ha gettato
molta luce sulla struttura e sulla funzione del sistema nervoso. Se
dovessi scegliere una data di nascita per la neurobiologia, opterei per
una sera tempestosa del settembre 1786, quando l'anatomista
bolognese Luigi Galvani (1737-1798) aveva escogitato un esperimento a
casa propria, appendendo con degli uncini metallici alla ringhiera del
balcone gli abituali preparati neuromuscolari di rana (vedi figura 12 (a) e
(b)) su cui voleva controllare l'effetto dell'elettricità atmosferica (e per
questo aveva scelto una serata di temporale). Così facendo si accorse
casualmente che, quando toccava la ringhiera di ferro, il muscolo si
contraeva; interpretò il fenomeno come dovuto alla chiusura di un arco
di un circuito che permetteva il passaggio di cariche elettriche,
generate nel midollo spinale, al muscolo. Veniva in tal modo delineato il
concetto di una "elettricità animale" che poteva essere alla base del
funzionamento del sistema nervoso (per la storia della quale rimando,
per esempio, a M. A. B. Brazier, "A History of Neurophysiology in the
17th & 18th Centuries", Raven Press, New York 1984, in particolare p.p.
205-217).
Galvani doveva confermare questo effetto in esperimenti condotti in
laboratorio. Ma tali esperimenti vennero replicati da Alessandro Volta
(1745-1827) che, diversamente da Galvani, era un fisico interessato
all'elettricità. Lo scienziato comasco confermò il risultato, ma lo
interpretò ben diversamente, finendo con il negare che l'effetto
scoperto da Galvani fosse dovuto a elettricità animale, sostenendo
invece che l'elettricità fosse causata dal contatto fra due "diversi"
metalli. Nello specifico Volta aveva (parzialmente) ragione: del resto, è a
tutti nota la vicenda dell'invenzione della pila che gli fruttò onori e
denari. Ma, in un senso più generale, aveva ragione Galvani, poiché
l'elettricità animale c'era, anche se semplicemente coperta dall'effetto
Volta, come poi Galvani stesso e suo nipote Giovanni Aldini (1762-1834)
riuscirono a mostrare con altri esperimenti. Oscurata dal successo di
Volta, in cui ebbe una parte di primo piano persino Napoleone,
l'intuizione di Galvani restò patrimonio di pochi, quegli specialisti che
nell'Ottocento con pazienti ricerche di laboratorio raffinarono i concetti
delineati dall'anatomista bolognese, gettando infine le basi di una
nuova disciplina pertinente il sistema nervoso, l'"elettrofisiologia" (è la
disciplina a cui appartengo, ed è pertanto naturale che mi dilunghi un
poco sulle sue origini).
Nell'Ottocento il sistema nervoso andava rivelando anche la sua
«organizzazione fine» attraverso una serie di studi che, alla fine del
secolo, culminarono in un'altra celebre controversia: quella tra Camillo
Golgi (1843-1926) e lo spagnolo Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) se le cellule nervose fossero tra loro tutte direttamente collegate a
formare un «reticolo diffuso» oppure staccate (vedi figura 13) ancor che
reciprocamente connesse. Nel Novecento lo scenario muta
radicalmente con l'avvento della biologia molecolare che apre la via
all'indagine della struttura e della funzione dei componenti cellulari
elementari e alla neurogenetica molecolare.
Oggi sappiamo che il sistema nervoso è un complesso di stazioni e di
vie che le collegano, costituite da cellule nervose e dai loro
prolungamenti o fibre, secondo un'architettura estremamente precisa e
complicata, i cui segreti (in parte) sono stati svelati dallo studio dello
sviluppo del sistema nervoso nella vita sia prenatale sia postnatale.
Sappiamo inoltre che le cellule nervose, pur appartenenti a stazioni
diverse, possono comunicare tra loro attraverso delle vie a rapidissima
conduzione sulle quali viaggia l'impulso nervoso, un fenomeno
elettrochimico generato a livello della cellula. Quando l'impulso
nervoso arriva all'estremità della fibra, cioè alla terminazione della fibra
nervosa, il messaggio che deve passare alla cellula successiva è
mediato da una sostanza chimica nota come «neurotrasmettitore».
Questo reagisce con la membrana della cellula successiva e trasmette
il messaggio. In tale punto di giunzione, che prende il nome di
«sinapsi» (termine inventato da Charles Sherrington (1861-1952),
premio Nobel nel 1932), può prodursi una serie di elaborazioni dei
segnali che viaggiano su queste vie, poiché l'evento mediato da una
interagisce con tutte le altre sinapsi che arrivano sulla stessa cellula
(ne possono arrivare fino a un milione su un'unica cellula nervosa:
possono sommarsi, sottrarsi, e comunque interagire). Inoltre, la sinapsi
è il punto dove più facilmente avviene una modulazione della
trasmissione per effetto di varie sostanze fra cui, per esempio, gli
ormoni; molti dei farmaci che vengono abitualmente utilizzati vanno ad
agire in questo punto. E ancora, la sinapsi ha un'importantissima
proprietà, che è quella dell'adattabilità in rapporto all'uso, o «plasticità»,
la quale ha un'enorme rilevanza nella spiegazione della funzione
nervosa. Sostanzialmente, tutto è organizzato per facilitare la
comunicazione e, al tempo stesso, salvaguardarne la specificità - il che
è dovuto alla suddetta architettura delle vie che devono portare i
messaggi e a una differenziazione dei neurotrasmettitori, che sono
specifici a seconda del tipo di messaggio (eccitatorio, inibitorio) che
devono portare.
L'informazione che proviene dal mondo esterno entra nel sistema
nervoso attraverso i recettori. Questi sono tessuti modificati in maniera
tale da essere sensibili a variazioni di energia dell'ambiente. Per fare un
esempio abbastanza comprensibile pensiamo alla retina: in essa vi
sono delle cellule recettoriali (i coni e i bastoncelli) che vengono
modificate dalla luce, e questa loro modificazione genera un primo
segnale che innesca una catena di eventi nella via nervosa che porta il
messaggio fino alla corteccia visiva. Studiando il sistema visivo
abbiamo appreso che il messaggio proveniente dalla periferia, lo
stimolo che va a colpire il recettore, viene fin dall'inizio, cioè fin dalla
porzione più periferica, acquisito e analizzato in maniera differenziata
nei suoi vari aspetti. Per esempio, la forma, il colore, la cinetica (cioè il
fatto che lo stimolo sia in movimento o sia fermo) e le coordinate
spaziali entro cui si colloca lo stimolo sono analizzati da sottosistemi
differenziati. E' interessante constatare che il sistema che si occupa
della localizzazione dello stimolo nello spazio è già molto sviluppato
negli animali più semplici; evidentemente, si tratta di un tipo di
informazione importante per la sopravvivenza. Ciò appare del resto
logico; immaginiamo per esempio che lo stimolo sia generato
dall'avvicinarsi di un predatore: non importa, allora, sapere se il
predatore abbia i baffi lunghi o corti; quel che interessa è sapere da
quale direzione stia arrivando per fuggire immediatamente in direzione
opposta...
Altre cose ci ha insegnato lo studio del sistema visivo, per esempio il
fatto che esistano nel sottosistema che si occupa dell'analisi della
forma cellule che sono sensibili alle forme geometriche al punto che
alcune cellule sono specificamente sensibili a determinate ampiezze di
un angolo. Questo ci induce a congetturare che l'invenzione della
geometria non derivi tanto dall'osservazione della realtà, quanto dal
modo con cui viene osservata, che dipende a sua volta da proprietà
insite nel tipo di analizzatore che viene messo in causa (in realtà, le
buone forme geometriche in natura non sono poi molte: i cristalli,
qualche particolare guscio di animale...).
Ciò che si è detto per il sistema visivo può essere applicato a tutti gli
altri sistemi. Alla fine, le aree che si ritrovano sulla corteccia cerebrale
dove arrivano tutte le informazioni dal mondo esterno sono moltissime
(solo per il sistema visivo se ne sono contate fino a 32), ma tutte
strettamente interconnesse: tutto quello che è stato fino a quel
momento in qualche modo disaggregato può venire riaggregato
secondo diverse modalità che, per esempio, tengano in considerazione
le informazioni che arrivano su diversi canali sensoriali e sono relative
allo stesso tipo di fenomeno o di oggetto. La percezione globale nasce
infatti dalla sintesi di informazioni somestesiche, visive, uditive,
olfattive e gustative relative all'effetto della percezione. Si usa dire che
nel cervello, e in particolare nella corteccia, sia presente una "mappa
del mondo" - metafora forse non del tutto felice perché il termine
«mappa» evoca immediatamente un osservatore capace di utilizzarla
per orientarsi. Qui, però, non c'è alcun osservatore esterno: la mappa è
piuttosto dentro l'osservatore, coincide con lui, è il suo modo di
osservare la realtà (vedi figura 14).
Non possiamo sapere come sia "realmente" il mondo: già gli antichi,
del resto, conoscevano gli inganni dei sensi (il bastone che immerso
nell'acqua appare spezzato) - per non parlare delle varie illusioni ottiche
ottenute giocando sul rapporto figura/sfondo (pensiamo alle immagini
care agli psicologi della "Gestalt" di cui la figura 15 porta un esempio).
Ne abbiamo una prova ancora più sottile e inquietante: i messaggi
infraliminari, quei messaggi, cioè, che non arrivano a livello della
coscienza, ma sono comunque in grado di influenzare il
comportamento delle persone come «persuasori occulti». Tanti
osservatori, tante diverse percezioni del mondo - ce ne rendiamo conto
anche studiando il comportamento dei nostri animali domestici come
cani e gatti, che esperiscono il mondo grazie a informazioni, per
esempio olfattive, di cui noi non disponiamo se non in forma
rudimentale. Non siamo in grado, dunque, di accedere alle cose in sé,
anche se possiamo "constatare" la rispondenza delle nostre percezioni
alle nostre e/o altrui azioni compiute nel mondo esterno. Tale confronto
può avvenire anche in rapporto con altri individui; e proprio la
congruenza con altri soggetti, o meglio la congruenza della "mia"
percezione del mondo con la "tua", costituisce la base su cui costruire
una cultura "comune".
Si possono approfondire i metodi di indagine e si può percorrere molta
strada nella conoscenza biologica della percezione: c'è, però, un limite
che resta insuperabile per il biologo. Si tratta del «passaggio» per cui la
percezione dei segnali che arrivano dall'esterno diventa parte del Sé. Di
fronte a questo limite il biologo è costretto ad assumere che
l'autocoscienza sia implicita nei processi di conoscenza analizzabili
sulla base del comportamento, senza poterne fornire una dimostrazione
diretta.
Come si è detto, la rappresentazione sensoriale del mondo non è solo
dell'uomo, anzi per alcuni animali è addirittura più ricca. C'è qualche
cosa che, però, è peculiare dell'uomo: un secondo tipo di
rappresentazione del mondo, quella nel dominio linguistico. Essa
consente una notevole facilitazione dei processi di categorizzazione
della realtà, nonché combinazioni inedite di esperienza, permettendoci
in qualche modo di prevenire un'esperienza o addirittura di
contraddirla, e comunque di trascenderla attraverso il gioco della
rappresentazione verbale. Il linguaggio potenzia in maniera
straordinaria il trasferimento dell'esperienza da un individuo all'altro, e
anche da una generazione all'altra, rappresentando così un elemento
essenziale per la costituzione di una cultura. Conferisce a chi lo
possiede la capacità di descrivere se stesso e il mondo, ed è così
strumento fondamentale per la riflessione.
Per questo si può legittimamente sostenere che il linguaggio sia criterio
necessario e sufficiente per differenziare la specie umana dalle altre
specie animali, con buona pace degli studiosi del linguaggio animale. I
risultati di questi studi peraltro affascinanti non ci hanno infatti fino a
ora fornito evidenze di un uso spontaneo del linguaggio nel mondo
animale anche lontanamente paragonabile a quello che caratterizza la
specie umana.
Il linguaggio dà forma allo stupore e alla «meraviglia» che il mondo
suscita in noi fin da quando, bambini, chiediamo i primi «perché».
Abbiamo cominciato allora, non abbiamo più smesso: fiduciosi (se
siamo credenti) che alle domande esistano delle risposte ultime;
convinti (se, come me, non credenti) che questa aspettativa sia
infondata e che la catena delle domande e delle risposte possa
svolgersi all'infinito. Tutti però, credenti e non, accomunati da quella
inesauribile tensione verso la conoscenza che ci rende uomini.
MENTE E CERVELLO
(Alberto Oliverio).
Da sempre la mente è al centro della "riflessione filosofica", ma è solo
di recente, appena da pochi decenni, che le "neuroscienze" hanno
cominciato a studiarne in modo rigoroso le caratteristiche. Attenzione,
sensazione, percezione, sonno, memoria, apprendimento, emozione
sono soltanto alcune delle funzioni cerebrali che vengono analizzate,
collegate a circuiti e a strutture nervose, interpretate alla luce delle
nuove conoscenze che provengono da discipline sperimentali in
continua e rapida espansione. Per esempio, le neuroscienze hanno
compiuto enormi progressi nello studio della memoria, nella
identificazione delle sedi di alcune attività mentali, nella comprensione
di alcune alterazioni o "deficit" del comportamento: parlano il
linguaggio del "riduzionismo", in linea con tutto quel sapere scientifico
che è in grado di analizzare sempre più a fondo la realtà che ci circonda
e di modificarla attraverso le tecnologie. Considerato in quest'ottica, il
cervello può sembrare una complessa macchina che i ricercatori
smontano e riducono alle sue diverse parti nel tentativo di sottrarlo a
quell'alone di mistero che da tempo lo circonda.
Eppure, per quanto entusiasmanti e suggestive paiano le scoperte delle
neuroscienze, esse non hanno ancora chiarito come i diversi
«meccanismi» del cervello "cooperino" e come dalla loro interazione
emerga una "mente" che non deriva dalla semplice somma di singole
attività, separate tra di loro da compartimenti stagni. Conosciamo, per
esempio, i meccanismi dell'emozione, il gioco di molecole che ne è alla
base, i centri nervosi che vi sono coinvolti: ma cosa possiamo dire,
come nota anche Sergio Moravia (vedi "L'enigma della mente", Laterza,
Roma-Bari 1986), del significato dell'emozionarsi, dei suoi rapporti con
lontane esperienze, del modo in cui le emozioni contribuiscano a dare
un senso alla nostra esistenza, a orientare i nostri fini, a strutturare i
nostri schemi mentali? Anche se alcune teorie della mente tengono
conto dei risultati che provengono dalle conoscenze neuroscientifiche,
la mente cui guarda il filosofo è diversa da quella descritta dallo
psicobiologo: nonostante siamo sempre più in grado di analizzare il
cervello e di comprenderne i meccanismi, restiamo lontani dal
considerarlo in modo unitario, dal comprendere come dalla materialità
dei circuiti cerebrali possa scaturire quel mondo dei significati che ci
guida in ogni azione, anche la più banale, della vita quotidiana.
Tradizionalmente, lo studio delle attività psichiche è aperto a due campi
di indagine che sembrano essere tra loro in conflitto: da un lato,
filosofi, psicoanalisti e psicologi si indirizzano a un ricco mondo
soggettivo, a vissuti densi di significato, a una realtà nascosta che è
necessario interpretare; dall'altro, gli studiosi del cervello vanno alla
ricerca di un mondo oggettivo, palese, accertabile, in cui gli eventi
psichici e i fenomeni mentali si traducano in correlati dotati di
un'inoppugnabile evidenza. Le tecniche di cui dispongono oggi gli
scienziati del cervello sono sempre più affascinanti, in grado di
spalancare una porta su quel mondo oscuro che si cela all'interno della
nostra testa. Pensiamo, per esempio, alle tecniche che utilizzano i
neurologi, ben più potenti di quelle radiografie che un tempo
consentivano di «vedere» il cervello ed eventualmente di svelarne i
processi patologici: oggi tecniche come la TAC, la PET, la R.M.N.
fondono il sapere del radiologo con quello dell'esperto in computer e
consentono di guardare «in diretta» al funzionamento del cervello e di
evidenziare se una particolare area cerebrale sia più attiva quando il
nostro cervello svolge una specifica funzione. Vedere, udire, provare
dolore, memorizzare, ricordare, pensare, eccetera, implicano che una
data parte del cervello «lavori» più di quelle circostanti, in altre parole
che vi siano regioni cerebrali responsabili di funzioni ben precise.
Dopo che il neurologo ha puntato il dito su queste regioni,
candidandole a rappresentare i diversi ruoli di cui si compone il nostro
comportamento, neurofisiologi e biochimici si concentrano su
minuscole caratteristiche funzionali o strutturali di quelle parti del
cervello che sono «responsabili di», per porre in evidenza quali siano le
basi materiali del vedere, dell'udire, del memorizzare, eccetera. In tal
modo un evento, per esempio un dolore, non viene descritto per ciò che
significa per chi lo prova, ma per la sede cerebrale in cui esso si
verifica, per le modifiche dell'attività delle cellule nervose che sono
coinvolte nella sensazione del dolore, indipendentemente da ciò che
questa implica "per me", soggetto di tale esperienza. Per quanto
affascinante, questo approccio non ci rivela molto sulla caratteristica
fondamentale degli "eventi mentali", in quanto ne minimizza la ricca
componente soggettiva, il significato. Spesso, però, gli scienziati
cercano di rifuggire proprio da questo aspetto, il significato, in quanto
si prefiggono di attenersi all'oggettività e, quindi, di ridurre la vita
psichica ai suoi correlati osservabili e quantificabili. L'intento è quello
di non interpretare, di non addentrarsi in una foresta densa di
trabocchetti e mostri quasi mitici: i desideri, gli scopi, i significati...,
ossia tutto l'universo della soggettività.
Malgrado i progressi nell'ambito delle neuroscienze - o, forse, per
causa loro - sembra dunque persistere un contrasto tra il mondo
dell'oggettività e quello della soggettività, tra il mondo dei meccanismi
e quello dei significati: da un lato, vi è lo scienziato che descrive un
aspetto del comportamento, per esempio il desiderio sessuale, in
termini di meccanismi nervosi coinvolti nelle motivazioni e
nell'emotività, di centri nervosi responsabili del piacere, di ormoni
sessuali alla base della "libido"; dall'altro, l'Io che sente che il suo
desiderio significa un complesso di turbamenti, passioni, fantasticherie
che affondano le loro radici in precedenti esperienze e desideri, e che il
suo desiderare lo investe in una dimensione conscia, ma anche
inconscia...
Questo contrasto tra due diversi modi di guardare alle attività mentali è
stato sottolineato da molti filosofi, e in particolar modo da Maurice
Merleau-Ponty (1908-1961) che al tentativo di spiegare il
comportamento attraverso meccanismi causali locali oppone l'esigenza
di comprenderne il significato "globale", il senso in termini di
esperienza. Nella "Fenomenologia della percezione" (1945) si legge:
«Tutto l'universo della scienza è costruito sul mondo vissuto e se
vogliamo pensare la scienza stessa con rigore, valutarne esattamente il
senso e la portata, dobbiamo anzitutto risvegliare questa esperienza del
mondo di cui essa è l'esperienza seconda» (trad. it. Il Saggiatore,
Milano 1965, p. 17). Per Merleau-Ponty la pratica scientifica non si
mostrava capace di illuminare la natura dell'esperienza soggettiva: «le
vedute scientifiche per le quali io sono un momento del mondo, sono
sempre ingenue e ipocrite, perché sottintendono, senza menzionarla,
l'altra veduta - quella della coscienza - per la quale originariamente un
mondo si dispone attorno a me e comincia a esistere per me» (ibidem).
A mezzo secolo di distanza, il conflitto sembra ancor più radicale,
almeno se consideriamo le asserzioni di numerosi biologi e studiosi del
cervello: per esempio, vi è chi, come Evelyn Fox-Keller, indica come la
biologia molecolare e le neuroscienze consentano di descrivere l'uomo
in modo «oggettivo», ponendo addirittura fine all'era della soggettività,
o chi, come Patricia Churchland («A perspective on mindbrain
research», "Journal of Philosophy", 77 (1980), p.p. 185207), sostiene
che le neuroscienze si stanno trasformando in "neurofilosofia", in
quanto classici temi della discussione filosofica - il rapporto mentecorpo, l'identità, la coscienza, il libero arbitrio, eccetera - non possono
più essere affrontati al di fuori di esse.
Da un lato, allora, vi sarebbero le neuroscienze che tendono ad
accertare la realtà naturale del cervello e, dall'altro, la filosofia che, non
meno della tradizione psicoanalitica, è impegnata a comprendere i
significati, palesi o reconditi che siano? Ci ritroveremmo di fronte
all'antitesi tra scienze naturali e scienze umane, alla contrapposizione
tra "Erklären" (ossia il tentativo di spiegare una realtà esistente, dotata
di un'evidenza propria) e "Verstehen" (vale a dire la comprensione del
significato)? Generalmente, si fa risalire la tradizione del "Verstehen",
inteso in questa accezione, al pensiero di Giambattista Vico (1668-1744)
che, sulla base del principio del "verum et factum convertuntur", si
oppose all'enfasi di René Descartes (1596-1650) sulla certezza fornita
dalle scienze naturali. Per Vico il "vero", ciò che possiamo sapere con
sicurezza, equivale al "fatto", ciò che noi stessi abbiamo creato: gli
uomini sarebbero atti a comprendere azioni, opere e istituzioni, nonché
storia, attività spirituali e produzioni della mente più che i fenomeni
naturali, che non sono opera loro. Perciò, nell'ambito di questa
concezione, ripresa tra gli altri anche da Wilhelm Dilthey (1833-1911) e
da Max Weber (1864-1920), le scienze dello spirito (e della mente) si
oppongono a quelle della natura (e del cervello).
Certo, nel passato i biologi che si sono rivolti allo studio dei rapporti tra
cervello e comportamento hanno sovente peccato di riduzionismo
spicciolo, negando ogni valore a quelle nozioni che sono al centro delle
concezioni del "Verstehen", quali intenzione, desiderio, decisione,
percezione, giudizio, eccetera; soprattutto, hanno finito per minimizzare
una dimensione fondamentale nelle scienze umane: quella storicotemporale. Tuttavia, questa dicotomia oggi dovrebbe apparire in larga
parte superata, e la stessa opposizione tra scienze naturali, dotate di un
carattere universale, e scienze umane legate al particolare, appartenere
a schemi concettuali ormai in disuso. Tutte le scienze, infatti, da quelle
«umane» a quelle «naturali», possono essere viste come una sorta di
tappe ideali successive, con diversi livelli di certezza, in cui trova
spazio un'importante dimensione: il tempo. Tale dimensione non
riguarda soltanto la storia naturale degli esseri viventi e, di
conseguenza, ogni aspetto della vita, in quanto le specie, gli organismi
e lo stesso programma genetico di un particolare individuo
rappresentano il prodotto storico di epoche passate: nell'ambito delle
stesse scienze del cervello non esiste infatti aspetto - lo sviluppo, la
formazione dei circuiti nervosi, la memoria, l'oblio, eccetera - che non
sia segnato da tempo e individualità.
Ciononostante, continuano ad affermarsi modelli riduzionistici della
mente, spesso a immagine e somiglianza di quelle funzioni simbolicocomputazionali che sono tipiche dell'Intelligenza Artificiale (I.A.),
ovvero a immagine e somiglianza della cosiddetta "macchina di Turing"
(una sorta di idealizzazione del computer che differisce da un
calcolatore reale solo per il fatto di avere capacità di memoria illimitata
e di essere in grado di eseguire computazioni senza mai commettere
errori o senza mai rompersi, vedi figura 16). Ora, se è vero che il
paradigma dell'I.A. può essere utile per elaborare modelli del
funzionamento cerebrale, è innegabile che, quando le teorie della mente
umana coincidono con quelle relative alle «menti» artificiali, possano
emergere problemi che vanno oltre la specifica questione delle teorie
della mente e le cui ricadute investono l'immagine stessa dell'uomo: è
possibile, si chiede a riguardo Margaret Boden («La simulazione della
mente al calcolatore è socialmente dannosa?», in R. Viale (a cura di),
"Mente umana e mente artificiale", Feltrinelli, Milano 1989, p.p. 3-17),
che in futuro i valori umani possano avere quale punto di riferimento
primario il campo teorico e applicativo dell'Intelligenza Artificiale? Che
le teorie della mente basate su paradigmi di tipo computazionale
possano influenzare l'immagine dell'uomo, nell'ambito di una
concezione neomeccanicistica che induca una svalutazione di quei
valori della persona che rappresentano l'istanza ultima di ogni etica?
Tali interrogativi possono essere estesi ad altri ambiti, e in particolare a
un'interpretazione riduzionistica della mente in cui non trovino posto i
significati (vedi anche "questo volume", p.p. 62-64).
Per affrontare questo problema, e così andare alla radice stessa della
dicotomia mente-cervello, possiamo partire da uno dei temi più
dibattuti, ossia quello degli scopi che guidano il comportamento di un
individuo: come può, infatti, un'idea, uno scopo influenzare la nostra
azione fisica? I nostri comportamenti sono intessuti di scopi e
intenzioni al punto che questi non vengono mai esplicitati. Quando essi
mancano o sono incongrui, oppure non sono suscettibili di
interpretazione razionale, siamo propensi a ritenere di essere in
presenza di disturbi mentali e a credere che la vita di un individuo non
abbia più senso poiché egli «non avrebbe più uno scopo». Il nostro
agire sembra essere talmente motivato da un senso, da desideri,
ambizioni, interessi, necessità che difficilmente usiamo la parola
«scopo» per spiegare le nostre azioni - ed è proprio per questo, per
l'ovvietà della loro presenza, che non pochi studiosi della mente
sostengono di non doversi prendere cura degli scopi e di dover tacere
di questo aspetto dell'agire umano.
Anche nell'ambito della fisiologia cerebrale ci si è, almeno inizialmente,
opposti all'idea di scopo in quanto non pertinente a quelle descrizioni
fisiche in cui rientrano struttura e funzioni del cervello: tuttavia vi sono
stati alcuni neurofisiologi che sono ricorsi a un concetto che in qualche
misura è implicito in quello di scopo, vale a dire quello di modello
cerebrale o di rappresentazione interna del mondo. Secondo Kenneth
Craik ("The Nature of Explanation", Cambridge University Press,
Cambridge 1943), a cui si devono molte delle idee più influenti circa la
teoria del cervello, nel nostro sistema nervoso vi sono meccanismi
fisici che svolgono il ruolo di modelli interiori del mondo. E' grazie a
loro che percepiamo la realtà, che la pensiamo e la modifichiamo, e a
loro dunque devono fare capo le spiegazioni dei fenomeni psicologici,
poiché senza le rappresentazioni interiori non si potrebbe dar ragione
delle esperienze e delle azioni di un individuo.
Inizialmente, l'esistenza di modelli simili nell'ambito di un cervello
umano è stata postulata facendo riferimento alla neurofisiologia dei
movimenti. Per quanto possano sembrare banali automatismi, questi
sono in realtà improntati a complessi schemi che vengono realizzati
tramite azioni selettive e mediate dei muscoli e degli arti. In mancanza
di uno schema generale, ossia della visione di un certo «mondo», non è
possibile alcuna variazione o adattamento degli schemi motori a
situazioni simili o differenti. Pensiamo alle varietà stilistiche con cui
vengono rappresentate le lettere dell'alfabeto, per esempio la lettera
«A»: ne esiste una versione in corsivo e una in stampatello, una in
caratteri latini e una in caratteri greci o in stile gotico, eccetera. Per
realizzare versioni differenti della «A», la nostra mano deve compiere
dei movimenti diversi a seconda della specifica «A» che vuole
tracciare: movimenti circolari o interrotti, linee continue o spezzate.
Nonostante tali differenze a livello motorio, che comportano l'impegno
di muscoli diversi, le varie realizzazioni e forme di una stessa lettera
rispondono a un'idea comune, a un medesimo schema mentale, quello
per cui siamo disposti a riconoscere immediatamente che, pur nella
varietà di stili, tutte le lettere «A» rinviano a uno stesso significato. Il
nostro cervello, infatti, non ha bisogno di far capo a singole memorie
per ogni possibile versione di una medesima lettera in quanto le
accomuna tutte sotto uno stesso schema.
E' stato proprio riferendosi alla memoria che F. C. Bartlett (1932) ha
introdotto il termine «schema» in relazione a quell'organizzazione di
esperienze e reazioni del passato che dà forma ad apprendimenti
successivi (vedi "La memoria. Studio di psicologia sperimentale", trad.
it. Franco Angeli, Milano 1974) Ma il concetto di schema è ritrovabile
nella maggior parte delle teorie della mente - pensiamo, per esempio,
alla psicologia dello sviluppo. Per «schema» Jean Piaget (1896-1980)
intende, infatti, la rappresentazione generalizzata di un insieme di
situazioni che consente all'organismo di agire in un'intera gamma di
situazioni analoghe, e di generalizzare così alcuni comportamenti.
Tuttavia, il modello di schema forse più noto e sicuramente più legato a
basi neurofisiologiche è quello riferito ai cosiddetti «meccanismi innati
di scarica» (gli istinti) studiati dall'etologia: lo schema, in questo caso,
è un «pacchetto» di informazioni trasmesse per via genetica che
consente ai membri di una specie animale di reagire a un dato stimolo
con una serie di azioni concertate e stereotipate. Per quanto il termine
«istinto» goda di scarso credito presso non pochi etologi, poiché
sembra escludere un ruolo attivo dell'esperienza, esso rinvia a quella
componente predeterminata e stereotipata del comportamento oggi
definita «schema d'azione fisso» (FAP, dall'inglese "fixed action
pattern") - un'espressione che indica come gli animali, dopo aver
interagito con gli stimoli ambientali ed essere sospinti da una pulsione
interna (fame, motivazione sessuale, necessità territoriali, eccetera),
mettano in atto sequenze comportamentali più o meno comuni a tutti i
membri di una stessa specie. E' il caso del falco che uccide la preda
compiendo una rigida serie di movimenti, della maggior parte dei
corteggiamenti che rispondono a veri e propri schemi di
comportamento, o delle femmine che depongono uova o partoriscono e
hanno cura dei piccoli secondo modi che dipendono da un programma
preesistente, uno schema appunto, il quale si traduce in opportune
interazioni con gli stimoli ambientali in movimenti, azioni finalizzate
emozioni, eccetera. Lo schema di un istinto è iscritto nei circuiti
nervosi: prova ne è che la stimolazione di specifiche aree del cervello
attraverso una tenue corrente elettrica fa sì che l'animale metta in atto
frammenti più o meno rilevanti di attività istintive, quali comportamenti
di alimentazione (masticare, inghiottire), di predazione (aggredire,
uccidere, consumare), di attività sessuale (corteggiare, accoppiarsi),
eccetera. Anche se, al momento, nessun neurofisiologo ha descritto in
maniera dettagliata l'architettura delle strutture e dei modelli interiori (il
programma) alla base degli schemi istintuali, la psicobiologia ha
mostrato che vi sono sedi specifiche in cui essi sono depositati e che
uno schema o modello cerebrale è implementato su una matrice
nervosa, materiale. Non è allora possibile che gli stessi modelli
cerebrali che sottendono scopi, intenzioni convinzioni e idee abbiano
aspetti simili a quelli di altre forme di schemi, come avviene, per
esempio, per gli istinti?
Ma ritorniamo alla nostra analogia informatica, che per i sostenitori
delle scienze cognitive rappresenta qualcosa di più di una semplice
metafora, e al possibile rapporto tra modelli interiori cerebrali e
fenomeni mentali. Ora, se anche gli studiosi della biologia cerebrale
conoscessero il cervello in ogni suo dettaglio, dovrebbero sempre
utilizzare delle spiegazioni di tipo psicologico per comprendere i
fenomeni mentali. Questo significa che la psicologia non può essere
ridotta alla fisiologia - se con ciò intendiamo che una dettagliata
conoscenza di tipo fisiologico segnerebbe la fine di concetti quali
scopo, idea, convinzione, intenzione -, mentre possiamo ammettere che
la psicologia sia riducibile alla fisiologia, nel senso che entità di tipo
psicologico come quelle sopra menzionate possono essere ricondotte a
realtà cerebrali, invece di essere considerate categorie prive di alcuna
spiegazione scientifica. Tuttavia, l'adesione a quest'ultimo principio (la
riducibilità «limitata» della psicologia alla fisiologia) non implica
necessariamente che l'eventuale conoscenza dei modi attraverso cui gli
scopi sono incorporati nei meccanismi cerebrali possa esimerci dal
considerare quei concetti che permettono di esprimere ciò che
contraddistingue ogni singolo essere umano rispetto agli altri.
Quali possono essere le modalità - per non utilizzare l'ambiguo termine
«meccanismi» - per cui il cervello è l'organo della mente? Attraverso
quali vie esso può dare espressione delle concezioni del mondo e far sì
che un individuo abbia scopi o metta in pratica «copioni», atteggiamenti
generali con cui interpretare e modificare la realtà? Per rispondere a tali
interrogativi è opportuno soffermarsi su come è stato affrontato in
passato il problema mente-cervello. Sovente il cervello è stato
considerato un rivelatore della mente, un dispositivo in grado di
connettere l'esistenza di un uomo con la sua esperienza soggettiva o
meglio con la sua realtà spirituale. In contrasto con le ipotesi
spiritualistiche, i sostenitori di un approccio naturalistico hanno, infatti,
guardato al cervello come a un sistema formato da un insieme di
microorgani specializzati, ognuno dei quali responsabile di sensazioni,
movimenti volontari, motivazioni, memorie, idee. Gruppi particolari di
cellule nervose, disposti in particolari strutture cerebrali, sarebbero
responsabili della produzione di speciali stati mentali, e le funzioni
mentali sarebbero delle proprietà elementari primarie, delle «capacità»
del cervello: attraverso le associazioni tra le diverse singole capacità
emergerebbero le funzioni mentali superiori.
Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo di tecniche per lo studio del
cervello ben più potenti e sofisticate di quelle che erano a disposizione
degli studiosi dell'Ottocento ha consentito di individuare le sedi di
disparati processi psicologici: il cervello appare frammentato in una
serie di centri e aree della corteccia responsabili di «funzioni» che
vanno dalla motricità alle sensazioni, dal linguaggio all'attenzione, dal
sonno ad alcuni aspetti dell'emozione. Le analisi condotte attraverso
queste nuove tecniche (PET e R.M.N.) hanno sempre più consentito di
evidenziare lo stato di maggior attività di una particolare area nervosa
rispetto alle aree circostanti, e quindi di ritenerla responsabile di una
specifica attività nervosa: muovere una mano comporta una maggior
attività dell'area motoria della corteccia; provare dolore si traduce in
un'elevata attività dei nuclei profondi del cervello e della corteccia
sensoriale; sentire un suono comporta un'attività della corteccia
temporale; vedere una luce significa un aumento dell'attività della
corteccia occipitale, eccetera. Una frammentazione ancor maggiore
viene postulata nell'ambito delle scienze cognitive che considerano il
cervello una sorta di alveare formato da singole cellette, ognuna
funzionalmente autonoma. In realtà, la situazione non è così semplice e
un'ipotesi naturalistica improntata a un meccanicismo semplicistico
non rende conto della complessità della vita mentale.
Ciò vale, in particolare, per le caratteristiche delle stesse strutture
cerebrali che non sono «rigide» e predeterminate come le componenti
di una qualsiasi macchina. L'organizzazione cerebrale è, infatti,
plastica: i rapporti tra una particolare struttura e una particolare
funzione variano nel tempo, a seconda delle necessità e delle richieste
ambientali, compreso l'ambiente interno del nostro corpo e del nostro
cervello. Per esempio, gli esperimenti effettuati da alcuni neurofisiologi
hanno mostrato che certe funzioni, come quelle motorie e sensoriali,
sono localizzate in specifiche aree della corteccia dove è possibile
tracciare delle «mappe topografiche» che consentono di identificare un
gruppo di cellule nervose che corrispondono ai territori periferici da cui
ricevono informazioni (corteccia sensoriale) o a cui inviano comandi di
tipo motorio (corteccia motrice). Ma la presenza di queste mappe
corticali implica che esse siano rigide e «fisse», immutabili per tutta la
vita di un individuo? Oppure si tratta di carte topografiche i cui confini
possono variare nel corso del tempo, adattandosi alle nuove esigenze e
alle situazioni dei territori periferici? Vari esperimenti effettuati in questi
ultimi tempi indicano che la rappresentazione di una particolare
funzione sensoriale o motrice a livello della corteccia cerebrale è
fortemente variabile, estremamente plastica e soggetta a profondi
rimaneggiamenti - e ancor più plastici sono quei circuiti cerebrali che
sono coinvolti in funzioni più sfumate e complesse come
l'apprendimento e la memoria. Consideriamo, per esempio, l'area
motoria corticale, una sottile estensione di neuroni organizzati in una
mappa dei territori muscolari periferici che prende il nome di
«omuncolo»: essa è deformata, in quanto alcuni organi come la mano o
il volto sono rappresentati da un maggior numero di neuroni rispetto al
tronco o alle gambe a causa della complessità delle funzioni motorie
necessarie alla manipolazione fine, alle espressioni facciali o al
linguaggio. Ebbene, l'omuncolo non costituisce una carta geografica
immutabile nel tempo, ma varia di forma - cioè rispecchia un diverso
rapporto numerico tra i neuroni e i territori periferici - a seconda della
situazione della periferia, ossia dell'uso o del disuso di arti e muscoli.
Immaginiamo che in seguito a una lesione traumatica una persona
perda un arto: cosa succede a livello dell'omuncolo corticale per
quanto riguarda la rappresentazione di un territorio periferico ormai
inesistente? Diversi studi indicano che la mappa corticale dei territori
periferici, sia quella che rappresenta la motricità sia quella analoga che
rappresenta la sensibilità (vedi "questo volume", p.p. 82-83, va incontro
a profondi rimaneggiamenti di tipo adattivo, utili a dare maggior spazio
o «rappresentazione» centrale a quelle aree del corpo che ora
potrebbero fare le veci della funzione scomparsa: l'altro arto, il
moncone residuo dell'arto, eccetera. Tuttavia, non c'è bisogno di
ricorrere a una situazione drastica quale la perdita di un arto per
comprendere la plasticità dell'omuncolo e, quindi, della corteccia
cerebrale: per esempio, si è osservato che un aumento della funzione di
un territorio periferico - si pensi alla mano di un pianista o alle braccia
di un giocoliere - comporta una dilatazione della mappa corticale. In
altre parole, un maggior numero di neuroni si fa carico di una
particolare funzione, come se la mappa corticale fosse tracciata sulla
superficie di un palloncino di gomma e questo venisse più o meno
gonfiato o deformato.
Negli ultimi anni alcune ricerche in campo neuroscientifico hanno visto
la ripresa e rielaborazione del concetto di «area localizzata». Si pensi,
per esempio, agli studi ormai classici di David H. Hubel e Torsten N.
Wiesel («The period of susceptibility to the physiological effects of
unilateral eye closure in kittens», "Journal of Physiology", 1970, 206,
p.p. 419-436) che hanno mostrato come alcune aree della corteccia
occipitale siano predisposte per la visione binoculare in modo da
assicurare la fusione delle immagini formate sulle due retine e da
fornire una rappresentazione tridimensionale della realtà. Infatti, parte
dell'area corticale visiva è strutturata in «colonne di dominanza
oculare», disposte in modo tale che se una colonna ha un campo
recettivo nell'occhio sinistro (riceve informazioni da una piccola area
della retina dell'occhio sinistro), la colonna a fianco, distante poco
meno di mezzo millimetro, risponderà agli stimoli che incidono sullo
stesso punto dell'occhio destro. Queste colonne si alternano per tutta
l'area corticale: si può quindi affermare che esiste un'evidente
predisposizione per una decodificazione «intelligente» degli stimoli
visivi e che questa funzione è localizzata in una specifica parte della
corteccia.
Anche in questo caso, tuttavia, il rapporto tra la predisposizione
genetica, alla base delle caratteristiche e delle localizzazioni della
funzione corticale, e gli effetti dell'ambiente risulta complesso: è, infatti,
sufficiente che nel corso delle fasi precoci dello sviluppo gli stimoli
provenienti da uno dei due occhi vengano a mancare per un certo
periodo (come avverrebbe se si bendasse l'occhio di un neonato per
più giorni), perché venga a cessare l'alternanza funzionale, in quanto
tutto lo spazio disponibile verrebbe «invaso» dalle fibre nervose
provenienti dal solo occhio funzionante. L'altro occhio diventa così
«cieco», non tanto perché non percepisce più gli stimoli visivi, quanto
perché la corteccia su cui si proiettavano le sue fibre nervose è stata
occupata dalle fibre provenienti dall'occhio non bendato.
Ma se la localizzazione e la rappresentazione topografica degli schemi
motori e sensoriali può variare nel tempo, non è possibile che vari
anche la stessa rappresentazione dei ricordi? In altre parole, non è
possibile che i ricordi vengano ristrutturati, deformati, «reimpastati» in
modo tale che il nucleo originale di una memoria perda alcune delle sue
caratteristiche per la sovrapposizione di «strati» successivi? Non è
possibile che esista un'evoluzione del ricordo che riveli il lavorio del
tempo, la sovrapposizione di strati e di sedimenti appartenenti a
esperienze successive, a ere diverse? Numerosi studi sulla memoria
animale e umana indicano che ogni singolo ricordo non viene registrato
tramite un procedimento di tipo «fotografico», come se ogni singola
esperienza contribuisse a impressionare un'ideale lastra fotografica e il
cervello fosse simile a un immenso archivio. Ogni esperienza si
riallaccia, infatti, a una precedente: vengono formate categorie,
compiute generalizzazioni, riaggiornati vecchi schemi in un processo
plastico che comporta un continuo reimpasto delle memorie, una loro
contaminazione e ristrutturazione nel corso del tempo, cosicché esse si
trasformano al punto da occultare il loro nucleo originario.
La mutevolezza dei ricordi è testimoniata da molti dati sperimentali e
clinici, e soprattutto dalle analisi di tipo longitudinale basate sulle
cosiddette "life histories" o autobiografie, raccolte a distanza di 2, 5,10
anni dallo stesso sperimentatore. Anche in questo caso si nota come la
persistenza di alcuni ricordi, che una determinata persona ritiene
fondamentali in quanto «pietre miliari» della sua vita, sia tutt'altro che
stabile: il medesimo evento viene narrato in modo diverso, cambiano i
particolari, compreso il suo stesso significato, quasi che la memoria,
anziché corrispondere a una precisa «fotografia» della realtà, modifichi
la propria forma come un pezzo di plastilina. Ma, nonostante questo
continuo processo di reimpasto, ogni singolo individuo ritiene non solo
di essere un fedele custode delle proprie memorie, ma pure che queste
siano immutabili: riconoscere che possano essere soggette a
cambiamenti significherebbe accettare che la propria individualità e
identità siano precarie, ossia porre in discussione la coerenza del
nostro «io» e delle nostre esperienze.
Dunque, a differenza di quanto avviene nelle macchine tradizionali, a
livello cerebrale tutto è soggetto a essere rimaneggiato, plasmato e
modificato. Se il cervello è una «macchina» è allora una macchina
particolare, e non ha senso affermare che una funzione è localizzata in
una particolare struttura e dipende esclusivamente da quell'area della
corteccia o da quel nucleo sottocorticale. Oggi, sta lentamente
tramontando una concezione dei rapporti mente-cervello basata
sull'esatta coincidenza di funzione mentale e «microorgani»
specializzati: i processi mentali vengono considerati come complesse
attività di analisi dell'informazione, in grado di «riflettere» la realtà.
Nell'ambito dell'attività mentale le singole informazioni vengono
collegate tra loro e combinate per costruire progetti o programmi
comportamentali che aderiscono a scopi: ogni funzione del cervello
umano, dalla percezione alle stesse emozioni, rappresenta una sorta di
attività funzionale che riflette il mondo esterno attraverso una continua
analisi e riaggiornamento dell'informazione, e che contribuisce a
elaborare progetti e programmi. In questa complessa attività svolge un
ruolo importante una parte del cervello che, rispetto agli altri primati, è
tipica dell'uomo e che è formata dalle aree frontali e prefrontali, cioè le
parti anteriori del cervello: esse sono coinvolte nel perseguimento di
scopi, progetti e programmi di azione, e la loro lesione, come avviene
per alterazioni di tipo vascolare o in più rari casi di interventi chirurgici,
comporta l'affievolirsi delle motivazioni e il disintegrarsi dei cosiddetti
progetti diretti a un fine.
L'analisi
dell'informazione,
l'adattamento
all'ambiente
e
il
perseguimento degli obiettivi e delle «visioni del mondo» dipendono in
sostanza dalla globale cooperazione dei diversi sistemi funzionali del
cervello che sono strutturati sulla base di programmi e progetti
incorporati nel corso dello sviluppo individuale nell'ambito di un
particolare sistema sociale. Questa concezione dei rapporti mentecervello va al di là della classica opposizione tra mentalismo e
naturalismo, in quanto ha una dimensione che non si limita a ridurre la
mente alla somma dei meccanismi cerebrali responsabili di elementari
funzioni mentali: essa permette di superare il sogno di un facile
riduzionismo neuroscientifico secondo cui la corrispondenza tra un
evento mentale e il funzionamento del cervello sarebbe così stretta da
permettere di giungere, col progredire delle tecniche, a conoscere le
esperienze e la mente di una persona mediante l'analisi del suo sistema
nervoso. In conclusione, le neuroscienze ci consentono oggi di
tracciare un'immagine della mente che è forse meno prevedibile e
confortante di quella che ci si attenderebbe da un approccio scientifico
che, in quanto tale, viene spesso ritenuto sinonimo di ordine, di
semplicità e di lineare univocità. Tuttavia, proprio per questo motivo, le
concezioni della mente che vanno emergendo da un nuovo modo di
guardare al cervello sono più vicine al mondo degli uomini, alla
variabilità e complessità del vivente che a quello delle macchine.
DIALOGO
(Carlo Maria Martini e Giuliano Avanzini).
CARLO MARIA MARTINI: Lei ha preso le mosse dalla circolarità della
conoscenza, come se uno strumento studiasse se stesso. Che cosa
suggerisce questa immagine? Un limite o un orizzonte?
GIULIANO AVANZINI: Dal punto di vista biologico non vedo la
possibilità di uscire dalla circolarità nell'approccio alla conoscenza.
Infatti, il neurobiologo non ha gli strumenti per compiere il salto dai
meccanismi che studia (in maniera anche sofisticata) alla percezione
soggettiva, cioè all'"autoriferimento". A mio avviso, la linea di condotta
legittima è quella più modesta: attenersi alle espressioni osservabili,
studiare il comportamento, paragonare differenti reazioni di viventi
diversi. Così facendo il neurobiologo può ottenere una certa
comprensione dei processi che portano alla conoscenza. Ma questo
non significa affatto poter colmare la lacuna di cui si diceva.
MARTINI: Sembra dunque delinearsi una lacuna, forse incolmabile:
quella tra la percezione dei segnali e la nascita dell'autocoscienza.
Potremmo mai comprenderla o dovremo dare per scontata
l'autocoscienza senza riuscire a spiegarne scientificamente
l'emergenza?
AVANZINI: Spero di non essere stato troppo drastico nel criticare
l'immagine della mappa (vedi p. 83). Oggi sappiamo abbastanza su
come l'interazione tra varie zone del sistema nervoso restituisca un
quadro della realtà quale quello che potremmo leggere sulla corteccia
cerebrale. Tuttavia, nemmeno questo ci porta a sondare con uno
strumento diretto l'autocoscienza. Lo stesso vale per il passaggio dalla
percezione intesa quale afferenza di segnali alla percezione intesa
come esperienza che entra a far parte del Sé. Dunque, sono ben
disposto a riconoscere i limiti dell'approccio biologico. Questo
riconoscimento è peraltro necessario perché tale approccio sia
scientifico, in quanto in qualsiasi ambito non si ha scientificità se non
si precisano i limiti di validità.
MARTINI: Il fenomeno dell'espressione verbale è solo allargamento
della conoscenza o anche limitazione della conoscenza a causa dei
vincoli che la lingua impone?
AVANZINI: Credo che il linguaggio offra all'essere umano opportunità
uniche: la possibilità di plasmare la realtà, ricombinandola e
anticipandola, magari contraddicendola, nonché la possibilità di far sì
che la conoscenza divenga problema. Certo, il linguaggio impone delle
regole, e forse anche modalità conoscitive meno ricche rispetto a quelle
che pertengono alla sfera emotiva e all'elementare adesione
all'esperienza immediata del mondo che ci deriva dai nostri sensi.
MARTINI: La sua risposta sul tema affascinante della lingua mi fa
pensare che esistano cose che si intuiscono senza poterle dire. Vengo
così alla questione per me fondamentale, quella della relazione tra
processi sensoriali cognitivi e ciò che chiamiamo anima. Lei, insieme
con Baroukh M. Assael, ha scritto un libro, intitolato "Il male dell'anima"
(Laterza, Roma-Bari 1977), che è forse pertinente alla mia domanda. Si
può davvero spiegare il processo della conoscenza, e persino quello
dell'autocoscienza, unicamente in termini di crescente complessità dei
processi sensoriali? Oppure bisogna supporre altro perché tutto ciò
abbia unità?
AVANZINI: Devo precisare che l'espressione "male dell'anima" è stata
usata da Assael e da me nel libro, che Lei gentilmente cita, come
metafora della condizione di disagio che il pregiudizio e
l'incomprensione di molti generano nel vissuto di una persona che
soffre di epilessia. Il discorso che vi si svolge ha rilevanza con il tema
di questa conversazione solo come esempio delle distorsioni che una
cultura (o piuttosto "incultura") alimentata da un atteggiamento
ascientifico e umanamente deteriore può indurre nella visione della
realtà che ci circonda. Ma venendo alla domanda rispondo che non
ritengo legittimo compiere il passo che, in mancanza di una
spiegazione biologica, porta a far riferimento ad altro. Ciò che
chiamiamo anima non è deducibile dall'indagine scientifica e rientra
piuttosto nella sfera delle convinzioni personali. Non penso, d'altra
parte, che la constatazione di un limite insuperabile per una
determinata metodologia scientifica possa portare consequenzialmente
a postulare un'istanza che si sottrae a ogni possibilità di controllo.
Anche per questo ho affermato che non ha senso parlare di un
osservatore esterno alla mappa. Ancora recentemente mi è capitato di
vedere un articolo intitolato «Chi legge nel cervello il processo
temporale dei suoni?» - come se una parte del cervello fosse
sovraordinata a un'altra nella rielaborazione delle informazioni. In
realtà, il processo di codificazione dell'informazione e la sua lettura
sono nel sistema nervoso centrale coincidenti.
Vorrei riprendere un punto di quello che ho già detto: se è vero che
possiamo inferire la presenza della percezione o della conoscenza dal
comportamento interattivo del vivente con il mondo, dobbiamo pure
notare che già esseri unicellulari interagiscono con il loro ambiente, per
esempio fagocitando «prede» o allontanandosi da zone che sono per
loro a rischio: si comportano come se di quell'ambiente avessero
comunque una conoscenza. Il che ci porta alla provocatoria
affermazione che possa sussistere conoscenza senza sistema nervoso
- cioè che le due cose non siano necessariamente coincidenti. Il
sistema nervoso potrebbe, allora, non essere altro che il risultato di una
differenziazione adattativa sviluppatasi negli esseri pluricellulari per
garantire la sinergia delle parti nella produzione di comportamenti
coordinati utili all'interazione con l'ambiente. Una ipotesi chiaramente
«eretica», ma proprio per questo ricca di implicazioni dialettiche che
sarebbe forse interessante sviluppare.
DIALOGO
(Carlo Maria Martini e Alberto Oliverio).
CARLO MARIA MARTINI: La memoria è la radice non solo della
personalità, bensì della cultura, della coscienza storica di un popolo, la
radice delle religioni - in particolare la religione cristiana vive di
memoria e di riproposizione di gesta del passato nel presente e per il
futuro. Lei ha parlato soprattutto di memoria dell'intelligenza. C'è anche
una "memoria del cuore", degli affetti? E' possibile studiare l'unità di
tutti i processi di memoria, compresi quelli affettivi, considerandoli da
un'unica prospettiva scientifica?
ALBERTO OLIVERIO: La memoria del cuore, quella emotiva, è
fondamentale; quasi non esiste ambito del nostro ricordo che, in
qualche misura, non faccia capo all'emozione. Difficilmente ogni nostra
esperienza è neutra, ed è raro che dimentichiamo quello che ha valenza
emotiva. Possiamo non ricordare un appuntamento di lavoro o il nostro
codice fiscale - ma alcune «pietre miliari» restano, quelle che rivestono
per noi un significato particolare. Può capitare che non si abbia
memoria per la nostra professione, ma che non si dimentichi nulla di un
"hobby", cioè di un qualcosa che ad altri sembrerà un dettaglio, mentre
invece noi vi abbiamo investito emozioni e aspettative. La dimensione
emotiva è dunque al centro, così come lo è quella corporea. Non c'è
rapporto al mondo che non sia tramite il corpo: naso, mani, occhi,
eccetera ci regalano un patrimonio di sensazioni che consentono di
avere ricordi segnati dalla nostra individualità corporea. Per questo non
credo all'ipotesi dello «scambio» "à la" John Locke (1632-1704). Nel suo
"Saggio sull'intelletto umano" (1690) si legge: «Se l'anima di un
principe, portando con sé la consapevolezza della vita passata del
principe, entrasse a informare di sé il corpo di un ciabattino subito
dopo che questo fosse stato abbandonato dalla propria anima, ognuno
vede che egli sarebbe la stessa "persona" che il principe, responsabile
solo delle azioni del principe, ma chi direbbe che si tratta dello stesso
uomo?» (Libro secondo, XXVII, 117, trad. it. Laterza, Bari 1972, p. 344).
Senza imbarcarmi nella discussione dell'anima, mi sembra che nel
passo citato Locke ipotizzi una sorta di trasferimento nel corpo del
ciabattino della memoria del principe. Certo, chi oggi concepisce una
persona come "software" o informazione potrebbe riproporre un
esperimento ideale analogo a quello del "Saggio sull'intelletto" (e molte
trame di fantascienza fanno questo). Ma a queste concezioni lockiane o
neolockiane ribatto che la memoria non è solo sistema nervoso; è una
serie di strategie, movimenti, capacità di padroneggiare l'ambiente,
eccetera che sono inscritte nel nostro corpo. Qualsiasi gestualità
(pensiamo a un pittore, a un pianista, a un attore) porta con sé una
memoria, che gradualmente si modifica, si raffina, anche tramite i suoi
oblii...
MARTINI: Avanzini ha menzionato (vedi p. 107) una conoscenza
addirittura a partire dalla cellula. Se la memoria è presente in stati di
vita alquanto primitivi, e comunque è presente negli animali, che cosa
caratterizza la memoria di un'intelligenza propriamente umana?
OLIVERIO: Indubbiamente, a livello animale le basi della memoria (le
basi
molecolari,
neurobiologiche)
rispondono
a
principi
fondamentalmente simili. Ogni specie animale, ogni età della vita, ogni
individuo ha poi capacità di interagire con la realtà che sono assai
differenti. Chiaramente, la memoria degli uomini è diversa da quella
degli altri animali, grazie anche al linguaggio che consente di ritagliarsi
la realtà ciascuno a suo modo, di rielaborarla, di creare scenari
ipotetici, e così via.
MARTINI: A proposito di dinamismi della memoria, penso ai bambini
letteralmente bombardati da «realtà virtuali»: c'è differenza tra il modo
in cui si forma la memoria del bambino oggi e quello in cui si è formato
il nostro tesoro di ricordi? Il fatto che la memoria sia plastica è d'aiuto
per evitare la confusione tra memorie reali e impressioni virtuali?
OLIVERIO: Di fatto, il bambino è ancora più vittima dell'adulto, vive
nell'immediatezza, e labile è per lui il confine tra realtà e finzione. Senza
voler invadere il campo degli psicologi dell'età evolutiva, mi pare lecito
affermare che vi sono età in cui è assai difficile discriminare tra la
propria esperienza e quella rappresentata. Per questo, le immagini
virtuali, non mediate dall'intelligenza, hanno una forte presa sui
bambini, sulle loro emozioni, e a mio avviso oggi non si è ancora a
sufficienza riflettuto sui pericoli di tale "memoria acquisita". Forse
perché gli «esperti» sono degli adulti che hanno poca dimestichezza
con il «meraviglioso mondo nuovo» in cui stanno crescendo le ultime
generazioni. Un bambino che gioca in cortile o per strada con altri
bambini, ha esperienze e visioni del mondo ben diverse da quelle di un
bambino che fa solo giochi virtuali - giochi che troppo spesso si
prestano a stimolare l'aggressività. Certo, anche i giochi dei bambini di
una volta erano carichi di aggressività. Però, in genere ci si sapeva
fermare quando ci si rendeva conto che l'altro subiva le nostre stesse
piccole sofferenze. Ora che tutto è smaterializzato, l'altro può essere
schiacciato, tritato, polverizzato, annullato, e poi miracolosamente
dovrebbe ricomporsi - come in un videogioco. Nella realtà nessuno si
ricompone, nessuno risuscita!
MARTINI: Sono dunque così minacciose tutte le tecnologie del virtuale?
L'intero cammino verso l'Intelligenza Artificiale finirà per svalutare il
valore della persona, riducendola a pura meccanica? O, invece,
saranno i valori dell'uomo a indurre la scienza ad aprire nuovi fronti
grazie alle conquiste tecnologiche? In un futuro prossimo o remoto non
potrà l'impresa scientifico-tecnica seguire interessi più profondi?
Penso, per esempio, al miglioramento dell'apprendimento dei bambini,
alla cura delle malattie invalidanti degli anziani, allo smascheramento
della trappole su cui si sorreggono le odierne tecniche del consenso.
Tutto questo costituisce uno scenario molto incoraggiante, purché
l'intelligenza umana rimanga padrona dei processi...
OLIVERIO: Non mi sento di azzardare previsioni, anche perché le
tecnologie hanno spesso conseguenze "inattese", ben diverse dagli
scopi per cui sono state ideate. Non è detto che siano sempre
conseguenze "perverse", ma a volte si rivelano comunque di vasta
portata. Pensiamo all'automobile ieri e all'informatica oggi. Forse, non
siamo ancora in grado di cogliere un'imponente crescita di cui godiamo
i vantaggi immediati. I timori di quanti pensavano che l'uomo potesse
un giorno risvegliarsi «antiquato» rispetto alle "performances"
dell'Intelligenza Artificiale, sono a mio avviso in gran parte infondati. In
campo informatico si cerca oggi non di emulare l'intelligenza umana
con quella artificiale, quanto di accoppiare proficuamente l'una all'altra.
E tutto il complesso delle scienze cognitive - dalla riflessione sulla
natura e significato dei linguaggi di programmazione alle neuroscienze,
alla psicologia - ha contribuito a riorientare l'originario programma della
I.A. E' come se ci avessero detto: state attenti che l'intelligenza reale
non è l'intelligenza formale, non è soltanto la logica; ma è anche tutto
un insieme di cose: l'analogia, l'emozione, l'intelligenza del cuore...
4.
FILOSOFIA E TEOLOGIA: ANCELLE DELLA SCIENZA?
NELLE PIEGHE DELLA SCIENZA
(Giulio Giorello).
Ma io che ci faccio qui? Tentativo di risposta: «Il filosofo è mezzo
scienziato, mezzo artista, e interamente (poiché non vi può essere una
terza metà) sacerdote» (A. Emo, "Supremazia e maledizione. Diario
filosofico 1973", a cura di M. Donà e R. Gasparotti, Cortina, Milano 1998,
p. 106). Perché attribuire questa triplice natura al filosofo?
Innanzitutto, lo "scienziato": ritengo che, non diversamente dalla
scienza, lo stile della filosofia sia quello dell'"analisi" un'investigazione che non obbedisce ad alcuno scopo estrinseco e si
svolge nella più completa autonomia. Per dirla con Galileo Galilei, in
filosofia non ci dovrebbe essere necessità alcuna di un'autorità cui
conformarsi: «ci è bisogno di scorta ne i paesi incogniti e selvaggi, ma
ne i luoghi aperti e piani i ciechi solamente hanno bisogno di guida; e
chi è tale, è ben che si resti in casa, ma chi ha gli occhi nella fronte e
nella mente, di quelli si ha da servire per iscorta» ("Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo", in "Opere", VII, p. 138) . Quanto alla
"sintesi", cioè alla ricomposizione di quello che l'analisi ha
pazientemente sezionato, essa è sovente ottenuta al di là delle
intenzioni. L'analisi è premio a se stessa.
Poi, l'"artista": la parola filosofica è a sua volta "poiesis", apertura di
mondo, ossia creazione di senso, di immagini che non celano nulla. Per
questo ritengo che non si possa considerare il filosofo come un
professionista. Vi sono, certo, dei professionisti della filosofia, i
professori universitari, per esempio, ma la filosofia è altro.
Infine, il "sacerdote": il filosofo lo è «interamente» perché prende sul
serio la finitezza dell'esistenza, muove dall'esperienza dello scacco.
Cito ancora da Andrea Emo (1901-1983) «la filosofia [...] è anche pratica,
è come la religione, un sistema, un modo di sopportare l'atroce
assurdità della vita. Una religione che ha degli eretici e degli apostati,
delle cattedrali e delle catacombe» (A. Emo, op. cit., p. 106). Il filosofo
riconosce la nostra natura «sospesa» tra la constatazione della
relatività di tutte le nostre conquiste e il bisogno di assolutezza che a
esse ci motiva. L'uno aspetto è il rovescio dell'altro: «non possiamo
vivere senza essere assoluti, non possiamo vivere senza essere
relativi» (A. Emo, op. cit., p. 96).
Eppure, che strano personaggio è quello in cui tre nature si sommano
insieme, e alcune solo per metà? A prima vista, è più bizzarro del
mitologico centauro, metà umano e metà equino. Nel caso del filosofo
la componente scientifica e quella artistica si saldano in modo da
rendersi irriconoscibili ai professionisti sia della scienza sia dell'arte.
Una delle metà altera i contorni dell'altra: a differenza che nell'impresa
scientica, le «immagini» filosofiche non hanno la forma né di teorie
empiricamente controllabili né di istruzioni tecnologicamente affidabili
(se mai lo diventano, cessano di essere filosofia), diversamente
dall'arte, non danno luogo a «opere» ma a «sistemi» - che, ovviamente,
possono essere articolati anche in modo asistematico, pensiamo alle
domande impertinenti di Socrate, agli aforismi di Nietzsche o alle
«osservazioni» di Wittgenstein, eccetera.
Per capire questo punto è bene, forse, muovere dalle parole con cui
Friedrich von Hardenberg, in arte Novalis (1772-1801), riassumeva la
lezione copernicana: «Tutti i buoni ricercatori [...] fanno come
Copernico: ruotano i dati e i metodi per vedere se così va meglio»
("Allgemeines Brouillon", 517, trad. it. "Opera filosofica II", a cura di F.
Desideri, Einaudi, Torino 1993, p. 385). Sembrerebbe un'operazione
abbastanza innocua, è invece la rivoluzione. «La fil[osofia] "scioglie"
ogni cosa - relativizza l'universo - Come il sistema copernicano, essa
toglie i punti "fissi" - e di quanto quietamente riposava fa un qualcosa
di fluttuante. Essa insegna la relatività di tutti i fondamenti e di tutte le
proprietà - l'infinita varietà e unità delle costruzioni di una cosa»
("Allgemeines Brouillon", 622, trad. it. cit., p.408).
Non si intendano queste battute come l'annuncio di un relativismo a
buon mercato. Del resto, non c'è affermazione che evochi un assoluto
più di quella che dichiara che «tutto è relativo». Lasciatemi citare, per
un'ultima volta, Andrea Emo: il «mistero» che caratterizza quella
particolare «religione» che è la filosofia è il rapporto che essa istituisce
«tra l'infinito e la sensazione» (op. cit., p. 106). Almeno, da quando
Talete ha insegnato a cercare l'"arche" al di là della varietà del mondo
fenomenico. E' questo «spirito» della filosofia che traspare dalla stessa
"Fides et Ratio": la «grande sfida» di più di venticinque secoli fa come
alle soglie del terzo millennio «è quella di saper compiere il passaggio,
tanto necessario quanto urgente, dal fenomeno al fondamento. Non è
possibile fermarsi alla sola esperienza; [...] è necessario che la
riflessione speculativa raggiunga la sostanza spirituale, il fondamento
che la sorregge» (n. 83).
Ma di questo fondamento il filosofo è «interamente» sacerdote. E lo è al
punto da riconoscere in esso unicamente un "nome": «si dice di Dio:
'nessun nome può nominarti'. Ciò vale per me: nessun concetto mi
esprime, niente di quanto viene indicato come mia essenza mi
esaurisce: sono solo nomi. [...] "Proprietario" del mio potere sono io
stesso, e lo sono in quanto so di essere "unico". Nell'"unico" il
proprietario stesso rientra nel suo nulla creatore dal quale è nato. Ogni
essere superiore a me stesso», ossia ogni fondamento, «sia Dio o
l'uomo, indebolisce il sentimento della mia unicità e impallidisce
appena risplende il sole di questa mia consapevolezza. Se io fondo la
mia causa su di me, l'unico, essa poggia sull'effimero, mortale creatore
di sé che se stesso consuma, e io posso dire: io ho fondato la mia
causa su nulla» (M. Stirner, "L'unico e la sua proprietà", trad. it.
Adelphi, Milano 1979, p.p. 380-381).
Non si tratta, però, di fare dell'assenza di fondamento un nuovo idolo di
fronte al quale piegare le ginocchia. Né si tratta di abbandonarsi in
modo compiaciuto all'esperienza dello «spaesamento» o del
«disincanto», ritirandosi nell'«attesa». Al contrario, è in quel nulla della
causa che trova ragione la filosofia. Certo, essa per secoli ha cercato di
svelare l'essere in quanto tale - e le cosiddette "filosofie speciali"
mirano a enucleare le condizioni di possibilità delle differenti pratiche
umane: la filosofia dell'arte per l'arte, la filosofia della politica per la
politica, la filosofia della scienza per la scienza. Tuttavia, l'ossessiva
ricerca del fondamento ne consuma la sostanza, immagine di nulla,
così che non c'è alcuna divinità che possa sorreggerci. Come diceva
Novalis, «una vera anarchia è l'elemento generatore della religione»
("La Cristianità ovvero l'Europa", in "Opera filosofica II", trad. it. cit., p.
601).
Per questo, se il filosofo è sacerdote, lo è per "non credenti", e quella
della filosofia è una fede per increduli, una verità che non salva, poiché
non c'è alcuna anima da salvare; una ricerca della salvezza che si
compie in un esercizio senza fine che rinuncia al suo possesso.
Esercizio del rischio, perciò stesso rischioso. Verità che non è
monopolio di alcuna Chiesa, nemmeno di quella dei liberi pensatori.
In che modo, allora, si può dire che la filosofia sia «ancella delle
scienze» - per riprendere il titolo di questa sezione? Sicuramente, non
nell'accezione letterale del termine, per cui "ancilla" deriverebbe, come
diminutivo, da "ancula", ossia serva o schiava. Se c'è uno spirito che
mi pare estraneo alla filosofia è il cosiddetto "spirito di servizio". Ogni
tanto qualche malcapitato rinfaccia alla filosofia di non servire a nulla.
Appunto, non serve a "niente" e a "nessuno". Quindi, nulla essa
guadagnerebbe a passare da "ancilla theologiae" ad "ancilla
scientiarum". Questo non significa, però, che il confronto tra filosofia e
scienza sia insensato o vano. Per dirla ancora con Novalis: «Ogni
s[cienza] ha il suo Dio che al contempo è la sua meta. Così la
meccanica vive propriamente del perpetuum mobile - e nello stesso
tempo cerca, come suo massimo problema, di costruire un "perpetuum
mobile". Così la chimica con il menstruum universale - e la sostanza
"spirituale" o la pietra filosofale. La fil[osofia] cerca un primo e unico
principio. Il matem[atico] la quadratura del circolo e un'equazione
principale. L'"uomo-Dio". Il medico un elisir della vita - un'essenza per
ringiovanire e il per[fetto] sentimento e trattamento del corpo. Il politico
uno Stato perfetto - la pace perpetua - "Stato libero"» ("Allgemeines
Brouillon", 314, trad. it. cit., p. 323).
Qualsiasi studente delle medie superiori sa, o almeno dovrebbe sapere,
come in matematica, in meccanica o in chimica il particolare «Dio»
indicato da Novalis abbia segnato al tempo stesso lo scacco di un
ambizioso programma e l'innesto di nuove o più proficue tecniche di
ricerca. Quanto alla medicina, non è forse uno dei grandi sogni o incubi
del nostro tempo «il perfetto trattamento del corpo»? Sulle «piccole»
guerre che costellano le «grandi» paci di questo fine secolo non sto
nemmeno a spendere parola - mentre di quanto sangue possa grondare
uno «stato libero» lo sanno tutti quelli che l'hanno provato. Eppure,
sono queste «aspettative sempre deluse e sempre rinnovate» (Novalis,
"Allgemeines Brouillon", 314, trad. it. cit., p. 323) a informare ogni
pratica di ricerca. La stessa filosofia è un po' come la «pietra
filosofale», una sorta di «quadratura del cerchio», in qualche senso
impossibile, in un altro necessaria: «la filosofia è l'intelligenza stessa»
(vedi Novalis, "Allgemeines Brouillon", 640, trad. it. cit., p. 416).
Oggi l'impresa scientifica riesce a prospettare un quadro plausibile
dell'evoluzione del cosmo (a partire da tempi di poco superiori al
"tempo di Planck", vedi "questo volume", p.p. 19-22 e in particolare p.
21) e del vivente (vedi p.p. 51-64), della struttura del cervello umano
(vedi p.p. 77-86) e del comportamento cosciente o meno (p.p. 87-103).
Riesce a fare tutto ciò perché ha saputo abbinare speculazione teorica
e potenza tecnologica. Talvolta, sono gli stessi ricercatori scientifici a
riconoscere quanto le loro "analisi" restino tuttavia lontane da una
possibile "sintesi" (valga per tutti l'esempio di Roger Penrose, "Il
grande, il piccolo e la mente umana", a cura di M. Longair, trad. it.
Cortina, Milano 1998). Peraltro, la cosmologia contemporanea si
alimenta persino dell'audace congettura su quello che vi era prima
dell'inizio (vedi "questo volume", p.p. 23-24), e la biologia si arrovella
sulla comparsa del vivente (cioè sulla transizione dal chimico al
biologico, vedi p.p. 43-50), e poi sul modo in cui dai procarioti si è
passati alle cellule più complesse di cui noi siamo fatti, gli eucarioti
(vedi p.p. 65-66), per non dire sull'«emergenza» nella vita
dell'"intelligenza". Si darà mai un senso a un'espressione come
«macchina pensante», o una spiegazione di cosa sia la «mente»?
Come si vede, un qualche «Dio» di Novalis è sempre all'opera, e ogni
volta che si produce quel particolare effetto di «delusione» e insieme di
«rinnovamento», la filosofia, non tanto come disciplina definita, quanto
piuttosto come compito di continuo ridefinibile, si insinua "nelle pieghe
della scienza". E' possibile farne a meno? Forse, ma a quale prezzo?
Nel paesaggio che ci è offerto dall'impresa scientifica è fin troppo facile
che la luce delle conquiste finisca per abbagliarci facendoci
dimenticare le zone d'ombra. Ed è in questa loro «"prosperity"» che va
rintracciata, paradossalmente, quella "crisi delle scienze" di cui ha
trattato molta riflessione del Novecento (e che non va intesa come crisi
nelle scienze o crisi di una disciplina particolare).
Nei successi delle «scienze», innegabili - così come innegabile è la loro
portata conoscitiva -, si cela, quasi a condizione di possibilità della loro
efficacia, la rinuncia, consapevole o meno, a porre la questione del
senso. Del senso non solo delle loro pratiche, ma anche dell'esistenza.
E', dunque, l'oblio, pressoché necessario, di tali domande da parte della
scienza l'indice dell'esigenza di rivendicare il diritto all'interrogazione
filosofica. Senza cadere per questo in facili irrazionalismi o in ancor più
facili atteggiamenti antiscientifici che, di fatto, rappresentano la
negazione dell'istanza della filosofia.
Si è evocata (vedi "questo volume", p.p. 16-18) anche la figura di
Giordano Bruno (1548-1600). Vorrei rifarmi qui, oltre che al cosmologo
del "De l'infinito, universo e mondi" (1584), al teorico di "Gli eroici
furori" (1585). Per il Nolano non vi sono unicamente furori distruttivi,
bensì anche furori alimentati da spirito lucido ed intellettuale», «dal
fuoco del desio e soffio dell'intenzione» - tali che «nel solfro della
cogitativa facultade accendono il lume razionale con cui veggono più
che ordinariamente». Tali furori «non sono oblio, ma una memoria; [...]
non è un raptamento sotto le leggi di un fato indegno, [...] ma un impeto
razionale» ("Dialoghi italiani", nuovamente ristampati con note da G.
Gentile, terza edizione a cura di G. Aquilecchia, Sansoni, Firenze 1958,
p.p. 986-987).
Non paia strano che qui si rimandi a colui che morì da ultimo dei maghi
e primo dei moderni, e che aveva fatto del copernicanesimo lo
strumento per ripristinare l'antichissima religione di un Dio
infinitamente infinito (cui può solo convenire un universo senza "limiti":
«straccia le superficie concave e convesse, che terminano entro e fuori
tanti elementi e cieli» ("De l'infinito, universo e mondi", in "Dialoghi
italiani", cit., p. 536). Bruno non fu l'illuminista "ante litteram" o il
«libero pensatore» dell'iconografia ottocentesca, e fu quasi certamente
l'iniziato ben disposto a lasciare le masse (se vogliamo ancora usare
questa orribile parola) sotto i vincoli delle religioni positive. Nonostante
questo, o forse proprio per questo, risalta la forza del suo gesto
filosofico.
A qualche secolo di distanza, la posta è sempre la stessa: «il maggior
pericolo [...] è la stanchezza. Combattiamo contro questo pericolo
estremo, in quella disposizione d'animo che non teme nemmeno una
lotta destinata a durare in eterno; allora dall'incendio distruttore
dell'incredulità, dal fuoco soffocato della disperazione, dalla cenere
della grande stanchezza, rinascerà la fenice di una nuova interiorità di
vita e di una nuova spiritualità» (Edmund Husserl, "La crisi delle
scienze europee e la fenomenologia trascendentale", trad. it. Il
Saggiatore, Milano 1983, p. 358).
PER UNA ETERONOMIA FONDATRICE
(Bruno Forte).
Teologia: ancella della scienza? Questa domanda è figlia del tempo
della modernità: alla teologia - "regina scientiarum" nell'enciclopedia
del sapere medioevale - la ragione moderna ha sostituito se stessa
quale protagonista e vertice della conoscenza. Ecco perché nell'epoca
iniziata dall'Illuminismo il vero problema del rapporto fra teologia e
scienza "non" è quello della loro separazione, quanto piuttosto quello
di una loro eccessiva conciliazione: da una parte, la ragione moderna
tende ad assorbire in sé la fede, a farne una «provincia dello spirito»,
regolata dalle leggi del divenire che abbraccia tutte le cose; dall'altra,
una certa apologetica teologica tende ad asservire a sé il dato
scientifico in un concordismo a tutti i costi. La crisi delle pretese della
razionalità moderna, la cosiddetta «dialettica dell'Illuminismo», investe
questo tipo di rapporto fra scienza e teologia: si avverte l'insufficienza
di ogni «scientismo», di quell'ideologia della scienza, cioè, che è stata
smentita nelle sue presunzioni deterministiche assolute dalla stessa
evoluzione delle teorie scientifiche, al tempo stesso in cui appare non
meno ideologico e insostenibile un uso teologico strumentale della
scienza. La crisi dei modelli di sapere prodotti dalla modernità
smaschera i possibili impianti ideologici della conoscenza scientifica e
di quella teologica.
Teologia e scienza si scoprono così entrambe più povere: però, è forse
questa nuova povertà che consente anche un nuovo dialogo. Da una
parte, la razionalità teologica non potrà che avere un compito blasfemo
nei confronti di una razionalità scientifica che continuasse ad avanzare
pretese di assolutezza: essa si pone come correttivo antiidolatrico,
denuncia del limite di ogni totalità chiusa, stimolo all'apertura sulla
traccia dell'infinito. Dall'altra, la razionalità scientifica avrà ragione di
mostrarsi disinteressata e scettica, perfino canzonatoria nei confronti di
una teologia concordistica a ogni costo. Dove però la teologia saprà
essere non meno, ma più «teologica», e si presenterà dunque come
pensiero della "Krisis" (Karl Barth), dell'interruzione (Johann Baptist
Metz), anti-ideologico per eccellenza, e la razionalità scientifica saprà
coniugare la conoscenza del mondo dei fenomeni all'onesta
consapevolezza dei propri limiti, allora entrambe potranno assumere
una singolare rilevanza nell'attuale contesto di «caduta degli dei» che è
la crisi delle ideologie, specie nel Nord del mondo.
Teologia e scienza, più modeste e consapevoli del loro servizio a tutto
l'uomo in ogni uomo, possono allora incontrarsi sul piano della
intenzionalità ultima e della responsabilità etica. Nel tramonto degli
idoli, legati ai grandi miti dell'ideologia, esse si trovano a confrontarsi
non come due mondi chiusi che si sfidano, ma come due forme del
pensare e dell'agire umano, chiamate entrambe a misurarsi sull'altro
per cui esistono. Oggi scienza e teologia sono entrambe sfidate in
modo nuovo dalle loro responsabilità etiche: è su questo terreno che il
loro incontro potrà essere ben più radicale e fecondo di quanto la
contrapposizione o l'assimilazione a buon mercato abbia potuto far
ipotizzare per il passato.
Vorrei soffermarmi su tre aspetti: 1) le responsabilità della scienza, 2) le
responsabilità della teologia, 3) l'eteronomia fondatrice tra scienza e
teologia.
1) "Le responsabilità della scienza". La razionalità scientifica è
chiamata in causa dal problema - oggi più che mai attuale - della
distinzione fra ciò che è tecnicamente possibile all'uomo e ciò che gli è
eticamente consentito: il mito della neutralità della scienza, fondato
sulla soppressione di questa basilare distinzione, si è rivelato
clamorosamente distruttivo e alienante proprio nei suoi risultati umani
e sociali. Per esempio, la crisi ecologica, di cui si è così acutamente
consapevoli ai nostri giorni, consiste precisamente nel turbamento
indiscriminato indotto nei ritmi e negli equilibri naturali dalla
trasformazione accelerata cui essi sono sottoposti a causa del
comportamento umano, che la scienza ha dotato di potenzialità prima
imprevedibili. Si potrebbe affermare che il nucleo della crisi ambientale
stia nella differenza tra «tempi storici» e «tempi biologici», nella
sfasatura cioè fra i velocissimi tempi della tecnologia e i lentissimi
tempi della biologia. Le conseguenze di questa sfasatura - di cui
l'esempio più eclatante è il possibile impiego distruttivo dell'energia
nucleare - non sono solo riscontrabili negli effetti devastanti che essa
ha sul deterioramento ambientale e sul ricambio energetico, ma anche
nelle prospettive che si disegnano per i soggetti storici.
Il profilarsi della scissione fra etica e scienza coincide con quella che
Martin Heidegger ha chiamato «l'epoca dell'immagine del mondo»: è il
tempo in cui il trionfo moderno della soggettività si è consumato a
prezzo della riduzione degli enti a mero oggetto, compiuta attraverso
«un rappresentare, un porre-innanzi ("vor-stellen"), che mira a
presentare ogni ente in modo tale che l'uomo calcolatore possa esser
sicuro, cioè certo dell'ente» («L'epoca dell'immagine del mondo», in
"Sentieri interrotti", trad. it. La Nuova Italia, Firenze 1984, p.p. 83 seg.). Il
conoscere diviene possesso del conosciuto e la ricerca esercizio della
«volontà di potenza» della ragione assoluta: gli esseri umani si
relazionano al mondo come al vasto campo del loro dominio, «maîtres
et possesseurs de la nature» (Cartesio). Il «sapere aude» illuministico si
coniuga al «sapere è potere» (Bacone), che sta alla base del moderno
sviluppo della scienza e della tecnica. Si profila a pieno campo il trionfo
della ragione strumentale! La violenza che si esercita sul reale, per
assimilarlo alla rappresentazione concettuale, è percepita come una
forma di affermazione della verità, come uno stabilire l'«ordre de la
raison» sull'irrazionale disordine del tempo storico. Imperialismo della
soggettività, volontà di potenza e rapporto strumentale con la natura si
corrispondono.
Anche la concezione del tempo è plasmata dalla svolta moderna verso
il dominio del soggetto: la ragione, che sa di sapere e vuole tutto
dominare, imprime ai processi storici di adeguamento del reale
all'ideale un'incalzante accelerazione. Questa fretta della ragione si
esprime tanto nella crescente rapidità dello sviluppo tecnico e
scientifico, quanto nell'urgenza e passione rivoluzionaria, connessa
all'ideologia. Il mito del progresso non è che un'altra forma della
volontà di potenza della ragione: in esso la presunzione della finale
conciliazione, che superi la dolorosa scissione fra reale e ideale,
diviene chiave di lettura dei processi storici, anima ispiratrice
dell'impegno di trasformazione del presente. Il divario fra «tempo
storico» e «tempo biologico» è spinto al massimo dalla sete di
compimento totale, di soluzioni finali, tipica delle «grandi narrazioni»
dell'ideologia del progresso, anche scientifico. Porre un limite alle
pretese della scienza, negare il principio scientista per cui tutto ciò che
è tecnicamente possibile è anche lecito, diventa urgenza richiesta dalla
tutela della qualità della vita di tutti.
2) "Le responsabilità della teologia". Anche la teologia ha in tutto
questo le sue responsabilità: le radici culturali della mentalità, che
presiede allo sviluppo del rapporto squilibrato fra uomo e natura, sono
state certo anche teologiche (si veda in particolare Lynn White junior,
«The historical roots of our ecological crisis», "Science" 155 (1967),
p.p. 1203-1207, trad. it. in "Il Mulino", marzo-aprile 1973). In modo
particolare, la sopraffazione esercitata dall'uomo sulla natura sarebbe
giustificata dal comando divino riportato nel libro della Genesi: «Siate
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che
striscia sulla terra» (1, 28). Questa affermazione - rivestita dell'autorità
della rivelazione - avrebbe determinato lo sviluppo di un'etica del
dominio, fortemente antropocentrica, tale da giustificare la
finalizzazione e la strumentalizzazione del mondo agli interessi del
soggetto umano.
Un secondo rimprovero che viene mosso alla teologia propria della
tradizione ebraico-cristiana è quello di aver comportato un originario
«disincanto del mondo» (Max Weber), che avrebbe consentito
l'abbandono di ogni atteggiamento sacrale verso la natura:
enfatizzando la divinità di Dio e la Sua sovrana trascendenza, il
pensiero biblico avrebbe operato la più radicale delle secolarizzazioni,
spopolando l'Universo dei suoi numi e riducendolo a semplice terra di
conquista abbandonata alla cupidigia dell'uomo.
Viene infine attribuita alla tradizione teologica ebraico-cristiana la
responsabilità del profilarsi di quella concezione lineare del tempo, che
è alla base del moderno mito del progresso, causa di tanta violenza nei
confronti
della
realtà
naturale,
forzatamente
piegata
alle
rappresentazioni ideali e alle loro ambizioni di compimento rapido e
trionfante. La visione biblica dell'Esodo e del Regno, la religione della
promessa e l'etica della speranza sarebbero colpevoli di aver proiettato
gli uomini verso il futuro, imprimendo un'esasperata accelerazione al
tempo storico. La derivazione della moderna filosofia del progresso
dall'eredità teologica occidentale caricherebbe di responsabilità proprio
la teologia nei confronti delle tragedie prodotte dai vari «totalitarismi»
ideologici affermatisi nel «secolo breve» (Eric Hobsbawm).
3) "L'eteronomia fondatrice tra scienza e teologia". Sia le responsabilità
della scienza sia quelle della teologia rimandano, dunque, a una misura
che sia fuori del chiuso orizzonte delle visioni ideologiche, teologiche o
scientifiche, a un criterio altro, capace di fondare un impegno morale,
che aiuti a discernere fra ciò che è possibile e ciò che è lecito in vista
del bene di tutti. La tradizione ebraico-cristiana coglie questo criterio
nell'orizzonte biblico dell'alleanza con Dio: pur ricevendo una
particolare dignità e responsabilità, l'uomo sta davanti a Dio nella
solidarietà con tutto il creato, chiamato a realizzarsi nel suo rapporto
col Creatore e in quello con gli altri uomini e l'Universo intero. Accanto
a Gen 1, 28 c'è l'affermazione dell'altro e più antico racconto della
creazione, dove l'atteggiamento richiesto all'uomo verso il mondo
presenta i tratti della sollecitudine, dell'affidamento e della cura: «Il
Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse» (Gen 2, 15). La tradizione ebraico-cristiana,
peraltro, ha espresso esempi altissimi di rapporto non strumentale e
anzi amorevole con la natura: ne sono prova per esempio, la laboriosità
benedettina, ricca di tensione spirituale, la «custodia» del creato nello
spirito di Francesco d'Assisi e del suo "Cantico delle creature", o la
«riverenza» ignaziana verso tutto ciò che esiste, in quanto porta in sé
l'impronta del Creatore.
Certamente, in questa prospettiva la natura non ha nulla che possa farla
divinizzare: essa è creatura, come lo è l'uomo. Tuttavia, proprio in
quanto oggetto dell'amore creatore del Dio dell'alleanza, essa riveste
una dignità altissima, costantemente richiamata dall'espressione del
compiacimento divino dinanzi all'opera dei sei giorni: «Dio vide che era
cosa buona» (Gen 1). Il disincanto del mondo compiuto dalla
rivelazione biblica si traduce allora non nel rapporto esclusivo uomonatura, interpretato nella forma dello sfruttamento e del dominio, ma
nella relazione articolata fra l'universo creaturale, la più alta delle
creature, e l'unico Signore del cielo e della terra. E' proprio la relazione
dell'uomo e della natura al Creatore, dunque, a fondare una
responsabilità ecologica di alto livello nella coscienza del soggetto
storico.
Sul piano etico questa relazione impegna l'uomo a render conto al Dio
vivente della maniera in cui si rapporterà al mondo, che l'Eterno ha
affidato alle sue cure, e tanto più del modo in cui si relazionerà all'altro
uomo, come lui immagine di Dio. Secondo la nota tesi di Karl Löwith
non è la radice teologica, ma la sua perdita che trasforma il mito
moderno del progresso in una permanente minaccia all'equilibrio dei
rapporti fra l'uomo e il suo ambiente. Dove è perduto il senso della
Trascendenza, ogni alterità è svuotata di consistenza e l'imperialismo
del soggetto ha libero corso, anche nei rapporti con la natura. L'Altro
non riducibile al medesimo è, dunque, quanto la coscienza morale
ispirata dalla fede biblica propone all'uomo come misura del suo agire,
altrimenti indiscriminato: in questo senso, il Dio biblico è davvero
l'avvocato dell'uomo, non la sua minaccia o il suo concorrente.
Alla luce di questo criterio fondamentale la teologia ricorderà alla
scienza che nessun intervento promosso dalla ragione scientifica sarà
moralmente accettabile se comporterà in qualunque forma o misura
una violazione della sacralità della vita umana e della unicità e
irripetibile dignità dell'essere personale (come nel caso di applicazioni
di ingegneria genetica a scopo alterativo o distruttivo di esseri umani).
Viceversa, dove la persona sarà rispettata o promossa (come nel caso
delle applicazioni della genetica a livello diagnostico, terapeutico o
produttivo, sempre che le tecniche adoperate non comportino danno
all'integrità o alla vita stessa dell'essere umano), l'intervento di
manipolazione scientifica risulterà moralmente fondato. Dove vi è
autonomia assoluta del protagonismo storico, ogni manipolazione e
alienazione risulterà possibile. Dove, invece, è riconosciuta e accolta
un'eteronomia fondatrice, anche le forme più avanzate di ricerca
scientifica rispetteranno il valore assoluto della persona umana e
promuoveranno una cultura della vita e della sua qualità per tutti e per
ciascuno. Affermare l'eteronomia fondatrice vuol dire, insomma, per lo
scienziato non ergersi a misura del tutto e di tutti, ed entrare nella
logica di un'etica della solidarietà e della responsabilità che sola è
capace di servire tutto l'uomo in ogni uomo.
In questo tempo postmoderno, descritto già come quello del «naufragio
con spettatore» (Hans Blumenberg), in cui ciascuno è al tempo stesso
naufrago e responsabile dinanzi al naufragio, nel dialogo fra teologia e
scienza non si svolge solo una battaglia dell'uomo con se stesso, ma
una vera e propria lotta di Giacobbe, in cui la posta in gioco è la dignità
stessa dell'essere umano e la qualità della vita per tutti. In questa lotta
vince chi si lascia vincere dalla maestà dell'altro, trascendente e
sovrano: solo dove l'esistenza della persona è riconosciuta come dono
da accogliere e rispettare, inviolabile nella sua sacralità, fondata
eteronomamente, la ricerca scientifica conosce limiti e misure di ordine
deontologico e sfugge ai rischi dell'alienazione.
La qualità etica della scienza non sta nelle sue possibilità e nelle sue
pretese di assolutezza, ma nel suo essere consapevole dei propri limiti
e delle proprie capacità in campo etico e sociale, per inserirsi
ordinatamente in un progetto di umanità solidale e di responsabilità
morale nei confronti di ogni essere umano. E' ricordando questo alla
scienza che la teologia si fa sua «ancella»: è tacendo su questo, che si
fa complice della caduta della razionalità scientifica nelle secche
alienanti dello «scientismo». Dunque, non una teologia ancella della
scienza in senso servile, né una scienza ancella della teologia in chiave
concordistica, ma teologia e scienza ancelle entrambe dell'altro, al
servizio di tutto l'uomo in ogni uomo, aperte all'Ultimo, che tutto supera
e trascende, nella fedeltà al penultimo, senza lasciarsi catturare da
alcuno.
DIALOGO
(Carlo Maria Martini e Giulio Giorello).
CARLO MARIA MARTINI: Lei ha trattato della filosofia entro le pieghe
della scienza, accennando peraltro a quelle «zone d'ombra» relative
all'origine dell'Universo, alla comparsa della vita, all'emergenza della
mente. Che cosa ha da dire la filosofia sui "limiti" della scienza? Ha una
dottrina, una riflessione in proposito?
GIULIO GIORELLO: Nella luce accecante delle certezze può dar sollievo
l'ombra della palma. Sulle più varie pratiche umane la filosofia
incessantemente solleva dei dubbi. E' questo il suo «sistema». Potrei
quindi rispondere che, a proposito dei limiti della scienza, la filosofia ha
certo una riflessione, anche se non una dottrina. Tuttavia, non è che la
filosofia debba giudicare la scienza (come, del resto, ci parrebbe
bizzarro che la scienza giudicasse la filosofia). Si tratta piuttosto (come
ho detto a p. 120) di cercare la filosofia nelle stesse pieghe della
scienza - e riprendo la bella immagine del mio maestro Ludovico
Geymonat (1908-1991) (vedi "Lineamenti di filosofia della scienza",
Mondadori, Milano 1985, p. 144). Una filosofia "nella" scienza, dunque:
una filosofia che è all'opera in essa, e non soltanto nei termini di quella
«metafisica influente» che parte dell'epistemologia contemporanea (da
Karl Popper a John Watkins, da Joseph Agassi a Imre Lakatos, per non
dire di alcuni spunti suggeriti dalle ricognizioni «storiche» di Thomas
Kuhn e di Paul Feyerabend) ha più volte enfatizzato. Alludo piuttosto
alla possibilità di "pensare" filosoficamente entro la scienza, avendo il
coraggio di spingere l'interrogazione fine alla linea d'orizzonte che
idealmente ne delimita il «patrimonio» (il termine è ancora di
Geymonat). "Orizzonti e limiti della scienza": «linea aperta e
invalicabile», l'orizzonte è invenzione del nostro occhio e si muove con
esso (vedi A. Emo, "Supremazia e maledizione", cit., p. 110); quanto ai
limiti, riconoscerli non esclude che "si lavori su di essi", «una paziente
fatica che dia forma alla nostra impazienza per la libertà» (vedi M.
Foucault, «What is Enlightenment?», in P. Rabinow (a cura di), "The
Foucault Reader", Pantheon Books, New York 1984, p.p. 32-50, poi in
"Dits et écrits 1954-1988", vol. 4, Edition établie sous la direction de D.
Defert et F. Ewald, Gallimard, Paris 1994, p.p. 562-578, in particolare p.
578).
MARTINI: La filosofia può spingersi allora oltre i limiti della scienza, in
riferimento all'origine dell'Universo, della vita e della mente? Oppure
tutto questo esula dal suo campo?
GIORELLO: Non penso sia compito della filosofia dire ciò che la
scienza non dice. A lei spetta, semmai, far riflettere sul perché siano
dette certe cose, e non altre (e quali implicazioni abbiano). Possono
essere utili due esempi. Il primo è pressoché un classico per lo storico
del pensiero scientifico. Nelle parole di Federigo Enriques (1871-1946):
«quando Newton scoprì che l'attrazione si esercita non tanto tra il Sole
e i pianeti, ma anche tra i pianeti - reciprocamente da ciascuno di essi
sull'altro - ei s'avvide che l'ordine del sistema solare ne risulterebbe
turbato, ché le ellissi kepleriane descritte dai corpi andrebbero
deformandosi e così la bella armonia dell'insieme potrebbe rompersi un
giorno. Ma lo spettacolo della catastrofe bruciò gli occhi al severo
scienziato, che, dimentico in quel punto delle esigenze fondamentali del
proprio metodo, si rifugiò nella fede divina, lasciando alla Provvidenza
di ristabilire l'ordine turbato del cosmo» ("Scienza e razionalismo",
Zanichelli, Bologna 1912, ristampa anastatica 1990, p. 288). Qui
addirittura era la teologia a essere messa al servizio della scienza. O
meglio, si sostenevano in una sorta di circolo la concezione newtoniana
di un Dio garante dell'ordine del mondo e una filosofia della natura
fortemente matematizzata che faceva esperienza dei propri ostacoli
interni (vedi V. I. Arnol'd, "Huygens & Barrow, Newton & Hooke", trad.
it. Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 63). Dopo Newton (1642-1727) la
ricerca fisico-matematica ha ripetutamente affrontato la questione fino
alla svolta segnata dai contributi di Henri Poincaré (1854-1912) che
consentirono di impostare «il problema in modo tutto nuovo»: «invece
di cercare formule che esprimessero il variare della posizione dei corpi
celesti nel corso del tempo egli si interrogò sull'aspetto qualitativo delle
orbite: i pianeti si avvicinano tra loro? Possono cadere sul Sole oppure
allontanarsene? e via di questo passo» (V. I. Arnol'd, cit., p. 73). E'
risultato alla fine che il moto in un sistema di più di due corpi è ora
regolare, ora caotico a seconda delle condizioni iniziali. E «anche se il
moto di un pianeta [...] è regolare, è sufficiente una perturbazione
arbitrariamente piccola dello stato iniziale per renderlo caotico.
Fortunatamente, la velocità con cui si instaurano queste perturbazioni
caotiche è estremamente piccola, sicché il tempo necessario al
manifestarsi della caoticità, per una perturbazione abbastanza piccola
allo stato iniziale, è lungo rispetto all'intera durata del sistema solare.
Così, per i prossimi miliardi di anni [...] 'l'orologio meccanico' descritto
da Newton continuerà a funzionare diligentemente» (V. I. Arnol'd, cit., p.
75). E che ne è ora del suo Dio?
Si potrebbe pensare che il mescolare l'Onnipotente ai problemi fisicomatematici sia proprio di un periodo ancora aurorale, benché
grandioso, della «filosofia naturale». Di fatto, sono talora i ricercatori
scientifici a ritornare oggi sul terreno che un tempo era tipicamente
filosofico, se non teologico. L'idea del "fine tuning" (vedi "questo
volume", p. 22) per cui se le costanti universali che sono alla base della
fisica dell'Universo avessero valori anche minimamente differenti, la
vita (come la conosciamo) non si sarebbe potuta sviluppare su questa
Terra (e noi non saremmo qui in questa Cattedra...), è per qualcuno il
modo migliore per riaffermare l'idea che nella nascita e nell'evoluzione
dell'Universo si manifesti una sorta di Grande Disegno. Curiosamente,
miscredenti come Fred Hoyle e credenti come John Eccles sembrano
convergere in questo argomento del Progetto che parte dalla chimica
stellare per concludere che l'Universo non aspettava altro che la
comparsa dell'«osservatore intelligente», l'uomo. Per non parlare,
addirittura, di una "Fisica dell'immortalità" (come pretende Frank Tipler,
trad. it. Mondadori, Milano 1995). Di fronte a scenari del genere, dove il
fisico si annette «imperialisticamente» i territori del teologo, è bene
guardarsi intorno alla ricerca di qualche alternativa - nella fattispecie
l'alternativa dei molti universi (o «Multiverso») che riduce la portata
teleologica del cosiddetto ragionamento antropico in un contesto
matematicamente ed euristicamente assai stimolante. Sarà, per ora,
mera speculazione, ma non dobbiamo dimenticare che per secoli
alcune «speculazioni», come quella bruniana (e non solo) della pluralità
dei mondi, hanno impedito al pensiero di restare schiavo di quella che
all'epoca era considerata la teoria scientifica accreditata. E se la
cosmologia del Multiverso pare violare il principio di parsimonia
usualmente attribuito a Occam, per cui gli enti non vanno moltiplicati
senza necessità, bisogna pur dire che essa ci libera da quel finalismo
che farebbe della fisica un dio, come vorrebbe Tipler. Per altro,
Guglielmo di Occam (ca 1280-1347) considerava possibile la pluralità e
non la riteneva in contrasto con il suo nominalismo; vedi S. J. Dick,
"Plurality of Worlds", Cambridge University Press, Cambridge 1982, p.p.
30-35; per il criterio della «economia» cui si contrappone la «liberalità»
di Dio creatore vedi L. Bianchi, "Il Vescovo e i filosofi", cit., p.p. 81 e 99).
La filosofia non va oltre la scienza, ma si muove "a latere", e questa sua
attenzione alle possibilità di riaprire lo spazio delle alternative
rappresenta il corrispettivo per la teoria di quella che è per la pratica la
responsabilità di cui ha trattato Bruno Forte (p. 129).
MARTINI: Quali sono i punti di incontro possibili con la teologia?
Filosofia e teologia convergono soltanto sul tema etico della
responsabilità, o anche nel delineare delle risposte a interrogativi
sull'origine, sulla fine e sul senso della vita umana?
GIORELLO: Insisto ancora sul senso della nostra finitezza, che porta il
filosofo a situazioni apparentemente paradossali. Certo, concordo con
Bruno Forte nel considerare "forma particolare di tirannide" una ricerca
in cui tutto ciò che è tecnicamente possibile venga per ciò stesso
attuato. Né basta a giustificare la cosa il desiderio di conoscenza. Trovo
ripugnante, per esempio, che a scopo «conoscitivo» non venga
somministrato un farmaco a una data categoria di persone pur sapendo
che quel farmaco potrebbe salvarle. Nel 1972 venne resa pubblica negli
Stati Uniti l'esistenza del «Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the
Negro Male», un progetto dell'U.S. Public Health Service perseguito dal
1932: i medici avevano messo sotto controllo seicento maschi neri e
poveri della Georgia, di cui 399 malati di sifilide. Lo scopo della ricerca
era studiare il decorso della sifilide in assenza di trattamento (anche
quando venne scoperta la penicillina e il medicamento si rese
largamente disponibile alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i
dottori continuarono a non curare gli uomini sotto inchiesta).
Ora, non c'è dubbio che si avverta l'esigenza di limiti. Limiti, questa
volta, esterni e non interni alla pratica scientifica - limiti etici direbbe
Forte, limiti che vengono dalla nostra responsabilità, dal nostro
riconoscimento dell'altro in quanto altro e non in quanto cosa. Tuttavia,
bisogna avere la forza di porre limiti a chi pone limiti. Se, infatti, non si
rischia tale circolarità, si finisce per cadere sotto la dittatura non dei
tecnocrati ma dei superesperti della morale, che fissano doveri e scopi,
condannando in nome dei loro valori ogni forma di dissenso. Dunque,
anche nel caso dei limiti esterni, o etici, proprio l'esercizio coerente
della responsabilità impone di «lavorare sui limiti» e di mettere pertanto
in discussione la natura stessa di quei valori in nome dei quali ci
dichiariamo responsabili. All'idea di una responsabilità assoluta "per
ogni altro" opporrei l'istanza di una responsabilità che sappia farsi
carico della sua stessa contingenza, del suo limite, in una parola, della
sua finitezza - aprendo così alla possibilità di una responsabilità "di
altri".
MARTINI: Bruno Forte si è soffermato a lungo e in maniera sofferta
sulla violenza di cui sarebbe accusata la teologia a proposito del
dominio - sfruttamento e asservimento - della natura, e le ha opposto la
via del servizio dell'altro e dell'orizzonte dell'alleanza. A suo avviso, non
c'è il rischio di violenza nella ricerca incessante dell'assoluto anche in
ambito filosofico? Se non lo raggiunge, forse il filosofo non osa
imporlo. Ma se pretende di raggiungerlo, non lo vuole con ciò stesso
imporre? Bisogna allora scegliere tra ricerca di assoluto e libertà?
GIORELLO: In ogni esperienza di liberazione vi è una forte componente
di violenza. Pensiamo all'immagine platonica della caverna: il filosofo
libera gli schiavi incatenati "biai", «con violenza» ("Repubblica" 515e, e
su questo punto tornerà Heidegger nelle sue lezioni su Platone). E la
violenza è propria di ogni assoluto. Tuttavia, c'è un punto che è, forse,
la salvezza e insieme la perdizione del filosofo: se lo imponiamo,
l'assoluto non è più un assoluto, si è già dissolto, relativizzato. E'
diventato l'idolo; la faccia della divinità è già altrove. Di nuovo, è
l'esperienza della nostra finitezza che in qualche modo,
paradossalmente, ci salva. Ci salva con la rinuncia alla salvezza, e
all'imposizione di questa nostra salvezza agli altri. E tutto ciò ha nome
libertà. Vorrei riprendere l'immagine della fenice (p. 121) che nel
scegliere il suo nido nel fuoco che la distrugge potrebbe prestarsi a
emblema della filosofia, se non fosse che quella, la fenice, si «accende
con certezza», mentre questa, la filosofia, «con dubio de riveder il sole»
(G. Bruno, "Degli eroici furori", in "Dialoghi italiani", cit., p. 1043 ).
Forse, è questo «dubio» che meglio incarna il senso della
responsabilità filosofica, dell'apertura all'altro in quanto tale: ciò che il
cristianesimo chiama «amore».
DIALOGO
(Carlo Maria Martini e Bruno Forte).
CARLO MARIA MARTINI: Sarei tentato di riproporre a Bruno Forte le
stesse domande che ho rivolto a Giulio Giorello - allo scopo, questa
volta, di saggiare il taglio del teologo...
BRUNO FORTE: Sono domande che fanno pensare, soprattutto l'ultima,
quella radicale: la "quaestio de veritate", per dirla con terminologia
antica. E' mia convinzione che su questo si giochi tutto il nostro
discorso. Poiché siamo figli di una tradizione culturale segnata dal
passaggio dalla verità come "aletheia", come svelamento del nascosto,
come esibirsi alla visione di ciò che era prima celato, alla verità in
termini di dominio, di una "adaequatio (rei et intellectus)" che è anche
possesso. In realtà, c'è almeno una tradizione, quella biblica, dove la
verità si pensa nei termini della "emet". L'ebraico non ha una parola che
dica «verità»; dice «verità» la parola «fedeltà», "emet". Le conseguenze
sono enormi. La verità greca è monistica; la verità ebraica è pattizia. La
verità ebraica sta nella relazione; quella greca nella comprensione, nel
dominio, nell'idea (stessa radice dell'aoristo del verbo "orao", vedo).
Dunque, la verità greca porta con sé un potenziale di violenza, di
necessità. La verità ebraica vive nel regno della libertà, dell'incontro. Il
greco possiede la verità, l'ebreo deve lasciarsi possedere da essa. Il
greco vede, l'ebreo ascolta: "Shema' Israel, Adonai eloenu. Adonai
echad".
Mi sembra sia questo il punto. Se il filosofo e lo scienziato, o il teologo
e lo scienziato, si pongono davanti alla verità non come oggetto di
dominio, bensì come alterità da cui lasciarsi inquietare, possedere permettete che usi l'espressione teologica -, come Mistero ultimo che ci
raggiunge, ci turba, allora si viene liberati da quella tentazione di
violenza che porta con sé la "ideo-logia" in tutte le sue forme, anche
teologiche.
MARTINI: Questo significa, allora, che anche la teologia dovrebbe
muoversi "a latere" della ricerca scientifica, così da indicarne i limiti?
FORTE: Per quanto riguarda i limiti della scienza, una teologia che sia
correttivo antiidolatrico, che abbia il compito blasfemo di denunciare
l'idolo, è denuncia dello scientismo. Dunque il «no» di un teologo
obbediente a una verità come "emet", patto, relazione, amore non è il
«no» alla scienza, ma allo scientismo, ossia alla scienza praticata come
ideologia totalizzante, al determinismo proprio di una scienza intesa
come violenza. Può il teologo andare oltre i limiti della scienza, oltre i
suoi «buchi neri»? Ritengo che sia compito del teologo denunciare gli
orizzonti chiusi, e proprio per questo segnalare il Mistero, farsi in
qualche modo voce dell'Altro, avvocato dell'altro; pur se - questo è il
punto specifico e caratterizzante - il teologo riconosce il luogo dove
l'Altro si è detto, pronuncia un nome, il nome del Cristo, del suo amore
crocefisso.
MARTINI: Quali sono, dunque, i punti di incontro fra il filosofo e il
teologo?
FORTE: Potremmo testimoniarli insieme, Giulio Giorello e io, e i molti
altri con cui ho da tanto tempo cercato e pensato: la comune povertà, il
domandare e non il dominare. Quando si hanno domande vere, si
trovano risposte vere. Domandare è il primo compito del pensiero. E poi
pensare l'altro, riconoscere l'altro come la vera questione. Allora, la
grande domanda posta dal filosofo al teologo è che cosa induca il
teologo a riconoscere nell'altro la traccia dell'Altro. Se entrambi sono
inquieti e pensosi, se entrambi si pongono domande, se il credente è un
ateo che si sforza ogni giorno di cominciare a credere e il non credente
pensoso è forse un credente che si sforza ogni giorno di cominciare a
non credere, che cosa ci aiuta a compiere il passo che nell'altro prossimo e vicino - ci faccia riconoscere l'Altro che fonda anche in
maniera ultima e radicale la responsabilità etica? Vorrei rispondere non
argomentativamente, ma in forma quasi narrativa, con le parole di una
giovane donna ebrea morta ad Auschwitz, il cui "Diario" è inquietante
per tutti (cristiani, ebrei, credenti, atei): Etty Hillesum. Ella motiva la sua
scelta di consegnarsi ai tedeschi e di andare nel campo di
concentramento in un piccolo testo che cito dal suo "Diario" del 12
luglio 1942:
«Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero
sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me
passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una
cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l'oggi
con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani - ma anche questo
richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò
di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma "a priori"
non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più
evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma siamo noi a
dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che
possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti,
è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche
contribuire a disseppellirti nei cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio
sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali,
ma anche esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua
responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare noi responsabili. E quasi a
ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci,
ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi.
Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di metter in
salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d'argento - invece di salvare te,
mio Dio; e altre persone, che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di
innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio
corpo. Dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può
essere nelle grinfie di nessuno, se si è nelle tue braccia» ("Diario 19411943", a cura di J. G. Gaarlandt, trad. it. Adelphi, Milano 1985 e 1997,
p.p. 169-170).
Ecco il passaggio dall'altro all'Altro. Forse, lo si può compiere quando
si capisce, come Etty Hillesum, che si tratta di aiutare Dio. E aiutando
Dio, un Dio umile, crocefisso, forse il filosofo e il teologo insieme
scoprono un sentiero di trasgressione verso l'Altro, che li aiuta a vivere
la loro responsabilità verso gli altri.
5.
SCRITTURE DELL'UOMO E SCRITTURA DI DIO.
UNA RIFLESSIONE
(Carlo Maria Martini).
"Premessa".
"Orizzonti e limiti della scienza". Parole che invitano, intuizioni che
stupiscono, scoperte che meravigliano. Vorrei iniziare citando un
poesia di John Donne (15721631) - "Batter my heart, three person God,
for you" - nella splendida traduzione di Cristina Campo:
"Sfascia il mio cuore, Dio in Tre persone!
Per ora tu solo bussi, aliti, risplendi,
e tenti di emendare. Ma perché io sorga e regga
tu rovesciami e tendimi la tua forza
a spezzarmi, esplodermi, bruciarmi e farmi nuovo.
Usurpata città, dovuta ad altri, io mi provo
a farti entrare, ma ahi! senza fortuna.
La ragione, in me tuo viceré
mi dovrebbe difendere ma è
prigioniera e si mostra molle o infida.
Pure teneramente io t'amo e vorrei essere
riamato. Ma fui promesso al tuo nemico.
Divorziami, disciogli, spezza il nodo,
rapiscimi, imprigionami: se tu
non m'incateni non sarò mai libero,
casto mai se tu non mi violenti".
Ho scelto questi versi del teologo inglese, caposcuola dei «poeti
metafisici», perché esprimono in maniera drammatica quel dialogo
fede-ragione che si è tentato negli interventi di "questo volume".
L'icona di partenza del mio intervento è suggerita dal titolo stesso:
"Scritture dell'uomo e Scrittura di Dio". Scritture dell'uomo: i risultati
della matematica, dell'astronomia, della fisica, della biologia, nonché
della stessa filosofia; Scrittura di Dio, cioè le Scritture ebraico-cristiane,
la Bibbia, dove i credenti ritrovano un messaggio «dall'alto» che offre
risposte profonde ai grandi interrogativi della vita.
Si potrebbe anche delineare - e lo si è fatto qui alle p.p. 115-140 - un
confronto tra filosofia e teologia, intendendo per "filosofia" la
riflessione razionale che abbraccia il cammino umano della ricerca, e
per "teologia" la riflessione sistematica sui dati rivelati da Dio mediante
le Scritture, le voci dei profeti e dei grandi maestri dell'umanità.
Ancora l'icona delle due Scritture, traducibile dunque nel binomio
filosofia-teologia, è suscettibile di venir espressa con un'altra
immagine, con un altro simbolo, richiamato da Giovanni Paolo Secondo
all'inizio dell'enciclica "Fides et Ratio". Scrive il Papa: «La fede e la
ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s'innalza
verso la contemplazione della verità». L'immagine delle due Scritture si
tramuta così nell'icona delle due ali: quest'ultima indica più
chiaramente la necessità, per chi desidera volare bene, di equilibrare le
ali, di tenerle in sintonia di movimento, come un uccello addestrato al
volo.
E a queste immagini - Scritture e ali - farò qui idealmente riferimento nel
tentativo di rendere ragione di quanto, come discepolo in ascolto di
maestri, ho cercato di capire e di assimilare.
Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vorrei tracciare l'itinerario del
nostro ultimo incontro. Resto, comunque, un "quidam de populo,
quidam de plebe audientium", uno della folla che si è sforzato di farsi
una sintesi interiore, che si è lasciato coinvolgere e quasi soverchiare
da una serie infinita di interrogativi, numerosi come le stelle del cielo e
come gli universi possibili di cui si è trattato.
Intervengo, quindi, come persona che vuole pensare e capire, che vuole
dar voce in sé al credente e al non credente.
Alla fine del mio dire esprimerò, anche come cristiano e come Vescovo,
ciò che sento, ciò che vedo di luci e di ombre nello scenario immenso
di problemi evocato dagli uomini di scienza.
Procederò secondo l'ordine che segue:
PRIMO. "Attese e risonanze". A modo di richiamo spiegherò anzitutto
perché mi sono deciso a mettere a tema, in questa decima sessione
della Cattedra, le questioni della scienza; che cosa mi aspettavo e che
cosa temevo; che cosa globalmente ne ho tratto, anche stimolato dal
dialogo con i singoli relatori.
SECONDO. "Orizzonti che si allargano". In un secondo momento vorrei
sottolineare alcuni degli orizzonti che ci si sono aperti, e il rapporto tra
tali orizzonti dell'impresa scientifica e quelli del credere (insisterò così
sul rapporto tra orizzonti aperti dalle scritture umane e orizzonti
proposti dalla Scrittura divina).
TERZO. "Limiti che emergono". In un terzo momento, ispirandomi al
titolo generale della Cattedra, "Orizzonti e limiti della scienza", tratterò
dei limiti che «un profano» come me può cogliere nei diversi contributi,
e di ciò che la Scrittura sacra suggerisce a proposito di questi limiti, e
del loro (eventuale) superamento.
Per ritornare, in "conclusione", all'icona iniziale delle due Scritture e
delle due ali.
"Attese e risonanze".
1. Mi sono deciso a proporre questa sessione della Cattedra perché da
sempre sono affascinato dagli orizzonti e insieme dai limiti della
scienza. Gli "orizzonti" sembrano sconfinati: si può arrivare quasi a
tutto. Nello stesso tempo, però, emergono i "limiti": ci sono barriere che
sembrano invalicabili anche concettualmente, per non parlare dei limiti
etici. Penso a domande fondamentali come quelle sull'origine e la
durata dell'Universo, la comparsa della vita, eccetera. Avvertivo il
bisogno di approfondire tali orizzonti e tali limiti, come pure di coglierne
la relazione con il credere e il non credere.
Sovente si ritiene, infatti, che gli "orizzonti" sconfinati della scienza
favoriscano il non credere; si ha l'idea che con la scienza si possa
arrivare a spiegare e fare ogni cosa, senza bisogno di altre istanze,
siano esse filosofiche, metafisiche o religiose. E, normalmente, si
ritiene pure che, invece, i "limiti" della conoscenza favoriscano il
credere, invitino a pensare che vi sia "al di là" qualcosa in grado di
spiegare ciò che noi non riusciamo a spiegare e di dire ciò che noi non
possiamo raggiungere con la sola ricerca, restando nell'ambito della
«verità» scientifica.
2. Desideravo andare oltre queste due percezioni oltre la sintesi, troppo
facile, che suona: più scienza meno fede, meno scienza più fede.
Volevo indagare la correlazione esistente tra questi due esercizi dello
spirito - scienza e fede - e cercare se e come sia possibile
un'integrazione nel vissuto di una persona, pur nella distinzione degli
ambiti. Ossia, come si possa esser scienziati senza rinunciare a
pensare "al di là", e come si possa esser credenti senza rinunciare a
lasciarsi interrogare e mettere in questione dai dati sempre nuovi della
scienza.
Volevo sentire da persone in vario modo coinvolte nell'impresa
scientifica come esse vivano le aperture di orizzonti e i limiti, le
frontiere del loro conoscere. Non mi interessava una semplice
divulgazione dei risultati, in sé legittima e assai utile, che ha già i suoi
luoghi propri. Cercavo una riflessione che si collocasse sull'orlo della
scienza, tra il sapere e il non sapere. Dunque, neanche una discussione
dei rapporti tra scienza e fede, ma, semmai, una testimonianza sul
conoscere al limite del non conoscere, e sul credere al limite del non
credere.
Si trattava, me ne rendo conto, di una sfida ardua, che forse esigeva
troppo da chiunque fosse stato chiamato a «rispondere».
3. Se questo è ciò che mi aspettavo, che cosa invece temevo? In parte,
l'ho già accennato: che fosse difficile riuscire a non separare il
ricercatore dall'uomo in ricerca, il classificatore e il controllore dei dati
dall'indagatore dei significati - poiché i dati non possono essere intesi
se non entro una cornice di senso, ordinandoli, sollevando ipotesi e
domande.
Se poi le mie attese si siano realizzate e i miei timori siano stati del tutto
fugati lascio al lettore decidere.
"Orizzonti che si allargano".
1. Chi scorre qualche buon libro di scienza ha sovente l'impressione
che gli schiudano grandi orizzonti, e ricordo la metafora dell'orizzonte
quale linea circolare aperta e insieme limite invalicabile, e tuttavia
mobile.
Ascoltando coloro che sono impegnati nella ricerca è possibile cogliere
la verità delle parole che Giovanni Paolo Secondo pone quasi a
conclusione della "Fides et Ratio": «Non posso non rivolgermi agli
scienziati, che con le loro ricerche ci forniscono una crescente
conoscenza dell'universo nel suo insieme e della varietà
incredibilmente ricca delle componenti, animate e inanimate, con le loro
complesse strutture atomiche e molecolari. Il cammino da essi
compiuto ha raggiunto, specialmente in questo secolo, traguardi che
continuano a stupirci» (n. 106).
Anche noi non abbiamo cessato di stupirci, sentendo nostra l'immagine
di Isaac Newton: «Io mi vedo come un fanciullo che gioca sulla riva del
mare, e di tanto in tanto si diverte a scoprire un ciottolo più levigato o
una conchiglia più bella del consueto, mentre davanti mi si stende
inesplorato l'immenso oceano della verità».
Di fronte a questo oceano ci si sente a volte quasi smarriti. La fatica
della ricerca, lo stupore per i risultati raggiunti, il dubbio mai del tutto
eliminato circa le conquiste della conoscenza sono i fili conduttori dei
saggi qui raccolti, dedicati alla descrizione delle varie scienze, prima
che dal momento «analitico» si passasse a un tentativo «sintetico» da
parte di filosofi e teologi.
Pur non essendo tra gli addetti ai lavori, per così dire tra gli iniziati, ho
potuto percepire il fascino della scienza derivante non solo
dall'incredibilità dei traguardi raggiunti e dalla sfida di ipotesi ardite, ma
anche e soprattutto dal dispiegarsi del processo di conoscenza con la
sua capacità di penetrare le leggi invisibili della natura.
I numeri che la cosmologia e la biologia hanno prospettato sono difficili
da immaginare, e incutono meraviglia e timore: un Universo antico di
qualche miliardo di anni, la comparsa della vita collocabile a oltre un
miliardo di anni fa, e la sua fantasiosa potenza riproduttiva capace di
generare milioni di specie diverse. Un Universo già difficile da
comprendere, che forse si dilata in un Multiverso (vedi "questo
volume", p.p. 23-25). Tre generazioni di stelle per dare origine a un
"quantum" di sostanze chimiche sufficienti a far scaturire la vita. Infine,
la comparsa di questo vivente che da animale è diventato "Homo
sapiens" (vedi p.p. 27-33 e p.p. 43-50).
Si è poi passati dal molto grande dell'Universo al molto piccolo dei geni
che regolano la vita biologica e giustificano la diversità delle specie,
secondo le vigenti teorie neodarwiniane - teorie che sono sufficienti a
spiegare molti fatti dal punto di vista biologico, ma che vacillano di
fronte al fenomeno umano (vedi p.p. 51-64). Più specificamente,
abbiamo imparato a conoscere il funzionamento del cervello umano, a
un tempo soggetto e oggetto del nostro ricercare, in una circolarità che
è propria della conoscenza (p.p. 77-103). Anche il cervello, in quanto
«entità biologica» è andato incontro a una progressiva complessità
evolutiva, differenziandosi quantitativamente da quello degli altri
animali e qualitativamente, però, solo con la comparsa del linguaggio.
Ed è questo salto evolutivo che la biologia non sembra saper spiegare.
Se la potenza del regno animale sta nell'agire, quella dell'uomo sta nel
pensare e comunicare. Il mondo - è stato detto - è percepito tramite un
dispositivo di recettori e di segnali, introiettato e archiviato mediante i
sistemi della memoria, estratto ed elaborato attraverso le funzioni
cognitive, trasmesso grazie a un codice simbolico, il linguaggio, che
permette la comunicazione tra simili e la consegna transgenerazionale.
L'uomo, dunque, «coscientizza» la propria esistenza e crea, con il
pensiero e il linguaggio, cose nuove che arricchiscono il patrimonio
conoscitivo.
Questi, in sintesi, alcuni degli orizzonti scientifici che, pagina dopo
pagina, si sono aperti a me (e, credo, si aprano a tutti i lettori del
"presente volume") .
2. Sorge qui la domanda che è tipicamente mia: gli orizzonti che si
allargano toccano, in qualche modo, anche gli orizzonti della Scrittura e
della Rivelazione cristiana? Oppure, si tratta di campi del tutto
indipendenti, riguardanti ambiti dell'esistenza tra loro distinti, non
comunicanti, che non interferiscono l'uno con l'altro?
Mi è sembrato di cogliere, in alcune affermazioni, un certo ottimismo,
quasi una sorta di irenismo circa il rapporto scienza-fede, che è in
qualche modo rintracciabile anche in chi sostiene la piena compatibilità
tra esperienza scientifica ed esperienza di fede, le quali opererebbero in
contesti pressoché indipendenti pur riguardando una medesima entità,
l'uomo. Tuttavia, prima che si traggano conclusioni affrettate, ritengo
utile sottolineare tre aspetti, riprendendo e integrando alcuni elementi
emersi negli altri saggi del volume.
"Primo") Il primo, espresso chiaramente, è il rifiuto deciso di ogni
"concordismo" tra scienza e fede - concordismo sia alla maniera antica,
vigente ancora ai tempi di Copernico, Galilei, se non oltre, che
collocava le categorie spaziali della Bibbia in un mondo stellare
concepito secondo i principi di Aristotele prima e di Tolomeo poi, sia
nelle varie rielaborazioni moderne e contemporanee, tra cui, in
particolare, il già citato tentativo di Frank J. Tipler (che ammette di aver
cominciato la sua carriera di cosmologo da «ateo convinto», "La fisica
dell'immortalità", trad. it. cit., p. XI), per il quale gli squarci aperti dalla
ricerca sull'origine e l'evoluzione dell'Universo offrirebbero persino una
dimostrazione dell'immortalità.
"Secondo") Inoltre, si è insistito sul fatto che scienziati, filosofi e
teologi hanno a che fare con la persona umana e che tutti sono,
dunque, di fronte al mistero dell'altro, del volto. Ciò pone - come
giustamente è stato detto - il problema etico nel cuore stesso della
scienza, ed esso ne investirebbe pure le applicazioni tecnologiche.
"Terzo") Mi sono chiesto, tuttavia, se, oltre ai rapporti relativi all'etica,
non vi siano tra "scienza" e "teologia" rapporti di tipo conoscitivo tali
da non permettere a chi legge le Scritture di affermare con tranquillità
che i due ambiti non si toccano. Penso, in particolar modo, ai temi
riguardanti l'origine del mondo e della vita, la comparsa dell'uomo,
quella che chiamiamo la creazione dell'anima dal soffio di Dio, il
peccato originale e, più in generale, la natura dell'Universo (uno o
molteplice, o addirittura «Multiverso» senza confini?).
Lo sfondo della Bibbia appare lontano dal pensiero evoluzionistico e
dal modo con cui tale pensiero prospetta l'origine dell'uomo e
dell'intero Universo. La Bibbia racconta di un uomo che sembra
nascere perfetto e direttamente dalle mani di Dio, già essenzialmente
"diverso" e "superiore" a ogni specie animale. Le ricerche della scienza
sui processi di ominazione non hanno ancora trovato una collocazione
per un periodo di stacco preciso da ogni specie animale e di inizio
perfetto con quelle doti umane evocate dalle prime pagine della
Scrittura e che sottostanno al racconto della colpa primitiva da parte di
una prima coppia umana. Dov'è, per la scienza, la prima coppia umana?
Nella Bibbia l'Universo, concretamente limitato al sistema solare, è
presentato sì come costituito a tappe - e questo ha potuto illudere
qualche accanito «concordista» di poter facilmente indicare
corrispondenze tra i giorni della creazione e le diverse fasi dell'origine
del mondo descritte dalla scienza - ma non sembra possibile leggere un
vero e proprio dinamismo evolutivo nelle pagine del "Genesi".
Da quando la Chiesa ha preso atto della plausibilità delle teorie
evoluzionistiche, si sono rese necessarie una rilettura e una
reinterpretazione dei dati biblici circa l'origine dell'Universo, la
comparsa delle specie vegetali e animali e, in particolare, dell'uomo e
della donna. Oggi si è abbastanza d'accordo nel considerare quelle
pagine non come una storia e neppure come un mito, bensì come
un'affermazione teologica del primato di Dio, della sua potenza di
creatore, del suo privilegiato rapporto con la persona umana
intelligente e libera, chiamata al dialogo con Dio; un'affermazione del
fatto che il male morale del mondo non è una forza primigenia, ma la
conseguenza del cattivo uso della libertà umana. Si ammette, anzi, che
l'intuizione di Dio sull'uomo, il sogno di Dio sull'uomo, delineato nei
primi capitoli della Bibbia, sia in realtà il punto di arrivo di un
lunghissimo cammino e prefiguri, in qualche modo, come già suggeriva
Paolo nella "Lettera ai Romani" (vedi, in particolare, capitolo 5), quel
senso ultimo del dinamismo impresso nel cosmo che Teilhard de
Chardin riassume nell'idea di "punto omega", ossia il punto di
aggregazione di tutta l'umanità in Cristo.
Tuttavia, vi è nella Bibbia qualcosa di molto importante che esprime
una tensione evolutiva e ha qualche analogia con una visione evolutiva
dell'Universo. Alludo, in generale, alla sensibilità che il testo biblico
mostra per il divenire, per lo sviluppo della storia. In particolare, penso
al principio per cui i passaggi, i salti di qualità nel divenire non
avvengono globalmente e uniformemente secondo rigidi determinismi,
ma emergono in luoghi e fatti concreti, singoli, e da questi si diffondono
e si propagano.
E' il "principio della elezione", che richiama il principio della selezione.
E' la costante della singolarità dei momenti salvifici portanti e del loro
dinamismo, del modo in cui avvengono i salti di qualità nel cammino
della storia della salvezza. E' vero che sono semplicemente assonanze
e analogie, però stanno a dire come la Bibbia non sia estranea a un
dinamismo simile a quello del pensiero evoluzionistico. Tende a dargli
nome e volto anche nel processo storico, fino a lasciare emergere il
principio fondamentale che, secondo la Scrittura, presiede al
dinamismo di tutto l'essere: l'"Amore".
Al di là di tali riletture, peraltro non ancora ben recepite a livello di
coscienza collettiva, è presente il bisogno di una riflessione teologica
approfondita sul senso dell'Universo e del suo «espandersi» fino alla
persona umana. George Coyne parla addirittura di una «nuova
teologia» (vedi p.p. 40). E' necessaria una riflessione inedita che tenga
conto del dinamismo evolutivo del cosmo e renda ragione di quella
solitudine e marginalità della specie umana nell'Universo o nel
Multiverso che sembra in contrasto con la visione di un Dio che ha di
mira, nella sua creazione, soprattutto l'uomo e il suo destino, fino al
farsi uomo del Figlio. Che senso ha questo apparente spreco di tempi e
di mondi, se tutto è creato per l'uomo? Quale concezione ne deriviamo
per la gratuità e quasi la «giocosità» di Dio nell'Universo?
La teologia ha pure il compito di rispondere a tali domande, e grandi
spiriti come Teilhard de Chardin e Karl Rahner vi si sono cimentati, con
fortune diverse. Rahner è giunto a ricercare come una Cristologia - una
dottrina su Gesù Cristo Figlio di Dio e Redentore - sia compatibile con
una visione evolutiva del mondo, possa cioè essere presentata in modo
comprensibile a persone per le quali la visione evolutiva è uno schema
mentale ovvio.
Ci accorgiamo, così, che teologia e scienza non sono due grandezze
che procedono parallele o si toccano solo sul terreno etico; in realtà, vi
sono spazi in cui in qualche modo «si disturbano» e si stimolano,
invitando a guardare oltre e a pensare con più coraggio e audacia.
I temi concernenti l'uomo e l'Universo sottendono un'ulteriore serie di
domande che scienza e fede si pongono mutuamente: esse toccano il
mistero stesso di Dio, del Creatore, di Colui che nella filosofia classica
è chiamato causa prima, motore immobile del dinamismo dell'Universo.
Vi è ancora un posto visibile per Dio nella storia dell'Universo? La
scienza pensava di sì, almeno fino a Newton; anzi, postulava tale
presenza, ma George Coyne sostiene qui con chiarezza - e sono
d'accordo con lui - che non possiamo introdurre risposte di fede a
domande lasciate aperte dalla scienza. Ritengo, dunque, che la
speranza di trovare vestigia dirette di Dio, scientificamente dimostrabili,
nell'origine e nello sviluppo dell'Universo, vada al di là degli orizzonti
della scienza e che alcuni rinnovati tentativi in tale direzione conducano
a vicoli ciechi
E' importante che il mistero di Dio non venga sottomesso a verifiche
umane e appaia all'uomo quale manifestazione fatta alla sua coscienza
e intelligenza, a prescindere da argomenti scientifici, semmai contro di
essi. Il mistero di Dio si svelerà, dunque, all'uomo non in dipendenza di
controlli sperimentali o come ipotesi sostitutiva di anelli empirici
mancanti, bensì a partire da domande prime cui la scienza non potrà
rispondere: perché esiste ciò che esiste? Perché queste leggi di natura
e non altre? Che senso ha l'esistenza umana? Quale mistero vi è
nell'altro? Soprattutto, si svelerà a partire dalle testimonianze esteriori
o interiori con le quali il Mistero trascendente - che è "al di là" di ogni
mondo - continua a farsi conoscere nella storia umana, ossia nelle
testimonianze bibliche che invitano a credere.
"Limiti che emergono".
Così, siamo già entrati nel terzo momento del mio intervento: i limiti che
emergono entro e per la scienza.
1 . In pressoché tutti i contributi di "questo volume" sono stati
evidenziati, accanto ai molti «orizzonti» evocati, anche alcuni «buchi
neri», ossia interrogativi cui la scienza non è attualmente in grado di
rispondere e cui, in parte, sa forse di "non" poter rispondere. Essa
ritiene, per esempio, di non poter dire nulla sull'istante zero, quello
assolutamente iniziale del nostro Universo, prima dei famosi 10 alla
meno 43esima secondi; di non riuscire a cogliere alcuni salti decisivi
nell'evoluzione, come il passaggio dalle molecole prebiotiche alle
biomolecole e ai procarioti, e così pure quello da singole cellule a
cellule organizzate; di non saper spiegare l'emergere dell'intelligenza
come tale, di non capire ancora perché l'insieme delle cellule si
organizzi nella coscienza.
In particolare, la scienza non risponde alle questioni sollevate sin
dall'inizio da George Coyne: la vita, nel quadro dell'evoluzione
dell'Universo fisico, doveva necessariamente apparire? O è apparsa per
caso? La sua comparsa può essere spiegata? Inoltre, esiste soltanto
sul nostro pianeta? A livello dell'intelligenza e della coscienza,
rappresenta un fattore significativo per l'evoluzione futura
dell'Universo? Infine, noi esistiamo unicamente per riciclare energia,
oppure siamo esseri speciali nei quali l'Universo trova la possibilità di
passare dalla materia allo spirito?
Qui la scienza, a mio avviso, incontra i suoi limiti più estremi, e tuttavia
le è chiesto di non considerare tali domande insensate e vuote. Sono
domande cui essa non può oggi, e non potrà forse neppure domani,
dare risposta con gli strumenti di cui dispone, ossia con l'osservazione
e il controllo sperimentale, con il dialogo tra teoria ed esperimento.
Ciò significa, per usare le parole di Julian Chela-Flores, che non si deve
andare al di là della pratica scientifica, assumendo tacitamente una
posizione filosofica riduttiva, come ha fatto, a suo tempo, il
neopositivismo.
Abbiamo, dunque, individuato limiti etici e cognitivi della scienza. In tal
modo risultano definiti anche i limiti della teologia, che non deve
pretendere di colmare i «buchi neri» con ipotesi che introducano
soluzioni trascendenti in problemi che vanno invece lasciati al controllo
empirico, mediante osservazioni ed esperimenti.
2. Ma la questione che si pone con urgenza è quale sia il compito della
teologia, e della fede da essa espressa, circa le domande di tipo
esistenziale che non trovano risposta nell'ambito della ricerca
scientifica - e, finalmente, la domanda prioritaria, quella su Dio.
E' qui che l'uomo in ricerca, affascinato e stupito da quanto gli rivelano
i suoi strumenti di osservazione, intimorito e sbigottito dalla sua
piccolezza rispetto alle dimensioni dell'Universo, ritrovandosi come
Newton con in mano una conchiglia di fronte a un mare senza fine,
lascia emergere quegli interrogativi che si estendono al perché, al
significato ultimo di tutto ciò e, in particolare, al senso del suo essere in
questo mondo con la curiosità e l'avidità di sapere, e con l'angoscia di
fronte all'ignoto. Qui avviene il passaggio dallo scienziato in dialogo tra
osservazione e teoria a una ricerca di senso. E' qui che la dimensione
etica, inerente alla scienza, si domanda perché sia necessario rispettare
il mistero dell'altro e cosa si nasconda dietro all'intangibilità e dignità di
ogni volto.
Anzitutto, su tale terreno si avvertono le distinzioni di compiti tra
scritture umane e Scrittura divina, e insieme si coglie il fascino che la
Scrittura divina continua a esercitare sull'"Homo sapiens" in cerca di
conoscenza del mondo e di sé, del suo destino ultimo.
A questo punto, infatti, non bastano più i linguaggi umani della
misurazione e del calcolo matematico. Occorre un linguaggio che, non
avendo paura di esprimersi in simboli e in parabole, abbia il coraggio,
l'ardire di assumere le forme della poesia; che risvegli nel cuore
dell'uomo quella speranza che come scintilla primordiale attende di
poter riscaldare con il suo fuoco il gelo di un Universo senza senso, e
come goccia di rugiada può difendere dall'angoscia di masse infuocate
che sembrano espandersi minacciose in un cosmo senza destino.
Ricordo la parola poetica di Giobbe, che interroga spaventato colui che
ritiene essere il suo giudice ingiusto e si sente dire: «Dov'eri tu
quand'io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta
intelligenza! Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su
di essa la misura?». E Giobbe, alla fine, esclama: «Comprendo che puoi
tutto e che nessuna cosa è impossibile per te [...]. Io ti conoscevo per
sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono» (Gb 3 8, 4-5; 42, 1.5).
Il cristiano ritiene che il «vedere con gli occhi» qualcosa del mistero
invisibile gli sia donato dalla presenza tra noi di quel Signore che le
Scritture dell'ultima Alleanza pongono al centro del loro messaggio. Le
Scritture divine ci diranno pochissimo sul divenire fisico del mondo e
dell'uomo, e per di più mescolandolo a opinioni fisiche e biologiche
legate al passato, e dunque in parte superate. Tuttavia, ci hanno detto,
ci dicono e continueranno a dirci cose decisive sul senso del cammino
umano sulla Terra, sul primato della persona, sul carattere definitivo di
ogni gesto d'amore e su Colui che dà a ogni gesto d'amore un
significato eterno, superando tutti i mali e le assurdità di questo mondo
con una dedizione - quella della Croce - che riscatta le malvagità e può
suscitare in ogni essere umano germi di autentica speranza, di sincera
cura dell'altro, di fraternità e di solidarietà.
In altre parole, per un credente le due realtà, scritture umane e Scrittura
divina, e di conseguenza riflessione scientifico-filosofica e riflessione
teologica, si riferiscono a un dato comune, a un unico mondo. In
concreto, all'opera di Dio creatore e redentore, opera scritta nella storia
del cosmo e nel divenire dell'uomo e dei popoli, quindi leggibile dalle
scienze fisiche e storiche; e scritta, invece, su pergamena e papiro a
seguito della rivelazione dei profeti e degli uomini di Dio, quindi
leggibile dalla teologia alla luce della fede.
Certo, gli errori nella lettura sono in agguato in "ogni" attività
speculativa, e pertanto brandire un "credo", sia esso scientifico,
filosofico o teologico, per far quadrare i conti imponendo una
soluzione, è dolorosa premessa per un'ideologia fonte di violenza.
Ma altro è lo sforzo sincero di lettura che ognuno fa nella comunità
scientifica o nella comunità di fede.
Scienza e fede non sono, dunque, un unico binario su cui corre la vita
dell'uomo, e neppure strade divergenti o in collisione. Le vedo piuttosto
quali binari paralleli, tenuti in connessione dalla filosofia e dalla
teologia, che come traversine permettono ai binari di rimanere
affiancati, così che possa correre il grande treno della vita.
Scienza e fede sono anche le due ali che consentono di volare verso
orizzonti sempre più lontani. Procedere su binari, soprattutto con la
velocità delle odierne tecnologie, o volare con le ali a velocità
supersonica vuol dire spostare più rapidamente il nostro orizzonte, in
modo che quando sembra a portata di mano, di nuovo esso ci sfugge.
L'uomo pensante accetta volentieri un orizzonte continuamente
mutevole. Non vive di sole certezze, senza porsi dubbi, bensì, stupito e
meravigliato, si rimette ogni volta in gioco, facendo della domanda e del
dubbio la molla vitale per una ricerca onesta, animata da interrogativi
incessanti, nella speranza di una risposta che apra la porta a nuove
domande.
Per usare una metafora che traggo dall'intervento di Giulio Giorello, il
mondo non può essere visto né in una luce abbagliante, né nel buio
completo. La migliore acuità visiva è ottenuta nel contrasto tra luce e
ombra che permette agli oggetti di rivelarsi nella loro struttura
tridimensionale, anziché piatti e indifferenti.
"Conclusione".
Per tornare all'icona iniziale, le due scritture, per un credente,
soprattutto per un cristiano mistico - come John Donne di cui ho citato
una poesia o come Cristina Campo - che legge in unità e trasparenza il
cosmo e la storia (il cristianesimo del Duemila, secondo Karl Rahner, o
sarà mistico o non sarà), sono momenti dell'unica Parola, la Parola di
un Dio che vuole comunicare se stesso e, nascondendosi dietro a
caratteri spesso enigmatici, a guisa di geroglifici, ci invita a cercarLo
anche tra vicende drammatiche, decifrando il grande libro della natura e
della terribile storia umana, per giungere a compiere gesti di amore e di
fraternità. Confido che le pagine di "questo volume" abbiano suscitato
in qualcuno la voglia e il gusto di leggere più a fondo le scritture
dell'uomo e la Scrittura di Dio.
FIGURE.
FIGURA 1. Il cosmo della "Divina Commedia". Esso non è altro che
l'antico Universo della tradizione aristotelica cui è stato aggiunto
l'Empireo. La Terra di forma sferica, è « al centro» dell'Universo.
Descrizione fisica e connotazione teologico-morale si fondono tra loro.
Si noti la corrispondenza tra l'abisso dell'Inferno e la montagna del
Purgatorio, entrambi formatisi con la caduta degli angeli ribelli (per dirla
con Ezra Pound, "Cantos", LXXIV: «quando Lucifero cadde nel Nord
Carolina»).
FIGURA 2. a) Epiciclo. Il pianeta P si muove intorno ad A posto sul
cerchio deferente A-B-D. Quando l'epiciclo si trova in A il suo moto si
somma a quello del deferente, mentre quando si trova in D il suo moto
si sottrae a quello del deferente. b) «Salvare i fenomeni». Il moto
retrogrado di un pianeta che si muove su un epiciclo posto su un
deferente come in (a).
FIGURA 3. Eccentrico. Il pianeta P si muove uniformemente intorno a C
posto sulla linea che unisce il centro della Terra al Sole.
FIGURA 4. Equante. Il pianeta P percorre angoli uguali in tempi uguali
rispetto al punto equante E non corrispondente al centro C
dell'eccentrico né al centro della Terra, ma tale che EC = CT. Per una
chiara ricostruzione di come dall'equante di Tolomeo si sia pervenuti
alla legge delle aree di Keplero vedi M. Mamiani, "Storia della scienza
moderna", Laterza, Roma-Bari 1998, p.p. 34-35 e p.p. 86-88.
FIGURA 5. a) Sistema tolemaico. Se Venere viene fissato a un epiciclo
che si muove su un deferente centrato sulla Terra e se il centro
dell'epiciclo rimane sempre allineato con il Sole, un osservatore sulla
Terra scorge sempre del pianeta solo un bordo semicircolare. b)
Sistema copernicano. Se l'orbita di Venere circonda il Sole, un
osservatore sulla Terra dovrebbe vedere un ciclo di fasi come nel caso
della Luna. Copernico aveva anticipato la cosa nel capitolo decimo del
libro primo del "De Revolutionibus" - ma le fasi di Venere non erano
osservabili a occhio nudo. Sarà necessario l'«occhiale» di Galileo il
quale pretenderà che le sue osservazioni delle fasi di Venere
costituiscano un argomento a favore della «opinione copernicana» anche se, come noterà lo stesso Keplero, è possibile dar conto delle
fasi di Venere anche in altri sistemi, come in quello di Tycho Brahe e
persino in alcune opportune revisioni del sistema tolemaico.
FIGURA 6. La celebre immagine di Thomas Digges.
FIGURA 7. Il sistema tolemaico e quello copernicano contrapposti l'un
l'altro nella figura 7 della "Cena delle ceneri" (1584) di Giordano Bruno.
FIGURA 8. La concordanza «nel principio e minimo» di retto e curvo in
"De la causa, principio e uno" (1584).
FIGURA 9. L'albero della vita e i suoi rami.
FIGURA 10. La rottura di simmetria tra le quattro forze fondamentali. In
figura l'evoluzione dell'Universo è rappresentata dall'alto verso il basso.
Le temperature dell'Universo sono in gradi assoluti (K), i tempi
dall'inizio del Big Bang in secondi.
FIGURA 11. La struttura del D.N.A.
FIGURA 12. a) Così Galvani rappresenta se stesso mentre esegue le sue
esperienze con la rana che concepisce come un analogo della bottiglia
di Leida (nota del 10 dicembre 1781, archivio dell'Università di
Bologna).
b) Rappresentazione dell'esperimento di Galvani basata su uno schizzo
che il neurofisiologo Emile du Bois Reymond (1818-1896) eseguì
durante una visita a Bologna nel 1850.
FIGURA 13. Vari tipi di cellule piramidali (A-E) della corteccia frontale di
un bambino di un mese. Con "a" è indicato l'assone o fibra nervosa.
Disegno autografo da un preparato di Santiago Ramón y Cajal
effettuato col metodo di Golgi. Su immagini di questo tipo ottenute da
Golgi e Cajal con lo stesso metodo (quello di Golgi), l'uno (Golgi)
concludeva per l'esistenza di una rete continua, l'altro (Cajal) sosteneva
che i prolungamenti entravano tra loro in stretto contatto senza
fondersi. Alla cerimonia di assegnazione del premio Nobel, che
condivisero nel 1906, non si strinsero la mano.
FIGURA 14. Mappa rilevata da Penfield e Rasmussen (1950) della
rappresentazione della sensibilità corporea sulla corteccia parietale
umana ("homunculus sensitivus"). La deformazione delle varie parti del
corpo corrisponde alla loro diversa importanza funzionale,
particolarmente ampia quella delle regioni dotate di una fine sensibilità
discriminativa: il volto (e in particolare le labbra) e la mano.
FIGURA 15. Immagine ambigua che può essere vista come un profilo di
giovane donna o come il volto di una vecchia a seconda del tipo di
percezione del rapporto figura/sfondo.
FIGURA 16. Alan Turing (1912-1954) concepì una macchina ideale per
calcolare funzioni aritmetiche. Data una sequenza finita di cifre in una
base specifica (per esempio, nel sistema binario 0, 1), la macchina di
Turing computerà un'altra sequenza di cifre in quella base che
rappresenta il valore ("output") della funzione per il numero dato in
"input". Così concepita, una macchina di Turing può leggere le caselle
di un nastro (infinito) su cui sono stati scritti dei numeri. La macchina
ha una lista finita di istruzioni che le dicono, quando è in uno stato
particolare e legge una casella particolare sul nastro, di cancellare il
simbolo nella casella e di scriverne qualche altro al suo posto, di
spostarsi verso la casella successiva sulla sinistra o sulla destra del
nastro e di cambiare il suo stato. La figura illustra una particolare
macchina di Turing che opera sul vocabolario (B, 0, 1) - dove B
rappresenta una casella vuota ("blank") sul nastro - e che cambia
qualsiasi simbolo in 1. La macchina parte nello stato 1 alla casella 1 che
per convenzione è vuota. Poi si muove di una casella sulla destra e va
nello stato 2. Se la casella sulla destra della casella 1 è vuota (nessun
input), la macchina si ferma. Se la casella contiene uno 0, la macchina
scrive un 1 al suo posto e resta nello stato 2. Se la casella ha un 1, la
macchina si muove verso destra di una casella e resta nello stato 2. La
macchina descritta esegue il "particolare" programma qui specificato.
Si può definire una macchina di Turing "universale" in grado di
eseguire qualsiasi programma incorporandone sul nastro la
rappresentazione (dal momento che qualsiasi programma può essere
codificato come una sequenza "finita" di simboli).