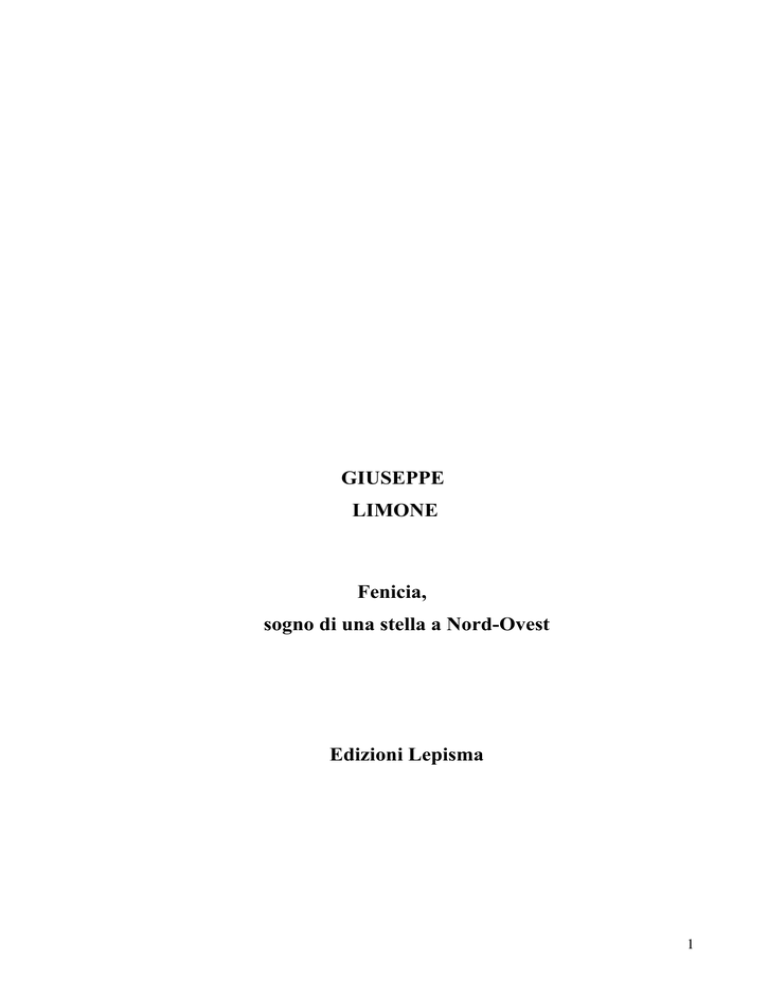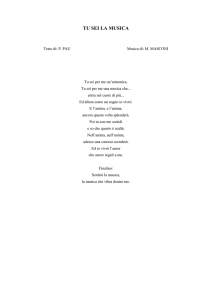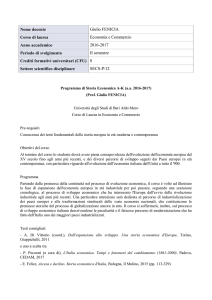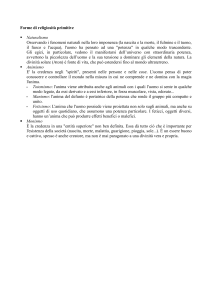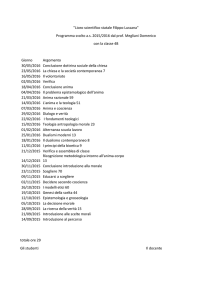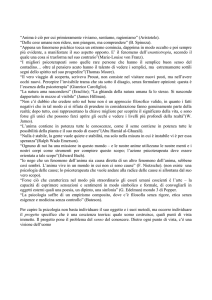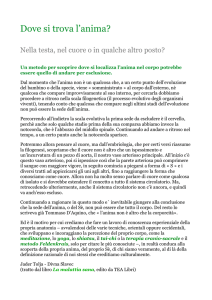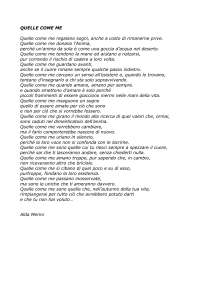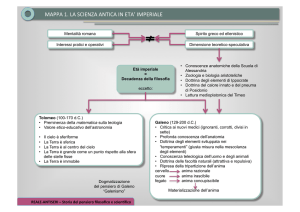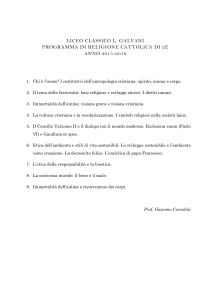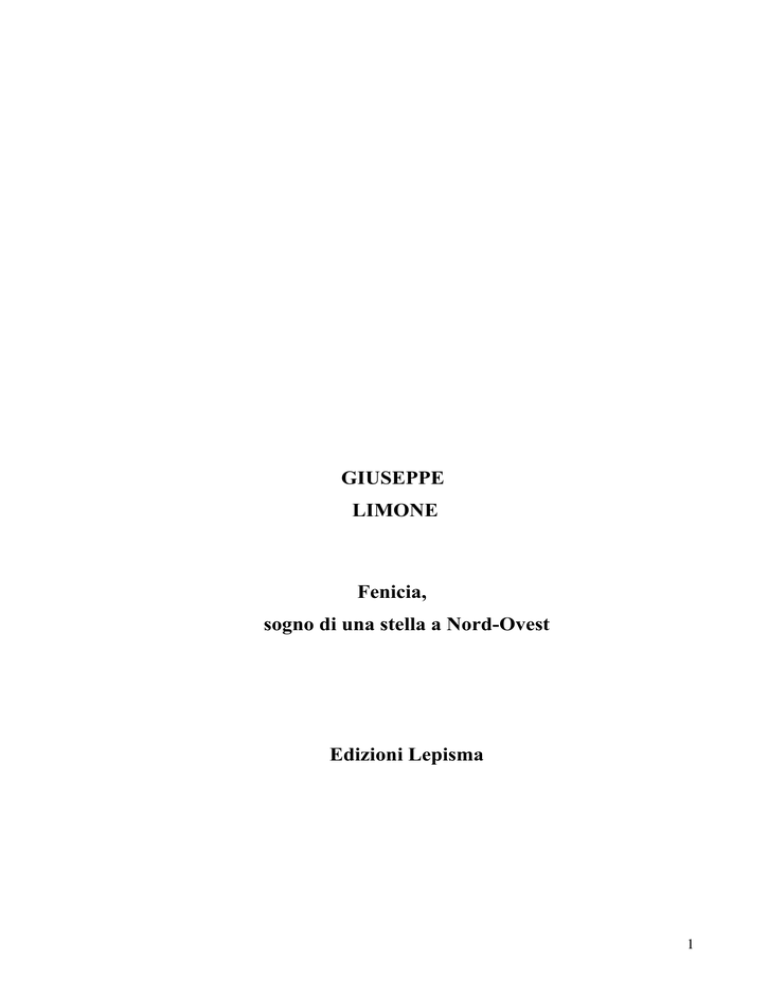
GIUSEPPE
LIMONE
Fenicia,
sogno di una stella a Nord-Ovest
Edizioni Lepisma
1
4
Prefazione
Salvatore Quasimodo sosteneva che i filosofi sono “i nemici capitali
della poesia”, naturalmente quando diventano “schedatori fissi del
pensiero”. Se invece il pensiero lo spargono armonicamente e lo distillano
in immagini e in scatti lirici si ha la grande poesia. Si confrontino Dante,
Campanella, Leopardi, Luzi, solo per fare qualche nome.
Sono pienamente convinto che il calligrafismo, il descrittivismo,
l’annotazione paesaggistica e l’annotazione psicologica sono elementi
importanti di un testo, ma se non affondano in una visione della vita e nelle
radici profonde dell’essere avremo opere piacevoli, carezzevoli, perfino
ammiccanti, ma incapaci di portarci all’esaltazione totale o allo scontro.
Non si dimentichi che i primi grandi poeti sono stati i presocratici e che
molte fonti della poesia anche contemporanea attingono a Platone e a
Plotino, a Seneca e a Montaigne, a Pascal e a Rousseau.
Ma questi sono discorsi accennati semplicemente per dire che se si
arriva alla poesia dopo lunghi e ponderati studi filosofici è certo che i
risultati saranno considerevoli.
È il caso di Giuseppe Limone che con Fenicia, sogno di una stella a
Nord-Ovest si ripresenta al pubblico dei lettori con la piena consapevolezza
che se vuole trovare la complicità del lettore e la sua comprensione deve
denudarsi, non nascondersi né dietro l’ombra delle parole né dietro la
concettosità né tanto meno dietro la complessità. Il suo deve essere un auto
da fe’ senza sospetti, un bilancio che non esclude nulla, che sia a un tempo
partita doppia della propria esistenza e del tempo in cui viviamo.
Credo che Limone riesca subito a conquistare il lettore, a portarlo
dentro le ragioni obiettive della sua confessione, dentro una ontologia del
possibile che è infinita, che si apre di continuo come matriosche sempre più
piccole e sempre più essenziali. Si osservi che nel corpo vivo del tessuto
poetico s’incrociano, facendo risonanza e vertigine in luoghi diversi e
molteplici dell’itinerario dell’autore, tre temi lirici in una sola parola
evocativa visitata in più chiavi: la Fenicia. La quale si rivela, come in un
5
progressivo dissigillamento, al tempo stesso: la terra antica dei Fenici centro
di partenza simbolica di una civiltà mediterranea e marinara, altra ed alta,
possibile alternativa sommersa alle tante che si svilupparono di fatto nella
storia del mondo; la figlia del poeta, Fenicia, e il tema della resurrezione,
incarnato nella celebre figura del mito. Non ci si inganni: i tre motivi sono le
tre chiavi musicali di un unico plesso lirico – la catarsi solare del viaggio
come rigenerazione del futuro. Anche le citazioni letterarie nascoste sono
affluenti a questo fiume. Infatti il libro bisogna leggerlo come un unicum e
non come brani sparsi. Limone ne ha progettato fin nei minimi particolari la
scansione e lo sviluppo ed è evidente che è dall’insieme che si attende la
verifica degli esiti.
Per capire comunque la portata del testo è necessario partire dal
titolo che si richiama alla Fenice, uno degli uccelli mitici di cui ci hanno
dato notizia Plutarco ed Erodoto. Pare sia di origine etiopica, di bellezza
eccelsa, longevo, con il potere di consumarsi nella fiamma del fuoco e di
rinascere dalle proprie ceneri.
Sulla Fenice sono stati scritti molti volumi, soprattutto durante il
Medioevo che la considerò simbolo della Resurrezione di Cristo. In tutti i
modi possiamo leggere nel suo mito la resurrezione, l’immortalità e la
rinascita ciclica o, a partire da Origene, il simbolo della volontà di
sopravvivenza, il trionfo della vita sulla morte.
La premessa per dire che questo libro in fondo è una morte totale e
una altrettanto rinascita totale che Giuseppe Limone compie attraversando
“il punto più difficile, / cercando / gli affetti purissimi / e l’innocenza
dell’aquila / irredenta”. Così ha inizio la prima lirica, e dunque il poeta si
presenta privo di qualsiasi remora, affidandosi alla libertà e alla clemenza
del lettore e di se stesso, ricordando, prima a se stesso e poi a noi lettori,
quali siano stati gli elementi determinanti che l’hanno accompagnato per
lungo tempo e che a un certo punto si sono dissolti. Si rivolge direttamente
al Signore, Gli ricorda che ha soccorso “i fiori recisi”, “gli alfabeti / plurali
del respiro, / i gigli illesi, / i coriandoli del nome / e dell’onore” per
condurLo sul suo stesso piano, per invitarLo a scendere a patti con la sua
persona e chiederGli la restituzione delle cose perdute.
6
C’è in questo primo testo la disperazione starei per dire gaudiosa del
proprio percorso che deve servire come moneta e credito da offrire al
Signore per riavere nelle mani il proprio destino di uomo. Limone non
tergiversa, conosce la sua forza interiore, lo slancio con cui ha amato, ha
sofferto, ha goduto, e conosce la malinconia dell’addio, della rottura con
l’equilibrio e l’armonia del mondo. Un palpito ungarettiano si risolve in
scatto campanelliano. Le sofferenze sono un travaglio che deve suscitare
l’interesse di Dio. E per farci sapere fino a che punto Limone è stato uomo
di fede, soprattutto nella poesia, oltre che nella vita, fa ricorso a un nume
tutelare che si chiama Federico Garcia Lorca. Vi fa ricorso addirittura
ricalcandone i moduli espressivi (anche se riportati alla propria dimensione
e al proprio ritmo), ricorrendo a una dovizia di sinestesie che hanno il
bagliore delle lame di Toledo, a cominciare dall’incipit: “Il mio cuore
cavalca un puledro / di lucido sole”, fino alla glorificazione di
quell’arcobaleno che “è un pianoforte all’aria / per le tue dita / luce”.
Un lirismo starei per dire accecante in cui “il pianto rosso
dell’estate” diventa a un tempo malinconia fertile e danza irrequieta che
prelude a qualcosa di straordinario. La Fenice sa attendere, sa divincolarsi
dalle assurdità, dai dolori e trovare l’abbagliante mattino delle nuove albe. Il
poeta altro non è che la Fenice, un unico fiato, un unico fine, un’unica attesa
da cui salterà fuori la nuova strada.
Viene naturalmente da domandarsi se il tu colloquiale a cui si rivolge
Limone sia un astratto interlocutore oppure il suo doppio, o il suo amore
sempre sullo sfondo e sempre pronto a dissolversi nella nebbia del ricordo.
Eppure, anche nella caduta egli non recrimina, non fa la vittima, non si
atteggia a giudice, a moralista. Resta il poeta incantato nella speranza
fenicia e nel grumo irrisolto del dubbio. “Avrei voluto essere il lampo”
spiega l’atteggiamento di tenerezza che ricolma le azioni e i pensieri del
poeta che subito dopo si confessa e dichiara di non avere niente da dare
all’amata, “se non il mio ultimo respiro… la mia tenerezza invisibile … la
mia attesa inutile … questi occhi, / segnati da fuochi e da morsi”. Il “pulcino
rannicchiato” a questo punto deve ritrovare le braccia della madre e infatti
ricorre a lei, proprio nel giorno dei morti, il due novembre, ma
7
semplicemente per dirle che il pulcino “rannicchiato” è diventato
“sgusciato”.
Mi rendo conto che sto seguendo un itinerario di lettura che fa
sembrare questo libro un piccolo romanzo. In realtà è proprio un romanzo
questo avvicendarsi di ricordi, di incontri, di richieste, di attese, di
promesse, ed Etna è il punto nodale di un intermezzo vissuto come una
rivelazione. Diceva Borges che per capirci meglio, per ritrovare noi stessi a
volte basta soffermare lo sguardo sulle cose e rifletterci proiettando il nostro
doppio e colloquiando. In qualche modo Limone attua questo principio e ne
ricava riflessi abbaglianti che illuminano lo stato d’animo in cui si trova, le
atmosfere vissute in un travaglio che comunque sa sempre sfociare in rivoli
che sgusciano dalle tenaglie dell’esasperazione e della disperazione. In
Limone non c’è lo smarrimento del deserto a cui per esempio ricorsero nella
disperazione Marina Cvetaeva e Josif Brodskij, neanche quando descrive,
con lucida consapevolezza, “la sforza del cosmo che non passa, / come
l’istante che mai si consuma: / come una chiesa vuota / in cui nessuno crede
più, / in cui ramarri sonnecchiano annoiati”.
Limone intreccia, nella sua confessione, momenti di riflessione e
momenti lirici puri, momenti squisitamente narrativi e scavi nel proprio io.
Lo fa con naturalezza, incurante degli effetti psicologici, delle onde sonore
che produrrà, dello strazio che farà nascere nel lettore. Egli vuole il lettore
suo complice autentico e non come un viandante che lo sfiora e perciò non
esita a farci assistere a un colloquio col padre – 2 febbraio, per un
anniversario. A mio padre – in cui le vite s’intrecciano e in cui appare
evidente una visione di mondo tradito. Limone parla addirittura di cilicio e
la parola ci fa comprendere che cosa passa nella sua anima lacerata, nel
subbuglio del suo essere crocifisso all’altare dell’amore e dell’onore. In
Porto invece c’è quasi una nota elegiaca, con accenti civili che spesso
entrano ed escono dalla poesia di questo autore così ricco di sorprese, al
punto che nella successiva poesia ci parla di Dio che è solo a domandarsi
come svegliare i dormienti “domani diversi da come li creò”. Dio non è
forse simile a lui nella solitudine? Anche Dio! E qui la universalità della
poesia di Limone appare in tutto il suo fulgore, in tutta la sua ampiezza, fino
a trovare Lungo un cielo di braci la raffinatezza della contemplazione che
8
invece erompe in scintille infuocate in 27 dicembre, in cui c’è lo sferragliare
della decomposizione di un dolore senza riparo, e c’è l’isterilirsi di un
magma che deve trovare la sua rapida per uscire senza fare danno. Gli
accenti di Limone squillano come spifferi incandescenti, sbandano. Ma alla
fine ritrovano una ragione d’essere, seppure contaminata dal tripudiare del
male, dalle lacerazioni di un dissesto umano che all’inizio grida e si dibatte.
Ma la sua anima stessa è Fenice che rimonta il dissesto e ritrova il sole.
Dicesti è più ragionata, più pacata. È lirica che cerca il senso non dal
nonsenso, ma ancora una volta dalla meditazione, dal pensiero, dalla
rinuncia intesa come riscatto della verità, come promessa che svela il
mistero della stella.
Questi rapidi accenni che cercano di scandagliare i segreti
impollinati nelle parole di Limone sono appena un barbaglio percepito a
volo di rondine. Nelle poesie di Limone c’è molto di più, è quel sostrato di
filosofia “sfarinata” nei messaggi, diluita in un pulviscolo che irrora di
compostezza e di fermezza ogni verso. Ma teorizzare in maniera decisa a
prefazione di un libro così sfolgorante di metafore sarebbe un eccesso che
inficerebbe la lettura. Se vogliamo trovare supporti di carattere filosofico a
questa poesia che gronda umanità e si appella alla discrezione del canto
inteso come risorsa per salvare la persona, non sarà difficile trovare riscontri
nei tanti testi di Limone. Egli ha studiato a lungo e profondamente in che
consiste la centralità dell’uomo, non negli intenti rinascimentali ma in quelli
che sono i fermenti dell’anima a cospetto della degradazione e delle
rivoluzioni vere e fittizie e ne ha tratto convinzioni che andrebbero valutate
alla luce del frastagliamento odierno per misurare quanta parte di irrealtà
circola nelle tesi dei finti filosofi e nelle affermazioni dei politici che hanno
perduto la meta e sbandano in direzioni insensate. Nella poesia di Limone ci
sono le certezze del vivere, c’è l’amore, con e senza la maiuscola, che
determina il cammino e lo rende possibile. Tanto è vero che in Piramidi di
pietra noi sentiamo il peso e lo spessore del tempo e ne avvertiamo la
consistenza feroce, il passo deciso che rende tutto “alti misteri umani
prosciugati”.
Centrale nel libro comunque Nóstos, il ricordo del futuro in cui il
mondo greco e quello contemporaneo acquistano una luminosità inconsueta
9
e si fanno identità di un divenire eterno che detta le leggi dell’essere e del
non essere, facendo “tutto presente al tempo di chi guarda”.
Una intensità musicale si sprigiona da questo poemetto, una
religiosità foscoliana si alza a dilatare il canto e portarlo in una radura
incontaminata; e quel “papavero redento” diventa davvero ostia consacrata
per una comunione con Dio e con la natura, con ciò che fugge in fretta e si
disperde in pulviscolo luminescente. Non è la promessa della redenzione,
ma qualcosa di più, il ricordo del non accaduto, il tempo frantumato in
estasi, il bisturi che lacera il misterioso palpito di assonanze nascoste nel
diluviare delle idee e delle sensazioni, delle emozioni che spingono
comunque al futuro e dipingono “il tuo cuore d’ali / e le mie mani bucate
dalla felicità”.
E come sempre, Limone sa diradare la temperie addensatasi sul
sistema della felicità perduta, sulla possibilità diventata nodosa e paludosa.
Ed ecco “Venezia sposa”, che si fa specchio del vivere “Forse perché / ha
questo nostro medesimo morire”.
Gli ultimi tre testi, Fenicia, Andrò. Il sole di Möbius, L’ora della
Fenice sono un’apoteosi, un crescendo mozartiano che trascina e specifica
gli intenti umani e filosofici dell’autore oramai avviato al viaggio (il libro, o
come io l’ho chiamato, il romanzo, è un vero e proprio viaggio intorno a se
stesso e dentro se stesso) che si concluderà con il ritorno all’innocenza di
fanciullo. Il quadro è chiaro, il poeta andrà “verso ovest / a mare aperto ad
ali spiegate / dalle risse dei venti / e non avrò conforto di compagni”. Come
potrebbe essere altrimenti? È da sé, da solo che deve trovare, ritrovare le
coordinate del proprio essere, “avendo l’illusione che il tramonto / sia la
prova dell’alba” e tutto avverrà fuori dalle regole, senza aiuti, senza guida.
Come nell’attimo prima della morte ogni cosa apparirà nel cuore e le
immagini diventeranno limpide carezze, ogni cosa troverà il suo assetto
definitivo. Gli affetti si comporranno in un ricamo perfetto e il sapore della
vita rifluirà grazie alla presenza inseparabile dei figli, della donna amata,
delle sofferenze diventate calvario superato e medicato dalla poesia.
Tutto il libro ha qualcosa di profetico e di immenso; come se dalla
carne di Giuseppe Limone si sprigionasse un vento caldo che scorre tra le
parole e le rende cose. Non so quanto la lezione di Heidegger sia entrata
10
nella visione estetica di Limone: è certo che egli compie uno sforzo enorme
per portare alla sintesi mondi infiniti e mondi che stanno in agguato sullo
sfondo delle possibilità. Il poeta è come vinto costantemente dalla bellezza e
dall’amore e si avverte che la presenza, per esempio, dei due figli, è come
un medicamento salutare per fargli superare le avversità e ridargli vigore.
Naturalmente il “romanzo” non si conclude con nessun commento.
Tutto resta aperto, come il cielo, come le “rosse Fenici / calate in mare per
rigenerare / il perso alfabeto dei respiri, il giorno al sole, / le ceneri e la luce,
le radici e le ali, sempre votate a essere / immortali, /a risorgere da sé”.
In tempi come i nostri di “povere cose” e quasi mai miracolose, per
ricordare Lorenzo Calogero, un libro di questa portata è un atto di fede nella
gioia, nell’amore, nel mondo, nonostante la violenza, i lutti e l’indifferenza.
Dante Maffia
11
12
Intenzioni di viaggio:
Alla piccola Maria Raffaela Caterino
mia madre
nel cui futuro di stelle
sempre furono e saranno
i suoi gioielli mai visti
e più suoi,
Angelo e Fenicia.
Ai miei nipoti amatissimi
Angelo e Raffaella,
luci del mattino.
A Orlando,
mio fratello di amori e ricordi.
E ad Angelo Giuseppe, mio figlio,
oro di fanciullo,
perché conservi e promuova il suo grande valore
e perché ami Fenicia e sua madre
come io le ho amate.
13
14
LA MIA STELLA
La mia stella nacque a nord-ovest
nel punto più difficile,
cercando
gli affetti purissimi
e l’innocenza dell’aquila
irredenta.
Amai
Eurìalo e Niso,
l’amicizia intemerata,
dare onore
all’indole ingenua,
soccorrere i fiori recisi,
remare
i venti dell’anima
aperta ai battiti del sole.
Signore,
renderai alla mia stella nel dolore
del passo
il fresco del papavero
rosso,
il tumulto delle more, gli alfabeti
plurali del respiro,
il viso dei bambini
spuntati
nel cosmo e nel mio prato,
che amai
fra le doglie infrangibili del cuore?
15
Restituirai
a chi ti vide, Signore,
nella gola dell’ovest
le rondini, le dolomiti del respiro, le lacrime
perse nel cristallo muto del dolore?
Restituirai a chi abita il ricordo
gli occhi lucenti di stelle
che amai, i giorni rossi,
le risa d’acqua,
i gigli illesi,
i coriandoli del nome
e dell’onore,
l’alito inestinguibile del sole?
16
A FEDERICO GARCIA LORCA
Il mio cuore cavalca un puledro
di lucido sole.
Miagolío
di mani vispe
imbianca la mattina.
(Il mio cuore cavalca un puledro
di lucido sole)
Gli occhi
sono mandorle azzurre
filanti
in sospensione.
(Il mio cuore cavalca un puledro
di lucido sole)
Acuti seni
vivi
ti pungono d’argento
il desiderio.
(Il mio cuore cavalca un puledro
di lucido sole)
All’alto
17
zenit
è una magnolia appena
schiusa
la tua bocca.
(Il mio cuore cavalca un puledro
di lucido sole)
L’arcobaleno
è un pianoforte all’aria
per le tue dita,
luce.
(Il mio cuore cavalca un puledro
di lucido sole)
Abito la soda
tenerezza del tuo corpo,
mela
compatta.
Le mordo il cuore.
(Il mio cuore cavalca un puledro
di lucido sole)
Da sette note
nacque
tutto il mondo
del tuo fiore.
18
Il mio sogno cavalca un puledro
ed è lucido sole.
Mi è dentro il pianto rosso dell’estate.
19
POETA
Offri colori
mescendovi un ignoto
liquido sole
rosso in un creato
di meraviglie
da un gorgo ignoto
che si dà in faville.
Tutto si svela
e poi rifà quesito.
Il poeta
è uno strano incantatore.
Gocce di fuoco al cuor schizzate foggia
e le martella in iridi gemmate
rapendo a sé stupiti ammiratori
e gioca a dadi con i suoi dolori.
20
AVREI VOLUTO
Avrei voluto essere il lampo
del tuo riso
moro
la ricolma
malizia moscata del tuo onore.
Ma sono solo il furto della lama
che lo riluce
e aspetta
nella speranza del tempo che si cela
nella memoria
e si fa gatto alle tue notti di luna.
21
NON HO NIENTE DA DARTI
Non ho niente da darti, piccola creatura che
m’ami,
se non il mio ultimo respiro
la mia passione inutile
il mio residuo verde di fuoco
resistíto nel vaso dei mali. Non ho nulla
da darti se non
il manipolo bardato a cavallo di tutti i tradimenti
passati sul mio corpo nudo
come uno squadrone della morte.
Non ho niente da darti se non
la mia tenerezza invisibile
in un corpo senza volto,
giunto sul limitare degli abissi a dare il cambio
al dolore.
Non ho niente da darti se non il mio soffio
innocente, trasformato nell’orrore
di chi vi ha sputato all’unísono tutte le iniquità.
Non ho niente da darti,
piccola creatura che m’ami,
se non la mia attesa inutile
del volo in un’aurora d’estate,
seguíta dal decreto del sangue.
Non ho niente da darti se non questa mano,
perché tu la soccorra,
22
piccola creatura che m’ami. Nulla
potrò darti se non questo
pallido sorriso
in cui tu possa soffiare come in una bolla
iridescente,
che voli.
Non ho niente da darti se non questi occhi,
segnati da fuochi e da morsi,
per restituirmi al tuo nulla,
piccola creatura che non esisti
e che mi ami nel tuo nulla,
in cui scopro di vivere da sempre come un
pulcino rannicchiato.
23
2 NOVEMBRE, PER UN ANNIVERSARIO
Il vento scuote la luna,
madre,
questa notte,
draga
l’urlo del tempo,
unghia
lo strabuzzo dei vetri, smura
ragni indifesi
e tu ora tremi di freddo e di paura
nella tua tomba
come una
bolla
di nulla appesa alla mia notte,
come un grido d’amore senza dita,
come un pulcino sgusciato.
24
ETNA
Una paura
qui
rossa c’ingoia.
Il fuoco ride
nel nero volto fondo una
malizia
di sarcastica fiamma
a questa
còlta
in flagrante segreto
nostra
finitezza
d’esistere svelata.
Ci fu
tatuata
un dì
come una colpa
e poi
come colpa sepolta.
Due eruzioni sorgono in quest’una
che scende.
È oro sulfureo la notte.
25
RITORNERÀ SETTEMBRE
Ritornerà settembre e i pini rossi
grideranno aiuto alla sera
e tu verrai
col tuo passo leggero
in un’anima segreta
come fiato sottile sopra un vetro
che decima ricordi.
Non avrai né parole né pianto
né rovi d’ansie
né mani bianche trafelate dalla sera.
Sarà giurato l’onore
sulle cose non dette
su quelle più antiche
e più care
e più segrete.
Nasceranno sulla neve
orme minutissime e leggere
in successione muta
come di bimbi invisibili correnti una tastiera
di perle e notti.
E tu riavrai il tuo sorriso
deposto sul gioiello che t’apparve
in palmo
mentre il mare sorgeva
alla sua estate
26
in una notte tutta luna
meravigliata dalla luce dei tuoi occhi.
Sarà un’ora soltanto
ma assoluta,
immortale,
come la forza del cosmo che non passa,
come l’istante che mai si consuma:
come una chiesa vuota
in cui nessuno crede più,
in cui ramarri sonnecchiano annoiati,
mentre
prega solo un silenzio
esangue
a mani giunte d’erbe
e la memoria
tutta di pietra di ciò che resta e fu.
27
2 FEBBRAIO, PER UN ANNIVERSARIO.
A MIO PADRE
A papà Angelo
perché ne vivano
il nome, l’onore e il sangue i nipoti
Partisti
per il viaggio più lungo
un giorno di febbraio.
E mi accade
pensarti.
Un pensiero
che ha quindici anni è già adolescente.
Sono nel pozzo
d’un sogno
a cercare una stella,
a lastricare di buio le mie notti,
a vedere dal fondo come delimita il cielo
il breve giro di luce dell’affaccio.
Strappo lacerti di varchi
alla mia infanzia
per farla uscire e ne soffro
come nella storia di Nesso.
E ti risento, padre,
compagno di strada mentre mi tieni la mano
alla festa del santo,
soccorrermi,
darti
28
pensiero per me e donarmi
il bambino rosa
giocattolo
che faceva pipì d’acqua corrente
- era l’infanzia
che stavi regalando a te stesso
regalandola a me
e lo sapevi.
Ti telefono
oggi, papà,
per assaporare la tua voce.
Quante volte
ho composto il tuo numero
nelle ore difficili, padre,
dimenticando che sei morto.
L’anima
ha questi strani mancamenti
di tempo, percorsi
carsici
e io
sono qui l’inumana
eco che si fa concava al venir della tua voce
la bandiera sottovento
in attesa.
La vita
ha verità difficili, padre,
come un passaggio a nord-ovest
e le gioie dei ricordi
sono dolori retràttili
29
come unghiate nel sangue.
È incurabile
l’anima
all’irreparabile zodiaco dei volti
bianchi che tranciano le attese
nei sogni.
Siamo
cristalli di ore vive,
frastagli di tempi translucidi,
ali di farfalla friabili
al silenzio del sole.
Siamo
scalini d’ansia, formicai di memorie
e risparmi dell’anima ferita.
Lanciniamo
di ciò che perdemmo
ed è sezione aurea fra l’anima e il vero
il nostro dolore.
La tua
bontà fu inumana, padre,
spericolata come la tua dolcezza,
visionaria come l’arte e l’amore;
non resse
il teatrario del mondo
e tu ascoltami.
Sono il letto vuoto del tuo cuore,
il testimone del tuo nome, il procedere
dei tuoi possibili recisi
e tu sei la mia fame di rose.
30
Il crepaccio del fuoco e dell’anima.
L’ansia della stella che non passa.
Il labirinto di echi degli addii
frantumati da una voce.
Il mio cilicio.
Il mio canto.
Il mio viatico di semi sepolti nel sorgere dei figli.
Il mio sogno d’albe e tramonti visitati dal perdono.
Il mio tumulto di pace.
La mia fame di preghiera.
Oltre le nuvole,
oltre le stelle,
oltre l’abisso del grido,
tu.
31
PORTO
Non ebbi altro trovarti che perderti.
Non ebbi altro perderti che trovarti.
Un uomo è un re quando sogna e un
mendicante quando pensa,
e in nessun supermarket dei sogni
ho più ritrovato il tuo viso.
Porto nella borsa della spesa
i ricordi di ieri, un violino,
due popcorn per la caccia
e il giardino ove scoprii la tua mano
e il coniglino
Sisì.
A proposito, chi ha vinto in milan-napoli?
È il pubblico che fa gol al denaro o viceversa?
Meno male che le banche svizzere
hanno finanziato la fame del terzomondo
aprendo una sottoscrizione fra i drogati.
32
PIANETA
Si leva la mitissima notte, abitata
dalla speranza dell’alba.
Tutti
dormono ora sotto la luna
e Dio è solo.
A domandarsi come
rendere invalide tutte le torture e le stragi.
A domandarsi,
guardando i dormienti,
come poterli svegliare domani diversi da
come li creò.
33
LUNGO UN CIELO DI BRACI
Lungo un cielo di braci
che si sfalda
in un mosto di fiamme
e sangue bruno
arriva a fili sfrigola la sera
su lamiere di grilli.
E ruba in cuore un treno
che si sfa.
34
27 DICEMBRE. ERI
Eri
il mio prisma infinito di stelle. Dove fuggisti?
Che male oscuro ci prese? Quale drago
improvviso, rompendo
il dorsale
filo dell’orizzonte ci spense
l’apocalisse della luce?
Eri
il mio prisma infinito di stelle
screziato nel sole,
la mia
piramide di quarzo puro
elevata dalle cure dei miei giorni. Dove
fuggisti?
Stasera
un’aurora bambina,
braccia al cielo,
in uno stizzo di brace
franò.
Riaprì un’estate
di filanti luci liquide di notti
sillabata dall’oro dei tuoi occhi.
Due bimbi
fiorivano in fondo,
sommersi, segreti, a braccia aperte,
come due stelle di mare.
In mente Dei, in attesa di volare.
35
Ascolta. Qui ora
nel muto
fiordo
di questo spacco di casa
che fuma
davanti al silenzio d’un viso
curvo sul grembo del calore
un passero verde si fa fuoco, sibila, spara
in uno strozzarsi della luce:
due voci
in due lingue
di fiamma
improvvise
da uno stillicidio di fervori
ti prendono alla falda della gola
come
doppia frana tranciata
di rovo rosso lacero che preghi.
Fermenta
il dolore come un
bruco
gelatinato dal respiro,
sgocciola serpi,
sgrammàtica lampi di ricordi,
stride.
Ha lacrime verdi,
accidentate e mute
come ardesie scavate dalle stelle,
schizzi roventi
36
sulle fattezze immobili del buio
che dal buio disegnano la luce.
Ha corpo frantumato, cruda l’anima,
millenni irrimediati di memorie,
bagliori randagi di futuri,
avare luci
questo buio dolore.
O nostra sororal ultima luce,
residua Thule,
iscritta nell’annaspo di chi vive il
resistere sull’
orlo del respiro,
argine al tonfo
che idròvora dal fondo
della gola senz’anima del buio.
Solo per chi
non ha più speranza
fu data la speranza.
E l’amore
è la penultima risacca
che precede l’ignoto
e segue il mal di mare:
mai non si acquieta a spegnersi nel sale
e da ogni dove
sempre ritorna nell’esplodere dei guizzi.
L’avvento della notte
non è la morte del sole
e il filo di sorriso d’un bambino
non predice il rinascere
37
dell’alba, ma apre
sempre al possibile varco
del filo d’erba
acuto, inconfutabile e immortale.
Ci è restato
come il giorno più lungo
solo l’artigianato del dolore
che si fece parola:
come un oro illegittimo e segreto,
costoso di silenzi e doveroso
come l’onore
di Árjuna
e Sherazade.
Simile a
sabbia mobile ora sale
dal fondo inconsumato una preghiera
con la bocca ricolma,
strozzata
da una fede
pallida, implume, costipata.
Che Qualcuno
ci salvi. Ci aiuti. Rompa
col filo d’erba la roccia,
col possibile la necessità. Soccorra
nel cosmo fratturato dei respiri
la carestia degli occhi, la miopia dei giorni,
l’angustia rovinosa dei ricordi,
l’anoressia della speranza, il buio
tempestato di mani, l’insulso dell’inane,
38
il trapianto
di fedi
impoverite in serie, il silenzio
sigillato dell’anima
estirpata
dal laccio del nemico che l’avvita.
Che Qualcuno
soccorra
l’imperioso irredento,
l’incontenibile taciuto, il mare immoto,
l’universo di sole
risucchiato
dallo sghignazzo ingordo dell’assurdo.
Che Qualcuno
soccorra
le residue braccia
spalancate
a cielo perso
a un arcobaleno di bambini
dagli occhi verdi e neri,
grido pulcino dell’ultimo universo.
Sia preghiera per noi.
Che Fenicia
patria
sia promessa di varco a Nord-Ovest,
terra che respira
alfabeti di navi, rossi orizzonti, angeli per voli
di remi,
antichissimi ricci di coraggio
39
nautico e porpore di mani
nel ricordo celeste del Carmelo,
sia mediterranee luci come semi
di civiltà,
di uomini in bottiglia a cosmi nuovi
come frecce in faretre messaggere,
semi
di sorrisi
destinati a scoppiare dal gheriglio
di millenni di mare
in un’orologeria che dissigilli
varchi di fiori in boccio
nati da un sogno verde di maestrale.
Sia preghiera per noi.
Che il nostro
mondo minimo dirompa
il guscio che lo preme,
sia metafora e nido, vertice che scoppia
dal profondo e rinasce
come la Fenice
e respiri, mentre bruci
il minuscolo velo che lo tiene
in ceppi inespugnati
e in un lampo
sull’ultima riga del grido più alto arda
la nona stella.
Che Qualcuno
renda fede a chi giace. Lo sottragga
all’emorragia dei giorni, alle periferie dei
40
domani,
all’inconsulta inermità di chi è vivo.
Gli ricordi i perdoni.
Gli restituisca l’onore
d’esser stato.
Riapra
il corpo vivo del cosmo.
Perdóni
a chi ancora esiste
l’abisso aperto dell’essere nato.
41
DICESTI
Mi dicesti,
parlando a te stesso:
Non ci sono che due verità –
la ruota e la morte.
La morte,
per farti sapere che fosti,
e che, fra tanti, eri solo.
Bisognoso di orme
trovate e generate, a intreccio alterno
in un giro di necessità.
La ruota,
per farti sapere che eri
anche là dove non ti vedevi,
svelandoti di essere stolto.
Ah! dimenticavo.
C’è un’ultima
Verità, la terza: la stella.
È nascosta
e sorge solo a chi ama.
Come bianca forma su vetro
freddo
emerge solo, d’un soffio,
a chi le alita, a vivo,
evocando la sorpresa figura.
Che nasce agli occhi e riscalda
non si sa come.
42
E si leva.
E a nord-ovest
sul rovinare di mille universi luce unica brilla.
43
PIRAMIDI
Piramidi di pietra,
immani pugni
acefali rostrati,
rapaci stalammiti
a goccia a goccia
di sangue di uomini
levate,
schiene di terremoti al tempo emerse
in sassi di spigoli,
scoppiate
fiaccole morte infisse, sfingi nuove,
volumi di precípiti silenzi
eccellenti nel tempo,
voi
alti misteri umani prosciugati
in pietra dura,
granate da deserti,
messaggeri
di semi sigillati
nell’oceano del cosmo
come stelle in bottiglia,
navi d’oro
affidate nei secoli a pensieri
accorrenti stupiti in riva a un tempo
che scorre
ancora,
appollaiate
44
colombe nel deserto
a far vedetta a filo d’orizzonte
su tempi ancor marziali
ove saremo
finché sarà di noi guisa e memoria,
in voi si posa
la pettoruta speranza di salvare
a perdita di tempo
da una guerra ch’è adesso
antica pace
anime regali e civiltà.
Uomini fummo
come loro
ed essi come noi pietra saranno.
Argina il tempo
la memoria
a volte
e fa nel vostro corpo
civiltà.
Spesa per chi?
Quanti volenterosi voi nanosecondi
resisterete al bang
del cosmo che trapassa in altra età?
45
VENEZIA
Venezia sposa
i nati dei colombi al vecchio mare,
Atlàntide lenta al Carnevale.
Coltiva il fuoco
d’un fascino sottile.
Forse perché
ha questo nostro medesimo morire.
46
NÓSTOS, IL RICORDO DEL FUTURO
Non aver pace finché non ci componga
una mano
oltre i confini della sera
fra i tramonti di fuoco e i gigli dell’Eufrate
dopo l’Apocalisse del respiro
che ci farà diafani e lievi
come cristalli
di aria libera.
E tu
non avrai allora che pace
polícroma, di vite
liberate
nelle praterie delle ore irredente,
dei possibili
e dei gridi di fanciulli.
E tutte
le nostre vite
e le storie
e i possibili non nati
saranno coriandoli nel sole
di viventi
come di biblioteche lacerate:
tutte le nostre vite
frantumate e une
come farfalle
in sciami, come uccelli
prillanti in stormi,
47
a onde, per brani,
in geometrie mobili di volo
in un tempo ormai spazio
multívoco alle rotte del viaggio.
E la storia
così sarà lago
trasparente come cristallo
inconsùtile,
tutto presente al tempo di chi guarda.
E tu
nel grande sorriso del mare
non avrai più patrie di rimorsi
nell’ora alta, al ritorno dei perdoni.
E i porti
saranno respiri
e aquile le notti
e incroci d’ali le rondini
nel mosto dei ricordi
e svanirà
nel doppio giro della Tètrade, dopo
dieci giorni e dieci notti, nel sole,
l’ora nona del dolore.
E Balio e Xanto
saranno i miei destrieri
tornati,
mèmori del pianto segreto del divo
eroe invincibile, vulnerato dal destino,
ed Ettore
sarà vittorioso dentro le lacrime
48
fatte belle dalla morte
che seminarono venti
di rotte e pericoli e patrie e fuochi e mari di lune
e mille conati di nuovi possibili futuri.
E io,
macero e illeso come un papavero redento,
poltiglia di memorie,
svenerò dal giacimento dei visi
sul fondo della notte il sole del tuo riso
muto,
vivo tornato e presente come il respiro,
il tuo cuore d’ali il carminio
della tua anima svelata
in filari di notti
e le mie mani bucate dalla felicità.
49
FENICIA
Entro in sala d’attesa e in un alito mi appari.
L’aria è brumosa, silenziosa, densa,
gravida di fiati.
Mi appari
come un fulmine sereno. Sei
bella, fresca,
semplice, elegante,
liquida di moti,
raccolta nel sorriso d’una luce
bruna, che solo io riconosco da un lontano
tempo che
lungo mi si sgomítola nel cuore.
Mi appari
e sei piccola ninfa
altèra di dolcezze,
cara di forme
adolescenti e antiche, dagli occhi
screziati come un
miele
di lune e notti
accorse in volo da mari che non so.
Sei
sole azzurro, primavera di lacrime e sorrisi
e nell’ora spaccata
dall’anima
sei l’ape odorosa e sei l’amore,
tu
50
la mia sera d’estate, il carminio di una sosta
regalata ai deserti,
questa piena di verde che le valli
incantano confessandosi nel mare, il profumo
di aranci
in preghiera, viatico alla luna.
Tu
mi vieni incontro
qui,
cresciuta bimba ignara di te stessa,
Fenicia,
pulcina azzurra che vieni ora a tuo padre
qui dal futuro
a questo tempo presente che ci chiama
come un varco di luce, come un gorgo di domani, come un rogo
insaziato nell’incrocio
a trapezio fra i tempi
in un circo di epoche immortale. Oh
l’esercizio dell’ora, questo nostro
spezzato rimorso, questo colpo
verticale sull’anima
che trancia la melagrana della sera!
Tu
vieni incontro
a me ignoto
presa in un gorgo che ti tiene in palmo
cui non resisti
come una volta tua madre.
Come una volta –
51
il tempo ora ritorna
e ci tempesta di silenzi e soli
e di ciliegie mature
di ricordi
e di guizzi di lucciole e di lampi e
di tramonti perduti, oh tu ritorni
e l’estasi del tempo è un fiume d’oro
costellato di estati che sommerso
e invisibile sverna
nel futuro che irrora
tutte le rotte del mondo,
le mille e una dita delle notti
navigando
senza fine a nord ovest
all’incrocio degli sforzi
che cattura il silenzio delle voci
sepolte nelle falde che ogni tempo
issano
all’altezza dell’anima. E’ oro che dà lacrime al
dolore
il racconto lunghissimo di Sherazade, piccola
mia fata che vieni. E io
racconterò miliardi di favole alla morte
per tenerti per mano.
Vieni,
o ignota a te stessa,
o pastorella del tempo, o sorridente, o leggera,
o
senza voce bimba
52
qui rapita al tuo tempo per donarti
senza resti ora al mio, altèra di dolcezze,
chiacchierina
nei momenti d’amore
con tuo padre,
o tu invocata
nel gorgo che in un cesto ti conduce
come rondine a me, lucente di ricordi a questo padre
che t’indovina e ti avvince ora nell’ora
salvata dalle acque
o mia Nausicaa.
Vieni
– e spacchi la melagrana del mio cuore
in due fragole arrese,
emerse qui dal fendersi scoppiato
fra gli scisti dell’anima, alle ascisse dei ricordi, in un grondare di
stalattiti
sbriciolate
in memorie di
mille
grànuli
rossi.
Tu
vieni a me incontro e mi parli
ora d’amore
a voce bassa
– ma non ti riconosco, Fenicia, leva
la tua gàrrula voce come sempre,
scarrucolante d’anima,
53
porporina
di estri marezzati
di scontrosa tenerezza, mai dòma! –
Tu sei l’aurora cordiale
in un diaspro di lampi, sei il furore
d’infrenabili valli verso il mare,
la tempesta
di fiori bianchi graziati dal silenzio.
Ma non sento
parola fra noi – troppo tempo ci divide –
e parli a me di me come ad un altro, e questi
suoni
mi
cadono
nel fondo
come sasso nel pozzo
quando il fondo è lontano.
Tu
ora a me parli, che
intentissimo ascolto
ciò che ascoltandoti non sento:
come a un
orecchio
bassissimo un angelo mi
síllabi
in segreto
traducendo
ciò che non sentendolo comprendo.
54
Vieni, Fenicia, ché
ora mancavi
all’appello
di chi ti guarda non visto
dal futuro
come da specchi unidirezionali.
Vedi, bimbina: tempi lontanissimi
fra loro
intrecciano l’arcobaleno delle mani
e il minuto che vive
qui, dentro un vecchio quaderno
stanco, che non si stanca di aspettare,
è connesso col tuo,
dal tuo è comandato
come un sultano povero, come un ricco giròvago
di niente,
come un meticcio immortale
e mi raggiunge
a fil di seta nell’istante luce
come il colpo di spada
della mano di Artù,
che apre la cometa
del masso e il suo segreto –
a te fu dato il cómpito e l’onore.
Avesti la mia intelligenza e i miei occhi,
il fosforo segreto
che valica
non visto
lo sterminato argine del buio
55
a volo aperto sapendolo di luce –
quello sguardo
fu da sempre già tuo. Sono la conchiglia sotterrata
che tu ascolti da dentro,
dalla scatola nera del futuro. Tu mi leggi dal
grembo e mi prosegui
come un progetto a memoria, come una via lattea
di comete, come un loto
risorto ad altro cielo.
Siamo rosse Fenici
calate in mare per rigenerare
il perso alfabeto dei respiri, il giorno al sole,
le ceneri e la luce, le radici e le ali, sempre
votate a essere
immortali,
a risorgere da sé. E ora
per passi
cosmici e brevi in un vortice allacciati
cadiamo a raccoglierci
in un corpo
a due visi,
in un glicine di ricordi e parole,
in questo circolo di ore
che non soffrono il tempo,
ora che solo
un attimo lungo, questo fuoco, questo
giorno visionario e sonnàmbulo, questo
tòcco inconsumabile di cuore, questo covo di brace
verde, questo rovo
56
di carezze perdute
in un punto inconsútile ci vive.
Tu vieni a me e io ti riconosco
forse non visto ma senza sosta udito.
Siamo
braccia improvvise che s’aprono a distanza
involontarie
come ali spuntate.
Siamo del tessuto
di cui son fatti i sogni, fatti
di ciò che ci manca e perciò siamo l’amore.
Mai ci perderanno
i filari del tempo, i mari d’aria, le stelle
dei pensieri.
Tu sei l’asse
terrestre che
a spada mi traversa
in un essere nuovo, in un ruotare
di giorni, come un fulmine bambino,
in un ferirsi immortale ma felice.
Tu
sei la gioia che non passa, la mia perla
da ostrica scoppiata, l’insula in flumine nata,
la passione
d’ambra e di luce, il complicato
alfabeto del sangue, il mio costato,
tu sei
lo sbriciolarsi dell’anima
in pensieri, queste mille parole,
57
questo fiato,
il mio nero di fiamma che cammina.
Vienimi incontro e prendimi per mano.
Forse soffrirai
qualche volta
anche tu,
ma sarà breve il travaglio perché
tuo padre ti veglia da lontano
e da dentro –
come il verde nell’anima del tronco, il suo gorgo,
la sua linfa immortale, il respiro
di sole alla radice –
e sarà solo per renderti felice.
58
ANDRÒ. IL SOLE DI MÖBIUS
Ad Angelo e Fenicia
Andrò verso ovest
a mare aperto ad ali già spiegate
dalle risse dei venti
e non avrò conforto di compagni.
Il sole
sarà gelido e gli occhi avrò appiccicosi
di solitudini e di notti
e sarà vetro il respiro,
senza tregua, senza scampo, senza
nemmeno il filo di strazio che fa compagnia
alla memoria.
E sarà monito il lutto
dei dolori non compresi e troppo verde l’addio
dell’anima esiliata sull’uscio, come una storia raccontata
da un prepotente a un ubriaco
di fedi indimostrate.
Andrò verso ovest
senza rifugio e senza guida,
avendo l’illusione che il tramonto
sia la prova dell’alba.
E non avrò né lari né domani,
nient’altro
che la mia povertà inestinguibile, accesa
come un falò votivo a rimorsi
senza identità,
senza delitti,
esposti nella cattedrale del vero
59
come idoli creduti.
E il cuore vivrà tagliato
da una scure sottile, emostatica, indolore, senza
esiti di morte.
Andrò verso ovest
guardando il sole come un tulipano promesso
e creduto contro ogni certezza,
come un’illusione comprata al mercato per
talismano.
Andrò verso ovest per ritornare avanzando
là donde mossi,
come in un nastro di Moebius,
come Ulisse e Colombo,
come Vico, come Riemann, come il mitico Alberto,
come ogni povero nano
destinato a reinventar l’universo
alla scala
della sua unica carne,
volando per interstizi di alfabeti
ricomposti in altre babeli di forme per trafori verticali.
E sentirò il dio sommerso: - Ritornerai senza mai
voltarti. Andando sempre
in avanti,
nello spazio e nel tempo nell’anima. Ti vedrai
dalle spalle,
alla fine,
raggiungendoti da dietro, tornando
là donde partisti.
60
Così dirà il dio.
E io incrocerò, al colmo del corso,
sempre avanzando, da dietro, sulla via del ritorno
Fenicia,
mia figlia, la
mia fanciulla dagli occhi di luna,
stelo forte di stella,
dal viso
rosso argento dell’anima,
nel suo vestito acceso in cui il sole si stempra,
ed Angelo,
sarà con lei, pensieroso figlio,
mio sorso d’aria e mio sposo di fontane
smeralde, mio sogno fenicio
d’un’alba
azzurra e buona, sterminata aquila di mare
tempestata di soli verdi.
Nasceranno ancora
per me come Veneri dal mare
le mie due felicità bambine, fiori del Carmelo.
Ritornerò donde mossi
ritornando senza tornare
e tutto sarà contemporaneo al mio cuore –
e Itaca sarà il tramonto e l’aurora,
e il corallo e la gioia dei fondali,
e il nido e la vendemmia dei ricordi,
e l’origine del viaggio e l’approdo,
e la lacrima della conchiglia e la luna,
e nell’incontro improvviso
61
fra i ritornati senza ritorno
tutti saremo maturi all’abbraccio
senza mai che sappia
nessuno chi sia stato a tornare.
Tutto sarà contemporaneo al mio cuore
e tutte le scale
del cosmo e tutti i frattàli
e tutti i tempi dell’Ecclesiaste
come lupi e agnelli del divenire,
come gocce di cosmo, come visi del creato,
potranno intrecciarsi in un luogo
unico, un punto,
potranno dirsi perdono,
potranno approdare in un sogno a un
arcobaleno di mani.
62
L’ORA DELLA FENICE
Fenicia,
terra di mezzo,
piccola striscia di montagne e fiumi,
esile terra regalata al mare,
nozze di petali e colori,
storia di minimi uomini lontani
abbacinati dai luoghi del tramonto,
che nell’anello terracqueo del mondo
antico,
volando da spalti di monti e cedri
come farfalle dal Carmelo,
traboccarono dal cuore patrio,
irrorarono i mari di alfabeti
e di mani operose e di porpore
e di gioie
e di coralli di popoli intrecciati
e di ali di remi
per sementi
di civiltà – Eliòpoli ti vide
e gli Enèidi che si sciolsero da te
in genti nuove –, da sempre ardi,
rossa Fenicia,
di amuleti e di rondini
a sperimentare i limiti del mondo,
la babele delle voci,
i volti molteplici di Dio.
Sono le doglie del parto
63
di un universo di mezzo
rotto in un mondo agglutinato
in labirinti di piste della pace
e cròtali di morte.
A che scala
fummo del frattàle?
Noi
risorgeremo
dalle ceneri del cuore come la Fenice.
Poi
il sole sarà l’incendio delle notti
nell’ora tarda
e tanti bimbi azzurri accorreranno
su nuovissime spiagge
come piccole flotte di pensieri
e risa d’occhi
freschi all’approdo.
E voi sarete lì,
stelle bambine,
come miei figli,
come minuscoli Iddìi,
per rifiorire a nord-ovest.
Come i miei figli,
angeli e fiori del Carmelo,
lanciati come semi del futuro
in messaggi d’aurore all’universo –
e io sarò tra voi,
rinato,
nella tornata mia innocenza di fanciullo
64
ch’ebbe fede nel sole,
per gioire a chi ha pace
e perdonarci
ed elevare il battito del volo
e perdonare agl’imperdonati.
65
INDICE
3
Prefazione
13
La mia stella
15
A Federico Garcia Lorca
18
Poeta
19
Avrei voluto
20
Non ho niente da darti
22
2 Novembre, per un anniversario
23
Etna
24
Ritornerà settembre
26
2 febbraio, per un anniversario. A mio padre
30
Porto
31
Pianeta
32
Lungo un cielo di braci
33
27 dicembre. Eri
40
Dicesti
42
Piramidi
44
Venezia
45
Nóstos, il ricordo del futuro
48
Fenicia
57
Andrò. Il sole di Möbius
61
L’ora della fenice
66