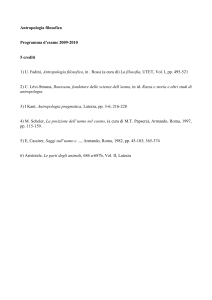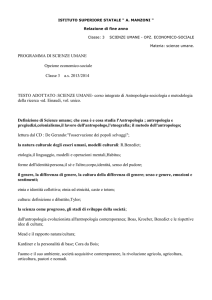UOMO L’ESPRESSO Professione Antropologo
IN VIAGGIO
A CACCIA DI
TRIBU
Percorrono tutte le rotte del pianeta.
Dalle foreste alle periferie.
Dai villaggi alle metropoli. Si muovono
tra riti antichissimi e modernità
estrema. Sono gli esploratori del presente
DI SABINA MINARDI
vete intenzione di ritornare? Il vecchio
Tanika, accovacciato all’ingresso della
sua capanna nel nord
del Benin, fissa curioso l’uomo bianco.
Chi è costui? Un occidentale che non scatta foto. Non dà mance. Non fa cose utili.
Ai suoi occhi la spiegazione è una sola: la
minaccia di un nuovo colonialismo.
Claude Lévi-Strauss sta per entrare nel suo
centesimo anno di vita. Eppure gli stessi
addetti ai lavori lo riconoscono: difficile
dire chi sia un antropologo. «Individuo tra
gli individui», secondo Marc Augé nel libro “Il mestiere dell’antropologo” (Bollati Boringhieri). «Un ladro di culture», per
Alberto Salza. «Sarà poi davvero un mestiere?», si domanda Marco Aime. Ma se
A
12
la definizione è difficile, lo statuto problematico, la qualifica di scienza discussa, certo è che l’antropologia non è mai stata in
voga come oggi. E lo studio dell’uomo evocato nelle riflessioni sul corpo e sull’ambiente, sul turismo e la religione, dai diritti umani alla moda. Lo scenario globale di
migrazioni e meticciati fa il
resto: scalza la sociologia
da chiave di lettura dei fenomeni più attuali. E candida l’antropologia a diventare la bussola più efficace della contemporaneità. Costringendo gli esploratori del presente a fare i
pendolari: tra le foreste, in
mezzo agli ultimi primitivi,
e i bordi delle città, alla scoperta degli ultimi diversi.
«È vero, sta diventando un mestiere di moda, quando ho iniziato a insegnare avevo
15 studenti, oggi 300», dice Marco Aime,
docente di Antropologia culturale all’Università di Genova, da anni frequentatore
del Benin, in Africa: fu lì che il vecchio Tanika lo scambiò per un colonialista. «L’antropologo non ricerca più il buon selvaggio, ma è interessato a cogliere come gli elementi più diversi penetrano nelle culture e vengono rimodellati.
Oggi la realtà globale fa i conti
con l’occidentalizzazione. Ho
visto cammellieri a Timbuctù
scaricare montagne di sale e correre in un Internet café a controllare la posta. Rituali vodoo praticati con bevande simili alla gassosa. Famiglie africane riunite
intorno alla tv impazzire per
l’Ispettore Derrick». “La scienza del rimorso” di Lévi-Strauss,
L’espresso
Foto: Eyedea - Contrasto (3), J. Bauer - G. Neri
Marco Aime
Un pastore Samburu, in Kenya. Sotto: una danza
tradizionale Samburu. Al centro: giovani donne
della stessa tribù. In basso: Claude Lévi-Strauss,
padre dell’antropologia, alle soglie dei 100 anni
cantiere aperto in una società
dove l’incontro con la diversità
è continuo, offre gli strumenti di
comprensione. A patto di riuscire a stabilire una comunicazione: «Entrare a far parte di una
comunità è difficilissimo. Fondamentale è l’appoggio locale: costruiamo
le nostre ricerche sulle spalle degli altri, ricercatori, traduttori. È un lavoro fatto anche di molti tentativi a vuoto. Perché le società non sono né meccaniche né razionali. Ma hanno un grado di imprecisione, di
tolleranza e di trasgressione alle regole, che
creano uno sfasamento tra ciò che la gente dice di fare e quello che effettivamente
fa». Aime sta lavorando a una ricerca in
Mali sulle associazioni di età: gruppi di individui nati negli stessi anni che si riuniscono in azioni di solidarietà. «In una società
gerarchica questo reclutamento, fatto di rituali scherzosi, attenua le tensioni».
David Bellatalla
«La nostra società può trarre esemplari insegnamenti dai nomadi», dice David Bellatalla, docente di Antropologia culturale
alla University of Western Australia a
Perth. Partito nel 1992 per realizzare il sogno di un viaggio in Mongolia, da Venezia
1 novembre 2007
a Ulan Bator sulle antiche rotte commerciali, è un grande esperto del paese. «È una
società fluida, capace di cogliere la ricchezza della diversità. I nomadi si accolgono, si
mescolano, sapendo che si separeranno di
nuovo. In un campo, la famiglia del leader
si identifica dalla posizione della tenda. I
nuovi arrivati si posizionano in base al ruolo dell’antenato comune. Ci sono genealogie remote che resistono in questo modo.
Nel 1996 sono arrivato tra gli uomini-ren-
na delle montagne della Taiga, ai confini
con la Repubblica di Tuva: un gruppo di
186 persone chiamato tsaatan. C’era
un’epidemia di brucellosi. Ho allertato gli
organismi internazionali. Dopo un anno,
nessuno aveva mosso un dito. E la popolazione era allo stremo: la brucellosi si era
estesa alle persone. Così è nato il progetto
Sos Taiganà. Oggi quel gruppo conta 300
individui». La più grande lezione? «L’ho
avuta da un anziano che mi raccontava
13
In senso orario: tende
mongole a Bayan-Olgii;
tiro con l’arco a
Naadam, in Mongolia;
una donna nella Valle
dell’Orco. In basso:
Marino Niola
dei suoi antenati, fino a dieci
generazioni prima. Ricordava
persino i nomi dei cavalli. A un
certo punto mi mi ha chiesto
dei miei antenati. “Ho una
nonna”, gli ho risposto. Allora lui ha ripetuto la domanda.
Io ho chiesto di spiegargli che
mi era impossibile dirgli di
più. “Come pretendi di sapere
dove andare se non sai da dove vieni?”, mi ha detto il mongolo. Ho chiuso la Moleskine.
E non ho più preso appunti».
Foto: Eyedea - Contrasto (3), G. La Malfa - Team / G. Neri
Duccio Canestrini
In Duccio Canestrini la passione per l’antropologia era scritta nei geni: discendente
da un Giovanni Canestrini che nel 1859
tradusse “L’origine delle specie” di Darwin. Ma l’episodio che gli ha svelato la
strada è ancora impresso nella mente:
«Erano i primi anni Ottanta, mi trovavo a
Canaima, in Venezuela. Conversavo con
un indio, che mi raccontava di creature soprannaturali. A certo punto arrivò un
gruppo di turisti. Il ragazzo entrò nella capanna, si tolse i jeans, indossò un perizoma e si mise in posa con un arco in mano.
Tutti scattarono foto, gli diedero delle monete, risalirono sul pullman e se ne andarono. Io assistevo allibito: era una messa in
scena di antropologia pura. In quel momento pensai che la vera tribù da studiare
era la mia». Nasce così l’interesse di Canestrini per l’homo turisticus: con la mobilità eletta al fatto antropologicamente più
interessante della contemporaneità. Poi i
progetti a favore delle popolazioni colpite
dallo tsunami. Viaggi in Afganistan. E l’attenzione per la maschilità: microritualità
contemporanea, dai riti dei masai agli addii al celibato. «Essere messi
alla prova è una sensazione
bellissima». Esempi estremi? «Ritrovarmi nel golL’espresso 1 novembre 2007
Professione Antropologo L’ESPRESSO UOMO
La lezione di
Gengis Khan?
Trasparenza tra
ciò che si dice
e ciò che si pensa
Gli altri siamo noi DI MARINO NIOLA*
I generali vanno a scuola dall’antropologo.
La scienza dell’uomo è l’ultima arma
dell’esercito americano nella lotta
al terrorismo in Afghanistan e in Iraq.
Più comprensione degli usi e costumi
locali, meno azioni di guerra. È questa la
filosofia ispiratrice della nuova strategia
della conoscenza che sta già dando
i primi risultati. Una diminuzione
degli scontri del 60 per cento, dicono
al Pentagono. In realtà entrare nella
cultura dell’altro, nemico o amico che sia,
imparare a mettersi dal suo punto di vista
è il più antico antidoto contro il conflitto.
Ed è la ragion d’essere dell’antropologia.
Che nasce come indagine sulle culture
diverse dalla nostra. Su ciò che ci
rende eguali in quanto umani e tuttavia
diversi in quanto appartenenti a
questa o quella cultura. Tutti parenti
e tutti differenti. Primitivi e civilizzati.
La scienza dell’uomo è figlia primogenita
delle esplorazioni geografiche
e del colonialismo. Non a caso sono
l’Inghilterra, la Francia, l’Olanda
i maggiori protagonisti della prima
grande stagione dell’antropologia iniziata
nell’800. Mentre le potenze coloniali
studiano gli altri
nei loro domini
lontani, paesi come
gli Usa e l’Italia
la differenza ce
l’hanno in casa. Se
i mohicani, i sioux,
gli apache fanno grande l’antropologia
americana, sono le culture popolari,
contadine e urbane, l’oggetto di quella
italiana. In realtà l’antropologia ha due
anime. Da una parte scienza al servizio
delle politiche sociali. Dall’altra coscienza
critica dell’Occidente, dei vizi e della sua
pretesa superiorità. Ora come allora, a
fare l’antropologia non è l’oggetto, ma un
certo modo di vedere, una sensibilità alla
differenza che consente di scoprire negli
altri ciò che è più difficile vedere in noi.
Uno sguardo da lontano, l’ha definita
Claude Lévi-Strauss. Oggi lo scenario
è mutato e l’antropologia ne riflette le
trasformazioni. I selvaggi sono scomparsi.
Eppure le differenze continuano
a prodursi, ma all’interno del nostro
mondo. Niente più paradisi esotici
o inferni tropicali. Oggi gli altri sono
fra noi. Abitiamo un pianeta affollato
e comunicante, mobile e flessibile.
Apparentemente diventiamo tutti uguali.
Ma sul piano dei consumi. Perché ogni
società interpreta l’occidentalizzazione
a suo modo. Così nascono nuove culture
ibride, inediti arcipelaghi glocal.
Usi e costumi del cittadino globale,
miti e riti della postmodernità.
Un mondo da scoprire. Il nuovo terreno
per gli esploratori del presente.
*docente di Antropologia culturale
all’Istituto universitario Suor Orsola
Benincasa di Napoli, esperto di miti
e immaginari metropolitani
UOMO L’ESPRESSO Professione Antropologo
ANCHE IL CANNIBALE HA UNA CULTURA
COLLOQUIO CON MARSHALL SAHLINS DI MARINO NIOLA
L’antropologia è analisi delle
diversità. L’occidentalizzazione
del mondo farà svanire l’oggetto
stesso della sua indagine?
«Trent’anni fa i miei professori
dicevano che, venendo meno le
differenze tra le culture, manca
l’oggetto dell’antropologia. I loro
professori lo dicevano a loro volta
e fra trent’anni si dirà ancora».
Un lamento di corporazione.
«In parte. Non si comprende che
la trasformazione ha continuità.
Le culture cambiano, ma
ciascuna in una logica propria».
Ogni società ha un suo cammino
verso l’occidentalizzazione?
«Certo. Pensiamo al Giappone,
ma anche a piccole società
oceaniche. Paradossalmente
la tradizione è proprio un modo
per cambiare, per adattarsi.
L’innovazione ha una sorta di
stabilità: è storica e strutturale».
Qual è, allora, il compito
dell’antropologia oggi?
«Studiare le forme tradizionali
in rapporto alle trasformazioni».
Lei considera l’antropologia una
scienza o un’interpretazione?
Mi piazzai alle spalle: il risultato fu
una polifonia di narrazioni». Anche
questo è un antropologo: «Uno che
sceglie dove posizionarsi».
Alberto Salza
delli di carne da ogni osso.
Si dipinge con l’urukum,
che dà un rosso vivo. I parenti si graffiano fino a bagnare le ossa del loro stesso
sangue. Nel teschio vengono poi collocate piume di
arara, che richiamano la
condizione del bambino
ma anche il pappagallo che
si ritiene fondatore della loro cultura. Così
la morte viene reinserita in un ciclo che si ricollega alle origini. Il rito dura tre notti e
quattro giorni. Durante i quali una persona canta al suono delle maracas. Traendo
energia dai borori morti di tutti i tempi». La
sfida è ora quella di applicare le tecnologie
digitali allo studio dell’uomo. «Sempre più
spesso le popolazioni
tribali filmano se stesse. Affidargli la telecamera aiuta a penetrare
nella loro mentalità.
Sette anni fa filmavo
un rito. Notai che
c’erano degli xavante
che facevano lo stesso.
Soli su un’isola
dove tutti sono
ubriachi. O
in Micronesia.
Da un oracolo
inquietante
come la Pitia
fo di Darien, a Panama, su un isolotto in cui
tutti, vecchi e bambini compresi, erano
ubriachi. Per giorni avevano bevuto una bevanda ottenuta dal mais fermentato che le
vecchie sputavano in un pentolone».
Massimo Canevacci
«Contro le previsioni di Lévi-Strauss nei
suoi “Tristi tropici”, i bororo non sono
scomparsi». Massimo Canevacci è docente
di Antropologia culturale alla facoltà di
Scienze della Sapienza di Roma. Lavora
con le popolazioni indigene del Mato Grosso, xavante e guaranì. Il suo ultimo libro
“La linea di polvere” (Meltemi) è dedicato
a un complesso rituale: il funerale bororo.
«Quando una persona muore il cadavere è
ricoperto da polvere e foglie. E innaffiato
continuamente. Dopo 20 giorni viene esumato. Si pulisce il cranio, si tolgono i bran16
Insegnava all’università, Alberto
Salza, a Torino. Ma non ha resistito.
E ha cominciato a camminare: chilometri e chilometri in Africa, mescolandosi tra i locali. Tra i boscimani
del Botswana ha simulato la vita degli antenati: «Mangiavamo bacche.
Carni secche. Erbe. Percorrevamo
ogni giorno almeno 20 chilometri a
piedi. Alla fine eravamo in ottima salute, e avevamo sviluppato difese altissime. Quell’esperimento dimostrò
che in condizioni di vita miserabili
non c’è spazio solo per la sopravvivenza, ma anche un ricchissimo tempo sociale». Da 30 anni frequenta la
regione del lago Turkana. «Sto lavorando alla pacificazione tra i Samburu del Kenya, tribù antichissima dove si consuma una violenza che ricorda il Rwanda. Situazioni di pericolo?
«Solo una volta, era il Natale del
1971, mi trovavo in una zona dell’attuale Benin con mia moglie e amici. Avevamo comprato due gemelli di legno, piccole sculture che avevamo lasciato in macchina. E ci eravamo uniti ai festeggiamenti dei locali. A un certo punto li vediamo
imbracciare bastoni e minacciarci, indicando i due gemelli abbandonati, che nella loro tradizione sono antenati da trattare con cura. Sospettavano che li avessimo
rubati. Ho sussurrato a mia moglie di fingersi incinta. Così la situazione è cambiata». Salza studia oggi la miseria estrema
negli slum delle megalopoli. «Dove l’incertezza è assoluta e la sopravvivenza
istantanea. La miseria provoca una speciazione, una derubricazione a un’altra
condizione esistenziale. Col tempo porterà anche mutamenti genetici». n
«Non una scienza come
quelle naturali. In antropologia
la relazione ha luogo
tra un soggetto e un altro
soggetto. Per Lévi-Strauss
si va da oggetti singolari verso
significati familiari. Esempio:
il cannibalismo delle Figi
dall’esterno è repellente.
Ma se considero che i capi
figiani offrono vittime da
mangiare a quelli che hanno
dato loro donne da sposare,
vedo una logica di scambio.
Il caso aberrante è ricondotto
in un sistema coerente.
Si giunge a una comprensione
altrimenti impossibile».
E si comprende l’altro?
«No, perché più conosciamo
l’oggetto e più esso si allontana.
È la differenza tra le scienze in
senso proprio e l’antropologia».
A destra: lavoratori del ferro
negli slum di Nairobi. Al centro:
l’antropologo Duccio Canestrini.
Sopra: Marshall Sahlins
della Chicago University
Foto: B. Cannarsa - G. Neri (2), L. Savino - Contrasto
Gli oggetti non sono cose ma
rappresentazioni, i cui significati
variano da un paese all’altro.
A lungo le scienze sociali sono
state vittime di un miraggio, che
faceva intravedere nello sviluppo
del capitalismo, cioè della nostra
storia, la fine delle altre culture.
Questa mistica del capitalismo
globale ha visto l’antropologia
assumere il ruolo di buona
coscienza lamentosa: ha
elaborato un lutto sulla morte
delle culture, sulla scomparsa
delle differenze, sulla
omologazione prodotta
dall’Occidente. È la tesi di
Marshall Sahlins, professore alla
Chicago University, autore di
“L’economia dell’età della pietra”
(Bompiani), “Cultura e utilità”,
(Bompiani), “Isole di storia”,
(Einaudi): il più noto antropologo
vivente dopo Lévi-Strauss.
È come se «l’Occidente avendo
materialmente invaso le vite
degli altri volesse ora negare loro
l’integrità culturale. Riducendo
gli altri a noi e noi allo
sviluppo: cioè al mercato».