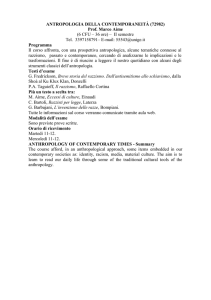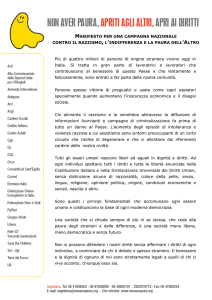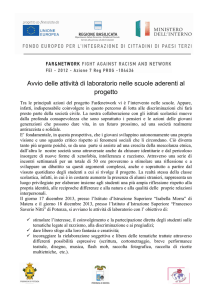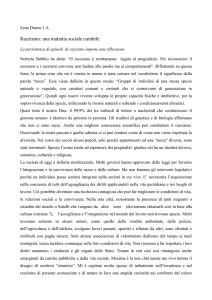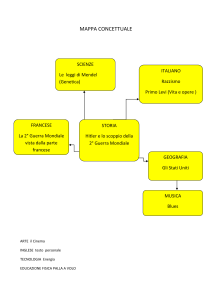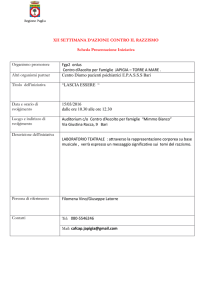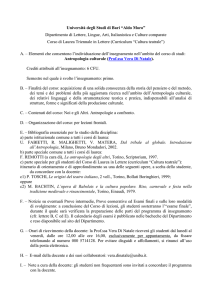ACHAB
Rivista di Antropologia
2004 numero III
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Editoriale
Con questo terzo numero festeggiamo il primo anno di Achab e ci proiettiamo in una nuova stagione
che promettiamo essere ricca di nuovi spunti di riflessione, incontri ed attività: il "viaggio" di Achab
continua e ci auguriamo, come per la stagione passata, di coinvolgere il maggior numero possibile
di lettori.
Achab è un progetto che mira a raccogliere la sfida (culturale ed intellettuale) di una
contemporaneità sempre più complessa e che, proprio per questo motivo, necessita della collaborazione
e della commistione di prospettive ed entusiasmi diversi. In questo senso vogliamo continuare ad
offrire il nostro contributo proponendo temi di discussione, riflessioni e approfondimenti che siano
espressione di un profondo desiderio di conoscenza e condivisione.
Partecipiamo, dunque, alla negoziazione di significati che dà luogo alle forme del sapere
contemporaneo consapevoli del fatto che "l'importanza della produzione di senso per la vita umana è
riflessa in un campo concettuale affollato: idee, significato, informazione, saggezza, capacità di
comprendere, intelligenza, consapevolezza, capacità di apprendere, fantasia, opinione, conoscenza,
credenze, mito, tradizione…" [Ulf Hannerz "La complessità culturale" p. 5]. .
La Redazione
Achab - Rivista di Antropologia dell'Università di Milano-Bicocca - Anno I , Numero III
Redazione: Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi, William Pioltelli
Impaginazione: Amanda Ronzoni
Grafica copertina: Lorenzo D'Angelo
Responsabile del sito: Antonio De Lauri
Tiratura: 600 copie
Se desiderate collaborare al progetto della rivista con vostri lavori o commentare gli articoli, potete scrivere a:
[email protected] oppure [email protected]
La rivista è disponibile anche in formato pdf sul sito: www.studentibicocca.it/achab
Indice
Zygmunt Bauman: riflessioni a partire dai suoi testi
di Daniela Carosio
pag. 2
riflessioni sul concetto di cultura
di Ugo Fabietti
pag. 9
Il razzismo
di Antonio De Lauri
pag. 14
Il Quilombo di Frechal
di Michele Parodi
pag. 22
La coltivazione di papavero da oppio dilaga in
Afghanistan
di Elisa Giunchi
pag. 37
Sincretismi, ibridazioni e compresenze
tra tradizioneindù e mussulmane in India
di Giulia Bellentani
pag. 38
Luti e Liwat
di William Pioltelli
pag. 54
La Società dell'Incertezza e Voglia di Comunità
Da idoli della tribù a idolo del foro:
Una recensione riflessiva di un'etnografia dialogica:
Alla confluenza di due oceani
Achab segnala: Seminario sull’Africa
pag. 63
1
Zygmunt Bauman: riflessioni a partire dai suoi testi
La Società dell'Incertezza e Voglia di Comunità
di Daniela Carosio1
Il presente articolo riflette sui temi dell'identità e dell'incertezza,
che Bauman tratta in La Società dell'Incertezza, Il Mulino, 1999
('SI') e ciò che rappresenta il loro contrappeso, ossia , il desiderio
crescente di comunità, che Bauman descrive in Voglia di
Comunità, Laterza, 2001 ('VC'), come reazione al vuoto che
emerge dai percorsi identitari moderno e post-moderno.
In Bauman il testo scientifico stesso fluisce come formazione
discorsiva nel raccontarci il nostro mondo contemporaneo2. Ma
è il mondo stesso che nell'interpretazione post-moderna emerge
come complessa interrelazione di "processi locali in continua
lotta e negoziazione sui significati, valori e risorse…siamo tutti
architetti della 'modernità' e cannibali dell'ordine sociale3".
Bauman stesso afferma pessimisticamente che "mancano gli
strumenti concettuali per risistemare un quadro contorto e
frammentato, per immaginare un modello coerente e integrato
che emerga da una esperienza confusa e incoerente, per legare e
tenere insieme gli elementi disseminati" (pag. 12 SI). Si avverte
nei suoi testi non tanto la "Sehnsucht" della felicità di un mondo
più sicuro , quanto, piuttosto, l'affermazione di un principio di
realtà, che tiene conto della società e in particolare dell'Altro,
contro il prevalente principio del piacere, quello del collezionista
dei piaceri che dimentica l'alterità o la trova al massimo
interessante per i propri fini individualistici. Ne risulta un
profondo senso etico e civile nell' 'intelligere' la realtà e nel
sottolineare la responsabilità di ciascuno di noi.
Per Bauman, infine, la responsabilità passa dal principio di
realtà e non da quello del piacere e "assumersi la responsabilità
verso l'alterità, l'identità e l'autonomia dell'Altro è una
condizione cruciale per la realizzazione di ogni individuo ed è
una parte indispensabile di ogni autentica 'pragmatica dello
scambio' (pag. 125 SI)".
pulsioni e dell'istinto. L'epoca moderna, positivista e utilitarista,
che aveva massima fiducia nelle capacità della scienza e della
ragione, nemica di ogni processo di degenerazione (fisico,
sociale, morale) ha sacrificato il principio del piacere (libertà) in
nome del principio di realtà (sicurezza), tuttavia, come
ammonisce Freud, "forse è bene abituarsi a pensare che ci sono
alcune difficoltà intrinseche alla natura della civiltà in grado di
resistere a qualsiasi tentativo di intervento".
Qualcosa di simile è avvenuto nell'incontro coloniale con i c.d.
paesi non civilizzati e poi con il mito dello sviluppo del Terzo
Mondo, in realtà si è giustificato l'intervento civilizzante delle
potenze coloniali prima e quello pianificante della cooperazione
allo sviluppo dell'Occidente poi, al fine di portare la civiltà e lo
sviluppo ai c.d. popoli nativi o selvaggi. Il prezzo è stato lo
stravolgimento delle società tradizionali, delle loro
rappresentazioni, tradizioni e amministrazioni e la nascita di
fenomeni di resistenza locali o movimenti identitari (come i
movimenti messianici, i profetismi, nuove forme di feticismi delle
merci in Sud America, i riti del cargo in Oceania, ecc.).
In "Voglia di comunità" Bauman chiarisce come la comunità, la
Gemeinschaft, intesa come reciproca comprensione di tutti i suoi
membri in contrapposizione alla nascente società moderna, la
Gesellschaft5 , una volta distrutta, non può essere più ricostruita
artificialmente, come hanno cercato di fare vari filantropi o teorici
illuminati dell'organizzazione industriale sulla scia di Elton
Mayo, "scuola dei rapporti umani" (pag. 36 VC), inutili tentativi
di 'reimpiantare gli sradicati' (disembedded).
In epoca moderna "il regime della 'regolamentazione', di cui
fabbrica ed esercito erano i principali strumenti e modelli
istituzionali, sostituisce l'originaria paura moderna dell'incertezza
con la paura della trasgressione delle norme, il timore della
devianza e delle sanzioni derivanti (pag. 107 SI)". L'epoca
moderna era quella dell'uomo produttore, della fabbrica e della
caserma, del panopticon6 e delle altre istituzioni totali (la scuola,
l'ospedale, la caserma, il carcere, il manicomio, ecc.). L'epoca dei
popoli nazione, della costruzione delle identità nazionali,
attraverso la creazione dei confini e dell'allontanamento dello
straniero. L'epoca dell'ingegneria sociale delle fabbriche e della
vita organizzata, della biotecnologia, della medicina e dello studio
sistematico volto a confinare l'ultimo dei nemici, la morte. Così la
salute pubblica diventò prioritaria e ben delineata secondo confini
specifici. In quell'epoca lo straniero e il vagabondo erano delle
figure devianti, che procuravano incertezza perché sfuggivano al
controllo della società. In particolare, lo straniero, non avendo
una collocazione precisa ed essendo cognitivamente ambivalente,
incrinava la chiarezza delle divisioni, delle classificazioni e dei
confini ed ostacolava la realizzazione dei compiti dello Stato
La Società dell'incertezza
Bauman definisce la società contemporanea o "post-moderna"
come "la società dell'incertezza", quella stessa incertezza il cui
spettro era stato esorcizzato nell'epoca moderna attraverso una
rigida regolamentazione. Se la modernità emerge come una
risposta non scelta e non voluta al crollo dell'ancien regime, il
post-moderno emerge come "effetto non desiderato" o paradosso
della modernità, risultato dello svuotamento progressivo dei
valori, rappresentazioni e istituzioni dell'epoca moderna, che
ossessionata dal terrore dell'incertezza aveva prodotto un
"eccesso di ordine" e regolamentazione al prezzo della restrizione
della libertà. In questo senso Bauman richiama esplicitamente S.
Freud, che in "Das Unbehagen in der Kultur" del 1929 sottolinea
come la modernità e la civiltà, fondandosi sulle categorie di
bellezza, pulizia e ordine, siano costruite sulla restrizione delle
2
moderno. Nei suoi confronti venivano intraprese due tipi di
strategie da parte dello Stato e della società: una antropofagica o
di assimilazione , consistente nell'eliminare le distinzioni e
diversità e assimilare completamente gli stranieri rendendoli una
copia di sé e la seconda antropoemica o di esclusione, consistente
nel confinare e ghettizzare gli stranieri, fino alla loro eliminazione
fisica nella sua forma più estrema (olocausto).
Se la modernità fin dall'inizio si è connotata per un eccesso di
mezzi rispetto ai fini, nel nostro tempo postmoderno, i mezzi sono
gli unici strumenti di potere rimasti sul campo ormai abbandonato
dai fini. L'epoca postmoderna si porta dietro la crisi delle
istituzioni e la loro privatizzazione, lo smantellamento dei sistemi
di Welfare e la 'deregulation' in ogni ambito dell'economia e della
società. Nell'epoca moderna la responsabilità sociale era
demandata allo Stato, alle burocrazie e alle varie istituzioni c.d.
responsabili. Ma quella responsabilità era una responsabilità di
funzione o di finzione, in Modernità e Olocausto, Bauman parla
di burocratica "legge di nessuno", che consente di commettere i
più terribili misfatti in nome dell'ingranaggio e della macchina
moderna. Questa tendenza a dispensare gran parte delle azioni dal
giudizio morale e addirittura dal significato morale, cresce come
indifferenza morale o "adiaforizzazione"7 in epoca post-moderna.
Nelle strategie di vita postmoderna, l'Altro è oggetto di
valutazione estetica e non morale. Il risultato è una crescente
distanza tra l'individuo e l'Altro, con un prevalere dell'autonomia
individuale sulle responsabilità morali8, un prevalere delle
relazioni tattili, con la separazione del valore d'uso/piacere da
ogni impegno e coinvolgimento che riguardi amore, onore,
obbedienza…è la completa adiaforizzazione (mediata dagli
snapshot e dalla burocrazia moderna). Nel mondo globalizzato la
nuova élite cosmopolita economica e intellettuale vive una
condizione di massima libertà in un'area priva di comunità e
lontano dalla vischiosità che minaccia la gran parte degli abitanti
del mondo, i deboli, gli individui de iure, ma non individui de
facto. Si tratta di un mondo dai confini sempre più confusi, con
mappe di potere sempre più contorte e aggrovigliate, dai confini
indefiniti (blurred). I centri urbani che erano stati pianificati in età
moderna a griglia o accampamento romano come proiezioni sul
paesaggio della razionalità ordinata e classificatoria, sono oggi
disseminati di aree ghetto "no go area" con valenza duplice…"no
go in" e "no go out"9. Il rapporto con lo straniero nella società
postmoderna è ambivalente10 , da un lato c'è chi gode di maggiore
libertà e minore incertezza o vischiosità e trova lo straniero
interessante ed esotico, dall'altro ci sono invece coloro che hanno
poche risorse e capacità e vedono nello straniero una minaccia.
Per interpretare l'ambiguità con la quale viene affrontata la figura
dello straniero nella società postmoderna si può utilizzare
l'immagine di una retta dove su di un polo viene riportata la
massima precarietà economica e dall'altro la massima possibilità
di scelta, accompagnata da una bassa paura dell'inadeguatezza.
Mentre tra coloro che hanno ampie possibilità prevale la curiosità
per lo straniero, portatore di qualcosa di diverso, di una identità
altra e per questo interessante. Lo straniero viene percepito come
un concorrente dove alta è la precarietà e la paura di
inadeguatezza. Qui lo straniero è colui che porta via il lavoro, che
disgrega ulteriormente ciò che è già disgregato e degradato, colui
che incarna tutte le paure derivanti dalla massima incertezza e
ancora una volta il responsabile di tutti i mali. Si innesca dunque
una guerra tra poveri. Si teme lo straniero perché è anche colui
che non ha i nostri schemi mentali. "La vischiosità che
attribuiscono agli stranieri è il riflesso della loro mancanza di
potere che cristallizza nei loro occhi la terrificante forza degli
stranieri" (pag. 71 SI). Bauman in sostanza ci dà una
interpretazione del razzismo dei poveri e dei deboli, di coloro che
si sentono inadeguati e denuncia come questa debolezza possa
venire facilmente strumentalizzata per scopi demagogici. "La
paura del 'vischioso' sedimentata dagli individui senza potere, è
sempre un'arma allettante da aggiungere all'arsenale di coloro che
hanno sete di potere…per arruolare i senza potere al servizio degli
abili di potere. Occorre solo ricordare loro la vischiosità degli
stranieri…" (pag. 72 SI).
L'identità come problema: dal moderno al postmoderno
Bauman definisce l'identità postmoderna una nozione
ambivalente. Parla di identità "riciclata"11 , in quanto continua
ricostruzione e ridefinizione del sé, gioco liberamente scelto e
presentazione teatrale del sé (Goffman). Come emerge
chiaramente in Voglia di Comunità, la comunità rappresenta
l'humus da cui viene estratta la nozione di identità. La ricerca
dell'identità, come sradicamento (disembedding), uscire dal
mazzo, essere diversi e in quanto tale unici, non può che dividere
e separare, smembrare la comunità. Il paradosso è che per potere
fornire un modesto livello di sicurezza, l'identità deve tradire la
propria origine e negare di essere un surrogato, deve evocare un
fantasma di comunità identica a quella che va a sostituire. Ed è
infatti paradossale, che nel momento in cui la comunità crolla
viene inventata la nozione di identità (pag. 16 VC). Significativo
è che, nonostante ciò, entrambi i termini vengano oggi evocati in
modo ossessivo. "Mai il termine 'comunità' è stato usato in modo
tanto insensato e indiscriminato come nei decenni in cui le
comunità in senso sociologico del termine sono diventate sempre
più difficili da trovare nella vita reale"12. E ancora Bauman: "Oggi
si sente parlare di identità e di problemi connessi più di quanto se
ne sia parlato nei tempi moderni. E nonostante ciò, ci si può
chiedere se l'ossessione del momento non sia semplicemente un
altro di quei casi che seguono la regola generale secondo la quale
le cose si scoprono soltanto ex post facto, quando svaniscono,
falliscono o cadono a pezzi (pag. 27 SI)".
Per chiarire la specificità dell'analisi di Bauman può essere utile
riprendere la sintesi di Loredana Sciolla13 dei vari contributi del
pensiero sociologico sul tema dell'identità. Sciolla evidenzia una
convergenza dei vari approcci su tre dimensioni fondanti
l'identità: la dimensione locativa (ossia il campo, anche
simbolico, che delimita i confini del sé), quella selettiva (ossia il
sistema d'ordine tra più alternative all'interno dei confini
delineati) e quella integrativa (il quadro interpretativo che collega
3
le esperienze passate, presenti e future nell'unità di una biografia.
Da questa impostazione derivano due considerazioni
fondamentali, ossia la funzione conoscitiva dell'identità, in quanto
percezione e organizzazione del campo delle possibilità, e la
funzione normativa, in quanto fornisce le "mappa" di significato
per l'azione e l'interazione sociale e rappresenta il criterio chiave
per comprendere i processi decisionali degli individui. Inoltre,
una distinzione fondamentale è quella tra identità individuale
(identità come predicato di un soggetto individuale) e identità
collettiva (identità come predicato di gruppi di individui). La
riflessione contemporanea privilegia un'analisi dell'identità non
come persistenza dell'unità del soggetto al variare degli attributi
(definizione filosofica aristotelica), ma come insieme di relazioni
e di rappresentazioni e sottolinea la crescente importanza
dell'elemento simbolico e culturale 14 nella dimensione locativa e
dei c.d. confini simbolici. L'attenzione viene data agli aspetti di
complessità, alle modalità imprevedibili e sempre in ridefinizione
in cui l'organizzazione e l'interazione sociale influenzano le
mappe di significato degli individui 15 (fenomeni di ibridazione e
meticciato).
Bauman, pur avendo presenti nella sua analisi tutti questi aspetti,
ci dà una visione quasi mitico-simbolica del processo identitario
dal moderno al postmoderno, e parte da uno sguardo molto esteso
che si avvale di diverse chiavi interpretative, anche mutuate dalla
psicanalisi16 e dalla letteratura, per leggere il disagio diffuso, a
livello sociale e individuale, attraverso i microeventi della
quotidianità, le mode, da quella della cura del corpo a quella delle
diete alimentari o dei viaggi, il mondo delle relazioni occasionali
e del sesso plastico, della fuga dai sentimenti e del divorzio facile,
il mondo segregato degli emarginati con tutta la carica esplosiva
di violenza e di frustrazioni che coltiva in sé.
La dinamica identitaria nella società
postmoderna: da pellegrino a turista
moderna
(pag. 28 SI)" e quindi la preoccupazione per l'identità rappresenta
un tentativo di sfuggire a questa incertezza. Diviene compito
dell'individuo trovare una via di uscita dall'incertezza. L'identità
diventa una proiezione critica di ciò che è richiesto da e/o si cerca
in ciò che esiste. "E' un'asserzione obliqua dell'inadeguatezza o
incompletezza" e giustifica il formarsi di una pletora di
consulenti, allenatori, guide, insegnanti…tutti interessati ad
affermare una conoscenza superiore tale da guidare e consigliare
'in loco parentis '.
Per descrivere questo compito dell'uomo moderno Bauman
utilizza la suggestive metafora del pellegrino. Il pellegrino non è
una figura moderna, bensì dei primi tempi del cristianesimo,
eppure incarna la strategia di vita moderna, preoccupata dal
compito inquietante di costruire una identità, perché la verità è
altrove. "La cultura giudaico cristiana riguarda, alle sue vere
radici, esperienze di dislocazione spirituale e vagabondaggio"18. I
grandi monoteismi nascono da culture nomadi con l'esperienza
del deserto. Il deserto è la terra dell'autocreazione, contrapposta ai
legami della quotidianità mondana, ricca di posti, di regole e
tradizioni. Gli eremiti sono sgravati e sradicati (disembedded),
simili a Dio perché qualunque cosa facciano la fanno ab nihilo19.
Attraverso la metafora del pellegrino c'è un richiamo esplicito a
L'Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo di Max Weber.
Bauman stesso definisce il protestante, come la figura modello
dell'uomo moderno. Infatti, i protestanti sono divenuti pellegrini
all'interno del mondo, assumendo la vita-intramondana come
compito e il dovere professionale come strumento per ottenere la
salvezza dell'anima. Il mondo è stato trasformato in un deserto,
senza posti, senza tentazioni seducenti. Impersonalità, freddezza e
vuoto sono assurte a virtù, nel tentativo di combattere le
tentazioni del mondo e di rendere il mondo esterno insignificante
e privo di valore.
Bauman afferma con una frase emblematica che richiama
l'interpretazione di Max Weber20 che "i pellegrini hanno perso la
loro battaglia vincendola!". Ovvero, i protestanti nel ridurre il
mondo ad un deserto, ad un luogo ventoso21, dove è difficile
lasciare traccia, hanno perso la loro battaglia spirituale. Se prima
il pellegrino e il deserto in cui camminava acquistavano
significato l'uno dall'altro. Ora, in un mondo in cui il deserto è
fuori dalla casa, ante portas, il pellegrinaggio non è più una scelta
eroica o santa, ma una necessità per evitare di perdersi nel deserto
e questa versione moderna del compito o pellegrinaggio si è a
poco a poco trasformata in un vagabondare senza meta, ossia il
fine ultimo che dà significato al pellegrinaggio. Infatti, è la
distanza che permette ai progetti di esistere, le coordinate spaziotemporali sono i vettori del senso e dell'identità. In termini
oggettivi la distanza è spazio; in termini soggettivi è
insoddisfazione, ossia quella differenza tra piacere agognato e
quello ottenuto, lo iato tra l'ideale dell'ego e la realtà presente. La
fede stessa richiede un salto nel vuoto22. La distanza misurata in
termini di tempo consente di costruire e dare significato
all'identità. Dà forma alla gratificazione differita che traccia
l'inizio dello sviluppo personale e della costruzione identitaria. Il
e
Bauman afferma che l'identità è un'invenzione moderna, perché è
il risultato senza peso e consistenza dello sradicamento
("disembedding"17 ) del singolo dalla comunità che lo teneva in
una sorta di humus comune. L'identità è nata come un problema
(anche questa parola è utile intenderla etimologicamente, dal
greco 'gettare in avanti'), nel senso di questione cui dare una
soluzione, che si origina da quella sottodeterminazione o libero
fluttuare risultante dallo sradicamento. Ha lo statuto ontologico di
un progetto e contiene in sé una idea di futuro. Nella società degli
sradicati, la società del XIX secolo, quella della Grande
Trasformazione (Polanyi), della distruzione della comunità, "di
quella intricata rete di interazioni umane che dava un senso al
lavoro dell'uomo, che trasformava la mera fatica in attività
lavorativa densa di significato, in un'azione finalizzata (pag. 29
VC)", l'identità entra nella pratica moderna come "compito"
individuale o un "problema" cui dare una soluzione. "Si pensa
all'identità quando non si è sicuri della propria appartenenza,
quando non si sa come inserirsi nella varietà di stili e moduli
comportamentali esistenti, di come le persone intorno ci accettino
4
differimento della gratificazione (nonostante la frustrazione
momentanea) fornisce lo stimolo alla costruzione dell'identità se
esiste la fede nella linearità e cumulatività del tempo e la fiducia
che il futuro ripaghi i risparmi con gli interessi! Senza questa
fiducia non ci potrebbe neanche ipotizzare l'attività economica e
un mercato.
'riconfezionando' a misura di vagabondo.
Il turista è come il vagabondo in movimento, ma differisce la
direzione dello stimolo al movimento. Il vagabondo è per lo più
cacciato via. Il turista è invece attratto da esperienze di novità e di
differenza. Cerca un mondo strutturato su criteri estetici, un
mondo dove anche l'avventura sia dosata, addomesticata e sicura.
Il turista ha una casa ovunque vada. Il vagabondo è un senza tetto.
La casa del turista è percepita in modo ambivalente come rifugio
o prigione, a seconda del momento. Si sente stretto a casa, ma ne
sente la nostalgia in viaggio.
Il giocatore vive in un mondo soffice ed elusivo; ogni partita è
una "provincia di significato" per sé. Non deve lasciare
conseguenze durevoli, eppure il gioco deve essere senza pietà.
Simile alla guerra….la guerra come gioco assolve gli individui
dalla mancanza di scrupoli. Ironicamente …"il segno della
maturità postmoderna è la volontà di abbracciare il gioco a cuore
aperto, come fanno i bambini!" (pag. 48 SI) .
Nel mondo post-moderno tanto le persone che le cose hanno perso
solidità, definitezza e continuità. Il mondo fatto di oggetti duraturi
è stato sostituito da beni di consumo dalla rapida obsolescenza.
Una volta nascosto e non più vettore, il tempo non struttura più lo
spazio, ogni differimento, incluso il differimento della
gratificazione perde di significato. Il compito di oggi è quello di
evitare che una ogni fissazione duratura di identità ci si
appiccichi. La frammentazione del tempo e dello spazio e il loro
"collassamento"23 in epoca di società dell'informazione e di
globalizzazione hanno come riflesso rapporti umani frammentari
e discontinui, contrari alla costruzione di reti di doveri e obblighi
reciproci che siano permanenti. Nell'epoca postmoderna anche la
tensione morale assume connotati diversi, viene meno l'adesione
incondizionata a una morale a priori, ad una verità assoluta, nel
mondo dell'ambiguità e dell'incertezza dei singoli individui anche
la responsabilità e la visione etica fanno parte di una conquista
identitaria. Si cerca di evitare di impegnare la propria vita per una
vocazione o rapporti lunghi e duraturi, di evitare di sistemarsi e
legarsi alle persone e a un posto. Nell'età della 'razionalizzazione'
del posto di lavoro, del lavoro flessibile o interinale che ha
soppiantato il posto fisso, dell'amore confluente, della sessualità
plastica, è importante imparare a vivere alla giornata,
possibilmente dimenticare il futuro e isolare il presente da
entrambi i lati, separandolo dalla storia 24.
Identità e alterità in epoca postmoderna
In epoca postmoderna l'identità e il fenomeno identitario è molto
più ambiguo, segue percorsi molto frammentarie in continuo
divenire, non è data una volta per sempre ma è in continuo
formarsi, come nella metafora della matita dove la gomma
cancella contemporaneamente ciò che scrive sul foglio bianco. La
cosa più fastidiosa e pericolosa è oggi avere una identità
immutabile, perché c'è il rischio che diventi obsoleta, seguendo il
tasso di obsolescenza delle macchine e delle merci. Le stesse
istituzioni, un tempo intramontabili, tramontano lasciando dietro
una forte dose di incertezza e precarietà in tutti coloro che vi
hanno lavorato o che a distanza le hanno mitizzate (la crisi della
FIAT, l'insolvenza di primarie società americane come Enron,
WorldCom, la caduta degli eroi come il mitico Jack Welch, CEO
di General Electric). Nel postmoderno cambia anche l'elenco
delle paure. Horkheimer e Adorno individuano il nucleo centrale
delle angosce moderne nella paura del vuoto…tutto viene
ordinato, organizzato e costruito in modo da eliminare il vuoto,
sperimentata come paura di essere diversi e separati. La madre
delle paure postmoderne è, invece, l'inadeguatezza. "La mentalità
postmoderna si è allontanata dalle coordinate fornite dall'ideale di
una verità universalmente fondata e accettata; la nostra è una
mentalità insicura dei propri fondamenti, della propria
legittimazione e funzione. Un tipo di mentalità che può solo
suggerire comportamenti eccentrici, inconsueti, irregolari,
aggiungendosi al già ampio elenco delle incertezze" (pag. 140 SI).
Il flaneur, il vagabondo, il turista e il giocatore sono le metafore
utilizzate da Bauman per descrivere la strategia di vita
postmoderna.
Il flaneur è il "pittore della vita moderna" di Baudelaire
(Benjamin lo trasformò in simbolo della città moderna), colui che
vive la vita "come se", costruisce a piacimento delle storie con i
frammenti sfuggenti della vita degli altri. Il flaneur è il
consumatore di oggi, colui che si aggira nel regno sicuro ed
illusorio degli shopping malls, caratterizzati dalla episodicità e
apparenza degli incontri, dall'illusione di essere registi, pur
essendo oggetto di regia. I flaneurs sono gli abitanti delle città
pure e senza macchia, sorvegliate dalle videocamere, i
consumatori della TV assolutamente non impegnativa. Nella loro
vita la dipendenza si stempera nella libertà e la libertà va in cerca
della dipendenza.
Il vagabondo, figura non tollerata dalla modernità, perché senza
padroni e senza controllo, è un estraneo ovunque vada. Il suo
cammino è erratico a differenza di quello del pellegrino. Mentre
in passato il vagabondo vagava attraverso luoghi ordinati, oggi
sono pochi i luoghi ordinati e sistemati per sempre, ora il
vagabondo non è tale per la sua riluttanza o difficoltà a sistemarsi,
ma per la scarsità di luoghi organizzati, perché il mondo si sta
L'incertezza comporta costi individuali, sociali ed economici25
elevatissimi in quanto relativizza le mappe di significato, porta ad
una "crisi di intelligibilità" e ad una esperienza costante di
ambivalenza nelle rappresentazioni e nelle interazioni.
Nel relativismo dell'identità postmoderna, cambia l'alterità. Nella
città, il luogo rappresentativo della vita postmoderna, ciascuno di
noi è straniero quando esce di casa. L'alterità è data dalla distanza
5
tra le nostre mappe cognitive e quelle degli altri. La distanza tra
ciò che occorre per sapere navigare e ciò che si sa o si crede di
sapere circa i problemi reali e probabili del prossimo. Lo spazio
vuoto generato dalla separazione attrae e allo stesso tempo
respinge, è un territorio ambivalente di libertà e pericolo, che può
generare sia avventura eccitante sia confusione paralizzante.
La costruzione delle città ha rispecchiato i due poli opposti del
problema: nostalgia della communitas e paura di smarrire la
propria identità. La vita di città assume significati differenti per
persone differenti, così come l'immagine dello straniero, che
come Giano bifronte ha due facce: una sexy, promette
gratificazione senza chiedere alcun patto di lealtà (per il flaneur)
e l'altra misteriosa, ma in senso sinistro dello straniero ante
portas (per coloro che si trovano nelle 'no go out' areas e che
vivono sulla propria pelle un elevato grado di vischiosità) .
(quella che in economia viene definita la manutenzione
ordinaria). Perché per la costruzione di un'autostrada, la
razionalizzazione di una scuola o di un ospedale, ecc. si generano
costi straordinari, conflitti di interesse, che generano malcontenti
e rivendicazioni diffuse. Per lo più tali rivendicazioni non si
sommano o condensano, ma sono conflittuali le une con le altre e
competono le une con le altre per attirare le scarse risorse
dell'attenzione pubblica.
Conclusioni
Due accenni conclusivi a due temi che Bauman non tratta
esplicitamente in 'La società dell'incertezza': la figura dello
psicanalista e il ruolo dell'economia.
Un quadro desolante frutto di un'analisi attenta alle varie
sfumature del reale. Ma è sempre in nome del principio di realtà
che Bauman mette in guardia sulla necessità di trovare un
equilibrio tra libertà e sicurezza, tra identità e comunità; la
considerazione dell'Altro, ci porta nella sfera etica e solo una
relazione piena può essere morale.
In epoca post-moderna si è conquistata maggiore libertà al prezzo
di maggiore incertezza. Di fatto, va precisato che la maggiore
libertà è di pochi, ma al prezzo dell'incertezza di molti. Bauman
solleva esplicitamente il punto interrogativo di quanto godibile sia
questa libertà di pochi. Alla lunga tale maggiore libertà non sarà
godibile, perché "la libertà senza comunità diventa pazzia e la
comunità senza libertà diventa schiavitù". Come è allora possibile
sacrificare quel poco di libertà al fine di rendere il tormento
dell'incertezza tollerabile?
Bauman, pur parlando di Freud, non parla esplicitamente dello
psicanalista, ma tutto il discorso identitario lo dà per scontato. Il
successo della psicanalisi nelle nostre società postmoderne è una
ulteriore conferma della lettura sociale di Bauman. Lo
psicanalista è cercato per dare una risposta a questo sentimento di
ansia e inquietudine di fronte all'incertezza privatizzata, riportata
pesantemente sui singoli, dopo la fine della utopia moderna…si
tratta sicuramente di un lusso per chi se lo può permettere,
indicativo della privatizzazione della salute nella nostra
società…se sei ricco ti puoi permettere di stare male in più modi.
Se sei povero, no. E per il momento, nell'assenza di certezze e
sistemi di regolamentazione e riduzione dell'incertezza, anzi con
la sua crescita, dovuta allo smantellamento dei sistemi di Welfare
e al venire meno dei 'mediatori' tradizionali, come il sacerdote e il
rabbino nella cultura ebraica, lo psicanalista diventa un sostituto
privato a pagamento.
Bauman suggerisce in alcuni punti del suo testo che l'unica
risposta può venire dall'impegno morale e civile.
Nel nostro mondo l'Altro viene visto come oggetto di valutazione
estetica e non morale, di gusto e non responsabilità. Non sono gli
attributi dell'Altro ad essere oggetto della nostra attenzione, ma le
emozioni che ci suscita l'incontro, in termini di interesse e
piacere. Lo stesso atteggiamento che tiene il consumatore al
supermercato, passa in rassegna gli oggetti sugli scaffali e se non
lo soddisfano, passa oltre. E' chiaro che questa è una funzione
cognitiva fondamentale, quella di essere selettivi, ma diventa un
problema quando dalla sfera cognitiva si passa a quella
normativa.
Si cerca per lo più di evitare il coinvolgimento nel destino
dell'altro e di impegnarsi per il suo benessere. Tuttavia, il culto dei
rapporti personali e della sensualità rappresentano compensazioni
psicologiche per la solitudine che affligge i soggetti orientati dal
desiderio estetico e dal principio del piacere.
In tale sistema che ha assorbito tutto, persino la pratica militante
è stata assorbita da una pratica difensiva. L'unico dovere del
cittadino postmoderno è di condurre una vita piacevole e lo Stato
si deve preoccupare di fornirgli le risorse giudicate necessarie per
tale compito e non mettere in dubbio la fattibilità di tale compito
(fondamentale è il ruolo della macchina del consenso e in
particolare del capitalismo stampa, dei media). Non si tratta però
di un panorama idilliaco, in quanto lo scontento cresce quando
emergono questioni che vanno oltre la cura ordinaria del sé
L'economia si occupa dell'allocazione ottimale delle risorse,
queste ultime influenzano i mezzi e le capacità individuali,
nonché la possibilità di esercitare le libertà individuali,
nell'interazione con la natura e l'ambiente, da una parte e nella
produzione e scambio di contenuti simbolici dall'altro. Da una
parte, il potere si sta spostando sempre di più dalla mera
appropriazione delle risorse, al controllo delle condizioni di
riproduzione dell'identità collettiva e del consenso. Dall'altra
l'incertezza crescente del mondo sta minando alla base l'economia
che si fonda sulla certezza e la dimensione del futuro come
motore degli investimenti e dell'attività economica, nonché della
certezza e trasparenza degli scambi sul mercato. Fenomeni di
corruzione e mancanza di trasparenza minano alla base
l'economia di mercato, che da una parte non gradisce la
regolamentazione, dall'altra in assenza della stessa collassa su sé
stessa per le imperfezioni intrinseche al mercato (contrariamente
al mito della concorrenza perfetta e degli equilibri endogeni).
6
Nel mondo esiste sempre di più un sentimento diffuso di impegno
morale e civile (es. Fondo Sociale Mondiale di Porto Alegre che
si è svolto quest'anno per il secondo anno consecutivo in
contemporanea al World Economic Forum di Davos, in evidente
polemica con lo strapotere dell'ideologia economica nel nuovo
ordine mondiale), ma questo impegno deve emergere sempre di
più in quelle élites economiche e intellettuali che con il loro
isolamento meritocratico accrescono le situazioni di
sperequazione tra individui de iure e de facto. L'erigere comunità
fortificate rende più difficile ricomporre l'odierna guerra dei "noi
contro loro", lo "scontro delle civiltà" teorizzato da S.P.
Huntington e rende tutti bersagli più facili in balia
dell'insicurezza. La guerra del petrolio porterebbe solo ad un
inasprimento incontrollabile delle attuali tensioni.
In conclusione, ci auspichiamo con Bauman che il principio di
realtà porti ad una svolta del pensiero meritocratico verso un
crescente impegno etico e civile e che nel mondo globale, come
tra i Baruya della Nuova Guinea, le capacità e il merito
accrescano 'la responsabilità sociale e cosmica degli individui e
dei gruppi'26.
NOTE
Daniela Carosio ([email protected]) è un analista finanziario indipendente che ha approfondito tra l''altro i temi della Corporate
Governance e della Corporate Social Responsabilità, anche con attenzione agli aspetti culturali delle aziende.
2
Per chiarire meglio l'approccio di Bauman, mi sembra utile associarlo a quello di alcuni antropologi post-moderni, Fergusson, Hobart
e Escobar, influenzati dall'opera di Foucault, che affrontano gli oggetti di analisi in termini di formazione discorsiva. Così James
Fergusson nel descrivere il fallimento della politica di sviluppo in Lesotho "I sistemi di discorso e i sistemi di pensiero sono così legati
in una complessa relazione causale con il flusso di eventi pianificati e non pianificati che costituisce il mondo sociale. La sfida consiste
nel trattare questi sistemi di pensiero e di discorso come ogni altro tipo di pratica sociale strutturata, non scartandoli come effimeri e
neppure cercando nelle loro produzioni le chiavi di lettura per quegli elaborati e seminascosti meccanismi di produzione e riproduzione
strutturale in cui sono coinvolti come parti componenti." The anti-politics machine, Cambridge Univ. Press, 1990.
3
Alberto Arce and Norman Long, Consuming modernity, Anthropology, Development and Modernities: Exploring Discourses,
Counter-Tendencies and Violence, Routledge, London, 2000.
4
In quanto la felicità è effimera e non può essere il fine di una società, citando Freud, "ciò che chiamiamo felicità deriva dalla
soddisfazione di bisogni che sono stati accuratamente repressi e per sua natura è possibile solo in quanto fenomeno episodico".
5
F. Toennies, Gemeinschft und Gesellschaft, 1963.
6
"The Panopticon of Jeremy Bentham is an architectural figure which "incorporates a tower central to an annular building that is
divided into cells, each cell extending the entire thickness of the building to allow inner and outer windows. The occupants of the cells
. . . are thus backlit, isolated from one another by walls, and subject to scrutiny both collectively and individually by an observer in
the tower who remains unseen. Toward this end, Bentham envisioned not only venetian blinds on the tower observation ports but also
mazelike connections among tower rooms to avoid glints of light or noise that might betray the presence of an observer. The
Panopticon thus allows seeing without being seen. Such asymmetry of seeing-without-being-seen is, in fact, the very essence of power
for Foucault because ultimately, the power to dominate rests on the differential posession of knowledge. According to Foucault, the
new visibility or surveillance afforded by the Panopticon was of two types: The synoptic and the analytic. The Panopticon, in other
words, was designed to ensure a 'surveillance which would be both global and individualizing" (pag. 138 e 162). Barton, Ben F., and
Marthalee S. Barton. Modes of Power in Technical and Professional Visuals, 1993.
7
Da "adiaforia", ideale etico dei filosofi cinici e stoici, consistente nell'indifferenza verso le cose che non sono né virtù né vizio.
8
Vari antropologi hanno riscontrato come in varie comunità tradizionali il merito si accompagnasse alla responsabilità nei confronti
degli altri membri della comunità. E ciò si traducesse in una assenza di disuguaglianza economica, proprio perché le risorse
economiche venivano godute in forma comunitaria. L'antropologo marxista Maurice Godelier nel suo saggio del 1972 sui Baruya della
Nuova Guinea sottolinea come "la disuguaglianza tra i lignaggi, alcuni dei quali avrebbero ricevuto dagli antenati il potere di fornire
alla società i migliori guerrieri o gli sciamani migliori, non contraddice, anzi rafforza la responsabilità sociale e cosmica degli individui
e dei gruppi".
9
Questo è particolarmente vero per le megalopoli del c.d. Terzo Mondo, in particolare dell'America Latina, ma anche dei Paesi c.d.
sviluppati, ad es. New York, Londra, Parigi. Interessante in proposito il nuovo film di Martin Scorsese, Gangs of New York.
10
"Per coloro che nella città postmoderna leggono l'avvertimento no go area (strade e quartieri degradati) come 'no go in' area, il
termine straniero ha un significato differente rispetto a quelli per i quali no go si traduce in 'no go out' area" (pag. 70 SI).
11
Si potrebbe dire l'identità riciclata di "gente di plastica", per usare il titolo suggestivo di un lavoro teatrale di Pippo Delbono, che ha
1
7
messo insieme una compagnia teatrale di c.d. marginali che però sta ottenendo il riconoscimento del pubblico e della critica.
12
Eric Hobsbawn, The Age of Extremes, London, 1994, pag. 428.
13
Teorie dell'Identità (Introduzione), Percorsi di Analisi in Sociologia, a cura di Loredana Sciolla, 1983. L. Sciolla elenca tra i filoni
in sociologia che hanno elaborato maggiormente il concetto di identità: il funzionalismo, l'interazionismo simbolico e la fenomenologia
sociale.
14
Clifford Geertz e sua definizione di simbolo e cultura.
15
Per quanto riguarda una interpretazione antropologica collegata si veda l'approccio actor-oriented e "l'analisi delle situazioni di
"interfaccia" dove i differenti mondi della vita interagiscono e si compenetrano", N. Long, Battlefields of Knowledge, Routledge,
London 1992.
16
Ci sembra che la presenza della chiave interpretativa della psicanalisi prevalga rispetto ad autori come Melucci, che pratica la
professione di psicanalista. Ma ciò è coerente con l'impostazione metodologica di attenzione alla complessità e difficile intelligibilità
del mondo contemporaneo., esplicitata dall'autore stesso.
17
Il cui senso letterale è quello di estrarre e tirare via qualcosa da un tutto composito e ben amalgamato come la terra (to embed = to
fix firmly in sorrounding mass).
18
R. Sennet, The conscience of the Eye: the Design and social life of Cities, London, Faber & Faber, 1993.
19
La Chiesa ufficiale ha sempre avuto un rapporto difficile con i movimenti eremitici e spiritualisti e ha sempre cercato di riportare a
sé le loro forze centripete.
20
"Gli effetti culturali della Riforma furono in buona parte conseguenze non previste e addirittura non volute del lavoro dei Riformatori,
spesso lontane o addirittura contrastanti rispetto a ciò che essi vagheggiavano (pag. 78)". L'Etica Protestante e lo Spirito del
Capitalismo. Max Weber, 1904.
21
Weber parla di gabbia d'acciaio e di pietrificazione meccanizzata adornata da un convulso desiderio di sentirsi importante…di un
mondo con specialisti senza spirito e gaudenti senza cuore.
22
Come afferma Clifford Geertz , la conoscenza religiosa è un credere per conoscere, presuppone un atto di fede. Inoltre, sempre
Geertz che il simbolo plasma la realtà e così il pensiero protestante e la sua valenza simbolica hanno plasmato il mondo moderno.
23
Interessante la definizione utilizzata da Fabietti per descrivere il cambiamento del rapporto con lo spazio ed il tempo che hanno avuto
le società indigene venendo a contatto con la colonizzazione e che le ha portate a ripensarsi in termini identitari, un'altra spiegazione
dei fenomeni di profetismo, millenarismo o messianismo che si sono sviluppati in gran parte del mondo colonizzato, quali "i riti del
cargo" in Oceania, "l'harrismo" in Costa d'Avorio, la riscossa dell'identità afro-americana attraverso una serie infinita di sette e
confraternite.
24
Questo tipo di disposizione è spiritualmente più vicina alla visione orientale o al misticismo di paesi meticci quali il Brasile. Guide
spirituali e guru di varia estrazione predicano questo tipo di atteggiamento stoico attraverso i più svariati pacchetti di offerta corsi e
seminari.
25
Bauman tratta il discorso economico, in particolare come evoluzione delle teorie organizzative aziendali e guardando alla figura dei
top managers nella società contemporanea che si sono sempre più deresponsabilizzati delle sorti delle istituzioni che guidano. Le
istituzioni stesse devono diventare flessibili sotto la guida di tali personalità, pronte a cambiare strategia rapidamente, ad essere
ristrutturate e a cedere all'esterno gran parte delle attività che prima venivano svolte al loro interno (outsourcing).
26
Cfr. nota 6.
8
Da idoli della tribù a idolo del foro:
riflessioni sul concetto di cultura
di Ugo Fabietti
Quando qualche tempo fa un collega mi ha chiesto di intervenire
in un convegno con qualche riflessione sul concetto di cultura, ho
provato una certa esitazione, una specie di "ritrazione" di fronte
all'idea di dover dire qualcosa su questo tema. La mia esitazione
potrà sembrare paradossale: in fondo chi, più degli antropologi si
è occupato della "cultura"? Ma la verità è che da circa tre decenni
non esiste, per gli antropologi, una nozione più imbarazzante di
questa.
Tale imbarazzo si è tradotto in una serie di espressioni e di
metafore dotate di un diverso spessore denotativo con cui gli
antropologi hanno cercato di sfuggire (insoddisfatti) a ciò che loro
stessi hanno ritenuto essere via via un insieme complesso di
costumi, un'entità superorganica, una risposta all'ambiente, una
configurazione di valori, un processo comunicativo, un testo, una
rete di significati, un'invenzione e, infine, un impiccio e un
imbroglio. Ultimo, e in certo senso riassuntivo di tutti gli altri
disagi, quello di uno dei più noti antropologi di oggi, Arjun
Appadurai, che così esprime il suo personale imbarazzo:
"Mi trovo spesso a disagio con il sostantivo cultura… Se penso
alla ragione di ciò mi rendo conto che gran parte del disagio
dovuto al sostantivo ha a che fare con il preconcetto che la cultura
sia un qualche oggetto, una cosa o una sostanza, fisica o
metafisica. Questa sostanziazione sembra riportare la cultura
entro lo spazio discorsivo della razza, e cioè proprio entro
quell'idea per contrastare la quale era stata in origine concepita.
Se implica una sostanza mentale, il sostantivo cultura privilegia
di fatto quell'idea di condivisione, accordo e compiutezza che
contrasta fortemente con quel che sappiamo sui dislivelli di
conoscenza e sul prestigio differenziale degli stili di vita e
distoglie l'attenzione dalle concezioni e dall'azione di coloro che
sono emarginati e dominati. Se è invece vista come una sostanza
fisica, la cultura comincia allora a puzzare di qualche varietà di
biologismo, inclusa la razza, che abbiamo sicuramente superato
come categorie scientifiche".
E' da un disagio di questo tipo che deriva il mio timore a dire
qualcosa sulla cultura, ma anche la necessità, credo, di "ripensare
la cultura".
Partiamo da una statistica, frutto di una rapida ricerca su internet
condotta un paio di anni fa negli Stati Uniti: il termine "cultura"
rinviava a più di cinque milioni di pagine web (tolte tutte quelle
che facevano capo a pratiche agricole - in inglese agricoltura
suona "agri-culture").
Ma in riferimento alle discipline antropologiche, il numero delle
pagine crollava a sessantamila, mentre il sito di Amazon, la più
grande libreria on-line del mondo, riportava oltre ventimila titoli
con il temine cultura di cui però solo milletrecento erano testi di
antropologia (culturale).
Questa statistica è sicuramente congruente al disagio degli
antropologi perché significa chiaramente che oggi il termine
cultura lo si ritrova per lo più "fuori" dell'antropologia.
A prima vista gli antropologi sembrerebbero doversene rallegrare.
In fondo hanno sudato sette camicie, e almeno sette decenni, per
imporre questo concetto all'attenzione delle scienze sociali e del
pensiero occidentale. Certamente in parte è così. Ma se
guardiamo che cosa ha davvero significato, per il concetto di
cultura, questo ritrovarsi fuori dall'antropologia, scopriremo che
gli antropologi hanno molte meno ragioni di sentirsi soddisfatti.
Sia chiaro che il concetto di cultura, così come è stato elaborato e
utilizzato dall'antropologia ha avuto (ed ha) alcuni meriti che
nessuno potrebbe negare. Senza farne una genealogia, si può dire
che il concetto di cultura consentì di pensare il genere umano
come capace di esprimere ovunque, in ogni epoca e luogo, una
creatività materiale, comunicativa e simbolica che, per quanto
diversa da luogo a luogo, da epoca a epoca, presentava
caratteristiche di assoluta commensurabilità1 .
Concettualizzata come cultura umana, questa creatività ricevette
letture e specificazioni particolari, legate a contesti storici, sociali,
linguistici individuali (le "culture umane"). Il concetto, usato in
maniera estensiva o universalista (la cultura umana) consentì
infatti di ricomprendere, stavolta usato in maniera intensiva (o
particolaristica), le forme locali che questa cultura umana
assumeva in punti diversi del pianeta (le culture umane).
Sorvolando sulle implicazioni epistemologiche di questa mossa
intellettuale che fu l'elaborazione del concetto antropologico di
cultura, possiamo dire che si trattò di una mossa politicamente
importante, perché in questo modo si cominciarono a prendere
seriamente in conto delle realtà umane distribuite nello spazio che
una visione eurocentrica aveva praticamente ignorato come
elementi utili per una migliore comprensione della storia
complessiva del genere umano.
Dalla elaborazione del concetto di cultura l'antropologia, da parte
sua, trasse un vantaggio: quella di presentarsi come la prima
forma di riflessione socialmente riconosciuta, e accademicamente
autorizzata a trattare di forme di vita culturali e sociali "altre".
Così come è stato impiegato dagli antropologi anche in relazione
alla pratica etnografica, il concetto di cultura è venuto a
significare un comportamento umano strutturato in modelli
appresi. Proprio l'idea che la cultura consista di modelli mentali e
comportamentali strutturati e appresi costituisce oggi il caposaldo
ultimo dell'idea antropologica di cultura. Così definita, però, la
cultura deve essere "spiegata", e questo non può avvenire se non
grazie ad analisi particolari e circostanziate, cioè grazie
all'etnografia (senza la quale l'antropologia, è bene ricordarlo, non
avrebbe senso).
Come ci dice la statistica però, i contesti d'uso extra-antropologici
del termine cultura sono di gran lunga più numerosi rispetto di
9
quelli in cui il concetto è impiegato dagli antropologi. I concetti
non sono le parole che li evocano, e infatti il loro significato
cambia a seconda del contesto in cui vengono usati. Se nel
contesto antropologico cultura rinvia a un complesso di
comportamenti mentali e pratici strutturati e appresi, che deve
essere sempre spiegato, cioè descritto e reso coerente, "fuori
dall'antropologia" cultura è venuta a significare qualcosa di
diverso, non di completamente diverso, ma diverso quel tanto che
basta per rovesciarne a volte le finalità con cui gli antropologi lo
hanno da sempre usato.
Nel contesto non-antropologico la cultura non deve ad esempio
essere spiegata, ma è qualcosa che "spiega": spiega il
comportamento, i gusti, le idee politiche, quelle relative al
rapporto tra i sessi, e naturalmente l'economia, l'organizzazione
sociale e le visioni del mondo, sia del mondo sensibile che di
quello ultrasensibile. Spiega le guerre etniche in Africa e nei
Balcani, spiega le difficoltà di inserimento degli immigrati dei
paesi poveri nelle megalopoli europee e nordamericane, spiega le
tensioni tra bianchi e neri e ispanici nelle città degli Stati Uniti,
spiega tanto i "miracoli economici" di alcuni paesi asiatici quanto
le loro crisi ricorrenti. Spiega l'11 settembre e, naturalmente, lo
"scontro delle civiltà".
Com'è allora che un concetto elaborato dall'antropologia come
guida per la pratica etnografica, cioè per descrizioni e spiegazioni
localmente circostanziate di comportamenti e di disposizioni
umane socialmente apprese, al di fuori dell'antropologia è
diventato un "concetto-spiega-tutto"?
L'elaborazione del concetto di cultura da parte degli antropologi
rappresentò, ho detto prima, non solo un'importante mossa
intellettuale, ma anche una mossa politica significativa, il
concetto ebbe altri risvolti "politici", e non solo nel senso che
mediante esso una cultura (quella europea) si aprì alla
comprensione delle culture "altre". Formulato per la prima volta
in Inghilterra nel 18712 , divenne particolarmente centrale
nell'antropologia americana dei primi del Novecento, per poi
dispiegarsi
nuovamente
nell'antropologia
europea
successivamente alla II guerra mondiale. Senza stare a dire i
perché e i percome di questo "giro", fu in America che il concetto
di cultura sviluppò le caratteristiche di un "anti-concetto", che
erano già contenute nella sua formulazione originaria del 1871.
Quello di cultura è infatti un concetto con forti valenze anti-. Per
gli antropologi "cultura" non indica solo tutto ciò che non è
natura, ma anche, e soprattutto, tutto ciò che non può essere
descritto e spiegato mediante nozioni e discorsi che fanno capo a
una idea di eredità culturale biologicamente trasmessa.
Negli anni di formazione di questo concetto l'idea in voga era
quella di "razza" la quale veniva usata per distinguere
indifferentemente delle diversità, tanto di carattere culturale che
somatico.
Il carattere peculiare del contesto in cui tutto ciò avvenne
(l'antropologia culturale e le scienze sociali americane della prima
metà del Novecento) ebbe un impatto decisivo sullo stile
intellettuale degli antropologi. Se la cultura era ciò che doveva
difendere le scienze sociali americane dalla razziologia e la
10
società americana dal razzismo, gli antropologi si guardarono di
fatto dall'esportare questa loro posizione nella sfera pubblica, e
preferirono, per una serie di ragioni anche comprensibili,
mantenere questo discorso entro i limiti del campo disciplinare.
Queste ragioni sono da ricondurre all'uso del concetto di "cultura"
come concetto simbolo dell'antropologia, il portabandiera della
lotta contro i darwinisti sociali, i razziologi e i razzisti; ma anche
un'opzione-rifugio, un bastione dietro al quale trincerarsi per
distinguersi dalle discipline che proprio in quel periodo
riuscivano, attraverso l'adozione e l'applicazione di metodi
quantitativi, a presentarsi come "più scientifiche"
dell'antropologia culturale.
L'effetto lungo di questo "arrocco" (tanto per usare una metafora
scacchistica) fu che cultura non indicò più soltanto ciò che non era
natura o razza, ma anche ciò che avrebbe potuto essere
concettualizzato in termini di "storia" e di "classe sociale".
Diventò una specie di punto di vista auto-legittimato da cui
osservare un campo distinto dell'attività umana. Diventò un modo
per guardare ai popoli in una loro astratta "totalità", senza
specificare quelle differenze e disomogeneità di prospettive, di
potere e di interessi che sempre esistono all'interno di "una
cultura".
E' vero che non fu sempre così, soprattutto in Europa3. Se però
consideriamo il ruolo che gli Stati Uniti hanno avuto, nella
seconda metà del Novecento, nella diffusione in Europa e nel
mondo di idee e di modelli di consumo, compreso il consumo
delle idee, non dobbiamo stupirci se tra queste idee esportate
troviamo anche il concetto antropologico di cultura (o almeno una
lettura particolare di esso).
Diventato un punto di riferimento irrinunciabile per
l'antropologia, e assunte le caratteristiche di un vero e proprio
paradigma scientifico, il concetto di cultura, si trasformò, una
volta messo in circolazione fuori dell'accademia, in un concetto
rigido, autoesplicativo e capace di denotare qualcosa di molto
concreto, proprio come il mercato, l'arte, lo stato, l'economia ecc.
della cui esistenza nessuno poteva dubitare.
Reificata, la cultura da concetto descrittivo divenne esplicativo,
mentre più spiegava più si irrigidiva, e più si irrigidiva più
spiegava, come altre idee reificate: da idolo della tribù (la
comunità antropologica) si trasformò in idolo del foro (lo spazio
pubblico).
Una volta reificata, la cultura è diventata non solo ciò che spiega
tutto: conflitti, differenze, interessi, atteggiamenti ecc. ma anche
un appiglio per giustificare tutto e tutti, secondo una malintesa
idea di relatività culturale. Sul versante opposto la cultura viene
oggi chiamata in causa per sostenere la tesi dello scontro di
civiltà, per promuovere politiche educative spesso retrive, per
riproporre in chiave debiologizzata nuove forme di razzismo, per
progettare nuove forme di segregazione sociale, così come per
sostenere le tesi di quegli ambienti iperliberisti che fanno una
missione di civiltà del loro desiderio di esportare ovunque, e con
qualsiasi mezzo, le proprie vedute in materia di politica
economica.
E' sconfortante, per chi frequenta le discipline antropologiche,
assistere oggi a una simile utilizzazione del concetto di cultura
quando si credeva che il suo destino fosse invece quello di
liberarci dal biologismo e dal razzismo, di promuovere il
pluralismo e affermare una disposizione etica ed intellettuale
all'ascolto della diversità.
Esportato al di fuori dell'antropologia, il concetto di cultura non
ha certo contribuito a eliminare il biologismo dalle scienze
sociali, né il razzismo dal discorso comune e della politica.
Piuttosto li ha trasformati. Il biologismo si è abbarbicato all'idea
di cultura, dal momento che non si vede come certe dinamiche
biologiche potrebbero sostanzializzarsi se non in comportamenti
culturali; il razzismo invece, ne è uscito de-biologizzato, dal
momento che non si presenta più come una teoria che pretende di
fondarsi su dati biologici. Il neo-razzismo si avvale dell'idea
antropologica di relatività culturale per estremizzarla al punto da
sostenere che le culture umane sono tra loro radicalmente diverse,
incommensurabili e per questo incomunicanti.
Questo razzismo infatti fa leva, rovesciandone il senso, su due
assunti emersi, guarda caso, proprio dal discorso antropologico: il
primo è quello per cui le culture umane, per quanto diverse e per
quanto diversamente organizzate, hanno tutte diritto a
considerazione e riconoscimento. Il secondo afferma che se alle
diverse culture è riconosciuta una pari dignità di esistenza, allora
deve essere anche riconosciuto, a chi lo rivendica, il diritto alla
differenza e alla propria identità. È dal "bricolage ideologico" tra
questi due assunti e l'idea che le culture umane sono
incommensurabili che il neorazzismo trae le proprie
argomentazioni per proporre l'esclusione e la segregazione delle
culture.
Nel contesto esterno all'antropologia il concetto di cultura è
diventato infatti un modo per impacchettare velocemente razza,
etnia, lingua, religione e utilizzarle come marcatori della
differenza.
Preoccupa il fatto che questo modo di maneggiare il concetto stia
diventando una merce d'esportazione in tutto il mondo. Samuel
Huntington, già noto anche da noi per il suo libro Scontro di
civiltà (1995), ha curato nel 2000 un libro intitolato Culture
Matters, ("Questione di cultura"). La tesi di fondo degli autori che
hanno contribuito a questo libro è che i divari e gli squilibri socioeconomici tra differenti regioni del pianeta, sarebbero il prodotto
di eredità e disposizioni culturali, il tutto in barba alle teorie dello
scambio ineguale e delle strutture della dipendenza.
Su altri versanti la cultura è spesso invocata per rivendicare un
proprio diritto alla differenza, ma anche per affermare la propria
supposta superiorità nei confronti di altri. Anche quando si presta
a un uso relativistico, la cultura propria e degli altri è oggetto di
discorsi che evocano una scala graduale di importanza e di valore,
come avviene ad esempio nei discorsi sullo sviluppo.
In questo gli antropologi hanno, come ho detto, le loro
responsabilità. Sorvolo su quelle teorico-epistemologiche più
complesse. Una di queste responsabilità è però senz'altro quella di
aver utilizzato il termine cultura in riferimento a unità d'analisi
sempre più piccole e al tempo stesso estremamente generiche:
non solo la cultura trobriandese o balinese, ma anche la cultura
dei contadini, dei pescatori, del cibo, del turista e dell'impresa. Se
con il termine cultura si vuole indicare una entità circoscritta,
localizzata e descrivibile nella totalità dei suoi elementi
componenti, è evidente che oggi tale concetto è destituito di
fondamento. Qualcuno ha parlato di "esagerazione della cultura",
qualcun altro di "eccesso". Questa "esagerazione" fu il frutto di
intenzioni originariamente non del tutto disprezzabili, perché
corrispose al tentativo di presentare ai lettori occidentali i popoli
altri come capaci di elaborare esperienze umane ampiamente
condivise e dotate di senso4 . Ma questa "esagerazione" ebbe
effetti di reificazione e, trasportata nella sfera pubblica, andò ad
alimentare il culturalismo. Il fatto è che non furono più solo gli
antropologi a "esagerare" le culture, ma anche, e soprattutto,
coloro che si sentirono, grazie a questo concetto, in grado di
perseguire finalità e interessi propri.
Un problema connesso all'uso indiscriminato del concetto di
cultura consiste proprio nel fatto che le stesse nuove forme di
soggettività che emergono oggi nei vari luoghi del pianeta
(soggettività religiose, etniche, politiche, sessuali, giuridiche, di
genere ecc.) sono le prime a fare riferimento alla "cultura" come
ad un parametro di legittimazione del diritto alla differenza,
autonomia, indipendenza, riconoscimento ecc.
La risposta dell'antropologia, di fronte a queste utilizzazioni del
concetto è ovviamente critica, ed è consistita nel sottolineare
come tali soggettività siano non solo delle costruzioni, ma
addirittura delle invenzioni spesso finalizzate a produrre nuove e
scandalose esclusioni. Ma cosa si è guadagnato col dire che
queste soggettività sono delle invenzioni e delle costruzioni?
Spesso, quello che gli antropologi hanno guadagnato da questa
critica è nientemeno che l'accusa di….razzismo o, nel migliore
dei casi, quella di voler negare agli altri il diritto di rivendicare la
propria autenticità. Meglio sarebbe allora analizzare come queste
soggettività si producono nella dialettica della vita reale e
nell'immaginario che, grazie alla diffusione planetaria dei media,
sta diventando una delle più potenti risorse nella costruzione di
queste soggettività.
Forse la principale ingenuità da parte degli antropologi è stata
quella di pensare che, operando nello spazio neutro
dell'accademia, avrebbero potuto influenzare positivamente la
società politica e civile, mentre invece mettendo in circolazione
un concetto come quello di cultura, hanno soltanto contribuito, in
maniera del tutto paradossale, a rafforzare i pregiudizi della
società o a ridicolizzare la stessa idea di cultura, come nel caso di
una pubblicità che mi è capitato di vedere di recente, in cui una
ditta di sanitari magnificava la propria….. "cultura del bagno".
Sono infatti ben pochi coloro che ormai si prendono la briga di
chiedere agli antropologi cosa sia la cultura (e tra questi vi è il
collega che mi ha sollecitato a compiere qualche riflessione in
merito). Ma non è questo il punto.
Mi sembra importante infatti far notare come al di fuori
dell'accademia gli antropologi abbiano reso un miglior servizio
alla società e all'antropologia tutte le volte che non si sono
accontentati di arzigogolare sul concetto di cultura, ma quando
hanno invece investito teoricamente alcune categorie culturali
11
politicamente significative. Non nel senso che si sarebbero dati
alla politica, ma nel senso che hanno analizzato le pratiche e i
discorsi del culturalismo, del razzismo e dell'etnicità senza
limitarsi a dire che in fondo la cultura, la razza e l'etnia sono
soltanto delle invenzioni.
Se si pensa alla frequenza con cui la cultura è tirata in ballo per
spiegare ciò che accade nel mondo, dovremmo forse chiederci se
non sia il caso di cominciare a mettere tra parentesi il concetto
stesso di cultura. E' un concetto a cui gli antropologi (me
compreso) sono particolarmente affezionati proprio per le ragioni
che ne hanno promosso l'elaborazione e l'utilizzazione e che
prima ho cercato di riassumere brevemente. Tuttavia bisogna
chiedersi se il fatto di perseverare nella sua utilizzazione non
generi una sorta di legittimazione, di assuefazione o addirittura,
dell'uso del concetto in contesti extra-accademici.
Cosa voglio dire quando mi azzardo (e non sono certo il solo) a
dire che forse il concetto di cultura dovrebbe essere messo tra
parentesi? Infatti non vorrei essere frainteso.
Spiegare le recenti diatribe sul crocifisso nelle scuole italiane, o
sull'opportunità di evocare Babbo Natale ai giovani studenti
musulmani invocando la diversa "cultura" delle parti in causa,
appare altrettanto inadeguato che riferirsi alla cultura per spiegare
le diverse concezioni giuridiche presenti nelle diverse aree del
pianeta. Abbiamo bisogno della "cultura" per spiegare le sevizie
sui prigionieri iracheni? O per comprendere i motivi che un paio
d'anni fa spinsero delle donne cecene a cercare di farsi saltare per
aria con gli ostaggi in un teatro di Mosca, oppure quando una
ventina di anni fa centinaia di adepti di una setta guidata da un
predicatore americano scelsero di compiere un suicidio di massa?
Tutto questo ha forse a che vedere con cose come "la cultura"
occidentale e quella orientale, quella cristiana e quella
musulmana? Prendiamo un esempio concreto: la distruzione delle
statue del Budda avvenuta nel 2000 nella Valle di Bamyan, in
Afghanistan per opera dei taleban. Certo possiamo rifarci alla
"iconofobia" della "cultura" musulmana… Ma a parte il fatto che
anche il cristianesimo ha una lunga tradizione iconofobica che va
dall'VIII al XIX secolo, i veri motivi per cui i talebani fecero
saltare le statue è perché queste rientravano nel patrimonio
dell'umanità stilato dall'UNESCO, una categoria costruita, a
giudizio dai talebani, da una cultura, quella occidentale, coi cui
principi i talebani non avevano nessuna intenzione di identificarsi.
Se i talebani non sono gli unici musulmani a non riconoscersi in
questa "cultura", tuttavia non a tutti i musulmani sarebbe venuto
in mente di distruggere le statue. Se dovessimo applicare il
modello culturalista, cosa dovremmo dire dei movimenti
estremisti ebraici che vorrebbero radere al suolo il Tempio della
Roccia costruito a Gerusalemme dal califfo Omar e poi ricoperto
d'oro dai crociati per sostituirlo con un nuovo Tempio? Se non
affrontiamo analisi puntuali e articolate delle motivazioni sociali,
politiche, psicologiche che muovono gli esseri umani, e ci
rifugiamo nella "cultura" avremo fatto il gioco solo di quanti lo
scontro delle civiltà lo vogliono davvero.
Allo stesso modo, non è sufficiente dire che i film che vediamo
alla televisione, la diffusione della coca-cola e dei MacDonald nel
mondo sono il segno dell'esportazione della cultura americana su
scala planetaria: forse sarebbe meglio interrogarsi sugli interessi
che muovono questi fenomeni, sui discorsi che li promuovono,
sui modelli di accettazione o di rifiuto nei loro confronti e sulle
motivazioni e sull'immaginario che stanno alla base di questi
opposti atteggiamenti…
Poiché il valore d'uso dei concetti dipende dal contesto storicopolitico del loro impiego, del concetto di cultura vanno
certamente mantenuti i suoi significati di base, cioè quelli che
fanno capo all'idea di modelli di comportamento e di
ragionamento strutturati e appresi. Questa idea va declinata però
attraverso descrizioni di come questi modelli siano costruiti,
selezionati, utilizzati per produrre progetti che si confrontano
tanto con la dimensione della vita locale quanto con le forze della
globalizzazione (tecnologie, media, modelli di consumo,
rappresentazioni del mondo); e su come queste forze vengano
utilizzate, manipolate e reinterpretate localmente in funzione delle
esperienze, delle aspettative, degli interessi, dell'immaginario e
dei progetti egemonici o di resistenza degli interessati.
Concludo queste mie riflessioni con una domanda retorica. Perché
gli antropologi (ma non solo loro) dovrebbero affidare la propria
comprensione del mondo a una parola che l'uso extraantropologico ha trasformato in un idolo del foro e in un feticcio?
NOTE
Tale commensurabilità risultò possibile per via del progetto dell'antropologia di allora: disponendo su una ideale scala temporale le
culture, le società e le loro istituzioni, queste apparivano ordinabili per maggiore o minore complessità, essendo ciascuna di esse
"rappresentante" di una fase evolutiva della cultura umana generale. Successivamente, quando gli studi etnografici si defezionarono
nei metodi e nella teoria, apparve sempre più chiaro che tali semplicistici raffronti non erano più adeguati. Le culture cominciarono ad
1
12
essere studiate nella loro particolare singolarità, per cui apparvero non più commensurabili, ma piuttosto incommensurabili, in quanto
le loro specificità non potevano più dare luogo a raffronti basati su criteri superficiali e spesso del tutto privi di aggancio con la realtà.
Questa idea di incommensurabilità delle culture, che favorì l'adozione di una prospettiva relativistica in antropologia, fu un "progresso"
nello studio delle culture", dal momento che faceva piazza pulita di prospettive teoriche basate sulla speculazione e su giudizi di valore
impliciti del tutto euro-centrici. Introducendo l'incommensurabilità e il relativismo metodologico gli antropologi si disposero a
problematizzare lo studio delle culture in direzione di un lavoro di traduzione e di ripensamento delle categorie (euro-centriche) della
loro disciplina.
2
"La cultura o civiltà, considerata nel suo più ampio significato etnografico, è quell'insieme complesso che comprende il sapere, le
credenze, l'arte, i principi morali, le leggi, le usanze e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisite dall'uomo quale membro di una
società". Edward B. Tylor, Primitive Culture, London 1871.
3
Nell'antropologia europea il concetto di cultura ha conosciuto utilizzazioni più articolate e specificazioni che hanno tenuto conto della
stratificazione interna, dei dislivelli, e della natura storica delle culture. Ripreso negli anni Ottanta in Gran Bretagna dalla tradizione
dei Cultural Studies, il concetto di cultura è stato utilizzato in una prospettiva che reintegrava le problematiche del potere, della storia,
dell'egemonia.
4
Oltre che il frutto dello sforzo di costruire degli oggetti di riflessione che fossero in qualche modo comparabili tanto tra loro quanto
con l'esperienza culturale dell'osservatore.
13
Il razzismo
di Antonio De Lauri
C'è solo lo sforzo continuo e necessario per ridurre l'opacità,
per diminuire l'ingiustizia, per rendere più vivibile il pianeta che abitiamo,
in definitiva per diventare un po' di più esseri umani.
Alberto Melucci "Culture in gioco"
Letteratura, arti figurative, filosofie più o meno misticheggianti
denunciano il disagio moderno, ma assieme non lo sanno oltrepassare.
Ernesto De Martino "La fine del mondo"
Il razzismo nacque come pratica prima ancora che ci fosse un
termine o una categoria che ne designasse l'atto. Parafrasando
Touraine, che lo definì una malattia sociale dei tempi moderni, ed
Etienne Balibar, potremmo considerare il razzismo come un fatto
sociale totale, un fenomeno nel quale sono implicate pratiche,
discorsi, rappresentazioni e razionalizzazioni.
Il razzismo è un concetto che fa la sua comparsa nel contesto
sociale europeo verso negli anni venti del ventesimo secolo. Nel
1925 l'aggettivo "razzista" veniva usato nella pubblicistica
francese con riferimento alla destra del partito nazionale tedesco;
nel 1927 Edmond Vermeil coniò il sostantivo "razzismo", usato
come sinonimo di xenofobia, imperialismo, nazionalismo
soggettivista.
Tuttavia gli scienziati sociali europei e statunitensi raramente
usarono il concetto di razzismo, erano preferite espressioni quali
"relazioni razziali", "società di casta" e altre. La prima ad usare il
termine razzismo per designare fenomeni di sfruttamento,
subordinazione ed esclusione fu Ruth Benedict. Nel suo lavoro
"Race: Science and Politics", pubblicato nel 1940, l'antropologa
si proponeva di definire il razzismo, vale a dire quel fenomeno
sociale, politico ed ideologico, come il "nuovo calvinismo", che
asserisce che un determinato gruppo ha le stigmate della
superiorità e un altro quelle dell'inferiorità. Sulla base delle
conoscenze antropologiche, sociologiche e biologiche del tempo,
la Benedict tentava di togliere valore alle principali affermazioni
del razzismo; ella sosteneva infatti che vi fosse una totale assenza
di relazioni fra la "razza", che è una classificazione fondata su
tratti ereditari, la lingua, che è un comportamento acquisito e la
cultura, che è un comportamento trasmesso socialmente. Il lavoro
dell'antropologa si concentrava essenzialmente sul problema della
natura del razzismo, della sua nascita e della sua diffusione. La
Benedict riteneva la categoria di "razza" uno strumento utile ai
fini dello studio scientifico della storia umana, ma questa sua fede
in una sorta di scienza oggettiva, priva di implicazioni
ideologiche e di valori, non permetteva all'antropologa di rendersi
conto "che proprio nella categoria di razza si nascondeva un
tentativo di classificare e ordinare il mondo, per disciplinare e
pianificare una società moderna attraversata da conflitti e
ambivalenze" [Alietti, Padovan: 40].
14
"I fenomeni razzisti sono onnipresenti nella storia […] l'odio
razziale è ancorato nella natura umana" [Taguieff: 9]. Queste
affermazioni dello storico Joel Kovel, riprese da Taguieff,
rimandano a quella che è la visione continuistica del razzismo:
"essa consiste nell'identificare l'etnocentrismo, fenomeno
antropologico universale, come fonte o origine del razzismo, il
quale viene ridotto, di conseguenza, a una delle sue
manifestazioni storiche, al suo ultimo derivato moderno" [ibidem:
9]. Il sociologo W. G. Sumner propone una definizione di
etnocentrismo: "il punto di vista secondo il quale il gruppo a cui
si appartiene è il centro del mondo e il campione di misura a cui
si fa riferimento per giudicare tutti gli altri" [ibidem: 10]. In ogni
società è presente una certa idea di che cosa sia l'uomo, una
determinata concezione dell'umanità e di ciò che non è umano, in
altre parole una particolare concezione dell'alterità, del diverso.
L'etnocentrismo è un fenomeno comune ad ogni società, esso
consiste in "un atteggiamento che porta a giudicare i modi di
comportarsi, le credenze e le idee sul mondo, il sapere degli altri
nei termini dei propri valori e della propria tradizione culturale"
[Fabietti, Malighetti, Matera: 12]; possiamo quindi considerarlo
come un fenomeno che limita o, comunque, che rende difficile la
comprensione degli altri. L'etnocentrismo ci conduce a
disumanizzare l'altro, nella modernità ciò si realizza con la
creazione politico-scientifica di categorie di sotto-uomini.
"L'etnocentrismo conduce ogni popolo a esagerare, ad accentuare
i tratti particolari che appartengono ai propri costumi e che lo
distinguono dagli altri popoli" [Taguieff: 10]. Tenendo in
considerazione una definizione ampia del pregiudizio razziale
come "gli altri popoli sono inferiori a noi in quanto sono differenti
da noi", questo risulterà come un derivato dell'etnocentrismo.
Tuttavia, vedremo che il pregiudizio razziale non è sufficente per
spiegare il razzismo, sarebbe quindi un errore ridurre il razzismo
all'etnocentrismo. Come sostiene Clara Gallini, "ciascun popolo
ha l'etnocentrismo che si merita" [Gallini: 8]; le categorie e i
modelli che utilizziamo, gli schemi mentali che siamo in grado di
mettere in atto, sono frutto di una logica e di un sapere ben
determinati culturalmente e storicamente, non è possibile dunque
immaginarsi al di fuori di tale processo, "non è pensabile porsi al
di fuori della propria storia, di quei contesti che comportano
necessariamente una certa dose di etnocentrismo" [Siebert: 158].
Tuttavia, suggerisce la Gallini, ciò che possiamo fare è porci in
una prospettiva di "etnocentrismo critico": "la relazione con l'altro
non si gioca in uno spazio neutro, al di là e al di sopra della storia
e dei rapporti di forza economici e politici" (Siebert: 159). La
nostra attenzione deve orientarsi, quindi, sia alle contingenze
storiche, sia ai meccanismi di costruzione e di rappresentazione
dei diversi universi simbolici che danno senso alla percezione e
alla comprensione dei fenomeni umani.
quindi una teoria basata sul determinismo biologico delle
attitudini, delle disposizioni e degli atteggiamenti propri di una
particolare "razza", in rapporto alla sua cultura, civiltà e
intelligenza. Da questo punto di vista, il termine razzismo
rimanda alle dottrine ed alle pratiche che rimandano alle teorie
antropologiche della fine del diciottesimo secolo e sviluppatesi
poi nel diciannovesimo. Il razzismo è essenzialmente non
egualitario e pretende di fondarsi sulla conoscenza scientifica; ne
sono un esempio il "razzialismo" di Gobineau e il "razzialismo
evoluzionista" di Le Bon, Haeckel e Vacher de Lapouge, i quali
prendono a prestito alcuni termini della teoria darwiniana. Il
fondamento del razzismo dunque è la disuguaglianza degli
uomini, dove alcuni sono ritenuti di valore inferiore, in base alla
naturale appartenenza ad una "razza", ritenuta anch'essa di valore
inferiore.
· La teoria modernista ampia. Quest'ultima fa riferimento a tre
modelli di "protorazzismo" i quali hanno in comune il mito della
purezza del sangue e la mixofobia, ossia la fobia per gli incroci fra
le "razze". Tali modelli sono: il mito del "sangue puro" in Spagna
e Portogallo; lo schiavismo e il colonialismo europei; la dottrina
delle "due razze", ossia la dottrina aristocratica francese. In
quest'ultimo caso, il termine "razza" significa stirpe, lignaggio: i
Franchi, cioè la nobiltà, e i Galli o i Gallo-romani, cioè il terzo
stato, costituivano nel loro conflitto la popolazione francese.
Il mito del "sangue puro" nella penisola iberica può essere
considerato la prima forma di protorazzismo occidentale che fece
la sua comparsa tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo, nel
secolo d'oro spagnolo. Si basava fondamentalmente su due
aspetti: una visione negativa degli ebrei e la convinzione che i
"difetti" attribuiti agli ebrei fossero legati alla loro natura, cioè
trasmessi ereditariamente come una "incancellabile macchia".
Siamo quindi di fronte ad una forma di "antisemitismo razziale",
in cui il mito del "sangue puro" è il fulcro ideologico atto a
garantire gli interessi della classe dirigente e a difenderne i
privilegi, attraverso pratiche di esclusione e di discriminazione. In
questa società cattolico-monarchica, nel quindicesimo secolo si
sostituì una legislazione discriminatoria basata sulla "purezza"
della fede, con una basata sulla "purezza" del sangue. Questa
ipotesi di un pre-razzismo antiebraico mette in discussione la
teoria modernista ristretta con i suoi assunti, in quanto precede di
circa due secoli la comparsa delle prime classificazioni delle
"razze".
Lo schiavismo, lo sfruttamento coloniale dei popoli di colore e il
razzismo aristocratico francese, si muovono nella stessa
direzione. Il razzismo schiavista e antinegrista si basa sulla
superiorità razziale dei conquistatori: idolatria, cannibalismo,
resistenza al cristianesimo, sono le "accuse" mosse contro i
conquistati; stigmatizzate e giudicate negativamente divengono le
tesi su cui si fonda la superiorità dei conquistatori. Secondo Eric
Williams, la schiavitù sta all'origine del razzismo: il pregiudizio
del colore è visto in chiave funzionalista, proprio per il fatto di
essere nato dalle esigenze economiche delle piantagioni, la sua
funzione è quella di legittimare lo sfruttamento e consolidare un
sistema di dominio per renderlo "naturale". Ciò non significa che
Il razzismo come fenomeno moderno
Per ciò che concerne la teoria del razzismo come fenomeno
moderno è possibile distinguere tre varianti.
· La teoria modernista ristretta. Questa identifica il razzismo come
"un immediato successore dell'attività di classificazione delle
razze umane diffusasi nel corso del diciottesimo secolo"
[Taguieff: 20]. Le "razze" vengono distinte in base ai loro caratteri
morfologici, considerati ereditari. Le classificazioni sono di tipo
gerarchico, una determinata "razza" viene collocata in un preciso
punto in base ad una scala di valori, più precisamente il nero viene
posto al gradino più basso della scala ed il bianco a quello più
alto. La collocazione in questa scala gerarchica è irreversibile e da
tale posizione derivano l'esclusione, la discriminazione e la
segregazione.
Coloro che sostengono questa teoria ritengono che non vi possa
essere razzismo senza tenere in considerazione il moderno
concetto di "razza". In questo particolare caso, il razzismo si
poggia sulle tassonomie dei primi naturalisti-antropologi quali
Buffon, Camper etc.
Occorre fermarsi, prima di proseguire, sui termini di segregazione
e discriminazione. Il primo può essere applicato a realtà diverse,
in particolare etniche, razziali e sociali. La segregazione razziale
vede l'emarginazione di un gruppo dislocato in spazi ad esso
riservati, una separazione geografica quindi a cui di solito si
affiancano un certo tipo di misure restrittive più o meno rigide:
ghetti ed enclavi sono un classico esempio di segregazione. La
discriminazione razziale può essere applicata a tutti i campi della
vita sociale: scuola, lavoro, etc. e si manifesta anche nel modo in
cui i discriminati vengono trattati dai media o dal cinema. La
discriminazione corrisponde ad una logica di gerarchizzazione
mentre la segregazione coincide con una logica di
differenziazione.
· La teoria modernista ultraristretta. Qui il razzismo è ridotto a
dottrina del determinismo delle attitudini, cioè dei comportamenti
e degli atteggiamenti utili per fornire un fondamento scientifico
alla tesi della "disuguaglianza delle razze umane". La teoria
ultraristretta del razzismo riduce quest'ultimo alle "teorizzazioni
scientifiche della razza e alle loro conclusioni normative,
osservabili nel diciannovesimo secolo e durante la prima metà del
ventesimo secolo" (ibidem: 27). La "razza", nel quadro di un
determinismo ereditario di specifiche caratteristiche, viene
definita in base ad un'origine e allo stesso tempo ad una forma,
negando in tal modo l'unità del genere umano. Il razzismo è
15
prima della comparsa dello schiavismo non vi fossero dei
pregiudizi europei contro i neri ma, con lo sfruttamento
capitalistico della manodopera di colore, tali pregiudizi furono
legittimati e resi coerenti in una ideologia. In questo contesto
schiavista razzializzato, le relazioni tra padroni e schiavi vengono
regolamentate dal Codice nero, promulgato dall'amministrazione
regia nel 1685 e ripreso nel 1724. Tale Codice rappresentò il
manifesto delle paure, per esempio del diffondersi dei meticci a
seguito dei matrimoni interrazziali, della società bianca; medianta
questo Codice si esprimeva la volontà di mantenere la "barriera
del colore" inalterara e invalicabile. In questo modo nella società
schiavista venne a crearsi una "linea del colore" per separare i
bianchi dai neri e dai mulatti, a loro volta gerarchizzati sulla base
di più piccole differenze.
La teoria modernista ampia appare quindi più conforme alla realtà
storica: sebbene il sapere scientifico moderno abbia contribuito
alla legittimazione ed alla diffusione del razzismo moderno, non
lo si può porre all'origine ed alla base di quest'ultimo.
gruppo esterno sentendosi legittimato a comportarsi seguendo
uno schema collettivamente condiviso. Quindi il pregiudizio è
sostenuto e riprodotto dal continuo confronto tra sé e il proprio
gruppo di appartenenza da una parte, e tra il gruppo di
appartenenza e gli altri gruppi, situati geograficamente nello
stesso spazio, dall'altra. Seguendo tale ragionamento, se
prendiamo per esempio in considerazione una società divisa dal
criterio del colore della pelle, i contenuti dell'identità sociale di un
membro del gruppo bianco dominante forniranno le motivazioni
ideologizzate dell'inferiorità degli individui con la pelle nera.
In "Caste and Class in a Southern Town", John Dollard afferma
che il pregiudizio dei bianchi nei confronti dei neri si inscrive in
un rapporto di dominazione che influisce sul perpetuarsi di una
situazione di casta e di "inferiorizzazione". Gli atteggiamenti dei
bianchi appaiono all'autore "determinati non tanto dal contatto
fisico con i neri, quanto dal contatto con l'atteggiamento
prevalente nei loro confronti" [Wieviorka: 42]. Il pregiudizio
perciò è il risultato dell' "evoluzione della personalità razzista,
delle frustrazioni vissute nell'infanzia, delle difficoltà incontrate
nella vita adulta" [ibidem: 42], tale ostilità non riesce a sfogarsi
nel gruppo dei bianchi e si orienta verso i neri.
Una simile concezione del pregiudizio la ritroviamo nell'opera di
Gunnar Myrdal, "An American Dilemma. The Negro Problem and
Modern Democracy" del 1944. Qui il problema del razzismo pone
gli americani davanti al dilemma fra il loro credo, ricco di valori
morali legati alla nazione e alla democrazia, e l'oppressione dei
neri, alimentata dall'ignoranza. "Il nero è presentato in maniera
stereotipata, continuamente distorta, sempre nel senso di una
svalutazione; il razzismo contro i neri è carico di concetti e di
immagini che le caratteristiche del bersaglio che colpisce non
bastano a spiegare" [ibidem: 42].
Diverse critiche sono state mosse nei confronti dell'analisi del
razzismo che parte dal pregiudizio per studiare tale fenomeno.
Bisogna dire, infatti, che non sempre un comportamento razzista
è preceduto dal formarsi di un pregiudizio razzista, può essere una
reazione che nasce dalla paura, da disagi, da conflitti etc. In
particolar modo, inoltre, una visione del razzismo che prende
piede a partire dal pregiudizio, non tiene in considerazione quello
che è il fenomeno collettivo del razzismo: l'ideologia razzista,
l'esistenza di gruppi razzisti, le politiche di segregazione e
discriminazione, etc., sono aspetti cruciali del razzismo, che
diventano ancor più gravi nelle loro conseguenze e nelle loro
manifestazioni.
Il pregiudizio
Un punto di arrivo in quella che è la tradizione di studi psicosociologici degli anni trenta-quaranta sul pregiudizio è
rappresentato dall'opera di Gordon Allport: "La natura del
pregiudizio", 1954.
Con il termine pregiudizio, secondo Allport, possiamo indicare
"un atteggiamento di rifiuto o di ostilità verso una persona
appartenente ad un gruppo, semplicemente in quanto appartenente
a quel gruppo, e che pertanto si presume in possesso di qualità
biasimevoli generalmente attribuite al gruppo medesimo"
[Allport: 10]. Il risultato maggiormente significativo che il
pregiudizio comporta è il fatto di mettere il suo oggetto in una
posizione di svantaggio, immeritato, sulla base del
comportamento obiettivo. Vi sono secondo Allport alcuni fattori
socio-culturali che favoriscono il diffondersi e il riprodursi del
pregiudizio in una determinata società; è possibile quindi elencare
dieci punti:
- eterogeneità della popolazione;
- facilità dei movimenti verticali;
- rapide variazioni sociali con concomitante anomia;
- ignoranza e barriere alla comunicazione;
- densità relativa della popolazione che costituisce il gruppo
minoritario;
- esistenza di rivalità e conflitti reali;
- sfruttamento a sostegno di importanti interessi della comunità;
- sanzioni per combattere la coalizione contro capri espiatori;
- leggende e tradizioni sostenenti l'ostilità del gruppo;
- atteggiamenti sfavorevoli sia verso l'assimilazione, sia verso il
pluralismo culturale.
Per poter meglio comprendere la dimensione del pregiudizio, è
utile tornare alla teoria dell'identità sociale di Tajfel ripresa anche
da Alietti e Padovan: un individuo che appartiene ad uno specifico
gruppo, sfruttato sulla base di precise linee di differenziazione
sociale, come per esempio la "razza", agisce nei confronti di un
Verso un modello di intelligibilità
( Taguieff )
Secondo Taguieff ciò che chiamiamo razzismo si distribuisce in
tre diverse dimensioni: le attitudini, ossia le credenze, le opinioni,
etc; i comportamenti e quindi le pratiche e le azioni; le costruzioni
ideologiche.
Differenti lavori sono giunti alla conclusione che non esiste una
relazione causale tra razzismo-pregiudizio e razzismocomportamento, cioè tra la dimensione delle credenze, delle
16
opinioni e quindi tra il razzismo-ideologia e le pratiche di
discriminazione, di persecuzione, di violenza.
Non sarebbe dunque corretto unire causalmente ciò che
potremmo definire pregiudizi razziali, con i comportamenti
sociali razzisti, o meglio, tali comportamenti non derivano
solamente da opinioni razziste o xenofobe.
Un altro punto importante è che il razzismo si muove con
riferimento alla "razza" in senso biologico, "razzismo classico", o
riferendosi alle categorizzazioni elaborate sulla base dei tratti
culturali, "razzismo culturale".
Bisogna poi distinguere il "razzismo sfruttamento", vale a dire
quello coloniale e schiavista, dal "razzismo dello sterminio", il
quale auspica al totale annientamento di un determinato gruppo
umano. Il primo può essere spiegato con la teoria marxista,
ovvero la teoria della scelta razionale, sulla base di interessi
economici, in cui è legittimato lo sfruttamento delle "razze
inferiori". Nel secondo caso, lo "straniero" è visto come il nemico
assoluto che minaccia la sopravvivenza della propria identità.
Un'altra distinzione che viene proposta è quella tra "razzismo
concorrenziale", cioè delle relazioni razziste connesse ad interessi
contrastanti, e "razzismo del contatto", della fobia del contatto,
del contagio, della contaminazione.
Si possono mettere in evidenza le due forme del razzismoideologia: il "razzismo universalista", il quale rifiuta la differenza
e si fonda sulla negazione dell'identità; il "razzismo
differenzialista", basato sulla negazione dell'unità del genere
umano.
Prendendo in considerazione le caratteristiche in comune tra le
varie forme di razzismo elencate, è possibile ipotizzare un
"modello ideale di razzismo", partendo dalla distinzione tra le
caratteristiche cognitive e le caratteristiche pratiche del razzismo.
Per quel che riguarda le prime vi sono tre generi di operazioni
ricorrenti:
- una categorizzazione essenzialista degli individui e dei gruppi,
la quale riduce l'individuo a membro di un gruppo, la cui
appartenenza è normativa e implica il possesso di particolari tratti
comuni ai membri del medesimo gruppo. Da ciò deriva la
negazione della comune natura degli esseri umani.
- Una stigmatizzazione degli individui, ossia l'esclusione
simbolica dei membri ritenuti appartenenti ad un determinato
gruppo, con la conseguente creazione di una serie di stereotipi
negativi.
- La convinzione che alcune categorie di esseri umani non siano
civilizzate, ne tanto meno civilizzabili.
Sono due quindi i principi al centro del pensiero razzista: gli
esseri umani differiscono tra loro in maniera non egualitaria, ci
sono cioè delle categorie di uomini ritenuti ad un più basso livello
di umanità; questi gruppi umani che differiscono sono considerati
inutili e pericolosi, perciò rifiutati e inammissibili.
Per quel che concerne le caratteristiche pratico-sociali del
razzismo è possibile distinguere tre ordini di azioni:
- la segregazione, la discriminazione, l'espulsione dei "non
accettati";
- la persecuzione, attraverso l'uso della violenza, nei confronti dei
membri di un gruppo, proprio in quanto membri di quel gruppo;
- lo sterminio di tutti gli appartenenti ad una determinata categoria
della popolazione.
Il razzismo non si riduce ad un discorso ideologico-politico ma
"costituisce anche un'esperienza vissuta, mista di motivazioni non
coscienti e di "buone ragioni" legittimatorie per il razzista,
un'esperienza vissuta nella quale si intrecciano affetti (emozioni,
passioni), racconti leggendari, convinzioni e interessi legati a
delle situazioni, a dei contesti istituzionali, così come a delle
pratiche sociali dotate di valore funzionale (legittimare,
razionalizzare)" [Taguieff: 69].
La violenza razzista
Nel momento stesso in cui viene a costituire la negazione di un
individuo, il razzismo è violenza. È una violenza simbolica
quando tocca l'integrità morale di una persona, quando si esprime
attraverso il disprezzo, il pregiudizio, le manifestazioni di odio,
senza dirette conseguenze sull'integrità fisica di una persona. La
violenza razzista può essere, dunque, essenzialmente simbolica,
oppure manifestarsi in forma di microviolenza, comportamenti di
logoramento e anche in forme ancor più brutali come la violenza
omicida.
Rob Witte, ripreso da Wieviorka, nel suo lavoro sulla violenza
razzista e lo Stato, del 1966, individua quattro fasi nel fenomeno
della violenza razzista. Può trattarsi, secondo Witte, di un
problema individuale, sociale, un problema che rientra in un
determinato dibattito politico oppure un problema conseguente ad
un'azione da parte dello Stato. "Il suo ragionamento, che si
applica alle democrazie, non prevede il passaggio ad una quinta
fase, in cui sarebbe lo Stato stesso a mettere in atto una politica
razziale" [Wieviorka: 52].
Tenendo in considerazione il livello da cui scaturisce la violenza
razzista, possiamo sostenere che questa può innescarsi a livello
infrapolitico, dove è messa in atto da attori definiti in termini
culturali, economici e sociali, che stanno al di fuori dello spazio
politico o quanto meno dovrebbero ufficialmente essere fuori da
tale ambito. L'estensione e la gravità della violenza sono
determinate in questo caso dall'atteggiamento e dalla capacità di
intervento dei poteri pubblici, ma anche da una eventuale
legittimazione del fenomeno, oppure, per esempio il caso della
Francia con il Front National, dalla presenza di partiti politici che
la sostengono più o meno apertamente. In quanto fenomeno
infrapolitico, la violenza razzista è strettamente legata alle
tensioni che si generano nell'ambito socio-culturale.
La violenza razzista può essere anche di tipo politico, ossia
realizzata e coordinata da attori politici chiaramente intenzionati
a condizionare la vita politica di una determinata società. In
questo caso alle spalle vi è un'organizzazione che, sia dal punto di
vista ideologico che pratico, guida la violenza per raggiungere
precisi obiettivi, i quali possono essere conseguiti più o meno
legalmente, anche se quasi sempre si trasforma in violenza
incontrollata.
Le cause principali della violenza razzista rimandano a due piani
17
di analisi essenziali: sociale da un lato e identitario, culturale,
dall'altro.
Nel primo caso, sul piano sociale, gli episodi di violenza sono
posti in relazione ai meccanismi di funzionamento di una data
società, dove alcuni gruppi cercano di mantenere una posizione
dominante o di evitare l'indebolimento, l'esclusione dal quadro
sociale. In alcuni casi la violenza può essere strumentale, cioè
funzionale al mantenimento di un determinato ordine sociale:
"qui, la violenza non mira a distruggere o a escludere del tutto il
gruppo che prende di mira; intende semplicemente interiorizzarlo
[…] Tutto questo, in Sudafrica, è stato una caratteristica
importante dell'apartheid" [ibidem: 56]. In maniera diversa, la
violenza razzista può essere legata a situazioni di crisi
economiche, in cui un gruppo, privo di risorse, si contrappone ad
un'altro gruppo per escluderlo dal mercato del lavoro, "per
mantenere la propria occupazione e le proprie condizioni di vita,
per stabilire, attraverso la razza, una differenza sociale che rischia
di venire abolita" [ibidem: 57]. Tuttavia, la violenza razzista può
non rimandare a rapporti di dominazione o di sfruttamento e
quindi ad una logica di declino sociale ma, al contario, può essere
determinata dall'assenza di rapporti sociali e quindi da una logica
di esclusione.
"La violenza razzista può maturare anche a partire da significati
prevalentemente culturali, secondo una modalità offensiva oppure
difensiva" [ibidem: 60], in quest'ultimo caso può esprimersi come
una reazione ad una minaccia che mina l'identità collettiva, che
sia in termini di nazione, di comunità o di religione. In chiave
offensiva può essere letta come un'identità collettiva che
accompagna un processo di espansione, il razzismo coloniale ne è
un esempio. "L'appello a un'identità nazionale, religiosa, etnica, o
altro, nelle sue espressioni concrete non è di per sé né razzista né
violento. Ma quando lo diviene, la sua peculiarità è di essere
soprattutto differenzialista e di poter sfociare in una violenza
senza limiti" [ibidem: 60].
tema di dibattiti politici, sostenuto da partiti che organizzano e
dirigono la loro politica adottandolo come nucleo dei loro discorsi
e progetti.
· Razzismo totale. Il quarto livello infine è quello in cui il
razzismo penetra in ogni parte del corpo sociale, vengono attuati
programmi ispirati ad una dottrina razzista, mobilitando
eventualmente le forze attive del paese, organizzate in funzione e
a sostegno di alcuni principi razzisti fondamentali. L'esperienza
nazista, o quella dell'apartheid in Sudafrica, sono esempi di
attuazione di un razzismo totale.
Il pericolo maggiore è quindi rappresentato dalla possibilità che il
razzismo penetri nelle sfere istituzionali e politiche, poiché si apre
così la via alla sua progressiva integrazione e a nuove prospettive
di mobilitazione. "Legittima i comportamenti che vi si ispirano,
mette a sua disposizione le risorse dei partiti politici al potere o
delle istituzioni, risveglia nuove vocazioni nella vita intellettuale.
Si tratta quindi di qualcosa di più di un semplice cambio di scala:
rappresenta un salto di qualità" [ibidem: 66].
I mass media
"Se non si è mai avuta diretta esperienza di individui originari di
altri popoli, nell'incontro casuale che si può avere con tali
persone, la loro percezione da parte degli attori sociali avverrà
nell'ambito dell'orizzonte culturale costruito con le immagini e le
rappresentazioni ricevute dai mezzi di informazione a cui essi
hanno avuto accesso. Queste immagini strutturano la
socializzazione anticipatoria dell'altro. Se esse sono positive, vi
può essere un'apertura verso l'altro; viceversa, se sono negative,
vi può essere chiusura ed ostilità" [Cotesta: 263].
I media, in alcune situazioni, contribuiscono a riprodurre il
razzismo, ciò accade per esigenze di scoop, per ottenere le
cosiddette informazioni-spettacolo, dando di conseguenza un
certo peso e visibilità ad alcuni "attori" razzisti. Bisogna subito
precisare che non sempre i media diventano "portatori di
razzismo", in molti casi tentano di farsi attori dichiarati
dell'antirazzismo. Non è dunque corretto incolpare
eccessivamente i media per il loro contributo all'evoluzione del
razzismo, così come non si bisogna esonerarli da qualsiasi
responsabilità nel suo perpetuarsi.
Ai media può essere riconosciuta una certa capacità di garantire
riproduzione e diffusione al razzismo, quest'ultimo "è oggetto di
comunicazione, è un'ideologia che i media riproducono e
diffondono, perpetuando gli stereotipi e i pregiudizi che
traversano la società considerata" [Wieviorka: 91]. In un'altra
prospettiva le scienze sociali attribuiscono ai media la
responsabilità della nascita dell'odio e dei pregiudizi razziali. I
mezzi di comunicazione di massa sono visti come parte di un
mondo a sé stante, come sostiene Patrick Champagne: "leggendo
il giornale, la gente crede di apprendere ciò che accade nel
mondo; in realtà […] non apprende altro che ciò che accade al
giornale" [ibidem: 92]. In quest'ottica, il razzismo appare come il
prodotto del lavoro della società su sé stessa e allo stesso tempo il
risultato di una particolare attività di comunicazione, sviluppatasi
Quattro livelli di razzismo
· Infrarazzismo. Corrisponde al primo livello, qui il razzismo è
debole e si manifesta senza una specifica unità, la violenza è
diffusa, localizzata e i pregiudizi e le opinioni spesso non hanno
conseguenze pratiche. Raramente hanno luogo processi di
segregazione e gli atti di discriminazione, quando avvengono,
sono il più delle volte contenuti.
· Razzismo dispiegato. In questo caso il fenomeno è
maggiormente consolidato, si verificano più frequentemente atti
di violenza, i quali sono più brutali e messi in atto da gruppi attivi,
come per esempio gli skinheads. A questo secondo livello il
razzismo non è più un fenomeno marginale anche se le sue
diverse espressioni non sono ancora collegate e integrate nella
sfera politica.
· Razzismo istituzionalizzato. A questo livello il fenomeno entra a
far parte della vita delle istituzioni, le quali più o meno
attivamente, in maniera implicita o esplicita, contribuiscono ad
attuare la segregazione e la discriminazione. Il razzismo diventa
18
in maniera indipendente. Tuttavia, "nel circoscrivere il sistema dei
media a uno spazio che tende a rendersi autonomo dal lavoro della
società su sé stessa, si trascura quel che è proprio dei media in
democrazia, vale a dire il ruolo che essi svolgono nella
comunicazione moderna, che non si riduce certo né a una
funzione di specchio, né a un'attività autonoma. Avviene per il
razzismo quel che avviene per molti altri fenomeni sociali: i
media non agiscono né in maniera omogenea né unidimensionale:
fanno parte di sistemi d'azione che li vedono collegati a ogni sorta
di attori" [ibidem: 93-94].
In "Sociologia dei conflitti etnici", Cotesta mostra come esempio
dell'influenza dei media sulla formazione di pregiudizi e di
sentimenti negativi, il caso dei giornali italiani riguardo al
fenomeno dell'immigrazione. Secondo il sociologo le
informazioni sull'immigrazione sono spesso impostate su
stereotipi: "vi è una semplificazione eccessiva dell'immagine
dell'altro tutta giocata in termini di allarme sociale […]
Un'immagine imperniata sulla contrapposizione "noi"/"loro" e sui
tratti di una caratterizzazione positiva per "noi" e negativa per
"loro". "Noi" implica ordine, razionalità, solidarietà; "loro"
invece implica disordine, irrazionalità, bisogno. […] La
comunicazione sull'immigrazione legittima la "nostra" superiorità
e la "loro" inferiorità" [Cotesta:].
L'antirazzismo
La lotta contro il razzismo per poter essere veramente efficace
deve seguire, o meglio, deve adeguarsi alle trasformazioni delle
rappresentazioni "razzistizzanti" e alle continue riformulazioni di
tali argomenti, pensare quindi ad una pluralità di razzismi, e alle
metamorfosi che subiscono le concezioni razziste.
Nel Luglio del 1950 e nel Giugno del 1951, le dichiarazioni
dell'UNESCO si impegnavano a denunciare il razzismo come un
"mito assurdo", basato su convinzioni scientificamente false,
proponendo un programma fondato sull'istruzione scientifica e
sulla lotta intellettuale; l'antirazzismo era così auspicabile
mediante l'istruzione e l'educazione. Tuttavia diverse ricerche sui
pregiudizi e gli stereotipi di alcuni psicologi sociali hanno messo
in evidenza il carattere irrazionale connesso al pregiudizio
razziale: l'individuo soggetto a tali pregiudizi si rifiuta di accettare
la "verità" dei fatti scientifici e rimane ancorato alle sue idee,
contrastando con l'ottimismo dell'antirazzismo portato avanti
dall'UNESCO legato all'ideale educativo.
In periodi più recenti si è passati da un programma universalista
di educazione scientifica, alla pratica sistematica della sanzione
giuridica, vedendo come unico metodo di lotta al razzismo la
repressione giuridica: un ritorno al pessimismo nell'ambito
antirazzista, un ritorno legato alla visione del razzismo come
fenomeno inscindibile dalla natura umana. "Se lo spirito umano
ha queste tendenze a essere razzista, è molto probabile che un
simile comportamento si perpetui. […] La cosa naturale è il
razzismo, non l'antirazzismo: quest'ultimo può essere solo una
conquista" [Taguieff: 83]. In questa prospettiva la lotta al
razzismo diventa un'infinita lotta contro la natura umana, una
19
continua opposizione al ritorno della natura cattiva nel debole
ordine della cultura.
Un errore in cui è facile cadere è l' "errore fondamentale di
attribuzione", ossia la propensione a rimandare al comportamento
di un soggetto sulla base delle disposizioni di quest'ultimo senza
tenere in considerazione la situazione. Tale errore è spiegabile
attraverso "l'efficacia simbolica di una teoria "disposizionalista"
generale, intrecciata alla trama della cultura occidentale" [ibidem:
85]. Una teoria apertamente antirazzista può cadere nell'illusione
disposizionalista. Ciò appare più chiaro prendendo come esempio
la spiegazione di Memmi sulle cause del sistema coloniale: "gli
europei hanno conquistato il mondo perché la loro natura li ha
predisposti a farlo, i non europei sono stati colonizzati perché la
loro natura li condannava ad esserlo" [ibidem:87]. Da ciò si
potrebbe concludere che i conquistatori sono di natura superiore,
mentre i conquistati sono di natura inferiore. La seguente
citazione di Taguieff spiega chiaramente questo errore di
interpretazione disposizionalista: "non si è razzisti, lo si diventa e
dunque si può anche non esserlo più, pur essendolo stati. Il
razzismo manifestato dal comportamento di un attore sociale non
può essere spiegato attraverso le tendenze o le disposizioni di
quest'ultimo. […] L'illusione disposizionalista va di pari passo
con le pseudospiegazioni essenzialiste e con il ricorso a modelli
di legittimazione attraverso la naturalizzazione dei fenomeni
sociali" [ibidem: 88].
Taguieff si pone un'ulteriore domanda, apparentemente banale:
perchè essere antirazzisti? Egli distingue sei differenti risposte.
- In nome dell'Illuminismo, della civiltà, del progresso, lottando
contro la barbarie, mettendo fine alle disuguaglianze fra gli esseri
umani, alla discriminazione e alla segregazione. L'antirazzismo
diviene un tentativo di "riumanizzazione" di una umanità viziata,
ma può anche presentarsi come una forma di progressismo.
Quello che è implicito in tale ragionamento è l'inevitabile
gerarchizzazione tra ciò che viene riconosciuto come civile,
contro ciò che viene considerato barbaro: esiste un confine tra
barbarie e non-barbarie? Esiste quindi una scala di valori con
diversi gradi di umanità? In questa prospettiva, l'antirazzismo, ad
opera di un effetto perverso, offre i propri contenuti per un controrazzismo: "l'antirazzista pone se stesso, grazie alla sua posizione
antibarbarica, tra i civilizzati e i civilizzatori; si attribuisce il titolo
dell'essere più umano tra gli esseri umani; e pone i razzisti, coloro
che egli percepisce come tali, tra i semiumani da controllare"
[ibidem: 91].
- In nome della verità scientifica e del progresso della conoscenza,
con la continua lotta alla falsità, ai giudizi erronei, ai ragionamenti
infondati, stringendo così l'antirazzismo alla verità scientifica
sempre in evoluzione. Non è comunque sufficiente aggrapparsi ad
affermazioni che smentiscono scientificamente il razzismo.
Pierre-Henri Gouyon pone il problema da un altro punto di vista,
egli domanda a chi crede di poter lottare contro il razzismo
limitandosi a dire che le teorie sulle razze umane non possiedono
un fondamento genetico, a questi si chiede: e se invece ne
avessero uno? Bisognerebbe in quel caso essere razzisti? La
risposta a questa domanda è no, ma può essere un buono spunto
per poter valutare la plausibilità della posizione antirazzista
fondata sulla verità scientifica.
- In nome del bene, della volontà di mettere fine all'infelicità
umana e a tutto ciò che ferisce gli uomini, un antirazzismo morale
che auspica il raggiungimento di un mondo fraterno e pacifico.
Questo antirazzismo affonda le sue radici nella tradizione
giudaico-cristiana, in una posizione ostile ad ogni pluralismo,
quindi proiettata al riconoscimento di un unico Dio, di un'unica
verità, non riconoscendo la diversità e operando contro questa una
violenza simbolica. "La dolcezza fraterna ha un proprio rovescio:
la durezza dell'unica via implicata nella triplice tesi del Dio unico,
della verità unica e dell'unicità dell'umanità" [ibidem:96].
- In nome del fatto di evitare il peggio; un'altra risposta di ordine
morale, in cui l'obiettivo non è quello di eliminare ogni forma di
male, ma di evitare, o limitare le sue manifestazioni peggiori. Il
male peggiore va eliminato e ciò che rimane comunque fuori
dall'ambito del bene va tollerato. Tale tolleranza può essere
distinta a tre livelli: sopportare gli insopportabili; riconoscere il
valore di tutto ciò che differisce; sopportare solo le differenze che
differiscono bene. Il problema nasce nella misura in cui non è
possibile evitare il relativismo e il soggettivismo che rendono
arbitrario qualsiasi tentativo di definizione di intollerabilità. Cosa
può essere tollerato? Quale ordine morale può stabilire la linea di
confine tra bene e male?
- In nome della pace e dell'uguaglianza, attraverso l'eliminazione
di tutte le barriere razziali, etniche, culturali che da sempre
dividono gli uomini e li mantengono in conflitto tra loro. Il fine
ultimo è quello di giungere ad una "civilizzazione mondiale",
ogni divisione o differenziazione è un male, le identità nazionali
al pari delle identità culturali diventano degli ostacoli. Questa
posizione porta ad un inevitabile paradosso, ossia il fatto che gli
stessi antirazzisti arrivano a praticare l'eterofobia, a rifiutare la
differenza, proprio come i razzisti.
- In nome del diritto alla differenza, del rispetto delle identità
collettive, sostenendo che la diversità culturale sia un attributo
essenziale della natura umana. Riconoscere la dignità al gruppo di
appartenenza di un uomo vuol dire riconoscere la sua dignità di
essere umano, dando valore alla sua identità collettiva. La
negazione dell'identità è il compimento della disumanizzazione
dell'uomo, l'antirazzismo è così un differenzialismo, pluralista.
Tuttavia tale ragionamento implica una radicale posizione antiuniversalista, con la convinzione che il razzismo sia proprio una
forma di universalismo, riducendolo così ad un'eterofobia
biologizzante, un etnocentrismo mascherato.
Facendo un confronto tra le ultime due risposte, giungiamo alla
formulazione del "fondamentale dilemma dell'antirazzismo",
ossia alla scelta fra il rispetto delle differenze, allo scopo di
garantire la diversità umana, oppure il tentativo di creare una
"unità della specie umana", attraverso la mescolanza.
Taguieff nelle sue considerazioni conclusive mette da parte le
problematiche che stanno dietro alle definizioni di razzismi e
antirazzismi: "le difficoltà speculative incontrate nel tentativo di
fondare la lotta contro il razzismo possono e devono essere messe
tra parentesi in tutti quei casi in cui l'azione non può farsi
attendere. In breve, per le situazioni in cui bisogna agire d'urgenza
si possono fare delle scelte assiologiche e normative. […] La
finalità è unicamente quella di ottenere alcuni risultati,
adattandosi alle condizioni del contesto" [ibidem: 109-110]. Il
sociologo pone la questione da un punto di vista operativo,
tuttavia "in tutti quei casi in cui l'azione non può farsi attendere"
si agisce a partire da presupposti di tipo emotivo ed ideologico. I
risultati ottenuti sono la diretta conseguenza delle scelte operate e,
tali scelte, derivano dalla posizione che decidiamo di assumere
nel "discorso sul razzismo". L'analisi dei fenomeni razzisti e delle
ragioni antirazziste deve essere condotta attraverso una riflessione
storica e logica attenta ai processi di formazione e di
trasformazione delle società. Tale riflessione, tuttavia, sarà
necessariamente anche ideo-logica, il frutto delle convinzioni
soggettive ragionate e rappresentate.
Conclusioni
Alla luce di questa analisi del razzismo, appare appropriata
l'affermazione di Taguieff il quale, prendendo spunto da Hegel,
afferma: "il noto in genere, appunto perchè noto, non è
conosciuto" [ibidem: 1]. Il razzismo è ben noto eppure non lo si
conosce. È infatti diffusa una generica opinione su questo
fenomeno, difficilmente si trova qualcuno che non sappia nulla
sul razzismo, ciò però non significa che ci sia una reale
conoscenza delle sue implicazioni, delle sue origini, del suo
perpetuarsi nella storia con continue trasformazioni e delle sue
conseguenze a livello sociale, politico, economico e culturale.
In ultima analisi, il razzismo (ma sarebbe più corretto parlare di
razzismi) è una sfida che non va trattata né per eccesso, né per
difetto, ossia, non va drammatizzata e considerata come una lotta
insostenibile, né banalizzata o minimizzata. Il razzismo, in quanto
parte dei meccanismi di funzionamento e di cambiamento
sociale, è in grado di allargarsi ogni volta che le istituzioni e
l'apparato politico risultano incapaci di gestire le difficoltà socioculturali in maniera democratica, o ancora meglio in maniera
responsabile. Il rischio di razzismo è altrettanto evidente quando
talune comunità prosperano, ed impongono ai propri membri "la
legge del gruppo", senza rispettare i diritti e le generali modalità
della vita della "civitas", arrivando nei casi estremi alla sua
distruzione.
Renate Siebert afferma che "la nostra responsabilità, se vogliamo
contribuire a disimparare il razzismo, dovrebbe anche consistere
in un'attenzione al linguaggio. Le razze non esistono? Bene, allora
non ne usiamo neanche più la parola" [Siebert: 19]. Questo
atteggiamento, che parafrasando Alberto Melucci potremmo
definire come un processo di nominazione responsabile e
rinnovata, può condurci su strade diverse da quelle che fino ad
oggi abbiamo percorso: mettere in discussione un certo tipo di
linguaggio non è solamente un esercizio accademico ma può
essere un buon punto di partenza verso una migliore
comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda.
"Il problema, in ultima istanza, rimanda ad un'etica della
responsabilità che possa comprendere la dimensione della
20
differenza e soprattutto cogliere in anticipo quali possono essere i
"fatti sociali" che danno forma e sostanza al razzismo"
[Alietti, Padovan: 187].
BIBILIOGRAFIA
Alietti, Padovan "Sociologia del Razzismo" (2000) Carocci, Roma.
Allport "La natura del pregiudizio" (1973) La Nuova Italia, Firenze.
Bauman "Modernità e olocausto" (1992) Il Mulino, Bologna.
Cotesta "Sociologia dei conflitti etnici" (2001) Laterza, Roma-Bari.
Fabietti, Malighetti, Matera "Dal Tribale al Globale" (2000) Bruno Mondadori, Milano.
Gallini "Giochi pericolosi. Frammenti di un immaginario alquanto razzista" (1996) Manifestolibri, Roma.
Melucci "Culture in gioco" (2000) Il Saggiatore, Milano.
Siebert "Il Razzismo" (2003) Carocci, Roma.
Wieviorka "Il Razzismo" (2000) Laterza, Roma-Bari.
Taguieff "Il Razzismo" (1999) Raffaello Cortina, Milano.
21
Una recensione riflessiva di
un'etnografia dialogica:
Il Quilombo di Frechal
di Michele Parodi
A Frechal il passato persisteva nel presente [...] come "modello per
la realtà" e come strumento per rivendicare la proprietà della terra.
In questo senso era "storia viva"1
"Non sono monumenti [...] Frechal è una cosa viva [...]
Il quilombo 2 non è la sfinge, non è una piramide"3
Se l'analogia testuale invita ad analizzare le culture come dei
testi, possiamo anche pensare, invertendo i termini dell'analogia,
di analizzare un testo come una cultura. L'idea alla base di questo
lavoro è stata allora quella di provare a realizzare una recensione
come se fosse una sorta di etnografia. In questo caso, tuttavia,
volendo analizzare un testo etnografico, Il Quilombo di Frechal,
si trattava, inoltre, di creare un'etnografia di un'etnografia,
un'antropologia dell'antropologia, coinvolgendo direttamente
anche l'autore del testo e i suoi lettori in un complesso gioco di
ruoli. Ciò che mi interessava era soprattutto tentare di rendere
nella mia recensione gli aspetti performativi, illocutivi del testo
etnografico che intendevo studiare.
L'impresa si è rivelata sin dall'inizio estremamente difficile e
intricata per i numerosi, sovrapposti, intrecciati piani di analisi:
i nativi dell'etnografia di Frechal, il testo del Quilombo, il mio
medesimo testo in costruzione, le idee dell'autore del Quilombo
sul tipo di sperimentazione che intendevo svolgere. Soprattutto si
è rivelata così difficile perché le mie interpretazioni critiche delle
interpretazioni dell'autore si mescolavano con le mie
interpretazioni teoriche generali che invece utilizzavano le
interpretazioni dell'autore per sostenere le proprie tesi. Qui
presento i risultati di questa esperienza timidamente abbozzata e
certamente incompiuta.
nella bibliografia d'esame avesse inserito Il Quilombo di Frechal 4,
il libro in cui pubblicava i risultati delle sue ricerche su una
comunità brasiliana di discendenti di schiavi, ricerche di cui
avevo già letto alcuni resoconti preliminari 5.
Fig. 1
Tradizionali case di Frechal (taipas)6 .
Per fare in modo che il corso di etnografia, che ho poi
effettivamente frequentato tra marzo e aprile 2004, non rimanesse
solo una lunga discussione teorica di principi metodologici,
avevo pensato di mettere in pratica direttamente le questioni
epistemologiche che sarebbero emerse dalle lezioni, adottando un
atteggiamento riflessivo e ponendo la massima attenzione alla
processualità delle mie successive letture, alla dinamica dei miei
punti di vista, nel dialogo tra i vari testi che avrei dovuto
affrontare: i miei ricordi e i miei appunti delle lezioni, i testi
teorici proposti, le monografie etnografiche, le mie note e le mie
idee trascritte e organizzate in una sequenza apparentemente
disomogenea, ma fedele alla temporalità effettiva e contestuale
del mio pensiero; in pratica i miei testi "liminari", i miei "pretesti"7.
1. Premessa
Oggi è il primo Maggio. Finalmente mi decido a mettere per
iscritto in una forma coerente le tante idee che ormai da un mese
ho iniziato a registrare tra i miei appunti. Una raccolta di note e di
tracce disordinate che ora cercherò di percorrere fino in fondo,
seguendo i differenti piani da me seguiti nelle diverse letture del
Quilombo di Frechal.
Tutto ha avuto inizio quando ho deciso di frequentare il corso di
Metodi e teorie della ricerca antropologica, corso tenuto dal
professore Roberto Malighetti all'interno della Laurea
Specialistica in Etnologia e Antropologia Culturale. Conoscevo
già il professore da parecchio tempo e mi interessava il fatto che
22
Verso il termine del corso nacque infine l'idea di raccogliere
insieme questi materiali orientandoli ad un obiettivo concreto: la
scrittura di una recensione dialogica di una etnografia dialogica:
Il Quilombo di Frechal. Ciò mi avrebbe così permesso di
inaugurare un rapporto realmente dialogico con il docente del
corso, docente al medesimo tempo autore del testo che mi
interessava affrontare. Ciò significava impegnarmi a sostenere
innanzitutto le negoziazioni, i fraintendimenti, le manipolazioni,
le complicità, le collusioni, che l'incontro tra me e l'autoredocente avrebbero necessariamente sviluppato8 .
campo, simile al camaleonte, poteva raggiungere gli anfratti più
intimi della psicologia nativa, mi sembrava molto riduttiva.
Fig. 2
2. Prima lettura
La mia prima lettura del Quilombo è stata profondamente
influenzata dalle lezioni tenute dal professore Malighetti, lezioni
impostate inizialmente9 su una critica epistemologica molto
serrata dell'osservazione partecipante e sulla decostruzione della
rivoluzione mitopoietica prodotta, all'interno della comunità
accademica degli antropologi, dalla pubblicazione dei resoconti
etnografici delle ricerche di Malinowski nelle isole Trobriand. In
effetti anche successivamente le mie interpretazioni del Quilombo
si sono sempre posizionate in rapporto dialettico con Malinowski,
con le concomitanti letture dei suoi diari segreti10 e della sua prima
importante etnografia, gli Argonauti del Pacifico occidentale11.
Nelle mie interpretazioni, Malinowski/Malighetti, presentavano
due differenti strategie di superamento dell'opacità dei nativi,
strategie che io intendevo però considerare complementari
mettendo in evidenza gli aspetti poietici contenuti in entrambi i
punti di vista metodologici.
Nella lettura dei primi capitoli del Quilombo sono stato
inizialmente colpito dalla poca attenzione con cui l'autore si era
impegnato a ritrarre un quadro particolareggiato della comunità di
Frechal. Uno stile etnografico del tutto diverso dalla straordinaria
profusione di descrizioni contenute nelle monografie di
Malinowski. In effetti mi sembrava che la sindrome della tribù
noiosa di cui Malighetti si dichiarava affetto12, fosse prodotta da
griglie interpretative che non erano interessate a cogliere i dettagli
della vita sociale, famigliare e comunitaria degli abitanti di
Frechal. Lo stesso autore ne era cosciente13 , ed anzi questo
problema costituiva il punto di partenza del suo lavoro
etnografico.
Questa mancanza di descrizioni, di dati osservativi esaurienti mi
irritava poiché non forniva appigli alla mia immaginazione nutrita
dalle letture di Amado e Garcia Marquez, dai miti di Zumbi do
Palmares14, del "marronaggio" e delle rivolte nere, dal mito dei
remoti tam-tam dei negri che svegliavano i viaggiatori europei15.
In qualche modo ero anch'io sofferente di una patologia che mi
obbligava alla "frustrante ricerca di tratti o eventi eccezionali [...]
una sorta di "malattia infantile dell'antropologismo" 16 .
Però, la mia inquietudine aveva anche una ragione metodologica
più profonda. L'interpretazione critica di Malighetti
dell'osservazione partecipante, nei termini di un'impossibile e
paradossale immedesimazione totale con i nativi, di una
miracolosa e mistificante empatia attraverso cui il ricercatore sul
Zumbi.
Il mio punto di vista era differente. Ad un certo momento il
problema dell'osservazione partecipante mi si è in parte chiarito.
La prolungata "co-presenza" dell'osservatore e dell'oggetto di
ricerca, l'intimità che si sviluppa da tale vicinanza forzata, rende
possibile connettere tra loro una grande quantità di dati concreti,
osservazioni che il pensiero organizza gradualmente in quadri più
o meno coerenti. E' da questa forma di intuizione che a mio avviso
dipendeva l'inspiegabile "magia dell'etnografo" di cui parlava lo
stesso Malinowski17 . Come dice Clifford, la Verstehen, "la
comprensione degli altri, stando all'autorevole punto di vista di
Dilthey (1914), scaturisce inizialmente dal mero fatto della
coesistenza in un mondo condiviso"18, mondo costruito sulla base
di indizi, tracce, gesti, schegge di senso, attraverso un contatto
sensoriale che suggerisce una conoscenza cumulativa e
processuale19.
Si tratta dunque, secondo questa prospettiva di un'operazione
molto lontana dall'immedesimazione empatica. Nell'introduzione
agli Argonauti Malinowski insiste sull'importanza di organizzare
le osservazioni di campo in carte sinottiche capaci di evidenziare
i problemi irrisolti. Insiste sull'importanza di non trascurare né i
fatti banali della quotidianità, né gli eventi eccezionali, che una
prolungata permanenza permette di osservare. E' questo accumulo
di informazioni ridondanti che sviluppa la possibilità analogica di
determinare somiglianze, associando tra loro il quotidiano e
l'eccezionale. Ed è da questo contatto concreto con il campo, che
nasce la capacità stessa di osservare in profondità, la capacità,
potremmo dire forzando la nostra interpretazione, di esercitare
uno sguardo anche "ermeneuticamente" addestrato. E' lo stesso
Malinowski, nell'introduzione agli Argonauti, che sottolinea
l'importanza di compilare dettagliati e sistematici diari etnografici
dove tenere conto della processualità delle proprie osservazioni:
"E' importante che questo lavoro di raccogliere e fissare le
23
impressioni cominci abbastanza presto [...], perché certi piccoli
particolari che fanno impressione finché costituiscono una novità
non si notano più appena diventano famigliari, altri invece si
possono percepire solo con una migliore conoscenza delle
condizioni locali. Un diario etnografico, tenuto sistematicamente
per tutto il corso del lavoro in un distretto, sarà lo strumento
ideale per questo tipo di studio". 20
autobiografiche che invece aveva annotato con così grande
impegno e fatica nei suoi diari? L'idea che Malinowski avesse
espulso quei dati in quanto soggettivi e quindi non scientifici non
mi sembrava risolvere del tutto la questione.
La raccolta della più ampia possibile quantità di dati determina,
inoltre, la loro irriducibilità ad uno schema unico, implicando
digressioni, fuori tema, riaggiustamenti contraddittori e quindi
forme di analisi che assomigliano, più che a classificazioni
scientifiche, alla classificazione dei giochi di Wittgenstein:
"Questi fenomeni non hanno affatto in comune qualcosa, in base
al quale impieghiamo per tutti la stessa parola, ma sono
imparentati l'uno con l'altro in molti modi differenti. [...] Se li
osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a
tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una
serie. Come ho detto non pensare ma osserva!" 21. Possiamo così
"veder somiglianze emergere e sparire. E il risultato di questo
suona: vediamo una rete complicata di somiglianze che si
sovrappongono e si incrociano a vicenda"22 .
Nella mia idea, Malinowski nel costruire le sue categorie, ad
esempio nel trattare le tipologie dello scambio e della magia
trobriandese, metteva in campo una molteplicità di interpretazioni
che più che assomigliare a rigide definizioni scientifiche, mi
parevano "somiglianze di famiglia", interpretazioni dinamiche
all'interno di un processo di progressivo approfondimento del
materiale etnografico accumulato.
Secondo Clifford con Malinowski "ci troviamo di fronte ad uno
stile etnografico che non è ancora ‘autoritario’, negli specifici
modi messi oggi in questione sul piano politico ed
epistemologico. [...] Malinowski costituisce un complesso caso di
transizione. [...]. [Negli Argonauti, in Coral Gardens 23 ] ci
imbattiamo in pagine e pagine di formule magiche, nessuna delle
quali, in sostanza, espressa con le parole dell'etnografo"24 . Miti,
formule, dettagli che per sua stessa ammissione Malinowski non
sempre riusciva a comprendere e che determinano il carattere
"aperto", suscettibile di molteplici interpretazioni, delle sue
monografie.
Durante l'esame che ho sostenuto subito dopo la fine del corso25,
ricordo di aver discusso con il docente il mio punto di vista su
Malinowski invocando all'incirca gli stessi argomenti qui esposti.
Alla fine il professore un po' dubbioso mi ha chiesto: "In cosa può
servirti spiegare in questo modo la metodologia di Malinowski?
Quale è lo scopo di questa operazione?". Senza sbilanciarmi
troppo risposi che il mio fine principale era stato quello di cercare
di svolgere un esercizio di decostruzione del suo punto di vista
critico su Malinowski, esercizio che mi aveva permesso di
individuare una serie di tracce con cui leggere e interpretare i testi
di Malinowski e di conseguenza in opposizione anche il
Quilombo. Ma era tutto qui? Un'altra domanda ha continuato ad
assillarmi per lungo tempo: Perché Malinowski aveva ritenuto
non significative, da un punto di vista etnografico, le vicissitudini
A lezione, una volta, Malighetti ci ha narrato un episodio che gli
è capitato a Frechal. Una notte una donna che era caduta in uno
stato di trance era scappata nella foresta. Il villaggio si mobilitò
per cercarla e riportarla a casa. Malighetti si unì alla spedizione
notturna con tutto il suo armamentario di macchine fotografiche,
torce elettriche per illuminare il sentiero, quaderni. Come ci ha
detto si sentiva molto a disagio nel dover documentare una
situazione per certi versi anche drammatica. Il suo racconto
voleva commentare la natura intrusiva e violenta del lavoro sul
campo.
Leggendo il Quilombo mi sono stupito di non aver ritrovato
questo racconto. Mi sembrava potesse essere molto significativo
nel descrivere il contesto relazionale in cui erano implicati
l'antropologo e gli abitanti di Frechal. Ma proprio qui stava il
punto di non ritorno che giustificava anche la mia difficoltà nello
scrivere una recensione tradizionale. I continui tentativi di
svicolare dall'affrontare il compito che mi ero io stesso assegnato,
la recensione del libro, le continue digressioni fuori tema (ad
esempio i ricorrenti riferimenti a Malinowski), il mio sentirmi
troppo vincolato da un progetto simile si poteva capire infatti,
proprio a partire dalla natura del testo del Quilombo, dal suo stile
difficile da decifrare ad una prima lettura. Tutto il suo impianto
teorico era infatti teso a cogliere il complesso gioco intellettuale
di scambi dialogici tra il punto di vista dell'antropologo e il punto
di vista nativo. Gli aspetti relazionali, affettivi, sociali erano
sacrificati ad un'analisi più astratta e concettuale delle soggettività
in campo. Ma di questo ultimo punto ho preso coscienza solo
molto dopo la mia prima lettura del Quilombo.
Il problema principale per me era trovare il modo di scrivere una
recensione che non fosse solo un breve riassunto, ma che riuscisse
ad esprimere effettivamente qualcosa di ciò che la lettura del
Quilombo aveva "prodotto" in me. Consisteva nel fare in modo
che il lettore di queste righe potesse sperimentare un'esperienza
simile. Il mio ambizioso progetto si proponeva di rendere attivi
nel mio stesso testo quei meccanismi, quei dispositivi, che la
lettura del Quilombo aveva innescato sviluppando euristicamente
in me una comprensione superiore di tutta una serie di questioni
teoriche e pratiche riguardanti la ricerca sul campo e la sua resa
etnografica. Questa specie di "empatia interpretativa" tra il
Quilombo e la sua recensione, a cui aspiravo, faceva parte di un
mio più ampio progetto che coinvolgeva il problema di come
restituire in un testo etnografico esperienze di tipo estetico o
religioso, senza privarle del loro significato più profondo 26 .
Nella mia idea per rendere il senso di un testo, di una pratica, di
un rito, occorreva cercare di riprodurre i dispositivi che metteva
in azione. Mettere in scena le procedure logiche con cui operava.
3. Opacità, spaesamento e loro soluzione: una recensione
performativa
24
Non era sufficiente descriverli. Bisognava riuscire a farli agire
nella scrittura lasciando che qualcosa del loro senso operativo
pervenisse fino al lettore ultimo. Ed è proprio in ciò che mi
sembrava di essere in sintonia con l'autore del Quilombo. Se il suo
obiettivo era quello di rendere il senso e la processualità della sua
esperienza
etnografica
non
servivano
descrizioni
particolareggiate, al limite fuorvianti, occorreva rimanere fedeli a
quella esperienza in un modo più profondo e "reale",
"fenomenologico", occorreva riuscire a dire qualcosa di ciò che
realmente era accaduto nell'incontro tra lui e alcuni abitanti di
Frechal. Successivamente mi sono accorto che il mio
atteggiamento attento ai fenomeni illocutivi, pragmatici poteva
essere frainteso. Poteva sembrare voler attivare dei meccanismi
già inscritti nel testo da tradurre, delle specie di essenze e
dispositivi in esso contenuti ancor prima dell'incontro con il loro
interprete, così contraddicendo l'idea, alla base del paradigma
ermeneutico, secondo cui l'oggetto di analisi è già sempre il frutto
di una interpretazione, di una "reciproca appartenenza di soggetto
e oggetto"27.
nativi. Gli sforzi dell'autore di fondare la propria autorità di
antropologo sul campo. Narra i problemi d'igiene e di
alimentazione, i disagi sofferti a causa del clima terribilmente
caldo umido della stagione delle piogge (da gennaio a giugno), i
problemi dell'isolamento e della mancanza di energia elettrica; i
piccoli egoismi messi in atto per "sopravvivere" ad una situazione
ambientale piuttosto difficile; le fughe mensili a Guimarães (la
cittadina più vicina a Frechal) per telefonare in Italia, nutrirsi,
rilassarsi e mettere al sicuro le note di campo; le ansietà iniziali
del non saper cosa fare, gli imbarazzi paralizzanti prodotti dalla
sua intrusione nella vita dei nativi, gli ambigui atteggiamenti
manifestati nei suoi confronti da interlocutori che spesso lo
evitavano e si sottraevano alle sue interviste28; i tentativi di
affermare il proprio ruolo di ricercatore cancellando le
associazioni fittizie con i meccanismi assistenziali della
cooperazione in cui era stato precedentemente coinvolto 29 .
5. La ricerca dell'oggetto di ricerca
4. L'iniziazione alla comunità di Frechal
Il primo capitolo, Dal punto di vista dell'antropologo, è
certamente il più divertente. Contiene la parte diaristica del libro:
le vicissitudini di un antropologo sul campo. L'iniziazione al
villaggio di Frechal.
Fig. 3
Mappa del Brasile.
Frechal è una comunità, situata nel Nord del Brasile, nell'area
amazzonica dello stato di Maranhão ed è stata riconosciuta
ufficialmente dal governo federale comunità discendente dagli
antichi quilombos. La denominazione Reserva Extrativista
Quilombo do Frechal adottata dal decreto federale
successivamente trasformato in legge nel 1994, sottolinea il
carattere economicamente orientato, di "area estrattiva", delle
zone protette dall'istituzione della riserva.
Dal punto di vista dell'antropologo narra il primo contatto, i
primi fraintendimenti, le prime negoziazioni tra l'etnografo e i
25
Alla fine di questa complessa fase iniziatica, è venuto fuori
l'oggetto di ricerca scelto dall'autore: il tema dell'identità. Ma
come è emerso effettivamente? Mi sembrava che questa scelta
fosse stata il frutto di una specie di ripiegamento su un argomento
sufficientemente astratto e vago da lasciare l'autore
completamente libero di continuare il discorso teorico o metaetnografico che gli stava più a cuore. In seguito tuttavia mi è
sembrato di capire che è stata invece l'opacità dei nativi, la
difficoltà nello stabilire con essi un contatto effettivo a motivare
questa scelta. Le sue ragioni a mio avviso erano state quindi
specificatamente etnografiche, cioè dipendenti dal contesto
pragmatico che l'autore aveva dovuto affrontare. L'operazione
conoscitiva non poteva fondarsi unicamente sulla "complicità
ontologica" e sui vincoli di "affinità" o di "co-appartenenza" che
legano interprete e interpretato, sullo sforzo di incrociare le
interpretazioni dei nativi con quelle dell'antropologo, gli aspetti
emici con quelli etici, i concetti vicini all'esperienza con i concetti
distanti30. E' l'autore medesimo a spiegare questo punto: "Nel
corso del lavoro mi resi conto che era proprio il modello
epistemologico a non funzionare. L'opacità dei miei interlocutori
e le difficoltà del lavoro mettevano in crisi l'ottimismo cognitivo
su cui si basava. [...] Il mio approccio interpretativo non arrivava,
cioè, a concepire il sottile gioco d'interferenza fra le componenti
personali e autobiografiche e le componenti disciplinari della
ricerca" 31. Malighetti ha così operato una traslazione
metodologica decisa a riconsiderare la pratica etnografica in
quanto pratica sociale e il lavoro sul campo come il fondamento
distintivo della disciplina . Il tema dell'identità è diventato, quindi,
il tema decisivo attraverso cui penetrare all'interno di Frechal,
coinvolgendo i suoi abitanti in una processualità effettivamente
dialogica e polifonica. Come dice l'autore:
"Il tema dell'identità si imponeva in qualche modo ed è stato
particolarmente fortunato da tanti punti di vista, ma soprattutto
da quello della bifocalità. Il libro si intitola: Identità e lavoro sul
campo 33 dove identità è ambiguamente plurale e non singolare.
Non è solo l'identità di Frechal ad essere considerata. Sono le
identità, la mia e la loro, il gioco delle nostre identità. [...] Tutta
la dialogicità si inserisce molto bene nel tema dell'identità e non
è un caso che sia un tema molto sfruttato, molto ricercato in
questi ultimi decenni".34
scorrevole, fruibile, leggibile e questo, come sempre, ha imposto
delle scelte".38
La risposta alla prima domanda (perché è così importante
testualizzare la processualità della pratica etnografica?), che era
già presente nel libro 39, è maturata in me stranamente solo molto
tardi, mentre ero già impegnato in una seconda lettura del
Quilombo ed avevo ormai completato lo studio di Dal tribale al
globale, e di Il filosofo e il confessore 40, i testi a cui il corso si
affidava come riferimento teorico di base. Inizialmente mi
sembrava del tutto paradossale riuscire a controllare i propri
presupposti, i propri pre-giudizi, attraverso l'analisi della
processualità delle proprie esperienze di campo. In quanto "pre-"
dovevano essere considerati fuori dalla portata delle proprie
possibilità di comprensione. La testualizzazione della
processualità mi sembrava importante solo per minare lo stile
etnografico troppo "autoritario" delle monografie tradizionali,
creando resoconti resistenti ad interpretazioni totalizzanti41 ,
monografie aperte a una molteplicità non conclusiva di
interpretazioni; una sorta di incompletezza capace di preservare
l'alterità del campo e il suo carattere poietico e mutante.
Questa mia interpretazione riduttiva del ruolo delle descrizioni
autobiografiche e dialogiche mi permette ora di capire l'originaria
difficoltà che avevo provato nel localizzare le aporie di
Malinowski. Se una raccolta intensiva di dati "concreti", "il più
completa possibile" e quindi ipoteticamente interminabile,
determina una sorta di processualità anche nel paradigma
dell'osservazione partecipante 42 , o anche in un tipo di
osservazione etologica attenta a non compromettere l'oggetto
della ricerca con l'osservatore, questa specie di circolarità
interpretativa difficilmente riesce a mettere in discussione i
pregiudizi su cui gli stessi protocolli osservativi si basano. La
processualità delle interpretazione è limitata al livello referenziale
superficiale, ai differenti modi di incrociare e selezionare i dati,
mentre non giunge a coinvolgere i pre-concetti che guidano la
ricerca, il livello meta in cui si organizzano i fenomeni di
precomprensione attraverso cui i medesimi dati prendono senso.
Risulta così chiaro, a questo punto, anche la ragione per cui
Malinowski considerò i suoi diari del tutto privi di interesse ai fini
della ricerca etnografica, occultando nella sua monografia tutta la
problematicità esistenziale della sua vita alle Trobriand. La sua
ingenuità epistemologica non gli permetteva di cogliere
l'importanza ermeneutica di quei testi, la loro capacità di mettere
in discussione la rigidità delle sue presupposizioni, gli scopi, le
ragioni storiche contingenti e psicologiche più o meno inconsce
che motivavano le sue scelte e il suo lavoro.
Il paradigma etologico e il paradigma dell'osservazione
partecipante risultano quindi del tutto insufficienti per fondare
una metodologia della ricerca etnografica non viziata da un
atteggiamento che essendo incapace di mettere in discussione i
propri pregiudizi, risulta inevitabilmente etnocentrico. Una
maggiore attenzione al "punto di vista del nativo", combinata con
la rinuncia dialogica ad una parte della propria autorità in favore
di forme di eteroglossia, diventa così essenziale e decisiva per il
Diverse cose però non mi erano ancora del tutto chiare. Perché era
così importante testualizzare la processualità della pratica
etnografica, la successione degli errori, dei tentativi incompleti,
dei fraintendimenti, delle manipolazioni reciproche? E se era così
importante come mai ad un certo punto gli aspetti affettivi, sociali
del contesto relazionale sparivano dalla scena del Quilombo,
mentre le interviste progressivamente occupavano quasi tutto lo
spazio? In principio mi pareva che dopo la drammatizzazione
iniziale i soggetti, i protagonisti di quell'incontro che era avvenuto
a Frechal, fossero tornati nuovamente dietro le quinte, estromessi
dalla scena dell'azione. Le simpatie, le amicizie, le strategie, le
tensioni erano state ancora una volta rimosse (ed ero sinceramente
così apodittico nelle mie interpretazioni!). Tutto ciò mi ricordava
infatti il combattimento dei galli di C. Geertz 35, dove, come dice
Clifford il "primitivo senso di alienazione dai balinesi [...] viene
superato grazie all'accattivante storiella dell'incursione della
polizia e della sua [di Geertz] mostra di complicità"36. Subito
dopo, l'autore (Geertz), in questo caso insieme alla moglie, si
eclissavano per dare spazio all'etnografia vera e propria, condotta
secondo i principi standard del paradigma interpretativo
geertziano. Come dice lo stesso Malighetti, parlando del modello
di analisi di Geertz, ancora una volta emergono i significati ma
non i soggetti 37 . Nel caso del Quilombo, il seguito era però molto
diverso e se il contesto relazionale era espulso dal testo, le
soggettività erano incorporate in un assemblaggio molto denso e
articolato di interviste. Erano stati i miei pre-giudizi che mi
avevano impedito di vedere chiaramente questo fatto così
evidente? E' solo interrogando il medesimo autore che ho
compreso infine con chiarezza le ragioni della sua strategia:
"Si è lasciato che fosse l'andamento della lettura [...] la qualità
dell'intervista, il tipo di domande, rivelatori di questi rapporti.
Certo sarebbe stato interessante e importante anche descrivere il
contesto di ogni singola intervista, però avrebbe reso il testo
davvero [...] molto complesso, molto articolato, molto difficile
[...]. Ammesso che qui ci sia un tentativo di negoziazione, [...] in
Geertz non c'è proprio, sparisce l'antropologo ma spariscono
anche i nativi. Qui l'antropologo c'è attraverso le sue interviste,
[...]. Ho privilegiato la negoziazione dei significati sul campo, ho
privilegiato l'antropologo che continua a modificare i propri
paradigmi, le proprie idee in relazione ai testi, alle interviste ecc.,
rispetto alla descrizione dei contesti... Anche perché si snocciola
un discorso teorico che si articola processualmente.
L'inserimento di parti che, come dire, contestualizzavano
l'intervista avrebbe fatto perdere la processualità della ricerca
che andava avanti, l'avrebbe proprio interrotta... Continuamente.
E' stato invece fatto un grosso lavoro [...] per rendere il testo
26
discorso antropologico. Questa mescolanza di elementi personali
autobiografici, di componenti disciplinari, il punto di vista
dell'antropologo, e contestuali nativi, il punto di vista dei suoi
interlocutori, innesca una complessa dinamica interattiva
all'interno di un particolare spazio sociale43, una specifica
modalità di scambio e di comunicazione caratterizzata da una
riflessività cognitiva ed epistemologica che a sua volta genera la
dialettica fra anticipazioni di senso e comprensione, un linguaggio
di compromesso, una sorta di "pensiero meticcio" e "mutante", di
scrittura "interculturale"44 . E' in questa maniera che può realizzarsi
una fusione di orizzonti, un innalzamento a una universalità
superiore45 , che, sebbene sempre precaria e intrinsecamente
instabile, rappresenta forse il significato più profondo del tipo di
incontro attivato dalla ricerca etnografica, il suo valore
epistemologico e relazionale, mediazione di culture e visioni del
mondo in origine reciprocamente inconcepibili.
Fig. 4
Donne di Frechal mentre pilano il riso.50
6. Interviste e negoziazioni
La metodologia di ricerca etnografica dell'autore, coerentemente
con il paradigma dialogico da lui adottato, si è quindi basata
soprattutto su interviste o meglio su conversazioni fissate su
appuntamento, strutturate dalla presenza del registratore. Come
dice egli stesso: "il mio lavoro sul campo è stato
fondamentalmente relazionale e solo superficialmente
osservativo, condotto from the door of my tent"46.
Inizialmente, nelle sue pratiche di campo, l'autore era ancora
catturato dalla "trappola oggettivante"47 che considera il testo
culturale preesistente alla sua interpretazione: "pretendevo
inconsciamente che fossero loro a fornire le interpretazioni e
quindi per certi versi a produrre la monografia che invece ero
chiaramente io a dover elaborare... Ne ero chiaramente cosciente
quando misuravo su di me l'effetto delle mie domande a cui
spesso io stesso non avrei saputo rispondere" 48 . I suoi
interlocutori, sottoposti alle sue interrogazioni incalzanti e
insistenti, sul significato di essere quilombola, non potevano
direttamente formulare le interpretazioni che invece era
l'antropologo a dover elaborare. Questo fu segnalato all'autore
anche da molti dei suoi interlocutori:
"Roberto. Sei tu che devi dire [...]. Come era, come non era. [...].
Vedi tutti questi panni. Io devo lavarli e tornare a casa [...]. Sei tu
che devi scrivere il libro".49
Possiamo così vedere che se l'osservazione partecipante
chiaramente non consente di assistere al miracolo di nativi che
discutono della propria identità, un simile problema non è
facilmente risolvibile neppure attraverso i tentativi dialogici che
prescindono dai loro interessi e dai loro scopi. Questo perché i
progetti indigeni e i progetti dell'antropologia sono molto spesso
conflittuali. Certo si può “comprare” il coinvolgimento dei nativi
nell'impresa antropologica, ma in mancanza di altre motivazioni i
risultati di tale strategia sono molto aridi e privi della forza
euristica in grado di guidare l'interpretazione.
27
Durante la lezione conclusiva del corso, alla critica di alcuni
studenti che denunciavano l'assenza nel Quilombo di "dialoghi
nativi", cioè della osservazione-registrazione delle elaborazioni
degli abitanti di Frechal non provocate direttamente dalle
domande dell'antropologo, Malighetti giustamente rispose:
"Voglio parlare molto praticamente [...], lo scambio dialogico tra
i nativi di solito è del tipo: "Ciao come stai? Bene grazie. Dove
andiamo a coltivare il campo oggi?" [...] E' difficile [...] Non so
se lei con le persone a lei intime parla molto spesso dell'identità
italiana o della sua identità o dell'identità di sua moglie...
Soprattutto è difficile che l'antropologo riesca a esserci proprio in
quel momento [...] come una spia che esce dal cespuglio e cattura
la frase sul quilombo mentre sta avvenendo [...]. Certo che anche
loro [i nativi] ne parlano [...] è il momento in cui arriva
l'avvocato. Allora si siedono, ma non parlano di come
costruiscono la danças do Congo 51 , fanno discorsi specifici"52
A questa critica volutamente provocatoria dell'osservazione
partecipante - si potrebbe obiettare che ogni parola, anche la più
banale e quotidiana, può svelare molte cose dell'identità di chi la
pronuncia (e qui la linguistica antropologica ci può insegnare
moltissimo) - possiamo ora affiancare quanto detto in precedenza,
la medesima critica che l'autore formula a se stesso: se è difficile
capitare al momento esatto in cui le cose che ci servono accadono
e sono dette, può anche essere difficile suscitarle con le nostre
domande. La circolarità ermeneutica "gira a vuoto" e non
funziona efficacemente operando su materiali passivi 53 . E' allora
necessario intraprendere un lungo percorso iniziatico formato da
una sequenza tortuosa di compromessi, collusioni e
incomprensioni, malintesi e reciproci aggiustamenti. "Decisi
quindi, di tenere presente la successione degli errori e dei
tentativi, le interpretazioni false o incomplete e tutto quell'insieme
complesso di sentimenti, qualità e occasioni che fondano la
specificità del ‘metodo di lavoro’ antropologico" 54. E' il percorso
di processi e negoziazioni, costruzioni e decostruzioni,
semantizzazioni e risemantizzazioni narrato nel Quilombo. E' un
metodo, per quanto paradossale possa sembrare, in un certo senso
simile alla partecipazione empatica (l'autore non sarebbe
d'accordo con questa analogia), almeno per l'intensità del
coinvolgimento emotivo, cognitivo, esistenziale che richiede.
Certo non si cercherà di trasformare se stessi in contadini
discendenti di schiavi, ma lo sforzo di mettere in tensione i propri
pregiudizi con quelli nativi avrà la stessa intensità e sarà guidato
dalle stesse intenzioni di fusione e comprensione dell'altro che
forse hanno motivato il sogno romantico di una perfetta adesione
del proprio se ad una diversa cultura.
Riassumendo il percorso fin qui seguito, possiamo enunciare
sinteticamente la catena di implicazioni che ha caratterizzato la
processualità del lavoro sul campo a Frechal: le implicazioni tra
l'inadeguatezza del metodo interpretativo inizialmente adottato
dall'autore e l'opacità e la passività dei nativi, quindi tra questa
opacità e la sua scelta di riconsiderare il proprio modello
metodologico in chiave processuale, dialogica e infine tra la
nuova prassi metodologica e la scelta del tema dell'identità, o
meglio delle identità, della sua e dei suoi interlocutori, come
cavallo di Troia con cui penetrare all'interno di Frechal. La logica
un po' troppo rigida e formale con cui ho cercato di ricostruire
questa serie di nessi causali è stata discussa con l'autore. Qui
sarebbe stato importante, avendo più tempo a disposizione,
chiarire i nostri punti di vista innescando un'ulteriore possibilità
dialogica.
7. Descrizioni dense
Mi interessa chiarire a questo punto un'altra questione. Forse ho
dato l'impressione di pensare che il Quilombo sia povero di
descrizioni. Non è così. Il Quilombo non è povero di descrizioni.
O meglio, fedele all'ispirazione geertziana che lo guida 55 , le
continue descrizione che formano il suo tessuto sono dirette in
profondità, descrizioni dense56 in cui il particolare e il generale si
richiamano reciprocamente in una specie di simbiosi. Nel
Quilombo, "non essendoci generalizzazioni attraverso i casi, ma
solo al loro interno, l'elaborazione teorica procede a sprazzi,
percorrendo un sentiero wittgensteiniano tortuoso e pieno di
deviazioni ed incroci"58. Così le varie interpretazioni dell'identità
quilombola vi emergono e svaniscono nell'intrecciarsi con gli
eventi descritti, nel loro contesto "naturale", nessuna di esse
giusta o sbagliata eppure tutte valide da un certo punto di vista,
valide anche nel loro insieme nel loro accordarsi al tutto: "una
sequenza sconnessa ma intellegibile di sortite sempre più
approfondite"59 .
L'apparente banalità, la semplicità istituzionale e cerimoniale
dell'identità degli abitanti di Frechal - priva di possibili prese per
i miti di fondazione dell'antropologia (la parentela, l'animismo, la
possessione, la stregoneria, il dono... )60- inizialmente attribuita da
Malighetti, anche se con incerta convinzione, al processo di
rimozione del passato coloniale che li aveva discriminati e alle
politiche di annullamento, dispersione, omogeneizzazione delle
identità messe in atto dalle istituzioni schiaviste61, nel descrivere
in seguito le sue difficoltà di adattamento alle condizioni di
campo, viene attribuita dall'autore a se medesimo e alla sterilità,
all'inefficacia dei paradigmi teorici e metodologici da lui adottati.
Nel Quilombo è continuamente messa a profitto questa strategia
oscillante, strategia anch'essa di ispirazione geertziana, in cui
concetti lontani dall'esperienza62 (in questo caso il concetto di
identità) sono chiariti attraverso i particolari che li incorporano, i
vissuti esistenziali e fenomenologici più contingenti, mentre i
particolari sono pensati con i concetti teorici che li spiegano: "non
possiamo segare il ramo sul quale siamo seduti.. non possiamo
che usare teorie generali, è lì che parte il circolo ermeneutico, dal
sapere [...]. Se c'è un contributo teorico sull'identità è che l'identità
è un modello teorico [...] l'identità è un concetto, un fuoco
virtuale"63. E questo fuoco virtuale nel Quilombo non è indagato
in relazione al rapporto tra struttura e processo, ma è ricercato
dall'interno, "analizzandone la dinamica [...] a partire dagli attori
sociali, dal loro vissuto, dalle loro rappresentazioni"64.
8. La dinamica di un incontro dialogico
Torniamo ora alla domanda cruciale a cui ancora non abbiamo
fornito una risposta decisiva: Come è stata superata nel Quilombo
l'opacità di Frechal? Nonostante l'autore in più momenti affermi
la fondamentale "eterotopia"65 tra discorso nativo e discorso
antropologico e quindi la costitutiva ed inconciliabile opposizione
tra i progetti nativi e i progetti del ricercatore sul campo,
opposizione decisiva soprattutto nel fondare la sua autorità
etnografica, a mio avviso il successo della ricerca di Malighetti a
Frechal è dovuto proprio alla sua capacità di trasformare
situazionalmente le proprie aspettative, i propri scopi adattandoli
al contesto di campo, ai progetti nativi, alla loro logica e ai loro
bisogni. Abbandonate tutte le velleità di riscoprire a Frechal i miti
fondatori dell'antropologia e nello specifico ad esempio la
ricchezza culturale dei culti afro-brasiliani, l'autore nel scegliere
l'identità come polo decisivo attorno a cui articolare tutta la
dialogia del suo incontro con i nativi, dimostra la strategica
necessità di coniugare tale concetto astratto ai problemi più vivi
dei suoi abitanti, al problema ad esempio di come costituire
un'identità comune capace di rappresentare a se stessi e agli altri
la propria unità. Esigenza questa per i quilombolas del tutto
politica, motivata a sua volta dalla volontà di opporsi alla
drammatica realtà del latifondo, ai soprusi di un fazendeiro
incapace di continuare la consolidata relazione di armonia e pace
vigente con i precedenti proprietari di Frechal; dalla necessità di
dare peso giuridico alla legittimità delle proprie rivendicazioni
appellandosi a dispositivi costituzionali che riconoscono ai
successori degli antichi schiavi fuggiti il possesso della terra sulla
quale vivono. L'identità a Frechal non è stata allora studiata
dall'autore nei suoi aspetti culturali o folklorici ma nella sua
valenza essenzialmente politica. Sono questi problemi concreti
che hanno motivato, secondo il mio punto di vista, il crescente
interesse di Malighetti per la storia sociale ed economica della
regione di Frechal, per i documenti processuali della causa con il
28
fazendeiro, per le attività del Centro di Cultura Negra (CCN) di
São Luís e della Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos
Humanos (SMDDH).
Risultano ora chiare le ragioni che hanno guidato l'autore nel
selezionare i materiali etnografici da includere nel testo finale. Ad
esempio possiamo comprendere la scelta di scartare argomenti
anche molto interessanti e significativi come la possessione66 o il
carattere endo-gamico delle relazioni di parentela a Frechal.
Questi temi non erano decisivi per la strategia etnografica adottata
dall'autore, esattamente come per Malinowski non apparivano
cruciali i fatti descritti nei suoi diari.
In definitiva proprio le questioni che in teoria avrebbero dovuto
maggiormente compromettere l'antropologo nelle faccende locali,
incrinando la sua autorità, si sono rivelate le più efficaci
nell'attivare l'interesse nativo nei suoi confronti. Inizialmente la
relazione dei nativi con l'autore si è caratterizzata per le reticenze,
i sospetti, gli sviamenti e per una sorta di patto del silenzio.
All'inizio gli informatori avevano solo una vaga idea di ciò che
l'autore intendeva fare a Frechal67. Ma con il crescere della
confidenza hanno iniziato ad apprezzare la possibilità di
raccontare i loro problemi e le loro riflessioni (Ibidem). Durante
le interviste l'identità quilombola rappresentandosi all'autore e a
loro stessi, in un reciproco scambio interattivo di manipolazioni e
collusioni, andava trasformandosi e definendosi con maggiore
profondità. L'antropologo, in questo preceduto dalle associazioni
(CCN, SMDDH) che avevano aiutato gli abitanti di Frechal ad
istituire la causa contro il fazendeiro , ha acquisito un ruolo
maieutico capace di indurre nei nativi nuove modalità strategiche
con cui confrontarsi con l'alterità, con il mondo più vasto che
circondava Frechal; un ruolo anche terapeutico, capace di
suscitare nuove aspettative, nuove speranze, nuove energie. Nita,
una giovane donna di Frechal, così descrive il suo incontro con
l'autore:
9. A cosa serve l'antropologia?
Ma il lavoro etnografico sul campo in cosa si è distinto
dall'attività delle associazioni che hanno operato nello stesso
territorio? Quale è stato il suo specifico impatto sui nativi e cosa
è stato in grado di raccogliere e portare a casa?
Inizialmente si è istituita una doppia manipolazione, dei nativi sul
progetto antropologico e dell'antropologo sui progetti nativi. Gli
abitanti di Frechal, addestrati dalle logiche giuridiche messe in
atto dagli avvocati durante il processo contro il fazendeiro, hanno
usato Malighetti come un documento, un supporto su cui
appoggiare una rappresentazione condivisa dell'identità70 , oppure
semplicemente come un mezzo per acquisire un prestigio, da
spendere soprattutto con gli estranei e derivante dall'essere
studiati da un antropologo italiano71. Hanno anche influenzato
l'autore nelle sue scelte riguardo l'oggetto di ricerca, almeno
determinando in parte il contesto relazionale in cui il loro incontro
è avvenuto.
Fig. 5
"Penso che il tuo lavoro sia ottimo perché ci sta aiutando a
mostrare a noi stessi la nostra importanza. Attraverso le interviste
Inácio.72
ci obblighi ad approfondire le cose [...] Roberto sta aiutandoci e
noi aiutiamo Roberto a portare Frechal in Italia... " 68 .
Allo stesso tempo è stato l'autore a coinvolgerli nel processo
dialogico, stabilendo i luoghi e i tempi di tale incontro. Inoltre il
Se però inizialmente mi era parso di scorgere un crescendo di medesimo bisogno di un sapere controllabile che portava
intensità, un progressivo avvicinarsi e comprendersi, il graduale l'antropologo ad insistere sulle tracce scritte ha poi indotto
istituirsi di una sorta di alleanza interpretativa tra l'autore e i suoi un'analoga attenzione e valorizzazione da parte dei nativi per le
informatori, successivamente mettendo più attenzione alle date attestazioni documentarie 73 . Ma questo non è tutto. L'insistente
dei brani delle interviste inserite nel testo, in cui il prima e il dopo attenzione dell'autore per la processualità, per il carattere
si alternano senza sosta in un continuo oscillare difficilmente interpretativo essenzialmente contestabile di ogni costruzione
controllabile, mi sono dovuto parzialmente ricredere. La fusione culturale, e quindi sul carattere fittizio di ogni identità, ha finito,
tra i modelli interpretativi dell'autore e dei nativi si è svolta senza secondo me, per contagiare sottilmente il punto di vista nativo.
seguire una logica semplicemente sequenziale ma subendo dei Questa mia interpretazione, molto azzardata, è difficilmente
salti, affrontando nel suo svilupparsi delle accelerazioni e delle dimostrabile sulla base delle interviste inserite nel Quilombo. Se
contrazioni. L'illusione da cui ero stato sedotto era anche l'effetto accolta mi sembra però chiarire il differente modo in cui la
di un procedimento retorico: la messa in scena delle successive presenza a Frechal dell'antropologo ha influenzato i suoi
stratificazioni della scrittura, della sua processualità temporale, interlocutori rispetto invece al ruolo svolto dalle varie
dello scarto tra ""l'essere là" (sul campo), e "l'essere qui" (a associazioni che hanno operato a Frechal. Qui è come se io
raccontare del campo)" 69 .
provassi a ribaltare l'asimmetria tra l'antropologo e i suoi
29
interlocutori, tentando di guardare il processo di fusione dal punto
di vista dei nativi. In una prospettiva dialogica la fusione si genera
anche tra di essi74. La mia idea è che alcuni complessi concetti
disciplinari: il carattere costruttivo, fenomenotecnico dei processi
interpretativi, la loro funzione strategica e manipolatoria, si siano
insinuati pragmaticamente tra alcuni nativi realizzando così una
forma di fusione tra concetti vicini, la terra, la comunità e lontani
dall'esperienza, la storia. La storia di Frechal inizialmente era
concepita in modo sostanzialistico, come qualcosa da conoscere o
da scoprire attraverso le tracce lasciate nelle persone, nei
documenti, nel territorio. Come racconta Inácio, uno dei leader
della comunità di Frechal: "Quando arrivò Dimas75[...] noi gli
mostrammo i vari rifugi, le rovine. Loro furono lì a vedere e
Alfredo Wagner76 disse che lì era il quilombo" 77. Nel corso del
processo e successivamente, la storia del quilombo è stata
rielaborata dagli abitanti di Frechal in termini narrativi, ma sotto
gli stimoli dell'autore, a mio avviso, è affiorato, in un certo senso,
anche il carattere fittizio delle storie narrate, carattere che si è
infiltrato inscrivendosi sottilmente nei loro discorsi.
Parallelamente è emerso il valore vitale, utopico, orientato verso
il futuro del narrare:
si dimentica.
‘Esatto’" 83 .
Se protocolli di intervista non direttivi possono essere utili nel far
emergere risposte inaspettate e destabilizzanti è chiaro che una
totale non direttività, impedendo qualsiasi negoziazione tra
l'antropologo e i suoi interlocutori non può innescare alcuna
efficace dialogia. Il mestiere dell'antropologo, la sua "magia",
consiste allora proprio nell'acquisire la capacità di gestire questo
dilemma, di capire quando forzare le proprie interpretazioni e
quando lasciarsi conquistare dalle interpretazioni native:
" Inácio diceva... ‘No, no è il passato che crea il presente’, e però
‘storia viva’ è nata da lì. Non è che Inácio andasse in giro
dicendo: ‘storia viva, storia viva, la nostra è una storia viva’ [...].
C'è un anno di vita in comune lì [...] però si, c'è anche quello, la
forzatura. [...] E' il tuo mestiere... Il fare ricerca è acquisire
quella sensibilità di capire cosa puoi provocare, cosa non puoi
provocare, si potrebbe dire, cosa sei in grado di contenere, cosa
non puoi contenere"84
Intervistando sul Quilombo due compagne di corso,
sorprendentemente, sono emerse contemporaneamente le due
possibili interpretazioni dell'operazione condotta dall'autore.
L'interrogativo, anche se ingannevole, era molto semplice: "da
dove arriva il concetto di ‘storia viva’? è un'invenzione di
Malighetti o dei nativi?". Mentre la prima si era convinta che "la
chiave di lettura lui [l'autore] l'aveva già"85, la seconda era
persuasa che "la convergenza è stata si creata dall'autore, ma si è
creata proprio nello scambio tra le interviste e le elaborazioni"86 ,
cioè nello scambio dialogico. Per lei anche i momenti più
direttivi, quando Malighetti sembrava incalzare i suoi
"Mundoca lasciò una storia viva [...] Ciò che lei sapeva, interlocutori imponendo provocatoriamente le sue idee (come nel
raccontato dal marito, lo passava a noi.81 Se non fosse per i brano sopra citato), rappresentavano "un momento in cui il
racconti di questa schiavitù [...] forse non avremmo avuto una dialogo funzionava, [...] uno dei punti in cui il gioco viene
storia che potesse concretizzarsi [...]. Perché che cosa avremmo fuori"87. Anche se l'autore possedeva sin dall'inizio questa "chiave
detto se non fossimo stati schiavi?82".
di lettura" ciò rappresentava solo il punto di partenza su cui
innestare un discorso dialogico che manteneva una propria
Che la storia passata sia una costruzione del presente non emerge indipendenza e che poteva produrre sia fenomeni di convergenza
mai spontaneamente nelle risposte degli abitanti di Frechal. che viceversa incomprensioni e contrasti. Ecco cosa ci dice
Sembra però esserci un filo sotterraneo che scorre nei discorsi l'autore sul ruolo avuto nell'influenzare la realtà di Frechal:
nativi registrati dall'autore e che indirettamente segnala quell'idea.
Nei dialoghi si manifesta pienamente anche il ruolo attivo, "In che modo ho influenzato la realtà di Frechal? Questo è un
ironico, provocatorio dell'antropologo.
problema molto complesso [...], dovrei riflettere molto su questa
cosa. […] Parlare a fondo di cosa abbia significato la mia
"Il mio assunto teorico è che il presente crea il passato. Se non presenza a Frechal potrebbe essere oggetto di una ricerca. Anche
incontravate l'articolo 68, la parola quilombo non sarebbe stata perché la mia presenza si è accompagnata a tante altre presenze.
importante per voi [...]. Il presente vi obbliga a riconsiderare una Non è facile isolare il mio contributo" 88 .
cosa del passato come molto importante.
"Realmente. E' una verità. Tu hai detto in pochi minuti ciò che è Nel Quilombo di Frechal il carattere negoziale dell'identità è
importante [...] il presente è tanto importante per il passato e io esplorato con grande meticolosità, potremmo dire, citando la frase
penso anche così: io penso che anche il passato è importante per di Geertz con cui si conclude il libro, con "la precisione con cui ci
il presente."
tormentiamo a vicenda"89 . E' indagato il suo configurarsi come
Si. Ma senza presente non hai conoscenza del passato. Il passato fenomeno precario, funzione instabile, luogo di concorsi cui
"Ora io conosco l'altro lato della storia [...]. Questo è nato da me
a partire da alcune riflessioni con me stesso [...]. Sarà che il
lavoro degli schiavi fece questo Paese chiamato Brasile un Paese
ricco?78 Così iniziai a studiare i libri [...] e a vedere che era una
storia che non era raccontata dallo schiavo, ma che era
raccontata dagli storici bianchi. Mi chiedevo: "Sarà che chi
scrisse questo fu qualche schiavo?" 79 Essere quilombolas
significa essere [...] lottatori, conquistatori, negri che hanno una
conoscenza maggiore delle altre comunità80".
30
partecipano in misura ogni volta infinitesima le forze della natura
e della storia90 , l'identità come spazio in continua effervescenza
che manifesta un valore doppiamente pratico: mezzo
performativo per legittimare i propri obiettivi e strumento
euristico capace di isolare in un nome, in uno schema concettuale
la polisemia del dato empirico; categoria della pratica che può
essere detta solo in termini narrativi91. Ma tutto questo potrebbe
sembrare solo accademia se nel Quilombo non fosse praticato,
sperimentato etnograficamente sul campo. Ciò che risulta
significativo nel Quilombo è infatti soprattutto la narrazione
dell'incontro dialogico, il luogo in cui tutte le sofisticate teorie
antropologiche sull'identità, prima accennate, si incarnano in un
tessuto esistenziale più reale: sono le dinamiche di
manipolazione, fusione avvenute nel contesto etnografico.
Ma torniamo alla questione iniziale: il lavoro etnografico sul
terreno in cosa si è distinto dall'attività delle associazioni che
hanno operato nello stesso territorio? A mio avviso, il lavoro
antropologico dell'autore, attraverso le pratiche di costruzione e
decostruzione che ha manifestato anche sul campo nel tipo di
domande proposte ai suoi interlocutori, è stato in grado di
distanziarsi dalle strumentalizzazioni attraverso cui ad esempio i
concetti essenzialistici di "territorialità", "anzianità di
occupazione", "genealogia", "razza", si erano cristallizzati a
Frechal durante le varie fasi del processo giudiziario. In questa
prospettiva possiamo leggere quindi anche le differenze di punti
di vista, le tensioni, le inquietudini tra l'antropologo ricercatore
accademico (Malighetti) e l'antropologo militante al servizio di
associazioni per la difesa dei diritti umani di minoranze etniche
discriminate (Alfredo Wagner):
pregiudizi? Oppure è solo riuscito a impartire, senza volerlo, la
nuova lezione del sapere occidentale, in questo caso una lezione
di antropologia interpretativa, a nativi ancora una volta troppo
passivi? I concetti di creatività, poieticità, il concepire la storia
come costruzione pragmatica, non fanno anch'essi parte del
grande mito occidentale del progresso, dell'individuo demiurgo
imprenditore di se stesso? Sono convinto che a questi ultimi
interrogativi si possa rispondere negativamente e che
probabilmente siano anche interrogativi mal posti e sbagliati. Ma
preferisco mantenerli, mantenere il dubbio capace di minare le più
occulte inclinazioni con cui imponiamo i nostri discorsi agli altri.
Qui probabilmente ci scontriamo con i limiti e le forme generali
della dicibilità: i discorsi, citando Foucault, sono pratiche che
formano sistematicamente gli oggetti di cui parlano e in ciò
manifestano la loro specifica irriducibilità e la "perpetua
articolazione del potere sul sapere e del sapere sul potere" 93 .
Ma infine potremmo ancora chiederci: saremo mai capaci di
giungere al limite di noi stessi, fino a veder sorgere il vuoto in cui
obliandosi sopravvivere alla propria scomparsa?
10. Capire l'antropologia a partire da cosa fanno gli
antropologi
Le narrazioni autobiografiche di campo, la descrizione della
complessa fase di ricerca dell'oggetto di ricerca, contenute nei
primi paragrafi del Quilombo, svolgono, secondo le parole
dell'autore, delle "strategie testuali di costruzione di un'autorità e
di introduzione al discorso. Ci sono anche strategie retoriche che
hanno a che fare con la messa in intrigo, con la costruzione di
qualcosa di leggibile, di fruibile"94. Ma vi è qui pure un'altra
ragione più specificamente pedagogica:
"Alfredo Wagner De Almeida è un'autorità in Brasile. [...] Lavora
anche nel movimento dei Sem Terra... E' una persona che gira il
mondo. [...] Abbiamo avuto discussioni, abbiamo avuto anche
tensioni. Lui è un militante, a lui interessa che Frechal abbia la
terra... [...] Usare politicamente certe categorie, come razza,
gruppo etnico ecc. [...] è un grande problema. Non ho dubbi sulla
buona fede di Alfredo, però se metti in gioco categorie come
razza, colore ecc. poi se queste categorie che tu hai messo in
gioco vengono usate da altri, che non sempre hanno le tue stesse
finalità, la cosa diventa pericolosa. Specie per queste categorie
che
hanno una lunga storia. [...] Sono stato invitato
dall'associazione degli antropologi brasiliani ad un convegno e
qui ho fatto un discorso sull'etica, sulla ricerca... Sull'attenzione
che bisogna avere nell'usare i concetti, perché prenderli e usarli,
anche per finalità nobilissime, è comunque una questione
delicata. [...] Ciò che voglio sottolineare è un problema etico.
Non ho soluzioni. Voglio solo dire di fare attenzione".92
"Come dire, c'è tutta la ricerca dell'oggetto di ricerca. A uno
studente che vuole fare ricerca potrebbe interessare... Non sto
dicendo che sia la cosa più bella del mondo... Però si può dire:
"Guarda Malighetti, anche lui aveva questo problema". Mentre
Malinowski sembra che già il primo giorno sapesse cosa fare e
come farlo... "95.
"E' pesante fare ricerca, ti stressa. Per questo hai bisogno di
scrivere [...]. Il messaggio allo studente allora è: guarda che se
stai male perché c'è tensione è normale... Nel rapporto
interpersonale si arriva a casa distrutti... Se poi ci sono anche 60°
all'ombra e in più i tuoi interlocutori non parlano e sei anche
stanco e magari mangi poco... Si fa ancora più fatica. […]
Quando alcuni studenti mi dicono di voler fare ricerca sul campo
li avverto delle difficoltà, anche economiche, e del rischio di
tornare a casa a mani vuote"96.
Possiamo così concludere che l'impegno peculiare di Malighetti,
più che riportare a casa nuove conoscenze monografiche, ha
portato indietro un'idea, un esempio di cosa significa fare
antropologia oggi.
Un dubbio però ancora rimane: Malighetti ha realmente attivato
un processo riflessivo capace di decostruire anche i propri
"C'è sempre un po' di pudore e timidezza nel tirare fuori il
quaderno degli appunti, nel fare le domande. [...] Penso quanto
il libro sia stato scritto anche per gli studenti, per coloro che...
Sono imbarazzati a tirare fuori il quaderno degli appunti, che
pensano che estraendo il quaderno in qualche modo tradiscono i
31
propri interlocutori, il loro rapporto di amicizia. Non si tratta di
essere amici. Non si è amici. Si è lì perché si è antropologi e
l'antropologo tira fuori il quaderno degli appunti. E questa è
violenza. Penso a quanto il libro possa essere un libro introduttivo
per capire cosa fanno gli antropologi, cosa è l'antropologia a
partire dal vedere cosa fanno gli antropologi. Anche per via
negativa dicendo: ‘L'antropologia deve essere il contrario di
quello che fa Malighetti".97
Fig. 6
intrecciano nella pratica etnografica.
Ma il valore formativo del Quilombo, a mio avviso, va oltre
questo intento esemplare ed educativo. Il Quilombo con il suo
complesso intreccio di interpretazioni costituisce un testo aperto,
"un testo vivo" che suscita continuamente nuove possibilità di
lettura. Così ne parla una compagna di corso:
"Più lo leggevo, più mi piaceva, nel senso che leggendolo era
come se... Mi sono vista così... Mi sono vista in circolarità
ermeneutica con il libro [...]. Mi sembrava ogni volta di capire
delle cose in più [...]. Se non avessi letto questo libro non so se
avrei capito adeguatamente Dal tribale al globale, magari si
avrei capito più o meno..." 99
Potremmo dire, continuando le sue parole: "si avrei capito, ma
non così concretamente, così praticamente, così fisicamente".
Il Quilombo costituisce perciò un testo poietico, un testo
estetico 100 , la cui bellezza è inscritta nella potenzialità
interpretativa che risveglia nei suoi lettori, nella sua
incompletezza che induce a soffermarsi e a riflettere su di essa.
Un testo creativo attraverso cui prendere coscienza dei propri
pregiudizi e sviluppare le proprie capacità critiche. Tutto il mio
intento è stato allora quello di manifestare questa proprietà
profonda del Quilombo cercando di riattivarla nella mia
recensione. Molte cose che ho scritto costituiscono delle
interpretazioni estremamente personali del libro, interpretazioni
più o meno condivisibili, spesso provocatorie. La mia adesione al
testo va però cercata nel suo esito performativo: una recensione
aperta, di un'etnografia aperta, di una storia viva.
11. Saudades
Questa Estate sono andato in Brasile101 , un mese in viaggio tra São
Paulo e São Luís. São Luís la capitale dello stato di Maranhão, a
poche ore di viaggio da Mirinzal e Frechal. Ma non ho avuto il
coraggio o la volontà di colmare quella distanza. Come se avessi
avuto paura di superare lo spazio virtuale che ancora mi separava
da Frechal e nutriva le mie aspettative, i miei desideri, le mie
illusioni. Prima o poi ci tornerò. A São Luís ho incontrato Ivo102 ,
quasi per caso. Ho incontrato Elenice, figlia di Inácio e sorella di
Hélio marito di Márcia madre di Kindè103 e Kindara 104. Forse non
mi sentivo ancora pronto per incontrarli di persona... Poi una sera
ho conosciuto Dimas, uno degli avvocati di Frechal come se il
destino mi avesse guidato in quel bar sulla spiaggia, la praia do
Calhau a São Luís... 105
Bambini quilombolas. 98
Tutte le tematiche più complesse che deve affrontare
l'antropologo sul campo - il problema di come stabilire la propria
autorità, le possibili strategie retoriche con cui affermarla sul
campo e nel testo, il problema dell'opacità dell'oggetto di ricerca,
la violenza dell'intrusione etnografica e la conflittualità tra i
progetti nativi e i progetti antropologici, il carattere costruttivo,
manipolatorio, processuale dell'impresa etnografica e della sua
testualizzazione, le oscillazioni problematiche delle
interpretazioni dell'antropologo tra il generale e il particolare, tra
concetti lontani dall'esperienza e concetti vicini - sono affrontate
nel Quilombo svolgendo direttamente, nella processualità della
scrittura, le ingarbugliate articolazione attraverso cui si
32
NOTE
1
R. Malighetti, Il Quilombo di Frechal, Cortina, Milano, 2004, Pag. 211.
La parola portoghese quilombo deriva dai termini bantu quibundo, kilombu, espressioni con cui si indica l'accampamento, la tenda.
Originariamente, la parola quilombos era usato dai portoghesi per denotare i campi di concentramento provvisori dove venivano
radunati gli africani sulle coste dell'Angola e dell'Africa occidentale, prima di essere imbarcati per le Americhe. Successivamente il
termine passo a designare le comunità di schiavi fuggiti dalle piantagioni e dalle aziende agricole delle colonie portoghesi in Brasile
(Malighetti 2004, op. cit., p. 74). Il vocabolo derivato quilombolas, "abitanti del quilombo", ha un significato analogo a quello di bush
negros ad Haiti, o di marrons nella Guiana e nel Suriname (Malighetti 2004, op. cit., p.14). Al di la della definizione storica ed
etimologica, la definizione di quilombo possiede una polisemia di connotazioni dinamiche che si sono modificate storicamente e
strategicamente anche in tempi recenti a seconda degli scopi di coloro che hanno avuto il potere di stabilirla e di affermarla (Malighetti
2004, op. cit., pp.101, 199-200).
3
Malighetti 2004, op. cit., p. 177. Intervista dell'autore ad Alfredo Wagner De Almeida, 23 Aprile 1996.
4
Malighetti 2004, op. cit.
5
R. Malighetti, Identità e lavoro sul campo nel Quilombo Frechal, 2000. In La ricerca Folklorica, n. 41, pp.97-111.
6
Foto gentilmente messa a disposizione da Roberto Malighetti.
7
Malighetti 2004, op. cit., pp. 3-4.
8
Per una serie di impegni contingenti e per la mancanza di tempo determinata dai termini di consegna della recensione, un'effettiva
dialogia tra me e Malighetti non è stata alla fine realmente possibile limitandosi solo ad un'intervista molto strutturata effettuata a fine
Giugno, ad alcuni brevi incontri informali e alla discussione del testo finale della recensione. Per questa ragione il titolo dell'articolo
che doveva essere: Una recensione dialogica di una etnografia dialogica, è stato trasformato nel titolo attuale: Una recensione
riflessiva di una etnografia dialogica. Nonostante ciò, posso però anche dire che nell'analisi e nella comparazione tra i vari testi
affrontati, le lezioni del docente e le successive interviste, almeno una forma abbozzata di dialogia si è infine realizzata.
9
In particolare le lezioni del 17 e 19 marzo.
10
B. Malinowski, Giornale di un antropologo [A Diary in the Strict Sense of the Terme], Armando, Roma, 1992 [1967].
11
B. Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale, Bollati Boringhieri, Torino, 2004 [1922]. Entrambi i volumi, gli Argonauti e i
diari, erano parte della biografia d'esame che comprendeva anche: U. Fabietti, R. Malighetti, V. Matera, Dal tribale al globale, Bruno
Mondadori, Milano, 2000.
12
Malighetti 2004, op. cit., p. 43.
13
Ibidem, p. 52.
14
Gli storici riportano l'esistenza di molti quilombos. Il Quilombo dos Palmares fu però il più grande per estensione e durata. La sua
origine é anteriore al 1600, e resistette più di 100 anni alle incursioni militari di olandesi e portoghesi. L'epopea di Palmares è legata
alle imprese dei leggendari condottieri Zumbi (1655-1695) e Ganga Zumba. Nato in uno dei villaggi di Palmares, Zumbi, catturato
ancora bambino (c.1660), fu consegnato ad un prete di Porto Calvo, padre Antonio Melo, che lo allevò insegnandoli a servire messa
da chierichetto. Con il suo aiuto Zumbi apprese anche il portoghese e il latino. A 15 anni però fuggi a Palmares e ancora molto giovane
fu capo di una delle tribù del quilombo, fino a diventare nel 1678 il capo delle forze armate dello stato. Dal 1670 al 1680 furono
realizzati dai portoghesi moltissimi attacchi al Quilombo di Palmares. Nel 1694 ci fu un grande combattimento con molte morti dalle
due parti. Infine il quilombo fu distrutto dai cannoni. Nel 1695 Zumbi fu visto nella foresta dello stato di Alagoas comandare un gruppo
di ribelli alla ricerca di armi e munizioni. Il 20 novembre del 1695 Zumbi, tradito da un compagno, fu catturato e assassinato. La sua
testa fu tagliata ed esposta in una piazza pubblica, a Recife. Le terre di Palmares furono divise tra i signori che avevano finanziato la
battaglia finale. Nel 1986, ascoltando le rivendicazioni della comunità nera, le terre in cui esistette il Quilombo di Palmares, nella Serra
da Barriga, furono acquisite dal Governo Federale, creando sul posto il Memoriale Zumbi, dove tutti gli anni, il giorno 20 Novembre,
si realizzano atti pubblici, celebrazioni e commemorazioni. I fatti memorabili qui riportati sono il frutto di una sintesi di una serie di
testi da me raccolti su alcuni siti Internet brasiliani (ad esempio http://www.vidaslusofonas.pt/) mobilitati nel rivalutare la storia degli
schiavi in Brasile. Non hanno quindi un valore storico rigoroso e scientificamente documentato. Possono però essere utili per illustrare
uno dei modi e il tipo di testi attraverso cui oggi si produce un idea diffusa e condivisa della storia e della cultura delle comunità nere
afro-brasiliane.
15
"I grandi proprietari chiudevano un occhio: per loro, quel che importava era esclusivamente la produzione, e purché il negro
conservasse la propria vitalità e la capacità di lavoro, tanto valeva che si divertisse". R. Bastide, I culti afro-americani. In H.-C. Puech,
Storia delle religioni. Colonialismo e neocolonialismo, Laterza, Bari, 1978, p. 49.
16
R. Malighetti 2004, op. cit., p. 52.
17
Malinowski 2004, op. cit., p. 15.
2
33
18
J. Clifford, I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, Torino, 1999 [1988], p. 51.
Cfr. Ibidem, p.52.
20
Malinowski 2004, op. cit., p. 29.
21
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1995 [1953], p. 46.
22
Ibidem, p. 47.
23
B. Malinowski, Coral Gardens and Their Magic, 1935.
24
J. Clifford 1999, op. cit., pp.62-63.
25
Il giorno 26 Aprile 2004.
26
Cfr. M. Parodi, Arte, Religione e Medicina: il ruolo terapeutico e soteriologico dell'alterità presente, in Achab, Rivista Studentesca
di Antropologia della Università Statale di Milano Bicocca, N.1, 2004, pp. 13-20. versione online: www.studentibicocca.it/achab.
27
Malighetti 2004, op. cit., p.6.
28
Cfr. Ibidem, pp. 26-34.
29
Cfr. Ibidem, pp.17-18.
30
Malighetti 2004, op. cit., pp. 56-57.
31
Malighetti 2000, op. cit.; vedi anche Malighetti 2004, op. cit., pp. 64, 67
32
Questa trasformazione paradigmatica sembra qui dimostrare nel modo più evidente e concreto come la dicotomia tra teorico e
descrittivo sia fittizia, la teorizzazione rimandando sempre alla pratica, ai problemi concreti di una particolare situazione di campo e
viceversa l'immediatezza irriducibile dell'evento risultando comprensibile e dotata di senso solo attraverso l'attività teoricointerpretativa dell'antropologia. Cfr. Fabietti, Malighetti, Matera 2000, op. cit., p. 139-140.
33
Si tratta del sottotitolo del Quilombo di Frechal: Identità e lavoro sul campo in una comunità brasiliana di discendenti di schiavi.
34
Cassetta 4, 32'45"- 33'45". La Cassetta 4 contiene la registrazione dell'intervista a Malighetti da me eseguita il 29 Giugno 2004.
35
C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987 [1973], pp. 399-449
36
Clifford 1999, op. cit., p. 57.
37
Malighetti 2004, op. cit., p. 65.
38
Cassetta 4, 23'- 25'.
39
Cfr. ad esempio Malighetti 2004, op. cit., p. 69.
40
R. Malighetti, Il filosofo e il confessore. Antropologia ed ermeneutica in Clifford Geertz, Unicopli, Milano, 1991.
41
Cfr. Clifford 1999, op. cit., pp. 62-64.
42
Può essere utile, per chiarire il mio punto di vista su Malinowski, citare ancora l'introduzione agli Argonauti: "Nel lavoro effettivo
sul campo la comparazione dei dati e il tentativo di metterli insieme riveleranno crepe e lacune nell'informazione che guideranno a
nuove indagini. Per mia esperienza personale posso dire che molto spesso un problema mi sembrava risolto e ogni cosa ben ferma e
chiara finché non cominciavo a buttar giù un breve abbozzo preliminare dei miei risultati. Solo allora mi accorgevo delle enormi
deficienze, che mi indicavano dove vi erano nuovi problemi e mi guidavano ad un nuovo lavoro [...]. Questa fertilizzazione incrociata
fra lavoro costruttivo e osservazione l'ho trovata preziosissima e penso che senza non avrei potuto compiere alcun reale progresso"
(Malinowski 2004, op. cit., pp. 22-23). Riguardo al ruolo della teoria nella ricerca sul campo dice ancora Malinowski: "L'etnografo
non deve solo tendere le sue trappole al posto giusto e aspettare quello che ci cadrà dentro. Deve essere anche un cacciatore attivo [...]
guidato dai più moderni risultati dello studio scientifico [...]. Più problemi porterà con se sul terreno, più sarà disposto a plasmare le
sue teorie in accordo con i fatti e a considerare i fatti come sostegno della teoria" (Malinowski 2004, op. cit., p. 18). Bisogna però
ammettere che Malinowski non è sempre molto lineare nel descrivere il suo punto di vista metodologico: le sue esperienze personali
di ricerca, il suo metodo pratico, contraddicono spesso la sua impostazione teorica. Così, nell'introduzione agli Argonauti, parlando
del ruolo del ricercatore sul campo, afferma in sostanza il contrario di quanto sostenuto solo qualche pagina prima riferendosi alla sua
esperienza personale: "Naturalmente egli può essere insieme un pensatore teorico e uno che lavora sul terreno, e in questo caso può
trarre stimoli da se stesso, ma le due funzioni sono separate e nella ricerca effettiva devono essere separate sia come momenti sia come
situazioni di lavoro" (Malinowski 2004, op. cit., p. 19).
43
Malighetti 2004, op. cit., p. 71.
44
Ibidem, p. 7.
45
Ibidem, p. 56.
46
Ibidem, p. 57.
47
Ibidem, p. 53.
48
Ibidem, p. 53.
49
Ibidem, p. 59. Intervista dell'autore a Marisete, 26 Febbraio 1996.
50
Foto gentilmente messa a disposizione da Roberto Malighetti.
51
Manifestazione che mette in scena la lotta tra due regni africani (Malighetti 2004, op. cit., nota 44, p.43).
52
Cassetta 1, 4'56"- 8'25". Le cassette 1 e 2 si riferiscono alla registrazione integrale della lezione finale del corso tenutasi il 16 Aprile
19
34
2004. Le indicazioni di tempo indicano l'inizio e la fine del brano citato nel testo.
53
Cfr. Malighetti 2004, op. cit., p.65.
54
Cfr. Ibidem, p.68.
55
Nonostante l'autore sia anche molto critico del tipo di analisi etnografica condotta da Geertz, dove, come abbiamo già evidenziato,
e qui è ancora Malighetti a suggerirci le parole, "l'antropologo non è considerato un attore sociale che faccia parte della scena e gli
interlocutori semplicemente sono assenti, o, al più, oggettivati in modo generico" (Malighetti 2004, op. cit., p.69-70).
56
Cfr. Geertz 1987, op. cit.; in particolare il primo capitolo: Verso una teoria interpretativa della cultura (nell'edizione originale
inglese: Thick Description. Toward an Interpretative theory of Culture).
57
Durante l'esame che ho sostenuto con l'autore, l'ultima domanda del professore è stata la seguente: "Mi parli del rapporto tra il caso
particolare e la teoria generale nel Quilombo". Non ricordo più bene cosa gli ho risposto, ma questa domanda ha continuato ad
assillarmi per lungo tempo.
58
Malighetti 1991, op. cit., p.96. Cfr. Geertz 1987, op. cit., p.64.
59
Geertz 1987, op. cit., p. 64
60
Malighetti 2004, op. cit., p.43.
61
Ibidem, p.48.
62
Cfr. C. Geertz, Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna, 1988; in particolare il capitolo terzo: "Dal punto di vista dei nativi":
sulla natura della comprensione antropologica.
63
Cassetta 2, 42'20"- 42'50".
64
Malighetti 2004, op. cit., p.137.
65
Ibidem, p.59.
66
"C'era tutto un capitolo, che è stato omesso, che era un capitolo divertentissimo dal mio punto di vista, sulla storia della trance, della
possessione. C'era tutta la storia delle persone di Frechal che entravano in trance. Il mio problema era che quando ero con loro queste
persone non cadevano mai in trance, ma appena andavo via un attimo, andavano in trance. I miei interlocutori allora mi dicevano: "Hai
visto sei andato via e Mundica è andata in trance". Naturalmente cercavo di capire per loro cosa fosse la trance e se praticavano il
tambor das minas [culto afro-brasiliano basato sulla possessione simile al candomblé di Bahia]. A Frechal non ne parlavano. Così ero
arrivato a pensare che avessero un pensiero esoterico che non volevano rivelare. Se andavo da Mundica e le chiedevo di parlare del
trance lei mi rispondeva dicendo che aveva vergogna a parlarne. Quando le chiedevo cosa facesse mentre era in trance, replicava di
non saperlo appunto perché era in trance. Questa parte intendeva chiarire cosa volesse dire fare ricerca. Poi invece questo capitolo è
stato omesso. Non c'era spazio. Bisogna fare delle scelte sempre dolorose" (Cassetta 2, 24'20"-28'35").
67
Malighetti 2004, op. cit., p.42.
68
Ibidem, p.141. Intervista eseguita dall'autore il 31 Marzo 1996.
69
Fabietti, Malighetti, Matera 2000, p.154.
70
Cfr. Malighetti 2004, op. cit., pp.140-141.
71
Cfr. Ibidem, p.42.
72
Inácio: uno dei leader della comunità di Frechal e il principale informatore dell'autore. Foto gentilmente messa a disposizione da
Roberto Malighetti.
73
Malighetti 2004, op. cit., p.140.
74
Bisogna però ricordare, per non essere fraintesi, che, come dice l'autore, "la fusione di orizzonti è [sempre] fatta da qualcuno, in
questo caso dall'autorità dell'autore che ha autorizzato quella fusione. [...] Non è una fusione che accade nel mondo. Il meticciamento
non è un processo naturale, è il prodotto artificiale di un autore che si è posto in quella prospettiva" (Cassetta 4, 36'20- 36'50").
75
Avvocato dell'associazione SMDDH impegnato nella causa di Frechal contro il fazendeiro.
76
De Almeida Alfredo Wagner: antropologo brasiliano consulente della SMDDH e del PVN (Projecto Vida de Negro); autore di
numerosi libri sui conflitti per la terra nello stato di Maranhão (vedi la biografia in Il Quilombo di Frechal).
77
Malighetti 2004, p. 204. Intervista eseguita dall'autore il 6 Maggio 1996.
78
Ibidem, pp.196-197. Intervista dell'autore a Hélio, 30 Maggio 1996.
79
Ibidem, p.198. Intervista dell'autore a Hélio, 24 Febbraio 1996.
80
Ibidem, p.198. Intervista dell'autore a Hélio, 30 Maggio 1996.
81
Ibidem, p.211. Intervista dell'autore a Inácio, 21 Aprile 1996.
82
Ibidem, pp.211-212. Intervista dell'autore a Inácio, 21 maggio 1996.
83
Ibidem, pp. p.216-217. Intervista dell'autore a Inácio, 21 Maggio 1996.
84
Cassetta 2, 21'26"-24'05".
85
Cassetta 3, 4'. La Cassetta 3 contiene 4 interviste eseguite il 16 Giugno 2004 ad alcuni compagni di corso.
86
Cassetta 3, 6'.
87
Cassetta 3, 12'.
35
88
Cassetta 4, 37'- 38'05".
Geertz 1987, op. cit., p. 69.
90
Cfr. C. Lévi-Strauss, L'identità, Sellerio, Palermo, 1980 [1977], p.131.
91
Cfr. Malighetti 2004, pp.225-226.
92
Cassetta 2, 29'25"- 37'. Vedi anche Malighetti 2004, op. cit., pp. 206- 208.
93
M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino, 1977, p.133.
94
Cassetta 4, -22'25"- 22'40".
95
Cassetta 2, 41'50"- 42'15".
96
Casetta 2, 47'10"- 50'40".
97 Cassetta 1, 19'40- 21'20".
98 Foto di Riccardo Teles, dal libro Terra de preto.
99 Cassetta 3, 44'20"- 47'05".
100
Cfr. U. Eco, Trattato di semiotica generale, Edizioni Bompiani, Milano, XII ed. 1991 [I ed. 1975], cap. 3.7.
101
Dal 19 Luglio al 19 Agosto 2004.
102
Ivo Fonseca Silva attualmente lavora per l'Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (ACONERUQMA). Associazione fondata nel 1997, successivamente al periodo di permanenza dell'autore a Frechal, in occasione del V Encontro de
Comunidades Negras Rurais, Quilombolas e Terras de Preto do Maranhão. L'associazione ha sede in São Luís.
103
La partenza dell'autore, verso la fine del 1996, fu festeggiata (!) con una grande festa di tambor de crioula (danza realizzata in circolo
esclusivamente dalle donne di fronte ai tamburi suonati dagli uomini che battono il tempo e cantano). In quella occasione fu anche
celebrato l'ingresso dell'autore nella comunità come padrino di un nuovo membro del villaggio: Kindè (1995) figlio di Márcia e di
Helio figlio di Inácio (Malighetti 2004, op. cit., p.18).
104
Nome di origine africana che significa abitante del quilombo (Malighetti 2004, op. cit., p.198).
105
Si ringrazia Roberto Malighetti per la disponibilità con cui ha assecondato questa strana esperienza di scrittura "etnografica". Inoltre
tutti gli studenti della Specialistica di Antropologia Culturale che si sono sottoposti pazientemente alle mie assillanti domande sul
Quilombo.
89
36
La coltivazione di papavero da oppio
dilaga in Afghanistan
di Elisa Giunchi
Elisa Giunchi (tratto da: E. Giunchi, "Ridefinizione dell'identità
nazionale e ricostruzione in Afghanistan", in C. Molteni, F.
Montessoro, M. Torri, a cura di, Le risposte dell'Asia alla sfida
americana, Bruno Mondadori, Milano, 2004).
Nel 1999 l'Afghanistan era diventato il maggior produttore di
oppio al mondo, superando il cosiddetto "triangolo d'oro" Thailandia, Birmania e Laos. L'anno successivo il mullah Omar
aveva emesso un decreto che vietava la coltivazione del papavero,
ma non il suo commercio. La produzione si era drasticamente
ridotta, determinando l'aumento dei prezzi dell'oppio e dei suoi
derivati sul mercato internazionale. Nell'autunno del 2001,
approfittando dell'assenza di un'autorità centrale, in varie regioni
del paese i contadini avevano ricominciato a seminare papavero
da oppio. Nel gennaio successivo Karzai aveva vietato la
produzione, la raffinazione, l'uso e l'esportazione di oppio,
fornendo nel contempo incentivi ai contadini che distruggevano i
propri raccolti. Ma dinnanzi al limitato controllo centrale sulle
province e in mancanza di colture alternative altrettanto
redditizie, il divieto di Karzai non ha avuto alcun effetto e la
produzione di oppio è continuata ad aumentare. Già nel 2002 sono
state prodotte 3.422 tonnellate di oppio. Nel 2003 il raccolto è
cresciuto del 6%, arrivando a 3.968 tonnellate, vicino ai livelli
record del 1999. A questi sviluppi hanno contribuito le condizioni
climatiche, che hanno migliorato la produttività del terreno, e
l'aumento della superficie coltivata a papavero da oppio, reso
possibile dall'assenza di un controllo capillare del governo e di
alternative economiche serie. Nel 2003, in effetti, la coltivazione
di oppio si è estesa su 28 province rispetto alle 24 del 2002,
passando da 30.750 ettari a 61.000. Un altro sviluppo
preoccupante è rappresentato dal fatto che l'oppio afgano viene
37
sempre più spesso raffinato nel paese, tanto che, ormai, solo il
30% è esportato allo stato grezzo. Il valore delle esportazione di
oppiacei, inclusi i loro derivati, è oggi di 2,3 miliardi dollari, una
cifra equivalente al 50 % del Pil afgano. I contadini coinvolti nella
produzione, circa il 7% della popolazione, ne ricavano introiti ben
superiori al reddito medio. Ma i principali beneficiari del
narcotraffico sono altri: signori della guerra, commercianti e
trasportatori, militanti islamici. Le aree di Helmand, Kandahar e
Nangarhar, tradizionalmente centri della coltivazione di papavero
da oppio, sono controllate dai talibani, mentre la produzione di
oppio nella provincia settentrionale di Badakhshan, che nel 2003
è diventata la terza provincia produttrice, è controllata dal partito
estremista Hezb-i-Islami. Ed è proprio il legame tra estremismo e
oppio che ha convinto Washington ad assumere nell'autunno del
2003 un ruolo più attivo nella lotta al narcotraffico, finora guidata
dalla Gran Bretagna. Non è ancora nota la strategia che sarà
seguita dagli Stati Uniti, ma è chiaro che la distruzione delle
coltivazioni, qualora non sia parte di una strategia più vasta di
collaborazione regionale e di incentivazione economica, rischia di
essere poco efficace, se non addirittura controproducente. La
questione dell'oppio afgano è complessa e presenta un dilemma di
difficile soluzione: non vi può essere ricostruzione e sviluppo
economico (e, quindi non è realistico pensare di poter offrire
opportunità economiche alternative alla coltivazione dell'oppio)
senza che sia ristabilita la sicurezza e senza che vi sia un governo
centrale stabile; ma, in mancanza di opportunità economiche
alternative, la coltivazione di oppio continuerà e, di conseguenza,
rafforzerà i signori della guerra e gli estremisti, cioè coloro che
hanno solo da guadagnare dall'attuale instabilità e
frammentazione del potere.
Alla confluenza di due oceani
Sincretismi, ibridazioni e compresenze
fra tradizioni indù e musulmane in India
di Giulia Renata Maria Bellentani
1. Una cartolina dall'India, terra di scontro e d'incontro
musulmani venne ad inserirsi una terza voce, quella della potenza
coloniale perché questa sarebbe un'altra storia ancora da
raccontare. La storia di come gli indù impararono a considerarsi
sempre più indù, separati dai musulmani e i musulmani
impararono a considerarsi sempre più musulmani, separati dagli
indù; e i due gruppi non parlarono più l'industani, ma l'hindi e
l'urdu, censiti come diversi nello stesso territorio. Questa sarebbe
davvero un'altra storia da raccontare. Una storia tragica.
Kolkata, West Bengal, fine Marzo 2003.
E' il capodanno Sind.
Un corteo di persone festanti si snoda lungo la strada. C'è "l'area
delle danze", rigorosamente al maschile, ci sono gli immancabili
portatori di lampade a gas sulla testa, ci sono carri con persone
che offrono cibo; carri che portano immagini, credo, di santi
musulmani; carri che portano generatori per illuminare altri carri.
Conosco ben poco della storia e dell'iconografia di tradizione
islamica perciò non riesco a comprendere quali siano le
personalità omaggiate, ma non ho alcun dubbio sull'immagine
trasportata per prima: è una divinità indù.
E' Ganesh, è Ganapati, il dio dalla testa d'elefante, il figlio di
Parvati, "colui che rimuove gli ostacoli", il "Signore della
saggezza", ecc… ed è qui con la comunità Sind festante! Capisco
il perché della sua presenza: il suo carro è bellissimo, con neon
multicolori intermittenti, veramente degno di aprire il corteo.
Perciò perché formalizzarsi e non farlo partecipare, stracarico di
bimbi nei loro abiti più belli?
D'altronde al Durga Puja insieme alle immagini di Durga viene
portata in processione anche la Madonna cristiana,
opportunamente adornata!1
2. Storia dell'India ANCHE islamica
2.1 L'arrivo dell'islam in terra indiana
La tradizione vuole che l'Islam sia stato introdotto in India da un
mercante dell'attuale Kerala, Cheramen Perumal, di ritorno
dall'Arabia dove era stato convertito dal Profeta alle cui
predicazioni aveva assistito. Cheramen Perumal sarebbe il
fondatore della prima moschea indiana, situata nella cittadina di
Cranganur, nei pressi di Cochin.
Effettivamente la comunità musulmana del Kerala è la più antica
dell'India; la sua origine risale molto prima dell'epoca delle
conquiste musulmane e, soprattutto, occorre ricordare che queste
non avvennero mai in questa zona meridionale dell'India.
Questo ci dimostra che l'arrivo dell'Islam in India fu un processo
che non avvenne solo con la forza militare, con lo scontro di
culture narrato nei testi degli storici, ma fu anche un'ovvia
conseguenza degli intensi scambi commerciali che l'India
intesseva con le altre terre con viaggi di merci, uomini,ma anche
di idee, pensieri, approcci.2
Anche il nord dell'India vide la penetrazione del pensiero islamico
prima della sua definitiva conquista. Infatti l'islam cominciò a
diffondersi sia nella vallata del Gange sia nel Gujarat nei decenni
centrali del XI secolo, cioè in un periodo in cui né l'una né l'altra
di queste regioni erano ancora passate sotto il controllo di stati
retti da monarchi islamici. Qui la conversione fu opera dei mistici
sufi, di cui parleremo più avanti.
Il processo di conversione fu quindi indipendente dal processo di
conquista.
Questa è l'India di cui voglio parlare.
L'India non è solo terra di fondamentalismi, di scontri tragici fra
appartenenti alle varie tradizioni. Non c'è solo Ayodhya, simbolo
estremo del fanatismo religioso e delle tragedie che questo
comporta, anche se i nostri mezzi di comunicazione solo questo
riportano.
L'India è anche un luogo dove numerose tradizioni religiose
coesistono, spesso influenzandosi reciprocamente non solo nella
tradizione popolare di oggi ma anche nella storia di questo paese,
che è caratterizzato non tanto da scontri quanto da coesistenze e
ibridazioni.
Voglio parlare non dell'India dei fondamentalismi, ma dell'India
che sa essere sia indù che musulmana. Per questo cercherò nella
sua storia i momenti in cui le due tradizioni religiose si sono
incontrate, e non scontrate, dando anche talvolta origine a nuove
espressioni di sentimento religioso. Perché il confronto con
l'Altro non può risolversi solo in reciproca chiusura ma anche in
dialogo, in ricerca di somiglianze e creazione del nuovo.
Per quanto riguarda l'arrivo dell'islam in armi, le prime incursioni
avvennero nel Sind, conquistato da Muhammad bin Qasim nel
711 - 712.
Successivamente i governatori arabi del Sind, dopo aver ultimato
la conquista della valle dell'Indo, avevano lanciato una serie di
scorrerie e tentativi di invasione contro il resto dell'India, a cui i
principi rajput3 si opposero con successo. Più difficile fu
Scelgo di trascurare il periodo in cui nel dialogo fra indù e
38
fronteggiare le invasioni dei signori della guerra turchi che
avevano Ghazni (Afganisthan) come capitale4. Questi riuscirono
ad impossessarsi di Peshawar e delle zone circostanti e da qui,
successivamente compirono una serie di incursioni che misero a
ferro e fuoco una larga parte della vallata indo-gangetica, con
l'obbiettivo non tanto della conquista quanto della razzia
(soprattutto delle grandi ricchezze accumulate nei templi).
Circa due secoli dopo questi avvenimenti ci fu un altro
conquistatore turco - afgano che penetrò nella vallata gangetica:
Muhammad, principe di Ghur, che pose le fondamenta di quello
che sarà il primo regno musulmano in India, il Sultanato di Delhi.
Muhammad Ghuri penetrò nella valle dell'Indo nel 1175,
conquistandone uno dopo l'altro i principati arabo-islamici e da
qui proseguì arrivando a conquistare rapidamente le immense
distese della pianura gangetica. Con la sua morte, e con la morte
del fratello, questi territori non fecero più parte del sultanato di
Ghur ma vennero affidati ai generali di Muhammad e il più
potente di questi nel 1206 assunse il titolo di sultano iniziando
così la storia del sultanato di Delhi, anche se questa divenne la
capitale solo col suo successore.
Il periodo del sultanato di Delhi gettò le basi di una società
islamica caratterizzata da una commistione di aspetti islamici e
non islamici nell'ideologia dello stato e nella cultura popolare.
Dopo la disgregazione del sultanato di Delhi e dopo un trentennio
di guerre venne creato un nuovo stato imperiale musulmano:
quello mughal, così chiamato perché il fondatore Sahir ud-Din
Muhammad, detto Babur ("tigre"), di stirpe timuride vantava
un'assai incerta parentela con Gengis Khan, il conquistatore
mongolo.
L'egemonia mughal durò circa duecento anni: dal 1526 fino alla
conquista coloniale britannica.
interna e le conversioni locali) fecero sì che fossero presenti tutte
le varianti dell'islam: comunità religiose sunnite e comunità sciite,
con un pluralismo di gruppi etnici e di movimenti, che si
ispiravano alle concezioni degli ulama, dei sufi e dei riformatori.
L'India mantenne sempre la sua caratteristica di presentare una
coesistenza, talvolta sofferta e talvolta serena, di numerose
tradizioni religiose.
2.2 Il buongoverno, fra indù e islam
I governi musulmani nel subcontinente indiano si caratterizzarono
da subito per l'attiva partecipazione di esponenti indù. Già il
conquistatore arabo del Sind, Muhammad bin Qasim (sec. VIII) si
rese conto che l'uso puro e semplice della forza era improponibile
per governare una popolazione assai più numerosa per cui scelse
la collaborazione con le precedenti classi dirigenti, stabilendo il
modus operandi poi usato dal sultanato di Delhi e,
successivamente, dal regno moghul.
A tutte le popolazioni conquistate venne esteso lo status di
dhimmi (cioè individui "protetti" in cambio del pagamento di una
tassa pro capite) nonostante l'interpretazione letterale del Corano
lo riservasse ai "popoli del libro", cioè ebrei e cristiani. 5
I conquistatori dovettero appoggiarsi ai brahmani, detentori del
prestigio e delle conoscenze necessarie al governare, per creare
un'amministrazione ordinata, efficiente e potente. Si stabilì così
un rapporto d'interdipendenza fra l'élite brahmana e i regnanti
islamici.
L'ascesa al potere temporale di sovrani musulmani determinò una
nuova situazione per cui l'islam divenne la religione della nuova
classe dominante e convertirsi ad essa divenne per le classi agiate
il passaporto per accedere ai vertici della società.
Anche le classi più povere, in particolare dalit e tribali avevano
una forte motivazione sociale per convertirsi all'islam: quella di
sfuggire alla rigida classificazione indù che li vedeva come
intoccabili fuori casta. Questo processo vede una progressiva
islamizzazione della popolazione con l'espandersi dell'agricoltura.
Ciò avvenne specialmente nel Punjab occidentale (al tempo del
sultanato di Delhi) e nel Bengala orientale (con l'impero mughal)
a seguito della colonizzazione interna promossa dai nuovi
dominatori musulmani interessati ad ampliare gli insediamenti
agricoli. Le popolazioni sedentarizzate vennero incoraggiate a
convertirsi all'islam; incoraggiate, ma mai obbligate poiché la
religione islamica non venne mai imposta con l'uso della violenza.
La conversione all'islam si diffuse progressivamente con la
creazione di stati retti da dinastie islamiche, ma ciò non portò mai
alla completa conversione degli abitanti del subcontinente:
sembra poco probabile che più del 20 - 25 per cento della
popolazione sia mai divenuto musulmano. Inoltre le varie fonti da
cui l'islam era giunto (le migrazioni dal Medio Oriente e dall'Asia
39
Gli indù furono coinvolti attivamente: nelle loro mani c'era
l'amministrazione, i vertici dell'apparato fiscale e molte delle
attività legate all'economia e al commercio, incluso il conio di
nuove monete. L'influenza di questa elite era così forte che forse
questo spiega il fatto che le monete coniate nel sultanato di Delhi,
dal tempo di Muhammad fino al 1290, se presentavano da un lato
la shahada (la dichiarazione dell'unicità di Dio) in caratteri arabi,
dall'altro portavano impressi simboli religiosi indù quali la dea
Lakshmi 6 o il toro Nandi 7.
Obiettivo prioritario dei regnanti era il buon funzionamento dello
Stato, piuttosto che la diffusione dell'islam.
Già Balban (sultano di Delhi dal 1266 al 1287) ammetteva con
cinico realismo che la realizzazione pratica di un governo basato
sulla sharia non era più attuabile nel mondo contemporaneo; Alaud-din Khaliji (sultano dal 1296 al 1316) esplicitamente
confermava: "Per quanto non abbia studiato la Scienza (religiosa)
o il Libro (il Corano), sono un musulmano discendente da
musulmani. Per prevenire la ribellione, nella quale a migliaia
muoiono, io promulgo quegli ordini che ritengo buoni per lo stato
e per il bene del popolo. Non so se ciò sia secondo la legge
(islamica) o a essa contrario (ma) qualsiasi provvedimento io
ritenga essere per il bene dello stato o adatto in un caso di
emergenza, quello io decreto." 8
Dovere, e scopo, del monarca era guardare soltanto al bene
pubblico.
L'adattamento fra la nobiltà sultaniale e gli strati privilegiati della
società indù (mercanti, finanzieri e aristocrazia rurale) fece sì che
essa, pur continuando a sentirsi parte integrante dell'umma
(comunità) musulmana si indianizzasse sempre di più dal punto di
vista culturale.9
Ci furono così un numero crescente di traduzioni in lingua
persiana di opere sanscrite, trattati in persiano sulle espressioni
artistiche indiane e una produzione poetica che esaltava questa
terra e i suoi abitanti. Sultani musulmani come Muhammad bin
Tughlak presero l'abitudine di osservare festività indù, di
intrattenersi con yogi indù e di onorare gli asceti jaina. Fino ad
arrivare al tentativo d'un colto principe moghul10 di trovare la
completa identità fra sufismo islamico e vedanta indù.
Questo processo di adattamento e riconoscimento dell'Altro fu
tutt'altro che fluido e uniforme, presentò una serie di
contraddizioni clamorose ma diede anche vita a interessanti
sperimentazioni di convivenza e incontro.
3. Gli ingredienti della religiosità nel subcontinente
In India si incontrarono quindi induismo e islam: una tradizione
religiosa antichissima ricca di innumerevoli variazioni e un credo
assai recente ma non per questo privo di una pluralità di
atteggiamenti.
3.1 Cenni sull'induismo ( e non solo)
Induismo è un insieme di religioni così variegato e complesso che
è più corretto parlare di tradizione indù11, all'interno della quale si
possono inserire anche buddismo e jainismo, considerate dai non
indù come religioni autonome, ma viste dagli indù come varianti
più o meno eterodosse della tradizione.
3.1.1 All'origine: i Veda
All'origine vi sono i Veda, composti probabilmente intorno al
1500 - 800, per la tradizione sono molto più antichi e privi di
autore: non composti dagli uomini e neppure dettati da un Dio, ma
visti dai veggenti.
I Veda contengono inni dedicati a numerose divinità, canti
liturgici per la celebrazione dei sacrifici, descrizioni della
magnificenza delle divinità, formule magiche, incantesimi,
preghiere con richieste di beni e felicità. In essi viene anche
presentata una prima riflessione sull'origine e composizione del
mondo, da cui si evince una concezione estremamente stratificata
della società che pone ai vertici del prestigio la classe sacerdotale
bramana.
3.1.2 I Vedanta, "fine dei Veda" e inizio della riflessione
monistica. Il pensiero di Shankara.
Nel corso della seconda metà del primo millennio a. C. la
crescente insoddisfazione nei confronti di una ritualità vedica
sempre più complessa e i cambiamenti sociali dovuti all'emergere
di una nuova classe mercantile portarono alla nascita di nuove
correnti di pensiero.
La tradizione vedica, vissuta ormai come ovvia e limitata venne
rinnovata con nuovi testi e commentari e nacquero anche nuove
forme di pensiero eterodosso che da essa si discostavano (o
addirittura la rifiutavano), quali il buddismo 12 e il jainismo 13.
A questo movimento di rinnovamento appartengono i Vedanta 14 ,
ovvero "fine dei Veda": reinterpretazione delle loro verità
universali e ultimo dei commenti considerati come scritture
rivelate dagli indù ortodossi
Nei Vedanta viene enunciato il "grande segreto" dell'identità tra
anima universale (brahman) e anima individuale (atman) per cui
tutti gli esseri e tutte le cose sono compartecipi dell'anima
cosmica15 , da essa hanno origine e a essa faranno ritorno.
Oltre al pensiero monistico le Upanishad apportarono l'idea del
distacco dal mondo, la concezione ciclica della vita, l'attenzione
dedicata alla contemplazione attraverso particolari tecniche di
meditazione e molti secoli dopo furono alla base del pensiero di
uno dei più importanti filosofi indù: Shankara (788-820),
massimo esponente della scuola Vedanta (o Advaita: "senza un
secondo") che per il suo monismo sarà una delle principali
interlocutrici della tradizione islamica16.)
Shankara, brahmano del Kerala, diede un contributo
fondamentale alla sistematizzazione filosofica dell'induismo:
tramite integrazione, selezione e sintesi delle tradizioni
preesistenti elaborò un sistema filosofico omogeneo di grande
raffinatezza, dando giustificazione intellettuale alle varie forme di
religiosità popolare inglobate nella tradizione brahmanica.
Rifacendosi alle Upanishad, Shankara afferma che esiste un'unica
realtà, il Brahman, e ogni manifestazione di pluralità è
un'illusione. La pluralità degli esseri viventi è avvertita come
realtà a sé stante e l'anima individuale è vista come differente
dall'anima universale solo a causa di una scorretta percezione.
Questa illusione di dualità lega l'anima individuale al ciclo senza
fine di morte e rinascite e va superata attraverso la corretta
percezione, attraverso la conoscenza.
Sono possibili due vie per arrivare all'unione con l'Assoluto. La
prima è quella del superamento dell'illusione e della completa
identificazione nel Brahman. La seconda, per chi non ha grandi
doti intellettuali, è quella della religiosità popolare: la devozione
ed unione con la divinità Brahma, che, come ogni manifestazione
di pluralità, è illusione ma che attraverso essa permette il
raggiungimento dell'Assoluto di cui anche Brahma è parte.
3.1.3 Il brahamanesimo "classico"
A partire dal V sec. a C, come si è detto, vi fu una crescente
insoddisfazione nei confronti della religione vedica e la
fondazione di due nuovi pensieri spirituali: jainismo e buddismo,
che si diffusero rapidamente in tutta l'India, evolvendosi e
modificandosi.
Dopo circa un millennio la tradizione dei Veda, preservata dai
40
bramani, ritornò ad essere la religione principale, seppur
profondamente modificata.
I numerosi dei vedici quasi scomparvero, relegati a ruolo di
secondo piano rispetto a nuove divinità legate a culti locali. Fra i
nuovi dei assunsero primaria importanza Brahma (il dio creatore),
Vishnu (il dio conservatore) e Shiva (associato al preesistente
culto fallico della fertilità e considerato il distruttore). Si formò
una tradizione religiosa secondo cui Vishnu e Shiva17
discendevano periodicamente su questa terra, sotto varie forme
col fine di ristabilire l'ordine e di eliminare il male (lo stesso
Buddha venne cosiderato manifestazione di Vishnu.)
Vennero riproposti i concetti presenti nelle Upanishad di
brahman e di incarnazione. Vi furono anche derivazioni dal
pensiero buddista e jaina: il concetto di "non violenza" dei jaina e
l'importanza data al retto comportamento morale con
l'introduzione della necessità di una via etica per congiungersi al
brahman18.
Permaneva però la subordinazione alla classe sacerdotale
brahmanica; il processo di rinnovamento infatti non coinvolse la
suddivisione sociale, confermata se non ulteriormente irrigidita.
Una caratteristica fortemente innovatrice del tantrismo, forse
derivata da preesistenti culti autoctoni, era l'enfasi data alla forma
femminile della divinità, che ebbe come conseguenza l'emergere
della Devi (la Dea) e la comparsa accanto alle divinità maschile
di dee dotate di grandi poteri (sia in ambito indù20 che buddista21).
Anche il tantrismo si proponeva come via per il conseguimento
della liberazione attraverso il superamento della dualità per il
raggiungimento dell'Unione, ma questa non era necessariamente
solo metaforica.
3.1.4 La via dello Yoga
Il termine bhakti significa "devozione", "venerazione" e a sua
volta deriva da bhaj che, in contesto religioso, vale per
adorazione amorosa o devozione, ma ha anche il valore di
"condividere, prendere parte, godere". Implica quindi devozione
verso una singola divinità ma anche magica associazione fra
sacrificante e divinità, reciproca partecipazione..
Dando l'accento alla mistica unione col divino in un rapporto
personale d'amore il movimento bhakti rende inutile
l'intermediazione rituale del bramino22 e introduce l'uso dell'icona
come livello di congiunzione tra fedele e il suo dio 23 .
3.1.6 Solo amore e devozione: la bhakti
Nel medioevo indiano nacque e si diffuse un'altra corrente indù:
la bhakti, dottrina della liberazione attraverso la fede, in esplicita
opposizione alla dottrina vedica della liberazione attraverso le
opere o la conoscenza. Libera dalle raffinate speculazioni
filosofiche di Shankara e non interessata all'esoterismo dei
Tantra, presentava un solo scopo: amare, amare profondamente il
Divino, perdendosi in questo amore, smarrendo il proprio io per
giungere all'Assoluto.
All'interno dell'induismo, ma basata sui culti preesistenti, è la
pratica dello yoga, che si vuole fondata da Shiva, chiamato anche
il Grande Yogi.
Il termine yoga significa "atto di aggiogare ad un altro": aggiogare
mente e corpo al fine di ottenere una perfetta unità al di là dei
limiti del pensiero e del linguaggio. Solo in un secondo tempo
questa unione sarà intesa anche come unione col Divino.
Durante il suo sviluppo lo yoga si servì di diversi strumenti per
raggiungere i propri scopi: dagli incantesimi all'osservanza di
doveri religiosi e condotte morali fino alle pratiche di ascetismo.
In particolare ricordiamo le tecniche per il controllo del corpo e
del respiro; la ripetizione di formule magiche e il completo
assorbimento di sé nella contemplazione di un oggetto.
Sotto il termine induismo convivono quindi una pluralità di
sentimenti religiosi, articolati e complessi, che hanno conosciuto
infinite variazioni e rielaborazioni nel corso dei millenni.
In particolare le teorie del vedanta e del tantra, nonché le
tradizioni popolari della bhakti, seppero dare vita a fedi in
un'Unica Realtà Assoluta le quali si intrecciarono col lato più
mistico dell'islam, il sufismo, accomunate dalla ricerca
dell'unione con l'Assoluto rimanendo nell'esistenza.
3.1.5 La venerazione della Devi: il pensiero tantrico
Altro grande periodo di rinnovamento del pensiero religioso fu il
medioevo indiano (intorno al VII sec.) con la speculazione
filosofica di Shankara e la diffusione di nuove correnti che
proponevano metodiche di avvicinamento al divino senza
l'intermediazione brahmanica.
In quest'epoca si diffuse il tantrismo19 che si declinò sia in forma
indù che in forma buddista (soprattutto in Tibet).
Caratterizzato da un forte esoterismo, il tantrismo prevedeva
l'utilizzo di riti magici e di incantesimi che, attraverso il controllo
del corpo e dell'universo fisico, permettono di ottenere la
liberazione dalla realtà materiale e l' interruzione del ciclo di
morte e rinascita. Data la forte componente esoterica era una
pratica riservata ai soli iniziati, di non importa che casta o genere,
a cui veniva anche prescritta l'infrazione delle regole morali
dell'epoca.
3. 2 Cenni sull'islam (soprattutto sul sufismo)
3.2.1 L'islam
Col termine islam si definisce sia la religione islamica sia la
comunità dei fedeli che la professano.
La parola deriva dalla radice slm che significa "essere incolume",
"essere sicuro" e più specificatamente "affidare", "rimettere
qualcosa al giudizio di qualcuno" ed esprime una "concreta e
attiva sottomissione alla volontà di Dio".24
Il termine muslim, che solo in un secondo tempo designò gli
appartenenti all'islam, significa essenzialmente "monoteista" e
pone così l'accento sull'aspetto fondamentale di questa dottrina
41
religiosa.
Il punto centrale della dottrina islamica è espresso nella
dichiarazione di fede islamica (la shahada, "testimonianza") che
recita: "non c'è altro dio all'infuori di Dio e Muhammad è il suo
profeta". L'islam è quindi una religione fortemente monoteistica
annunciata sulla terra da un profeta, Muhammad, che si poneva
come ultimo in una tradizione cominciata con Adamo e
continuata coi profeti della tradizione ebraica.
Muhammad ibn Abdullah (570 - 632 d. C.) 25 all'età di quarant'anni
ricevette la prima rivelazione divina per bocca di Gabriele. La
rivelazione continuò negli anni successivi.
Le parole di Dio recitate da Muhammad ai fedeli, espresse in
versetti articolati in sura, vennero da questi raccolte e trascritte
dopo la morte del profeta, dando origine al Sacro Corano26. Il
Corano raccoglie quindi la parola stessa di Dio, da Lui trasmessa
attraverso l'angelo Gabriele27 al Profeta affinché questi la rendesse
nota agli uomini. Il messaggio è rivolto ad ogni essere umano
perché ogni essere umano è uguale agli occhi di Dio.
Questa eguaglianza viene ribadita dal Profeta nel suo testamento
spirituale, il Discorso d'Addio dove afferma: "tutti voi discendete
da Adamo, e Adamo era fatto d'argilla. Non c'è superiorità di un
arabo su un non arabo, né di un non arabo su di un arabo, né vi è
quella di un bianco su di un negro, né quella di un negro su di un
bianco, se non la superiorità guadagnata attraverso la
consapevolezza di Dio. In verità, il più nobile fra di voi è colui
che è più profondamente consapevole di Dio." 28 Ma vengono
stabilite anche delle disuguaglianze: tra musulmano e dhimmi; tra
ricchi e poveri, tra padrone e schiavo e tra maschio e femmina.
Fondamentale è il rispetto delle virtù raccomandate: moderazione,
equilibrio, timore di Dio, rispetto per la conoscenza, clemenza,
protezione dei deboli, decoro personale, e l'adempimento dei
propri doveri verso Dio, verso la comunità e verso la società in
genere.
Centrale è il concetto di dovere. Ad esempio, la preghiera è intesa
come adempimento di una precisa volontà divina, rispetto del
contratto che l'uomo ha con Dio e non come momento di
avvicinamento del credente alla divinità.
conservata nel cuore del Profeta e trasmessa solo ad alcune
persone scelte. La prima conoscenza è presente nell'insegnamento
dottrinale degli ulama mentre la seconda, strettamente esoterica,
è il mistico percorso sufi che rappresenta quindi la dimensione
interiore ed esoterica dell'Islam
Il sufismo si sviluppò attraverso diverse fasi.
I primi sufi erano musulmani ortodossi nel loro credo e nelle loro
pratiche: non avevano ancora iniziato le speculazioni metafisiche
e teologiche ed erano caratterizzati solamente dall'intenso timore
di Dio e del suo giudizio e dalla rinunzia ai piaceri del mondo.
Rinuncia e povertà erano però viste non come meritorie in sé, ma
come espressione della devozione verso Dio. Importante era
infatti non tanto l'assenza di beni, e quindi la mortificazione (che
non è mai richiesta dall'islam), quanto il completo superamento
del loro desiderio perché l'unico vero appagamento viene dalla
devozione a Dio.
In un secondo periodo i sufi, pur non abbandonando il loro ideale
ascetico, centrarono sempre di più la propria attenzione sulla
gnosi. In questo cambiamento giocarono un ruolo gli influssi del
neo-platonismo, gli insegnamenti parsi, indiani e buddisti ed
anche il misticismo speculativo cristiano. Il criterio discriminante
è stato quello di accogliere nella propria tradizione quegli aspetti
che fossero di supporto al concetto fondamentale dell'unicità
dell'esserci. E' caratteristica del sufismo la costante tendenza di
tentare la riconciliazione dell'islam ufficiale con pratiche e
tendenze di origine non musulmana, come ben vedremo nelle
vicende indiane di epoca moghul.
L'approccio al divino dei maestri sufi era basato sull'esperienza
diretta di Dio da parte del singolo, in un rapporto estatico che
veniva descritto come un totale rapporto d'amore del fedele nei
confronti dell'Assoluto. La realizzazione di questo rapporto era
perseguita anche attraverso l'utilizzo di tecniche particolari, fra
cui il controllo del respiro e l'invocazione dei nomi di Dio, basata
sull'utilizzo di parole o sillabe che venivano affidate dai maestri ai
discepoli.
3.2.2 La tradizione sufi
Come abbiamo visto, l'Islam era già presente in India all'inizio del
VIII sec., ma si diffuse in particolare nel periodo XII - XIII sec,
proprio con la predicazione dei maestri sufi che non solo si era
inserita nel sentimento religioso popolare della bhakti, ma godeva
anche di una particolare predilezione da parte dei regnanti
musulmani. Questi infatti si trovavano a dover dare coesione
culturale e ideologica ad un vasto territorio con una cultura
originaria profondamente diversa. Tentarono quindi di attenuare
le rivalità fra le fazioni, consolidare l'unione tra i musulmani e
integrare gli indù al potere. Per fare ciò l'ideale era appoggiarsi
alle confraternite sufi perché erano ben integrate nella mentalità
dell'epoca e avevano una concezione gerarchica del potere.
Nel subcontinente indiano furono così presenti numerose
confraternite sufi e vennero fondate anche diverse loro sedi,
chiamate khanqa, comprendenti oltre alle sale per le riunioni e per
l'audizione mistica, anche cucina29, celle per il ritiro dei residenti
3.2.3 Confraternite sufi in India
Ci interessa in particolare la tradizione sufi poichè ebbe un ruolo
di
primo
piano
nell'islamizzazione
dell'India
e,
contemporaneamente, dall'altro venne da questa influenzata.
Secondo alcuni il termine sufi è derivato dall'arabo safa,
"purezza"; secondo altri da suf, lana poiché nei primi tempi gli
asceti indossavano vesti di lana come simbolo della volontaria
povertà. Ma c'è anche chi sostiene che questo termine è troppo
sublime per essere derivato da alcunché: esso ha valore per la sua
pregnanza acustica, è una sillaba sacra.
Questo vocabolo iniziò ad essere usato intorno al 815 d. C., ma
ciò a cui si riferisce, l'esoterismo islamico, era già presente alla
morte del Profeta.
Il sufi ritiene che Muhammad ricevette due rivelazioni: una,
contenuta nel Corano, è accessibile a tutti; l'altra, invece, venne
42
e alloggi per gli ospiti, nonché, a volte, la tomba del maestro.
Costruite spesso ai margini delle città, le khanqa fungevano da
centri di accoglienza per pellegrini di tutte le religioni.
divino con tecniche mistiche e, possedendo poteri sovrannaturali,
aiutano fedeli e anche sovrani nei problemi del mondo.
A livello di credenza popolare c'è corrispondenza fra le devozioni
che si effettuano sulle tombe dei santi ed i culti indù31.
L'ordine che ebbe sempre maggior importanza in India fu la
Cishtiya, fondata da un maestro sufi proveniente da Samarcanda:
Mu'in - ud - Din Chisti (1141 - 1236) che, dopo molti anni di
studio e peregrinazioni, si era stabilito in India, ad Agmir, dove si
era sposato ed aveva fondato la sua khanqa. L'ordine, attivo
ancora oggi, è improntato ad ampia tolleranza, non violenza e
carità.
" Spesso le analogia fra le concezioni, le tecniche e il modo di vita
dei sufi rispetto a quelle dei locali sant'uomini bhakta erano così
forti che i maestri sufi furono in grado di portare avanti il loro
apostolato in India senza essere percepiti dal popolo comune
come diversi dai maestro bhakta.32"
Particolarmente attivi in ambito politico furono la Suhrawardiya e
la Naqshbandiya.
La Suhrawardiyya, fondata da 'Abu al-Qahin AbuNagib alSuhrawardi (morto nel 1168) e diffusa in India ad opera del
nipote, ammetteva più degli altri ordini il coinvolgimento del
fedele nella vita sociale e politica.
Alla Naqshbandiya.faceva riferimento uno dei più noti pensatori
sufi indiani: Shah Wali Ullah, esponente della corrente opposta a
quella che andiamo ad analizzare. Scopo di Shah Wali Ullah era
epurare il misticismo islamico di tutte le influenze esterne e
trassformarlo in una concezione teo-politica per la supremazia
dell'islam e il potere sunnita.
Diffuse particolarmente fra i ceti alti legandosi alle elite locali era
la Sattariya, fondata da 'Abd Allah Sattari (morto nel 1485),
giunto in India dall'Iran.
Fra gli ordini che, invece, rifiutavano la vita mondana ed erravano
per il paese ricordiamo la Malamatiyya e la Qalandariyya.
I Malamati, "quelli del biasimo" facevano voto di povertà non
accettando neppure l'elemosina ed erano contro le manifestazioni
esteriori della fede (in un certo senso anche contro i sufi secondo
il concetto per cui è vanagloria palesare anche la santità).
La Qalandariyya deriva il nome da qalandar: "vagabondo che si
attira il biasimo con una condotta scandalosa e libertina". Sono
considerati una discendenza dalla Malamatiya, oggi sono
riassorbiti dalla Cishtiyya e spesso ricordati nei testi di musica
qawwali.
3.3 Cenni, discorsi e conversioni fra sufi e indù
Gli insegnamenti sufi ben si armonizzavano con la dottrina indù
della bhakti poiché identificano in Dio l'oggetto dell'amore
dell'asceta. Inoltre, questa non è la sola analogia riscontrabile fra
le due dottrine e le figure ad esse collegate.
La concezione sufi di Dio è simile a quella indù di brahaman.30 .
La relazione fra il murid (discepolo) col suo pir (precettore
spirituale) presenta strette similitudini con la devozione del
discepolo verso il proprio guru: così come nessuno può diventare
sufi senza l'aiuto di un pir, allo stesso modo fra gli indù chi
desidera intraprendere un cammino spirituale deve in prima
istanza cercare il proprio guru.
Il sufi e il rinunciante indù, lo yogi distaccato dal mondo dotato di
poteri magici, hanno lo stesso ruolo: ambedue hanno accesso al
E così Muin-ud-din Chisti non solo riuscì a convertire il raja
locale, Ram Deo, con la sua predicazione ma la tradizione
racconta anche che, coinvolto in una sfida dialettica col bhakti yogi
shaiva Jaipal33, riuscì a convertire Jaipal stesso, che grande
reputazione di santità.
Uno dei discepoli di Muin-ud-din Chisti, Farid-ud-din Gan-i
Shakr34, stabilitosi in un piccolo villaggio del Punjab per condurre
in perfetto isolamento la vita da santo eremita, venne dapprima
venerato dagli abitanti indù del villaggio che poi presero
l'abitudine di andare da lui per consiglio e successivamente la sua
fama si estese e attorno a lui si raccolse un cerchia di discepoli che
lo appellarono Baba Farid.
Baba Nur ad-Din (1377-1438) fu addirittura soprannominato
rishi, "veggente"35 , ma anche "colui che fa vedere" perché è
l'ideale per tramite del quale gli altri uomini possono godere di
uno sviluppo spirituale. Ricevette questo epiteto riservato ai più
grandi sant'uomini indù grazie all'aderenza del suo credo e della
sua regola di vita ai canoni dei sadhu e dei rishi indù. I suoi
seguaci diedero vita alla Rishiyyah, confraternita sufi ancora oggi
presente in Kashmir, che porta quindi un nome di origine vediche.
Finora abbiamo parlato di sufi, ma bisogna ricordare anche il caso
analogo dei dai, missionari appartenenti alla setta eterodossa e
minoritaria degli ismaeliti (o sciiti settimani) che operarono
soprattutto in Gujarat convertendo anche interi gruppi castali.
Secondo un'antica tradizione il primo dai, il mulla Muhamad Ali,
giunto in India via mare, era divenuto discepolo di un santo
bhakta locale che aveva grande seguito in zona. Muhammad Ali
giunse quindi a convertire all'islàm sia il suo maestro sia molti dei
suoi discepoli, nonché alcuni membri della locale corte raj'put.
4. Monoteismi indiani in salsa mistica
Nella terra del politeismo indù vi furono anche sentimenti
religiosi monoteisti: il pensiero vedanta, il movimento bhakti e il
misticismo islamico sufi.
Questi si intrecciarono e si confusero tanto che c'erano discepoli
bhakta con maestri sufi, discepoli sufi con maestri bhakta e
discepoli che non avevano ben chiaro a quale corrente
appartenesse il proprio maestro.
Nel Nord dell'India l'influsso della predicazione bhakti e di quella
sufi, unito all'insofferenza per la rigidità dell'induismo classico e
alla sua inderogabile suddivisione gerarchica, originò a partire dal
43
XI sec. anche due nuovi percorsi per avvicinarsi al divino: il Nath
panth e il Sat mat, di cui Kabir e Guru Nanak sono considerati
esponenti .
4.1 Nath panth.
Sviluppatosi nel XI-XII sec. e ancora oggi praticato, il Nath
panth, fa risalire i propri insegnamenti al dio Shiva in persona
(viene infatti chiamato Adi-nath, "primo maestro") e le proprie
origini al leggendario Gorakhnath, considerato il più grande dei
nove maestri nath che, secondo la leggenda, raggiunsero
l'immortalità e si ritirarono sull'Himalaya. Questa credenza,
assieme all'utilizzo di pratiche esoteriche volte a conseguire poteri
magici, evidenzia il forte influsso del buddismo tantrico a cui si
accompagna il monoteismo di derivazione bhakti.
Il nath panth era incentrato sul culto di Shiva e ricercava il
dominio del mondo sensoriale per poter giungere attraverso di
esso alla liberazione. Rifiutava tutte le regole formali
dell'induismo, quali le divisioni catastali, i pellegrinaggi ai luoghi
santi, i riti, le visite ai templi, ecc… e si apriva al sufismo tanto
da intrecciarsi ad esso sostenendo che Muhammad era stato
discepolo di Gorakhnath, e che alcuni profeti nominati nel
Corano non erano altro che maestri nath. La sostanziale analogia
dei due insegnamenti fece sì che ci furono non solo prestiti di
termini e di metafore simboliche fra le due fedi, ma anche
conversioni di maestri nath al sufismo e di mistici musulmani al
nath panth.
4.2 Sant Mat
Accanto al Nath panth si sviluppa un'altra corrente mistica: il Sant
Mat.
Caratterizzata da un forte monoteismo, a differenza dei nath (che
veneravano Shiva) o dei bhakta (che facevano oggetto della
propria devozione uno dei molteplici avatar di Visnu e
praticavano anche il culto degli idoli) prescriveva ai seguaci di
riservare il proprio amore devozionale all'Essere assoluto e
inconoscibile, senza attributi, privo di forma, omnipervadente e
presente nell'intimo di ogni uomo, non pensabile in forma umana
e identificabile con la Verità (Sat). A volte i fedeli,
polemicamente, usavano contemporaneamente il nome di Allah
Ram e Hari ma consideravano appropriati per identificare il Dio
termini come Nam (nome) Shabd (parola) e Ek (uno).
Nel Sant Mat la meditazione assume il ruolo centrale: col
progressivo ritirarsi dalle percezioni sensoriali è possibile "morire
vivendo", cioè iniziare il cammino mistico verso la Divinità; ma
l'aiuto di un maestro è indispensabile per il corretto uso di queste
tecniche.
Anche nel Sant Mat c'era il rifiuto della divisione catastale
4.2.1 Kabir
Fra i principali maestri del Sant Mat vi è Kabir36, che ebbe anche
una grande familiarità con le tecniche yogiche del Nath panth.
Egli apparteneva ad un umile casta di tessitori recentemente
convertitesi all'islam residenti nella zona di Varanasi, la città santa
degli indù.
La sua personalità emerge di volta in volta come quella di un sufi
e di bramino, di un paria e di un vaishnavita 37 , mentre la sua
speculazione filosofica assume gli atteggiamenti più disparati con
verosimile disinvoltura 38 .
Egli si considera "il rampollo di Rama e di Allah" implicando così
che il Brahman, il Non-Essere omipervadente, può avere più di un
nome pur restando Uno; così chiama il Divino con una sequela
interminabile di nomi: Allah, Rama, Shunya (Vuoto), la mistica
sillaba Aum rappresentante la realtà suprema, Jagannath (Vishnu),
Kartara (il Creatore), Rahim (il Compassionevole) e con tutti gli
appellativi di Krishna39 quali Govinda, Gopinath, Madhava,
Murari, ecc…
Kabir talvolta personifica il Dio che il Sant Mat vorrebbe senza
attributi, facendone un'Entità a cui ci si può rivolgere come Padre
o come Madre o, meglio, come Sposo Amatissimo 40; Dio diviene
pertanto il Supremo Oggetto d'amore, secondo la pura tradizione
sufica.
A minare questo amore c'è maya, "illusione", la tentatrice,
l'ammaliante cortigiana che torna e torna ancora a sedurre il
devoto, la liana che si avviticchia all'albero e vive della sua linfa,
il pesante tendaggio che impedisce di vedere il sole. La
personificazione emblematica della maya è direttamente
derivante dal Satana sufico, il Demonio che rappresenta le buie
forze del male e che ostruisce la via della fede. Ma una volta
debellata maya appare ciò che è in realtà: una semplice
manifestazione limitata dell'Illimitato, come espresso nel vedanta.
Visto come tentativo di fusione di tradizioni indù e musulmane, il
percorso di Kabir fu qualcosa di più: fu la ricerca di superamento
delle religioni esistenti e dei loro testi, incapaci di avvicinare il
fedele a Dio.
Kabir combatté tutta la vita contro la strumentalizzazione di ogni
tipo di religione, impartì i propri insegnamenti a indù e
musulmani senza distinzione e non diede mai vita ad una vera e
propria setta. Ma dopo la sua morte, raccolti i suoi insegnamenti
in forma scritta, crebbe intorno alla sua figura una setta dalle
regole rigide ed anche ossessive.
4.2.2 Guru Nanak
Esponente del Sant Mat e fortemente influenzato dalla
predicazione di Kabir, Guru Nanak (1469-1539) fu anche il
fondatore della religione sikh. Di casta alta, proveniva da un
gruppo sociale privilegiato e ricevette una solida istruzione
frequentando nel suo villaggio sia gli insegnamenti del pandit41
sia, forse, quelli del mulla 42 allo scopo di apprendere il persiano.
Nanak avrebbe mostrato fin dalla fanciullezza una spiccata
inclinazione alla vita meditativa andando continuamente in cerca
della compagnia di sadhu indù e di faqir musulmani. Ma la sua
predicazione mostra non tanto un tentativo di sintesi delle due
tradizioni, quanto un atteggiamento antitetico ad ambedue,
ritenute incapaci, coi loro formalismi e superstizioni, di
44
avvicinare il fedele a Dio.
Fortemente in rottura con le due tradizioni è l'usanza del langar,
la cucina pubblica per il pasto serale che vedeva riunita tutta la
comunità, senza differenze né di casta né di genere; infrangendo
così sia le inflessibili proibizioni indù riguardo la consumazione e
preparazione del cibo, sia l'isolamento delle donne proprio della
tradizione musulmana.
Nanak, come Kabir predicò sia a indù che a musulmani43
insegnando le tecniche della meditazione come via principale per
arrivare all'unione col Dio ineffabile già in questa vita ma, a
differenza del mistico di Varanasi, pose le basi per una vera
religione istituzionalizzata quando designò il proprio successore
alla guida della comunità religiosa. L'insegnamento di Guru
Nanak si trasformò nelle generazioni successive in una religione
istituzionalizzata, attenta ai segni esteriori di appartenenza, e
dopo due secoli pure militarizzata.
I guru sikh divennero non solo guide spirituali di una comunità
religiosa, ma anche capi temporali di uno stato e spesso si
scontrarono coi regnanti musulmani.
Ma nel Guru Granth Sahib, Libro sacro dei sikh e loro autorità
religiosa sono contenuti oltre agli insegnamenti di Guru Nanak,
raccolti in forma scritta dai suoi discepoli, degli altri Guru e brani
di mistici indù nonché di Kabir, anche versi di un mistico
musulmano, Sheikh Farid.
Nel sacro testo sikh viene affermata l'unicità di Dio 44 , che è anam,
"senza nome", perché sono infiniti i nomi con cui gli uomini si
sono rivolti a lui; nomi che lo stesso Nanak talvolta usa benché
preferisca chiamarlo Nam, "nome", o anche Sat-nam, "vero
nome". Obbiettivo del fedele è immergersi totalmente nella natura
di Dio, sconfiggendo l'ignoranza con l'aiuto del Guru 45. Occorre
liberarsi dall'egoismo. Nel percorso sikh non è contemplata la
rinuncia al mondo e alle sue leggi, non viene indicato di cercare
nella solitudine la via maestra per la salvezza, come invece era
pratica degli asceti indù e talvolta sufi. Infatti il compito del
credente sikh è quello di imparare a rimanere puro pur vivendo fra
le impurità del mondo.
5. Moghul masala
L'impero Moghul fu caratterizzato, come già il Sultanato di Delhi,
da un'attiva partecipazione degli intellettuali indù alla corte
islamica, non solo per quanto riguarda la complessa
amministrazione dell'impero ma anche nel campo intellettuale e
artistico.
Questa pluralità di tradizioni di pensiero ed espressione, a cui si
aggiunsero anche influssi europei, creò un particolare "masala",
miscela 46 in cui erano presenti sia la tradizione sufi (si trattava di
un impero islamico) declinata nelle sue più diverse forme, sia
quella autoctona indiana, in particolare nelle sue espressioni
monoteiste del vedanta e delle pratiche mistico-esoteriche dello
yoga, soprattutto di origine nath e tantra.
L'unione delle varie tradizioni è evidente nelle espressioni
figurative, dove i canoni delle ritrattistica indù si fondono con la
decorazione islamica, e nelle espressioni poetiche di cui
45
ricordiamo il Padmavat di Malik Muhammad Jayasi dove
racconti locali di resistenza all'espansione musulmana divengono
anche una rappresentazione del percorso mistico sufi nonché yogi.
Da questo clima di commistione e di ricerca sincretica non ne è
esente la famiglia imperiale: il più grande imperatore Moghul si
propone come maestro sufi della "pace universale" e, più tardi, il
giovane principe Dara Shikoh ritiene che le differenze fra Corano
e Vedanta siano solo a livello linguistico.
5.1 Akbar. Il tentativo di una religione universale per un grande
impero.
All'interno di un discorso sul sincretismo religioso, merita
un'attenzione particolare il secondo imperatore moghul, Akbar47 ,
che con le sue brillanti campagne militari e con lo splendore della
sua corte fu il vero creatore della potenza moghul.
Fin dall'inizio accolse nel suo seguito sia indù che musulmani,
infatti la sua prima azione politica fu il matrimonio, nel 1561, con
una principessa raj'put, figlia del raja Bihara Mahal di Amber
(Jaipur) il quale chiedeva protezione offrendo in moglie la propria
figlia (presso i raj'put questo comportava un rapporto d'alleanza
in cui il padre della sposa aveva una posizione subordinata nei
confronti del proprio genero). I familiari della sposa vennero ad
assumere degli importanti ruoli a corte.
Fu consuetudine di Akbar accettare la sottomissione dei vari
principi e capi militari indiani ammettendoli a fare parte della
nobiltà moghul. Questa non era una novità: sempre negli imperi
musulmani in India erano presenti a corte anche indù e parsi, ma
la loro accettazione non era mai stata così sistematica e frequente.
Consapevole che il potere, per essere durevole ed effettivo, deve
sposarsi al consenso Akbar cercò in un primo tempo di darsi una
legittimazione ideologica indossando il manto del ghazi, del
combattente per la fede. Di conseguenza l'assedio e presa della
grande fortezza raj'put di Chittor (1568) venne presentata come
vittoria dell'islam contro gli "infedeli" e furono prese misure
restrittive contro gli indù. Ma tale presa di posizione non era
affine alla personalità di Akbar e non durò a lungo. Infatti
riportano le cronache dell'epoca che Akbar "fin dalla più tenera
età conobbe i riti religiosi più disparati e con grande talento si
impossessò del sapere a lui indispensabile, collezionando anche
libri che si faceva leggere ad alta voce48 . Lentamente crebbe in lui
la convinzione che in tutte le religioni ci fossero uomini dai
sentimenti profondi e pensatori eccellenti e in tutti i popoli
persone con grande capacità. Se si poteva trovare la verità in ogni
dove, perché farla diventare patrimonio esclusivo di un'unica
religione, addirittura di una fede giovane com'è l'Islam, con
appena mille anni di vita?"49 . L'imperatore, dotato di una cultura
straordinaria, di vivacità e curiosità intellettuali estreme e
circondato da un gruppo di amici e consiglieri sia indù che
musulmani, tutti di vedute eccezionalmente aperte, aveva
incominciato ad interrogarsi sulla validità delle varie religioni.
Nel 1575 fu fatta costruire nella nuova capitale, Fatehpur Sikri, la
cosiddetta "casa delle preghiere" che divenne sede di dibattiti,
presieduti dallo stesso imperatore, che coinvolgevano esperti
rappresentanti dell'islam e delle altre religioni (indù, jaina,
seguaci di Zoroastro, alcuni dotti padri gesuitie, pare, addirittura
degli ebrei). Vennero anche fatte tradurre le principali opere
religiose indù: il Mahabharata, il Ramayana, la Bhagavad Gita50,
l'Atharva Veda e anche altri testi come il Pancatantra 51.
Il sincretismo religioso dell'imperatore Akbar era tale che un suo
contemporaneo disse di lui: "Per i musulmani era un indù, per gli
indù un cristiano e solo per i cristiani un musulmano"52.
Nel 1579 fu emessa la Dichiarazione (mahzar, poi definita dagli
storici "Decreto dell'infallibilità") che dava l'ultima parola
all'imperatore nelle dispute teologiche proclamando la capacità di
Akbar sia di arbitrare in caso di controversie interpretative tra
dottori della legge islamici, sia di dare nuove interpretazioni e,
pertanto di promulgare leggi su base religiosa.
Nello stesso anno Akbar enunciò la dottrina del sulh-i-kull (la
"pace generale") una dottrina di "universale tolleranza odiata dai
musulmani ortodossi" 53 che aveva come cardine il principio della
tolleranza verso tutti. Coerentemente vennero abolite le imposte
discriminanti quali la jizya, tassa procapite pagata dai dhimmi e le
tasse imposte agli indù in pellegrinaggio. Venne abolito anche il
regolamento che prescriveva una distinzione tra il modo di
vestirsi degli indù e dei musulmani. Tra loro non ci fu più nessuna
differenza ufficiale 54.
La posizione di Akbar non era più limitata dai principi della legge
islamica, bensì solo dalle esigenze del buon governo che, nella
sua opinione, si fondavano sulla tolleranza verso tutte le
confessioni religiose e sul perseguimento della gioia e della
concordia.
L'imperatore a partire dal 1582 cominciò a dare espressione alla
propria religiosità praticando apertamente rituali di sua
invenzione e proponendo un insieme di credenze i cui punti
chiave erano il monoteismo e il ruolo sulla terra di un maestro
supremo (ruolo ricoperto da Akbar). Questo viene visto da alcuni
storici come abbandono dell'islam e tentativo di creare una
propria religione (la "religione di Dio", dîn-i-ilâhi). Ma è più
probabile che Akbar si considerasse un sufi, ovvero un maestro
mistico che, pur rimanendo nell'ambito dell'islam, presentava
molte analogie con la pratica devozionale della bhakti.
Forse la sua identificazione con la figura di maestro sufi era il
passo culminante del tentativo di dare una legittimità anche
religiosa al proprio potere 55. Alcuni cortigiani seguirono per
compiacenza il sulh-i-kull ma sostanzialmente nello stato rimase
validissimo il principio della libertà di religione. Questa
tolleranza rimase una delle caratteristiche dello stato moghul,
tranne che durante il regno del quinto sovrano, Aurangzeb.
XVI sec. e considerato uno dei capolavori delle letterature
indiane di ogni tempo.
L'autore è Malik Muhammad Jayasi56, seguace della Cisthiya e
ispirato dai racconti popolari sulla caduta di Cittor, rielabora le
"canzoni di eroi" del Rajasthan fino a comporre un poema che è
al medesimo tempo un avvincente racconto di amore e di guerra
e un'appassionata esposizione dei principi della dottrina sufi
nonché del pensiero yogi.
Nel Padmavat la narrazione delle gesta del re di Cittor si fa
descrizione degli stadi della pratica spirituale sufi, dall'abbandono
del mondo all'unione con Dio, fino al ritorno al mondo e alla
comprensione della natura illuminante della propria vita
quotidiana.
Il primo capitolo si apre con una lauda al Divino, al Profeta, e agli
imperatori:
"In principio rammento quell'unico creatore, che diede la vita e
che creò il mondo. Creò lo splendore della prima luce e, per
amore di quella, il paradiso; creò il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra
e li dipinse di molteplici colori. Creò questo mondo, i cieli e gli
inferi e generò svariate incarnazioni; creò l'uovo cosmico (…)57" .
Ci si muove quindi in un contesto rigidamente monoteista,
evidentemente islamico: la "prima luce" è il profeta Muhammad;
ma contemporaneamente "l'uovo cosmico" fa riferimento ad uno
dei più antichi miti cosmogonici indiani.
Il poema narra del re Ratan'sen, sovrano di Cittor, che dopo aver
udito un pappagallo - brahmano magnificare la bellezza di
Padmavati, principessa di Simhal, decide di partire per
conquistarne il cuore. Abbandona così il suo regno e i suoi beni,
nonché la sua sposa Nag'mati, per farsi asceta e mettersi in
cammino.
È il tema, del tutto convenzionale nella poesia sufi,
dell'abbandono del mondo e morte dell'io.
Tutti mettono in guardia il giovane sovrano contro i pericoli di
quella ricerca d'amore. Lo stesso pappagallo, che è "esperto dei
quattro veda" afferma "Amare è un'impresa difficile (….). Per
conoscere il loto, bisogna essere come quell'ape che, pur
depredata lungo il sentiero, e pur rinunciando alla propria vita,
non se ne allontana mai (…) Solo chi abbandona il mondo può
percorrere quel sentiero: lo yogi, l'anacoreta, l'asceta, l'eremita."58
Il re compie questa scelta: indossa il saio da asceta e si mette in
marcia perché "per chi è pazzo d'amore non esiste né sole né
ombra"59, perché "fin quando non si giunge a perdere sé stessi non
si ottiene nulla" 60 . È un "sentiero su cui spuntano germogli
acuminati, sui quali verrà impalato un ladro o un nuovo Mansur"61
il mistico martire dell'islam che venne messo a morte per avere
affermato la propria "identificazione amorosa" con Dio. È anche
la via mostrata dalla tradizione spirituale indiana che, sin dalle
Upanishad, considera il distacco dal mondo come requisito
necessario per il raggiungimento della salvezza e della
liberazione.
Sopprimere il proprio sé, morire a sé stessi. Sopprimere l'"io"62 .
Rinunciare a tutto.
Quando Ratan'sen, incapace di accostare l'amata, decide di
immolarsi sul rogo gli appare Shiva, dio degli asceti, che gli rivela
5.2 Malik Muhammad Jayasi. Il racconto del re innamorato,
che è guerriero, è yogi, è sufi.
In questa epoca di tentativi di riconciliazione dell'islam ufficiale
con pratiche e tendenze delle tradizioni popolari di prevalenza
indù un ruolo privilegiato spetta alla composizione della poesia
spirituale.
Un esempio è il poema Padmavat composto verso la metà del
46
il segreto della pratica spirituale "soggiogare il respiro e diventare
padrone della tua mente e se devi morire, allora uccidi il tuo "io!"
La resa di sé è completa.
Come un sufi nella suo percorso verso il Divino, come uno yogi
nella sua ricerca dell'Assoluto, così è Ratan'sen nel suo cammino
verso la bella Padmavati" 63.
Il tema dell'annullamento di sé nell'amore per il Divino unisce
tradizioni mistiche musulmane e tradizioni religiose più
propriamente indiane.
La figura di Ratan'sen, il re che annulla il proprio io sul cammino
dell'amore, fonde insieme temi, personaggi e ammaestramenti
spirituali.
Ratan'sen è allo stesso tempo il sufi - asceta figura che prevalse
nei primi secoli del sufismo nei paesi arabi e nelle regioni di
confine, e il sufi - mistico innamorato di Dio, figura che si affermò
soprattutto in Persia. Mostra anche atteggiamenti propri della
Malamatiya quando condotto di fronte al re del paese ove vive
Padmavati e condannato al patibolo, potrebbe salvarsi rivelando
di essere anch'esso un sovrano, ma invece dice: "perché chiedete
la mia casta? Sire, io sono uno yogi mendicante, un'asceta senza
casta, che non si adira per le ingiurie né si vergogna per le
percosse (…) Come potrebbe non ridere, alla vista del patibolo
uno come me, che vive dimorando nella morte?"64. È la tendenza
a compiere atti disdicevoli per conquistare il disprezzo della gente
o, comunque, di celare a tutti le proprie conquiste spirituali.
Inoltre la figura del penitente - innamorato sufi viene interamente
sovrapposta a quella dell'asceta indiano, in particolare con lo yogi
di tradizione gorakh'nati: le corrispondenze con la dottrina dei
nath sono tante e tali che tutta la prima parte del poema sembra
una illustrazione didascalica. Quando Ratan'sen intraprende il
sentiero d'amore la sua immagine esteriore corrisponde fin nei
dettagli a un discepolo del Nath path65.
D'altronde quasi contemporaneo a Malik Muhammad Jayasi è
Shaikh 'Abdu'l-Qudddus 'Gangohi (m. 1573), i cui insegnamenti
tendono a identificare completamente le nozioni sufi basate
sull'idea dell'"unità dell'essere" con le dottrine formulate da
Gorakhnath fino all'asserita corrispondenza dello stato di "vuoto"
(shunya) con quello di "permanenza in Dio" (baqâ') tanto caro
alla mistica sufi.
Anche il pensiero tantrico è presente nel poema: la donna amata
viene assimilata al guru, al maestro 66 .
C'è anche l'eco della Bhagavad Gita dove Krishna insegnava ad
Arjuna che la via non sta nell'astenersi dall'azione, ma nell'essere
totalmente presenti in essa senza attaccarsi ai suoi risultati e all'io
che la compie. Così Shiva esorta Ratan'sen a non rinunciare
all'azione, ma ad immergersi totalmente in essa.
Il sufismo sottolineava come le stesse conquiste spirituali
andavano intese come strumento per partecipare in maniera
finalmente libera e illuminata a quelle medesime "cose del
mondo" dalle quali, in partenza si era generato un disgusto per la
vita quotidiana.
Il fine del percorso non è l'abbandono del mondo: è la capacità di
andare oltre alle sue illusioni, pur rimanendovi all'interno. Così
come la liberazione è chiusa nell'amore, così la verità è contenuta
47
nelle cose di ogni giorno.
Nel Padmavat prima è raccontato il distacco dal mondo, dal suo
inganno, consumando il proprio io nel fuoco dell'amore; poi il
ritorno nel mondo: Ratan'sen, unitosi a Padmavati, rimane nel
mondo, cogliendone la vera natura.
Nel poema viene celebrata la vita intera intesa come vera e
propria realizzazione della emancipazione spirituale. Essere nel
mondo, non essere del mondo.
Come aveva raccomandato Shiva a Ratan'sen: "uccidi il tuo io!
Fuori, continua a parlare delle cose del mondo, ma in segreto
dedicati a Quello che la tua anima ama"67 .
Superato l'io; affrancatosi dai vincoli individuali di attaccamento
e avversione; Ratan'sen ritorna a Cittor. Ha percorso il cammino
d'amore e raggiunta la completezza, simboleggiata dall'unione di
sé con l'amata.
Nel palazzo lo aspetta l'altra sua sposa, Nag'mati. Così ora vi sono
due regine: Nag'mati la scura e Padmavati la chiara, come la
Ganga e la Yamuna 68, come le correnti energetiche del corpo
umano che finalmente fluiscono libere e s'incontrano nell'istante
della Consapevolezza.
Ritornato a Cittor il re, come Arjuna, deve andare in battaglia.
In quest'ultima parte del poema vengono conservati gli elementi
della leggenda popolare con l'esaltazione del guerriero raj'put,
della sua etica e del suo coraggio.
Se Ratan'sen aveva già enunciato il motto "per la mia propria vita,
non ho brama" ora le stesse parole riecheggiano sulle labbra di
tutti i guerrieri impegnati nella battaglia di Cittor. Difensori e
assalitori vanno incontro alla morte senza timore: si sono già
affrancati da essa, sono dei "liberati in vita" (jivan - mukta). Sono
come l'asceta innamorato: capaci del totale sacrificio di sé, liberati
dai vincoli della vita umana. Pur combattendosi ferocemente,
sono affratellati dal comune sacrificio di sé. La cruenta battaglia
viene descritta con immagini che rimandano alla festa di Holi,
ovvero la gioiosa festa indù della primavera.
Ed è così che "tutte le donne si uccisero nel fuoco e tutti gli
uomini uscirono in battaglia; l'imperatore distrusse la fortezza, e
Cittor divenne musulmana"69 .
5.3 Dara Shikoh. Islam e vedanta come un'unica verità nella
prospettiva d'un principe moghul.
Dara Shikoh, nato nel 1615, figlio prediletto del quinto
imperatore moghul, come il suo antenato Akbar manifestò grande
vivacità intellettuale e vivo interesse per le religioni comparate
ma, a differenza di questi, tale attenzione non era motivata da
alcun calcolo politico, anzi. Dara dedicò tutto il suo tempo allo
studio e alle traduzione dei testi sacri, così che giunse totalmente
impreparato alla lotta per la successione al trono. In quanto figlio
primogenito era designato a ereditare il potere del padre, Shah
Jahan, ma nella lotta per il regno si dimostrò di scarso talento
strategico e politico: era "ingenuo come un lattante" come
affermò fratello Aurangzeb che lo sconfisse, lo fece condannare
"per ripetute offese alla religione" e quindi decapitare nel 1659 70 .
Dara ricevette una classica educazione da principe moghul con lo
studio del Corano ma da subito ne rifiutò i commentari ortodossi
e cercò la compagnia dei saggi sia musulmani che indù; venne
iniziato all'ordine sufi dei Qadiri e ne seguì l'insegnamento
esoterico che comportava la ritenzione del respiro e l'invocazione
del Nome supremo; si interessò alla filosofia comparata e studiò
la Torah, i Vangeli, i Salmi e i testi del sufismo, sempre attento a
coglierne la dottrina dell'unità. Il suo scopo era studiare tutti i testi
sacri al fine di conoscere la verità attraverso la parola divina,
poiché egli riteneva che solo questa fosse l'interprete del proprio
mistero e si presentasse talvolta velata e talvolta in modo
accessibile a tutti.
E fu nei testi sacri dell'India, nella filosofia del vedanta, che Dara
trovò esposta chiaramente la dottrina dell'unità di cui il suo cuore
aveva sete71 .
Tradusse in persiano cinquanta Upanishad72 e forse anche la
Bhagavat Gita e compose diverse opere, tutte a carattere
religioso, fra cui la più rappresentativa del suo pensiero è la
Majma 'al-Bahrayn, ovvero La confluenza dei due oceani, studio
comparativo sulle nozioni filosofiche indiane e islamiche. Il testo
presenta una esposizione dei termini tecnici delle due religioni
trovando fra essi precise corrispondenze e identità. Dara infatti
sosteneva che fra l'induismo e l'islam, sul piano trascendente della
gnosi, non ci fossero che delle "divergenze verbali". Egli aveva la
profonda convinzione che la realtà è una, ma appare sotto forme
multiple rivestite da particolarità inerenti alle singole religioni.
Ma molte conclusioni sono semplicistiche perché vengono viste
solo le concordanze e manca invece lo spirito critico per cogliere
differenze e incompatibilità. Inoltre le affermazioni fatte non
vengono sufficientemente giustificate. Pare quindi esserci non
tanto una ricerca metodica, un'analisi comparata delle due
religioni, quanto un percorso intimo di visioni intuitive basate su
una credenza a priori: la dottrina dell'unità universale. Questo
studio appare pertanto come uno sforzo per confermare la sua
visione di due religioni identiche fino ai loro minimi dettagli
concettuali.
Così la resurrezione islamica è analoga al pralaya73 perché
ambedue denotano la fine di una condizione; poco importa che la
prima segni il divenire post-mortem dell'anima nel suo passaggio
negli intermondi e che l'altra si rapporti alla creazione e
dissoluzione dei mondi secondo la dottrina dei cicli cosmici.
L'arcangelo Gabriele, angelo della rivelazione, non è altro che
Brahma74, divinità della creazione e poco importa che uno sia un
angelo e l'altro una divinità perché ambedue denotano sul piano
cosmogonico l'Intelligenza cosmica.
Dara non trova alcuna differenza tra le dottrine indù e quelle
islamiche poiché le realtà spirituali sono universali; ma
soprattutto, perché non voleva trovare differenze: su di esse si
basa l'ostilità fra ulama, bramani e pandit. Dara voleva appianare
le discordanze, voleva estirparle per promuovere il sistema
armonioso dell'unità universale scorto nel vedanta.
Il sogno grandioso di Akbar di realizzare una religione universale
dove indù e musulmani si potessero riunire liberati da tutti i
pregiudizi confessionali e quello, più elevato, di Dara Shikoh che
si sforzò di comprovare la stretta identità della gnosi speculativa
dell'Islam e del monismo Advaita, non raggiunsero lo scopo di
integrare pensiero indiano e cultura islamica. Però essi
caratterizzano comunque "un'epoca privilegiata i cui valori sono
lontani dall'essere conosciuti" 75 .
Ma Dara venne condannato a morte, nel dolore della folla, e
l'incoronazione ufficiale di Aurangzeb fu l'ultimo barlume di
splendore della corte moghul.
6. Conclusioni. Oggi.
L'India, il subcontinente indiano di cui si è parlato nel 1947, con
l'indipendenza dagli Inglesi, venne suddiviso in due: uno Stato
musulmano76 e uno Stato che taluni vogliono laico e altri indù
Risulta un po' difficile portare avanti questo discorso di
sincretismi e convivenze, quando ambedue si sono dotati di
armamenti atomici destinati al vicino.
In più dai dotti islamici vengono criticamente messi in
discussione la dottrina dei santi e quegli aspetti che permettevano
un dialogo con l'induismo sostenendo che "se vogliamo far
rivivere l'islam (…) occorre che i musulmani si astengano da
questo abuso, come il diabetico deve rinunciare allo zucchero" 77.
Ma i dolci indiani sono dolcissimi e la commistione continua.
Così ancora oggi in due dei principali santuari sufi di Delhi
possono essere osservati atti d'origine indù, se non indù che vi
giungono a pregare l'intercessione dei santi.
Il santuario naqshbandi fondato a Delhi contenete la tomba di
Mirza Mazhar Jan-i Janan78 è aperto agli asceti indù che vengono
per pregare (a anche agli occidentali tanto che è noto come il
"dargah79 degli italiani").
Numerosi indù vanno a pregare anche nel complesso sacro chishti
chiamato Nizamuddin dove ogni anno si onorano quattro grandi
feste: tre seguono il calendario lunare musulmano e la quarta è la
festa di primavera, improntata all'induismo e fissata secondo il
calendario luni-solare indù. E la circodeambulazione della tomba
di Nizamu'd-Din Awliyya, ragione d'essere del complesso, viene
fatta in senso orario com'è costume indù e non in senso inverso
com'è uso nell'islam.
Si diffondono nuovi movimenti sincretici quali la Warithiya, nata
durante il periodo coloniale. Il suo fondatore, Warith Ali Shah
(1818-1905), aveva viaggiato in Medio Oriente e in Europa,
indossava l'ihram, il vestito del pellegrino alla Mecca, si
comparava a Gesù e a Krishna. Il movimento, che non ha alcun
rituale prefissato e semplicemente prescrive l'Amore, conta circa
400.000 discepoli fra musulmani (sciiti come sunniti), cristiani,
ebrei, parsi e indù di tutte le caste.
A questo punto non so più a quale gruppo religioso i Sind festanti
visti a Kolkata possano appartenere. Ma non importa. Mi hanno
dato l'opportunità di riflettere su alcune pagine della storia indiana
che sono ben più ricche di quanto la teoria dello "scontro di
culture" aveva scritto. Mi hanno fatto vedere un altro aspetto di
questo paese, come se mi avessero mostrato un altro mondo. "Un
altro mondo possibile", come discutevano i delegati indù e
pakistani al social forum di Mumbai?80
48
NOTE
1
Ringrazio Stefano Caldirola per la sua testimonianza del Durga Puja di Jabalpur.
Ricordiamo che sempre in Kerala esiste anche la più antica comunità cristiana dell'India, la cui evangelizzazione viene attribuita a
San Tommaso.
3
I raj'put, gruppo a cui appartenevano pressoché tutte le dinastie regnanti del Nord India dalla fine del VIII sec., non erano gruppo
razziale ben definito. Le loro origini derivano da un agglomerato di clan e di bande guerriere con in comune una sola caratteristica:
essere coloro che nell'India del nord si dedicavano alla professione delle armi. Successivamente questi vari gruppi cominciarono a
legarsi fra loro con rapporti matrimoniali, crearono una nuova classi nobiliare regolata da una rigida etica guerriera e i brahmani
costruirono per loro delle nuove grandiose genealogie.
4
Si tratta di: Alptigin, che nella seconda metà del X secolo fece di Ghazni la sua capitale, e dei suoi successori: Sabuktigin prima e
Mahmud poi.
5
Ma già in Persia erano considerati dhimmi anche i seguaci di Zoroastro.
6
Dea indù dell'abbondanza.
7
Cavalcatura della divinità indù Shiva e anche sua rappresentazione zoomorfa.
8
Cit. in: Torri Michelguglielmo, Storia dell'India, Laterza, Bari, 2000, p. 214.
9
Vedi: Torri Michelguglielmo, Storia dell'India, Laterza, Bari, 2000, p. 218.
10
Dara Sikoh, di cui parleremo più avanti.
11
Inoltre il termine indù venne usato per la prima volta dagli invasori arabi nel VII sec. per definire la popolazioni autoctone del
subcontinente.
12
Il buddismo, una delle nuove dottrine "eterodosse", fu fondato da Siddartha o Gautama, detto il Buddha (l'"Illuminato"), vissuto tra
la metà del VI sec. e la metà del V sec. a.C.
La predicazione del Buddha si basava sulla constatazione che la vita è dolore, e che il dolore è l'inevitabile conseguenza del desiderio.
Al dolore si può porre termine attraverso l'eliminazione del desiderio; il desiderio si può eliminare solo percorrendo il nobile ottuplice
sentiero (retta visione, retta decisione, retto stile di vita, retto sforzo, retta attenzione, retta concentrazione). Buddha non si pronuncia
sull'esistenza del divino, ma prende atto della sofferenza insita nel vivere e cerca una via per ovviare a questa dolorosa verità.
Alla base del pensiero buddista c'è la constatazione che il desiderio ha origine dall'illusione che vi siano permanenza e individualità
laddove né l'una né l'altra esistono. Il mondo è flusso e cambiamento continuo e anche il singolo non è altro che un'instabile aggregato
di componenti che dopo la sua morte si riaggregheranno a formare altri individui, che però saranno condizionati dalle precedenti
esperienze dei propri elementi costitutivi. Il fine del singolo deve essere quello di interrompere questo processo attraverso il
raggiungimento del Nirvana, l'"Estinzione", pari all'estinguersi di una fiamma della candela, fine dell'esistenza individuale e
raggiungimento di una suprema beatitudine.
Col cambiamento della situazione socio - politica il buddismo, che nel frattempo aveva subito numerose modificazioni, scomparse
pressoché totalmente dall'India ma si diffuse in tutta l'Asia.
13
Il jainismo fu fondato da Vardhamana Mahavira ("Grande Eroe") conosciuto come Jina ("Conquistatore"), contemporaneo del
Buddha con cui presenta molte coincidenze.
Il pensiero cardine del jainismo è che tutto ha un'anima propria, individuale: tutti i viventi e anche tutti gli oggetti apparentemente
inanimati. Quest'anima, caratterizzata da purezza, beatitudine, omniscienza e autosufficienza, è immersa e compenetrata dalla materia
attraverso un legame, il karma. Il karma incatenando l'anima individuale alla materia la condanna alla sofferenza della vita e al ciclo
perenne delle reincarnazioni E' possibile agire su questo legame: gli atti egoistici e crudeli lo consolidano, mentre all'opposto
l'ascetismo e la volontaria sofferenza lo alleggeriscono. Da qui l'enfasi sull'altruismo e sulla non violenza.
L'ideale massimo del jainismo è quello dell'asceta che, per non nuocere ad alcunché, si lascia morire di fame e pare che anche uno dei
più grandi antichi imperatori indiani scelse questa strada.
14
I Vedanta sono chiamati anche Upanishad, termine composto da upa, che significa "complementare", "aggiuntivo" e ni-sad "sedere
ai piedi di un maestro".
15
Ma questa affermazione non comporta un'etica della fratellanza.
16
Vedi l'opera di Dara Shikoh.
17
Brahma ha un ruolo minore nel culto. Non è stato abbandonato il pensiero "utilitaristico" dell'epoca vedica e quindi si considera
inutile venerare e omaggiare il dio creatore quando non c'è più bisogno di lui dato che il mondo è già stato creato.
18
Non solo quindi la via della conoscenza e dell'adempimento degli obblighi rituali come era in precedenza.
19
Da Tantra, "trama e ordito", ovvero i testi religiosi di questa corrente.
20
Nei Veda era invece presente una sola divinità femminile.
2
49
21
Il buddismo, che all'inizio non si era pronunciato sul divino, aveva assunto all'epoca la forma di religione dotata di divinità proprie,
fra cui la figura divinizzata di Buddha (che era anche entrato nel pantheon indù).
22
Il movimento non critica il sistema brahmanico, ma si esprime al di fuori di esso.
23
Nel medioevo si iniziò la costruzione di edifici sacri templi proprio per accogliere le icone.
24
Vedi Vercellin Giorgio, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, Torino, 199, pp. 6-7.
25
Muhammad ibn Abdullah è un personaggio storico su cui abbiamo notizie relativamente accurate ed abbondanti.
26
Il quale contiene 114 sura (6536 versetti), ordinate per lunghezza decrescente, fatta eccezione della prima.
27
Gabriele nella tradizione islamica viene chiamato angelo e non arcangelo come presso i cristiani.
28
Cit. in: Torri Michelguglielmo, Storia dell'India, Laterza, Bari, 2000, p. 174.
29
Langar, come nella tradizione sikh.
30
E come fra i sufi oltre alla scuola monistica c'è anche quella shuhudi che presenta un moderato panteismo, così nell'induismo abbiamo
il non-dualismo advaita (o vedanta) e la dottrina vishishtadaivita della dualità non differenziata.
31
" Per i musulmani i santi rimpiazzano i numerosi dei degli indù" Garcin de Tassy 1831 cit in: Gaborieau Marc, Le Soufisme et les
Confréries dans l'Inde contemporaine, intervento alla Conferenza Internazionale The role of sufism and Muslim brotherhoods in
contemporary Islam. An alternative to political Islam?, Centro Edoardo Agnelli per gli Studi Religiosi Comparati, Torino, 20-22
Novembre 2002, p. 14.
32
Torri Michelguglielmo, Storia dell'India, Laterza, Bari, 2000, p. 176.
33
Nella tradizione indiana la comparsa di un nuovo maestro comportava la sua sfida dialettica da parte degli esponenti degli altri
pensieri religiosi.
34
m. 1245.
35
I rishi erano coloro che in virtù della perfezione dell'ascesi avevano "visto" i Veda.
36
Vissuto probabilmente tra il 1398-1448.
37
Seguace di Vishnu.
38
Vedi Mishra Laxman Prasad (a cura di), Mistici Indiani Medievali, UTET, Torino 1971, pp. 35 - 36.
39
Krishna, come Rama, era per gli indù uno degli avatar di Vishnu.
40
"Hari è il mio Amante / ed io sono la sua sposa, / tanto piccola / quant'Egli è immenso". Pada 117 in Mishra Laxman Prasad (a cura
di), Mistici Indiani Medievali, UTET, Torino 1971, p. 39.
41
L'autorità religiosa e intellettuale indù.
42
Dotto erudito nelle discipline religiose musulmane.
43
Una strofa popolare lo ricorda così: Baba Nanak shah faqir / hindu ka guru musal'man ka pir : "Il venerabile padre Nanak, sovrano
fra i santi, maestro degli hindu e precetttore dei musulmani" ( Giorgio Milanetti, Il Dio senza attributi, Ubaldini, Roma, 1984, p. 47)
44
Il Guru Granth Sahib si apre con:
"Uno è l'Essere supremo.
Il suo Nome è "colui che veramente è". E' un Dio personale, creatore, privo di paura e inimicizia. Non soggetta al tempo tempo è la
sua immagine. Non generato, esistente per se stessa, Egli è il maestro dispensatore di grazia". (in Piano Stefano, Canti Religiosi dei
Sikh, Bompiani, Milano 2001).
45
Il maestro. La tradizione sikh vede dieci Guru succedersi alla guida della comunità. Sucessivamente il ruolo del Guru è stato affidato
al testo sacro, il Guru Granth Sahib.
46
Masala è la miscela di spezie usata nella cucina indiana. Usiamo scherzosamente questo termine per indicare quanto questo momento
fosse ricco di molteplici apporti che, fusi insieme, crearono quel momento culturale unico che è il periodo moghul.
47
Akbar regnò dal 1556 al 1605.
48
Akbar era analfabeta. Gli storici danno diverse motivazioni a questo fatto. Alcuni spiegano ciò con l'infanzia passata fra campi di
battaglia, con un'educazione militare ma non intellettuale. Altri, appartenenti alla tradizione musulmana ortodossa che tutt'ora non
esprime grandi simpatie per Akbar, affermano che semplicemente egli si è sempre disinteressato di leggere e scrivere (ma allora perché
la biblioteca di 28.000 volumi e la grande considerazione in cui teneva i libri?) Più probabile l'ipotesi che il sovrano fosse dislessico.
49
Abu al-Fazl, storiografo alla corte di Albar. In Behr Hans-Georg, I moghul. Splendore e potenza degli imperatori d'India dal 1369
al 1857, Garzanti, 1987, p. 114.
50
Mahabharata e Ramayana sono i due grandi poemi epici-religiosi della tradizioni indù e contengono la descrizione delle gesta di
due avatar di Vishnu. La Bhagavad Gita è parte del Mahabharata e contiene la predica che Krishna, avatar di Vishnu, fa al principe
guerriero Arjuna esortandolo ad andare in battaglia. Viene qui proclamato che solo tramite le azioni disinteressate, la devozione e la
fede nella grazia divina si può giungere alla comunione col brahman.
51
Raccolta di racconti aventi lo scopo di educare il giovane principe all'arte del governo. Si presume che questo testo, giunto in Europa
tramite le tradizioni islamiche, diede l'ispirazione a Baccaccio per il suo Decameron.
52
al-Badaoni , in Behr Hans-Georg, I moghul. Splendore e potenza degli imperatori d'India dal 1369 al 1857, Garzanti, 1987, p. 115.
50
al-Badoni, sunnita ortodosso, fu storiografo di corte, prima che l'imperatore lo licenziasse come storiografo a causa delle sue idee
ortodosse e gli affidasse il compito di tradurre il Mahabharata!
53
Behr Hans-Georg, I moghul. Splendore e potenza degli imperatori d'India dal 1369 al 1857, Garzanti, 1987.
54
E al-Badaoni nei suoi scritti così commenta "segno più che certo che l'imperatore aveva definitivamente abbandonato la vera via".
(Cit. in Behr Hans-Georg, I moghul. Splendore e potenza degli imperatori d'India dal 1369 al 1857, Garzanti, 1987, p. 131).
al-Badaoni nei suoi appunti era sempre fortemente critico nei confronti dell'imperatore e del sincretismo dell'epoca. Ad esempio,
commentava così quanto avveniva a corte: "il motivo fondamentale è la grande quantità d'ogni colore e setta venuti a corte da tutte le
parti. Sua maestà ascolta l'opinione di ciascuno, ma tiene conto soltanto di quelle a lui favorevoli e respinge le altre. Così Akbar
raccolse tutto ciò che gli esseri umani possono trovare nei libri, con uno spirito di osservazione in contrasto con i principi dell'Islam.
In seguito l'imperatore rifiutò la verità rivelata e diede retta a tutte le bestemmie dei cortigiani contro la nostra gloriosa religione".
55
Così ipotizza Marc Gaborieau (in Le Soufisme et les Confréries dans l'Inde contemporaine, intervento alla Conferenza Internazionale
The role of sufism and Muslim brotherhoods in contemporary Islam. An alternative to political Islam?, Centro Edoardo Agnelli per gli
Studi Religiosi Comparati, Torino, 20-22 Novembre 2002.
56
Nato nel 1495 d. C.
57
Padmavat I.1 (in Giorgio Milanetti, Il poema della donna di loto, Marsilio, 1995, p. 67).
58
Padmavat XI.5 (p. 127).
59
Padmavat XV.2 (p. 143).
60
Padmavat XI.6 (p. 127).
61
Padmavat XI.6 (p. 127).
62
Padmavat XXII.10 (p. 176).
63
Afferma: "Il mio viaggio avrà fine solo quando la potrò incontrare. Allora mi strapperò la vita, chinerò la fronte a terra, e le darò un
trono nel cuore. (…) Se mi chiedesse la vita, gliela offrirei in sacrificio; se volesse la mia testa, gliela donerei assieme al collo; se mi
volesse uccidere, mi inchinerei ancora di più. Per la mia propria vita, non ho brama: sto davanti alla porta dell'amore e chiedo a lei per
elemosina. La sua sola vista è una lucerna e io, il mendicante, sono la falena: se pure mi passasse una sega sulla testa, morirei senza
piegare un dito XXIV p 191.
64
Padmavat XXV.2 (p. 198).
65
"Si coprì di cenere il viso bello come la luna e le membra profumate di sandalo, finché tutto il suo corpo parve fatto di terra; quindi
prese il cordone d'asceta, lo zufolo, l'anello e il gorakh'dhandha (il bastone dell'asceta shivaita) il panno per meditare, la collana di
rudraksha (rosario shivaita ) e la gruccia, indossò il saio, strinse il bastone in una mano e, come un Perfetto (siddha), cominciò ad
invocare Gorakhnath". Padmavat XXII.1 (p. 129).
66
Ratan'sen afferma: " È Padmavati il mio maestro: io sono il suo discepolo, e solo per lei ho praticato l'ascesi". Padmavat XXIV.8 (p.
191).
67
Padmavat XXII. 10 (p. 176).
68
I due principali fiumi sacri hindu, ma anche metafore del femminile - maschile, sinistro - destro, ecc…
69
Padmavat LVII.4 (p. 400).
70
La vittoria del terzogenito Aurangzeb comportò la sconfitta (con battaglie od inganni) e uccisione anche degli altri fratelli - rivali e
la condanna di Dara appare totalmente strumentale agli scopi politici di Aurangzeb e niente affatto rappresentativa del clima tollerante
dell'epoca. Clima che d'altronde finì con l'ascesa di Aurangzeb, musulmano ortodosso con spiccata tendenza al bigotto, che creò un
mostruoso apparato di inquisizioni e spionaggio.
71
Shayegan Daryush, Hindouisme et Soufisme. Une lecture du Confluent des Deux Océans, Albin Michel, Paris, 1997 p. 13.
72
Le Upanishad vennero tradotte col titolo Sirr-e Akbar, "Il più grande dei misteri", e Dara scrisse anche una prefazione che comincia
con la formula indù convenzionale Om Shri Ganesha Namoh (omaggio a Ganesh).
In esse Dara trovò pienamente espressi e spiegati i segreti che aveva cercato a lungo con un'intensa lettura dei testi sacri di tutte le
religioni.
Dara chiama le Upanishad "il primo dei libri celesti" e "la fonte delle corrente monoteistiche" e ritiene addirittura che siano state
menzionate nel Corano nel seguente verso: "Questo è l'onorevole Corano, nel libro nascosto, che nessuno lo tocchi se non il puro. Esso
è una rivelazione dal Signore dei mondi".
Per Dara Shikoh l'nsegnamento nascosto nel cuore del Profeta, il sapere che nessuno tranne il puro poteva comprendere era il testo
delle Upanishad, che permettono di conoscere lo sconosciuto e di comprendere il non capito.
73
Pralaya: "dissoluzione", letteralmente un processo (pra) di fusione (laya), e dunque di dissoluzione e distruzione, in particolare
riferimento alla distruzione dell'universo al termine di ogni era cosmica. A ciò segue un nuovo processo di creazione o emanazione.
Mahapralaya: la distruzione dell'universo che si ripete al termine di ogni era cosmica.
Dara nel suo testo afferma:
"I monisti indiani ritengono che dopo un lungo soggiorno al paradiso e all'inferno avverrà il maha parala (mahapralaya) che è la
51
resurrezione maggiore, come si deduce dal versetto "Quando verrà il cataclisma molto grande (Corano LXXXIX:35) e "Allora sarà
soffiato nella tromba (una prima volta) e coloro che sono nel cielo e sulla terra saranno fulminati, tranne quelli che Allah vorrà
risparmiare" (Corano XXXI: 68). Coloro che Allah vorrà risparmiare sono i gnostici che sono protetti contro l'incoscienza e l'ignoranza
in questo mondo come nell'altro. Dopo la distruzione dei cieli e della terra e l'annullamento dell'inferno e del paradiso, e la conclusione
dell'età di brahmanda e l'assenza di questo, le genti del paradiso e dell'inferno raggiungeranno la liberazione mokt (mukti), ovvero i due
gruppi diverranno uno con l'Essenza divina, come dice questo versetto: "Tutti coloro che sono sulla terra sono perituri, quando
sussisterà il volto del tuo Signore che detiene la maestà e la magnificenza" (Corano LV : 26, 27).
Majma 'al-Bahrayn, cap. XIX, "La descrizione della Resurrezione" (in Shayegan Daryush, Hindouisme et Soufisme. Une lecture du
Confluent des Deux Océans, Albin Michel, Paris, 1997).
Mukti, o moksha, significa "liberazione" e consiste nel riassorbimento nel brahman, nell'Assoluto divino.
Di essa Dara così scrive: "La mukti consiste nel riassorbimento e annullamento di tutte le particolarità nell'Essenza divina come appare
in questo versetto: "la Soddisfazione di Allah è più grande. Là è l'Immenso Successo" (Corano IX : 72). Entrare nel rîzwân-e akbar
che è il Paradiso è la liberazione, mukti (…)".
Majma 'al-Bahrayn, cap. XX.
74
Majma 'al-Bahrayn, cap. XXI.
75
Shayegan Daryush, Hindouisme et Soufisme. Une lecture du Confluent des Deux Océans, Albin Michel, Paris, 1997, p. 12.
76
Che poi diverrà due stati musulmani.
77
Abul A'là Maududi 1903-1979 il teorico dello stato islamico Pakistan cit in Gaborieau Marc, Le Soufisme et les Confréries dans l'Inde
contemporaine, intervento alla Conferenza Internazionale The role of sufism and Muslim brotherhoods in contemporary Islam. An
alternative to political Islam?, Centro Edoardo Agnelli per gli Studi Religiosi Comparati, Torino, 20-22 Novembre 2002, p. 16.
78
Mirza Mazhar Jan-i Janan (1699-1781) poeta e mistico, noto per le sue simpatie per gli indù. Egli considerava gli avatar indù come
dei profeti.
79
Santuario.
80
Ancora una volta ringrazio Stefano Caldirola per i suoi lunghi resoconti dall'India.
Inoltre ringrazio Marilia Albanese, Alessandra Consolaro, Elisa Giunchi e Jolanda Guardi per le preziose indicazioni bibliografiche.
52
BIBLIOGRAFIA
Albanese Marilia, Appunti per il Corso di Cultura Indiana, ISIAO, Milano, s.d.
Appadurai Arjun, Il numero nell'immaginazione coloniale, in Modernità in polvere, Meltemi, Roma, 2001 (ed. or.: Modernity at
Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis-London, 1996).
Armstrong Karen, L'islam, Rizzoli, Milano, 2001 (ed.or.: Islam, 2000).
Baghat R. B., Role of Census in Racial and Ethnic Construction e Census and the Construction of Communalism in India. Saggi
reperibili nel world wide web a partire dal sito dell'International Institute for Population Sciences di Mumbai (www.ipsindia.org).
Behr Hans-Georg, I moghul. Splendore e potenza degli imperatori d'India dal 1369 al 1857, Garzanti, 1987 (ed. orig.: Die Moguln,
Dusseldorf, 1979).
Corbin Henry, Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano, 1989 (ed. or.: Historie de la philosophie islamique, Paris, 1964, 1974
e 1986).
Dasgupta S. N., Hindu Mysticism, Frederick Ungar Publishing, New York, 1973.
Devos Claire, Qawwali. La musique des maitres du soufisme, Éditions du Makar, Paris, 1995.
Dudani
Niranjan,
Sindh's
resistance
against
fundamentalism
through
sufism
24.09.2003,
nel
sito:
www.saag.org/papers8/paper797.html.
Gaborieau Marc, Le Soufisme et les Confréries dans l'Inde contemporaine, intervento alla Conferenza Internazionale The role of sufism
and Muslim brotherhoods in contemporary Islam. An alternative to political Islam?, Centro Edoardo Agnelli per gli Studi Religiosi
Comparati, Torino, 20-22 Novembre 2002.
Guardi Jolanda , Alcune considerazioni sulle confraternite sufi in India, in Culture, Milano, 1998. Consultabile nel world wide web
all'indirizzo: www.club.it/culture/culture98/jolanda.guardi/corpo.tx.guardi.html.
Jayasi Malik Muhammad, Padmavat. Trad italiana: Il poema della donna di loto, Marsilio, 1995.
Lapidus Ira M., Storia delle società islamiche, Einaudi, Milano, 1995 (ed. or.: A History of Islamic Societies, Cambridge, 1988.
Milanetti Giorgio, Il Dio senza attributi - Yoga, conoscenza e devozione nella pratica spirituale dei "Sant", Ubaldini, Roma 1984.
Milanetti Giorgio, Introduzione a: Il poema della donna di loto, Marsilio, 1995.
Mishra Laxman Prasad (a cura di), Mistici Indiani Medievali, UTET, Torino 1971.
Molé, Marijan, Les Mystiques Musulmanes, Les Deux Oceans, Presses Universitaries de France, Paris 1982.
Rafique Mohammad, Sufism and Hinduism: mutual influences in history and perspectives of cultural convergence, intervento
presentato alla Conferenza Internazionale The role of sufism and Muslim brotherhoods in contemporary Islam. An alternative to
political Islam?, Centro Edoardo Agnelli per gli Studi Religiosi Comparati, Torino, 20-22 Novembre 2002.
Rama Krishna, Lajwanti, I Sikh - La leggendaria setta dalle origini al XX secolo, Convivio, Firenze 1991 (ed or.: Les Sikhs. Origine
et développement de la Communauté, Llimoges, 1933).
Rizvi Saiyid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, Munshiram Manoharlal Publishers, NexDelhi, 1978.
Piano Stefano, Canti Religiosi dei Sikh, Bompiani, Milano 2001.
Shah Idries, La strada del sufi, Ubaldini, Roma, 1971 (ed. or.: The Way of the Sufi, London, 1968) .
Shayegan Daryush, Hindouisme et Soufisme. Une lecture du Confluent des Deux Océans, Albin Michel, Paris, 1997 (edizioni
precedenti : Les relations de l'hindouisme et du soufisme, Edition de la différence, Paris, 1979).
Sila-Khan Dominique, Le culte d'un saint musulman chez les Brahmanes Shekhavati, in Le Rajashtan. Ses dieux, ses héros, son peuple,
INALCO - Publications Langues'O, Paris, 2000.
Singh Nagendra Kumar, Islamic Mysticism in India, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi, 1996.
Stutley Margaret e James, Dizionario dell'Induismo, Ubaldini, Roma 1980 (ed. orig.: A Dictionary of Hinduism, London 1977).
Subhan John, Sufism - Its Saints and Shrines , Cosmo Book, New Delhi, 1999.
Tagore Rabindranath (a cura di), I canti di Kabir , RED edizioni, Como 1999.
Torri Michelguglielmo, Storia dell'India, Laterza, Bari, 2000.
Upadhyay R., Sufism in India: Its origin, history and politics, 16. 02. 2004 nel sito. www.saag.org/papers10/paper924.html.
Vacca Virgina, L'India musulmana, ISPI, Milano, s.d.
Vercellin Giorgio, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, Torino, 1996.
53
Luti e Liwat
di William Pioltelli
Attraverso il prisma dell'amore omosessuale ciò che si tenta di
cogliere sono tutte quelle possibili relazioni, spesso già tessute tra
una cultura orientale profondamente pervasa di religiosità e una
società occidentale che deve trovare altri modi per rapportarsi e
dialogare con essa. L'amore gay e le contraddizioni attraverso le
quali è vissuto e praticato, forse può allora rappresentare una
delle nuove porte d'Oriente. Da costruire e da aprire.
Arabi e noi, Gianni De Martino
Homosexualités", stampata in Francia nel marzo del 1973 e
immediatamente ritirata dal commercio.
Il capitolo di immediato interesse è il secondo dal titolo "Les
Arabes et Nous", probabilmente a cura di Michel Foucault, che
poi è anche diventato un libro indipendente. Entrambi sono
praticamente introvabili e quel che è più interessante è il fatto che
in Francia questi libri sembrano non esistere e non essere mai
esistiti, non risultando infatti in nessun catalogo bibliotecario
nazionale regionale o cittadino. Una sorta di rimozione
dall'inconscio collettivo.
Il senso politico dell’omosessualità nel mondo arabo
Olio su tela di Jones Michel.
Immagine digitale tratta da Gaymiddleeast Community
Introduzione
Parlare di omosessualità nel mondo arabo-mussulmano vuol dire
affrontare una questione antropologica rilevante perché in essa
confluiscono tematiche classiche di questa disciplina quali i
rapporti tra i generi, il nesso tra sessualità e potere, la questione
coloniale, lo scontro (più ideologico che realmente fondato tra
oriente e occidente) e anche quello relativo alla Umma virtuale.
Tutta questa complessità non era sfuggita agli antropologi
francesi già a partire dagli anni settanta, quando cominciarono a
denunciare pubblicamente i rapporti di potere che si venivano a
creare tra i giovani europei e gli operai arabi, prevalentemente
magrebini, ma non solo, e che si esprimevano appunto in relazioni
di tipo omosessuale. Nomi quali quello di Michel Foucault, JeanPaul Sartre, Felix Guattarì, Gilles De Leuze e molti altri hanno
analizzato la questione in una rivista monografica "Recherches"
con il titolo "Trois Milliards de Pervers. Grande Encyclopédie des
54
La teoria o quella che l'autore definisce "..encore moins comme
une théorie" è quella che lega la pratica omosessuale al campo
dell'indagine politica: "…présence diffuse et mobile d'un de désir,
mise à jour d'un rapport de forces, d'une violence et d'une mort
au sein du désir même, dans l'instauration d'un code érotique
spécial: ‘je sens toujours la mort, j'ai l'expérience de la mort
chaque fois que je me fais enculer. Surtout avec les Arabes’
…découvre au contraire une sexualité qui, sous cette forme ou
sous une autre, appartient de toutes manières au champ social
politique, et investit les lignes des force constitutives de ce
champ".
La lettura politica dell'omosessualità può essere affrontata su
differenti livelli ; tale pratica esprime una sorta di affermazione
dei rapporti di dominazione (coloniale e non solo) attraverso
l'inversione. La pratica omosessuale con uomini del mondo arabo
sembra talvolta presentarsi come un rituale che prevede tre fasi
assimilabile a quelle del Diwan; va precisato però che se ne
possono osservare gli elementi tipici ma in modo diffuso e non
ritmicamente 1 sequenziali.
1 - la pianificazione del viaggio e del soggiorno,
all'interno di un movimento esotico del pensiero e delle proiezioni
dell'immaginario, che possono essere riscontrate non solo nelle
interviste somministrate a viaggiatori abituali, ma anche nel
flusso pubblicitario che le agenzie specializzate propinano nei
circuiti mediatici televisivi, quali tv satellitari (si pensi a gay TV)
o a riviste di interesse.
2 - la ricerca in strutture turistiche di qualche ragazzo o
uomo arabo per consumare l'atto sessuale in qualche albergo.
3 - la richiesta immancabile di " regali occidentali " e
magari di un visto per andare in Europa.
(omo)sessuale occidentale, nella logica perversa e inversa della
passività tra le lenzuola, sembra essere il prolungamento (M.
Foucault direbbe "fallocratico") del territorio nazionale,
dell'impero coloniale, nel senso delle categorie socio-cognitive
che esso ha generato e continua a generare, pur in modi differenti
e meno evidenti. (in questa direzione sembra leggersi la figura
tratta dal libro sopra citato).
Che la pratica omosessuale sia una questione squisitamente
politica e non morale, non solo nell'analisi antropologica, ma
anche, dialogicamente nelle convinzioni dei protagonisti
mussulmani, si vede bene nel cortometraggio, presentato al
Cinefestival di Torino nel 2003, all'interno di una rassegna sul
cinema di genere arabo, dal titolo Yawmiyat A'hir (Diary of a
Male Whore) di Tawfik Abu Wael, prodotto in Palestina, a colori
nel 2001.
Il cortometraggio, il lingua palestinese, e doppiata in inglese, è la
trasposizione del romanzo autobiografico Il pane nudo di
Mouhammed Shukri, scritto sulle disavventure di un giovane
marocchino molto povero, il quale picchiato dal padre, è costretto
da fame e povertà a lasciare il proprio villaggio, per andare nella
capitale, dove giunto, tra i molto espedienti adottati per
sopravvivere, c'è anche quello della prostituzione omosessuale
(con un anziano occidentale). Nel cortometraggio però il giovane
magrebino (eterosessuale) diventa un giovane palestinese, Esam,
che non si trova più il Marocco ma a Tel Aviv e il suo prostituirsi,
finalizzato alla sopravvivenza, è con un maturo israeliano. Da
questo adattamento traspare chiaramente una lettura politica
dell'omosessualità, vista da un arabo.
L'occidentale è, secondo ricerche effettuate e secondo la
consuetudine di pensiero della comunità omosessuale
occidentale, prevalentemente, se non esclusivamente coinvolto,
su esplicita richiesta, in qualità di maschio ricettivo. Il maschio
penetratore è l'arabo, per il quale comunque non è concepibile un
ruolo (femminile ?) di passività/sottomissione, poiché egli è il
detentore del deposito virile e quando anche questi consumasse
un atto sessuale con un con-sessuale mussulmano, quest'ultimo
finirebbe per venire classificato sotto una categoria sociale che
non è quella del maschio (arab).
Storia, Corano e omosessualità
Il termine che designa l'omosessuale è luti. L'accanimento che si
osserva nelle Scritture è tale da far pensare che in passato,
soprattutto tra i militari, fosse molto praticata quale forma di
coercizione.
Secondo M. Chebel i termini arabi utilizzati variamente per
descrivere la pratica della sodomia non stanno ad indicare
l'omosessualità addomesticata e civilizzata, quale viene intesa
oggi, ma è relativa piuttosto ad una pratica sessuale bruta, di
dominanza, una specie di omosessualità panica allo stato grezzo,
la quale trasgredisce contemporaneamente i codici dell'ospitalità
(si trova eco di ciò anche nel libro della Genesi), della natura
sovrana e della morale tribale.
Tale forma di violenza sessuale, applicata indifferentemente ai
maschi e alle femmine, e che si concretizzava in stupri sui vinti
durante battaglie e razzie, sembra fosse particolarmente diffusa
tra i nomadi ai tempi del Profeta. La norma coranica è da
intendersi probabilmente come una prima forma di legislazione
progressista che intendeva tutelare i più deboli.
Leggiamo infatti che tutti i rapporti extramatrimoniali erano
fortemente condannati dalla Sharia, e in particolare, per quanto
riguarda quelli omosessuali nel Corano: VII, 80-81: "E Lot,
quando disse al suo popolo: ‘Compirete forse voi questa
turpitudine, tale che mai nessuno la commise prima di voi al
Nella pratica omosessuale con un maschio occidentale si assiste
ad una inversione, almeno psicologica, dei rapporti (coloniali/neo
economici) di potere, finalizzato però alla riaffermazione
perversa, della disuguaglianza politica, culturale, sociale. Il breve
e fugace atto di sottomissione sessuale del maschio occidentale è,
inversamente, una riaffermazione, violenta a tratti del potere
dell'uomo bianco. Questo rituale, per quanto molto diverso da
quelli ai quali siamo abituati quando poniamo altrove la nostra
attenzione, come tutti i rituali di inversione pone una questione di
tipo politico, sul rapporto economico tra zone diverse del pianeta;
parafrasando Marc Augé, esso mette in scena il potere
(economico, tecnologico e occidentale) bianco, contro la
sottomissione araba. Questa struttura, che lo stesso M. Augé
definisce perversa, mette in scena parossisticamente, la mutazione
della sorgente del potere (l'occidentale è il passivo sottomesso,
l'arabo è il penetratore che, almeno nel contesto di una camera di
albergo, domina). Quello che in realtà avviene, e lo sottolinea
bene Michel Foucault, ha a che fare con la morte, quella del
maschio arabo, e metonimicamente della cultura/civiltà/storia che
esso porta e rappresenta, quale " Altro", ha a che fare con la sua
oggettivazione e la sua trasformazione. L'affermazione
55
mondo? Poiché voi vi avvicinate per libidine agli uomini anziché
alle donne, anzi voi siete popolo senza freno alcuno’. E anche:
XXVI, 165-166: “V'accosterete voi ai maschi fra le creature
dell'Universo? E avrete un commercio carnale con gli uomini,
abbandonando le spose che per voi ha creato il Signore? In verità
siete un popolo di trasgressori ignoranti ed empi”. Un hadith dice
che ‘…quando un uomo monta un altro uomo, il trono di Allah si
agita’; tale comportamento è ritenuto come una forma di
ribellione (fitna) ed e associata anche alla seduzione. In
particolare il liwat (maschio recettivo) è considerato un
maledetto, un folle che fa danno a se stesso.
La Sharia, all'articolo 307, decreta che "…ogni mussulmano
maggiorenne che avrà commesso un atto impudico, o innaturale,
con un individuo dello stesso sesso, sarà punito con la pena di
morte da attuarsi tramite pubblica lapidazione".
La pratica omosessuale era comunque molto diffusa, come
testimonia anche la fiorente letteratura araba in materia di
erotismo. La quantità e la qualità delle produzioni è tale che
alcuni antropologi hanno suggerito di considerare l'esistenza di un
terzo genere, quello dei prostituti (khanith), per i quali però è
complesso trovare un analogo equivalente culturale occidentale.
L'aspetto importante che suggerisce l'utilizzo di questo termine è
che nel mondo mussulmano sembra che in passato fosse
riconosciuta all'uomo una maggiore libertà nell'assunzione del
genere e del ruolo, non essendo esso legato ad una fenomenologia
biologica statica e dinamica troppo e pubblicamente evidente. La
perdita progressiva di questa flessibilità potrebbe essere legata
all'incontro con altre culture. L'antropologia comparativa sembra
portare prove in questa direzione.
La proibizione dell'omosessualità maschile è comunque ben
radicata nell'Islam fin dalle origini e a nulla sono valsi tentativi
successivi di studio e approfondimento per cercare di introdurre
spazi di variante o di possibilità. Nel XIV secolo assistiamo alla
nascita di un discorso laico sulla questione, peraltro molto rigido
che vede in questo comportamento una causa di decadenza,
rimproverando la mancanza di generazione, in un momento
storico di grande incertezza perché i Mongoli cominciavano
l'aggressione all'impero dei califfi. Proprio questo discorso
sembra riportarci ad una dimensione politica dell'omosessualità.
bianco passivo non è considerato maschio nel senso di Arab,
come non lo è l'adolescente che presta sé al piacere dei coetanei).
L'omosessualità intesa come forma eterodossa dell'idioma
maschile si pone nelle dinamiche dei rapporti di genere in
particolare credo per quanto riguarda il controllo critico della riproduzione dello spazio pubblico (maschile) e dei quello privato
(femminile), perché la discrepanza spaziale all'interno del Diwan
si pone come elemento di rottura formalmente non integrabile nel
concetto di Arab, pur presentando tutti gli altri requisiti sociali
che ne legittimerebbero la presenza contestuale. Un maschio che
pratica l'omosessualità, in privato, è tollerato purché il suo
comportamento non abbia visibilità (potere) nella sfera pubblica.
Quando questo avviene siamo di fronte, non tanto ad una
perversione di tipo morale, quanto piuttosto di una perversioneinversione di tipo politico, una pesante critica al potere pubblico
dei maschi (anziani). La pratica omosessuale in Palestina, nella
sua evidenza fenomenologica, sembra essere prevalentemente
giovanile (tra i 18 e i 34 anni). In essa sembrano confluire, almeno
dalle risposte degli intervistati una critica ai padri anziani,
colpevoli dell'incapacità di aprirsi ad un mondo in rapido
cambiamento.
Said, un omosessuale palestinese di circa 30 anni, esprime la sua
rabbia rivolta verso l'anziano padre, che sente ogniqualvolta vi è
una recrudescenza negli attacchi israeliani. Nonostante l'affetto
che traspare dalle sue parole, emerge anche la sofferenza per un
conflitto culturale, quando egli si definisce "gay man and
Palestinian" e quando afferma la sua paura che il padre "flight…to
escape me, the gay son he could never embrace". L'annullamento
dello spazio (l'abbraccio), quando questo è in un contesto
percepito come extra tribale, determinerebbe la distruzione
dell'idioma della maschilità, e significherebbe il riconoscimento
della critica stessa alla società ed in particolare alla
configurazione dei rapporti di genere. Said sembra ben
comprendere questo processo, che forse non è completamente
cosciente, ma è interessante osservare come esso venga
apertamente messo in relazione con la guerra (War, Fight). In
medio oriente le comunità omosessuali più visibili, potenti e
sviluppate sembrano essere fiorite in quei paesi che hanno
incorporato e sperimentato un lungo periodo di guerra sul proprio
territorio. Il caso più emblematico è forse quello libanese.
L'esistenza pubblica di un maschio, che deliberatamente sceglie
di non aderire ai canoni riproduttivi sia in senso sociale che
biologico, è dotata di una forza così distruttiva, che rischia di
minare l'assetto stesso della società; per questo motivo spesso gli
omosessuali vengono uccisi dagli stessi familiari, secondo il
rapporto delle associazioni gay, in particolare di AGUDAH e di
Amnesty International.
Secondo Malek Chebel, antropologo psicoanalista, "...attraverso i
problemi sessuali, certo molto complessi, della gioventù araba
impegnata in una dinamica di mutazione sociale, la questione
omosessuale non cessa di porre la problematica dei processi di
costruzione e di articolazione dei cambiamenti personali,
istituzionali e politici in una struttura tradizionale, conservatrice
per definizione" 2.
Diwan e omosessualità: il caso palestinese
E' necessario precisare ai fini di una corretta comprensione che
nel mondo arabo non esiste una omosessualità inquadrabile
secondo le categorie culturali più vicine al pensiero occidentale.
Si parla di comportamento e pratica dell'omosessualità ma non di
identità e di identificazione. Persone omosessuali mussulmane
esistono, come esistono comunità gay squisitamente arabe ma
questo è un fenomeno decisamente recente, al riguardo del quale
dirò più avanti.
La pratica omosessuale acquisisce la forma di un idioma di genere
particolare ma sempre e comunque maschile. E' raro se non
impossibile trovare, nel medio oriente, omosessuali effemminati,
salvo il loro inserimento in altre categorie culturali locali (il
56
L'omosessualità in Palestina rappresenta anche, nonostante i suoi
alti costi, il miraggio di "un biglietto aereo per l'Europa
(Occidente)"; esso però non è un processo cosciente e strumentale
come si può osservare in Marocco, ma qualcosa di estremamente
più sottile, forse incorporato, inconsciamente idiomatizzato nella
costruzione dei giovani. L'impossibilità di un Coming out 3 in
patria e la paura mortale di un Outing4 danno origine ad un flusso
migratorio, che interessa immediatamente Israele.
Infatti, secondo un accordo firmato nel 1951 all'ONU, anche da
Israele, la persecuzione per motivi sessuali permette di fare
domanda di asilo politico; ma per un omosessuale palestinese non
è facile. Sono circa trecento i giovani gay conosciuti, che hanno
scelto di fuggire dalla Cisgiorrdania o dalla Striscia di Gaza, per
andare a vivere, ma spesso a sopravvivere in Israele. Qui giunti,
sempre secondo quanto riferisce Amnesty International,
dimenticano la lingua araba e imparano alla perfezione l'ebraico,
si atteggiano come giovani israeliani: pizzetto, pantaloni militari
sdruciti e indossando anche medaglioni e ciondoli con la stella di
David. Rimane però forte il senso di colpa, l'asciumà, il senso di
venire meno ai propri doveri riproduttivi e quindi anche materiali
verso il proprio clan. Per un palestinese questo equivale a essere
un collaborazionista perché l'omosessualità è innanzitutto un
tradimento sociale verso la propria patria. La vita dei giovani gay
emigrati in Israele è così fragile, perché ricattabili in ogni
momento; spesso, continua Amnesty International, vengono
comprati come informatori in cambio di una promessa di
documenti. Rani, 19 anni, ricorda come, scoperto dai parenti,
fosse scappato a Tel Aviv, dopo che dei militanti palestinesi lo
volevano obbligare a partecipare ad un attentato suicida per
"espiare la sua colpa"5 .
Nonostante la seconda Intifada, e nonostante essa renda
certamente difficoltosa la vita dei giovani palestinesi omosessuali,
le coppie miste che vedono un palestinese e un israeliano "fare
famiglia" sono veramente molte. Ma come si spiega che un odio,
se non atavico certamente molto radicato e complesso, venga
superato in situazioni marginali come queste, inteso in senso sia
sociologico che antropologico?
Ad una prima osservazione puramente visiva, tutte le coppie
sembrano ricalcare il modello occidentale di "Gay Pride", ma
nessuno dei ragazzi con i quali sono venuto in contatto è
decisamente effeminato. Il modello del maschio (Arab) è
certamente lontano, e per questi giovani normalmente viene
utilizzato il termine tanguy, che probabilmente vuol dire
immaturo, debole, infantile, ma che non rimanda immediatamente
ad una pratica o a una condizione omosessuale; esso sta ad
indicare i giovani che vestono secondo i canoni europei,
sottolineando quindi che i giovani gay palestinesi e israeliani, nel
seguire tale modello, non esprimono che una possibile condizione
giovanile e non uno specifica rivendicazione in chiave di genere
o orientamento. Ma allora qual è il senso di queste coppie?
Semplice opportunismo? O movimento culturale?
Bisogna sapere, che nonostante il forte veto dei religiosi
ortodossi, e una opinione pubblica abbastanza contraria, come mi
spiega Nir, il mio amico informatore a Tel Aviv, le coppie
omosessuali sono riconosciute e due giovani maschi possono
unirsi attraverso un contratto matrimoniale, dal 1997.
La complessa situazione politica sembra accanirsi proprio verso
le coppie miste, nonostante lo status di rifugiato politico dei
palestinesi omosessuali; i permessi di soggiorno rilasciati dal
ministero dell'interno e dal quello degli affari sociali non vengono
progressivamente rinnovati, a motivo del veto dei servizi di
sicurezza, gettando però nella clandestinità centinaia di giovani,
che peraltro rischiano seriamente la vita, non potendo più
rientrare in Palestina.
La questione è di estrema gravità ed è presa molto seriamente non
solo dalle associazioni omosessuali locali, tra le quali la più
importante è Agudah che fornisce questi dati, ma anche dalle
associazioni per la tutela dei diritti umanitari.
Shaul Gonen, membro di Agudah riferisce che la condizione degli
omosessuali palestinesi è drammatica e che le coppie miste spesso
decidono di vivere in clandestinità, inosservate, rimanendo chiuse
in casa dopo ogni attentato per paura di forme di rappresaglia.
Prima dell'11 Settembre gli omosessuali palestinesi erano costretti
a nascondersi solo in quei luoghi e in quelle comunità dove i
gruppi di integralisti islamici erano particolarmente forti e in
soprattutto in zone quali Nablus, Hebron, i villaggi nei dintorni e
nei campi profughi da Gaza; mentre in città quali Ramallah ed El
Bireh era tollerata dall'Autorità palestinese. A seguito della
seconda Intifada, le coppie miste (visibili) sembrano diminuite in
Israele, per i timori di espulsioni e rappresaglie, ma ad un rapido
calcolo statistico potrebbero essere circa meno di 290.
Samir e Shlomi, israeliano e palestinese hanno circa trent'anni e
vivono insieme da cinque. La loro unione è sancita da un contratto
matrimoniale ed è rispettata e tollerata. Purtroppo il permesso di
soggiorno di Samir è scaduto e non è stato possibile rinnovarlo,
nonostante i suoi 14 anni di residenza in Israele e l'interessamento
di numerose persone. Samir non può tornare nel suo villaggio in
Cisgiorrdania perché verrebbe arrestato, probabilmente torturato,
accusato di collaborazionismo e anche ucciso dai suoi stessi
familiari, nonostante la legge palestinese preveda meno di 5 anni
per il reato di sodomia e pratiche omosessuali.
Said invece vive nei Territori occupati ed è fornito della carta di
soggiorno, o meglio dell'autorizzazione a risiedere il Israele; ciò
nonostante è costretto a vivere quasi come un clandestino6. Ha 27
anni, parla un ottimo ebraico ma un pessimo inglese. Anche lui ha
per compagno un israeliano con il quale convive e lavora. Ha
preso consapevolezza di sé durante l'adolescenza ed è venuto a
conoscenza della comunità gay israeliana attraverso i media. Il
suo primo approccio con Israele è passato per la prostituzione, fin
quando, scoperto dai parenti, è stato costretto alla fuga, anche
perché il fatto è avvenuto al ritorno del padre dal pellegrinaggio
alla Mecca. Sa di non poter tornare a Ramallah perché
probabilmente verrebbe ucciso e l'unico modo per evitarlo
sarebbe quello di uccidere Shlomo, per espiare il peccato,
dimostrarsi pio, e salvare l'onore della sua famiglia, riscattandosi
così dalla maledizione che il padre gli ha fatto.
Quando si affronta la questione religiosa dice "...mi sento
mussulmano e praticante. Lo so che l'omosessualità è un peccato,
57
ma questa è una cosa tra Allah e me. (N.d.A. fuori dal Diwan).
Per il resto sono un buon mussulmano".
Riconosce di avere rapporti migliori con gli ebrei e spera un
giorno di poter vivere in pace e poter considerare gli ebrei alla
stregua di fratelli. Non nasconde la speranza che la Palestina
possa diventare uno Stato pienamente sovrano in senso
democratico, e spera che il contributo del movimento
omosessuale possa servire in tal senso. Anche Shlomo fatica a
vedere la differenza tra il combattere per il riconoscimento dei
diritti degli omosessuali, fare pressione sul governo perché
accolga i profughi ed essere contro l'occupazione.
L'aspetto interessante, con dati di prima mano raccolti
(virtualmente), è che l'omosessualità sembra essere
significativamente diffusa tra i giovani militari israeliani e come
si legge anche in uno studio a cura dell'esercito di Israele; mi è
difficile comprendere se in termini di comportamento o di
identità, ma la questione è comunque interessante poiché sembra
presentare una analogia con la critica che i giovani omosessuali
palestinesi incorporano nei confronti del Diwan. Uno Stato
fortemente militarizzato, e, nei suoi dirigenti, molto in difficoltà a
trovare "vie terze" per una pacifica convivenza e una reciproca
tutela, viene criticato attraverso forme sotterranee di
comportamenti eterodossi anche dal punto di vista della pratica o
dell'identità sessuali; un recente film ha affrontato la questione 7.
Possiamo allora trovare in queste linee di indagine un primo
punto fermo. Una coppia mista, pubblicamente riconosciuta che
integra la cultura israeliana e quella palestinese, meticciandole,
anche tra Oriente e Occidente, rappresenta, non solo una critica,
ma
in
senso
funzionalista,
un
processo
di
creazione/trasformazione e di adattamento/ibridazione di
comunità culturali costrette a condividere ecologicamente spazi
sociali e territori.
Il fenomeno è molto simile all'inoculazione tra gli alberi. Due
piante, anche di specie differenti, venendo in contatto, e sfregando
la corteccia fino a consumarla e a mettere in contatto la loro parte
viva, finiscono spesso con dare origine a un innesto naturale.
Inoltre, considerando una qualunque società, non come un blocco
statico, ma come l'espressione di un mutamento in continua
evoluzione, dinamico e non totalmente ciclico, l'omosessualità,
sia il comportamento omosessuale, che la vera e propria
identificazione di gruppo e di orientamento, hanno una funzione
molto simile alle anse di espansione dei fiumi, nei periodi di
piena. Mi spiego: nella logica dell'inversione l'esistenza di gruppi
omosessuali o di pratiche di tale natura è funzionale alla
riaffermazione, alla ri-produzione e al mantenimento dei valori
del gruppo dominante (in questo caso di matrice eterosessuale,
maschile e femminile). L'emersione di una modalità permanente,
in termini identitari e culturali, è certamente questione complessa
e non solo dal punto di vista antropologico, ma è forse in
relazione all'anomalo periodo di anomia che stiamo
attraversando, alla generale insicurezza e alla conseguente
ipertrofia di valori e modelli che i media diffondono ormai a
livello planetario.
Dunque l'omosessualità sembra avere tre funzioni importanti: la
prima è quella della creazione di uno spazio intimo, che non è
però quello privato associato alla femminilità, uno spazio che non
gode di una valenza pubblica (maschile) e dei diritti conseguenti
ma che risulta essere funzionale alla riproduzione della società in
termini di idiomi, per una ri-appropriazione perversa dei confini.
La seconda funzione è simmetricamente correlata alla prima e
certamente più evidente: riguarda l'aspetto critico della
riproduzione degli idiomi di genere e dello spazio (potere in
relazione a ) ad esso associato. Essa rappresenta lo spazio di
rottura, di incommensurabilità, di distanza tra l'ideale e il reale, la
necessità continua della "parola", dell' "idioma" detti e ri-detti,
continuamente ri-affermati. E' una funzione critica al potere, il
quale rischierebbe altrimenti di essere autoreferenziale, a rischio
di incancrenimento, funzione che lo obbliga a riaggiustare
continuamente il tiro in relazione all'individuo, all'economia, alle
parole, e a tutti gli input e ai suoi stessi output, nel processo di
retroazione, nella logica di un equilibrio, di una complessità
caotica e contingente 8 . La terza funzione è quella
dell'inoculazione, che potremmo anche chiamare "ponte". Una
coppia omosessuale mista, proprio per la sua marginalità sociale,
non in senso morale ma funzionale, crea legami deboli9 e
(socialmente) ritrattabili, perché, avendo la funzione di apripista,
avvia il processo di creazione di categorie e prassi sociali nuove e
terze, ma non avendo una generazione biologica che sia la sintesi
delle due provenienze, non rischia di inserire nel tessuto sociale
forze "altre", potenzialmente pericolose per l'identità del sistema
e in definitiva per la sua stessa esistenza, pur permettendo
appunto esperimenti e pratiche di tipo sociale, quali, banalmente,
la convivenza. Le statistiche qualitative e quantitative sulla
composizione delle coppie omosessuali sembrano confermare
questa ipotesi, nonché il materiale etnografico raccolto e
analizzato.
Corpi, Islam e omosessualità
La categoria dell'impuro
L'incontro del mondo arabo con il messaggio del profeta ha
radicalizzato una bipolarità che forse prima era più flessibile,
come detto, almeno per l'orientamento di genere o semplicemente
per le pratiche sessuali in generale. Assumiamo dal medioevo
islamico come l'universo sociale, peraltro rimasto immutato da
allora10 fosse stato distinto dalla teologia e dalla giurisprudenza in
dhakar (sesso maschile) e ountha (sesso femminile), entità
complementari ma ordinate secondo una gerarchia religiosa.
Dhakar è un termine che rimanda l'idea di membro virile, di
memoria e di radice, costruendo culturalmente il maschio come
colui che ha ricevuto il deposito virile da Dio per la trasmissione
del messaggio divino, come essere forte e sintesi di pene, ragione
e fede. L'uomo è difettosamente memoria di Allah, che comunque
rimane l'unico, pura trascendenza, verticalità assoluta e che
soprattutto non va in coppia. Ountha rimanda invece l'idea di
debolezza, erba verde, smemoratezza, ed è associata
inconsciamente a Iblis, il senza pene per eccellenza.
58
Il giovane omosessuale, cresciuto nella pedagogia tribale, anche
quando accetta di vivere come un luti, ha con il proprio corpo un
rapporto molto particolare, quasi ossessivo; infatti fin da piccolo
apprende la categoria dell'impurità. I suoi atti sono
inconsapevolmente guidati dall'assimilazione del Corano.
Bisogna però precisare che tale comportamento non affonda le
radici nella psicologia individuale è proprio una
sovradeterminazione culturale, uno spazio performativo e
cognitivo. Non è l'atto sessuale, neanché se omofilo, ad essere
considerato impuro, quanto piuttosto i liquidi organici quali il
sangue (in analogia con il mestruo femminile), il liquido seminale
maschile, gli escrementi, l'urina, le cui tracce devono essere lavate
dal corpo per una esigenza metafisica.
La cura del corpo occupa molto tempo nel giovane omosessuale,
come in tutti i credenti, poiché, al di là della pratica, è necessario
per mettersi davanti a Dio nella preghiera, attraverso le abluzioni
(rituali)11 .
picchiarlo con ogni possibile oggetto, compresi ferri arroventati,
perché sorpreso in compagnia di un amico.
Le immagini del processo della Queen Boat (celebratosi in
Egitto), e salito all'attenzione per la grande quantità di imputati
accusati12 di "atti immorali" 13, circolate clandestinamente sulla
rete, pur sfocate, riportano particolari raccapriccianti. Le brevi
testimonianze riportate sull'Internazionale e apparse su Telquel
con i titolo di "Détenus pour déviance sexuelle" parlano da sole:
"…una volta arrestati, i sospetti vengono torturati. In tre casi,
dove si era stabilito che la vittima di un assassinio aveva avuto
rapporti omosessuali, centinai di gay sono stati arrestati e
torturati per strappargli confessioni e anche per sadiche
rappresaglie…”. "Eravamo 300 o più. Ho visto torture
incredibili. I lineamenti di un ragazzo, si chiamava Shadi, si
distinguevano a malapena: aveva gli occhi gonfi, il volto
sembrava un pallone da calcio per tutte le percosse che aveva
ricevuto. Abbiamo visto un altro gay al quale avevano slogato
una spalla. Gli avevano legato le mani dietro la schiena e
l'avevano appeso al telaio della porta. Poi gli avevano legato una
bombola di gas alle gambe. Dopo, nella cella, lo avevano
ammanettato ad un anello conficcato per terra. Gli impedivano di
andare al gabinetto. Lo hanno lasciato così per quattro giorni".
L'articolo continua con i racconti di ustioni inferte, di scariche e
morse nei genitali per tempi infiniti, di bottiglie impropriamente
utilizzate.
Il parlamento palestinese sta preparando una legge, che prevede
però un iter lunghissimo prima della presentazione al premier, ma
l'opposizione è grande poiché, spiega Isam Abdeen, docente
universitario e consulente governativo, "se venisse approvata una
legge simile, scoppierebbe una guerra civile", poiché continua
"...non può essere considerata una forma di libertà, è piuttosto
un'offesa...". Un teologo iraniano, recentemente interrogato sul
tema da uno studente durante una conferenza universitaria, ha
affermato che la giusta condanna per chi pratica gli atti
omosessuali condannati da Corano e Sharia, dovrebbe "...essere
tagliato in due partendo dalla testa".
AIDS
Nonostante questa cultura di cura del corpo, e la presenza dei
media, la prevenzione ad opera delle associazioni omosessuali
israeliane e non, secondo l'agenzia Reuters la diffusione del virus
HIV tra gli arabi omosessuali negli strati più poveri della
popolazione palestinese (e israeliana) è maggiore di quella che
l'OMS ha stimato essere fino ad oggi in questa regione.
L'ostilità culturale peggiora costantemente l'epidemia e la
pressione sociale non migliora lo stato delle cose, poiché l'AIDS
è tabuizzato e considerato, soprattutto dagli anziani, un castigo
divino a motivo del proprio comportamento. Secondo il direttore
del Centro AIDS di Hadassah i sieropositivi presenti nei territori
palestinesi sono circa 200.
Tortura
Spesso in Palestina, come in altri paesi mussulmani quali l'Iran e
l'Egitto, quando un omosessuale viene arrestato viene sottoposto
a tortura. E' difficile capire - ci vorrebbe un indagine approfondita
sul campo- se le forme di tortura, delle quali porterò esempi di
seguito, possano inquadrarsi in un qualche discorso.
Probabilmente sì. E' molto impressionante sentire parlare
dell'argomento e sorge spontaneo chiedersi il perché di tanto odio,
non giustificato a mio avviso neanche dalle categorie culturali che
costituiscono l'identità di genere.
La Umma virtuale: The Gaymiddleeast Community
Molti omosessuali arabi e mussulmani sono emigrati all'estero,
sia negli USA che in Europa e questo ha permesso recentemente
la nascita di una fragile rete Web tutta palestinese. Il 21 marzo è
stato deciso il suffisso che distinguerà i siti palestinesi (.ps).
Mailing List appositamente dedicate esistono da tempo quali:
[email protected],
o
la
più
recente
[email protected] e numerose altre divise per regione
geografica di provenienza e accomunate dalla comune matrice
omosessuale, islamica e anche a volte palestinese. Esistono anche
chat dedicate e siti che mettono in contatto omosessuali
mussulmani tra loro, nel più puro stile occidentale. Decido di
iscrivermi alla Mailing List [email protected] e dopo
poco tempo vengo ammesso nel gruppo, nonostante le mie origini
italiane e cristiane. Scelgo di non intervenire mai e semplicemente
Ahmed ha 23 anni e vive in Israele dal 1998. In occasione dei
funerali del padre è tornato in Cisgiorrdania, dove è stato fermato
dalla polizia, condotto in caserma e picchiato. Ha passato l'intera
notte immerso in una fossa piena di acqua di fogna, poi, in
assenza di prove e di una confessione, è stato rilasciato.
Mohamed racconta, e sono ancora ben visibili i segni delle ultime
ore trascorse nella casa della sua famiglia, di essere stato legato
ad una colonna dai fratelli e dai genitori, che hanno iniziato a
59
This group is conected and activated by gaymiddleeast.com - the biggest website
for/about GLBT in the Middle East. You can join us and send your Add's / News
/ Stories and more, by this you will join the big revolution that
GayMiddleEast.com creat on the net.We always need more information and
participation to help us taking that revolution forward.
The countries on
http://www.gaymiddleeast.com : Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan,
Kuwait, Lebanon,Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UA
Emirates, Yemen.
di osservare gli argomenti che vengono trattati. La Mailing List in
questione rappresenta un'assoluta novità ed esiste da poco più di
un anno. I parteciparti coprono tutto il medio oriente ed è aperta
come leggiamo sullo stesso sito ai mussulmani dei seguenti paesi
(Middle East). E' interessante notare la presenza di Israele.
Il gruppo sembra essere di circa 40. Tre sono i sottogruppi.
Quello dei moderatori e fondatori, gli assidui e gli occasionali che
si dividono in arabi e non arabi. Sembra esserci una correlazione
il numero dei presenti per Stato, la forma di governo e
l'atteggiamento politico omofobico o omofilo di questi. In quei
paesi dove vi è una persecuzione maggiore, troviamo nella
Mailing List più rappresentanti, (es. Egitto, Siria, Iran), mentre
sono praticamente assenti o quasi quelli dove vi è una comunità
omosessuale con potere politico, visibilità o riconoscimento
legale (es. Libano, Israele). L'età dei partecipanti va dai 18 ai 54
anni ma con una concentrazione e una moda attorno ai 27-32. I
casi over 40 sembrano essere mussulmani europei naturalizzati
all'estero, generalmente nei paesi anglofobi o avventurieri
"esotici" occidentali. Gli argomenti trattati sono i più vari: dalla
mercificazione sessuale, alla politica interna, alle vicende legate
ai rapporti internazionali, prevalentemente statunitensi, alla
religione e al rapporto tra vita mussulmana e omosessualità,
nonché un buon livello di animazione culturale dedicata14.
Il mio incontro con Nadr avviene una sera di quelle piovose in
chat; sono solo e agli inizi della raccolta del materiale sugli
omosessuali palestinesi. Dopo giorni di appostamento, durante i
quali sperimento costantemente un senso di frustrazione nel
vedere la stanza (Room) sempre vuota, e ad attendere invano che
il responsabile di Agudah mi rinvii le risposte alle domande per le
quali si era così gentilmente prestato, compare il suo nome e lo
contatto. E' cordiale ma sembra avere una grande fretta.
Nonostante ciò riusciamo a chattare la prima volta circa un'ora e
anche altre volte. Ci scambiamo saltuariamente scarne e-mail.
Scopro in seguito che riesce ad avere la disponibilità di una
connessione una o due volte la settimana. Parla un pessimo
inglese molto elementare. Mi chiede di inviargli una fotografia e
sembra essere molto contento del fatto che un ragazzo italiano si
interessi a lui per conoscere la vita dei palestinesi. Vive a Gaza e
si definisce (sessualmente) top "…looda: i am top…". Riporto di
seguito stralci di conversazione.
W.: hi
looda: hi
W.: are you palestinian?
looda: yas
W.: wow
looda: you
W.: i am form italy
looda: i am in gaza
W.: i am a university student
W.: i am looking for gay in palestina
looda: wer ar you
W.: now?
looda: yas
W.: at home in italy
W.: milan
W.: do u know it?
looda: you love palastenyen
W.: are you there?
W.: yes
W.: i would like to know them better
W.: can you help me for that?
looda: hew old ar you
W.: 30
W.: and you?
looda: 29
W.: can we exchange email?
looda: i am not rait god english
W.: it is not a problem
W.: if you want you can write in arab
W.: i have some arab friends
looda: yas
W.: and so i can learn it
W.: my name is william
looda: (scritta in arabo)
W.: ok:-)
W.: i have to traslate it later
looda: i am nadr
W.: please give me yor email
adress...
60
W.: this is mine
looda: you have pik
W.: yes but not here
W.: i can send them later
W.: or by post
looda: xxxxxx@hot mail .com
W.: thanks
W.: mine
W.: [email protected]
W.: what do you do?
W.: work study?
looda: i am work
W.: what kind of job?
W.: :-)
looda: in markat
W.: ok
W.: my work is helping drug addicts
looda: you rait arapik
W.: eh?:-)
W.: ask me what you like
looda: yous spik arapik
W.: not speak
looda: weat you like
W.: about waht, in general?
…………………………
W.: have you a mate?
W.: if i send email to you, you will aswer to me?
W.: ehi...
looda: you have email in hot mail
W.: no
W.: it is better for you?
looda: wey
W.: i can create it
W.: ok i will do
looda: god
W.: so i will send my pics
W.: what time is there now?
W.: here is 19.30 pm
looda: it 8/30in nit
W.: one hour of difference
looda: 20.30
W.: yes:-)
…………………….
W.: have you ever come in italy?
looda: i am not come
looda: but i love com
looda: i am love italy
W.: ok:-)
W.: i love palestina
looda: and love itali gay
W.: i would like to know it better
looda: i am not andarstand
W.: what it means?
looda: i am not god in english
W.: no problem
W.: do you live alone?
looda: yas
W.: what do a gay there?
W.: to be gay there il forbidden, no?
looda: i am not have poy frand
W.: sorry... do you fell alone?
looda: i am alone
W.: any gay friend?
looda: in gaza no mor gay
……………………………..
looda: you comein gaza
W.: i woul d like
W.: i will do when possible
W.: i never come there before
looda: no possible
looda: i com you ??
looda: you go in egypt
W.: could you come to Italy?
looda: i wil thet
………………………….
W.: i will send an email from hot mail on monday, ok?
looda: i am not have mor tokin english
looda: ok
W.: ok
W.: i am leaving now
looda: ok
W.: bye Nadr, we hear soon
W.: ciao
looda: pye
W.: bye bye
W.: ehi...
W.: ciao
looda: ciao
W.: :-)
looda: pye
Conclusioni
Il cambio della condizioni di vita degli omosessuali palestinesi e
non, e il riconoscimento dei loro diritti civili non potrà non
passare attraverso un generale miglioramento della situazione in
Medio Oriente, e attraverso un'evoluzione in senso pluralista e
democratico degli stati islamici, in particolare della Palestina
fonte di tanti conflitti.
L'assetto democratico e parlamentare non è in ogni caso garanzia
del buon esito di questo processo, come dimostrano le vicende
politiche recenti. La vera sfida, come sempre è quella del dialogo
culturale, e quello della costruzione di una via terza che sappia
valorizzare gli aspetti migliori di tutte le parti in causa, per la
costruzione di un nuovo umanesimo (poiché credo che questa
parola non sia proprietà esclusiva di nessuna cultura, quanto
piuttosto l'affermazione della bontà ontologica dell'essere umano
e della sua capacità creativa).
61
L'operato delle associazioni israeliane, di quelle dei diritti umani,
dell'OMS per quanto riguarda la prevenzione dell'AIDS e la
riflessione antropologica (sessuale, politica e medica) porterà
certamente quei frutti, i cui primi germogli cominciano ad
intavvedersi.
L'augurio è che ci si renda conto che i diritti degli omosessuali
palestinesi non sono che uno dei tanti aspetti dei diritti dell'uomo,
per migliore i quali è necessaria una adeguata attenzione politica
e antropologica anche su questo argomento così specifico e forse
poco accademico.
Se anche alla comunità omosessuale mediorientale verrà offerta la
possibilità di integrarsi nel rispetto del ruolo che tale forma di
pratica e di identità incorporata sembra avere all'interno di tutti i
gruppi umani, di tutte le società e non solo quelle islamiche e
localizzate nell'area del Medio Oriente, avremo forse un mattone
in più per pace e giustizia.
Per ora ci rimane un campo di indagine antropologica interessante
e fecondo per la comprensione non solo dei ruoli di genere, ma
anche di come i sistemi e gli idiomi possono mutare anche in
contesti fortemente religiosi e ortodossi.
NOTE
1
Cfr Mauro Van Aken
Chebel Malek, Le corp dans la tradition au Magreb, Parigi, PUF, 1984
3
Rivelazione spontanea pubblica o privata della propria omosessualità.
4
Situazione per la quale la condizione omosessuale di una persona diviene di dominio pubblico, anche in un contesto più privato, per
motivi che prescindono dal suo consenso e dalla sua volontà.
5
Rani è misteriosamente scomparso dopo aver rilasciato questa breve intervista, secondo quanto riportano i suoi amici.
6
La carta rilasciata a chi gode dello status di rifugiato per discriminazione sessuale non è un vero e proprio permesso di soggiorno ma
fornisce uno status ibrido e spesso non è rispettato dalla polizia.
7
Youssi and Jagger, Israele 2002
8
"Contingente" nel senso utilizzato da K. Popper
9
I legami deboli per loro natura creano ponti, secondo le recenti acquisizioni della teoria delle reti cfr. M. Bukanan 2004
10
Stesso destino per il Cristianesimo se si pensa che i manuali di morale sui quali si formano generazioni di sacerdoti fa ancora
riferimento, per quanto guarda l'omosessualità, alle parole di San Girolamo (?) che nel Medioevo scriveva come …Dio la notte prima
di incarnarsi nel seno della vergine Maria avesse voluto sterminare tutti i pervertiti sodomiti, per poter nascere in un mondo di puri …
11
Ritorna l'idea dell'incontro sessuale leggibile in chiave rituale.
12
I media riportano che le persone coinvolte negli arresti erano almeno 300.
13
Si parla di "atti immorali" perché l'omosessualità ufficialmente non esiste; essa è un'invenzione occidentale.
14
Così ben organizzata che a volte mi veniva il sospetto fosse stata commissionata da Amazon.com.
2
BIBLIOGRAFIA
Libri
Augè Marc, Poteri di vita poteri di morte. Introduzione a un'antropologia della repressione, Cortina editore, Milano, 2003.
Chebel Malek, Le corp dans la tradition au Magreb, Parigi, PUF, 1984
Eickelmann, Antropologia del Medio Oriente.
Fabietti Ugo, Culture in bilico antropologia del Medio Oriente, Bruno Mondadori, Milano, 2002.
Herdt Gilbert, Guardian of the flutes, University of Chicago Press, 1994.
Internazionale, "Essere gay nel mondo arabo", n° 546 - Anno 11
Mouhammed Shukri, Il pane nudo.
Patanè Vincenzo, Arabi e noi. Amori gay nel Magreb, Derive Approdi, Roma, 2002.
Recherches, Trois Milliards de Pervers. Grande Encyclopédie des Homosexualités, Francia, marzo 1973.
62
Said Edward, Orientalismo, Edizioni Feltrinelli.
Van Aken Mauro, Facing Home. Palestinian Belonging in a Valley of Doubt, Shaker Publishing, 2003.
Vercellin Giorgio, Istituzioni del mondo mussulmano, Einaudi, Torino 1996.
Siti internet
www.amnestyinternational.com
www.gay.it
www.gayarab.org
www.gay.tv
Filmati
Yossi and Jagger, Israele, 2002.
Filmati sul caso della Queen Boat.
Tawfik Abu Wael, Yawmiyat A'hir, Diary of a Male Whore, video '14 col, Palestina, 2001, Middle Easter Cinemas.
4
Achab segnala...
Afriche in movimento: seminari sull´Africa in Bicocca
A partire da quest´anno, nell´ambito degli insegnamenti di antropologia della facoltà di
sc. della formazione, verrà organizzato un seminario permanente sull´Africa dal titolo
"Afriche in movimento". Si tratterà di una serie di incontri con studiosi italiani e stranieri
con l´obiettivo di discutere sulle dinamiche politiche sociali e culturali dell'Africa
contemporanea. Qui di seguito riportiamo i primi 3 incontri. Altri 3 verranno organizzati
nel corso del secondo semestre. Luogo e orario verranno comunicati in seguito.
28 ottobre - Francesco Remotti (Università di Torino)
Putrefazione e rigenerazione della vita nel bananeto nande
25 novembre - Ivo Quaranta (Università di Bologna)
Politiche del silenzio:
AIDS e nuove soggettività giovanili a Nso’ (Camerun)
14 dicembre - Georg Klute (Università di Bayreuth)
La poesia della rivolta tuareg
Per informazioni rivolgersi a: [email protected]
63
Se volete collaborare con la Rivista con vostri articoli o commentare,
proporre temi di discussione o suggerimenti, scrivete a:
[email protected]
oppure a:
[email protected]
La versione on line della rivista è disponibile su www.studentibicocca.it/achab