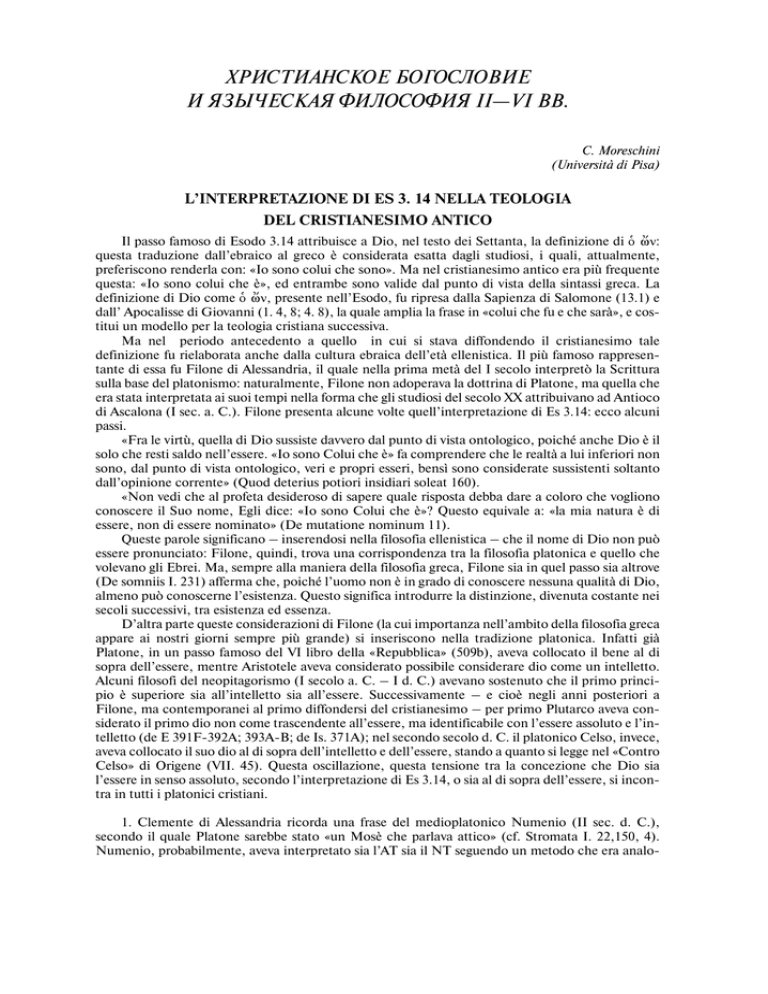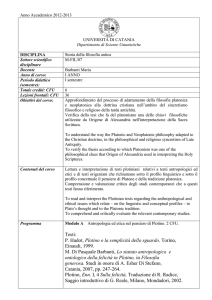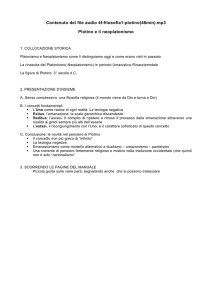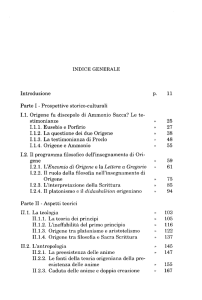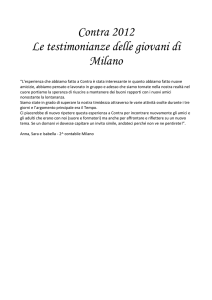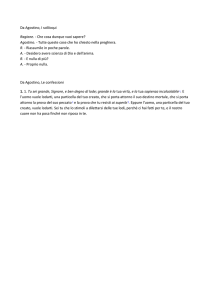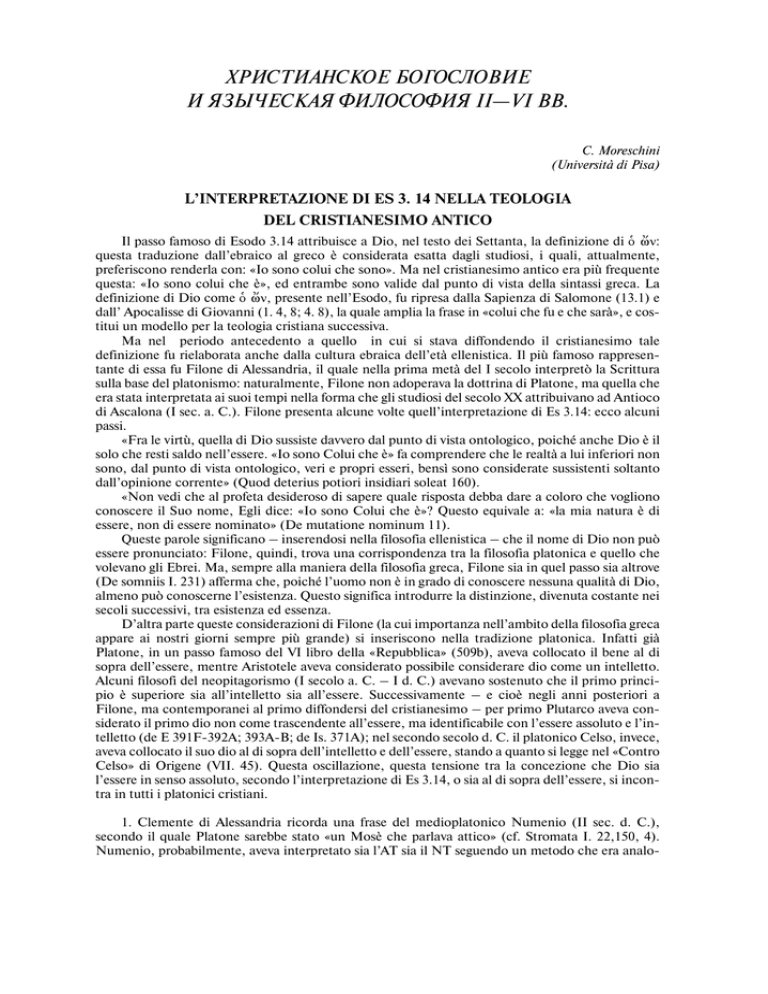
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
И ЯЗЫЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ II—VI ВВ.
C. Moreschini
(Università di Pisa)
L’INTERPRETAZIONE DI ES 3. 14 NELLA TEOLOGIA
DEL CRISTIANESIMO ANTICO
Il passo famoso di Esodo 3.14 attribuisce a Dio, nel testo dei Settanta, la definizione di +o @wn:
questa traduzione dall’ebraico al greco è considerata esatta dagli studiosi, i quali, attualmente,
preferiscono renderla con: «Io sono colui che sono». Ma nel cristianesimo antico era più frequente
questa: «Io sono colui che è», ed entrambe sono valide dal punto di vista della sintassi greca. La
definizione di Dio come +o @wn, presente nell’Esodo, fu ripresa dalla Sapienza di Salomone (13.1) e
dall’ Apocalisse di Giovanni (1. 4, 8; 4. 8), la quale amplia la frase in «colui che fu e che sarà», e costitui un modello per la teologia cristiana successiva.
Ma nel periodo antecedento a quello in cui si stava diffondendo il cristianesimo tale
definizione fu rielaborata anche dalla cultura ebraica dell’età ellenistica. Il più famoso rappresentante di essa fu Filone di Alessandria, il quale nella prima metà del I secolo interpretò la Scrittura
sulla base del platonismo: naturalmente, Filone non adoperava la dottrina di Platone, ma quella che
era stata interpretata ai suoi tempi nella forma che gli studiosi del secolo XX attribuivano ad Antioco
di Ascalona (I sec. a. C.). Filone presenta alcune volte quell’interpretazione di Es 3.14: ecco alcuni
passi.
«Fra le virtù, quella di Dio sussiste davvero dal punto di vista ontologico, poiché anche Dio è il
solo che resti saldo nell’essere. «Io sono Colui che è» fa comprendere che le realtà a lui inferiori non
sono, dal punto di vista ontologico, veri e propri esseri, bensì sono considerate sussistenti soltanto
dall’opinione corrente» (Quod deterius potiori insidiari soleat 160).
«Non vedi che al profeta desideroso di sapere quale risposta debba dare a coloro che vogliono
conoscere il Suo nome, Egli dice: «Io sono Colui che è»? Questo equivale a: «la mia natura è di
essere, non di essere nominato» (De mutatione nominum 11).
Queste parole significano – inserendosi nella filosofia ellenistica – che il nome di Dio non può
essere pronunciato: Filone, quindi, trova una corrispondenza tra la filosofia platonica e quello che
volevano gli Ebrei. Ma, sempre alla maniera della filosofia greca, Filone sia in quel passo sia altrove
(De somniis I. 231) afferma che, poiché l’uomo non è in grado di conoscere nessuna qualità di Dio,
almeno può conoscerne l’esistenza. Questo significa introdurre la distinzione, divenuta costante nei
secoli successivi, tra esistenza ed essenza.
D’altra parte queste considerazioni di Filone (la cui importanza nell’ambito della filosofia greca
appare ai nostri giorni sempre più grande) si inseriscono nella tradizione platonica. Infatti già
Platone, in un passo famoso del VI libro della «Repubblica» (509b), aveva collocato il bene al di
sopra dell’essere, mentre Aristotele aveva considerato possibile considerare dio come un intelletto.
Alcuni filosofi del neopitagorismo (I secolo a. C. – I d. C.) avevano sostenuto che il primo principio è superiore sia all’intelletto sia all’essere. Successivamente – e cioè negli anni posteriori a
Filone, ma contemporanei al primo diffondersi del cristianesimo – per primo Plutarco aveva considerato il primo dio non come trascendente all’essere, ma identificabile con l’essere assoluto e l’intelletto (de E 391F-392A; 393A-B; de Is. 371A); nel secondo secolo d. C. il platonico Celso, invece,
aveva collocato il suo dio al di sopra dell’intelletto e dell’essere, stando a quanto si legge nel «Contro
Celso» di Origene (VII. 45). Questa oscillazione, questa tensione tra la concezione che Dio sia
l’essere in senso assoluto, secondo l’interpretazione di Es 3.14, o sia al di sopra dell’essere, si incontra in tutti i platonici cristiani.
1. Clemente di Alessandria ricorda una frase del medioplatonico Numenio (II sec. d. C.),
secondo il quale Platone sarebbe stato «un Mosè che parlava attico» (cf. Stromata I. 22,150, 4).
Numenio, probabilmente, aveva interpretato sia l’AT sia il NT seguendo un metodo che era analo-
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЯЗЫЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ II-VI ВВ.
85
go a quello di Clemente e di Origene, cioè «allegorico». Ora, questo interesse di Numenio per la cultura ebraica (ma non per quella cristiana) si manifesta anche nel fatto che in un passo (framm. 1617 des Places) egli definisce dio come +o @wn. E un passo di un ignoto scritto ermetico, citato da
Lattanzio (Divinae institutiones I. 6. 4), si riferisce a dio con le parole +o @wn _an)wnumoq, cioè «colui
che è» è privo di nomi, perché i nomi definiscono, e quindi limitano, dio.
Ai tempi di Clemente questa interpretazione di Es 3.14 era diventata, quindi, canonica; in
Stromata V. 34. 4 lo scrittore presenta un’interpretazione del tetragramma sacro degli Ebrei, che
sarebbe simboleggiato dalle quattro colonne che si trovano all’entrata del Santo dei Santi. Il nome
di Dio «si pronuncia Iahvè, che s’interpreta “Colui che è e colui che sarà”»: la frase di Clemente
riprende molto probabilmente l’aggiunta di Apocalisse 1. 4, 8, alla semplice espressione «colui che
è», cui sopra abbiamo accennato. In Clemente incontriamo la maggiore propensione del cristianesimo verso la filosofia greca; Origene, che pure non fu meno interessato di lui alla filosofia,
ebbe, però, varie incertezze ad impiegarla. Clemente si rivolge perciò alla filosofia anche per discutere la problematica dell’uno e dell’essere, che, presente nella filosofia greca, era però rimasta fino
ad allora sconosciuta al pensiero teologico cristiano: in Stromata V. 81. 5-82. 1 si legge:
«Come potrebbe essere esprimibile Dio… non sarebbe corretto chiamarlo il tutto: il tutto implica grandezza, mentre Dio è il padre di tutti gli esseri. Né si dovrebbe parlare delle sue parti: l’uno
non è soggetto a divisioni, e perciò è infinito. Deve essere concepito non come inspiegabile, ma
come privo di dimensioni e illimitato; è pertanto senza forma e senza nome».
Come ha mostrato il Whittaker, il primo passo è basato sulle conclusioni delle prime due ipotesi del «Parmenides» di Platone, che si contrappongono l’una all’altra: mentre Dio, il Padre, è identificato con l’uno della prima ipotesi, che non può esser oggetto di conoscenza né di scienza
(Parmenides 142A), il Figlio riceve gli attributi positivi dell’uno della seconda ipotesi, in quanto è
oggetto della conoscenza (Parmenides 155D) ed è anche l’uno-tutto (Parmenides 145C, cf. 144B).
Il passo applica a Dio (il Padre) alcune importanti connotazioni negative dell’ «uno» della prima
ipotesi del «Parmenides»: Dio è inesprimibile (Parmenides 142A), non è intero e non ha parti
(Parmenides 137C-D), è infinito (Parmenides 137D), è senza forma e senza nome (Parmenides
137D; 142A). Ma già due secoli prima il neopitagorico Moderato aveva affermato che, mentre il
primo «uno» è al di sopra dell’essere – in questo modo egli interpreta il «non essere» della prima
ipotesi del «Parmenides» (142A) – il secondo «uno» è l’essere assoluto, intelligibile, ed è anche la
totalità delle idee. Di conseguenza, secondo Clemente, il Padre è superiore al Figlio: il Figlio è il più
alto fra gli esseri, la totalità degli esseri e l’idea platonica dell’essere, ma non è trascendente e ineffabile. Clemente, con queste affermazioni, preannuncia la filosofia di Plotino, il quale sostiene che
Platone, nel «Parmenides», distingue il primo uno, o uno assoluto, dall’ «uno-molti» (Enneades V.
1. 8).
Tuttavia non è facile conciliare il Dio dell’AT con l’uno del «Parmenides»: Filone si era già
trovato di fronte a questa difficoltà, per cui era ricorso alla interpretazione allegorica (cf. De posteritate Caini 14; De mutatione nominum 7). Nella misura in cui è cristiano e pensatore biblico,
Clemente non può far altro che affermare la Trinità e l’uguaglianza delle tre Persone, mentre, in
quanto è filosofo, non può immaginare che l’uno puro e l’uno molteplice siano equivalenti. Ma la
molteplicità rappresenta una discesa in tutte le sue tappe. Questa è una tendenza interpretativa che
porterà all’arianesimo, e che si manifesta nel modo più chiaro nell’osservazione di Fozio
(Bibliotheca 109), secondo il quale Clemente ipotizzava l’esistenza di due Logoi, quello paterno e
quello immanente. Il Logos incarnato sarebbe, dunque, molto inferiore all’altro. Insomma, il Logos
in quanto è molteplice può essere afferrato dall’intelletto umano, mentre in quanto è unità è divino.
Impostata da Clemente, la alternativa uno / essere non può più essere elusa. Secondo Origene,
il Padre è l’essere stesso, o meglio, è al di là dell’essere. Origene cita l’opinione di Celso in «Contra
Celsum VI. 64» e si sofferma su questa problematica, asserendo che partecipano all’essere coloro la
cui partecipazione è conforme al Logos di Dio. Tuttavia, più frequentemente troviamo in Origene
che Dio è no^uq o «primo no^uq». Inoltre, il primo no^uq è il principio di tutte le cose, e quindi è principio, causa, fonte, demiurgo o padre. Origene interpreta Es 3.14 in un contesto filosofico, secondo
il quale la natura immutabile di Dio è espressa rettamente dal nome +o @wn (Commentarii in evangelium Joannis XIII. 21. 123). Origene (Contra Celsum VI. 18) cita il passo della seconda epistola
pseudo-platonica che fa riferimento ai tre re e paragona il «re universale» al Dio di Isaia e Ezechiele,
il cui viso e i cui piedi sono coperti dai Serafini e che si trova al di sopra dei Cherubini.
L’atteggiamento di Origene nei confronti del «re universale» è quindi lo stesso di Clemente, e non si
86
XVII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
allontana sostanzialmente da quello di Plotino (sia per Origene che per Plotino il «re universale»
corrisponde al sommo Dio).
Qual è il rapporto tra Dio, l’essere e l’intelletto? Dio è superiore all’intelligenza e all’essere o
deve essere identificato con queste due realtà? La questione si pone anche in un passo del «Contra
Celsum VI. 64», e le due soluzioni vengono prospettate in un altro passo di quest’opera (VII. 38):
«diciamo che il Dio universale… è un’intelligenza oppure è al di sopra dell’intelligenza e dell’essere».
Il Padre, come il dio di Celso, come Dio secondo Filone e Clemente, ma non come il dio degli
apologeti greci, è assolutamente sconosciuto alla ragione umana (Contra Celsum VI. 65). Se è assolutamente trascendente e ineffabile nella sua «unicità», al Figlio spetta, invece, la molteplicità, pur
all’interno della natura divina, che egli possiede non diversamente dal Padre. Poiché si è incarnato,
il Figlio non è «uno». La subordinazione del Figlio al Padre è un concetto che ha già una forte presenza in Clemente, e Origene la deduce dalla filosofia platonica contemporanea, che sosteneva l’esistenza di un «secondo dio», ma era comune anche a delle tendenze assai pronunciate nel cristianesimo dei primi secoli, fino a concludersi nella dottrina di Ario. Il Figlio ha la funzione di Logos
intermediario tra il Padre e la creazione, e questa funzione è concepita come una manifestazione di
inferiorità.
Origene riprende questa concezione in un’ampia sezione dei «Commentarii in evangelium
Joannis I. 20, 22», facendo ricorso alla Scrittura e osservando le numerose denominazioni con cui il
testo sacro definisce il Figlio: sapienza, logos, immagine di Dio, splendore etc. Ognuno di questi
titoli esprime, quindi, un diverso aspetto del manifestarsi del Figlio di Dio al mondo, cioè della sua
funzione di intermediario (I. 2. 1). Di conseguenza, pur restando uno nella sostanza (De principiis
IV. 4. 1), Il Figlio è sapienza, in quanto è «luogo delle idee» secondo le quali venne creato il mondo
(I. 2. 2) (questa è una concezione che si trova già in Filone, secondo il quale le idee si trovano nel
Logos di Dio, e nei filosofi medioplatonici); è logos, in quanto interpreta e rivela i disegni di Dio (I.
2. 3); è verità e vita di tutto ciò che è vero e vive (I. 1. 4). Il Figlio, pur caratterizzato dalla trascendenza, percorre tutto il mondo e lo conserva in vita, come fa l’anima cosmica secondo i platonici
dell’età imperiale (II. 1. 3; I. 2. 9). Ogni essere razionale partecipa di lui, in quanto il Figlio è Logos
e principio della razionalità (I. 3. 5-6). Tale partecipazione si manifesta anche come conseguenza
della interpretazione di Dio come «colui che è» (Commentarii in evangelium Joannis II. 96-98):
«Ora, per noi che ci vantiamo di appartenere alla Chiesa, colui che pronunzia queste parole (Es
3.14) è il Dio buono, ed è a lui che il Salvatore allude, rendendogli gloria, con queste parole:
“Nessuno è buono, se non Dio, il Padre”. Quindi il Buono si identifica con “Colui che è”. Ora l’opposto del buono è il male o il malvagio; l’opposto di “Colui che è” è il non-essere: ne consegue che
ciò che è cattivo e ciò che è malvagio sono non-essere. … Pertanto tutti coloro che partecipano a
“Colui che è” (e i santi vi partecipano) si possono a buon diritto chiamare “esseri”; coloro invece
che hanno rifiutato la partecipazione a “Colui che è”, essendo privi di essere, diventano non-esseri»
(cf. anche Commentarii in Romanos IV. 5).
Origene considera il sommo bene come il primo dio e chiama il Figlio «secondo Dio», per
mostrare le differenza tra lui e il Padre (cf. Contra Celsum V. 39; VI. 61; VII. 57; Commentarii in
evangelium Joannis II. 10. 70; VI. 29. 202; De principiis I. 3. 5). Il primo è unico ed è un’unità e una
singularitas, una terminologia, questa, che è di origine pitagorica e quindi meraviglia non poco in
un pensatore cristiano come Origene. L’unità assoluta di Dio è sottolineata da Origene in «De principiis I. 1. 6»: Dio è «una natura semplice e intellegibile, una monade, e per così dire, una enade, un
intelletto e la fonte da cui prende inizio tutta la natura intellettuale e la mente (intellectualis natura
simplex, mon)aq, et ut ita dicam, +en)aq, et mens ac fons, ex quo initium totius intellectualis naturae
vel mentis est)».
Questi termini, come «semplicità», «unità» e «monade» erano correnti anche in Filone e in
Clemente di Alessandria.
Dopo Origene, la interpretazione di Es 3.14 nel senso di «io sono colui che è» è ripresa e ampiamente spiegata nella «Cohortatio ad Graecos» dello Pseudo Giustino, che fu scritta nella seconda
metà del III secolo. L’autore precisa, nella maniera tipicamente cristiana, che Mosè avrebbe detto
che Dio è +o @wn, mentre Platone aveva detto che è t9o 2on (Cap. 22): nello stesso modo Atenagora
(Legatio sive Supplicatio pro Christianis 7) aveva respinto l’accusa di ateismo mossa contro i
Cristiani, asserendo che essi non credono in un ye6ion impersonale, come i pagani, ma nel vero Dio.
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЯЗЫЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ II-VI ВВ.
87
È noto che la distinzione tra +o ye)oq e t9o ye‹on, anche se non ovunque osservata, manifesta la differenza tra mentalità greca e religione cristiana. Secondo lo Pseudo Giustino, Platone avrebbe tratto da Mosè la sua concezione di dio come essere: egli l’avrebbe appresa durante il suo viaggio in
Egitto, il paese nel quale Mosè era a lungo vissuto e in cui aveva insegnato. Ma, una volta tornato ad
Atene, Platone non avrebbe manifestato pubblicamente quanto aveva appreso dalla religione
ebraica, perché temeva di essere punito dall’Areopago; avrebbe, comunque, esposto la sua nuova
convinzione nel «Timaeus», là dove distingue tra l’essere che esiste sempre, e non possiede la nascita, e quello che nasce sempre e non è propriamente mai: appunto, avrebbe chiamato t9o 2on quello
che Mosè aveva definito +o @wn.
Il problema viene ripreso dopo l’intervento di Plotino e la organizzazione della sua dottrina
delle ipostasi originarie. In particolare, è Gregorio Nazianzeno, il «teologo», ad approfondire la
questione: Gregorio di Nissa non mostra un particolare interesse per l’esegesi di Es 3.14, ed in
Basilio se ne trova una, non molto approfondita, ma tradizionale, in Adversus Eunomium II. 18.
Gregorio, quindi, riprende la discussione, tenendo conto della speculazione di Plotino, che lo
aveva preceduto. Dopo avere a lungo parlato della inconoscibilità della natura di Dio, il Teologo
conclude dicendo che di Dio si può affermare solamente che esiste (Oratio 30. 18): «orbene, basandoci su quello a cui possiamo arrivare, “colui che è” e “Dio” sono, in certo qual senso, i nomi
soprattutto della sostanza divina, e, di questi, lo è soprattutto “colui che è”… e noi cerchiamo la sua
natura, grazie alla quale il suo essere è in sé e per sé e non è legato ad alcuna altra realtà; l’essere,
invece, è realmente specifico e tutto intero di Dio, non limitato né troncato da niente che lo preceda o lo segua, ché un tale essere non esiste».
Altrettanto aveva detto Plotino, ma, come è logico, a proposito del Nous, e non a proposito
dell’Uno: «dopo aver tolto ogni cosa e non dicendo su di lui niente e non asserendo, sbagliando, sul
suo conto, niente, come se qualcosa fosse presso di lui, si è lasciato solamente il termine “è”»
(Enneades V. 5. 13).
E’ chiaro, però (e Gregorio non manca di rilevarlo in Oratio 25. 17), che l’essere di Dio non è
la stessa cosa dell’essere nostro. Questa affermazione giustifica, quindi, in quanto la trasforma in un
contesto cristiano, una dottrina di puro sapore neoplatonico che doveva esser ben nota negli ambienti colti del quarto secolo e che Gregorio fa sua in Oratio 6. 12: «Dio è l’essere più bello e più
sublime, a meno che uno non preferisca collocarlo anche al di sopra dell’essere o porre in lui tutto
quanto l’essere, dal quale l’essere è derivato agli altri».
Questa affermazione è ricca di contenuto filosofico: Dio è al di sopra dell’essere, come avevano
di già detto Origene e, soprattutto, Plotino; ma noi crediamo che l’affermazione vada intesa con un
significato cristiano: l’essere di Dio è qualcosa che è al di là dell’essere che la nostra umanità ci
abitua a concepire; inoltre, possiede in sé tutto l’essere e da Dio deriva l’essere per tutte le altre cose.
Questa affermazione, che Dio possiede in sé tutto l’essere, si spiega in quanto Gregorio ha attribuito
a Dio le caratteristiche dell’Intelletto di Plotino: anche per Plotino, infatti, l’essere si trova nella
seconda ipostasi, mentre l’Uno, appunto perché anteriore all’Intelletto, viene a risultare «al di là
dell’essere».
Ma il passo dell’ Oratio 6 va collegato con altri di non minor significato teologico, che uniscono
strettamente l’eternità all’essere di Dio: non nel senso che Dio è eterno (che sarebbe troppo banale),
ma nel senso che l’eternità si può concepire solo se riferita a una totale pienezza dell’essere. Ora,
questa interpretazione più profonda della eternità e del tempo, totalmente nuova di fronte alle
definizioni tradizionali che collegavano il tempo semplicemente al movimento degli astri, è una
rielaborazione plotiniana del concetto di eternità che Platone aveva formulato brevemente nel
Timaeus 37D. Ed ecco i passi di Gregorio: «Dio sempre era ed è e sarà; o meglio, sempre è. Infatti
l’ “era” e il “sarà” sono porzioni del tempo che riguarda noi e della natura sottoposta allo scorrere;
Dio, invece, è sempre, e questo è il nome che egli dà a se stesso…» (Oratio 38. 7) «egli abbraccia e
possiede in se stesso tutto l’essere, che non ha avuto inizio né cesserà, come un mare di essere infinito e illimitato» (Oratio 38. 8).
Gregorio ribadisce, dunque, l’eterno «essere ora» di Dio: la frase «Dio sempre era ed è e sarà»,
va colta in tutta la sua pregnanza; essa corregge l’espressione più usuale e banale per sottolineare che
Dio «è» sempre. Per questo motivo, Dio (il quale è «colui che è», come più volte si è detto) si distingue dall’ «essere ora» parziale delle nature che nascono e periscono. L’ «essere ora» di Dio consiste nel fatto che Dio possiede in sé tutto l’essere, quasi il mare dell’essere. È escluso, quindi, in Dio
il futuro, poiché non si può verificare il momento in cui Dio abbia qualcosa che non ha già ora, men-
88
XVII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
tre il passato e il futuro si possono applicare solamente alle nature corruttibili. L’infinito «essere ora»
di Dio è l’eternità; l’ «essere ora», limitato, della natura corruttibile è il tempo, definito in maniera
tradizionale da Gregorio come «movimento del sole». E l’espresisone «il mare dell’essere» sarà
ripresa da Giovanni Damasceno nel De fide contra Nestorianos e da molti mistici medievali, anche
in Occidente, dopo che l’opera del Damasceno fu tradotta in latino.
Sulla stessa linea aveva ragionato Plotino, il quale, dopo aver ribadito (III. 7. 1) l’usuale
attribuzione della eternità alla natura eterna e del tempo alla natura che nasce e perisce, aveva, per
l’appunto, assegnato la eternità al mondo intelligibile, in cui si trova la pienezza dell’essere, con
l’esclusione assoluta del futuro (III. 7. 3-4), non potendosi concepire, per il mondo intellegibile,
una esistenza alla quale venga ad aggiungersi successivamente qualcosa che prima non aveva.
Particolarmente significative per il nostro assunto sono le parole di Plotino (III. 7. 3): «pertanto
quella realtà che non era e non sarà, ma solamente è, quella realtà che possiede immobile l’essere in
quanto non trapassa nel “sarà” e non è trapassata, ebbene, questa realtà è l’eternità. Pertanto la vita
che è intorno a quella realtà che è nell’essere, la vita tutta insieme e intera e piena senza differenze,
divine proprio quello su cui stiamo indagando, l’eternità. E non bisogna credere che questa eternità
si sia aggiunta dall’esterno a quella natura, ma che sia quella natura e che derivi da quella e sia con
quella».
Da tali parole si ricava che ciò che è sempre, con l’esclusione del passato e del futuro, è l’eternità; d’altro canto, l’essere eterno non significa altro che l’essere realmente (III. 7. 6): «infatti
l’essere realmente è il non essere mai e il non essere in alcun altro modo; ma questo significa essere
sempre allo stesso modo; ma questo significa l’essere senza differenziazioni. Pertanto l’essere non
possiede questa e quella cosa»; «di conseguenza non è possibile che una cosa sia l’essere, un’altra
l’essere sempre… e così l’essere possiede il “sempre” e “ciò che è” possiede il sempre, cosicchè si
può dire: “ciò che è sempre”. Di conseguenza bisogna intendere il ’sempre’ nel senso che viene
detto come “ciò che realmente è”, e bisogna raccogliere il “sempre” nella natura indifferenziata che
non ha affatto bisogno di niente, oltre a quello che già possiede; e d’altra parte essa possiede il tutto».
Al contrario, per Plotino (III. 7. 11 ss.), il tempo, quale immagine dell’eternità, era legato alla
vita dell’anima (e Agostino rielabora l’assunto plotiniano); il tempo non è il metro del movimento
degli astri, ma l’indicazione dei processi vitali dell’anima cosmica. Verisimilmente Gregorio non
poteva accettare la dottrina dell’anima cosmica, mentre quella dell’Intelletto poteva rientrare, con
gli opportuni adattamenti, in una concezione cristiana.
Ma non tutti erano in grado di seguire il ragionamento, così astratto e, insieme, mistico, di un
Plotino e un Gregorio Nazianzeno. Nel secolo successivo la idea che Dio debba essere il vero essere,
e non al di sopra dell’essere, si ripresenta. La «Historia philosophiae» di Porfirio serve a Cirillo, nella
«Contra Julianum imperatorem», per sostenere la sua tesi, che le dottrine di Platone concordano con
le dottrine cristiane, per cui la sostanza dell’essere divino giunge fino a tre ipostasi, e che il dio sommo
è il Bene; dopo di lui e come secondo, vi è il demiurgo, terza è l’anima del mondo. Fino all’anima,
infatti, è proceduta la natura divina. Di conseguenza, Cirillo vede in questa triade di Porfirio una corrispondenza con la Trinità cristiana: lo Spirito Santo è l’anima del mondo secondo Platone, perché
lo Spirito dà la vita e procede dal Padre, che è vivo attraverso il Figlio, e in lui viviamo e ci muoviamo e siamo (cfr. At 17. 28); lo dice anche Cristo: «è lo Spirito, che dà la vita» (Gv 6. 63).
2. Nell’occidente la interpretazione del nome di Dio si trova a partire da Novaziano, il quale è il
primo a citare Es 3.14. Per incontrare una più ampia discussione sul problema bisognerà attendere lo
sviluppo del platonismo cristiano, con Mario Vittorino, quindi Agostino, soprattutto, e poi Boezio.
Per Plotino, la seconda ipostasi è un’unità della diversità, diversità che rimane distinta e comprensibile proprio perché non è unità. Per Porfirio, invece, e quindi anche per Mario Vittorino,
l’Uno è movimento che identifica le opposizioni senza annullarle (cfr. Contra Arium I. 49. 17-40;
la stessa concezione si trova nell’anonimo autore del In Platonis Parmenidem commentaria II.
91V). Questo significa identificare, appunto, l’Uno con l’essere, e pertanto Porfirio, con questa sua
interpretazione, costituisce un’eccezione nella tradizione neoplatonica: se Dio è essere e insieme
non essere, pensiero e insieme non pensiero, sono legittime sia la teologia positiva sia la teologia
negativa, che infatti sono utilizzate entrambe da Agostino.
Secondo Agostino, «Io sono colui che è» indica il modo in cui Dio è chiamato e il vero nome
di Dio; il versetto inaugura la tradizione medievale dell’ «essere stesso» come contrassegno di Dio
(In Ioannis epistulam tractatus XXXVIII. 8. 10; De civitate Dei VIII. 11).
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЯЗЫЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ II-VI ВВ.
89
L’esegesi agostiniana, quindi, è basata su un concetto tipicamente plotiniano, quello dell’immutabilità eterna e della libertà dal divenire (cfr. Sermones 6. 3. 4; 7. 7; Enarrationes in Psalmos 38.
7). All’essere di Dio non manca niente, esso non è paragonabile all’essere delle cose create, che sono
quasi nulla (De Trinitatem II. 5. 9; IV. 17. 23; Enarrationes in Psalmos 9. 7; 38. 7-8; 38. 22; 39. 9;
101. 2. 10; 121. 6). L’essere è «il nome di Dio» (Enarrationes in Psalmos 101. 2. 10). Da una parte,
questa totalità dell’essere sembra pensata come pura e assoluta identità priva di determinazioni, dall’altra la tradizione neoplatonica impone alla sostanza divina di essere unità relazionale, esseremovimento, unità nella differenza e nonostante la differenza. Ora, Plotino ha applicato questa prerogativa alla seconda ipostasi, non all’Uno. Pertanto le «rationes», cioè le idee, sono presenti in Dio
(Confessiones XI. 9. 11), ma non si annullano in lui, conservano la loro determinazione senza
perdere la caratteristica dei loro contenuti differenti (Confessiones I. 6. 9).
Dall’Intelletto di Plotino e dall’Uno di Porfirio (che, come si è detto, si identifica con l’essere)
deriva, dunque, ad Agostino il concetto di Dio-Uno inteso come pienezza dell’essere, non unità
astratta, ma ricchezza di tutti i contenuti. Questo Dio contiene la ricchezza dell’essere, la totalità
delle forme platoniche, che sono nel Verbo (De Genesi ad litteram V. 16. 34). Così, nella Epistola
147, egli dice che alcuni intelligibili sono «omnia in uno sine angustia»; in De Trinitatem si trova la
locuzione «unum omnia» o «unus omnia» sia per indicare le tre Persone nella Unità (VI. 10. 12) sia
per indicare gli intelligibili nel Verbo (VI. 10. 11; cfr. De civitate Dei IX. 10. 13). Nella Epistola 14
la stessa locuzione indica l’unità degli intelligibili in Dio, presenti specificamente, ma insieme riuniti nell’Uno. D’altra parte, la stessa locuzione «unum omnia» è proprio la traduzione letterale dell’espressione plotiniana che indica la vita dell’Intelligenza (Enneades II. 6. 1. 8-9; III. 3. 7. 9; V. 8.
9. 2-3).
L’Uno-Dio di Agostino può, dunque, essere conosciuto, a differenza dell’Uno di Plotino (e
questo vale anche per i neoplatonici cristiani). Agostino ammette, infatti, la possibilità di conoscere
Dio e quindi di parlare di Dio, per quanto sempre frenata da proposizioni che sono solo in parte positive, ma che non sono mai una semplice espressione di apofatismo, un invito alla mistica dell’ineffabile: cfr. De vera religione 30. 56; De Genesi ad litteram IV. 14. 23; De Trinitatem VI. 4. 6; Epistola
169. 2. 7; De civitate Dei XI. 10. 3; XII. 19. La natura di Dio «deve» essere conosciuta, anche se per
via negativa: questo è il significato della visione di Ostia. Così, Agostino non attribuì alla teologia
negativa una funzione esclusiva: essa non è l’unica conclusione a cui deve ricorrere la conoscenza
del divino, ma costituisce la preparazione e la premessa di questa conoscenza. Così, noi sappiamo
quello che Dio non è, per poi giungere a conoscere quello che è (De Trinitatem VIII. 2. 3; V. 1,1;
Enarrationes in Psalmos LXXXV. 12; De doctrina christiana I. 6).
Il Gilson ha affermato che, per Agostino, vi è un Dio soltanto, e questo è l’essere; questa affermazione costituirebbe la pietra angolare di tutta la filosofia cristiana, e non sarebbe stato Platone, e
nemmeno Aristotele che l’avrebbe posta, ma Mosè. Ma se i Cristiani hanno scoperto nell’Esodo l’identificazione di Dio con l’essere assoluto, è proprio perché i Greci avevano fatto conoscere questa concezione dell’essere assoluto, come osserva P. Hadot. Agostino è probabilmente debitore a
Porfirio a questo proposito. Lo si può, dunque, considerare come uno dei fondatori di quella che
Beierwaltes suole chiamare «ontoteologia». Le conseguenze fondamentali della identificazione di
Dio con l’essere sono state ribadite da tutti, e lo stesso Agostino non ha niente di nuovo da dire a
questo proposito. L’originalità di Agostino nei confronti degli altri Padri latini è stata quella di unire
la ontologia alla soteriologia: Dio ha rivelato a Mosè non solamente il suo «nomen substantiae», ma
anche il suo «nomen misericordiae». Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. A tal proposito il Beierwaltes sostiene che Agostino ha inaugurato una «teologia dell’Esodo», mentre la sua speculazione sul «nomen substantiae» rimane sotto l’influsso della filosofia greca.
Un agostiniano nutrito di pensiero pagano è Boezio. Nel Contra Eut. et Nest. (3. 250-252) troviamo un’affermazione interessante. Innanzitutto, Dio è il «primum esse», cioè è l’essere al massimo grado: la differenza tra la realtà divina e la realtà materiale (una ovvia distinzione per un platonico) si legge in Boezio anche nel De arithm. I. 31. Anche in Boezio, quindi, nel neoplatonismo
cristiano il concetto platonico di «essere» è unito a quello biblico di Es 3. 14, interpretato nel modo
che oramai conosciamo. Che il primo principio possegga l’essere al massimo grado è, infatti, concezione, che risale a Porfirio (Sententiae ad intelligibilia ducentes 39) e che abbiamo già visto sopra
in Agostino: «Al contrario, dell’essere vero e immateriale, di per sè esistente, i predicati sono: persevera sempre in se stesso, è identicamente uguale, è sostanzializzato nell’identità, è immutabile
90
XVII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
nell’essenza, semplice, indissolubile, non è in un luogo né è disperso in una massa, non nasce e non
muore, e quanti altri predicati sono simili a questi».
Successivamente l’insegnamento di Porfirio è passato in Mario Vittorino, Contra Arium II. 4;
IV. 19 e 20. Vale a dire, poiché questo essere primo è senza legami, esso è, per eccellenza, sostanza:
Dio è soprattutto essere e sostanza. Pertanto il passo di Boezio è di stampo porfiriano, filtrato attraverso l’elaborazione di Agostino.
Ed un ulteriore risultato della dottrina dell’essere è l’asserzione che l’essere coincide con l’uno.
Boezio lo afferma in Contra Eut. et Nest. (4. 296-301) e nella Consolazione (III. 11. 36-37), ove
dice: «Infatti l’essere e l’uno sono interscambiabili. Anche le cose che sono formate da una
molteplicità, come un mucchio e un coro, sono comunque un uno».
A questo si collega il concetto che dall’essere di Dio derivi l’essere di tutte le cose: per esprimere
questa dottrina nel Contra Eut. et Nest. Boezio impiega il termine «proviene» (proficiscitur), in
Hebdom. il verbo «discese» (fluxit) (cf. 136. 142. 149), oppure «portare avanti» (producere) (140145), nella Consolazione (III. IX. 19) il verbo «fare avanzare» (provehere, che deriva probabilmente
da Proclo, Commento al Timeo I. 27). Con essi Boezio vuole evitare di ricorrere al concetto, cosi
poco neoplatonico, di «creazione». Così lo scrittore afferma che Dio è fons rerum (Consolazione
III. IX. 4-6; I. 6. 11; III. 12. 1 ss.; IV. VI. 43; V. 3. 27) e che è il rerum principium (Hebdom. 114115).
Ma anche questa affermazione si riscontra in Mario Vittorino: «Che cosa è quello da cui tutto
deriva? Dio» (Lettera di Candido 3). O, analogamente, poiche dal primo principio deriva l’essere di
tutte le cose, Dio è la prima causa (Lettera di Candido 1); la «omnium causa» (Gen. div. verb. 3. P.
134. 1; 6. P. 138. 3; 12. 13; 18. P. 156. 9 e 10-11); la «causa principalis» (Contro Ario I. 3. P. 196. 23).
Dunque, l’eredità che – sulla base del passo dell’Esodo, il cristianesimo antico aveva lasciato al
Medioevo, greco e latino, è proprio questa: Dio è l’assoluto esistente, la pienezza dell’essere, o, là
dove si manifesta più forte la tendenza all’apofatismo, anche «al di sopra dell’essere».
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСХ 3. 14 В ДРЕВНЕХРИСТИАНСКОМ БОГОСЛОВИИ
К. МОРЕСКИНИ ( УНИВЕРСИТЕТ Г. ПИЗЫ)
В доладе подробно рассматривается традиция эзеезы слов «Азъ есмь с+щий» (Исх 3:14)
в речесой (от Климента Алесандрийсоо до преп. Иоанна Дамасина) и латинсой патристие
(от Новациана до Боэция). Уазываются вероятные параллели + античных философов – Платона,
Плотина, Порфирия и Прола. Проблема пол+чает свое измерение в одном из лавных сюжетов
европейсой философии – соотношении с+щности и с+ществования, единоо и бытия. Библейсое
именование с+щий (ὁ ὤν) сопоставляется с платоничесим понятием с+щее (τὸ ὄν). Автор свидетельств+ет о наличии в патристичесой письменности а отождествления Боа с бытием
(т.н. онтотеолоия), та и разведения бытия и тоо, что (Кто) превыше бытия. Обстоятельно представлена тринитарная церовная традиция в онтесте толований ипотез платоновсоо
Парменида в платоничесой среде. Отмечается, что соотнесение Отца с первой ипотезой (абсолютное единое), а Сына – со второй (единое-мноое) в онечном счете приводит с+бординатистс+ю тенденцию в боословии ариансом+ +чению.
Ch. Tommasi Moreschini
(Università di Pisa)
IL DIBATTITO SUL COSIDDETTO «MONOTEISMO PAGANO»
TRA FONTI ANTICHE E INTERPRETAZIONI MODERNE
È ben noto come, presso gli strati colti della società nella prima età imperiale, la nozione di un
dio supremo, trascendente rispetto alla moltitudine degli altri dèi, aveva gradualmente guadagnato
terreno, sotto la spinta di movimenti di ispirazione platonico-pitagorica e stoica, ed anche, in parte,
dal contatto con alcune forme di religiosità orientale, in particolare del culto di Iside o Mithra, ed
anche del Giudaismo e del Cristianesimo: di qui l’interesse mostrato dagli studiosi nei confronti
della possibilità o meno di rintracciare nel mondo pagano forme più o meno latenti o rudimentali di