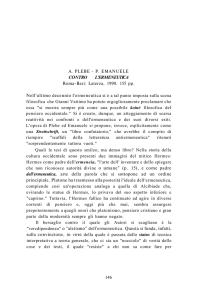Ermeneutica veritativa ed etica del
riconoscimento
Alcune domande a
Gaspare Mura
a cura di Bachisio Meloni
La filosofia ermeneutica è oggi a fondamento di tutte quelle filosofie
del dialogo e dell’interrelazione che, nell’attuale clima di incontroscontro tra culture, tradizioni, religioni diverse, dovrebbero tracciare il cammino che indichi come tale incontro possa divenire un
arricchimento nella verità e non un appiattimento relativistico o sincretistico. Ne parliamo con il Professor Gaspare Mura.
D.: A proposito della nozione di “verità” nella prospettiva ermeneutica, Lei sottolinea come quest’ultima, specie nei suoi maggiori
rappresentanti – da Gadamer a Ricoeur, a Betti – abbia saputo “custodire in sé un’istanza veritativa autentica, la quale non può essere
contrapposta per principio alla verità metafisica”. Con Gadamer, Lei
distingue all’interno dell’orizzonte ermeneutico il carattere trascendente ed unico del Logos e della Verità che fonda in senso platonico,
e agostiniano, la molteplicità delle prospettive sulla verità; prospettive che, come Lei tiene a ribadire, sono “destinate non a contrapporsi ma a comporsi in una ‘fusione di orizzonti’ capace di arricchire
la nostra comprensione della verità, anche metafisica”. Si tratterebbe di portare avanti un’idea di scavo ermeneutico della verità come
disposizione alla ricerca che, in senso agostiniano, sia in grado di
permanere “nella verità e non al di fuori di essa”. Ho l’impressione
che l’aporia – se di aporia si può parlare – risieda tutta in questa particolare “ermeneutica veritativa” del senso di “permanenza”, colta
in una duplice prospettiva: sia in quanto esperienza “coinvolgente”
di ricerca inesauribile di un fondamento, sia in quanto cammino a
partire da una condizione di verità assoluta ed astratta quale fondamento indeterminato in grado di sorreggere qualsiasi prospettiva di
ricerca.
R.: La sua domanda coglie uno dei nodi fondamentali della questione ermeneutica attuale, ma sembra tuttavia sottendere la tesi che la
verità in prospettiva ermeneutica sia qualcosa di puramente “astratto”, e quindi incapace di coinvolgere la dimensione esistenziale
della ricerca, la quale accentua piuttosto il fondamento linguistico,
dialogico e quindi storico dell’interpretazione; per ispirazione del
“pensiero debole” lei ritiene pertanto che siano incompatibili “ermeneutica” e “verità”. Di conseguenza, presuppone che la dizione
“ermeneutica veritativa”, che personalmente ho espressamente usato nei miei studi di ermeneutica, nasconda un’“aporia” non sanabile,
perché intenderebbe coniugare la nozione tradizionale di “verità”
con l’“ermeneutica”, la quale ne avrebbe ripensato il fondamento e
sostituito il ruolo nel contesto del pensiero postmoderno.
D.: Alluderei piuttosto ad un’idea di verità come procedimento di
determinazione e di ricostruzione infinita di senso o come farsi e
darsi stesso della soggettività partecipe nei termini dell’“esposizione” e in quanto tale, questo sì, segno di verità per altri.
Le risponderò allora riferendo le parole di uno studioso non sospetto, U. Galimberti, il quale riferendosi al commento fatto da Heidegger al verso del poeta S. George, che recita “nessuna cosa è dove
la parola manca” – e quindi sottolineando come la questione del
rapporto con la verità nasca, in contesto ermeneutico, dalla “svolta
linguistica” della filosofia, che ha capovolto la tradizione ontologica
che assegnava il primato dell’essere sulla parola –, si chiede quale
tipo di essere è quello che ha bisogno della parola per poter “essere”, ed afferma che le interrogazioni di Heidegger sul rapporto
essere-parola abbiano “aperto due itinerari ermeneutici giocati sul
rapporto parola-cosa” (Galimberti, Parole Nomadi, 20062, p. 62).
Primato della parola o primato dell’essere? Primato dell’ermeneutica o primato della verità dell’essere? Galimberti pone così una questione decisiva per lo statuto attuale della filosofia ermeneutica: “Si
dà una cosa al di là della parola? Si dà l’oggettività di un testo al di
là delle diverse letture? Si dà una verità al di là delle interpretazioni?”; questioni quanto mai importanti, innanzi tutto perché “dire ‘al
di là’ è dire metafisica” (ivi). Galimberti distingue di conseguenza
l’ermeneutica che nasce sui presupposti del “pensiero debole”, la
quale ritiene intrascendibile l’orizzonte linguistico, dall’ermeneutica “veritativa”, la quale viceversa recupera la pretesa metafisica del
conseguimento di una verità oggettiva. “Il ‘pensiero debole’ – scrive
Galimberti –, inaugurato da Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo, si
propone di indebolire questa pretesa attraverso la riformulazione
del concetto di verità, pensata non come dominio sull’essere, ma
come trasparire dell’essere nel gioco delle interpretazioni in cui si
esprime quella che Vattimo chiama ‘l’autonoma vita del linguaggio
che vive nel dialogo’. A partire da questo modello – continua Galimberti – Maurizio Ferraris ha ricostruito una Storia dell’ermeneutica
(1988) a cui si contrappone un’altra storia dell’ermeneutica scritta
da Gaspare Mura con il titolo Ermeneutica e verità (1990; 19972),
dove si dice che se le interpretazioni non hanno di vista una verità,
almeno come concetto limite a cui tendere, non riescono a costituirsi neppure come interpretazioni” (ivi). Poiché l’“ermeneutica
veritativa” si instaura su una lettura alternativa dei testi di Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Betti, rispetto a quella del “pensiero debole”, ritengo che con questa affermazione Galimberti riconosca che
l’“ermeneutica veritativa” abbia una sua legittimazione teoretica. In
effetti l’ermeneutica veritativa, continua Galimberti, “scorge, nel
pensiero che vuol indebolire la violenza nascosta nell’atteggiamento
metafisico che ipotizza un Ordine dell’essere al di là delle interpretazioni, il massimo della violenza, il massimo della hybris, della tracotanza dell’interpretazione che assolutizza se stessa nel momento
in cui nega la possibilità di uno sfondo interpretativo” (ivi). A parte
ulteriori considerazioni, desidero qui sottolineare il fatto che venga
riconosciuta, anche dal punto di vista storiografico – come peraltro
ho personalmente cercato ti fare attraverso una lettura diretta dei
testi di Gadamer, Ricoeur, Betti e lo stesso Heidegger –, la presenza di un’intenzionalità “veritativa” dell’ermeneutica, alternativa
certamente all’ermeneutica del “pensiero debole”, ma legittimata a
portare avanti le proprie istanze teoretiche, che non possono essere
considerate puramente “aporetiche”.
D.: Verità tuttavia che è tale se e in quanto aperta alla comprensione
di ciascuno; che giunge proprio in virtù della relazione con un’alterità per sua natura costitutiva irriducibile, e pure sulla base di una
relazione la cui spinta è definita da quanto si determina a partire da
me. È come se l’assoluto della verità si articolasse entro la cornice
della finitezza; che l’eterno si dischiudesse in virtù della caducità
della temporalità e dell’esser proprio e autentico di ciascuno. Nel
porre rimedio alle spinte nichiliste, dinanzi allo sfondo indeterminato ed oscuro dell’esistenza, più che il riferimento ad un’idea assoluta
di verità, il relativismo – se inteso in particolar modo come possibile
apertura di trasformazione e di ricostruzione della soggettività quale
luogo di ogni possibile presupposto di verità, e se interpretato in
quanto riscoperta in termini hegeliani dell’unificazione dell’io con
la realtà; riscoperta che è al contempo individuale e universale –
è presupposto che sembrerebbe calibrarsi con voce più discreta e
suadente.
R.: La suggestione del relativismo, indotta in particolare dal “pensiero debole”, e che informa gran parte della cultura contemporanea,
nasconde in realtà insidie molto maggiori, sia per la cultura che per
la vita etica e la convivenza umana, di quelle che pretenderebbe superare. Dopo aver “delegittimato” filosoficamente, storicamente e
socio-politicamente il pensiero moderno, il relativismo del “pensiero
debole” consente con Lyotard nella concezione di una “condizione
postmoderna”, che si esprimerebbe solo in una razionalità plurale,
che ricerca legittimazioni fluide, parziali, reversibili e si riconosce
nel pluralismo della comunicazione informatica e multimediale, nel
pluralismo delle culture e delle fedi religiose, nella libertà incondizionata delle scelte etiche. Il relativismo del “pensiero debole”
coniuga insieme l’affermazione di Nietzsche: “Dio è morto”, ovvero
sono definitivamente tramontati gli assoluti metafisici ed etici, con
la nozione epocale dell’Essere propria di Heidegger, secondo cui
l’“Essere non è ma accade”. Ciò significa che la storia dell’uomo
non ha un senso unitario, come pretendeva il pensiero moderno,
non ha punti di riferimento, né può essere concepita come un corso
unitario di eventi teso all’emancipazione dell’uomo: “La modernità, scrive Vattimo, nella ipotesi che propongo, finisce quando – per
molteplici ragioni – non appare più possibile parlare della storia
come qualcosa di unitario” (La società trasparente, p. 8); di conseguenza la società non è concepita come trasparente (Hegel), né
come organica (Marx), ma come “opaca”, perché luogo di liberazione delle innumerevoli differenze culturali, etiche, personali, in
cui vige un unico primato: quello dell’affermazione della propria
“diversità”. La società postmoderna sostiene pertanto una piena liberalizzazione della comunicazione attraverso i media, la stampa e
soprattutto Internet, perché vede in essa un antidoto ad ogni tipo
di omologazione conformista. La società postmoderna è la società
dei mass media e della comunicazione generalizzata al massimo:
“radio, televisione, giornali sono diventati elementi di una generale esplosione e moltiplicazione di Weltanschauungen, di visioni del
mondo” (Vattimo, La società trasparente, p. 12). Sotto l’apparente
caos della società postmoderna, indotto dal moltiplicarsi delle informazioni e delle comunicazioni, il pensiero debole vede l’affermarsi
della vera emancipazione dell’uomo, e la realizzazione di una vera
società democratica, fondata sugli ideali del pluralismo e della tolleranza. L’uomo postmoderno, liberatosi finalmente degli assoluti
metafisici ed etici, nonché della voce inquietante della “verità” –
quella che già Socrate voleva testimoniare di fronte all’assemblea
democratica che lo condannava, ricordando ai suoi giudici che “una
vita senza ricerca non è degna per l’uomo di essere vissuta” (Apol.
XXVIII, 38 a 5-6), e additando come missione al filosofo la ricerca
della verità in un costante dialogo con le anime che “ne sono gravide” (Menone 80 a-b) –, non nutre più rimpianti per antiche certezze
né inquietudini di ricerca della verità, ma si riconosce piuttosto nel
nichilismo dei valori e della verità. È lo stesso Vattimo ad affermarlo: “Oggi non siamo a disagio perché siamo nichilisti, ma piuttosto
perché siamo troppo poco nichilisti, perché non sappiamo vivere
fino in fondo l’esperienza della dissoluzione dell’essere” (Filosofia
del presente, p. 26). La conseguenza, come ha scritto uno studioso,
è che “nell’età della crisi dei fondamenti – e non solo del sapere
scientifico, sì anche della vita morale e politica – l’ermeneutica ha
decretato il trionfo dell’opinione sulla verità, della storia sulla logica,
del contingente e mutevole, del relativo sull’assoluto, in una parola:
della doxa sull’epistème” (Vitiello, Dall’ermeneutica alla topologia,
in “Aut Aut”, 2000). Ovviamente, l’ermeneutica di cui qui si parla è
l’ermeneutica del “pensiero debole”, che come dicevo ritengo personalmente alternativa all’“ermeneutica veritativa”.
Sebbene non sia possibile qui approfondire una critica teoretica e
storiografica del pensiero debole, che ho personalmente condotto
in altri studi, vorrei tuttavia sottolineare che le opere dei maggiori rappresentanti dell’ermeneutica filosofica, da Gadamer a Betti a
Ricoeur, mostrano di essere ben consapevoli, per usare un’espressione di Pareyson, che “non si dà interpretazione senza verità”. Vorrei qui invece contestare il relativismo del pensiero debole per affermare, contrariamente a quanto esso sostiene, che il primato dei
mezzi di comunicazione di massa non genera una società più democratica, né più sensibile eticamente al rapporto con l’alterità, ma
una società in cui vige la legge del più forte, una “folla solitaria” in
cui gli individui sono resi incapaci di rapporti interpersonali fondati
sull’autenticità, sulla condivisione, sull’amicizia. Senza un progetto
educativo e pienamente personalizzante delle coscienze, la società
dei media genera una catena di schiavi o, come si è espresso Sartori, dei “rimbecilliti dal video”. Contrariamente alle illusioni del
pensiero debole, occorre riflettere a fondo sulle radici della crisi del
dialogo e della comunicazione che attraversa la “modernità senza
illusioni”, secondo la definizione della nostra epoca offerta dal sociologo polacco Zygmut Baumann (Paura liquida, 2007). In questo
contesto postmoderno si inserisce l’illusione di un mondo unificato
attraverso i moderni mezzi di comunicazione – televisione, internet,
media – mentre in realtà, come ha affermato Gadamer, “la Tv è un
sistema che produce una catena di schiavi, perché è il contrario del
dialogo al cui interno si condivide la passione per la verità». Oggi,
osserva il filosofo, “ai giovani manca proprio questo dialogo, ovvero
la possibilità di fare domande e cercare una verità più profonda che
non può prescindere dall’educazione alla responsabilità, e dal saper
interpretare ciò che viene proposto». Gadamer, come Popper, sottolinea i richiami alla responsabilità della televisione, e la denuncia
di “chi usa i mezzi di comunicazione come un potere occulto per
indottrinare persone prive di strumenti critici». Nella nostra società,
la cui cultura ha messo al bando la verità, Tv, giornali e Internet
“tentano di imporre il proprio punto di vista come verità assoluta ad
un pubblico spesso inconsapevole», e ciò dimostra la tesi di Popper,
secondo la quale “non esiste libertà senza educazione al capire e
senza responsabilità; educazione e libertà sono le parole chiave di
una società liberale nel senso più vero del termine». Alla comunicazione antiveritativa della Tv occorre contrapporre un nuovo progetto
educativo, eticamente condiviso, e da realizzarsi attraverso rinnovati
rapporti interpersonali e sociali.
Ritengo allora personalmente che sia doveroso soprattutto per gli
intellettuali, onde evitare una nuova e pericolosa “trahison des clercs”, contrastare il relativismo veritativo ed etico con la proposta
condivisa di un umanesimo integrale e plenario, il quale richiede
la coniugazione dei valori del pluralismo (pluralismo delle culture,
della democrazia, delle visioni del mondo) con la verità, la quale non
può essere divisa né ritenuta un retaggio del passato, anche se da
ripensare nella sua dimensione personalistica, fenomenologica e “rivelativa” (aletheia). Il relativismo della cultura postmoderna, se non
vuole degenerare in solipsismo individualistico, deve comprendere
la necessità di valori etici e sociali non negoziabili, e che non sono
realizzabili al di fuori di un contesto veritativo. Per questo, un ulteriore tratto di questo “progetto” di umanesimo plenario deve poter
essere costituito dal riconoscimento del primato dell’etica e del suo
ordine, fuori del quale nessun valore personale o sociale (solidarietà
e condivisione), può essere fondato o realizzato.
D.: Sulla base di quanto Lei ha appena affermato, desidererei allora
far cenno ad una precisa volontà, quella dell’interpretazione di una
“ontologia della realtà” sulla base di una più precisa e consapevole
condizione di pluralità, di attenzione alla valorizzazione delle diversità. Tuttavia, però, dovremmo essere dell’avviso di dover convivere
con un profondo e forse anche lacerante senso di disinganno, quasi
a suggerire l’idea di porre, e una volte per tutte, la verità (o almeno,
la sua idea forte di pretesa universalizzante) alle nostre spalle; non
più di fronte a noi (o almeno non così vicini); non dunque l’utopia di
un meridiano da seguire, quanto la “nostalgia”, o l’illusione nostalgica, di una verità che è, pur tuttavia, esigenza incontenibile se vissuta
in qualità di ricerca di un senso più remoto, in grado di tradursi
sotto forma di caritas e di giustizia da recuperare, o da ricostruire in
termini genealogici quantomeno nei termini dell’applicazione del
diritto (in rimedio alle tante ingiustizie presenti) attraverso l’interpretazione degli infiniti reticoli di senso. Tuttavia, penso sia condivisibile la scelta di una precisa consapevolezza: che la riflessione sul
senso non debba equivalere al borioso compiacimento del possedimento di un potere ispirato alla verità, verità dunque quale ancilla
potestatis. Verità che al contrario rimane tale proprio in quanto in
perenne distanza da chiunque intenda farla propria; verità precaria,
o sempre dimentica degli assoluti, o “già-da-sempre” in perdita per
chi le sta al cospetto e viva la sua perenne ed autentica condizione
di nomadismo. È legittima una simile interpretazione?
R.: Nella sua domanda è celato, ancora una volta, il pregiudizio ispirato dal pensiero debole secondo cui dire “verità” significa per ciò
stesso dire “potere e violenza”. Vorrei qui accennare alle radici teoriche di questo pregiudizio. Giustamente lei accenna agli “infiniti
reticoli di senso” che caratterizzano la “condizione postmoderna”,
che rende la verità un qualcosa di “nostalgico” o “illusorio”, lontano
dalla nostra sensibilità, ma rendendo con ciò illusorie anche le nostre
aspirazioni etiche di giustizia, di legalità, di coerenza tra comportamenti privati e pubblici, di solidarietà sociale. Vorrei aggiungere
che una delle radici culturali che hanno giustificato lo smarrimento
della verità è dovuto all’interpretazione che il pensiero debole ha
dato della “svolta linguistica”. È vero infatti che comunemente gli
studiosi ritengono che il primato odierno assunto dalla questione
linguistica debba considerarsi ormai come una vera “koiné”, che
abbraccia tutte le espressioni della cultura, dell’etica e della vita
contemporanea. Tuttavia l’interpretazione debolista dell’odierno
primato assunto dalla questione del linguaggio, intende il linguaggio non luogo di un dialogo socraticamente e gadamerianamente
intenzionato ad una verità che, proprio perché tale, e sebbene conseguita in modalità sempre parziali e storiche, trascende tuttavia i
dialoganti, permettendone al contempo un consenso non soggettivo
ma mutuamente riconosciuto come veritiero, in ambito personale,
sociale ed anche politico. Attento a sottolineare le radici, le componenti e le derive relativistiche e soggettivistiche dell’odierna cultura, il pensiero debole ha parlato di “trasformazione semiotica del
kantismo” (Apel, Vattimo). Con questa espressione ha inteso sottolineare che, per l’odierna cultura derivante della “svolta linguistica”,
esistere “vuol dire stare in rapporto a un mondo: ma tale rapporto è
insieme condizionato e reso possibile dal fatto che si dispone di un
linguaggio: è quello che K.O. Apel chiama trasformazione semiotica
del kantismo” (Vattimo). Ciò significa che le categorie del trascendentale kantiano, nel contesto della svolta linguistica, non sono più
intese in senso stabile e come appartenenti alla sola ragione, ma
viceversa come modalità storiche con cui si organizzano i linguaggi
degli uomini, e che costituiscono l’orizzonte linguistico-storico della
loro comprensione di ogni realtà, culturale ed etica, profana e religiosa. È in questo senso che la filosofia ermeneutica viene intesa dal
pensiero debole, non tanto come un’“età ermeneutica della ragione” (Greisch), capace di ripensare ma non di eliminare la tensione
alla verità, ma piuttosto come la filosofia che “insiste sulla radicale
storicità dei linguaggi, i quali se vogliamo fare un esempio molto
familiare ai lettori di Wittgenstein, sono legati fra loro non dal fatto
di essere diverse attuazioni di una stessa stabile struttura, retta da
un’unica norma trascendentale, bensì da una sorta di rassomiglianza
di famiglia; appartengono a una serie storica di ‘trasmissione’ […]
nella quale non c’è alcun elemento che si mantenga identico dal
‘principio’ alla ‘fine’, perché la costante è solo il concatenamento,
la concatenazione” (Vattimo). In questo contesto l’ermeneutica del
pensiero debole non solo delegittima le grandi “narrazioni” della
modernità (“possiamo considerare ‘postmoderna’ l’incredulità nei
confronti delle grandi narrazioni”, Lyotard, La condizione postmoderna, p. 6), ovvero le grandi Weltanschauungen che hanno animato
la storia moderna, ma con esse anche i grandi ideali che proponevano, le grandi finalità, i grandi eroi, le grande sfide del confronto
e del dialogo, rinchiudendo la cultura, e la vita etico-sociale ad essa
ispirata in una pura pragmatica di giochi linguistici diversi, in cui
non si dà verità, né finalità, né ideali, né vere sfide, perché tutto è
omologato al “gioco”. Quali istituzioni potrebbero nascere da questo “reticolo” di giochi linguistici? Personalmente ritengo che qualsiasi proposta etica e socio-politica che si ispirasse alla cultura del
“pensiero debole” sia destinata prima o poi al fallimento, perché
l’uomo sente in modo ineliminabile il bisogno di ideali, di finalità
alte, di seri confronti e sfide su principi irrinunciabili, e quindi di
verità. Certo, una verità da condividere con altri, dopo il confronto
leale su ragioni e ideali diversi, una verità perseguita socraticamen-
te con la forza “non violenta” del dialogo e del confronto, ma pur
sempre capace di suscitare adesioni non “deboli” e provvisorie. Per
questo, diversamente da quanto lei afferma, la verità non sta alle nostre spalle, come qualcosa di “andato” di cui al massimo si può avere
“pietà” o “nostalgia”, ma sta di fronte a noi come compito che ci
attende sempre di nuovo, capace di smuovere la nostra indifferenza
e di farci camminare sulla sola via che ci permette di essere pienamente uomini. Perché, ancora una volta, “una vita senza ricerca non
è degna per l’uomo di essere vissuta” (Apol. XXVIII, 38 a 5-6).
D.: Che tale verità sia possibile solo a partire dalla relazione dialogica, quale insieme di tutte le possibili costituzioni e concatenazioni di
senso, implica necessariamente spinte di inesauribile apertura e movenze di ampia trasversalità. La prospettiva tracciata sembra perennemente condurci fuori da ogni possibile consapevolezza di precisa
appartenenza sia essa culturale che filosofica o religiosa; così, del
resto, la stessa unicità e irripetibilità della persona, come Lei stesso
ci suggerisce, è di per sé crocevia di scenari etici inediti ed imprevedibili. Mi chiedo allora quanto la comunità religiosa, specie a partire
da un senso sempre più vivo di disgregazione etica del mondo attuale, sia in grado di disporsi ad accogliere e gestire in maniera opportuna un’idea di verità sempre di là da venire, la cui natura persiste ben
al di là dall’essere ipotizzabile in termini assolutistici. Non pensa che
alle spinte nichiliste – per molti aspetti scongiurate da una tradizione ermeneutica ben concertata – si stia oltretutto sostituendo ora il
più insidioso ospite dell’indistinto, dell’indifferenza di senso?
R.: Nella sua domanda sono comprese numerose questioni diverse:
quella del multiculturalismo delle nostre società, quella del rapporto tra “verità” ed appartenenza, quella del rispetto della persona e,
infine, quella del porsi della comunità religiosa nei confronti della
disgregazione etica del mondo postmoderno, che rifiuta un’immagine “assolutistica” della verità, ma allo stesso tempo ospita al suo
interno il più insidioso pericolo “dell’indistinto, dell’indifferenza di
senso”. Dirò subito che la comunità religiosa, in particolare nella
sua espressione cattolica, resta fedele alla precisa indicazione evangelica: “la verità vi farà liberi” (Gv.8,32). Il modo con cui la Chiesa
sta affrontando oggi la tempesta che la sconvolge per l’indegnità di
alcuni suoi membri, testimonia chiaramente che essa intende rinnovarsi, con spirito di purificazione e di conversione, con un’adesione
più fedele alla “verità che fa liberi”. Ed è per questo che la comunità
religiosa non si adeguerà mai a quel relativismo che nasce dalla “dittatura del desiderio”, il quale permea non solo la morale individuale,
fino alle sue scelte estreme, ma sostiene l’indifferentismo delle scelte sociali e sovente politiche.
Vorrei invece soffermarmi brevemente su quale proposta etica e politica, e proveniente proprio dall’“ermeneutica veritativa”, possa oggi
essere capace di coniugare verità e libertà, verità e dialogo, verità
e rispetto delle diversità e del pluralismo. Al di là della complessa
questione del “multiculturalismo”, che richiederebbe un approfondimento a parte, ritengo che possa essere indicata come una punta
molto avanzata di questa discussione, e visto che stiamo discutendo
sul terreno dell’ermeneutica, la proposta fatta da Paul Ricoeur in
uno dei suoi ultimi studi: Percorsi del riconoscimento (2005). Perché di fatto nella questione del “riconoscimento” sono coinvolte le
principali tematiche che riguardano il pensiero morale, giuridico e
politico contemporaneo; e ciò sebbene la tematica del “riconoscimento” abbia storicamente un’origine che può farsi risalire al pensiero di Hegel, il quale, nella Fenomenologia dello spirito, ponendosi contro la concezione kantiana della coscienza, considerata solipsistica, mostra come sia importante per l’uomo che vive in società il
“riconoscimento” da parte degli altri, riconoscimento senza il quale
la propria soggettività non può svilupparsi. Anzi, afferma Hegel,
qualora una soggettività, nel confronto con le altre, non ottiene un
adeguato “riconoscimento”, finisce per sviluppare in sé una coscienza di “servo”, che lascia al vincitore il campo libero per affermarsi
come “padrone”.
D.: Riconoscimento la cui importanza è tale proprio in quanto la
vicenda esistenziale e trascendente del singolo non si afferma e si
rivela solo attraverso la propria esperienza, ma si sviluppa sulla base
della compartecipazione in seno al contesto originario della comunità umana.
È qui che si innesta la problematica “etica” del riconoscimento, alla
quale fa in particolare riferimento Ricoeur. Perché se il “riconoscimento” da parte dell’altro è fondativo di una società “riconoscente”, nella quale non solo è possibile sviluppare un’identità personale
matura, sia dal punto di vista psicologico che sociale, il “riconoscimento” diviene insostituibile anche per fondare una vita morale
“buona”, innestata su una buona relazione sociale di reciprocità.
L’etica dell’alterità e del riconoscimento tenta per questo di superare da una parte l’individualismo atomista del liberalismo, e dall’altra
anche il semplice comunitarismo. Essa si basa su una forte concezione dell’intersoggettività, per la quale ogni persona dev’essere riconosciuta insieme come singola, unica, irripetibile, ma anche
portatrice di una sua struttura intersoggettiva trascendentale, da
cui può trarre i valori morali di una “vita buona” dai buoni rapporti
intersoggettivi che essa sa stabilire. Fondandosi anche su osservazioni di tipo psico-sociologico, Ricoeur sostiene che il rapporto tra
soggettività umane, abitate insieme dal “desiderio” e dal “logos”,
può essere solo di due tipi: o di minaccia che porta al conflitto o di
disponibilità che porta al reciproco riconoscimento. L’etica del riconoscimento si basa proprio sul bisogno che all’interno di un contesto sociale ha ogni soggettività di essere “riconosciuta” per poter
vivere bene, a motivo della sua struttura intersoggettiva, e sostiene
che la relazione di conflitto conduce non solo alla morte dell’altra
soggettività, ma anche alla propria morte.
La relazione di riconoscimento reciproco tra le soggettività che
compongono un contesto sociale è dunque fondativa sia della personalità dell’altro, e dei suoi diritti, che della propria soggettività e
dei propri diritti. La dimensione intersoggettiva della personalità
individuale costituisce dunque l’apporto che l’odierna etica del riconoscimento offre alla concezione illuministica dei diritti individuali,
facendo derivare tali diritti da un trascendentale che non appartiene all’individuo isolato dalla comunità, e nemmeno dalla comunità
astrattamente intesa, ma dall’individuo in quanto membro solidale
di una comunità in cui vige l’etica del riconoscimento reciproco.
D’altro canto, però, il semplice riconoscimento delle “differenze”
nel contesto comunitario e sociale, senza tener conto di tutti i processi di tipo etico e culturale che conducono alla costruzione delle
identità personali, finisce per dissolvere il fondamento stesso della vita comune, e si risolve anch’esso in forme deviate di “riconoscimento”. La mancanza di un corretto rapporto tra “differenze” e
“riconoscimento”, a motivo di assenza di riferimenti etici, diviene
espressione di quel “disagio della modernità”, di cui ha parlato Taylor, ed individuato in tre fattori: l’individualismo, la ragione strumentale e la politica del mondo industriale. Questi fattori sono la
causa dei tre disagi della modernità: la mancanza del senso della vita
a causa della diminuzione dell’orizzonte morale, l’eclissi dei fini a
causa della ragione strumentale, e la perdita della libertà dovuta alla
perdita dell’identità personale, la quale non può realizzarsi se non
viene riconosciuta la dimensione morale dell’uomo, anche nel suo
aspetto ontologico. Questa incorporazione dell’etica del “riconoscimento” nelle norme della giustizia sociale rappresenta per Ricoeur
l’ideale regolativo di una società democratica nuova, capace di far
crescere la solidarietà e la fraternità come fattori di antidoto alle
“mancanze di riconoscimento” che, sul piano interpersonale e dei
rapporti tra gli stessi stati sono all’origine delle tensioni, delle lotte
e dei conflitti.
D.: In questo luogo di scambio e di riconoscimento reciproco segnato dall’incontro tra soggetto e mondo storico-sociale penso allora
sia possibile instaurare una degna e concreta prospettiva etica entro la quale disegnare scenari di verità autentica. Inutile aggiungere
quanto su ciò l’ermeneutica debba giocare un ruolo assolutamente
centrale e determinante.
Non a caso Ricoeur ritiene che per uscire dalla logica della violenza,
del dominio dell’uomo sull’uomo, dei conflitti armati tra gli stati, sia
necessario soprattutto uscire dalla concezione moderna della politica, secondo cui solo il “contratto” tra le parti impedirebbe l’“homo
homini lupus”. Ricoeur oppone coraggiosamente, alla logica hobbesiana, la logica del “dono”, fondata sull’etica del “riconoscimento”,
e che non è solo quella contrattualistica dello scambio e della reciprocità, ma è piuttosto quella della gratuità e della generosità; è,
per dirla con Ricoeur, la logica della “festività dell’esistenza”. L’etica
del “riconoscimento” impone allora che si prendano a modello dei
rapporti tra persone e tra nazioni, non gli stati di guerra ma gli stati
di pace. “La tesi che vorrei argomentare […] – scrive Ricoeur – si riassume nel modo seguente: l’alternativa all’idea di lotta nel processo
del mutuo riconoscimento va ricercata nelle esperienze pacificate
del mutuo riconoscimento, le quali si basano su mediazioni simboliche che si sottraggono tanto all’ordine giuridico quanto all’ordine
degli scambi commerciali; il carattere eccezionale di queste esperienze, lungi dallo squalificarle, ne sottolinea la gravità e per ciò
stesso ne assicura la forza di irradiazione e di irrigazione nel cuore
stesso delle transazioni contrassegnate dal sigillo della lotta” (Percorsi del riconoscimento, p. 247).
L’ermeneutica mostra così di essere capace, con Ricoeur, non solo di
svelare la propria intenzionalità veritativa, ma di fondare su di essa
proposte concrete per una vita etica e sociale fondata sui valori del
rispetto dell’altro, della giustizia, della condivisione, dell’amicizia e
infine della pace.