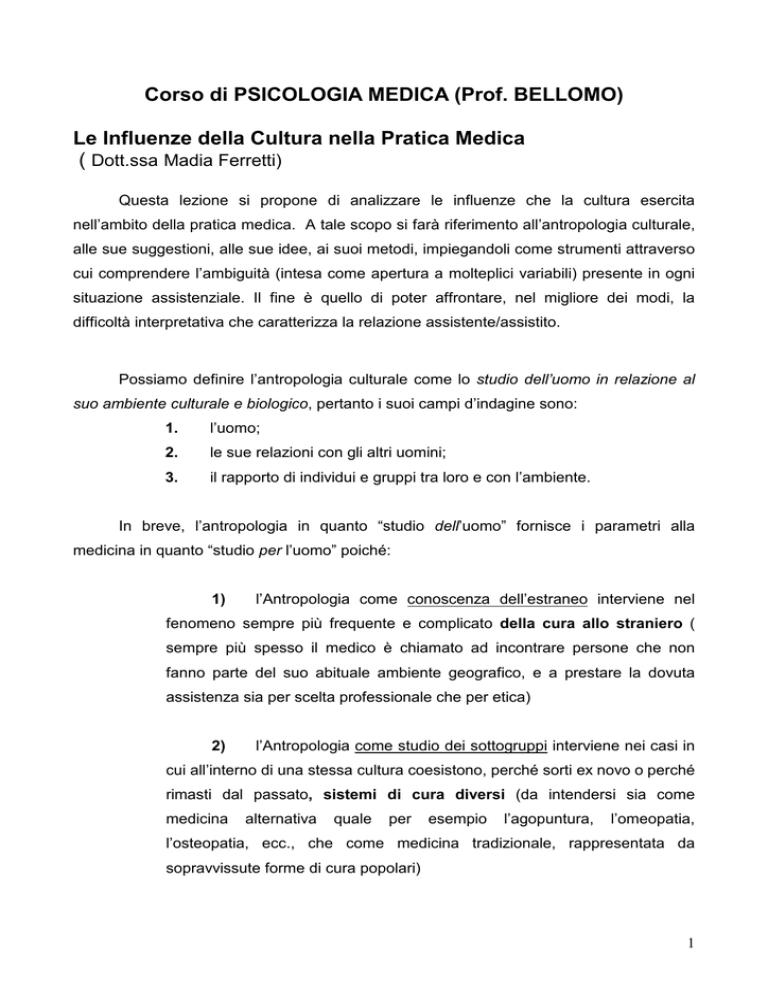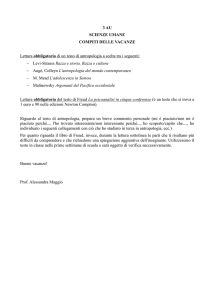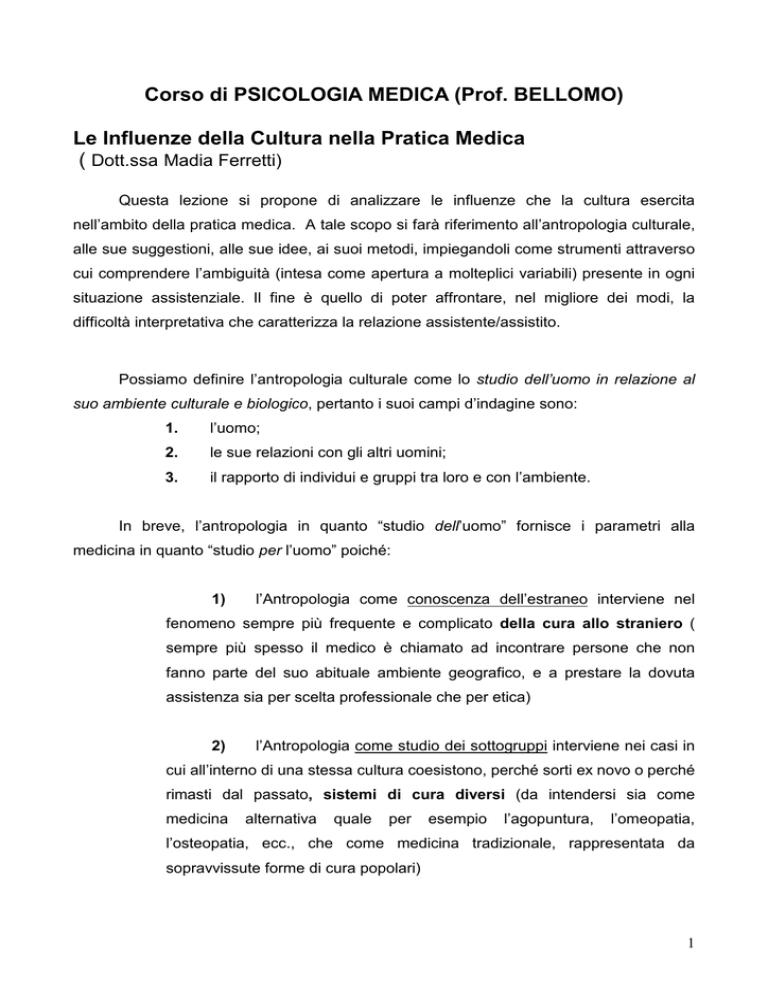
Corso di PSICOLOGIA MEDICA (Prof. BELLOMO)
Le Influenze della Cultura nella Pratica Medica
( Dott.ssa Madia Ferretti)
Questa lezione si propone di analizzare le influenze che la cultura esercita
nell’ambito della pratica medica. A tale scopo si farà riferimento all’antropologia culturale,
alle sue suggestioni, alle sue idee, ai suoi metodi, impiegandoli come strumenti attraverso
cui comprendere l’ambiguità (intesa come apertura a molteplici variabili) presente in ogni
situazione assistenziale. Il fine è quello di poter affrontare, nel migliore dei modi, la
difficoltà interpretativa che caratterizza la relazione assistente/assistito.
Possiamo definire l’antropologia culturale come lo studio dell’uomo in relazione al
suo ambiente culturale e biologico, pertanto i suoi campi d’indagine sono:
1.
l’uomo;
2.
le sue relazioni con gli altri uomini;
3.
il rapporto di individui e gruppi tra loro e con l’ambiente.
In breve, l’antropologia in quanto “studio dell’uomo” fornisce i parametri alla
medicina in quanto “studio per l’uomo” poiché:
1)
l’Antropologia come conoscenza dell’estraneo interviene nel
fenomeno sempre più frequente e complicato della cura allo straniero (
sempre più spesso il medico è chiamato ad incontrare persone che non
fanno parte del suo abituale ambiente geografico, e a prestare la dovuta
assistenza sia per scelta professionale che per etica)
2)
l’Antropologia come studio dei sottogruppi interviene nei casi in
cui all’interno di una stessa cultura coesistono, perché sorti ex novo o perché
rimasti dal passato, sistemi di cura diversi (da intendersi sia come
medicina
alternativa
quale
per
esempio
l’agopuntura,
l’omeopatia,
l’osteopatia, ecc., che come medicina tradizionale, rappresentata da
sopravvissute forme di cura popolari)
1
3)
l’Antropologia come analisi delle dinamiche interne ai gruppi ne
studia l’uso nella pratica medica.
4)
l’Antropologia come scienza dell’individuo in quanto esponente
di una particolare cultura/subcultura analizza il confine tra “normale e
anomalo”, quindi la misura in cui una persona, affetta da un disturbo o da un
disagio, può essere oggetto di stigmatizzazione e per questo tendere a
negare o distorcere il suo problema di fronte al medico.
5)
l’Antropologia come studio delle relazioni umane studia il
rapporto medico-paziente contestualizzandone l’interazione.
La collaborazione tra medicina e antropologia non è una realtà nuova, essa nacque
dalla convinzione, diffusa in passato, del particolare legame esistente tra alcune patologie
e determinate razze. Tale convinzione derivava dall’opinione che ad ogni etnia sia
collegato un bagaglio genetico standard.
Questa erronea credenza ha generato una serie di assunti stereotipanti per cui:
1)
una patologia può venire considerata congenita anche in
assenza di dettagliati accertamenti su ulteriori fattori ad essa connessi (per
es. l’osteoporosi nei bianchi);
2)
un fenomeno patologico può venire associato (positivamente o
negativamente) ad un concetto razziale, per cui essere poi esteso a tutti gli
appartenenti alla “razza” in questione ( per es. tutti i neri sono immuni da
osteoporosi).
Oggi, studi comparati hanno evidenziato come, al contrario, le caratteristiche
psicofisiche che contraddistinguono gli esseri umani siano paradossalmente più simili tra
popolazioni diverse che tra singoli individui. La naturale conseguenza è che il concetto di
razza non ha più nessuna validità scientifica né giustificazione se considerato in qualità di
parametro biologico e non esclusivamente nell’accezione di sistema simbolico e sociale di
classificazione ( quindi agente su un piano assolutamente diverso).
2
Al fine di elaborare adeguate procedure terapeutiche, quindi, la medicina moderna
tende a sostituire sempre più spesso l’obsoleta nozione di razza (intesa come condizione
subita dalla natura) con quella di identità etno-culturale (intesa, invece, come
identificazione agita nei confronti di un contesto). La sequenza:
Razza → Patrimonio Genetico → Patologia
Va pertanto trasformata in:
↓
Cultura → Identità Etnica → Malattia
Ciò è particolarmente evidente se si considerano le ricadute di natura psicologica
cui va incontro il paziente dopo essere venuto a conoscenza di una diagnosi: il processo di
adattamento alla malattia, il rapporto con il trattamento e le prescrizioni, sono, infatti,
condizionati dai modelli di malattia che la cultura di appartenenza gli propone.
A sottolineare l’importanza di questa nuova prospettiva, si aggiunge che l’analisi
delle statistiche su SALUTE-MALATTIA ha evidenziato come le maggiori cause di malattia
siano riconducibili a COMPORTAMENTI A RISCHIO, STILI DI VITA, e quindi a elementi
CULTURALMENTE DETRMINATI, sottolineando come essi arrivino a influenzare molte
funzioni fisiologiche ( si pensi alla dieta, l’uso di alcool, di tabacco, i comportamenti
sessuali ecc. fino ad arrivare agli stili di vita altamente stressanti tipici delle società
occidentali).
Sinteticamente possiamo individuare 5 funzioni principali che la cultura riveste nei
confronti della biomedicina:
1.
La cultura come strumento interpretativo ed esplicativo di
comportamenti patologici, che permette di evidenziare la natura non patologica
di determinati comportamenti altrimenti classificabili come tali
2.
La cultura come agente patogeno e patoplastico, che permette di
sapere come alcuni eventi o situazioni possano generare o accrescere patologie
(per es. l’assunzione di droghe o alcool, alcune pratiche di allevamento dei bambini,
ecc.)
3
3.
La cultura come fattore diagnostico e nosologico, che consente di
evitare la classificazione di patologie o comportamenti intrinseci ad alcune culture in
categorie appartenenti al sistema classificatorio dominante
4.
La cultura come fattore protettivo e terapeutico, che mette in
risalto come alcuni comportamenti o abitudini possano fungere da “cuscinetto” per
alcune forme patologiche ( è ciò che fanno le famiglie estese nella lotta allo stigma,
o le credenze religiose nei processi di guarigione e recupero)
5.
La cultura come elemento nella gestione e strutturazione di
servizi clinici , che promuove la consapevolezza di differenze nei bisogni
assistenziali, e quindi permette un’erogazione di servizi più mirata ed efficace.
Arrivare a tali determinazioni non è stato semplice, ed è soprattutto grazie al lavoro
di alcuni pionieri, operanti nel campo delle “malattie mentali” dove il legame patologiacultura diventa particolarmente pregnante, che oggi la visione della malattia e del “malato”
stanno cambiando.
Un breve excursus storico può servire a chiarire le idee sui passi fatti e aprire nuove
prospettive su quelli ancora da compiersi.
Fu J.C.D. Carothers, psichiatra inglese in missione militare in Africa, uno tra i primi
medici ad accorgersi delle potenzialità eziologiche della cultura, quando evidenziò come il
fenomeno patologico dei “Mau Mau”, fino a quel momento ritenuto di origine biologica
fosse invece imputabile a particolari caratteristiche culturali proprie della popolazione
keniota dei Kikuyu.
A lui seguì Fanon (1925-1961), che spostò acutamente l’accento dalla riflessione
sulla natura dell’altro a quella sulla relazione con l’altro e individuò, quali cause di alcune
condotte psicopatologiche, i fenomeni di mimesi e di ibridazione culturale cui sono
soggette le popolazioni dominate (tesi resa attualissima dal moderno e discusso fenomeno
della globalizzazione).
G.
Deveraux(1908-1985),
tutt’oggi
considerato
il
padre
del
“Metodo
Complementarista”, mise in luce come l’eventualità che una sorta di “Controtransfert
Culturale” del medico ( cioè l’insieme di assunti dettati dalla propria cultura e di cui, molte
volte è egli stesso “portatore inconsapevole”) possa interferire con il percorso di guarigione
del paziente; criticò l’universalità di assunti fino ad allora ritenuti “normali”( come per es. il
complesso di Edipo); estese le sue analisi alle società occidentali, fino ad allora rimaste al
di fuori da questo tipo di osservazione, e diede avvio a studi sistematici sull’interazione tra
4
psiche e cultura. Alla lista non può mancare l’italiano Ernesto de Martino (1908-1965),
singolare figura di etnologo, antropologo e storico, il cui contributo può dirsi basilare. Egli
individuò, infatti, il gap esistente, nell’ambito di una medesima cultura, tra le sue forme
ufficiali e le sue forme subalterne, zone d’ombra inaccessibili alla comune ragione, ed
inoltre elaborò le categorie della “Presenza” e della “Crisi della Presenza” .
Numerosi altri studiosi hanno “battuto” vie inconsuete nell’ambito del rapporto
malattia/cultura, fino a giungere a Tobie Nathan, attualmente operante a Parigi e il cui
progetto assolutamente rivoluzionario consiste nel promuovere un’alleanza terapeutica in
cui “l’altro” è visto non solo come portatore di patologie nuove, ma anche come fonte di
nuovi modi di affrontarle e risolverle. La convinzione che anima questo modo di intendere
la relazione medico-paziente è che ciò che conta, per l’efficacia della cura, è anzitutto la
ricerca di un sistema di pensiero idoneo alla costruzione di legami psichici efficaci:
fondamentale, cioè, non è il grado di verità delle interpretazioni, ma la conseguenza della
loro messa in atto.
Nato come metodo per lo studio dell’altro, nel primitivo senso di straniero, il legame
tra antropologia e medicina si è spostato col tempo, come abbiamo visto, ad analizzare in
modo nuovo, critico e consapevole, forme patogene e patologiche appartenenti al nostro
mondo.
Sempre più, infatti, la presenza di problematiche drammatiche per la loro potenza
distruttiva,
richiama
l’attenzione
del
medico
sui
fenomeni
tipici
delle
società
iperindustrializzate: i disturbi alimentari, i fenomeni di incesto nelle adozioni, le psicosi
brevi negli adolescenti, la personalità di tipo A, gli stati alterati di coscienza, il disturbo
post-traumatico da stress tipico dei rifugiati o dei sopravvissuti a guerre o a catastrofi
naturali, per non parlare del fenomeno tutto occidentale della scissione che sottostà al
comportamento dei serial-killers. Il confronto con questi e altri fenomeni non può lasciare il
medico indifferente, ma lo esorta a continui e rapidi cambiamenti nelle proprie usuali
griglie interpretative e nosologiche, pena il crollo dell’intera impalcatura etica ed ideologica
che ha animato la medicina fino ad ora.
Negli ultimi anni l'interesse scientifico verso tali eventi è notevolmente aumentato.
Tra i tanti, un’attenzione particolare In virtù della capacità di influenzare il percorso
terapeutico dei pazienti, meritano sette e gruppi di guarigione, raggruppati intorno a figure
taumaturgiche e carismatiche, oggi quanto mai presenti nella nostra società e, non di rado,
preferiti alla medicina ufficiale. Uno studio approfondito di questa realtà è utile a sostituire
5
la paura con la conoscenza e a trarre vantaggio dalla comprensione dei meccanismi
operanti al loro interno.
Questi gruppi hanno in comune la cosiddetta “caratteristica carismatica”: una
struttura di base che si regge sull’attribuzione di poteri superiori al leader o alla missione
del gruppo.
A livello strutturale, possono essere formati da una dozzina o poco più di seguaci
fino a centinaia o migliaia e sono caratterizzati dai seguenti elementi psicologici:
a.
i seguaci hanno un sistema comune di fede,
b.
dimostrano un alto livello di coesione sociale,
c.
sono fortemente influenzati dalle norme comportamentali
di gruppo,
d.
attribuiscono potere carismatico (o talvolta divino) al
gruppo o alla sua leadership.
e.
Alla base della tipicità dei comportamenti di chi vi aderisce, vi è, appunto, un
sistema di fede comune per cui i seguaci tendono a preoccuparsi molto del benessere
reciproco e ad impegnarsi a fondo in attività collettive. La loro considerevole coesione
sociale, essenziale per l'integrità del gruppo, si riflette nella stretta interrelazione tra
l'esistenza del singolo e quella di tutti gli associati e si manifesta attraverso la pratica di
frequenti riunioni. Tale caratteristica, specifica di questo tipo di affiliazioni, assolve al
duplice scopo di perno per le funzioni di gruppo e di occasione per rinvigorirne la
coesione: per un associato a gruppi di culto (o, come si è potuto riscontrare, anche per chi
aderisce a gruppi di autosostegno, terapeutici o di mutuo aiuto) è fondamentale essere
sempre al corrente dei futuri appuntamenti collettivi, anzi, un membro può essere
emotivamente molto vulnerabile all'interruzione dell’abituale routine, tanto che mancare ad
un incontro può arrivare a generare un forte senso d’angoscia (lo sanno bene i medici che
devono gestire i ricoveri, per esempio, dei Testimoni di Geova!).
Le norme di comportamento, poi, giocano un ruolo fondamentale nel canalizzare la
condotta dei membri, i quali vi fanno appello soprattutto quando si trovano in situazioni
nuove, come è il caso delle malattie, alle quali reagiscono in maniera pressocchè
standardizzata.
A livello medico è interessante notare come, in questi contesti, si verifichino casi in
cui i cambiamenti del comportamento arrivino ad imitare i sintomi di alcune patologie, e
questo perché, in molti gruppi a matrice mistico-religiosa, le esperienze trascendentali,
6
spesso allucinatorie, sono piuttosto comuni: un compagno morto sta “letteralmente”
accanto a un seguace, o un personaggio storico gli porta consigli d'ispirazione divina. Ciò
induce i membri a sperimentare esperienze emotive piuttosto intense, come euforia o
malessere profondi, le quali provocano episodi patologici in individui che altrimenti non
manifestano anomalie.
L’analisi di tali dinamiche, tuttavia, ha portato antropologi e sociologi a sottolineare
come, al di là di possibili implicazioni negative, un gruppo nasca essenzialmente per
raggiungere obiettivi pratici, trasformandosi solo in seguito in una sorta di dipendenza.
L’adesione a tale tipologia di gruppi, in effetti, ha molto in comune con altri tipi di
dipendenza (tossicodipendenza, alcoolismo, gioco ecc.) in quanto presenta, come
costante di base, una marcata correlazione fra il grado di affiliazione e il reale sollievo
dall'angoscia che si avverte entrandovi.
Uno tra i primi tentativi di “trasferire” i vantaggi di simili esperienze nel trattamento di
pazienti si deve allo pneumologo statunitense J.H. Prat che, nel 1908, lavorando con
soggetti tubercolotici, notò come il sostegno psicologico offerto dal lavoro di gruppo
contribuiva a favorirne il miglioramento anche da un punto di vista fisiologico.
Nel 1919 tale metodo venne adottato per la prima volta in un ospedale psichiatrico,
dove il dottor L.C. Marsh ne sperimentò un uso ancora diverso, avviando una serie di
incontri sistematici tra il personale istituzionalizzato al fine di migliorarne il grado di
efficienza.
Da allora molti passi sono stati fatti e oggi, anche grazie ad una collaborazione
sempre più feconda tra la medicina e le altre branche delle scienze dell’uomo, si è giunti
alla determinazione che l’analisi del rapporto corrente tra individuo e gruppo di
appartenenza sia essenziale, non solo per costituire un quadro diagnostico esaustivo, ma
anche per programmare un intervento terapeutico funzionale.
E’ questo il tipo di approccio su cui si basa la nuova visione della salute promossa
dall’OMS, la quale ha sancito il passaggio dal cosiddetto “modello biomedico” a quello
“biopsicosociale”, che fà risiedere il benessere (o il malessere) dell’individuo non solo nel
suo organismo biologico, ma anche nella qualità delle sue relazioni con il contesto.
Quando un soggetto si ammala, infatti, la sua situazione nel gruppo si modifica, e con
essa l’assetto del gruppo stesso. Questo perchè la malattia impone all’individuo un
rapporto particolare nei confronti delle consuete pratiche e norme sociali. La conoscenza e
l’uso di gruppi, quindi, possono rivelarsi strumenti preziosi in questi casi, dal momento che,
le difficoltà esplicitate nel setting possono servire da segnale per leggere quanto un
7
eventuale stato di disagio sia imputabile esclusivamente al rapporto con se stesso, o
quanto sia indotto, o almeno favorito, dall’azione del gruppo di riferimento. Come si è
detto, infatti, la malattia costringe tutta la rete relazionale del paziente a modificare gli
equilibri al suo interno. Favorire quella che abbiamo definito “funzione protettiva e
terapeutica della cultura” consente l’avvio di una serie di reazioni a catena che porta, in
un primo momento, le famiglie dei pazienti ad organizzarsi intorno al “malato” in modo da
accrescere il grado di assistenza e di tolleranza di fronte al problema, e ne favorisce, poi,
la prognosi di riadattamento, contribuendo con un’efficace azione di rinforzo alla terapia
medica.
Si intuisce quindi che una “rivisitazione” in chiave antropologica del rapporto
medico-paziente, può essere di grande aiuto per l’attivazione di quelle dinamiche positive
necessarie al buon esito di un trattamento.
In ogni relazione, infatti, entrambi gli attori portano con sè visioni della realtà che
nella migliore delle ipotesi potranno essere simili, ma non saranno mai coincidenti. Anche
la relazione di cura risente della specificità che caratterizza i due protagonisti e, per
questo, può considerarsi un vero e proprio incontro tra culture, in cui il paziente è
rappresentante della cultura del suo gruppo di appartenenza, mentre il medico di quella
del suo gruppo e del gruppo professionale che lo ha accreditato. Ne deriva uno degli
aspetti meno evidenti, sebbene più pregnanti di tale relazione, cioè il processo di
acculturazione cui, inconsapevolmente, viene sottoposto il paziente. In pratica ciò che gli
si chiede, sebbene in modo implicito, è di compiere un salto tale da bypassare le barriere
comunicative esistenti, accedere al “mondo altro” del suo medico, traslarne i significati ed
infine omologarsi ad essi. Esiste, quindi, un senso di “estraneità” che va oltre le differenze
geolinguistiche, ma non per questo è meno pericoloso. Ed è proprio sul rischio che
l’ambiguità genera in contesti insospettabili, che il sapere antropologico interviene
affiancando concretamente quello medico, e non solo per scongiurare l’eventualità che la
presenza di sincretismi possa confondere e ostacolare la comprensione dei fenomeni
patologici, ma anche perchè, dove non esiste affinità tra cultura del paziente e cultura del
terapeuta, non può esservi consenso sul progetto terapeutico, destinato inevitabilmente
all’insuccesso.
A questo proposito, studi recenti hanno dimostrato come, al contrario, il largo
consenso nei confronti delle pratiche mediche tradizionali, alterative alla medicina ufficiale,
sia da reperire proprio in quelle dinamiche comunicative e relazionali che le prime mettono
8
in atto. Al malato che chiede spiegazioni, il terapeuta tradizionale risponde con un sapere
condiviso, un codice culturale che entrambi riescono a padroneggiare.
Volendo cogliere i momenti salienti di tali sistemi di cura, possiamo affermare che,
ogni processo ha inizio con l’individuazione delle cause della malattia, le quali possono
spaziare dall’elemento naturale a quello magico o psico-emotivo, anzi il più delle volte essi
coesistono. Il passo successivo consiste nell’allacciare il problema del come a quello del
perché, operazione che permette di compiere un salto dalla dimensione oggettiva e
passiva del malato (tipica della biomedicina) ad una prospettiva soggettiva ed attiva.
Pertanto, la differenza fondamentale tra medicina non ortodossa e medicina
ufficiale risiede, essenzialmente, nel fatto che, mentre per la prima la questione
terapeutica è strettamente legata alla questione del perché, un perché che si può
facilmente rapportare alla soggettività del malato, al contrario la seconda considera ogni
malattia come frutto di agenti neutrali. Il successo di tale sistema risiede, dunque, nel fatto
che non si interessa alla malattia, ma al malato, dà voce al suo stare male e lo colloca in
una dimensione logico-causale che egli stesso può controllare
A fini esemplificativi possiamo sintetizzare le caratteristiche principali delle due
opzioni terapeutiche come segue:
Elementi caratterizzanti la medicina
tradizionale
Elementi caratterizzanti la
biomedicina
Nessuna discontinuità tra modello
"domestico" e prestazioni assistenziali
Frattura con i propri "mondi vitali"
soprattutto se ospedalizzati
Sensazione di una sinergia protettiva e
rassicurante tra familiare e "medico di
capezzale"
Semplificazione
delle
procedure
diagnostiche-terapeutiche
Sicurezza, o quasi, di una “fine” con i
familiari intorno
Sensazione di essere ancora un
soggetto ascoltato e corresponsabile di
decisioni.
Emarginazione istintiva da parte dei saniattivi, ("non sta bene, è fuori gioco, inutile
sentirlo")
Possibili contenziosi tra familiari circa la
presa in carico, a rotazione o meno
Difficoltà di tempo nello stabilire relazioni
"terapeutiche" con un familiare infermo
Negligenza nella somministrazione di
farmaci prescritti e/o nella dietetica
consigliata
Se il fine di una buona medicina è quello di attuare le pratiche terapeutiche migliori, il
compito di chi lavora per le persone, siano esse di culture palesemente differenti o meno,
non può prescindere dalla comprensione del sistema di credenze, valori, significati a
cui queste persone fanno riferimento, dall’interpretare la loro esperienza per riuscire a
9
cogliere i processi di attribuzione e creazione di significato, perchè, e non può essere
dimenticato, l’approccio alla malattia non può fare a meno di essere stabilito attraverso
criteri che fanno riferimento al sociale: una patologia diventa una “malattia” solo in una
società sensibile a riconoscerla come tale.
10