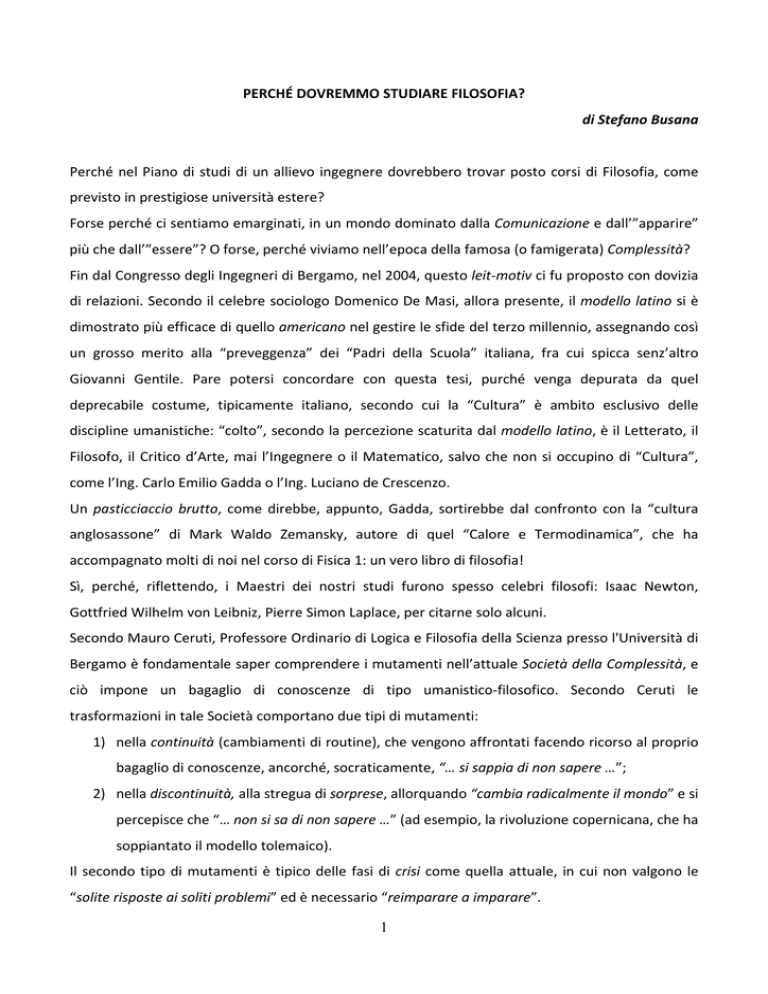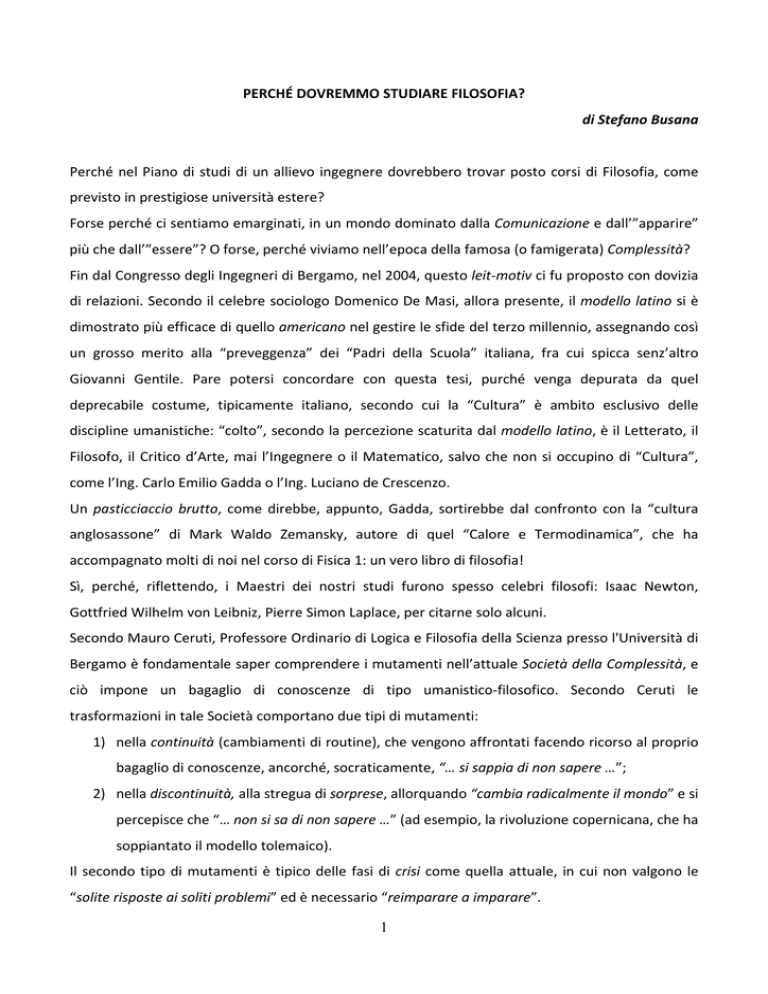
PERCHÉ DOVREMMO STUDIARE FILOSOFIA? di Stefano Busana Perché nel Piano di studi di un allievo ingegnere dovrebbero trovar posto corsi di Filosofia, come previsto in prestigiose università estere? Forse perché ci sentiamo emarginati, in un mondo dominato dalla Comunicazione e dall’”apparire” più che dall’”essere”? O forse, perché viviamo nell’epoca della famosa (o famigerata) Complessità? Fin dal Congresso degli Ingegneri di Bergamo, nel 2004, questo leit‐motiv ci fu proposto con dovizia di relazioni. Secondo il celebre sociologo Domenico De Masi, allora presente, il modello latino si è dimostrato più efficace di quello americano nel gestire le sfide del terzo millennio, assegnando così un grosso merito alla “preveggenza” dei “Padri della Scuola” italiana, fra cui spicca senz’altro Giovanni Gentile. Pare potersi concordare con questa tesi, purché venga depurata da quel deprecabile costume, tipicamente italiano, secondo cui la “Cultura” è ambito esclusivo delle discipline umanistiche: “colto”, secondo la percezione scaturita dal modello latino, è il Letterato, il Filosofo, il Critico d’Arte, mai l’Ingegnere o il Matematico, salvo che non si occupino di “Cultura”, come l’Ing. Carlo Emilio Gadda o l’Ing. Luciano de Crescenzo. Un pasticciaccio brutto, come direbbe, appunto, Gadda, sortirebbe dal confronto con la “cultura anglosassone” di Mark Waldo Zemansky, autore di quel “Calore e Termodinamica”, che ha accompagnato molti di noi nel corso di Fisica 1: un vero libro di filosofia! Sì, perché, riflettendo, i Maestri dei nostri studi furono spesso celebri filosofi: Isaac Newton, Gottfried Wilhelm von Leibniz, Pierre Simon Laplace, per citarne solo alcuni. Secondo Mauro Ceruti, Professore Ordinario di Logica e Filosofia della Scienza presso l'Università di Bergamo è fondamentale saper comprendere i mutamenti nell’attuale Società della Complessità, e ciò impone un bagaglio di conoscenze di tipo umanistico‐filosofico. Secondo Ceruti le trasformazioni in tale Società comportano due tipi di mutamenti: 1) nella continuità (cambiamenti di routine), che vengono affrontati facendo ricorso al proprio bagaglio di conoscenze, ancorché, socraticamente, “… si sappia di non sapere …”; 2) nella discontinuità, alla stregua di sorprese, allorquando “cambia radicalmente il mondo” e si percepisce che “… non si sa di non sapere …” (ad esempio, la rivoluzione copernicana, che ha soppiantato il modello tolemaico). Il secondo tipo di mutamenti è tipico delle fasi di crisi come quella attuale, in cui non valgono le “solite risposte ai soliti problemi” ed è necessario “reimparare a imparare”. 1
Nell’evoluzione tecnologica le discontinuità avvengono con ritmi sempre più frenetici, talchè oggi, finanche a quarant’anni, si percepisce, talora, la sgradevole sensazione dell’obsolescenza. In questo quadro è necessaria una notevole capacità di adattamento ai mutamenti del presente, creando veri e propri spazi “non finalizzati” di esplorazione; in altre parole, occorre comprendere che gli abituali strumenti di analisi, utili nella navigazione di routine e insiti nel nostro bagaglio culturale, mostrano la corda di fronte alla gestione dei mutamenti con discontinuità. Questi ultimi avvengono nel tempo, ma anche nello spazio, generando, come accennato, la Complessità, di cui si parla, spesso a sproposito, nel mondo odierno. L’analisi di siffatti sistemi complessi richiede quindi strumenti che vadano al di là delle mere leggi della fisica, poiché contengono l’imprevedibile e la singolarità; bisogna pertanto implementare strategie flessibili, in grado di fornire risposte, in tempo reale, ai mutamenti in atto, per mezzo dell’ibridazione dei saperi, che deve soppiantare l’attuale compartimentazione, adatta al più a gestire i mutamenti nella continuità. Il superamento dei modelli teoretici basati sulle leggi della fisica, è testimoniato dall’evoluzione tecnologica di alcuni settori, quali la bioingegneria e la genetica, che non hanno sempre trovato una teoria in grado di supportarli. In questa nuova situazione appare strategica la figura dell’ingegnere quale mediatore fra Progetto e Complessità del Sistema, che integra la funzione tradizionale di mediatore fra l’aspetto teorico e applicativo: in altri termini, fra il Sapere e il Fare. Per contro, la Complessità dei sistemi richiede anche Cultura Umanistica, indispensabile laddove vi sia interazione fra individui. Ed è in questa interazione che crollano le “certezze” dell’approccio convenzionale. L’ultima crisi che stiamo vivendo, partita dai santuari di Wall Street e dilagata fino alla bottega del fruttivendolo, è l’ennesimo esempio dell’inadeguatezza dei modelli razionali nella comprensione di trasformazioni nella discontinuità. Luminari di Economia si sono cimentati, con i loro oracoli previsionali, inanellando fallimenti in serie. Non parliamo poi dei grotteschi tentativi di prevedere “ex post” il decorso della crisi, a cura dei vari guru dell’Economia, intervistati h 24 su tutti i media. «Il futuro dell’uomo», ammette Fabrizio Pezzani, professore della Bocconi, nel suo pregevole “La competizione collaborativa”, «potrebbe essere meglio capito guardando la sua storia che non limitandosi ai fondamentali dell’economia, come lo studio di Toynbee dimostra». Il citato Arnold J. Toynbee fu un insigne storico, che seppe fornire elementi previsionali partendo da quelle che molti tacciarono come “speculazioni metafisiche”, perché non fondate su un rigoroso 2
determinismo alla Spengler (l’autore de Il tramonto dell'Occidente). Toynbee basava il suo concetto di Civiltà su criteri religiosi e culturali, con la religione considerata alla stregua di forza rigenerativa. E aveva ragione, perché la “variabile umana” è forse la più complicata da collocare, soprattutto nell’epoca della Complessità, come sosteneva Luigi Cadorna: «Capo è colui che conosce il cuore umano.» Fin dai primordi del Pensiero socio‐economico, passando da Max Weber, che nel suo L'etica protestante e lo spirito del capitalismo tracciava i lineamenti dell’homo oeconomicus forgiato nel crogiolo della Riforma di Lutero e Calvino, la comprensione dell’individuo umano soggetto all’influenza “culturale” del potere, è pratica assai affascinante e complessa. L’uomo moderno, in tal senso, è stato analizzato da un’eminente filosofa, Elena Pulcini, dell’Università di Firenze, che trascrive l’immagine foucultiana di “governo delle anime” come la più compiuta e recente espressione del problema. Nel suo saggio del 2001 “L’individuo senza passioni”, la Pulcini esprime l’involuzione dell’uomo moderno, frutto dell’atomismo, della massificazione, della solitudine, del conformismo, dell’indipendenza e dell’assoggettamento, che generano una mutata forma di individualismo «non più aggressivo e conflittuale, ma debole e apatico, indifferente e delegante […] in cui un illimitato desiderio di autorealizzazione appare come l’effetto speculare di un vuoto emotivo, di una perdita di pàthos che chiude l’Io in una logica identitaria responsabile sia dell’indebolimento dell’identità individuale, sia della crisi del legame sociale.» Illuminante, poi, la trattazione del tribalismo contemporaneo: «L’individualismo narcisista sembra dunque aver definitivamente compromesso la dimensione societaria in quanto rende obsoleta persino la possibilità che l’interesse agisca strumentalmente come risposta normativa. Esso produce semmai, come fenomeno opposto e complementare, il riemergere di passioni “disinteressate” che alimentano un “ritorno alla comunità” in forme, però, prevalentemente regressive e distruttive; come appare nei vari tribalismi e comunitarismi contemporanei (siano essi di origine etnica, religiosa o ideologica) che oppongono l’endogamica e violenta passionalità del “cum” all’apatia dello sradicamento e dell’omologazione. Di fronte a questa forbice tra un “individualismo narcisista” e un “comunitarismo regressivo”, tra un’assenza di pàthos che corrode il legame sociale e un eccesso di pàthos che lo ricostruisce in forme distorte ed esclusive, emerge dunque la necessità di ripensare con urgenza le forme dell’essere‐in‐comune capaci di riattivare la partecipazione alla vita pubblica, la sensibilità al bene collettivo.» 3
Si coglie, in quest’analisi, il portato dell’Antropologia filosofica, in grado di decifrare fenomeni che, purtroppo, passano sopra le nostre teste di vetusti ingegneri. L’11 settembre, ad esempio, è figlio di quel crogiolo di pulsioni, di frustrazioni, di esaltazioni che il mondo islamico stava covando in sé da molti anni, ma che pochi avevano previsto nella sua virulenza. Più modestamente, l’imbarbarimento dei rapporti umani che viviamo in questi anni va interpretato “ex post” ricorrendo a questi strumenti di analisi. In conclusione, noi ingegneri, “scienziati della tecnica”, dobbiamo decidere se vogliamo rimanere spettatori di questo contesto socio‐economico, di queste dinamiche, in una turris eburnea solipsista, o assurgere a quel ruolo da protagonisti che i nostri padri si erano ritagliati nel loro tempo, grazie alla loro preparazione peculiare. Ampliare gli strumenti culturali per muoverci nella società del terzo millennio richiede uno sforzo formativo, ma non solo nel nostro scibile. È ineludibile, soprattutto per i giovani, camminare nella Modernità ripartendo dal “miracolo greco” ‐ beffarda nemesi di ben altra, odierna, vicenda ellenica ‐ della filosofia speculativa, laddove il principio, il logos, l’idea immateriale costituiscono altrettanti mattoni di un edificio etereo e incorrotto dai sensi, così come appreso dai nostri Maestri, quei filosofi da cui abbiamo attinto la Scienza, non il Pensiero. 4