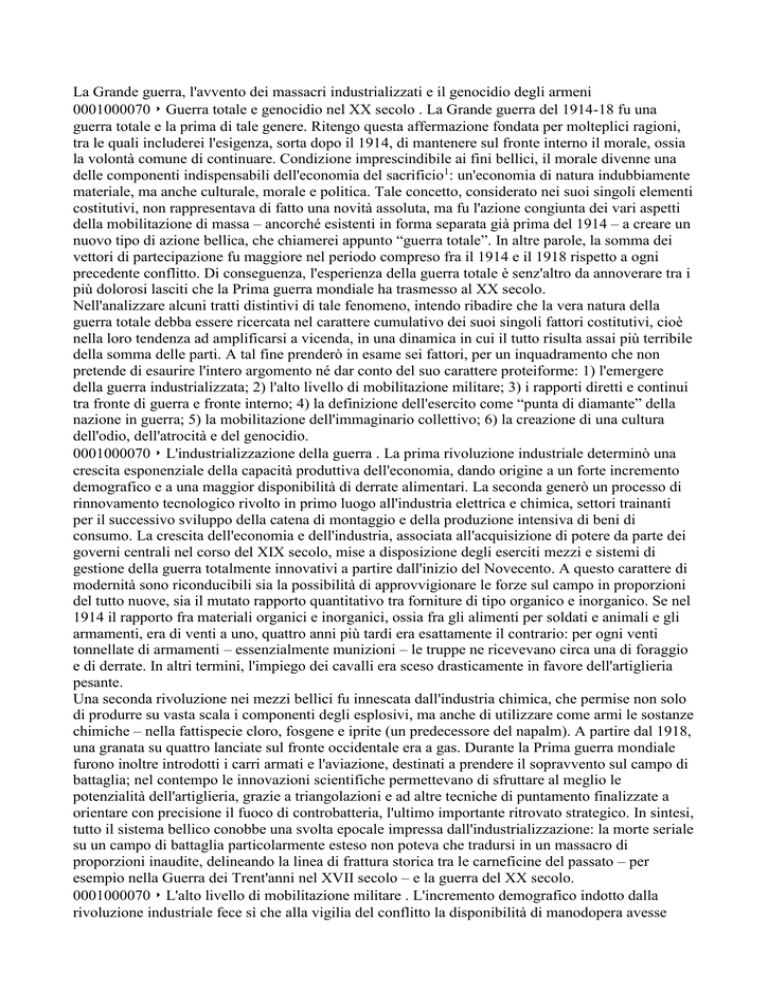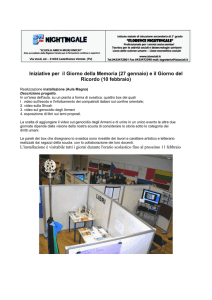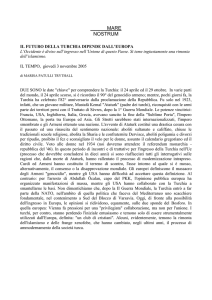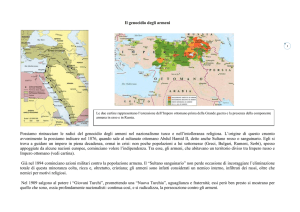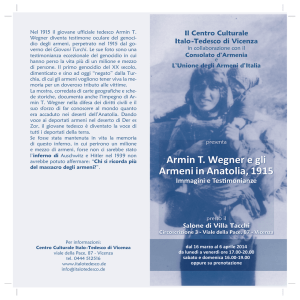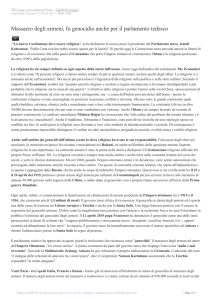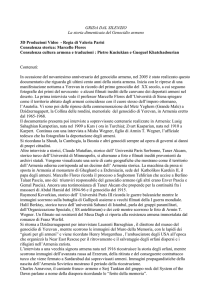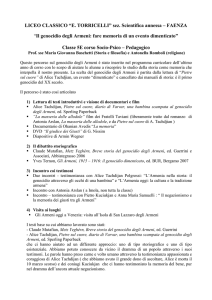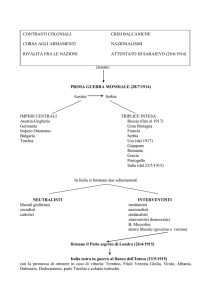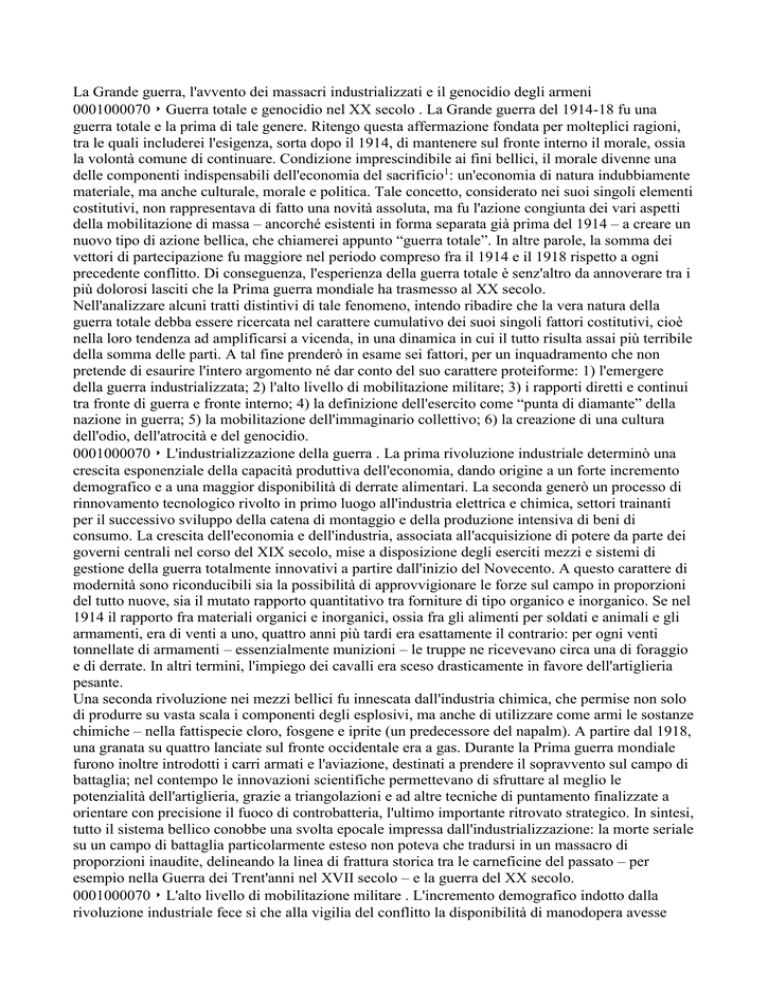
La Grande guerra, l'avvento dei massacri industrializzati e il genocidio degli armeni
0001000070 ‣ Guerra totale e genocidio nel XX secolo . La Grande guerra del 1914-18 fu una
guerra totale e la prima di tale genere. Ritengo questa affermazione fondata per molteplici ragioni,
tra le quali includerei l'esigenza, sorta dopo il 1914, di mantenere sul fronte interno il morale, ossia
la volontà comune di continuare. Condizione imprescindibile ai fini bellici, il morale divenne una
delle componenti indispensabili dell'economia del sacrificio1: un'economia di natura indubbiamente
materiale, ma anche culturale, morale e politica. Tale concetto, considerato nei suoi singoli elementi
costitutivi, non rappresentava di fatto una novità assoluta, ma fu l'azione congiunta dei vari aspetti
della mobilitazione di massa – ancorché esistenti in forma separata già prima del 1914 – a creare un
nuovo tipo di azione bellica, che chiamerei appunto “guerra totale”. In altre parole, la somma dei
vettori di partecipazione fu maggiore nel periodo compreso fra il 1914 e il 1918 rispetto a ogni
precedente conflitto. Di conseguenza, l'esperienza della guerra totale è senz'altro da annoverare tra i
più dolorosi lasciti che la Prima guerra mondiale ha trasmesso al XX secolo.
Nell'analizzare alcuni tratti distintivi di tale fenomeno, intendo ribadire che la vera natura della
guerra totale debba essere ricercata nel carattere cumulativo dei suoi singoli fattori costitutivi, cioè
nella loro tendenza ad amplificarsi a vicenda, in una dinamica in cui il tutto risulta assai più terribile
della somma delle parti. A tal fine prenderò in esame sei fattori, per un inquadramento che non
pretende di esaurire l'intero argomento né dar conto del suo carattere proteiforme: 1) l'emergere
della guerra industrializzata; 2) l'alto livello di mobilitazione militare; 3) i rapporti diretti e continui
tra fronte di guerra e fronte interno; 4) la definizione dell'esercito come “punta di diamante” della
nazione in guerra; 5) la mobilitazione dell'immaginario collettivo; 6) la creazione di una cultura
dell'odio, dell'atrocità e del genocidio.
0001000070 ‣ L'industrializzazione della guerra . La prima rivoluzione industriale determinò una
crescita esponenziale della capacità produttiva dell'economia, dando origine a un forte incremento
demografico e a una maggior disponibilità di derrate alimentari. La seconda generò un processo di
rinnovamento tecnologico rivolto in primo luogo all'industria elettrica e chimica, settori trainanti
per il successivo sviluppo della catena di montaggio e della produzione intensiva di beni di
consumo. La crescita dell'economia e dell'industria, associata all'acquisizione di potere da parte dei
governi centrali nel corso del XIX secolo, mise a disposizione degli eserciti mezzi e sistemi di
gestione della guerra totalmente innovativi a partire dall'inizio del Novecento. A questo carattere di
modernità sono riconducibili sia la possibilità di approvvigionare le forze sul campo in proporzioni
del tutto nuove, sia il mutato rapporto quantitativo tra forniture di tipo organico e inorganico. Se nel
1914 il rapporto fra materiali organici e inorganici, ossia fra gli alimenti per soldati e animali e gli
armamenti, era di venti a uno, quattro anni più tardi era esattamente il contrario: per ogni venti
tonnellate di armamenti – essenzialmente munizioni – le truppe ne ricevevano circa una di foraggio
e di derrate. In altri termini, l'impiego dei cavalli era sceso drasticamente in favore dell'artiglieria
pesante.
Una seconda rivoluzione nei mezzi bellici fu innescata dall'industria chimica, che permise non solo
di produrre su vasta scala i componenti degli esplosivi, ma anche di utilizzare come armi le sostanze
chimiche – nella fattispecie cloro, fosgene e iprite (un predecessore del napalm). A partire dal 1918,
una granata su quattro lanciate sul fronte occidentale era a gas. Durante la Prima guerra mondiale
furono inoltre introdotti i carri armati e l'aviazione, destinati a prendere il sopravvento sul campo di
battaglia; nel contempo le innovazioni scientifiche permettevano di sfruttare al meglio le
potenzialità dell'artiglieria, grazie a triangolazioni e ad altre tecniche di puntamento finalizzate a
orientare con precisione il fuoco di controbatteria, l'ultimo importante ritrovato strategico. In sintesi,
tutto il sistema bellico conobbe una svolta epocale impressa dall'industrializzazione: la morte seriale
su un campo di battaglia particolarmente esteso non poteva che tradursi in un massacro di
proporzioni inaudite, delineando la linea di frattura storica tra le carneficine del passato – per
esempio nella Guerra dei Trent'anni nel XVII secolo – e la guerra del XX secolo.
0001000070 ‣ L'alto livello di mobilitazione militare . L'incremento demografico indotto dalla
rivoluzione industriale fece sì che alla vigilia del conflitto la disponibilità di manodopera avesse
raggiunto livelli mai registrati in precedenza. A tale realtà non corrispondeva, tuttavia, un'adeguata
capacità da parte dei governi nazionali di fornire uniformi ed equipaggiare, dispiegare e mantenere
per anni questa enorme massa di soldati come forze combattenti all'interno di un apparato bellico
efficiente. Solo lo stato moderno, in virtù dei poteri di persuasione e di comunicazione, poteva
assolvere a un tale compito. È quindi corretto affermare che la guerra divenne “guerra totale” in
questo preciso contesto.
Analizzando il coinvolgimento nel conflitto, va notato infatti che tra il 1914 e il 1918 il numero di
individui di sesso maschile di età compresa fra i diciotto e i quarantanove anni chiamati alle armi
superò la soglia del 50% delle risorse disponibili, e si mantenne a un livello pari o superiore per un
periodo prolungato. Tra i paesi belligeranti, la quota più alta fu raggiunta da Francia e Germania
che, attraverso la coscrizione obbligatoria, arrivarono a mobilitare circa l'80% degli uomini fra i
quindici e i quarantanove anni alla vigilia del conflitto; l'Impero austro-ungarico si attestò al 75%;
Gran Bretagna, Serbia e Turchia fra il 50 e il 60%. Quanto alla Russia, che si collocò al livello più
basso della mobilitazione “totale” – da non intendersi ovviamente in senso letterale – furono sedici
milioni gli uomini in armi, ossia il 40% della popolazione maschile rientrante in quella fascia di età.
Anche in questo caso, tuttavia, venne inevitabilmente a crearsi un'alterazione sostanziale nella
composizione delle fasce d'età e nel rapporto numerico fra i sessi riguardante la popolazione non
belligerante. Gli Stati Uniti costituirono l'unica eccezione, in quanto la loro partecipazione al
conflitto, peraltro limitata a un periodo di diciotto mesi, riguardò circa quattro milioni di uomini,
che rappresentavano solo il 16% della popolazione arruolabile.
Un altro fattore di rilievo fu l'enorme aumento, rispetto al passato, dell'incidenza delle vittime sul
totale delle forze impegnate: circa nove milioni di morti (facendo una media tra le diverse stime),
pari a un soldato su otto, a cui vanno aggiunti feriti e prigionieri, nel rapporto complessivo di tre
soldati su otto. Ne risulta che solo il 50% dei combattenti che parteciparono alla Prima guerra
mondiale uscì indenne dal conflitto, mentre il restante 50% ne fu vittima in vario modo (cfr. tabella
1 pag. 246). Nel sottolineare le differenze esistenti tra le varie nazioni belligeranti, va ricordato che
il fronte orientale fu innegabilmente il teatro di battaglia più sanguinoso, nel quale malattie e azioni
belliche seguirono il corso di una guerra del XIX secolo combattuta con armi del XX. L'esercito
serbo subì il 37% delle perdite; rumeni, turchi e bulgari persero circa un uomo su quattro. Sul fronte
occidentale, dove si decidevano le sorti della guerra, i combattimenti ebbero esiti meno letali, con
una percentuale di vittime pari a circa la metà rispetto a quello orientale. Germania e Francia
persero circa un soldato ogni sei, la Gran Bretagna uno ogni otto: cifre che non rappresentavano
nulla di astratto per intere famiglie straziate dal dolore a causa della perdita dei propri cari. Al di là
di singole percentuali, le liste dei caduti si allungarono a tal punto che solo il linguaggio metaforico
o la poesia potrebbero forse esprimere l'orrore universale della guerra.
Sempre a proposito di guerra totale, può risultare alquanto sorprendente parlare di
democratizzazione delle perdite. All'inizio delle ostilità, in effetti, queste furono più ingenti
nell'ambito delle classi alte rispetto al resto della popolazione, in quanto gli ufficiali, spesso di
estrazione sociale elevata, in battaglia erano maggiormente esposti al pericolo rispetto alle truppe.
Di conseguenza, nelle fase iniziali, più alta era la collocazione sociale, maggiore la possibilità di
venire colpiti in battaglia. Con il 1917, le élite militari erano ormai state pressoché decimate, al
punto che l'esercito dovette ricorrere a giovani ufficiali provenienti da classi sociali inferiori, i quali
furono a loro volta colpiti duramente negli ultimi due anni di guerra. Paradossalmente, le fasce
meno toccate furono quelle al di sotto della linea di povertà. Le privazioni subite nel periodo
prebellico, infatti, ebbero l'effetto di salvare la vita a milioni di operai e contadini, affetti da malattie
o quantomeno di statura troppo inferiore alla media per superare i requisiti minimi necessari per
entrare nell'esercito. Nel caso della Gran Bretagna, circa il 35% degli individui esaminati per il
servizio militare risultò inabile al combattimento o addirittura non idoneo a indossare l'uniforme:
questi furono, alla fin fine, i più fortunati2.
0001000070 ‣ I rapporti tra fronte di guerra e fronte interno . L'entità numerica delle vittime strinse
il fronte di guerra e il fronte interno in una rete di nuove e complesse relazioni. Riguardo alla
mobilitazione della manodopera nelle economie belliche3 e agli effetti che la guerra ebbe sul lavoro
e sul benessere delle donne esiste una vasta letteratura4. È evidente che la guerra totale entrò a pieno
regime solo quando tutte le nazioni belligeranti divennero industrializzate o si inserirono nel
sistema di commercio mondiale basato sull'industrializzazione. Ma dove il legame tra i due fronti
assunse un carattere tangibile e non puramente evocativo fu nella consapevolezza dell'atrocità della
guerra da parte del mondo civile. Nel 1914-18, tutta la popolazione era informata delle atrocità della
guerra, anche senza mai essersi avvicinata al fronte e nonostante ciò che poteva leggere su molti
giornali e lettere scritte dai soldati in prima linea. Sin dal 1914 aveva visto milioni di rifugiati
provenienti dal fronte in Belgio, Francia, Serbia, Germania orientale, Russia; poi aveva visto i
mutilati e più tardi aveva iniziato a piangere i propri morti. Con l'ultimo anno di guerra,
praticamente ogni famiglia europea era stata in qualche modo colpita.
L'onnipresenza del lutto, caratteristica peculiare della guerra totale, fu già una realtà a partire dagli
anni centrali della guerra. Nel 1916 morì in Francia oltre un milione di soldati e il numero delle
perdite nelle file tedesche si aggirava pressoché sulla stessa cifra. Per i paesi impegnati sul fronte
orientale, la percentuale dei caduti rispetto alle forze effettivamente messe in campo era ancora più
elevata, con la Serbia tristemente al primo posto. Anche lì la morte di massa in proporzioni inaudite
fu una catastrofe condivisa da ogni famiglia che piangesse un caduto. La storia della guerra totale è
la storia di quest'esperienza di lutto collettivo nel corso stesso del conflitto. Il dolore è uno stato
d'animo; la perdita una condizione. L'uno e l'altra sono mediati dal lutto, un insieme di azioni e di
gesti tramite i quali i sopravvissuti esprimono la propria pena e passano per le varie fasi della
perdita5; molti di questi momenti sono vissuti all'interno delle famiglie col sostegno di
organizzazioni sociali. Le manifestazioni di dolore e di lutto, come anche gli atti di cordoglio,
continuarono durante il conflitto e si protrassero per anni dopo l'armistizio. Risulta quindi
assolutamente errato affermare che nella Prima guerra mondiale i civili non fossero consapevoli
dell'atrocità della guerra. È bene ripeterlo: sapevano, soffrivano, piangevano la morte dei propri
cari, anche se i giornali non facevano praticamente mai menzione di questa coscienza, né
riconoscevano l'onnipresenza di questo dolore.
0001000070 ‣ L'esercito come “punta di diamante” della nazione in guerra . L'entità e la durata
dello sforzo bellico richiedevano il riconoscimento popolare dell'esercito quale “punta di diamante”
della nazione in guerra: la serenità del fronte interno aveva un effetto determinante sulla capacità
degli eserciti di proseguire la lotta e, conseguentemente, sull'esito stesso della guerra. E non solo
perché risorse sempre nuove dovevano rimpiazzare i contingenti militari, ma anche perché un
conflitto di queste dimensioni implicava sofferenze e sacrifici tali per le famiglie dei soldati da
indurle a non abbandonare il campo di battaglia.
Riprendendo la definizione di “morale”, inteso come volontà di proseguire lo sforzo bellico da parte
di militari e civili, è possibile affermare che sarà proprio l'azione congiunta di questi due fronti a
condizionare l'esito della guerra, destinata a cessare nel momento in cui una delle due parti avesse
imposto la propria volontà sul morale dell'altra, mostrando l'inutilità di ulteriori sacrifici, in vista di
una vittoria ormai perduta. Per quanto apparentemente scontata, questa tesi ha avuto un peso non
irrilevante nella formulazione di interpretazioni errate riguardanti le cause che hanno determinato la
vittoria degli Alleati e la sconfitta delle Potenze centrali. Nel 1918 la guerra finì allorché sia il
morale dell'esercito, sia quello dei civili tedeschi crollarono, poiché su entrambi i fronti era emersa
chiaramente l'impossibilità della vittoria6. Ma l'evidenza di tale interazione verrà deliberatamente
offuscata dalla tesi di Hitler, secondo la quale i soldati tedeschi avevano dovuto arrendersi perché
traditi da codardi del fronte interno – la leggenda della pugnalata alle spalle7 –. La teoria di Hitler
invertiva di fatto i termini della realtà: una pugnalata, in effetti, era stata sferrata, ma dagli alti
comandi militari tedeschi, che prima avevano trascinato il paese in una guerra perduta in partenza e
poi si erano abilmente scrollati di dosso ogni responsabilità del disastro. Ma l'asserzione di Hitler
sull'esistenza del rapporto tra fronte di guerra e fronte interno metteva in luce un aspetto della
guerra totale molto importante, non solo per il conflitto del 1914-18, ma anche per i successivi. Una
delle lezioni che i nazisti trassero dalla Grande guerra riguardava proprio tale legame: minare il
benessere materiale della popolazione civile avrebbe significato compromettere tutto lo sforzo
bellico. Per tale ragione, nella Seconda guerra mondiale i nazisti fecero in modo di garantire un
livello di vita relativamente alto agli “ariani”, facendo pesare le privazioni unicamente sulle fasce
dei cosiddetti “subumani” [Untermenschen ]: slavi, prigionieri politici, zingari ed ebrei8. Per i
nazisti, gli ariani avevano diritto a un minimo standard di vita, migliore di quello garantito nella
guerra del 1914-18, quando la razione ufficiale era insufficiente a sostentare chiunque. Durante la
Prima guerra mondiale, per evitare la morte per fame, l'intera popolazione tedesca doveva infatti
infrangere la legge, ricorrendo al mercato nero, con la conseguenza di gravi tensioni sociali9.
Rispetto alle Potenze centrali, le nazioni belligeranti rette da sistemi democratici furono più
efficienti nella gestione della vicenda bellica, perché capirono l'importanza del consenso popolare.
Partendo da una situazione di grande vantaggio per l'estesa disponibilità di beni e servizi essenziali,
gli Alleati attribuirono alla distribuzione un valore altrettanto importante, in quanto derivante da una
chiara scelta politica che riguardava la selezione dei destinatari dei beni. La tipologia di governo
contribuì in modo rilevante a determinare l'efficienza bellica degli Alleati, mentre creò ostacoli di
notevole entità ai tedeschi. Secondo la mia tesi, tale differenza fu soprattutto evidente nel fronte
interno e operava attraverso la preesistenza di ciò che l'economista Amartya Sen definisce sistema
di “attribuzioni”, ossia un insieme di norme giuridiche ed etiche che regolano le reti di
distribuzione10. A Parigi e a Londra i diritti dei cittadini – cioè il diritto a un livello minimo di
sussistenza – contribuirono a preservare la comunità imponendo un equilibrio tra la sfera civile e
quella militare nella distribuzione dei beni e dei servizi necessari. A Berlino, dove l'ordine delle
priorità era diverso, l'economia in gran parte finalizzata a sostenere l'apparato militare finì per
distorcere il delicato sistema economico interno. Sembra quindi lecito affermare che la capacità di
adattamento e le migliori condizioni di vita esistenti nei paesi dell'Intesa fossero in parte il riflesso
di un sistema di distribuzione più equo e più efficiente rispetto a quello nemico. In Gran Bretagna
come in Francia, i civili ricevevano una maggior quantità di beni, sia perché la disponibilità era
maggiore, sia perché la loro quota di reddito nazionale era stata preservata, nonostante la crescente
richiesta di uomini e risorse da parte dei vertici militari. I tedeschi trascurarono tale esigenza di
equilibrio e crearono il primo complesso militare-industriale della storia, la cui incomparabile
efficienza nell'attività bellica si sarebbe tradotta in un disastro di dimensioni incontenibili.
Il punto è semplice. In Germania, la struttura fondamentale della vita quotidiana – dal lavoro, ai
salari, ai modelli di consumo – era maggiormente compromessa rispetto alle controparti occidentali.
I fattori che determinarono tale divario vanno ricercati soprattutto nel campo delle relazioni sociali e
nel diverso significato attribuito alla cittadinanza. Da tale sistema di valori derivava il diverso
atteggiamento nel privilegiare le esigenze dell'una o dell'altra sfera, quella civile e quella militare. Il
contrasto divenne manifesto soprattutto nella seconda fase bellica, allorché in Germania
Hindenburg e Ludendorff giunsero al vertice del potere sia nelle forze armate sia nella società
tedesca nel 1916, mentre gli Alleati stavano varando le nuove strutture economiche sia sul piano
nazionale sia su quello internazionale. In definitiva, le differenze fra le attribuzioni di Parigi e
Londra da un lato e Berlino dall'altro forniscono una sorta di esemplificazione delle ben più ardue
prove di carattere politico ed economico imposte dalla guerra alle potenze coinvolte. Prove che
misero in evidenza il diverso approccio verso la cittadinanza rispetto al diritto della popolazione a
una quantità minima di beni e servizi necessari per la conduzione della vita quotidiana. Il governo
di Guglielmo II in Germania non superò la prova, gli Alleati, nel complesso, ci riuscirono.
Quali furono le motivazioni alla base di tale successo? La questione può essere affrontata da due
punti di vista. Il primo prende in considerazione due elementi: la disponibilità complessiva delle
risorse e il controllo dei beni provenienti dalle colonie. È evidente che in un contesto in cui
maggiori sono le privazioni, tanto più aumenta la pressione sui sistemi amministrativi già logori.
Dopo il 1915, gli Alleati raramente si trovarono in condizioni critiche di restrizioni materiali, e
anche in tali occasioni, come nel caso della penuria di carbone, la reazione degli amministratori a
livello nazionale o interalleato fece sì che le scorte fossero messe a disposizione e utilizzate in
comune. In questo contesto è facile capire cosa poteva rappresentare per il benessere dei civili
francesi e inglesi la possibilità di attingere alle risorse coloniali e, per contro, il dramma dei civili
tedeschi di fronte all'assenza di tali scorte.
Il secondo approccio ricalca il metodo d'analisi seguito da Sen, in base al quale è più corretto
esaminare le crisi definendo il tenore di vita non attraverso il carico aggiuntivo di pesi assegnati a
un paniere di beni di consumo, bensì tramite la valutazione del criterio con cui gli apparati sociali e
politici forniscono a ciascun individuo la possibilità di affrontare la vita quotidiana attraverso un
insieme di “capacità e funzionamenti”11. Da questo punto di vista già nel 1914 l'apparato
governativo tedesco aveva una struttura completamente diversa rispetto a quella della Gran
Bretagna e della Francia, e con l'ascesa di Hindenburg e Ludendorff nel 1916 il divario si allargò
ulteriormente. La precedenza assoluta riservata al rifornimento delle forze armate generò
conseguenze sostanziali per la popolazione tedesca. Mentre gli Alleati, in effetti, raggiunsero un
equilibrio, ciò chiaramente non avvenne per le Potenze centrali, e per la Germania in particolare.
Ineguaglianza ed equità furono altri aspetti che influirono sul morale in Germania12. A Parigi e a
Londra, i governanti locali e nazionali si dimostrarono in grado di organizzare, con equità maggiore
rispetto a Berlino, la distribuzione dei beni e dei servizi disponibili, e quindi evitarono che si
ingenerasse quell'atmosfera di sospetto e rancore, colpevole di aver avvelenato la vita della società
tedesca nella fase conclusiva del conflitto. Le autorità civili tedesche, invece, dimostrandosi
incapaci di assicurare quanto meno una parvenza di giustizia nel criterio di distribuzione, furono i
primi rappresentanti del potere che persero la fiducia della popolazione urbana.
La grande offensiva tedesca, iniziata nel marzo del 1918, e il mito dell'invincibilità dell'esercito,
erano riusciti a tacitare lo scontento e le voci di dissenso; ma con l'arrivo dell'estate, allorché tutti si
resero conto che la guerra non poteva essere vinta, quelle voci di scontento tornarono a levarsi
sempre più alte. A quel punto la frattura nella società berlinese non era più recuperabile: migliaia di
persone vagavano per la città alla ricerca di un po' di cibo o di combustibile per sopravvivere,
aspettando ansiosamente notizie dal fronte. E quando le notizie arrivarono fu la fine. Svanita anche
l'ultima speranza di vittoria, non restava più nulla a sostenere un regime che era fallito letteralmente
su tutti i fronti : su quello interno, dove non aveva saputo distribuire neppure i viveri di prima
necessità; su quello di guerra, dove non aveva saputo ottenere la vittoria promessa.
Ci sembra opportuno accennare a un altro aspetto che influì sul dispiegamento della guerra totale. Si
tratta del blocco economico attuato dagli Alleati sin dal primo giorno di guerra. Imposto
inizialmente per impedire l'approvvigionamento dell'esercito tedesco, con il passare del tempo
assunse l'obiettivo di ridurre tutta la popolazione civile della Germania e dell'Austria-Ungheria in
uno stato di prostrazione fisica tale da spingerla a esigere la cessazione del conflitto. In tal senso, si
deve quindi parlare ancora una volta di condotta bellica totale. Non si trattava certo di una strategia
nuova, anzi, sin dall'antichità gli assedi avevano avuto questo scopo. Nuova nella Prima guerra
mondiale fu la dimensione del fenomeno, sia per le contromisure tedesche adottate per forzare il
blocco, sia per la durata del provvedimento. Più il blocco alleato si stringeva, più violenta era la
risposta della flotta sottomarina nemica, che sferrava attacchi dapprima alle navi alleate, poi anche a
quelle di stati neutrali. Uno degli episodi più gravi fu, nel 1915, l'affondamento del transatlantico
britannico Lusitania al largo della costa irlandese. Si trattò di un crimine di guerra, come
pretendevano le forze alleate, oppure nelle stive della nave erano state veramente nascoste, dal
Ministero inglese delle munizioni, armi il cui peso la fece colare a picco in pochi minuti? Non ci è
dato saperlo, ma sembra lecito supporre che la verità non stesse da una parte sola.
Anche la continuazione del blocco dopo l'armistizio del 1918 ebbe ripercussioni notevoli. Quando
la Germania capitolò sul campo di battaglia e la sua popolazione – malgrado le affermazioni dei
politici tedeschi – non poteva in alcun modo costituire una minaccia, Francia e Inghilterra
protrassero comunque il provvedimento fino al 28 giugno dell'anno successivo, spinte quasi
unicamente dal desiderio di punire la popolazione nemica per la follia dei suoi governanti. Gli
Alleati sapevano bene che infierire sui civili dopo un armistizio significava commettere un crimine
di guerra, ma ebbero il pieno appoggio dell'opinione pubblica. Se l'esercito era la punta di diamante
della nazione in guerra, e questa punta non era più in grado di colpire, allora, in condizioni di guerra
totale, la nazione, cioè anche le donne, i bambini, gli anziani, doveva essere sottoposta a un castigo
collettivo e a privazioni supplementari. Per certo, i setti mesi di proroga del blocco, dall'11
novembre 1918 al 28 giugno 1919, costarono agli Alleati la perdita di gran parte della superiorità
morale che detenevano sulla controparte, ma a nessuno importava: la brutalizzazione della guerra
comportava che anche i civili ne pagassero a lungo le atroci conseguenze.
0001000070 ‣ La mobilitazione dell'immaginario collettivo . Si è insistito finora sulle
caratteristiche strutturali della guerra totale e sull'importante funzione svolta in essa dal
mantenimento del morale. La guerra totale non può essere compresa senza esplorarne la storia
culturale e la capacità di far leva sulla devozione alla patria e sui pregiudizi della popolazione non
combattente13. Tali aspetti saranno approfonditi qui di seguito.
Il massacro su vasta scala esigeva una giustificazione. Per mantenere inalterato l'impegno nello
sforzo bellico sul fronte interno, infatti, ogni nazione belligerante organizzò elaborate campagne
culturali. Ma le sempre più numerose iniziative disposte dagli enti governativi erano meno
importanti della tendenza affermatasi nella società civile a promuovere campagne imperniate
essenzialmente su due obiettivi: temprare la volontà dei civili di andare avanti e smorzare il minimo
accenno di dissenso, rendendo così impossibile concepire alternative diverse dalla vittoria o dalla
sconfitta totale. Questo genere di propaganda tutto sommato funzionava. I sentimenti sfavorevoli
alla guerra si intensificarono con il perdurare del conflitto, ma, a eccezione del caso della Russia, il
dissenso non fu in grado di abbreviare anche di poco la durata dello scontro armato. In questa
importante mobilitazione culturale, la propaganda di stato aveva solo un ruolo limitato, consistente
nel verificare che i messaggi provenienti dal basso promuovessero con efficacia la necessità di
continuare a combattere. Il Grande Fratello non ebbe bisogno di generare consensi negli anni tra il
1914 e il 1918; al contrario, la Grande guerra mise in evidenza un'inquietante verità comune a tutti i
paesi coinvolti: l'inclinazione naturale della società a generare al proprio interno l'impegno di
proseguire una guerra di inusitata atrocità.
Senza dubbio, le élite politiche e sociali tentarono di manipolare l'opinione pubblica, non
disdegnando di far ricorso anche alla censura e alla detenzione, ma in realtà si trattò di interventi
senza grande impatto: lo sforzo per mobilitare l'immaginazione proveniva quasi esclusivamente dal
basso14. Tale sforzo aveva un carattere multiforme e decentralizzato. Fra il 1916 e il 1917 si
assistette a una nuova mobilitazione spontanea in cui veniva espressa la volontà popolare di
proseguire le ostilità, senza che fosse necessario l'intervento del governo o di altre organizzazioni.
Specialmente dopo le grandi battaglie di Verdun e della Somme, nel 1916, il controllo pressoché
completo delle iniziative fu assunto dal settore privato. Prodotti culturali di gusto kitsch, thriller e
varie trasmissioni d'intrattenimento popolare diffondevano messaggi dal forte impatto sulle masse,
in cui si esaltavano le virtù nazionali e la malignità dell'avversario15. Notevole sviluppo conobbero
il music-hall e l'industria del grammofono, che proponevano atmosfere sommesse o esaltanti a una
popolazione sempre più stanca e provata16.
Anche gli artisti d'avanguardia ebbero un ruolo di rilievo nello stimolare l'anelito alla vittoria, ruolo
che può apparire alquanto sorprendente, considerato il carattere cosmopolita dell'arte nell'anteguerra
e la tendenza tipica dei rappresentanti di quel mondo ad assumere atteggiamenti anticonvenzionali
che sfidavano le idee e le sensibilità borghesi. La Grande guerra, però, aveva impresso una forte
connotazione nazionalista ai movimenti artistici, i cui esponenti, uniti nella ricerca relativa
all'esplorazione di forme, colori, tonalità e immagini, si trovarono divisi dopo il 1914 su fronti
opposti. Per illustrare lo sviluppo del patriottismo d'avanguardia e i problemi che si trovò a
fronteggiare ricorriamo a due insoliti esempi di mobilitazione dell'immaginario: il balletto Parade,
nato dalla collaborazione di artisti come Cocteau, Picasso, Satie, Massine e Diaghilev, e il film
J'accuse di Abel Gance. Queste due opere avevano in comune il tema patriottico ed entrambe, sia
pur in modo diverso, finirono per trascendere il loro intento iniziale.
L'ispiratore di Parade fu Jean Cocteau, curatore insieme a Paul Iribe della rivista “Le Mot” uscita
per la prima volta nel novembre del 1914 con il proposito di difendere “la pura tradizione francese”
dal “ciarpame di Monaco” e Berlino, e di ristabilire il “buon senso, l'equilibrio e l'ordine
intellettuale”. All'entrata in guerra dell'Italia, la copertina di “Le Mot” uscì con il profilo di Dante e
un titolo sintetico: “Dante avec nous”. In sintesi, nel conflitto delle culture il tradizionalismo
patriottico era comunemente praticato e perfino l'arte d'avanguardia aveva perso il suo spirito
internazionale, critico, indipendente e dirompente, per assumere il nuovo ruolo di promotrice dei
valori nazionali contrapposti ai volgari gusti tedeschi. Due anni più tardi, con Parade, Cocteau
esaltò la supremazia culturale degli Alleati attraverso un'altra forma d'arte. L'allestimento ricalcava
uno spettacolo forain, con un baraccone da fiera, imbonitori e passerelle smontabili sulle quali i
ballerini rappresentavano la parade, cioè la sfilata di giocolieri e funamboli che si esibivano prima
dello spettacolo per attirare la folla nel circo. La messa in scena del balletto rappresentò
un'occasione irripetibile: amalgamare il cubismo di Picasso, l'arte dei Ballets Russes e la musica di
Erik Satie17. Cocteau era l'indispensabile elemento di mediazione fra gli artisti di forte
temperamento impegnati nella realizzazione dello spettacolo: Léon Bakst per i costumi, Léonide
Massine per la coreografia, Satie per la musica, con una partitura dalla velata ironia che alludeva al
ragtime, ma in uno stile “typiquement français sans être debussyste”18. E infine Picasso per le
scene, i costumi e il sipario.
Il sipario presentava i temi tipici del periodo di collaborazione di Picasso con la compagnia dei
Ballets Russes in Italia nel 1916. Sullo sfondo si stagliava il Vesuvio; a destra erano ritratti due
arlecchini ispirati alla tradizione della commedia dell'arte, dei contadini in abiti popolari
tradizionali, un marinaio italiano, un chitarrista spagnolo, un uomo di colore e un cane; a sinistra,
una scena da circo, con un'amazzone che allunga la mano per prendere una scimmietta e un cavallo
alato che allatta il suo puledro. Quando il sipario si alzò, il 18 maggio 1917 al Théâtre du Châtelet
di Parigi, il pubblico si trovò di fronte a una scena desueta e sconcertante: il profilo di una città in
stile cubista, con prospettive assolutamente anomale tracciate nei caratteristici colori grigio e verde.
Sul palco i ballerini sfilavano interpretando un prestigiatore cinese (Léonide Massine), una ragazza
americana (Maria Shabelska) e due acrobati (Lydia Lopukhova e Nicolas Zverev), ai quali si
affiancavano due manager, impresari dello spettacolo, con particolari costumi di ispirazione cubista
realizzati come costruzioni in rilievo, che li rendevano alti circa due metri e mezzo. Il manager
francese trasportava il suo paesaggio cubista su un abito da cerimonia; quello americano, in
cappello a tuba, aveva sulle spalle i grattacieli di Manhattan, come una sorta di manifesto
pubblicitario vivente. In origine avrebbe dovuto esserci anche un terzo manager, a cavallo, ma nel
corso delle prove venne eliminato, lasciando solo il cavallo rampante, interpretato da due uomini
che si muovevano sotto un unico costume.
La reazione del pubblico fu un tumulto. Le urla erano talmente alte, racconterà poi Diaghilev, da far
pensare che fosse caduto il lampadario. All'entrata in scena dei ballerini, l'unità culturale della
nazione vacillò. La stridente visione di ciò che essi erano in realtà, “pezzi ambulanti di arte
cubista”, riaccese con imprevedibile violenza la vecchia diatriba tra arte d'avanguardia e gusto
convenzionale. Il giorno seguente, le critiche furono tiepide o negative. Cocteau si era spinto troppo
avanti: una celebrazione della causa alleata si era trasformata in una “cause célèbre” con commenti
accesi, risposte astiose e insulti di ogni genere. A una critica alla sua musica Satie rispose:
Monsieur et cher ami,
Vous êtes un cul, mais un cul sans musique.
Erik Satie19.
La spinta conservatrice della cultura bellica non lasciava spazio alla sperimentazione, specialmente
in forme che si scostavano così radicalmente dalle convenzioni romantiche del balletto. In un certo
senso, Parade era una metafora perfetta della propaganda bellica. E nella figura dell'imbonitore, che
cerca di attrarre il pubblico nel tendone, si integravano l'aspetto commerciale e l'aspetto concreto
della propaganda. Il messaggio in favore della guerra e del sistema di vita proprio di ogni nazione
contendente doveva assolutamente essere venduto; per farlo, si mise in atto la campagna più
elaborata e a più larga diffusione mai realizzata prima. Tanto il soggetto di Cocteau quanto il sipario
di Picasso attingevano alla cultura popolare – la tradizione della commedia dell'arte – e ne
utilizzavano le immagini e il significato evocativo per celebrare la causa degli Alleati. Anche gli
Stati Uniti, nonostante fossero appena entrati in guerra, trovavano posto nella rappresentazione. Più
oscuro è il simbolismo impiegato per le altre potenze alleate, e in realtà risulta alquanto difficile
capire se la Gran Bretagna (o la Russia) fossero in qualche modo comprese in questa immagine di
gusto latino. A prescindere dalle licenze artistiche, ciò che Parade trasmetteva era il senso della
guerra come teatro, carnevale di sangue, evento culturale e militare al contempo.
Il cinema creò analoghe rappresentazioni del conflitto fra culture. Anche in questo caso, l'aspetto
commerciale nella propaganda proveniente dal basso ebbe un ruolo importante, benché la censura
ponesse maggiori limitazioni alla serie di immagini che potevano essere mostrate al pubblico. Ma
talvolta i film finivano per acquisire una vita autonoma, presentando immagini altrettanto scioccanti
di quelle di Parade. Uno di questi fu appunto J'accuse di Abel Gance, girato nel 1918 e uscito dopo
l'armistizio. Il film si apriva sul tono della rivendicazione patriottica, ma si spingeva verso
l'esplorazione del regno mitico della “generazione perduta”.
Nato nel 1889 a Parigi, Gance aveva iniziato a farsi un nome già nell'anteguerra nel mondo del
teatro, soprattutto con il soggetto della Vittoria di Samotracia, messa in scena da Sarah Bernardt.
Riformato all'inizio del conflitto per motivi di salute, iniziò a occuparsi di cinema, vendendo
sceneggiature alle principali case di produzione cinematografica francesi, Gaumont e Pathé. In
seguito, fra il 1914 e il 1916, intraprese anche la carriera di attore e di regista. Era affascinato
dall'effetto deformante prodotto da specchi e lenti, in grado di creare immagini che avrebbe poi
definito “visioni soggettive”. Il film J'accuse, finanziato in parte dalla Pathé, ricevette
l'approvazione per l'inizio delle riprese da parte della sezione cinematografica dell'esercito, per la
quale Gance lavorava dal 1917. Il titolo, un chiaro riferimento alle atrocità commesse dai tedeschi e
alla loro responsabilità nella guerra, rivela l'intento di stimolare lo spirito patriottico.
La pellicola venne proiettata per la prima volta alcuni giorni dopo l'armistizio, davanti a un
pubblico composto da rappresentanti delle varie forze alleate, all'Hôtel Dufayel, sugli Champs
Elysées. La prima proiezione pubblica si tenne nel marzo del 1919, al Gaumont Palace; nel maggio
del 1920 seguì la prima a Londra e, a distanza di un anno, quella di New York, nel corso della quale
Gance dedicò il film al presidente Harding. In America conobbe D. W. Griffith, tramite il quale il
film sarebbe poi stato acquistato dalla United Artists: il successo commerciale andò al di là di ogni
aspettativa, è non è difficile comprenderne le ragioni. Convenzionale nella struttura, la vicenda si
imperniava su un classico triangolo amoroso, ambientato in un villaggio del Midi. Il film si apre con
una farandole, una danza locale, per poi introdurre il personaggio di Edith Laurin (interpretata da
Maryse Dauvray), la moglie infelice di François (Romuald Joubé), individuo brutale, con un'insana
passione per la caccia, i cani e il sangue. L'assai più raffinato Jean Diaz (Severin Mars), un poeta, è
attratto da Edith. La donna trova consolazione nella sua compagnia e nelle sue poesie
magniloquenti. Uno dei componimenti, intitolato Les pacifiques, dipinge con toni forti i sentimenti
idilliaci che la natura e la stessa Edith gli ispirano. Mentre Jean è intento a leggere a Edith le sue
poesie, François, che spia la scena, punta il fucile su un passero e lo ammazza. La violenza
dell'uomo viene messa in evidenza da Gance in un'altra insolita scena: lo stupro della moglie e la
sua disperata sottomissione sessuale.
Allo scoppio della guerra, François viene chiamato subito alle armi, mentre a Diaz restano alcune
settimane prima di raggiungere la sua unità. Per proteggere l'onore, François costringe la moglie a
raggiungere la sua famiglia, a est. Seguono poi notizie terribili: i tedeschi hanno occupato il
villaggio dove è andata a vivere e un soldato tedesco la violenta. A tale notizia, Diaz scaglia sui
tedeschi il suo J'accuse e va immediatamente ad arruolarsi. Ultimato il corso da ufficiale, viene
assegnato alla stessa unità in cui il rivale presta servizio come soldato semplice. I due tuttavia si
riconciliano quando Diaz si offre per una missione suicida al posto del rivale. Fra loro viene a
crearsi un legame sempre più forte che porterà entrambi a rivelare il proprio amore per Edith.
Fino a questo punto la vicenda segue gli elementi tipici del melodramma sentimentale. Ciò che
rende J'accuse un film assolutamente inconsueto è il finale. Nell'ultima scena Diaz, l'eroe, comincia
a dare segni di squilibrio, scappa dall'ospedale e torna al villaggio. Qui riunisce gli abitanti e
racconta un sogno, che ha inizio in un cimitero di guerra con le croci di legno piantate
obliquamente. Nelle sequenze successive, appare sullo sfondo una grande nube nera e una serie di
figure umane simili a fantasmi emergono magicamente dal terreno. Con i corpi avvolti in bende
lacere, alcuni zoppicano, altri camminano tendendo avanti le braccia come i ciechi, altri ancora si
muovono barcollando simili al mostro di Frankenstein. Lasciano il campo di battaglia e,
percorrendo strade di campagna, attraversano la Francia per tornare ai rispettivi villaggi. L'obiettivo
della marcia è vedere se il loro sacrificio è stato vano: troveranno la meschinità e la grettezza della
vita civile, l'infedeltà delle mogli e la venalità degli abitanti del villaggio. La vista dei caduti
riempie questi ultimi di terrore e li induce a condurre una vita dignitosa. I morti tornano alle loro
tombe: la loro missione, adesso, è compiuta. Dopo aver raccontato il sogno, il poeta, ormai
completamente pazzo, comincia a urlare accuse al sole, colpevole di rimanere imperturbabile
mentre la guerra continua. Alla fine il poeta muore.
La sequenza dei morti che risorgono dalle tombe è una delle scene più grandiose degli esordi della
storia del cinema. La sua forza è resa ancora più pregnante se si considera che la maggior parte
degli uomini che apparivano sullo schermo erano veri soldati francesi, prestati a Gance dall'esercito
per recitare nel film. L'assistente alla regia era Blaise Cendrars, che aveva perso il braccio destro
combattendo nella Champagne con la divisione marocchina nel settembre del 1915. Mentre
Cendrars sopravvisse alla guerra, molti dei soldati che avevano interpretato la parte dei morti in
J'accuse tornarono al fronte negli ultimi mesi del conflitto e furono uccisi. Alcuni di quelli che si
vedono recitare la parte dei morti poco dopo morirono effettivamente. Nell'episodio del “ritorno dei
morti”, Gance seppe dare espressione a un surrealismo visionario che si manifestava attraverso un
linguaggio romantico con toni inquietanti. Il film J'accuse cominciava come una normale pellicola
di propaganda imperniata sulla nobiltà dello sforzo bellico francese contrapposta alla barbarie
germanica. Ma avvalendosi dell'assistenza di Blaise Cendrars, che aveva conosciuto il carattere
abominevole della guerra, Gance elevò il film da una pietà convenzionale a toni trascendentali.
La cristologia del finale del film J'accuse non è velata, ma stringente. Porta il segno del
romanticismo di un uomo che, stando a un critico dell'epoca, pretendeva di essere
contemporaneamente Victor Hugo, Henri Barbusse e D. W. Griffith20. Se si aggiunge a ciò un tocco
di Nuovo Testamento, è subito chiaro da dove Gance abbia tratto le immagini che fecero innalzare
il suo messaggio dalla dimensione del melodramma a quella del mito. Gance non era contrario alla
guerra in senso assoluto, ma alla tendenza, chiaramente presente in alcuni giornalisti e politici, a
dimenticare le sofferenze sopportate dai soldati. Un messaggio sicuramente pericoloso da
diffondere, in quanto poneva il tema spinoso dello sfruttamento della guerra da parte di
connazionali senza scrupoli. Questo tema è estremamente frequente nei giornali e nelle lettere dei
soldati21. Tradotta in forma cinematografica, un'accusa di questa natura suscitava un dubbio
terribile: forse i sacrifici dei soldati al fronte erano stati inutili, non perché non avessero condotto
alla vittoria, ma per la mancanza di senso morale dei popoli per cui si combatteva. Gance seppe
catturare il senso di un debito insoluto e insolubile che i vivi avevano nei confronti dei caduti22: è
per questo che la conclusione del film assume un carattere pregnante, del tutto differente dal tono
lacrimevole dell'inizio. In effetti, Gance si era lanciato in un tipo di impresa allorché era in pieno
sviluppo la propaganda a favore della guerra, mentre si era trovato coinvolto in una ben diversa
situazione: evocare la presenza della morte nello scenario bellico e post-bellico. Il suo romanticismo
era semplicemente andato fuori controllo.
È importante rilevare che solo occasionalmente la visione del regista riesce a superare la sua
magniloquenza. Proprio in questo, probabilmente, risiedeva la sua forza nascosta. Il messaggio
raggiungeva il pubblico attraverso una combinazione di “vecchio” e “nuovo”. Cocteau, invece, non
era riuscito a trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione e, considerando la forma
espressiva adottata, forse nessuno avrebbe potuto riuscirci. Gance si impegnò nella sperimentazione
per giungere a raccontare da un lato comuni storie d'amore e di patriottismo e, dall'altro, immagini
trascendentali di sogni, resurrezione e redenzione. D'altra parte, mentre J'accuse è un'opera d'arte
superata, Parade resta e resterà ancora nella memoria. Il risultato ottenuto all'epoca da Gance,
comunque, non deve essere sottovalutato poiché il regista riuscì a immergere il pubblico in un
universo familiare per poi trasportarlo in un mondo lontano e astratto, quello magico delle trincee e
quello mitico dei morti. In entrambi gli esempi presentati, si può osservare come il coinvolgimento
dell'immaginazione ai fini bellici abbia preso direzioni inattese. Nessuna autorità militare o politica
aveva condizionato Cocteau o Gance in qualche modo. Furono loro a concepire forme d'arte che si
adeguavano a una guerra di una modernità senza precedenti. Cocteau e Picasso si servirono del
cubismo per convogliare messaggi radicati nella cultura ottocentesca e nella commedia dell'arte.
Analogamente, Gance ricorse al mezzo più moderno dell'epoca – il cinema – per trasmettere un
messaggio antico sull'amore, il sacrificio, la redenzione. In altri termini, nella storia culturale
dell'epoca bellica si individua una tendenza a rivalutare e a imprimere nuova vita alle forme
tradizionali, in un conflitto di stupefacente modernità. Ben lungi dal creare le premesse di una
rivoluzione culturale, la Grande guerra rappresentò essenzialmente un momento
controrivoluzionario, il tempo in cui “il vecchio” si disintegrava per conferire senso a un genere di
guerra che il mondo non aveva mai visto prima23.
0001000070 ‣ La creazione di una cultura dell'odio e il genocidio degli armeni . La demonizzazione
del nemico, in un contesto di guerra totale, si rivelava indispensabile a una mobilitazione culturale
di massa. Si trattava di una tattica già utilizzata in passato (si pensi alle guerre di religione o alla
propaganda della Riforma e della Controriforma). Fu però l'aggiunta di questo fattore agli altri
elementi del quadro generale a cambiare radicalmente il modo di concepire la guerra e a dare
origine a uno scenario assolutamente nuovo e imprevisto, che divenne terreno fertile per quella che
Peter Gay ha definito la “coltivazione dell'odio”24. Questo sforzo creò il contesto per crimini di
guerra di una portata e di un genere fino ad allora inimmaginabili: mi riferisco al genocidio come
una caratteristica peculiare della guerra totale.
È importante sottolineare la natura contingente di questa tesi; infatti, sebbene non tutte le nazioni
coinvolte in guerre totali abbiano fatto ricorso al genocidio, la guerra totale ha comunque creato le
condizioni che lo hanno reso possibile. Il trattamento brutale di milioni di persone ha contribuito a
innalzare radicalmente la soglia di tolleranza alla violenza di alcune civiltà impegnate in conflitti
armati. La guerra totale agisce come un virus ed è in grado di infettare numerose popolazioni. La
maggior parte resta immune al contagio25 grazie al proprio ordinamento giuridico, all'educazione, a
credenze religiose, a tradizioni militari o a particolari tipi di usanze o altre convinzioni e pratiche.
Altre, non altrettanto fortunate, sono sprovviste di anticorpi (se si vuole utilizzare la stessa
metafora) e cedono all'infezione che causa quindi grandi sofferenze ai civili inermi. Il genocidio
può prendere forma in presenza di tali condizioni e in un contesto di guerra totale, come avvenne
nella Prima guerra mondiale.
Questo preambolo è necessario per comprendere quali siano state le cause che portarono al
genocidio perpetrato in Turchia nel 1915, nel corso della Grande guerra. Per decenni le autorità
turche hanno negato ogni accusa, ma i dettagli di quella serie di sconcertanti crimini di guerra sono
ben noti. Ciò che invece non tutti hanno colto è la loro natura rivoluzionaria26. Il 25 aprile 1915,
alcune ore prima dell'alba, gli Alleati sbarcarono a Gallipoli, nel tentativo temerario, destinato al
fallimento, di eliminare la Turchia dallo scacchiere della guerra. Quella stessa notte le autorità
turche diedero inizio alla repressione dei nemici interni: le comunità armene, formate da circa due
milioni di individui e concentrate nel nord-est dell'Anatolia (sul confine con i territori sovietici), ma
disseminate anche altrove in tutto l'Impero ottomano. Quel 25 aprile, con la complicità del buio,
diverse centinaia di armeni (tra i quali intellettuali, giornalisti, liberi professionisti, uomini di chiesa
e d'affari) furono sequestrati e uccisi. Gran parte dei notabili della comunità perse la vita quella
notte. Nei due anni successivi, la popolazione armena dell'Impero ottomano venne sradicata con la
forza e spinta verso le regioni desertiche della Mesopotamia. In questo processo morirono tra
500.000 e un milione di armeni inermi, uccisi o stremati dalle intemperie e dalle malattie contratte
nei campi di prigionia o nel deserto siriano. Le statistiche relative alle atrocità di qualunque natura
non sono mai precise o facilmente verificabili ma, anche se si ipotizza una stima per difetto sulla
base della scala e delle dimensioni dei luoghi di deportazione, è possibile affermare che le perdite
umane ammontarono al 50% dell'intera popolazione precedente al 1914. Nella fase centrale della
guerra, gran parte di una comunità prospera e ben radicata sul territorio, con caratteristiche culturali
e religiose peculiari, venne spazzata via; furono condannati a morte a causa della loro identità e
origine. In altre parole, a causa della loro etnia furono vittime di un innegabile crimine di guerra che
rappresentò un chiaro precedente dello sterminio nazista degli ebrei. Come poté avvenire questo
massacro?
Le tensioni tra armeni cristiani e turchi musulmani risalivano a ben prima della Rivoluzione turca
del 1908. Nel 1894 e nel 1896 i tentativi separatisti degli armeni erano stati soffocati nel sangue.
Dopo la rivoluzione del 1908 il nazionalismo turco, promosso dai Giovani turchi, mutò la natura
della rivalità tra le due comunità, gettando sugli armeni del territorio un'ombra ancora più cupa di
avversione e minaccia. Lo scoppio della guerra nel 1914 sembrò giustificare i timori della Turchia,
poiché alcune unità armene servivano al fianco delle forze russe nella regione del Caucaso e
parevano costituire una minaccia come quinta colonna dietro le linee turche. Il 20 aprile 1915, dopo
un periodo di sporadici scontri tra le due comunità, i turchi attaccarono gli armeni nella parte est
della città di Van, ma vennero respinti e persero sul campo 18 uomini. Questa “rivolta” servì da
pretesto per l'arresto notturno e l'uccisione di molte personalità di spicco della comunità armena
avvenuti quattro giorni dopo quell'episodio, ossia proprio nel giorno in cui la Turchia subiva il
tentativo di invasione da occidente. Il fallimento dello sbarco degli Alleati a Gallipoli diede il via,
nei mesi successivi, a una sequela di misure repressive contro i civili armeni. Se lo sbarco avesse
sortito esito positivo, portando a una rapida avanzata su Costantinopoli, la tragedia armena non
avrebbe mai avuto luogo. L'incapacità di ottenere una rapida vittoria condannò gli armeni all'esilio e
ad atroci sofferenze. Dopo Gallipoli il regime turco si trovò circondato su tutti i fronti. La decisione
di espellere gli armeni fu presa in questo clima di invasione e di grandi perdite tra le forze turche,
mentre erano impegnate sia a ovest (a Gallipoli), sia nel Caucaso contro le armate russe e armene.
Pare improbabile che il triumvirato turco formato da Taalat Pascià (ministro degli Interni), Enver
Pascià (ministro della Guerra) e Ahmed Gemal (ministro della Marina) abbia mai emesso
espressamente un ordine scritto per lo sterminio degli armeni. Non vi è dubbio che queste persone
furono i diretti responsabili delle deportazioni di massa, ma la sola deportazione – una strategia
antica nella Turchia del XIX secolo – non costituiva di per sé un genocidio, pur avendo causato la
morte di molti anziani, dei più deboli e degli infermi. Fu il contesto della guerra totale a trasformare
quel crimine di guerra in un genocidio vero e proprio: in brevissimo tempo la deportazione si
tramutò in uno sterminio di massa con abusi di ogni genere e la condanna alla fame di un intero
gruppo etnico, considerato potenzialmente pericoloso per un regime autoritario in stato di guerra.
Durante la Prima guerra mondiale la sobillazione fu una strategia universalmente adottata,
legittimata dal fatto che tutte le principali potenze coinvolte nel conflitto erano anche grandi imperi.
I tedeschi alimentarono il fuoco della ribellione in Irlanda e in Russia, nonché in Messico; gli
inglesi e i francesi fecero altrettanto nell'Impero austro-ungarico; i russi agirono invece sugli armeni
stanziati sul comune confine turco. Solo in Turchia, però, la minaccia di una ribellione portò allo
sterminio di centinaia di migliaia di “sovversivi” (uomini, donne e bambini). Quanto appena detto
fa intuire che lo spettro di una possibile rivolta in un impero multietnico in tempo di guerra non
fosse una ragione sufficiente a scatenare un genocidio, benché significasse più che mettere alla
prova i deboli legami esistenti all'interno delle compagini imperiali. Il genocidio fu invece scatenato
dalla guerra totale, un nuovo genere di conflitto che annullò completamente la distinzione tra
obiettivi militari e obiettivi civili, facendo della strategia del terrore un mezzo per sopprimere quelle
comunità interne sospettate di offrire al nemico un tacito supporto o un aiuto concreto.
L'idea di “guerra totale” non è nata in Turchia, ma in Occidente: le guerre napoleoniche in Spagna e
Russia coinvolsero sia civili sia forze di irregolari e la Guerra di secessione americana,
cinquant'anni dopo, portò a un'ulteriore radicalizzazione della violenza nei conflitti armati. L'8
settembre 1870 fu infatti un americano (il generale Philip Sheridan) e non un turco a confidare al
futuro cancelliere tedesco Otto von Bismarck che la “migliore strategia” in guerra
consiste in primo luogo nel colpire l'armata nemica il più duramente possibile, quindi nel causare ai
civili sofferenze così immani da costringerli a desiderare la pace e da imporre ai propri governi di
capitolare. Alle persone non dovevano rimanere che gli occhi per piangere le miserie della guerra27.
Le “persone” a cui si riferiva erano sì secessionisti, ma parlavano la medesima lingua, molte
condividevano la stessa religione e spesso erano addirittura legate da parentela. A cosa poteva
giungere la brutalità della guerra, se non era messa a freno neppure da simili legami culturali? Nel
1914, quando la Turchia entrò nel conflitto al fianco delle Potenze centrali, antiche tensioni etniche
si fusero con le nuove e letali dinamiche della guerra totale che fu scatenata contro i nemici interni a
opera di un esercito corrotto e privo di disciplina, determinando il massacro degli armeni. Nel corso
dei decenni erano stati compiuti diversi sforzi per ammodernare l'esercito turco. Già negli anni
Trenta dell'Ottocento, Helmuth von Moltke, divenuto in seguito capo di Stato Maggiore
dell'esercito prussiano e artefice della sconfitta delle armate francesi nel 1870, era stato inviato a
Costantinopoli con il compito di riformare le forze armate. Purtroppo il problema di fondo,
impossibile da eliminare nonostante i saggi consigli dell'alto comandante tedesco, era rappresentato
dalla diffusa corruzione all'interno dell'esercito, speculare a quella esistente nella società turca. Nel
1915 i soldati e gli irregolari erano ancora sottopagati e costretti ad approvvigionarsi con le proprie
forze, proprio come ai tempi in cui von Moltke aveva servito nell'esercito turco in Armenia e in
Egitto. I rifornimenti destinati alle forze armate erano venduti sul mercato nero per poi tornare agli
uffici governativi da dove erano partiti. Le unità turche, per sopravvivere, compivano scorribande e
razzie, ormai endemiche nel territorio accidentato della regione al confine con la Russia.
A partire dalla metà del 1915 questi gruppi d'assalto distrussero e depredarono numerosi villaggi e
città armene; banditi con l'uniforme turca e soldati sottopagati e malnutriti uccidevano restando
impuniti, maltrattavano gli armeni e li deportavano a sud verso campi di concentramento o zone di
confino incustodite in aree desolate del deserto della Mesopotamia.
Il massacro univa gli elementi peggiori del “vecchio” e del “nuovo”. È vero che nel 1915 l'Impero
ottomano combatteva per la propria sopravvivenza, ma la genesi delle deportazioni degli armeni
ebbe anche motivazioni ben più venali. La resistenza armata armena, che disponeva di forze esigue
ma agguerrite, fornì ai leader turchi una giustificazione di comodo per impadronirsi di proprietà,
terre e beni appartenenti alla comunità armena. Il crimine di cui si macchiarono inizialmente fu il
furto e la violenza su vasta scala, in maniera simile a quanto avvenuto nei primi anni Novanta del
secolo scorso nelle operazioni di “pulizia etnica” perpetrate dai serbo-bosniaci ai danni dei
musulmani e dei croati o in Ruanda dagli hutu ai danni dei tutsi. I turchi volevano effettivamente
liberarsi degli armeni, ma volevano anche impadronirsi delle loro ricchezze ed erano disposti a
uccidere, torturare e a far ricorso a ogni tipo di violenza pur di riuscirci. Le motivazioni avevano
radici antiche, ma il metodo era nuovo e agghiacciante: identificare un intero popolo come nemico
interno e deciderne semplicemente l'annientamento.
Questo crimine non era affatto ignorato. Vi furono numerosi testimoni della deportazione e del
massacro del popolo armeno. Johannes Lepsius, missionario tedesco in Turchia e direttore della
Deutsche Orient Mission e della Società armeno-tedesca, ben conscio di quello che stava
accadendo, compilò un rapporto dettagliato sulla situazione e indirizzò il suo resoconto a
personalità di spicco a Berlino, nella speranza che potessero in qualche modo adoperarsi per
fermare le uccisioni. La censura impedì però la divulgazione di una notizia tanto scomoda per
l'alleato della Germania. Le parole di Lepsius erano inequivocabili: nel rapporto riferiva che tre
quarti dei civili armeni erano stati spogliati dei loro averi e cacciati dalle loro case; inoltre se
rifiutavano di convertirsi all'Isla°m, venivano uccisi o deportati nel deserto. Solamente un settimo
della popolazione sfuggì alla deportazione. Lepsius indicava nei circoli politici vicini al Partito
Unione e Progresso i responsabili delle deportazioni, benché esse fossero autorizzate da un decreto
governativo. In diverse città i “circoli” dei Giovani turchi reclutavano gruppi di briganti e
delinquenti per “trasferire” i deportati fuori dalle città e rubare, violentare e uccidere quando era
opportuno.
Le testimonianze degli armeni sopravvissuti confermano il resoconto di Lepsius. A Bayburt
vivevano 17.000 armeni: nelle prime due settimane di giugno, circa settanta tra gli uomini più in
vista della comunità vennero imprigionati o portati sulle colline, probabilmente per essere fucilati,
mentre il vescovo armeno fu impiccato insieme ad altri sette notabili. Altri uomini che si rifiutarono
di lasciare Bayburt furono uccisi sul posto. Il resto della popolazione della città e dei villaggi
limitrofi venne diviso in tre gruppi e deportato. Sull'orrore di quel viaggio è rimasta la
testimonianza di una vedova. La donna fu deportata insieme alla figlia e ad altre 500 persone il 14
giugno 1915. Nel racconto emerge un dettaglio agghiacciante: il prefetto turco della città augurò
loro un “buon viaggio”. Il convoglio era scortato da quindici gendarmi, ma due ore dopo la partenza
venne assalito da briganti armati che, in combutta con le “guardie”, spogliarono gli armeni di tutti i
loro averi. Nella settimana seguente tutti i maschi di età superiore a 15 anni vennero percossi a
morte, mentre le donne giovani e i bambini furono sequestrati e condotti altrove. Col proseguire
della marcia, per strada si cominciarono a incontrare i corpi degli armeni partiti con i gruppi
precedenti. I deportati, spogliati di tutto e costretti a dormire all'aperto, si trovarono ben presto
ridotti alla fame. A un certo punto del viaggio furono superati da un convoglio di auto con a bordo
una trentina di vedove di guerra turche che da Erzurum erano dirette a Costantinopoli. Una di quelle
donne puntò a un armeno e lo uccise con la pistola di un gendarme. Alla vedova armena e alla figlia
venne concessa allora una scelta: rimanere con la colonna o seguire il convoglio turco. Il prezzo
della salvezza era la conversione all'Isla°m. Una volta raggiunta la piana di Erzurum, sulle rive
dell'Eufrate, videro corpi ovunque e bambini gettati nel fiume verso morte certa. Alcuni uomini
armeni cercavano di nascondersi “prendendo il velo” e spacciandosi per donne musulmane, ma
coloro che erano scoperti venivano freddati sul posto. La vedova e sua figlia raggiunsero
Costantinopoli dopo 32 giorni. La loro sorte ci è ignota.
Per riuscire a comprendere l'enormità delle deportazioni armene si deve moltiplicare questo
episodio, questa cronaca terribile, per migliaia di volte. La persecuzione avveniva in varie forme,
ma il suo carattere e lo scopo ultimo rimanevano immutabili. L'unico obiettivo delle deportazioni fu
di liberare la Turchia orientale da un'antica e prospera comunità, che generava con le sue ricchezze
invidia e risentimento e che, a causa della propria diversità etnica, appariva come un potenziale
nemico in tempo di guerra. La natura criminale delle deportazioni armene venne riconosciuta nel
1919 dalle corti marziali allestite nella Turchia del dopoguerra. In uno dei processi, riguardante i
massacri commessi nella regione di Yozgat, erano imputati tre uomini i cui capi d'accusa
comprendevano l'omicidio premeditato di deportati armeni della città, il saccheggio delle proprietà
delle vittime e il sequestro e l'abuso sessuale di donne armene. Dei 1800 armeni stanziati a Yozgat
nel 1915 solo 88 sopravvissero alla guerra. Le prove a carico per quei delitti erano numerose:
cablogrammi, messaggi cifrati e ordini firmati dagli stessi imputati. La corte marziale stabilì che
non vi fu alcuna provocazione o resistenza organizzata all'autorità turca da parte degli armeni di
Yozgat. Gli uomini erano stati separati dalle loro famiglie (poi deportate con la forza) e le guardie
con il compito di condurli in esilio erano state incaricate di ucciderli. Le proprietà delle vittime
sarebbero state quindi confiscate e ridistribuite. Tutto ciò che Lepsius aveva riportato nel suo
famoso rapporto segreto del 1916 trovò dunque conferma nelle parole degli stessi giudici turchi. In
base agli articoli 45 e 170 del Codice penale ottomano e all'articolo 171 del Codice penale militare
il più anziano degli imputati, Mehmed Kemal, di anni 35, fu condannato a morte. La sentenza venne
eseguita il 10 aprile 1919, quattro anni dopo il suo modesto coinvolgimento nelle fasi iniziali di
quella sanguinosa pagina della storia armena.
Per generazioni le autorità turche e i loro sostenitori hanno contestato con forza l'accusa di
genocidio per quei crimini28, ma le loro argomentazioni sono prive di fondamento. È indispensabile
adottare il termine “genocidio” per quei crimini, poiché comportarono la deportazione, l'umiliazione
e l'eccidio sistematico di un intero popolo. Il fatto che venissero massacrati anche i bambini insieme
agli adulti è un segno evidente della volontà di cancellare completamente ogni traccia della
popolazione armena, sia presente sia futura.
Per quanto sconvolgente, però, questo ignobile capitolo della storia della Grande guerra non è
assimilabile a quanto accadde ad Auschwitz e Treblinka, ed è bene sottolinearlo. Non è certo mia
intenzione soppesare tra loro le sofferenze di due popoli perché sarebbe inconcepibile: il mio scopo
è semplicemente quello di inquadrare questa catastrofe all'interno di un preciso contesto spaziotemporale. Il genocidio armeno non fu uno sterminio su scala industriale, poiché era più simile a
quelli avvenuti in precedenza nei Balcani o al massacro degli Indiani d'America nel XIX secolo.
L'ideologia da cui il genocidio prese le mosse era alquanto superficiale e i flussi di rifugiati
provenienti da altre zone di guerra (dalla Prussia orientale al Belgio fino alla Francia nel 1914), gli
spostamenti in massa di popolazioni e le violenze perpetrate nei loro confronti erano considerati un
male inevitabile della guerra. La deportazione in sé e per sé e l'omicidio indiscriminato erano
crimini di guerra, non genocidio: lo divennero in quel contesto di guerra totale. Ciò che i turchi
fecero agli armeni nel 1915 non era motivato da un'ideologia basata sul concetto di razza. Come si è
visto, alle donne veniva risparmiata la vita se sceglievano di convertirsi all'Isla°m. Gli ebrei durante
l'occupazione nazista non ebbero una simile scelta: il loro destino era segnato unicamente dal loro
sangue e non dal credo religioso o politico.
In conclusione, i numerosi crimini di guerra compiuti dalle forze turche sui civili armeni
costituirono una vera e propria campagna di genocidio, a prescindere dalle affinità riscontrate con le
deportazioni del XIX secolo. Il massacro della popolazione armena nel 1915, in quel contesto di
guerra totale, va perciò considerato in tutto e per tutto come un “atto di genocidio”. Quanto
avvenuto mostrò un nuovo aspetto della guerra totale che avrebbe portato a particolari e terribili
sviluppi. Lo sterminio degli armeni fu un fattore decisivo di discontinuità nella storia della guerra
del XX secolo; esso non fu identico a quello degli ebrei d'Europa voluto dai nazisti, ma costituì un
precedente alla pratica dei massacri su scala industriale. Per dirla con Primo Levi, sia in Armenia
sia in Europa la natura dell'offesa deve essere specificata e collocata nel tempo e nello spazio29. Con
il massacro degli armeni si tentò di compiere un genocidio, ma concordo con Martin Amis che
scrive, proprio seguendo Primo Levi, che la strategia nazista “fu unica, non per la sua crudeltà, non
per la sua vigliaccheria, ma per il suo stile – nella sua combinazione di atavico e di moderno. Fu al
tempo stesso strisciante e ``logistica''”. I nazisti “scoprirono il nucleo del cervello dell'animale
strisciante e costruirono un'autostrada che vi conduceva”30.
Il genocidio armeno rappresenta dunque un ponte tra il XIX e il XX secolo, nel senso che mostra
ciò che può accadere quando in un contesto di guerra totale l'odio etnico viene manipolato da élite
prive di scrupoli. I crimini commessi in quell'occasione indebolirono ulteriormente gli ostacoli alla
libera pratica dell'omicidio organizzato in tempo di guerra. Quanto avvenuto in Turchia nel 1915 fu
effettivamente un genocidio, il terribile preludio a ciò che sarebbe avvenuto.
0001000070 ‣ Conclusione . Sono convinto che sia stata la Grande guerra a segnare l'avvento
dell'era della “guerra totale”, un concetto che tenterò di definire, malgrado la difficoltà del compito.
Nei suoi singoli elementi costitutivi, la guerra totale era simile ad altri tipi di conflitto. Tali aspetti
non erano del tutto nuovi: non mancarono elementi precorritori e anticipatori (come la Guerra di
secessione americana). A produrre un nuovo genere di guerra, quella totale, fu l'interazione dei
fattori della mobilitazione di massa all'interno delle società industrializzate. Le sue caratteristiche
principali esistevano separatamente già prima del 1914, ma mai prima di allora erano state fuse
insieme. In altre parole, nella Grande guerra la somma dei vettori della violenza internazionale
superò di gran lunga quella di ogni altro conflitto precedente. Questo incremento esponenziale della
letalità e della portata della guerra fece assumere al conflitto una fisionomia mai vista prima di
allora.
Prima di sottolineare alcune caratteristiche peculiari di questo fenomeno, vorrei ribadire ancora una
volta che la vera natura della guerra totale deve essere ricercata nell'unione dei singoli fattori e nella
loro tendenza ad amplificarsi a vicenda fino a creare un insieme infinitamente più terribile della
somma delle parti. Con l'espressione “guerra totale” non si vuole ricorrere a una formula descrittiva
ma metaforica, giacché essa evoca e non descrive il decisivo inasprirsi del conflitto internazionale.
Una guerra totale, inoltre, non può essere mai intesa in senso letterale. Più correttamente essa è
“totalizzante”: maggiore è la sua durata, tanto più numerose saranno le risorse umane e materiali
travolte nella spirale della guerra. Il processo che a partire dal 1914 portò progressivamente alla
guerra totale è paragonabile alla corsa di un asintoto verso una curva data: un avvicinamento che
non prevede mai un punto d'incontro (come insegna il paradosso di Zenone). In termini weberiani la
nozione di “guerra totale” è un tipo ideale, uno strumento più euristico che descrittivo31. È dunque
un termine infinitamente complesso e non va usato a sproposito. La guerra del 1914 non riuscì a
concludersi in maniera rapida e si tramutò in una specie di assedio tra potenze industriali che
possedevano domini in tutto il mondo. In quel frangente essa cambiò fisionomia: divenne più
estesa, più letale e più logorante di qualsiasi altro conflitto precedente. È proprio a questa nuova
tipologia di guerra che si addice la parola “totale”.
Per alcuni storici la totalizzazione della guerra riguarda anche le guerre del Peloponneso, la Guerra
dei Trent'anni avvenuta nel XVII secolo, o ancora i conflitti tra gli imperi che coinvolsero tutto il
pianeta nel XVIII secolo. Se da un certo punto di vista esiste un fondo di verità in queste tesi, alla
luce dei fatti non posso accettare che si applichi il termine “guerra totale” ai conflitti anteriori al XX
secolo. La nascita della guerra industriale combattuta su scala mondiale a partire dal 1914 fu un
evento rivoluzionario. La concomitanza di quell'evento con atti di genocidio fu il frutto sia del caso
sia della premeditazione: la guerra totale creò le premesse del genocidio, in cui furono coinvolti
alcuni (ma non tutti) i belligeranti. Questa trasformazione della pratica della violenza di massa ebbe
luogo durante la Grande guerra. Quanto avvenuto in Turchia nel 1915 rappresentò il primo esempio
di un nuovo genere di conflitto, e poco importa che la Turchia non fosse una grande nazione
industrializzata. Quella guerra, combattuta dai turchi al fianco delle Potenze centrali, in breve tempo
si tramutò in qualcosa di mai visto prima e di ancor più brutale, in virtù anche del “contributo” dato
dalla Turchia con il genocidio degli armeni. La guerra totale non produsse dunque il genocidio, ma
creò un ambiente favorevole al suo verificarsi: una situazione militare, politica e culturale in cui ciò
poté avvenire una prima volta, e poi avvenire di nuovo.
Tabella 1. Vittime della Prima guerra mondiale Nazione Numero di combattenti Morti Feriti
Prigionieri/dispersi Totale % di vittime sul numero di combattenti Alleati Russia 12.000.000
1.700.000 4.950.000 2.500.000 9.150.000 76,25% Francia 8.410.000 1.375.800 4.266.000 537.000
6.178.800 73,47% Gran Bretagna + Domini 7.454.000 921.000 2.090.212 191.652 3.202.864
42,97% Italia 5.615.000 578.000 947.000 600.000 2.125.000 37,85% Stati Uniti 4.355.000 114.000
234.000 4256 352.256 8,09% Giappone 800.000 300 907 3 1210 0,15% Romania 750.000 335.706
120.000 80.000 535.706 71,43% Serbia 707.343 278.000 133.148 152.958 564.106 79,75% Belgio
267.000 13.716 44.686 34.659 93.061 34,85% Grecia 230.000 5000 21.000 1000 27.000 11,74%
Portogallo 100.000 7222 13.751 12.318 33.291 33,29% Montenegro 50.000 3000 10.000 7000
20.000 40,00% Totale 40.738.343 5.331.744 12.830.704 4.120.846 22.283.294 54,70% Imperi
centrali Germania 13.200.000 2.037.000 4.216.085 1.152.800 7.405.885 56,11% Impero austroungarico 9.000.000 1.100.000 3.620.000 2.200.000 6.920.000 76,89% Turchia 2.998.000 804.000
400.000 250.000 1.454.000 48,50% Bulgaria 400.000 88.000 152.390 27.029 267.419 66,85%
Totale 25.598.000 4.029.000 8.388.475 3.629.829 16.047.304 62,69% Totale generale 66.336.343
9.360.744 21.219.179 7.750.675 38.330.598 57,78% Fonti: Jay M. Winter, The Great \War and the
British People, Macmillan, London 1986, p. 75; The Great War,
http://www.locksley.com/greatwar/dead.htm Note al saggio
1 - A proposito di questa definizione e delle relative implicazioni cfr. Jay Winter, Jean-Louis
Robert, Capital Cities at War, London, Paris, Berlin 1914-1919, Cambridge University Press,
Cambridge 1997.2 - Per approfondimenti cfr. Jay Winter, The Great War and the British People,
Macmillan, London 1986, cap. 3.3 - Si vedano i riferimenti bibliografici in The French Home
Front, a c. di Patrick Fridenson, Berg Publishers, Oxford 1992.4 - Cfr. i riferimenti bibliografici in
The Upheaval of War: Family, Work and Welfare in Europe 1914-1918, a c. di Richard Wall e Jay
Winter, Cambridge University Press, Cambridge 1988 e per riferimenti più aggiornati Susan
Pedersen, Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State: Britain and France 19141945, Cambridge University Press, Cambridge 1993.5 - Ringrazio Ken Inglis per le discussioni su
questo argomento. La letteratura su questa tematica è sterminata. Per cominciare si veda il classico
di Sigmund Freud, Mourning and Melancholia, vol. 4 di Collected Papers, trad. Joan Riviere,
Hogarth Press, London 1950, pp. 152-70 [trad. it. Lutto e melanconia, vol. 8 di Opere di Sigmund
Freud, Bollati Boringhieri, Torino 1976, pp. 102-18]; Melanie Klein, Mourning and Its
Relationship to Maniac-Depressive States, in “International Journal of Psychoanalysis”, 21, 1940;
John Bowlby, Processes of Mourning, in “International Journal of Psychoanalysis”, 44, 1961; John
Bowlby, Pathological Mourning and Childhood Mourning, in “Journal of the American
Psychoanalytic Association”, 11, 1963. Per un quadro riassuntivo cfr. Colin Murray Parkes,
Bereavement. Studies of Grief in Adult Life, Tavistock Publications, London 1972 [trad. it. Il lutto:
studi sul cordoglio negli adulti, Feltrinelli, Milano 1980]; Colin Murray Parkes, Robert S. Weiss,
Recovery from Bereavement, Basic Books, New York 1983; Geoffrey Gorer, Death, Grief and
Mourning in Contemporary Britain, Cresset, London 1965; Bereavement: Its Psychosocial Aspects,
a c. di Bernard Schoenberg et al., Columbia University Press, New York 1975; Mardi J.
HoROWitz, A Model of Mourning: Change in Schemas of Self and Other, in “Journal of the
American Psychoanalytical Association”, 38, 2, 1990, pp. 297-324.6 - Cfr. Wilhelm Deist, Militär
Staat und Gesellschaft, Oldenbourg, Münich 1991.7 - Cfr. Adolf Hitler, La mia battaglia,
Bompiani, Milano 1934 [tit. orig. Mein Kampf, Verlag Franz Eher Nachfolger, München 19251927].8 - L. Borchardt, The Impact of the War Economy on the Civilian Population, in The German
Military in the Age of Total War, a c. di Wilhelm Deist, Berg Publishers, Oxford 1984.9 - Cfr.
Avner Offer, The First World War. An Agrarian Interpretation, Oxford University Press, Oxford
1989.10 - Amartya Sen, Poverty and Famines, Blackwell, Oxford 1976.11 - Id., The Standard of
Living: Lecture I, Concepts and Critiques, in The Standard of Living, a c. di Geoffrey Hawthorn,
Cambridge University Press, Cambridge 1987, pp. 2-3 [trad. it. Il tenore di vita. Tra benessere e
libertà, Marsilio, Venezia 1998].12 - Cfr. Barrington Moore, Injustice. The Social Bases of
Obedience and Revolt, Macmillan, London 1978 [trad. it. Le basi sociali dell'obbedienza e della
rivolta, Edizioni di Comunità, Milano 1983].13 - Cfr. Guerres et cultures, a c. di Jean-Jacques
Becker et al., Armand Colin, Paris 1994.14 - A tal proposito cfr. Stéphane Audoin-Rouzeau, La
guerre des enfants. 1914-1918, Armand Colin, Paris 1993.15 - Sui thriller cfr. Milan Voykovic, The
Culture of Thriller Fiction in Britain 1898-1945: Authors, Publishers and the First World War,
Tesi PhD, University of New South Wales, 1996.16 - Per quanto concerne l'industria del
grammofono cfr. Peter Martland, The Development of the Gramophone Industry in Britain, 18801935, Tesi PhD, Cambridge 1990.17 - Richard H. Axsom, ``Parade'': Cubism as Theatre, Garland
Pub., New York 1979, p. 35.18 - Richard Buckle, Diaghilev, trad. Tony Mayer, Edition JeanClaude Lattès, Paris 1980, p. 378.19 - Kenneth Silver, Esprit de corps. The Art of the Parisian
Avant-Garde and the First World War, 1914-1925, Thames & Hudson, London 1989, pp. 45, 47,
123, 165.20 - Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial. Des origines à nos jours, Flammarion,
Paris 1949, p. 167 [trad. it. Storia del cinema mondiale dalle origini ai giorni nostri, Feltrinelli,
Milano 1964].21 - 14-18, les combattants des tranchées: à travers leurs journaux, a c. di Stéphane
Audoin-Rouzeau, Armand Colin, Paris 1986.22 - Sull'argomento cfr. Antoine Prost, Les anciens
combattants et la société française 1914-1939, Gallimard, Paris 1985.23 - Per una trattazione più
approfondita del tema cfr. Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning: the Place of the Great
War in European Cultural History, Cambridge University Press, Cambridge 1995 [trad. it. Il lutto e
la memoria, il Mulino, Bologna 1998].24 - Peter Gay, The Cultivation of Hatred, Norton, New
York 1993.25 - Ringrazio George Mosse per la metafora. Per un confronto tra scelta e casualità cfr.
Jonathan Steinberg, All or Nothing. The Axis and the Holocaust, Routledge, London 1990 [trad. it.
Tutto o niente: l'Asse e gli ebrei nei territori occupati, 1941-1943, Mursia, Milano 1997].26 - Sul
genocidio armeno cfr. Johannes Lepsius, Rapport secret sur les massacres d'Arménie (1915-1916),
Payot, Paris 1987; Tribunal permanent des peuples, Le crime de silence. Le Génocide des
Arméniens, Flammarion, Paris 1984; Gerard Chaliand e Yves Ternon, Le Génocide des Arméniens
1915-1917, Editions Complexe, Paris 1981; The Armenian Genocide. History, Politics, Ethics, a c.
di Richard G. Hovannisian, Macmillan, London 1992; The Armenian Genocide in perspective, a c.
di Richard G. Hovannisian, Transaction Books, New Brunswick 1986.27 - Moritz Busch, Bismarck.
Some Secret Page of His History, 2 voll., Macmillan, London 18981, p. 128.28 - Per una
testimonianza delle reazioni critiche da parte di gruppi e individui turchi in merito all'accusa di
genocidio degli armeni, si veda la terza parte della serie The Great War and the Shaping of the
Twentieth Century del novembre 1996 realizzata da PBS (Public Broadcasting System).29 - Primo
Levi, Se questo è un uomo, De Silva, Torino 1947.30 - Martin Amis, Time's ArROW, Penguin,
London 1991, p. 176. [si veda anche la trad. it. La freccia del tempo, o La natura dell'offesa,
Mondadori, Milano 1993, p. 164].31 - Roger Chickering, Total War: the Use and Abuse of a
Concept, in Anticipating Total War: The German and American Experiences, 1871-1914, a c. di
Manfred F. Boemeke et al., Cambridge University Press, Cambridge 1999, p. 23.