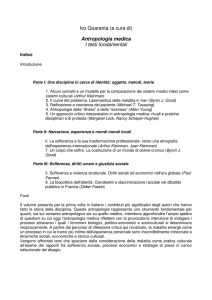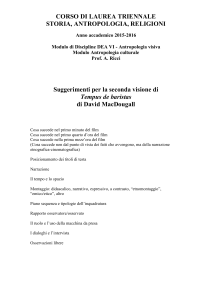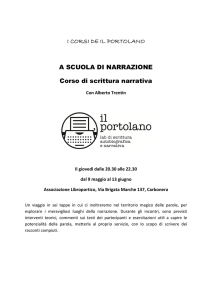ELEONORA PITTALIS*
ESERCIZI DI ANTROPOLOGIA DELLA NARRAZIONE
IN UNA CLINICA NEUROPSICHIATRICA ROMANA
ANTHROPOLOGICAL EXERCISES OF NARRATIVE IN A NEUROPSYCHIATRIC
CLINIC IN ROME
RIASSUNTO
L'articolo ripercorre i risultati di una ricerca etnografica intrapresa all'interno
di una Casa di cura romana a indirizzo neuropsichiatrico. All'interno della clinica sono
state ascoltate e raccolte le storie di vita di alcuni pazienti in essa ricoverati.
La ricerca si interroga sulle potenzialità degli strumenti antropologici in un
contesto clinico attraverso la sperimentazione del dispositivo di mediazione
etnoclinica. L'esercizio etnografico dell'ascolto permette di indagare il rapporto tra la
costruzione diagnostica della vita dei pazienti e la narrazione come pratica di
decostruzione nosografica.
L'analisi delle testimonianze raccolte restituisce informazioni sulle
interpretazioni e il senso che i soggetti attribuiscono all'esperienza di malattia in
relazione al radicamento con il proprio tessuto culturale e con le pratiche medicopsichiatriche. Vengono prese in rassegna, inoltre, le modalità attraverso le quali la
sofferenza psichica si radica e interagisce con lo spazio sociale, con il mondo
produttivo, normativo e relazionale.
SUMMARY
The article analyzes the results of an ethnographic research conducted in a
neuropsychiatric clinic located in Rome, by collecting the life stories of some patients in
care.
*
Dottore magistrale in Discipline Etnoantropologiche (Università degli Studi "Sapienza" di Roma Dipartimento di "Storia, Culture, Religioni"), perfezionata in Mediazione Etnoclinica presso il Centro Studi
Sagara, l'autrice si occupa di etnopsichiatria, antropologia della narrazione, salute, malattia e politiche globali.
69
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
The research questions the potentiality of anthropological tools within a clinical
context by experimenting the ethnoclinic mediation. The ethnographic exercise of
listening allows the investigation of relationship between the diagnostic construction of
patients' life and the narrative as practice of nosographic deconstruction.
The analysis of the interview provides information about the interpretations by
people and the sense that they attribute to the experience of illness in connection with
their cultural roots and the medical- psychiatric practices. Therefore, this article
reviews the ways in which mental disease is rooted and interacts with the social space,
with the productive, normative, relational world.
Introduzione
Il tema della salute mentale sembra essere oggi di competenza esclusiva
degli ambiti scientifici, dei reparti clinici e ospedalieri oppure dell'intimità e
della solitudine dei soggetti che si ritrovano a convivere e combattere con il
peso che la sofferenza psichica assume. Il clamore della riforma apportata dalla
Legge 180 è stato ormai da tempo silenziato e i temi concernenti la salute
mentale, le modalità di presa in cura - e tutto ciò che vi è naturalmente
connesso - non appaiono all'ordine del giorno né dell'opinione pubblica né,
tantomeno, degli ambiti politicamente e criticamente più attivi.
Il disagio psichico per i "non addetti ai lavori" sembra avvolto da una
nebulosa di interrogativi e viene spesso rifiutato o semplificato poiché appare
spaventoso e difficilmente decifrabile. Tuttavia, il lessico della "follia" continua
a costellare il linguaggio corrente e, instancabilmente, a creare immaginario,
descrivere personalità, mettere in guardia-da, mentre, nella progressiva
esposizione a fattori di rischio e tensione che caratterizza le società odierne, il
malessere psichico e psicologico trova sempre più radicamento, prende nomi
differenti e si mostra sotto inaspettate spoglie. Sembrerebbe dunque che non
esista alternativa possibile ai dispositivi istituzionali che conosciamo, ovvero
che "i matti", i "depressi", gli "psicotici" e i "disturbati" siano affare esclusivo
delle strutture di salute mentale, restando confinati in una vera e propria
alterità interna alla nostra società. In un tale contesto, inoltre, due processi tra
loro connessi appaiono consolidarsi in modo allarmante, rapido e incrociato, su
ciò che concerne la salute mentale e, più in generale, il benessere della
popolazione: da un lato l'allargamento esponenziale dei criteri diagnostici e
della nosografia medico-psichiatrica per cui un numero sempre maggiore di
esperienze vengono categorizzate come patologiche; dall'altro la proliferazione
di vite sempre più precarie e incerte che pone fortemente in crisi le stesse
70
Pittalis E. Esercizi di Antropologia della Narrazione...
possibilità di esistenza e di condurre una vita qualitativamente dignitosa e "in
salute". In queste congiunture le istituzioni medico-psichiatriche finiscono per
essere convocate in modo quasi esclusivo a una formalizzazione patologica di
tali esperienze, a una sorta di nosografia d'urgenza di alcune forme del
comportamento umano, alla riconfigurazione in sintomatologie "riconoscibili"
delle più disparate (quando non disperate) esperienze individuali e collettive.
Lo spaesamento dei soggetti appare così avanzare incessantemente,
minando la possibilità per sempre più persone di collocarsi all'interno del
tessuto sociale e produttivo, trovare "il proprio posto nel mondo" e riconnettersi
agli altri. Da questo punto di vista le riflessioni "storicamente profonde" di
Ernesto De Martino risultano particolarmente calzanti: le esperienze di
sofferenza psichica rappresentano una crisi, un vero e proprio «crollo del
soggetto rispetto al tessuto culturale» (De Martino 1977) al quale appartiene, e
proprio in conseguenza dei tentativi di adeguamento e radicamento ad esso.
La sofferenza emerge, allora, piuttosto, come un fatto prettamente
sociale «che ribadisce la necessità di andare contro natura, di cogliere i
processi costitutivi di ciò che più diamo per scontato, per dato e dunque
normale» (Quaranta 2006: 5). In questa direzione, le questioni chiamate in
causa dalla salute mentale non si presentano più né come ambito esclusivo
d'indagine e radicamento della scienza biologica o neuropsichiatrica, né come
fatto individuale e privato. Esse costituiscono, altresì, parte della più generale e
complessiva esperienza umana, intima quanto collettiva, culturalmente e
storicamente determinata.
Lo "spazio" della mediazione etnoclinica
In questa prospettiva, poiché le condotte psicopatologiche sono in
relazione con la cultura entro la quale si inscrivono, l’incontro tra studi
antropologici e mondo della psicopatologia e della psichiatria può risultare
molto fecondo e, del resto, l’etnopsichiatria ne rappresenta senza dubbio uno
degli esiti più significativi.
Come è noto, infatti, alla base della disciplina etnopsichiatrica vi è il
principio metodologico del complementarismo il quale prevede l'utilizzo dei
due discorsi (quello antropologico e quello psichiatrico/psicoanalitico) in
maniera non simultanea per leggere e analizzare un fenomeno psichico e
comportamentale. Gli strumenti propri dell’antropologia permettono dunque,
nel quadro delle pratiche psichiatriche, di poter esplorare e de-costruire con il
paziente le esperienze a partire dalle rappresentazioni culturali di appartenenza.
71
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
C’è da evidenziare, dunque, che il filone dell’etnopsichiatria si è riversato
soprattutto sulle complesse modalità di esperire e trattare le situazioni di
sofferenza e di malessere interculturali e alloculturali, tentando di popolare lo
spazio vuoto tra due letture radicalmente altre della realtà, quella occidentale e
quella della cultura d’origine del paziente. I pazienti beneficiano in tal modo di
una “presa in carico terapeutica” agita a partire da quello che potremmo
chiamare un dispositivo di mediazione etnoclinica. La mediazione, in questo
senso, rappresenta la possibilità di prevenire un conflitto o di ristabilire dei
legami tra delle persone o dei gruppi o, più frequentemente e in particolare, tra
istituzioni e persone/gruppi. Si tratta infatti di aprire uno spazio di relazione, un
luogo d’ascolto e di interfaccia tra due diversi universi.
La sfida e l’intento del lavoro che tenterò di descrivere nelle pagine che
seguiranno muovono, dunque, da presupposti simili ma dalla volontà di
ricercare sul campo un dispositivo di mediazione etnoclinica “at home”, che
faccia riferimento particolarmente ai soggetti formati in uno stesso ordine
culturale di matrice occidentale. In particolare, la ricerca si soffermerà sulle
esperienze e i vissuti di alcune persone ricoverate presso una Casa di cura
romana ad indirizzo neuropsichiatrico nella quale nell'anno 2013 ho svolto una
ricerca etnografica di circa cinque mesi.
Se, dunque, appare innegabile la stretta relazione tra psichiatria e
antropologia riguardo la propensione alla ricerca di codici interpretativi per
decifrare il comportamento, le attitudini, le infinite strategie di (r-)esistenza e
risposta psichica e culturale che gli individui singolarmente e collettivamente
producono, è altrettanto evidente anche quanto entrambe le discipline siano
sempre esposte al rischio e all'eventualità di un incontro potenzialmente
destabilizzante con l'"alterità". L'alterazione psichica non richiede, infatti, uno
sforzo di decifrazione simile a quello necessario nell'incontro con l'alterità
culturale radicale?
Le manifestazioni di disagio e sofferenza psichica che caratterizzano lo
stato di (cattiva) salute della nostra società occidentale fanno parte anch'esse,
pertanto, della molteplice trama di adattamento e risposta che l'individuo mette
in atto nella relazione con la specificità culturale da cui proviene. L'universo
culturale occidentale non è infatti certamente scevro e immune da meccanismi
di riduzione e naturalizzazione profondamente consolidati nella loro apparenza
di fatti a-storici, naturali e ordinari e, anch'essi, generati all'interno di un preciso
dispositivo etnico.
La questione che ha motivato la mia ricerca è stata così ispirata dalla
possibilità di immaginare e sperimentare le potenzialità di un dispositivo di
72
Pittalis E. Esercizi di Antropologia della Narrazione...
mediazione etnoclinica come apertura di uno spazio intermedio che permetta di
facilitare un incontro e, possibilmente, una diversa alleanza terapeutica. In
questo senso ritengo che la mediazione, operata attraverso l’intermediazione
degli strumenti antropologici in seno a una struttura psichiatrica, possa davvero
rappresentare una risposta originale alle difficoltà provocate dall’incontro tra il
paziente e le istituzioni della sua presa in carico, nonché avere un ruolo
importante nella possibilità di restituire queste esperienze particolari alla trama
culturale entro cui sono immerse. È bene, tuttavia, precisare che la mediazione,
di per sé, non costituisce certamente un dispositivo terapeutico, né forse
pretende di esserlo, in quanto, appunto, la pratica del mediatore si sforza
semmai di analizzare le possibili risposte nella direzione di un ancoraggio a un
nuovo tipo di pratica e di ascolto.
Ed è nondimeno importante sottolineare che un lavoro di questa natura è
possibile solo nella direzione di intraprendere una «sfida multidisciplinare ai
dispositivi di "normalizzazione" della sofferenza» (Faranda - Pandolfi 2014:
17), attraverso un lavoro di decostruzione critica delle proprie categorie.
Operare tale (ardua) decostruzione è a mio avviso possibile a partire dalle
dimensioni micro-, dall'osservazione attenta e partecipe dei più variegati campi
del vivere sociale e individuale e dalle testimonianze concrete dei vissuti
individuali e collettivi.
La possibilità di intraprendere la ricerca presso una struttura di
riabilitazione psichiatrica mi ha offerto infatti l'occasione di lasciare affiorare,
in primo luogo, la voce e il vissuto dei diretti interessati, in quanto è
direttamente ai pazienti della clinica che mi sono rivolta. In particolar modo, sin
dai primi approcci ho cercato, attraverso la pratica dell'intervista e il metodo
dell'ascolto antropologico, di elaborare una modalità di raccolta delle singole
storie di vita delle persone che avrei incontrato, tesa a recuperare le
interpretazioni e le ragioni sui percorsi che possono condurre a un ricovero
psichiatrico e, al contempo, a non ridurre la complessità esistenziale di una vita
intera agli eventi di malattia e alla patostoria dei narranti.
Oltre la costruzione diagnostica della vita
All'interno dei contesti medici, generalmente, le storie e le esperienze
personali vengono raccolte e ascoltate in funzione di uno scopo sostanzialmente
tecnico. L'antropologia, soprattutto statunitense, ha riflettuto a lungo su questo
particolare aspetto della clinica. Come spiega Byron Good, la compilazione
della cartella e le modalità attraverso cui essa viene indicizzata sembrano
73
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
organizzare «il paziente in forma di documento, di un progetto su cui lavorare,
scritto per un uditorio particolare». L'insieme di informazioni raccolte
rappresentano, in itinere e nella loro forma finale, la storia dei processi di
malattia strutturati in modo tale che «la persona, il soggetto della sofferenza,
viene rappresentato come il luogo della malattia piuttosto che come agente
narrante» (Good 2006: 121, 125).
Robert Laing si chiedeva a tale proposito come sia possibile
comprendere il significato umano e le ragioni della persona se «le parole che si
debbono usare sono state inventate apposta per isolare e circoscrivere in una
entità clinica particolare il senso della vita del paziente» (Laing 2001: 6).
A lungo gli indirizzi antropo-fenomenologici si sono dunque posti la
domanda su quale sia il ruolo e il posto, all'interno di tali pratiche, assegnato
all'esperienza e ai molteplici significati (soggettivi e collettivi) che gli individui
attribuiscono alla propria storia. Sottovalutando l'importanza del significato che
i pazienti attribuiscono alle loro esperienze di malattia, non si corre infatti il
rischio di non cogliere la rilevanza di altre dimensioni che, a fronte della
complessità e della varietà delle esperienze umane, non possono essere ridotte a
mera patologia? Non si rischia così di astrarre le esperienze dal loro tessuto
composito, indeterminato, storico, collettivo?
Liberare la narrazione dalle restrizioni nosografiche della medicina - che
costringono il soggetto a identificarsi unicamente con la patostoria e con le
coordinate diagnostiche - può allora aprire spazi inediti di agibilità in cui riraccontarsi e ascoltarsi: cioè luoghi del possibile, liberi da giudizi di valore
disciplinarmente e politicamente costituiti. É all'interno di questo incontro
sempre possibile e cangiante, infatti, che la narrazione dispiega tutte le
potenzialità e l'antropologo può forse configurarsi come medium attraverso cui
il racconto può prender forma e trasformarsi in un ponte tra esistenza e clinica,
esperienza e malattia, bisogni e cura, sé e altro.
Da questo punto di vista, il lavoro è stato immaginato, mutuando
un'espressione di Faranda, come un'«etnografia dei momenti di crisi» (Faranda
- Pandolfi 2014: 61], nel tentativo di ri-significare, attraverso lo scambio diretto
e la pratica della narrazione, una sofferenza che da esperienza intima e
abominevole può trasformarsi in strumento attivo di incontro tra persone e
mondi vissuti ed essere riavvicinata così alla dimensione umana e culturale da
cui è originata. Incontro necessario, poiché, come ricorda Bruno Callieri, l'altro
è fonte di memorie, esperienze, scoperte, ed è solo co-essendoci che è possibile
trasformare la «relazione oggettivante della medicina classica e di quella
scientifica in un incontro interumano» (Callieri 2007: 25). A fronte di
74
Pittalis E. Esercizi di Antropologia della Narrazione...
un'esperienza umana troppo vasta e varia per essere confinata e interpretata
rigidamente, lo psicopatologo antropo-fenomenologicamente orientato non
smette di ricordarci, infatti, che solo attraverso l'incontro, nell'esserci
reciprocamente con l'altro e mettendosi in ascolto, è forse possibile cogliere
l'intimo progetto di ciascuno (e al tempo stesso dei "molti") e ricostruire i
mondi vissuti "degli alienati". Poiché la psicopatologia altro non è che una
distorsione di tale coesistenza, cioè dell'esserci-insieme-nel-mondo, Callieri
invitava perciò a recuperare la capacità di sentire il noi, di applicare
un'antropologia della relazione nei termini di un vero e proprio impegno
morale.
Provando a non lasciare inascoltato questo invito, nelle mie intenzioni lo
strumento dell'intervista si è configurato come una sorta di meta-metodologia
che mi consentisse al tempo stesso di raccogliere materiale, racconti e
interpretazioni e di tentare una pratica alternativa alla compilazione
dell'anamnesi, nella direzione di verificare – in primo luogo – le possibilità
della narrazione come pratica di decostruzione nosografica.
A fronte di esperienze tanto composite e difficili, cercherò di esplicitare,
nelle pagine seguenti, gli esiti del mio esercizio volto a sperimentare le
possibilità di un incontro, per l'appunto, antropo-fenomenologicamente
orientato.
Dialogare con la sofferenza
La possibilità di svolgere la ricerca presso una determinata clinica di
riabilitazione psichiatrica è stata a monte motivata dai precedenti contatti
stabiliti con uno dei suoi psichiatri che conosceva (e riconosceva) esattamente il
fondamento della mia proposta di lavoro. In principio, si era stabilito di farmi
incontrare i possibili interlocutori, ovvero i pazienti che vi erano ricoverati,
previa decisione e presenza del medico e che, solo dopo una breve introduzione
del mio ruolo e dei miei intenti, saremmo stati lasciati soli per esplicitare infine
le ragioni della mia ricerca e le modalità che avrei utilizzato. In caso di assenso
da parte delle persone così incontrate, ci saremmo accordati sulla data in cui
avremmo iniziato l'intervista. Successivamente ho stabilito invece un approccio
più autonomo con i degenti e, previa richiesta al medico o alla riabilitatrice
psichiatrica, ho potuto domandare direttamente, senza intermediazione in
presenza, se avessero voglia di partecipare alla mia ricerca.
Fin dal principio, più per ragioni logistiche e di tempo che per scelta
metodologica, non ho preso visione delle cartelle cliniche né ho avuto una
75
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
presentazione anamnestica delle persone con cui mi sono relazionata. Intervista
dopo intervista, tuttavia, mi sono resa conto che ciò rendeva più semplice e
spontaneo il dialogo e permetteva di andare al fondo delle questioni con una
spontaneità che forse non avrei avuto se avessi conosciuto preventivamente le
ragioni mediche dei vari ricoveri in clinica. L'univocità dell'inquadramento
medico e la nosografia può infatti, non di rado, proporsi come vincolante non
solo per i pazienti, ma anche per chi si relaziona con essi, e i racconti degli
intervistati avrebbero potuto assumere un significato diverso se io non fossi
stata "vergine" di interpretazioni e definizioni già accertate in sede clinica. In
tal caso, probabilmente, la mia attenzione si sarebbe focalizzata sulla
decostruzione di quelle interpretazioni e sul modo con cui i narratori si
rapportavano alle proprie diagnostiche.
Nonostante l'uso del registratore, dopo pochi minuti i miei interlocutori
entravano nel vivo del racconto e procedevano, in molti casi, in autonomia e
sicurezza. Alcuni di essi, pur essendomi stati presentati come poco loquaci o
restii a sviluppare un racconto su tempi lunghi, si sono dimostrati invece molto
disponibili e appassionati nel racconto, mostrando una imprevista volontà a
raccontarsi a fronte di un approccio insolito rispetto a quello al quale erano
abituati.
Complessivamente ho cercato di lasciare che la narrazione scorresse
liberamente, cercando di inserire le mie domande nei momenti ritenuti più
opportuni. Tuttavia, nonostante specificassi ai miei interlocutori che non ero lì
per raccogliere esclusivamente la loro storia di malattia e gli chiedessi, anzi, di
raccontarmi la storia complessiva della loro vita, si è palesata, generalmente,
una precisa tendenza: spesso, fin dalle primissime battute, il racconto prendeva
la forma della loro patostoria.
Pur nella etereogeneità delle diverse situazioni, nella maggior parte dei
casi gli episodi esplicitati erano infatti direttamente concatenati allo sviluppo
del malessere e agli eventi che avevano condotto ciascuno degli intervistati alla
situazione attuale e al protrarsi della malattia. Appariva evidente, cioè, quanto
essi si riconoscessero entro un preciso inquadramento medico e quanto
desiderassero raccontare il proprio malessere, svelarne le cause e solo
successivamente rielaborare il proprio passato.
Prima di inoltrarmi nella restituzione dei contenuti delle interviste
raccolte, è necessaria un'ulteriore premessa di contestualizzazione. Le
narrazioni e i racconti che hanno dato corpo alla mia ricerca non possono che
rappresentare una variante parziale di una storia di vita, legati come sono alle
circostanze, al lavoro di selezione della memoria, alle condizioni dell'intervista
76
Pittalis E. Esercizi di Antropologia della Narrazione...
e al rapporto tra intervistatore e intervistato. Le persone intervistate erano
ricoverate, alcune da molto tempo, altre da meno, all'interno della clinica, e si
trovavano, dunque, nel pieno di un processo riabilitativo nel quale prende
forma un lavoro continuo di ripensamento, analisi e confronto serrato della
propria storia. Tra ascisse e ordinate del racconto, la clinica e la condizione di
"pazienti" rappresentano, a queste condizioni, il grado zero del piano cartesiano
che orienta le coordinate della storia. Il racconto è infatti sempre frutto dei
processi di simbolizzazione e comprensione che i narranti mettono in atto per
ricostruire e riappropriarsi di una certa storia, della propria storia.
A partire dalle storie raccolte, ho cercato dunque di recuperare
significati, segni, indizi, racconti ed esperienze da leggere singolarmente e
comparare per costruire contestualmente dei paradigmi indiziari attraverso cui
interrogarsi sul senso stesso di alcune idee radicate e costitutive del vivere
(Ginzburg 2002]. A partire dagli aspetti più ricorrenti enunciati dai narratori è
stato possibile rinvenire alcune tematiche principali che potrebbero essere
racchiuse, sinteticamente, in quattro macro-aree, seppure tra loro inscindibili e
strettamente connesse le une alle altre:
-1. Senso del male e ordine del discorso. Si è cercato di leggere le
testimonianze nel tentativo di decifrare i significati attribuiti all'esperienza della
sofferenza nelle forme e nei modi in cui viene narrata, categorizzata, messa in
forma e spiegata dai soggetti stessi che la esperiscono, alla ricerca di quel
"senso del male" che gli studi di antropologia hanno tentato di sintetizzare
(Augè e Herzlich 1986). Da questo punto di vista, nelle storie narrate, il
linguaggio medico-psichiatrico risulta, senza dubbio, estremamente
performativo. Le pratiche e il vocabolario della medicina rappresentano dei veri
e propri regimi di significazione che forniscono le condizioni per poter
attribuire significato a se stessi e alle proprie esperienze. Vissuti emotivi tra i
più comuni, come la sensibilità e l'affettività, vengono riconosciuti come
sinonimi di patologia e debolezza, attraverso geografie processuali
estremamente lineari alle cui estremità si trovano, come ipotesi inconciliabili,
l'idea di sanità e quella di malattia. In una società in cui i manuali diagnostici
continuano ad accumulare tipi e comportamenti da patologizzare, la
consapevolezza di esser patologicamente segnati viene esplicitata non solo
rispetto all'oggi e all'incidenza del disagio, ma rinvenuta e collocata nelle
proprie origini genetiche o attribuita, auto-colpevolizzandosi, alle proprie scelte
e attitudini.
Al contempo, in molti casi i pazienti sembrano non interrogarsi sulle
cause del proprio malessere, delegando completamente il senso delle proprie
77
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
esperienze ai medici specialisti e incorporando diagnosi decisamente radicali.
E' come assistere a una sorta di processo di auto-invalidazione assistita, entro
cui il nesso tra "sapere-potere" si mostra in tutta la sua efficacia, evidenziando
quanto le sproporzioni di sapere tra gli uni (i pazienti) e gli altri (l'apparato
medico-scientifico) incidano non solo sul modo di pensarsi e raccontarsi, ma
sulle possibilità e potenzialità concrete degli individui (Foucault 2011).
- 2. Delega: istituzioni e famiglia. Le testimonianze restituiscono
continui paradossi sulla degenza, sui limiti e i benefici delle soluzioni
terapeutiche, sulla contraddizione tra il bisogno di un'assistenza "ufficiale" e
l'assenza di spazi di agibilità e cura al di fuori di essa. I soggetti che vivono in
prima persona l'esperienza della malattia appaiono talvolta esposti a un
progressivo processo di sottrazione di autonomia i cui unici ancoraggi e
riferimenti possibili, anche quando ciò non aderisca esattamente ai loro
desideri, diventano la famiglia e le istituzioni mediche. Entro queste dinamiche,
seppur attraverso movimenti oscillatori e di rottura, si assiste a una vera e
propria modalità di divenire "pazienti" a partire da una delega quasi totale della
propria vita ai dispositivi clinici e medici. In questo processo, la vita sembra
venir presa in una morsa che vincola gli individui a un'esistenza da "soggetto
bisognoso", i cui tempi e possibilità sono mediati e trasformati
irreversibilmente dalle istituzioni presso cui si rivolge e da percorsi codificati. I
pazienti, infatti, pur riconoscendo in molti casi la necessità e l'importanza del
processo riabilitativo presso la struttura clinica, ne rivelano al tempo stesso luci
e ombre. Se da un lato essa rappresenta, nella sua chiusura rispetto al mondodi-fuori, un vettore di sottrazione di autonomia, dall'altra è un luogo "protetto"
poiché le mura che la circondano, seppur contenitive, tengono a distanza i
pericoli e le avversità del mondo esterno. Ugualmente, la degenza presso la
clinica rappresenta un'importante opportunità per uscire dall'isolamento
esistenziale e scoprire che altri condividono esperienze simili alle proprie.
Tuttavia appare evidente anche la difficoltà a tollerare quotidianamente il peso
delle altrui difficili esperienze e il desiderio di poter essere compresi anche al di
fuori delle arene preposte alla riabilitazione. Entro questi processi, poi, il
rapporto con la farmacoterapia riveste chiaramente un ruolo centrale. Le
testimonianze mostrano come in molti casi i farmaci assumano una funzione
ambivalente: strumento di cura quanto di blocco e trasformazione, sostanze
inibitrici capaci di modificare completamente le capacità performative degli
individui e la possibilità di reinserirsi nei canoni di "normalità" desiderati,
poiché, cancellando il rapporto tra sintomi e vita esperienziale, si configurano
come produttori di nuovi e potenti disagi. In tutte le storie narrate, nessuna
78
Pittalis E. Esercizi di Antropologia della Narrazione...
esclusa, viene evidenziato il problema di prescrizioni e farmacoterapie agite da
una "mala-psichiatria" che purtroppo è possibile incontrare sul proprio
cammino. Difficilmente i pazienti appaiono pacificati rispetto agli effetti dei
farmaci: essi si muovono allora tra momenti di resistenza, che si risolvono in un
altrettanto problematica decisione di interrompere la cura, e la rassegnata
accettazione della terapia nella speranza che possa in qualche modo lenire o
scalfire la sofferenza di cui si è vittime.
La quasi totalità dei pazienti incontrati mi ha rivelato che presso la
clinica entro cui si trovavano al momento dell'intervista hanno finalmente
potuto sperimentare un percorso di cura psichiatrico qualitativamente
differente. Molti di loro, infatti, dopo anni di cure e percorsi medici, hanno
rilevato, non senza frustrazione e stupore, di aver finalmente trovato una terapia
adeguata grazie alla quale ricominciare a pensarsi in prospettiva e a
immaginarsi al di fuori dello stigma della "malattia mentale". Ciò, invero,
palesa un ulteriore paradosso: quando è possibile fare i conti con una buona
psichiatria sembra che essa debba occuparsi di riparare i danni provocati dalle
stesse istituzioni e paradigmi da cui essa proviene.
3. Microfisiche della solitudine. Il tema della solitudine sembra essere
una sorta di costante che taglia trasversalmente le storie e i vissuti delle persone
incontrate in clinica, in alcuni casi come fattore scatenante dei disturbi, in altri
come conseguenza ineluttabile. Le storie mostrano come il rapporto con la sfera
sociale e relazionale, e particolarmente con quella educativa e lavorativa,
possano rivelarsi importanti produttori di situazioni di isolamento e disagio. In
questo senso il semplice scarto rispetto alle norme o l'impossibilità di
rispondere alle aspettative sociali danno forma alle idee di devianza, diversità e
inadeguatezza che sembrano incollarsi agli individui come uno stigma
indelebile. Le esperienze di sofferenza psichica risultano spesso come
conseguenza di una sfida sul campo e di una battaglia per la costruzione della
propria identità. Tale sfida è mediata dalla possibilità che gli individui hanno,
all'interno di un determinato contesto, di corrispondere a gradi di adeguatezza e
inadeguatezza pregiudizialmente previsti. Una pressante retorica centrata sul
senso del dovere e della responsabilità sembra infatti abitare questi interstizi
ponendo continuamente l'individuo di fronte a scelte da prendere
soggettivamente e "responsabilmente", pena il proprio posto in società e la
propria "dignità sociale". Sempre più, infatti, l'ordine sociale sembra iscriversi
nelle condotte a partire da un meccanismo di auto-normazione e autodisciplinamento dettato da invisibili forme di controllo performativo e
psicologico: la questione è strettamente legata alle dimensioni e alla pervasività
79
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
con cui i principi neoliberali di efficienza (performativa, produttiva,
relazionale) e di buona condotta, attraverso forme di controllo indirette e
distanti agiscano come vettori e produttori di differenziazione ed esclusione
sociale. Ciò avviene spesso all'interno di una situazione politico-economica
precisa: disoccupazione giovanile drammaticamente in aumento, redditi
vertiginosamente ridotti, accesso ai servizi sempre più limitato e annesse
retoriche di austerity che vincolano gli individui a meccanismi di ricatto e
dipendenza insolubili. Entro questo quadro, risulta chiaro quanto la condizione
di precarietà che caratterizza la nostra contemporaneità non sia solo materiale,
ma intimamente esistenziale. E la numerosa presenza di giovani e giovanissimi
ricoverati presso la clinica, nonché le loro storie, sembrano confermare questa
tendenza. In questo senso, la solitudine e la marginalità, in quanto fatti sociali,
rappresentano il vero sintomo e il cardine intorno cui molto spesso prende il via
il processo di incorporazione dell'esperienza sociale, e dunque il disagio e la
malattia. In questa direzione, le forme di alienazione che il capitale produce nel
continuo processo di messa a valore della vita sembrano risolversi in una
sofferenza in espansione, in una sorta di «rigetto collettivo e organico verso
condizioni di esistenza alla fin fine incompatibili con i bisogni, tempi e ritmi
della specie» (Coppo 2005: 140).
Cosicché in molti casi si assiste ad un progressivo processo di
smondanizzione, come suggerito da Callieri (2007), nel quale la rottura totale
con il mondo esterno sembra essere l'unica possibilità in campo. Relazione e
comunicazione appaiono interdette e, se da un lato la scelta o la condizione di
chiusura è in primo luogo vissuta e orientata soggettivamente, dall'altro il
mondo esterno si mostra incapace ad accogliere un malessere che ha assunto
proporzioni non più "tollerabili".
- 4. Inabilità sociali. A fronte di esperienze apocalittiche, psicotiche,
depressive, di "comportamenti antisociali" e bipolari, e più in generale di ciò
che potremmo chiamare modalità peculiari di esserci nel mondo, le
testimonianze mostrano quanto il malessere psichico assuma per sé e per gli
altri l'aspetto di un insieme di radicate inabilità sociali (produttive e relazionali)
e quanto desideri e prospettive siano in parte vincolati da tale condizione e dalla
sua rappresentazione. Nel riconoscersi deficitari rispetto alle proprie possibilità,
gli interlocutori hanno spesso restituito l'idea che la guarigione sia l'unica strada
per tornare ad essere, in primo luogo, socialmente accettabili. Entro questo
quadro il tema della produttività lavorativa si è rivelato estremamente
importante. È intuitivo come ciò sia fortemente connesso alle idee di autonomia
e responsabilità e più complessivamente ai temi del riconoscimento sociale,
80
Pittalis E. Esercizi di Antropologia della Narrazione...
delle prospettive per il futuro e delle aspettative. Come ci ricorda Foucault in
uno dei suoi studi archeologici sulla follia (Foucault 2011), il primo stigma di
uno statuto generale di ciò che nel tempo si è delineato come "malattia
mentale" si può rinvenire storicamente proprio nell'esclusione dal lavoro e dalla
produzione economica. Tale esclusione è certamente ambivalente: necessità
obbligata per il malato da un lato, spazio preclusogli dall'altro. La malattia,
infatti, sembra inibire completamente la possibilità di essere, o tornare a essere,
un soggetto produttivo (Macherey 2013) nei termini in cui è richiesto da una
società a capitalismo avanzato come la nostra. In quest'orizzonte, all'interno di
un'organizzazione sociale che non prevede una collocazione per la sofferenza
psichica se non ai margini o nei dispositivi istituzionali di cura, la necessità del
lavoro si configura spesso come unica prospettiva verso cui tendere per
riscattarsi dall'anomalia e dalla solitudine.
La lettura delle interviste sembra offrire, complessivamente, un
condensato, un precipitato, e al tempo stesso una miniatura di quanto lo
scollamento dalle reti sociali e la difficoltà a ricollocarsi nel mondo da parte dei
soggetti che patiscono la sofferenza psichica sia il sintomo non solo delle
proprie, ma anche e soprattutto delle inabilità di una società non predisposta o
poco abituata a scorgere, curare e includere il malessere degli individui che vi
appartengono.
Storia egemone e storie particolari
Nelle interviste da me raccolte e trascritte si incontrano storie vissute che
portano con sé un ben più pesante fardello di quello della malattia, poiché la
loro chiusura nell'intimità e nel confronto serrato con i medici elude la
possibilità stessa di traslarle in un orizzonte condivisibile e narrabile.
L'incontro diretto con una realtà clinica si inserisce, allora, nella precisa
volontà di ri-collettivizzare e riabilitare quanto possibile le voci e le storie delle
persone implicate direttamente in vissuti di questo tipo e di poterle pensare, in
prima istanza, come un piccolo ma importante patrimonio conoscitivo. Per
questo, nonostante la parzialità e l'insufficienza analitica del mio lavoro a fronte
di un tema complesso come quello della salute mentale, la restituzione delle
interviste rappresenta già di per sé un obiettivo concreto. A fronte delle grandi
narrazioni "ufficiali" della scienza e della psicologia o di tutti quei saperi
legittimati da un riconoscimento istituzionale o socialmente accreditato, le
storie di vita singolari, in tale direzione, rappresentano un prezioso archivio di
saperi e conoscenze mutuate direttamente dal mondo della vita e dall'esperienza
81
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
dei soggetti intervistati. L'incontro diretto, l'ascolto e la pratica della narrazione
più in generale, assumono rilevanza proprio nella possibilità di restituire
"memorie" in contrasto con quelle accreditate ufficialmente e di rendere la voce
a quei "saperi assoggettati" (Foucault 1977) che rimangono al di sotto del
livello di conoscenza e scientificità richiesta. La peculiarità e la potenza
decostruttiva di queste storie sta a mio avviso nel loro essere raccontate non "al
di sopra" delle parti, ma dalle parti stesse. Foucault, in questo caso, torna in
aiuto ricordando come le “grandi strutture della sragione” rimangono latenti
nella cultura occidentale ed escluse dal sapere storico positivo. Per questo, il
filosofo francese, ripercorrendo lo statuto storico della "follia", sottolinea come
la forzata riduzione di un universo complesso e composito a malattia mentale
abbia sottratto a tali esperienze individuali e collettive “profondità e potere di
rivelazione” (Foucault 2006). Come a dire che «una vita di cui non si possa
raccontare una storia rischia di rimanere una mera esistenza empirica»
(Cavarero 2009: 76) E, dunque, «se vale il principio secondo il quale
l'inesponibile è l'inesistente», l'unicità delle vite rimane parzialmente inesposta
«per mancanza di una scena condivisa di comparizione, ossia di uno spazio
politico vero e proprio» (Ivi: 77).
Il lavoro antropologico, da questo punto di vista, si muove nella
direzione di re-istituire questa scena con la consapevolezza della necessità di
costituire uno spazio plurale e condiviso di esposizione, confronto, incontro,
azione e narrazione. Raccontarsi può allora significare uscire dall'isolamento e
riconnettersi
alla
storia
collettiva,
recuperare
l'autonomia
e
l'autodeterminazione che troppo spesso i vissuti di malattia, le pratiche medicopsichiatriche e gli apparati burocratici sottraggono alla capacità e alla
consapevolezza degli individui. Porsi in relazione con un interlocutore che
raccoglie una storia, ascolta e interagisce può significare rompere il binomio
bisogno-cura, ovvero la relazione gerarchica medico-paziente che prevede, a
causa di porzioni di sapere ineguale, un rapporto di subalternità. Il bisogno e la
richiesta d'aiuto possono trasformarsi in altri termini in uno scambio vivace tra
conoscenze ed esperienze, in un incontro che elimina il profilo della delega e
della dipendenza e restituisce centralità alla condivisione e allo scambio
interumano.
Un tale metodo è alla base della tensione operativa e politica del mio
lavoro etnografico, nonostante esso non riesca, in questa sede, a rendere conto
di una parte importante di tale processo di restituzione. Una ricerca di questo
tipo, infatti, non può dirsi ultimata (per quanto lo sarebbe sempre in modo
provvisorio) fin quando il lavoro svolto non sia in qualche modo direttamente
82
Pittalis E. Esercizi di Antropologia della Narrazione...
restituito agli attori che vi hanno preso parte. Se, come si è detto più volte,
l'incontro e la narrazione sono postulati dalla relazione con l'altro, credo sia
necessario ri-volgersi con la restituzione concreta della propria testimonianza a
chi, attraverso il racconto, ha condiviso «un destino, una figura irripetibile»
della propria esistenza (Cavarero 2009: 10). Questa attività è necessaria,
dunque, anche per rendere concretamente operativi i tentativi intrapresi in
direzione dello spazio condiviso di esposizione ed azione a cui si è
precedentemente fatto riferimento. La restituzione della ricerca, tuttavia,
comprende un orizzonte di interlocutori più vasto. Per fare solo un esempio,
all'inizio della ricerca, il medico che ha mediato e introdotto la mia figura
all'interno della clinica, ha prospettato la possibilità futura che le interviste
raccolte potessero essere inserite all'interno della cartella clinica dei pazienti.
Tale opportunità credo possa rappresentare una prima e importante possibilità
applicativa del lavoro antropologico all'interno della dimensione clinica e
terapeutica. Inoltre, a partire dalle interviste, ci sono fatti e problematiche sulle
quali si ha sempre la tentazione di ritornare. In questa direzione, uno dei grandi
temi che rimane aperto e su cui l'antropologia credo possa contribuire in modo
radicalmente critico e politico mi sembra sia quello di continuare a interrogarsi
su come le esperienze psicopatologiche e di sofferenza più in generale possano
essere non solo arginate e prevenute ma incluse ed ascoltate nella dimensione
sociale e collettiva, anche fuori, cioè, dalle istituzioni convenzionalmente
predisposte a contenerle. L'attuale vivere sociale rende necessario, infatti,
scorgere il limite di quel crinale che, di fronte al malessere e al comportamento
culturale alieno, sembra separare la possibilità di essere sani da quella di essere
malati, come fossero due opzioni inconciliabili.
Michele Risso, tempo fa scriveva: «Quale cura, se il disagio di fondo
rimane immutato? Quale intervento se la ben nota qualità dei rapporti tra gli
esseri umani ne esce intoccata?» (Risso 1997).
L'interrogativo di fondo resta lo stesso e il presente lavoro si muove nel
fiducioso tentativo di tracciare qualche segno nel difficile percorso che può
condurre a una risposta, nella possibilità di iniziare a riempire un abisso che ha
la forma di una ferita. Forse, intraprendendo questa strada, gli "accidenti"
psichici ed emotivi in cui siamo presi e incappiamo continuamente possono
essere letti come un divenire che non sia un passaggio da una condizione a
un'altra e non preveda il confinamento in identità e ruoli prescritti una volta per
tutte «da una storia o una preistoria» egemone (il sano, il malato, il paziente, il
curante, ecc.) (Deleuze, Guattari 2013: 387). Fuori dalle maglie di una Storia
dominante, la solitudine e le "follie" degli individui potrebbero, allora, esser
83
Formazione Psichiatrica n.1 Gennaio-Giugno 2015
ascoltate in quanto forme di difesa e resistenza a fronte dell'invivibilità della
società, come ricordava del resto Basaglia. Il "malato mentale", in questo senso,
non rappresenterebbe esclusivamente la malattia, ma una crisi incompresa da
una scienza che applica le sue regole e da una società che inibisce ai singoli
destini di spiegare i loro mondi, di presentare la loro unicità e, al contempo, di
creare spazi di condivisione reale.
BIBLIOGRAFIA
Auge M., Herzlich C. (1986). Il senso del male. Antropologia, storia e sociologia della
malattia. Milano: Il Saggiatore.
Callieri B. (2007). Corpo, esistenze, mondi. Per una psicopatologia antropologica.
Roma: Edizioni Universitarie Romane.
Cavarero A. (2009). Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione.
Milano: Feltrinelli.
Coppo P. (2005). Le ragioni del dolore. Etnopsichiatria della depressione. Torino:
Bollati Boringhieri.
Deleuze G., Guattari F. (2003). Millepiani. Capitalismo e schizofrenia. Roma: Cooper
Castelvecchi.
De Martino E. (1977). La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi
culturali. Torino: Einaudi.
Faranda L., Pandolfi M. (a cura di), (2014). La salute mentale e il paradigma
geopolitico. Itinerari critici per un'etnopsichiatria radicale. Roma: Aracne.
Foucault M. (1977). Microfisica del potere. Interventi politici. Torino: Einaudi.
Foucault M. (2006). Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), a cura di Bertani
M.
Foucault M. (2011). L'archeologia del sapere, Una metodologia per la storia della
cultura. Milano: BUR Rizzoli.
Foucault M. (2011). Storia della follia nell’età classica. Milano: BUR Rizzoli.
Ginzburg C. (2002). Spine, radici di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spine.
Roma: Einaudi.
Good B. J. (2006). Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto
medico-paziente. Torino: Einaudi.
Laing R. D. (2010). L'io diviso. Studio di psichiatria esistenziale. Torino: Einaudi.
Macherey P. (2013). Il soggetto produttivo. Da Foucault a Marx. Verona: Ombre Corte.
Quaranta I. (2006). Introduzione, in AA.VV., Annuario di Antropologia: Sofferenza
sociale, vol. 8, Roma: Meltemi.
Risso M. (1997). Intervento sugli operatori psichiatrici, in Per ricordare Michele Risso,
Atti del convegno, Boves, 1 marzo 1996. Rivista di Storia, cultura, politica,
quaderno n°7.
84