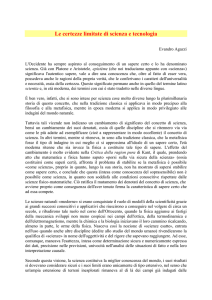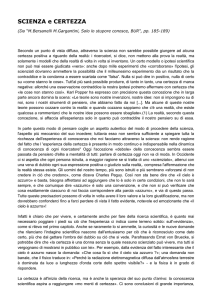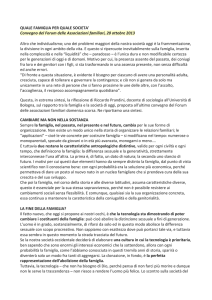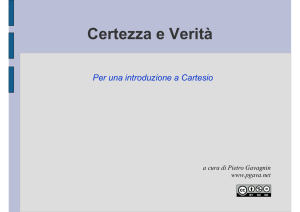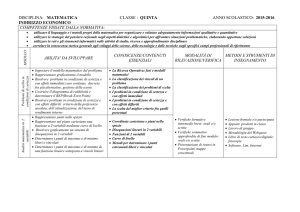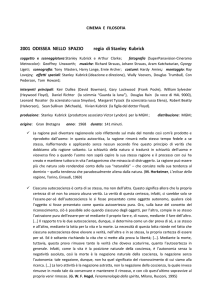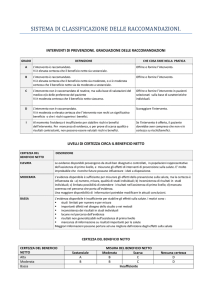E l’esistenza diventa
una immensa certezza
Dibattito a par tire dall’inter vento
di Costantino Esposito
al Meeting di Rimini 2011
da ilsussidiario.net
Questo quaderno riepiloga il dibattito che si è sviluppato sulle pagine
del quotidiano online ilsussidiario.net intorno all’intervento di Costantino Esposito (Ordinario di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Bari), durante il Meeting per l’amicizia fra i popoli
di Rimini, il 23 agosto 2011.
Il professor Esposito – la cui conferenza viene qui riproposta –
aveva svolto le sue riflessioni nel corso dell'incontro dedicato al titolo del Meeting 2011: “E l'esistenza diventa una immensa certezza”.
La pertinenza delle tematiche affrontate alla situazione dell'uomo
contemporaneo è documentata in queste pagine dalle riflessioni di
personalità autorevoli del mondo culturale italiano, che hanno accettato di paragonarsi con lealtà e serietà con i giudizi proposti a Rimini.
Indice
05
28
31
34
37
40
43
48
50
53
56
62
65
E l’esistenza diventa una immensa certezza
Costantino Esposito
Non ho una certezza ma non smetto di cercare
Intervista a Fausto Bertinotti
La mia certezza ha bisogno della realtà
Intervista a Giulio Sapelli
Le mie quattro piccole grandi «incertezze» sulla certezza
Maurizio Ferraris
Caro Ferraris, perché qualcuno ci ha voluto nel mondo?
Eugenio Mazzarella
Perché anche la fede più grande non smette mai di cercare?
Enrico Berti
Prevarrà la Verità o l'angoscia dello straniero?
Pietro Barcellona
Solo la realtà può sfidare il nichilismo felice
Sergio Belardinelli
La nostra domanda è una navigazione senza fine
Salvatore Veca
Grazie a Dio, non dipendo da nessuna verità
Gianni Vattimo
Caro Esposito, il nostro destino è la ricerca senza fine
Salvatore Natoli
Se l’aiuto più grande alla certezza morale
oggi viene dalla scienza...
Paolo Ponzio
Conclusione
Può esserci una verità senza il nostro io?
Costantino Esposito
3
E l’esistenza diventa
una immensa certezza
Rimini, XXXII Meeting per l’amicizia fra i popoli, 23 agosto 2011
Costantino Esposito
Per prima cosa io vorrei ringraziare chi mi ha invitato a parlare sul
tema del Meeting di quest’anno, perché mi ha dato l’occasione, direi quasi mi ha costretto, a chiedermi con quanta verità mi è possibile – ci è possibile – pensare e dire e domandare della parola
«certezza». A questo proposito devo ammettere, sin dall’inizio,
che non c’è nulla di quanto vi dirò che io non abbia imparato, e
dunque è proprio questa mia scoperta, molto di più delle opinioni
che potrei avere sul tema, ciò che mi preme comunicarvi. Per questo stasera mi permetto di invitarvi a un lavoro comune, perché
senza la vostra presenza, e cioè senza la vostra domanda, il mio
sarebbe solo un discorso, magari un discorso interessante, e non
– come invece spero – un’occasione di conoscenza.
L’incertezza come condizione diffusa del nostro tempo
Sembra che la condizione più condivisa dagli uomini del nostro
tempo – tanto diffusa da risultare quasi insuperabile, come una
condizione ormai «naturale» – sia l’incertezza. E la cosa ha una
sua innegabile evidenza, sia come percezione di una fragilità strutturale a livello psicologico, sia come l’esito di un’insicurezza endemica a livello economico, sociale e politico. Ma il fenomeno merita
un’attenzione particolare, perché del tutto particolare è la sua posta in gioco, la provocazione che esso ci lancia, e che difficilmente
riusciremmo a cogliere in tutta la sua portata limitandoci alle consuete analisi psico-sociali.
Intervenendo a un Festival di filosofia dedicato l’anno scorso al
tema della «fortuna», il sociologo Zygmunt Bauman osservava
acutamente che tutta la cultura moderna era nata con la promessa di sfidare, in una «guerra totale di logoramento» quel «mostro policefalo» che è l’incertezza1. A seguito delle guerre di religione che avevano infiammato e sfigurato l’Europa tra il XVI e il
XVII secolo, i filosofi avevano concluso che «Dio si era ritirato
dalla supervisione diretta e dalla gestione quotidiana della sua
creazione», e che quest’ultima, da parte sua, risultava definitivamente «sorda rispetto ai bisogni e ai desideri degli uomini». Oc5
correva dunque sottoporre il mondo a «una nuova gestione
(umana, questa volta) indirizzata a chiudere i conti una volta per
tutte con i più terribili demoni dell’incertezza: la contingenza, la
casualità, la mancanza di chiarezza, l’ambivalenza, l’indeterminazione e l’imprevedibilità». Questo avrebbe permesso di non far dipendere più la felicità degli uomini dai «colpi di fortuna», né di attenderla come un dono del cielo, ma di conquistarla come «il
prodotto di una programmazione fondata sulla conoscenza scientifica e sulle sue applicazioni tecnologiche».
Tuttavia, questa strategia di controllo non riuscì vittoriosa come si
sperava. Ancora nel XVIII e nel XIX secolo si pensava che la mancanza della vittoria definitiva sull’incertezza dipendesse da una serie di problemi non ancora scientificamente affrontati, ma che, con
il progresso della scienza, alla fine essi sarebbero stati risolti. La
vera novità, il cambiamento drastico, secondo Bauman, è arrivato
invece negli ultimi cinquant’anni (ma io direi anche prima),
quando ha cominciato a mutare lo stesso significato attribuito alla
«contingenza», cioè alla nostra condizione di essere finiti, e dunque dipendenti dai casi della natura e dagli eventi della storia. Se
in precedenza, infatti, ciò che era puramente casuale, imprevisto o
incontrollabile era considerato come un fenomeno marginale di disturbo, a partire dalla seconda metà del XX secolo è come se tutto
invece convergesse verso la precarietà: dalla conoscenza del cosmo all’analisi dell’io individuale, dalle strutture elementari della
materia alla dinamica delle società complesse, i fenomeni collaterali di disturbo venivano interpretati come «attributi primari della
realtà e sua principale spiegazione». Così, «[o]ggi ci stiamo rendendo conto che contingenza, casualità, ambiguità e irregolarità
sono caratteristiche inalienabili di tutto ciò che esiste, e pertanto
sono irremovibili anche dalla vita sociale e individuale degli esseri
umani».
A livello di esperienza individuale, sono cambiate soprattutto le
nostre preoccupazioni e le nostre ansie rispetto all’incapacità di far
fronte con i nostri mezzi alle minacce dell’imponderabile e del
caso: «A farci sentire un’incertezza più orrenda e devastante che
in passato sono la novità nella percezione della nostra impotenza
e i nuovi sospetti che essa sia incurabile»2. Da un lato dunque l’incertezza appare insuperabile; dall’altro lato, però, questo non significa – come ci si aspetterebbe – una rinuncia a trovare assicurazioni per l’esistenza: e da tale contrasto nasce una sempre più
diffusa paura.
Così l’organizzazione sociale, che nell’epoca moderna era stata
6
pensata come un argine rispetto all’instabilità e alla conflittualità
della natura (pensiamo per esempio a Hobbes), finisce per amplificare e moltiplicare i motivi dell’incertezza. Le soluzioni che finora
lo Stato sociale e assistenziale presumeva di poter garantire ai cittadini sono state scaricate sulla capacità dei singoli a trovare risposte individuali a problemi di ordine sociale3; e tuttavia il più
delle volte tale capacità appare come una finzione, perché non ci
sembra proprio di possedere la conoscenza e la potenza adeguate
per far fronte ai pericoli e agli imprevisti della vita. E questo ha
come esito «perdita di autostima, vergogna per essere inadeguati
di fronte al compito e umiliazione». E quasi a suggello di questa
breve storia dell’insicurezza moderna, Bauman conclude: «Tutto
ciò concorre all’esperienza di un continuo e incurabile stato di incertezza, cioè l’incapacità di assumere il controllo della propria
vita, venendo così condannati a una condizione non diversa da
quella del plancton, battuto da onde di origine, ritmo, direzione e
intensità sconosciuti».
L’incertezza ci si presenta così come una sorta di «precariato»
dell’esistenza: ma se da un lato noi continuiamo ad aspettarci
dalla tecno-scienza un controllo previsionale della natura fisica, e
a rivendicare dallo Stato la tutela dei nostri diritti individuali e sociali; dall’altro lato queste aspettative e queste rivendicazioni finiscono forse con il coprire quel livello più radicale e più inquietante
che sempre, poco o tanto, l’insicurezza rende evidente, e cioè che
non siamo i padroni del nostro destino. Ma allora si pone una domanda: la mancanza di certezza coincide totalmente ed esclusivamente con la nostra incapacità a far fronte agli imprevisti della
vita, ai casi della natura e agli accidenti della storia? Se la risposta
è sì, allora l’incertezza è solo il riverbero di uno scacco, di una
condanna, qualcosa come una maledizione. Ma se guardiamo più
attentamente, essa è in grado di attestare anche qualcos’altro,
vale a dire il nostro essere-esposti costitutivamente a ciò che accade, che ci raggiunge, ci tocca, e per ciò stesso ci spiazza, ci provoca, ci chiama in causa.
Il punto essenziale è dunque quello di non ridurre questo fenomeno dell’incertezza: il disagio che esso induce è innegabile e
inaggirabile: ma proprio in quanto tale, esso si mostra come il segno di un enigma più profondo e la traccia di un’inquietudine più
radicale, e cioè del fatto che il nostro compimento, la nostra realizzazione piena non è in definitiva realizzabile da noi. E questo
certamente a motivo della limitatezza della nostra esistenza individuale – ma non solo per questo; e certamente anche per l’inade7
guatezza di tutti quei progetti, scientifici e politici, che ci avevano
promesso un controllo più sicuro e un senso più pieno della vita e
del mondo – ma non solo per questo. In gioco c’è qualcosa di più,
e cioè che noi siamo un bisogno insopprimibile di certezza che non
riusciamo mai effettivamente a colmare. Anche se il più delle volte
copriamo questa impossibilità semplicemente – e comodamente –
negando tale bisogno. Che invece torna immancabilmente a imporsi, anche qualora fossimo garantiti nei nostri diritti e assicurati
nelle nostre aspettative da parte di leggi e strutture superiori. Bisogna dunque accorgersi di questo fattore e cercare di riconoscerne il richiamo.
La lotta impari con la fortuna:
alla ricerca della certezza perduta
Qui si riapre tutta la grande pretesa che ha sempre impegnato il
pensiero filosofico, soprattutto nell’età moderna: essere all’altezza
di riconoscere, spiegare e risolvere il dramma della certezza. Più
ancora dell’incertezza, infatti, è la certezza a essere una possibilità
drammatica per gli esseri umani, poiché essa sempre implica
un’alternativa di fondo: o seguire l’ipotesi che vi sia un significato
certo di sé e del mondo, da accogliere e verificare, oppure al contrario ritenere che esso sia solo una produzione, più o meno riuscita, della nostra mente.
Oggi questa partita filosofica si gioca soprattutto in quella che
possiamo chiamare la più diffusa ideologia del nostro tempo, vale
a dire il «naturalismo». Esso si fonda sull’idea che tutto quanto
nell’esperienza umana possa essere spiegato in base a determinati
fattori e meccanismi fisico-chimici e neuronali, riducendo così
tutto il nostro bisogno di certezza a una raffinata strategia evolutiva con cui gli uomini si premuniscono per la sopravvivenza, e
cioè per contrastare quella che resta pur sempre la grande legge
della natura, vale a dire il ciclo ininterrotto della nascita e della
morte. Ma nel naturalismo contemporaneo è presente anche un’altra idea, un’idea antica, quasi arcaica, che viene rivitalizzata paradossalmente attraverso i più raffinati avanzamenti delle scienze
biologiche e delle neuroscienze, e cioè che il vero destino degli uomini, il significato ultimo della loro esistenza, consista nella loro
appartenenza all’impersonale, necessario meccanismo della natura.
Il razionalismo filosofico moderno, almeno a partire dal XVII secolo con Spinoza, ha cercato di spiegare la radice del timore pro8
vocato in noi dall’incertezza della nostra condizione finita, sostenendo che esso è solo il frutto dell’ignoranza e del dannoso influsso della tradizione ebraico-cristiana, secondo la quale il finito
ha nell’infinito la sua origine e il suo destino. Ma se l’incertezza è
frutto dell’ignoranza, la soluzione razionalista consiste nel superarla attraverso una purificazione del nostro intelletto e una liberazione dalle nostre passioni, in modo da accettare in maniera sempre più convinta il nostro destino naturale. Per non essere più
divorati dal cancro dell’incertezza è necessario abbandonare una
volta per tutte l’idea che l’essere umano e il mondo intero possano
avere un’origine e uno scopo più grandi di sé. E quindi, in qualche
modo, si tratta di ribaltare il senso cristiano della libertà e della
storia. Si delinea così un programma che porterà i suoi frutti
estremi in un pensatore emblematico come Friedrich Nietzsche, il
quale così scrive nel Crepuscolo degli idoli (1888): «nessuno dà
all’uomo – né Dio, né la società, né i suoi genitori, né lui stesso –
le sue proprie caratteristiche […]. Nessuno è responsabile della
sua esistenza, del suo essere costituito in questo o in quel modo,
di trovarsi in quella situazione e in quell’ambiente. La fatalità della
sua natura non può essere districata dalla fatalità di tutto ciò che
fu e che sarà. Egli non è la conseguenza di un personale proposito, di una volontà, di uno scopo […]. Siamo stati noi a inventare
il concetto di «scopo»: nella realtà lo scopo è assente… Si è necessari, si è un frammento di fato, si appartiene al tutto, si è nel
tutto […] Ma fuori del tutto non c’è nulla! – […] tutto ciò soltanto è
la grande liberazione – con ciò soltanto è nuovamente ristabilita
l’innocenza del divenire»4.
Questa risposta non può essere liquidata a buon mercato: essa ci
inquieta sempre e, per molti, costituisce la più radicale alternativa
rispetto alla tradizione cristiana (e anche a tutte le filosofie che, in
un modo o nell’altro, sono derivate da quella tradizione, come è
per esempio lo stesso illuminismo). Ma se la si esamina con attenzione, si vede chiaramente che questa rinuncia alle categorie metafisiche dell’Occidente cristiano (che ci sia un fine nella natura e
negli esseri umani, che l’essere finito abbia una relazione costitutiva con l’infinito, che la libertà umana nasca e si eserciti solo a
partire dal riconoscimento di altro da sé) viene pagata a un prezzo
altissimo: la decisa svalutazione dell’io come soggetto irriducibile,
ossia come punto di «rottura» o «discontinuità» rispetto alla ferrea necessità dell’ordine naturale. In questa prospettiva, infatti, la
stessa volontà libera dell’uomo si compirà nell’accettazione della
fatalità, come se il tempo e la storia non potessero riservarci più
9
alcuna novità, ma solo un’eterna ripetizione. Ascoltiamo ancora
quello che scrive Nietzsche ne La gaia scienza (1882): «Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo
nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: “questa vita,
come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta
e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di
nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e
ogni cosa indicibilmente piccola e grande della tua vita dovrà fare
ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione – e così
pure questo ragno e questo chiaro di luna tra i rami e così pure
questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene
sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!”.
Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il
demone che così ha parlato? Ma potrebbe anche darsi che tu abbia vissuto per una volta sola un attimo immenso, per cui avresti
risposto così: “Tu sei un dio e mai intesi cosa più divina!”. […]
quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più
alcun’altra cosa che questa ultima, eterna sanzione, questo suggello?»5.
Ecco il punto infuocato di tutta la questione: amare se stessi per
Nietzsche significa non desiderare altro che la necessità di se
stessi, e ritenere che i propri desideri non abbiano mai un termine
più grande del meccanismo dei nostri bisogni naturali. Ma, alla
fine, chi potrà mai raggiungere questa posizione? Solo il saggio,
solo colui che sarà capace di «costruire» se stesso, così come avveniva nelle tecniche ascetiche dei filosofi pagani. Lo ha notato
con chiarezza Salvatore Natoli, a proposito del neo-paganesimo
che attraversa la nostra epoca: «per essere all’altezza di quel che
il tempo richiede è necessario ripiegarci su noi stessi, raccogliere
tutta la nostra potenza e trasformarci in punti di resistenza. […]
D’altra parte è noto che si è tanto più se stessi quanto meno si dipende. E solo se non si dipende ci si dona liberamente»6.
L’ideale sarebbe dunque quello del ritorno dell’areté, della pratica
delle antiche virtù, il più nobile tentativo di prendere in mano il
proprio destino, non nel senso della hybris, cioè di un’affermazione tracotante di sé, ma nel senso del «prendere su di sé il proprio peso». E la suprema virtù in quest’opera di auto-formazione
consiste proprio nella moderazione, nell’auto-regolamentazione e
nel governo di sé, in quello che i greci chiamavano «autarchia». In
tale prospettiva l’uomo virtuoso è colui che è capace di «amministrare la propria potenza» nella misura in cui sa misurare il proprio
desiderio, senza rinunciare a esso, certo, ma senza mai cedervi:
10
infatti «il desiderio è potenza che illude perché ci fa dimenticare
che siamo una quantità finita di forza»7.
Quello che avveniva nelle pratiche morali degli Stoici e degli Epicurei, il cui scopo era di creare la propria natura e di forgiare la propria misura di uomini, sembra trovare una singolare assonanza in
alcune tendenze di punta dell’odierna antropologia culturale
(penso ad esempio a un autore come Francesco Remotti), che sottolineano con forza come l’essere umano sia il prodotto di un continuo processo di «antropo-poiesi», cioè di costruzione della propria identità. La stessa «natura umana», secondo questa
prospettiva, non è nulla di dato, ma va assunta senz’altro come
un’illusione o una «finzione di umanità», nel senso che essa viene
di volta in volta elaborata come una fiction culturale, che dipende
esclusivamente dal grado di adattamento all’ambiente naturale e
al contesto sociale8.
Da questo punto di vista viene a cadere, come illegittima, la
stessa certezza di una base oggettiva della soggettività umana,
ossia la presenza condivisa di alcuni fattori caratteristici di essa,
giacché la natura umana, intesa come struttura, non dice molto di
più che la mera appartenenza alla specie, mentre il problema del
senso dell’esistere è ridotto a un’opzione meramente «soggettiva». Se dunque la natura umana non è più qualcosa di oggettivamente dato, essa sarà qualcosa da guadagnare e da raggiungere
attraverso lo sviluppo di tutta una serie di diritti (ma anche di divieti) che un’epoca, una cultura e una società stabiliscono di volta
in volta come determinanti per i soggetti individuali. L’altro lato
della necessità naturale è così il relativismo culturale.
Ma c’è sempre un punto che rimane aperto, direi drammaticamente irrisolto. E sebbene si tenti ogni volta di chiuderlo, esso si
riapre di continuo. Alla fine, infatti, sia accettando come insuperabile l’ordine necessario delle cause naturali, sia cercando di resistervi attraverso un’auto-formazione interiore, sia semplicemente
accogliendo come inevitabile la finzione e l’illusione come la vera
sostanza della nostra natura, il sentimento dominante non potrà
essere che quello di un’ultima insensatezza del nostro io. Questo
non vuol dire che non abbiamo più scopi o soddisfazioni, o che
manchiamo di progetti e di traguardi significativi nella vita personale e sociale, ma piuttosto che di fronte alla necessità del tutto –
unica ragione certa dell’essere – noi siamo sempre per così dire un
caso irrazionale, fortuito di esistenza. Così la certezza si suddivide,
da un lato, nell’assumere come unico senso dell’esistere il fatto
che siamo costretti a esserlo, secondo la legge dalla natura; dal11
l’altro lato, nell’approntare un’auto-assicurazione – attraverso
tutta una serie di diritti e garanzie – che ci permetta di resistere al
caso, cioè al nulla e alla morte.
Si dirà che in fondo questo è il nostro «destino», la nostra natura.
Ma se è così – ci chiediamo – perché questa natura non basta a se
stessa? Perché l’accidentalità e la casualità della nostra esistenza
sulla grande scena del mondo continua a crearci disagio e patimento? Perché tutte le spiegazioni che se ne possono dare non ci
appagano?
All’origine, la certezza dell’esistenza
L’incertezza ci inquieta proprio perché essa ci provoca a scoprire
che, all’inizio, noi siamo indelebilmente segnati da una certezza –
ecco il colpo di scena che il nostro stesso essere ci riserva: è solo
perché in qualche modo noi la conosciamo già, questa certezza,
che possiamo patirne la mancanza. Non si tratta di un’assicurazione o di una garanzia che abbiamo in anticipo sulla vita, ma
dell’esperienza originale che tutti ci ha segnati: quella di essere
voluti e accolti dallo sguardo amoroso di nostra madre e di aver
percepito il senso, magari non ancora cosciente ma certamente
presente, del nostro esistere naturale suggendo il suo seno. La
certezza che precede ogni incertezza e che a sua volta ogni incertezza clamorosamente attesta, è il fatto che noi siamo venuti all’essere in un rapporto, siamo di qualcuno, e in quanto tali siamo
davvero noi stessi. È in questa memoria che si apre lo spazio di
senso del nostro bisogno di certezza.
Quando affermo che dobbiamo andare al fondo dell’incertezza non
sto certo dicendo – si badi – che dobbiamo essere contenti di una
condizione di precarietà e confusione; al contrario, sto ipotizzando
che tutta la nostra debolezza non sarebbe neanche sperimentabile
se, dal fondo di essa, non si ridestasse quello che vale come un
imprinting del nostro io, vale a dire la certezza di un significato
che ci viene da altro da noi e da prima di noi. La certezza non è
qualcosa che innanzitutto costruiamo, ma è qualcosa che innanzitutto riceviamo. È qualcosa che ci genera, e che solo in quanto
tale può diventare nostra. Né si può dire che questa esperienza
non sia originale per tutti: basta osservare, come prova al contrario, quanti problemi derivino in fondo proprio dalla sua mancanza.
Viene in mente quello che diceva Agostino d’Ippona parlando del
desiderio più condiviso tra tutti gli uomini, vale a dire quello della
vita beata, della felicità: un desiderio che sarebbe del tutto incom12
prensibile, se gli uomini non sapessero già cosa fosse la felicità o
non ne avessero in qualche modo già fatto esperienza – anche se
in maniera embrionale e incompleta – in modo da poterla ricordare, desiderare e sperare. Solo perché abbiamo sperimentato la
gioia (gaudium), solo perché ci siamo già rallegrati di qualcosa che
riempiva il nostro animo, possiamo addirittura essere tristi per la
sua mancanza. E per Agostino non si tratta di un godimento qualsiasi, di una soddisfazione a buon mercato, ma di un godimento
vero, o meglio di un godimento del vero (gaudium de veritate),
ossia di una realtà certa perché infinita, più grande di sé9.
Ma viene in mente anche il percorso fatto da Cartesio, il quale era
partito da una condizione di dubbio universale su tutto quello che
c’è al mondo ed era arrivato a scoprire come unica certezza l’esistenza del nostro io come puro pensiero, sostanza pensante intesa
in maniera solipsistica, cioè separata da tutto ciò che è altro dal
pensiero, compreso il nostro stesso corpo. E poi però, proprio riflettendo sulle idee che questo io solitario può pensare, Cartesio si
rende conto che ve ne è una – l’idea dell’infinito o di Dio – che il
nostro io pensante trova in se stesso, pur essendo incapace di
produrla da sé, essendo egli una sostanza finita. Così, proprio colui che è passato alla storia come l’inventore del soggetto moderno può scrivere: «da ciò segue necessariamente che io non
sono solo al mondo»10, e che quindi «in me la percezione dell’infinito viene prima in qualche modo di quella del finito, ossia la percezione di Dio prima di quella di me stesso. In qual maniera infatti
sarei consapevole di dubitare, di desiderare, cioè di esser mancante di qualcosa, e di non essere del tutto perfetto, se non ci
fosse in me l’idea di un ente più perfetto, paragonandomi con il
quale riconoscessi le mie mancanze?»11.
Questa esperienza originaria della certezza, intesa come un rapporto costitutivo dell’io, non si manifesta soltanto in alcuni casi
particolari, per quanto importanti (come nella memoria agostiniana della felicità o nella percezione cartesiana dell’infinito), ma
rappresenta la struttura permanente di ogni nostro gesto cognitivo
e affettivo. La certezza è il riconoscimento soggettivo, ossia l’assenso che noi diamo a una verità – a un fatto, a un sentimento, a
un’idea, a un incontro – che si presenta come un fenomeno oggettivo: e oggettivo non semplicemente perché accade fuori di noi,
ma perché più precisamente si manifesta come «altro» da noi. E
può essere «altra» anche un’intuizione che emerga improvvisa nel
nostro spirito o una convinzione che abbiamo a lungo elaborato
nel nostro intelletto, non meno di un’impressione empirica o di
13
una percezione sensibile. Non sto dicendo che tutte le volte che
noi avvertiamo una tale certezza si tratti effettivamente di una verità «oggettiva», poiché potrebbe anche darsi che si tratti solo di
una credenza psicologica che prima o poi si riveli non meritevole
del nostro assenso (e quante volte abbiamo constatato amaramente di esserci sbagliati o illusi?); dico solo che quella della certezza è una condizione caratteristica, ossia una posizione inevitabile del nostro essere individui coscienti, consapevoli di sé e del
mondo. L’esser-certo può essere addirittura individuato come la
postura fondamentale del nostro «io». E come ce ne accorgiamo?
Ogni qual volta noi, incalzati dall’urgenza delle cose o dall’appello
delle circostanze, chiediamo il «perché», noi attestiamo a noi
stessi di essere fatti per una risposta, cioè di essere un desiderio
di verità e un bisogno di certezza.
Questo nesso strettissimo tra la ricerca e la certezza trova una
conferma illuminante in un libro recente del filosofo Diego Marconi, in cui viene commentata una celebre frase di Gotthold
Ephraim Lessing, il padre nobile dell’Illuminismo tedesco del XVIII
secolo. Scriveva Lessing: «Ciò che determina il valore del singolo
uomo non è la verità di cui egli è in possesso o di cui si crede in
possesso, ma il sincero sforzo per giungervi. Infatti, le sue forze
conseguono un miglioramento non in virtù del possesso della verità, ma in virtù della sua ricerca, e soltanto in questo consiste il
sempre crescente perfezionamento umano. Il possesso rende
quieti, pigri e presuntuosi»12. Così, se Dio avesse nella mano destra tutta la verità e nella sinistra l’eterno impulso a ricercare la
verità, e ci chiedesse di scegliere una delle due, Lessing non
avrebbe dubbi: la pura verità è riservata tutta a Dio e va lasciata
solo a Lui; la ricerca è tutta e solo dell’uomo, ed è l’unica cosa che
l’uomo può e deve scegliere. A questo proposito nota argutamente
Marconi: «Mai mi sognerei di negare il valore della ricerca filosofica o religiosa: tuttavia, questa idea di Lessing [cioè che l’importante sia la ricerca per la ricerca e non il trovare, n.d.r.] mi è sempre sembrata una nobile sciocchezza. Dalle chiavi di casa alla
terapia efficace del carcinoma ovario, si cerca per trovare. Se davvero si pensasse che non c’è nulla da trovare o che è impossibile
trovarlo, si smetterebbe di cercare (infatti non si cerca più di quadrare il cerchio o di realizzare il moto perpetuo). La nobilitazione
della ricerca rispetto al suo eventuale risultato è una razionalizzazione di quella che si considera l’estrema povertà dei risultati conseguiti […]: un tentativo di salvare il salvabile, pregiando il viaggio
più della meta, a cui non si riesce ad arrivare e che forse non esi14
ste. Ma è una razionalizzazione controproducente, perché fa di
un’impresa forse vana un’impresa sicuramente sciocca»13.
Ribaltando l’equazione di Lessing, potremmo dire che se una ricerca fosse solo fine a se stessa, con il tempo non si ridesterebbe
più, né ci renderebbe insonni, ma piuttosto languirebbe e finirebbe
per inaridirsi: non è il ritrovamento del vero, ma è piuttosto la rinuncia a esso il segno della pigrizia della ragione. Sta di fatto che
con Lessing si è già consumato il divorzio tra la ricerca del vero e
il possesso del vero, così che da un lato ricercare significa non dover mai giungere a una risposta, e dall’altro possedere significa
non dover cercare più. Se noi facciamo invece attenzione a come
la certezza si forma nella nostra esperienza, possiamo vedere che
essa costituisce l’ipotesi che guida ogni ricerca e quindi non si
identifica mai solo con la conclusione di un percorso, ma piuttosto
con l’intera dinamica del rapporto tra il nostro io e l’essere, tra la
nostra intelligenza e il darsi del mondo.
Il problema non riguarda soltanto la validità delle nostre conoscenze razionali considerate in se stesse, poiché esso porta a galla
dimensioni e opzioni fondamentali della nostra intera esperienza
personale. Per questo rilancio la posta e mi chiedo: quando diveniamo certi di qualcosa?
La certezza come il rischio dell’assenso:
ragione e volontà
Se la certezza implica sempre un assenso, allora essa consiste in
un atto dell’intelletto determinato dalla volontà. Da questo punto
di vista essa richiede per così dire un’adesione al vero – potremmo
dire una «fede» o «fiducia», in senso assolutamente non fideistico
o sentimentale, ma pienamente conoscitivo e razionale –, proprio
perché la certezza non è mai un procedimento meccanico, ma implica la nostra libertà. Alcuni filosofi, penso ad esempio a Edmund
Husserl, hanno chiamato questo atto primario della nostra intelligenza addirittura una «fede originaria» (Urglaube o Urdoxa). Ne
troviamo un’affascinante descrizione in questo brano di Hans Urs
von Balthasar: «Hanno ragione […] quei filosofi i quali, all’alunno
che si trova incerto e smarrito davanti al problema della verità,
danno il consiglio di gettarsi innanzi tutto nella corrente, per fare
esperienza, corpo a corpo con l’onda, di che cosa sia l’acqua e
come vi si avanzi. Chi non arrischia questo salto non sperimenterà
mai che cosa sia nuotare; e così pure, chi non osa il salto nella verità non raggiungerà mai la certezza dell’esistenza di essa. Questo
15
primo atto di fede, della fiducia che si butta, non è affatto irrazionale, bensì è la semplice premessa ad accertarsi in via di principio
dell’esistenza del razionale»14.
Ma questo rischio originario è anche l’inizio di una disponibilità che
non può interrompersi mai, proprio perché la certezza non è mai
acquisita una volta per tutte. Continua von Balthasar: «Come il
nuotatore deve nuotare sempre per non affondare, nonostante sia
divenuto sempre più abile nella disciplina del nuoto, […] così in
definitiva anche colui che conosce deve porsi ogni giorno, in maniera nuova, la domanda sull’essenza della verità, senza essere
per questo uno scettico sterile e distruttivo»15.
È quello che Tommaso d’Aquino chiamava «il cogitare», vale a dire
quel cammino di ricerca e di discussione che la nostra intelligenza
si trova a percorrere per poter raggiungere infine la «certezza
dell’evidenza» (certitudo visionis)16. Sia quando percepiamo dei
dati sensibili particolari, sia quando cogliamo dei concetti universali, quello che si richiede per arrivare alla certezza è un «atto di
decisione dell’intelletto» (actus intellectus deliberantis), chiamato
a verificare le ragioni per cui aderire al vero che ci si presenta.
La conferma più clamorosa di questo procedimento la si può vedere nel caso di quella certezza peculiare che è la fede. Non parlo
qui solo dell’originario atto di fiducia di cui si è appena detto, e
grazie al quale ci arrischiamo nella conoscenza della realtà, ma di
quell’atto razionale con il quale riconosciamo con certezza un
«dato» reale in base a indizi, segni o testimonianze indirette, ma
senza poterlo dedurre solo logicamente o misurare solo empiricamente. Ora, per Tommaso la fede non è ancora raggiunta mediante il semplice atto dell’intelletto che ha per oggetto il vero e il
falso, ma richiede un’adesione dell’io, o come egli dice, un «cogitare approvando» (cogitare cum assensu), intendendo per «assenso» o «approvazione» «un atto dell’intelletto in quanto determinato a una data cosa dalla volontà»17.
Questo vuol dire che per noi uomini la certezza non è mai una
conclusione obbligata o meccanica, dovuta alla dimostrazione necessaria di qualcosa nella sua inoppugnabile verità, né è mai un
acquisto fatto una volta per tutte, ma è piuttosto una strada in cui
la verità è sempre in attesa dell’approvazione di un «io» conoscente, e in quest’io è sempre richiesta l’azione aperta, rischiosa,
mai già pre-costituita della volontà libera. Alla natura della certezza appartiene dunque il fattore-tempo, condizione dell’esercizio
della libertà. Al di fuori della strada del tempo non vi sono scorciatoie, tranne quella del dogmatismo e dello scetticismo; e il non af16
frontare questo percorso non rende affatto più facile, bensì molto
più difficile, se non addirittura impossibile, accedere alla verità.
È stato soprattutto John Henry Newman a mettere a fuoco lo stupefacente fenomeno dell’assenso, quale condizione permanente
della certezza umana. Tutti gli oggetti che noi conosciamo, siano
essi cose concrete (cioè apprese per esperienza diretta e per immagini), siano essi nozioni interne alla nostra mente (che inferiamo per via indiretta da altre cose), richiedono un atto di assenso del nostro spirito. Ora, a noi sembrerebbe quasi ovvio dire
che il nostro assenso sarà tanto più certo, quanto più i nostri ragionamenti sono sviluppati attraverso una dimostrazione logica,
ossia attraverso una concatenazione necessaria di nozioni (come
accade per esempio in una legge fisico-matematica). E viceversa,
quanto meno i nostri ragionamenti dipendessero da una deduzione
logica (come ad esempio accade nei rapporti tra gli esseri umani),
tanto meno certo dovrebbe essere il nostro assenso. Newman ribalta invece la questione, permettendoci di scoprire una dinamica
sorprendente, che peraltro è sempre all’opera nella nostra conoscenza quotidiana: è proprio quando i nostri ragionamenti seguono la via della probabilità, cioè quando essi non si sviluppano
attraverso una piena dimostrazione razionale di verità, bensì, più
modestamente, attraverso illazioni da segni non del tutto espliciti,
ma bisognosi di attenzione e di interpretazione da parte nostra,
ebbene proprio allora l’assenso può essere incondizionato, cioè
pieno di ragioni. E questo non in maniera avventata o infondata,
ma con piena legittimità: quanto più è aperta l’avventura dell’interpretazione dei segni della realtà, tanto più è urgente, ma anche
pienamente possibile, il percorso della certezza.
«L’assenso in base a ragionamenti non dimostrativi [cioè non immediatamente evidenti per sola coerenza logica] è un atto troppo
universalmente riconosciuto per essere irrazionale, a meno che
non sia irrazionale la natura umana; è troppo familiare alla menti
più prudenti e lucide, per essere una debolezza o una stravaganza. Nessuno di noi può pensare o agire senza accettare delle
verità, non intuitive, non dimostrate, eppure sovrane. Se mai la
nostra natura possiede una costituzione e delle leggi, una di esse
consiste nell’accettare assolutamente, come vere, delle proposizioni che si trovano al di fuori del campo ristretto delle conclusioni
alle quali è vincolata la logica»18.
Sono molteplici i casi in cui noi diamo il nostro assenso incondizionato a cose che ci si presentano con delle prove solo probabili e
non dimostrate in senso assoluto: tutti per esempio crediamo (be17
lieve) indubitabilmente di esistere, di essere nati in una certa
data, di essere individui con una identità; così come tutti crediamo
senza dubbio che esiste un mondo esterno e che esistono altri io
diversi da noi, che ieri è successo un certo avvenimento e così via.
Ma molteplici sono anche i casi in cui il fondamento della certezza
è dato dalla fiducia che riponiamo in qualcuno. Come quando
(l’esempio è di Newman) una madre insegnasse al suo bambino a
ripetere un verso di Shakespeare – come «La virtù stessa si volge
in vizio, quando è male applicata» – e suo figlio le chiedesse cosa
significhi: allora lei potrebbe rispondergli che è ancora troppo giovane per capirlo, ma che quel verso possiede «un bel significato»
(a beautiful meaning), che egli in futuro potrà comprendere. Allora
il bambino, «confidando» nelle parole della madre (in faith on her
word), potrebbe dare il suo assenso alla proposizione espressa nel
verso shakespeariano, ossia «non al verso che aveva imparato a
memoria e il cui significato sarebbe fuori dalla sua portata, ma al
suo essere vero, bello e buono»19. Questo assenso possiede «una
forza e una vivacità» (a force and life) superiore ad altri assensi,
perché per il bambino «la sincerità e l’autorevolezza della madre
non costituiscono una verità astratta o la materia di una conoscenza generale, ma sono legate all’immagine e all’amore della
sua persona, che è parte di lui», tanto che egli «non esiterebbe a
dire che darebbe la vita per difendere la sincerità della madre»20.
Sarebbe dunque scorretto confondere la dinamica del nostro assenso a proposizioni vere (cioè ad affermazioni circa la verità delle
cose) con il grado di dimostrabilità logica di esse. Non che la prova
logica non sia importante, s’intende, ma se la si assume come
unico criterio del nostro assenso, sarebbe come se (secondo un altro esempio di Newman) per avvertire il fresco che ci viene dall’aria aperta ci limitassimo a leggere i gradi segnati sulla colonnina
di mercurio di un termometro, come se fosse il mercurio in sé la
causa della vita e della salute: «Se proviamo caldo o freddo, nessuno ci convincerà del contrario insistendo che il termometro segna 15 gradi. È la mente che ragiona e dà l’assenso, non un diagramma su un pezzo di carta»21.
Questa naturale capacità di assentire della nostra mente, accompagnata dall’ulteriore capacità di riflettere sul proprio assenso, costituisce per Newman il carattere peculiare della certezza umana:
essa è, secondo le sue parole, «la percezione di una verità con la
percezione che è una verità»22. Se dunque in ogni atto di conoscenza è richiesto il nostro assenso, il più delle volte in maniera
spontanea e non riflessa; nella certezza questo assenso viene per18
cepito esplicitamente, cioè diviene cosciente di sé. È come se (lo
dico con parole mie) conoscendo qualcosa di vero io ne percepissi
il gusto, il sapore – appunto, il sapere pieno e vissuto –, mi accorgessi del vero che mi raggiunge e di come io sono raggiunto, toccato, cambiato da esso. Questo genere di conoscenza, nella quale
sapendo qualcosa noi siamo al tempo stesso consapevoli di saperla – la certezza appunto – non solo è necessaria all’io per conoscere e per agire, ma ha bisogno a sua volta di tutto l’io, cioè della
nostra persona nella sua interezza – ragione, sentimento, volontà,
libertà – per essere raggiunta.
Apertura
Forse adesso siamo in grado di comprendere un poco di più la
frase di don Giussani che segna il Meeting di quest’anno: «l’esistenza diventa una immensa certezza»23: è nel verbo che mi pare
si raccolga il punto più interessante di questo fenomeno. La certezza è qualcosa che viene scoperto continuamente, non è un «assoluto», come la si interpreta superficialmente o ideologicamente,
ma è un «accaduto», e più precisamente qualcosa che continua ad
accadere, poiché se non accadesse nel presente non esisterebbe
affatto.
E in realtà, come potrebbe l’uomo superare la verifica più esigente
della certezza, quella rappresentata dal limite e del male? Non rischierebbe forse anche la nostra certezza più originale – come
quella del rapporto con nostra madre o con chi ci vuole veramente
bene – di soccombere di fronte al dolore e alla morte? D’altra
parte, potremmo mai accontentarci di proiettare la nostra certezza
al di là dell’esperienza presente, come un sogno o un’utopia, una
sorta di triste consolazione necessaria per vivere? Il dramma della
certezza mostra qui tutta la sua radicalità: il suo bisogno è infinito, e non può essere soddisfatto da niente di meno che dall’infinito.
Ci è voluto qualcosa di inatteso e sorprendente per riuscire a sperimentare un’altra possibilità di certezza, rispetto alla necessità del
meccanismo naturale o a quella della deduzione logica, ma che
non si riducesse nemmeno a una speranza irrealizzabile nel presente. È dovuto venire Cristo, nella carne del mondo, per riaprire il
ciclo inesorabile del tempo naturale, ponendosi come principio di
conoscenza nuova, l’unico capace di valorizzare fino in fondo il bisogno di significato, e cioè l’attesa di compimento e il desiderio di
felicità di ogni singolo uomo. Cristo è quel caso unico nella storia
19
dell’uomo, in cui il significato, il logos, è diventato amico del caso.
E da allora in poi ogni «caso» – ogni persona e ogni accadimento
– non è stato più solo un caso: e non perché, come in alcune filosofie pagane, tutto è necessario o addirittura tutto è Dio (il panteismo), ma perché Dio è diventato uomo, permettendo all’uomo di
essere finalmente se stesso, cioè un essere che domanda, desidera e attende, certo della risposta.
Come ogni studioso del pensiero filosofico non può non riconoscere, è il cristianesimo che ha inaugurato la possibilità della libertà: non la semplice possibilità di scegliere una cosa rispetto a
un’altra, ma la possibilità di scoprire il valore irriducibile, infinito di
me in virtù del rapporto diretto con chi mi ha creato e mi sta creando ora. Ed è il cristianesimo che ha inaugurato la storia, il cammino verso il compimento in virtù di un avvenimento che ha dato
una nuova direzione al tempo. C’era bisogno di Cristo perché la
certezza dell’uomo non fosse pagata al prezzo della sua libertà, né
sottratta al dramma della storia, ma al tempo stesso non fosse tenuta sotto scacco dalla finitezza e dalla morte. Grazie alla sua resurrezione nella carne si è compiuta una vera e propria «rivoluzione copernicana» nella possibilità di conoscenza e nella capacità
di certezza dell’uomo. Quel fatto si è presentato e continua a presentarsi nella storia come l’avvenimento più pertinente alla ragione umana, perché afferma una presenza misteriosa dell’essere
che non è riducibile alla natura, ma grazie alla quale noi possiamo
divenir certi che la natura stessa e la vita ci è donata, è «per» noi.
Come ancora osserva don Giussani, è grazie a un «dono dello Spirito» che l’uomo può diventare, appunto, consapevole della «gratuità abissale» del suo essere, scoprendo che la solitudine e l’impotenza sono vinte grazie alla forza di un Altro. Ed è solo perché
questa realtà misteriosa ci raggiunge di continuo, e non per una
nostra illusione o peggio per una nostra presunzione, che la certezza può diventare «immensa».
C’è sempre, nella vita di un uomo, un punto in cui questo significato almeno una volta si è reso manifesto, attraverso la testimonianza di uomini certi; ed è quello che la tradizione cristiana ha
chiamato con il nome più oggettivo e laico, cioè il meno ideologico
o clericale che si possa immaginare: che noi siamo chiamati ad essere in ogni istante, che il nostro io è «vocazione», che noi siamo
strutturalmente in rapporto con quello che ci dà l’esistere e con
Chi ci dona il senso dell’esistere; e questo senso non è mai una
motivazione astratta ma si gioca sempre in incontri storici, nei
«casi» della vita, appunto.
20
Non si tratta, come si può vedere, di un programma elaborato dai
filosofi, ma di un fenomeno che permette un’inaspettata novità
per la stessa filosofia, intesa qui come la domanda cosciente della
ragione sul senso ultimo di sé e del mondo. Per me personalmente, la verifica più interessante e anche più stringente di questa novità nel mio lavoro filosofico, è stato scoprire che la certezza
inaugurata da Cristo è l’unico caso in cui una risposta totale e ultima alla domanda dell’uomo non annulla questa domanda, semplicemente risolvendola, ma anzi la rimette in moto, la alimenta, e
addirittura la esalta come la strada propria dell’umano. Al contrario di quanto si ritiene abitualmente, per pigrizia o per inesperienza, è solo un uomo certo che può essere veramente inquieto e
finanche godere della propria inquietudine, come un’attesa che
permette alla certezza di riaccadere sempre24.
È davvero singolare questa dinamica dell’esperienza svelata dal
cristianesimo: proprio perché la certezza non è una nostra costruzione, essa è ciò di cui abbiamo veramente bisogno per tutte le
nostre costruzioni, sia a livello personale che sociale. È questo che
in fondo fa la differenza nella storia: non solo che la certezza sia
più o meno assicurata dal funzionamento delle strutture dello
Stato (che comunque resta un fattore di grande importanza: basti
pensare alla vertiginosa moltiplicazione di incertezza che in questi
giorni sta condizionando la vita economica, lavorativa e politica di
moltissimi Paesi), ma che siano in gioco degli uomini, i quali, per
una certezza vivente su di sé, possano affrontare le tante situazioni di crisi, e guardarle in modo diverso, direi più concreto e più
realistico. Ogni crisi infatti può essere guardata come una chance
per comprendere tutta l’ampiezza del nostro bisogno, e paradossalmente per riconoscere che c’è un bisogno irriducibile a tutte le
nostre strategie di soluzione. Ma, appunto, è grazie a questo bisogno più grande, immenso, che possiamo tentare di dar risposte efficaci ai tanti bisogni della vita e della società. Potremmo descrivere questo percorso come il passaggio dall’assistenzialismo al
protagonismo, da un’immagine di certezza come un’assicurazione
che garantisca dagli imprevisti della vita a una certezza come il riconoscimento del significato irriducibile e inesauribile di noi stessi,
e come affezione, adesione, decisione per esso.
C’è un sintomo che forse più degli altri attesta questo lavoro della
certezza, ed è che cambia la percezione del tempo. Il tempo infatti
può rappresentare la grande, inevitabile contestazione di ogni sicurezza, per il semplice fatto che destina tutto a passare; ma può
essere anche la grande prova, la più radicale verifica della cer21
tezza riguardo alla ragione per cui siamo al mondo. E il segreto di
questa verifica, il motore del tempo, se così posso esprimermi, è il
nostro domandare. Ogni qualvolta un uomo chiede il «perché» di
sé, degli eventi, delle cose, accade una novità – piccola o grande
che sia – nel flusso altrimenti meccanico o caotico degli eventi, e il
tempo diventa storia: non solo un passare di accadimenti, ma l’accadere dell’io.
Come ci è stato ricordato nel messaggio di saluto di Benedetto XVI
al Meeting di quest’anno, «L’uomo non può vivere senza una certezza sul proprio destino. […] Solo quando il futuro è certo come
realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. […] Il fatto che
questo futuro esista, cambia il presente; il presente viene toccato
dalla realtà futura, e così le cose future si riversano in quelle presenti e le presenti in quelle future»25. Anche in questo caso Cristo
permette all’uomo una possibilità di esistenza altrimenti sconosciuta, cioè quella della speranza nel futuro che nasce dalla certezza presente: «Egli è l’eschaton già presente, colui che fa dell’esistenza stessa un avvenimento positivo, una storia di salvezza
nella quale ogni circostanza rivela il suo vero significato in rapporto all’eterno».
Per questo la certezza è riservata a chi non cessa di domandare;
ma si può continuare a domandare il perché di se stessi e del
mondo, solo domandando a Qualcuno che con la sua presenza desta il mio desiderio di essere, cioè di conoscere e di amare. È
quella scoperta di cui una volta ha raccontato Dante, quando dice
di aver intravisto negli occhi di Beatrice un nutrimento che non fa
mai finire la fame o estinguere la sete, anzi, è tale da ridestarle di
continuo:
«Mentre che piena di stupore e lieta
l’anima mia gustava di quel cibo
che, saziando di sé, di sé asseta»26.
1. Si tratta del «Festival di Filosofia» tenutosi a Modena, Carpi e Sassuolo dal
17 al 19 settembre 2010 sul tema «Fortuna». L’intervento di Z. Bauman
era stato parzialmente anticipato sul quotidiano la Repubblica del 16 settembre 2010 con il titolo: La società dell’incertezza, trad. di D. Francesconi, pp. 46-47, da cui citiamo.
2. Bauman ha approfondito questa analisi, tra gli altri luoghi, soprattutto in
Liquid Fear, Polity Press, Cambridge 2006, trad. it. di M. Cupellaro, Paura
liquida, Laterza, Roma-Bari 20084.
3. Cfr. U. Beck, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della globalizzazione, ed. it. a cura di S. Mezzadra, trad. di L. Burgazzoli, il Mulino, Bologna 2000. Ma si vedano anche: Ch. Lasch, L’io minimo. La mentalità della
22
4.
5.
6.
7.
8.
9.
23
sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, trad. it. di M. Cornalba, Feltrinelli, Milano 1985 (ultima ed. 2010) e M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca
delle passioni tristi, trad. it. di E. Missana, Feltrinelli, Milano 2004 (ultima
ed. 2011).
«Niemand [giebt] dem Menschen seine Eigenschaften, weder Gott, noch die
Gesellschaft, noch seine Eltern und Vorfahren, noch er selbst […]. Niemand
ist dafür verantwortlich, dass er überhaupt da ist, dass er so und so beschaffen ist, dass er unter diesen Unständen, in dieser Umgebung ist. Die Fatalität seines Wesens ist nicht herauszulösen aus der Fatalität alles dessen,
was war und was sein wird. Er ist nicht die Folge einer eignen Absicht, eines
Willens, eines Zwecks […]. Wir haben den Begriff “Zweck” erfunden: in der
Realität fehlt der Zweck […] Man ist nothwendig, masn ist ein Stück Verhängniss, man gehört zum Ganzen, masn ist im Ganzen […] Aber es giebt
Nichts ausser dem Ganzen! – […] dies erst ist die grosse Befreiung – damit
erst ist die Unschuld des Werdens wieder hergestellt»: F. Nietzsche, GötzenDämmerung, oder Wie man mit dem Hammer philosophirt, «Die vier grossen
Irrthümer», § 8, in Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe, VI/Bd. 3, de
Gruyter, Berlin 1969, pp. 90-91; trad. it. di F. Masini, Crepuscolo degli idoli,
ovvero Come si filosofa col martello, «I quattro grandi errori», Adelphi, Milano 1983, pp. 64-65.
«Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: «Dieses Leben, wie due es jetzt lebst
und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz un jede
Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse
deines Lebens muss dir wiederkommen, und Alles in der selben Reihe und
Folge – und ebenso die Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen,
und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom
Staube!» – Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen
ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: «du bist ein
Gott und nie hörte ich Göttlicheres!». […] wie müsstest du dir selber und
dem Leben gut werden, um nach Nichts mehr zu verlangen, als nach dieser
letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung? –»: F. Nietzsche, Die fröhliche
Wissenschaft, Aph. 341, in Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe,
V/Bd. 2, de Gruyter, Berlin 1973, p. 250; trad. it. (qui modificata) di F. Masini, La gaia scienza, aforisma 341: «Il peso più grande», Adelphi, Milano
1977, pp. 201-202.
S. Natoli, Il buon uso del mondo. Agire nell’età del rischio, Mondadori, Milano 2010, p. 136.
Ibidem, p. 141.
Cfr. F. Remotti, Contro natura. Una lettera al Papa, Laterza, Roma-Bari
2008, pp. 207 e 211.
Aurelius Augustinus, Confessionum libri tredecim / Le confessioni, testo latino dell’ed. Skutella riveduto da M. Pellegrino, trad. it. e note di C. Carena, Citta Nuova («Nuova Biblioteca Agostiniana»), Roma 1993, in part.
X.20.29-X.23.33.
10. «…hinc necessario sequi, non me solum esse in mundo»: R. Descartes,
Meditationes de prima philosophia, III, ed. Adam-Tannery, vol. VII, p. 42;
trad. it. (qui modificata) di I. Agostini, Meditazioni di filosofia prima, in
Opere 1637-1649, testo francese e latino a fronte, a cura di G. Belgioioso,
Bompiani, Milano 2009, p. 737.
11. «…nam contra manifeste intelligo plus realitatis esse in substantia infinita
quam in finita, ac proinde priorem quodammodo in me esse perceptionem
infiniti quam finiti, hoc est Dei quam mei ipsius. Qua enim ratione intelligerem me dubitare, me cupere, hoc est, aliquid mihi deesse, et me non esse
omnino perfectum, si nulla idea entis perfectioris in me esset, ex cujus comparatione defectus meos agnoscerem?»: R. Descartes, Meditationes de
prima philosophia, cit., pp. 45-46; trad. it. cit. (qui modificata), p. 741.
12. «Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgend ein Mensch ist, oder zu sein vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen. Denn nicht den Besitz,
sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte,
worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit bestehet. Der Besitz
macht ruhig, träge, stolz»: G.E. Lessing, Eine Duplik (1778), in: Sämtliche
Schriften, Hrsg. Lachmann-Muncker, Reprint de Gruyter, Berlin 1968, Bd. 13,
pp. 23-24; trad. it. (qui modificata), Una controreplica, in Id., Religione e libertà, a cura di G. Ghia, Morcelliana, Brescia 2000, p. 33.
13. D. Marconi, Per la verità. Relativismo e filosofia, Einaudi, Torino 2007, p.
44.
14. «So behalten denn auch jene Philosophen recht, die dem Adepten, der zögernd und ratlos vor dem Problem der Wahrheit setzt, den Rat erteilen, sich
erst in den Strom hineinzustürzen, um Leib an Leib mit der Welle zu erfahren, was Wasser ist und wie man darin vorankommt. Wer diesen Sprung
nicht wage, werde nie erfahren, was schwimmen heißt, und so werde auch,
wer den Sprung in die Wahrheit nicht wage, niemals die Gewißheit ihrer Existenz erlangen. Dieser erste Akt des Glaubens, des sich hingebenden Vertrauens sei keineswegs irrational, sondern die schlichte Vorbedingung dafür,
sich der Existenz des Rationalen überhaupt zu vergewissern». H.U. von Balthasar, Theologik, Bd. 1: Wahrheit der Welt, Johannes Verlag, Einsiedeln
1985, p. 13; trad. it. di G. Sommavilla, Verità del mondo, vol. 1 di Teologica,
Jaca Book, Milano 1989, p. 29.
15. «Wie der Schwimmende immer schwimmen muß, um nicht unterzugehen,
obwohl er es vielleicht zu immer größerer Meisterschaft in der Schwimmkunst gebracht hat, […] und so muß schließlich auch der Erkennende täglich
neu die Frage nach dem Wesen der Wahrheit stellen, ohne deswegen ein unfruchtbarer und zerstörerischer Zweifler zu sein»: H.U. von Balthasar, Theologik, Bd. 1: Wahrheit der Welt, cit., p. 14; trad. it. cit. (qui modificata), p.
29.
16. «…dicitur cogitare magis proprie consideratio intellectus quae est cum quadam inquisitione, antequam perveniatur ad perfectionem intellectus per certitudinem visionis»: Thomas de Aquino, Summa theologiae, IIª-IIae, q. 2,
art. 1, co (trad. it. a cura dei Domenicani italiani, La somma teologica, testo
latino dell’ed. leonina a fronte, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1985).
17. «Et ideo assensus hic accipitur pro actu intellectus secundum quod a volun24
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
25
tate determinatur ad unum»: Thomas de Aquino, Summa theologiae, IIªIIae, q. 2, art. 1, ad 3.
«Assent on reasoning not demonstrative is too widely recognized an act to
be irrational, unless man’s nature is irrational, too familiar to the prudent and
clear-minded to be an infirmity or an extravagance. None of us can think or
act without the acceptance of truths, not intuitive, not demostrated, yet sovereign. If our nature has any constitution, any laws, one of them is this absolute reception of propositions as true, which lie outside the narrow range
of conclusions to which logic, formal or virtual, is tethered»: J.H. Newman,
An Essay in aid of A Grammar of Assent, ed. a cura di I.T. Ker, Clarendon
Press, Oxford 1985, cap. VI, § 1/5, p. 118; trad. it. (qui modificata) di M.
Marchetto, Saggio a sostegno di una grammatica dell’assenso, in Id., Scritti
filosofici, testo inglese a fronte, Bompiani, Milano 2005, pp. 1143-1145.
«…and he, in faith on her word, might give his assent to such a proposition,
– not, that is, to the line itself which he had got by heart, and which would
be beyond him, but to its being true, beautiful, and good»: J.H. Newman, An
Essay in aid of A Grammar of Assent, cit., pp. 17-18; trad. it. cit., p. 877.
«Her veracity and authority is to him no abstract truth or item of general
knowledge, but is bound up with that image and love of her person which is
part of himself […]. Accordingly, […] he would not hesitate to say […] that
he would lay down his life in defence of his mother’s veracity»: J.H. Newman,
An Essay in aid of A Grammar of Assent, cit., p. 18; trad. it. cit., p. 879.
«If we feel hot or chilly, no one will convince us to the contrary by insisting
that the glass is at 60°. It is the mind that reasons and assents, not a diagram on paper»: J.H. Newman, An Essay in aid of A Grammar of Assent,
cit., p. 119; trad. it. cit. (qui modificata), pp. 1145-1147.
«Certitude […] is the perception of a truth with the perception that it is a
truth»: J.H. Newman, An Essay in aid of A Grammar of Assent, cit., chap. VI,
§ 2/3, p. 129; trad. it. cit., p. 1175 (corsivo nostro).
L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, Milano 2006, p.
109.
Ho tentato di documentare questa posizione nel mio recente volume Una
ragione inquieta. Interventi e riflessioni nelle pieghe del nostro tempo, Edizioni di Pagina, Bari 2011.
Cfr. Benedetto XVI, Enciclica Spe salvi, nn. 2 e 7.
Purgatorio, XXXI, vv. 127-129.
IL DIBATTITO
da ilsussidiario.net
27
Non ho una certezza
ma non smetto di cercare
Intervista a Fausto Bertinotti *
Lei che rapporto ha con la certezza? «Non lo dico con una formula,
che suonerebbe assai incerta. La mia dimensione interiore è piuttosto quella dell’incertezza. Ma avverto il bisogno di cercare la certezza, e capisco chi dice che è una ricerca senza posa. So di non
arrivarci, ma per questo non smetto di cercare».
Fausto Bertinotti, sindacalista, leader storico di Rifondazione comunista, ex presidente della Camera dei deputati, si è fatto mandare la relazione che ieri, nei padiglioni della fiera di Rimini, il filosofo Costantino Esposito ha tenuto sul titolo del Meeting, E
l’esistenza diventa una immensa certezza. «Preferisco limitarmi a
un ossimoro, quello delle certezze relative. In esse mi sento molto
più a mio agio - dice Bertinotti - anche se comprendo la portata,
pur senza accettarla, di una certezza che diviene “immensa” come
quella di Cl».
Presidente, l’incertezza è la condizione più diffusa del nostro tempo. Tanto che tutta la cultura moderna si è proposta di sfidare quel «precariato dell’esistenza» che condiziona così profondamente le nostre vite.
La relazione di Esposito comincia con uno scacco della modernità
che mi sembra troppo radicale. Mi attengo a una esperienza più
circoscritta. Condivido le affermazioni sull’assolutizzazione della
scienza e sul suo tentativo prometeico di risolvere una volta per
tutte i destini umani. Ma bisogna andare oltre. Questa ideologia,
giustamente denunciata, si poggiava e si poggia, per quel che ne
resta, su una cosa ben più sostanziosa, e cioè la ricostruzione del
primato del capitale sull’uomo, la mercificazione dei rapporti
umani. È questa la base materiale di quella gigantesca riduzione,
la «base oggettiva» dell’umanità citata.
L’uomo ha usato il suo potere per chiudere i conti con l’incertezza, ma tutti i tentativi – dice Esposito – non possono
nascondere un fatto inoppugnabile, che tutta la modernità
sembra confermare: non siamo padroni del nostro destino.
Nella vicenda contemporanea c’è senz’altro questa ricerca di asso28
luto quasi prometeica dell’uomo per ritirarsi dall’incertezza esistenziale, legata al suo essere creatura finita. Ma, ripeto, la modernità non è solo scacco. Vedo anche una grande speranza: la
speranza di poter mettere alle spalle gli orrori degli stermini di
massa e delle tragedie di ogni prevaricazione. Molto dobbiamo alla
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, alla costruzione delle Nazioni
unite, a quello straordinario capolavoro politico istituzionale che è
la nostra Costituzione repubblicana...
Cosa c’entra la Costituzione, presidente?
Nel suo articolo 3 c’è una cosa maturamente laica. Non dice che il
compito dello stato è il raggiungimento della felicità, ma quello di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana. Sono elementi di realismo
politico e civile, frutto di altrettante certezze civili e politiche di chi
ha investito il presente con una grande passione.
Il disagio personale con il quale lei accusa le contraddizioni
del capitalismo non è il sintomo di un fatto profondamente
umano, e cioè che noi non abbiamo un bisogno di certezza
– sulle sorti e sul bene dell’uomo, per esempio –
ma siamo questo bisogno?
È un discorso che sfiora gli assoluti e come tale è legittimo, guai a
censurarlo. Ma se mi chiede di dialogare su questo, la mia risposta
è nel fatto che la politica in cui io credo e che traduce in opera il
carattere finito dell’uomo, appartiene all’ambito delle certezze
possibili, relative. È questo l’ambito al quale sento di appartenere.
Sì, preferisco limitarmi a un ossimoro, quello delle certezze relative. Comprendo che questa dimensione lasci umanamente insoddisfatti...
Cosa intende dire?
La certezza è sempre tentativo di approssimazione. È questa la
«mia» certezza. La certezza che lascia intatto il grande interrogativo sul destino dell’uomo, aperto, come domanda, alle sollecitazioni che il credente, a differenza del non credente, vede manifestarsi al di là dell’orizzonte.
Siamo indelebilmente segnati da una certezza: «è solo perché la conosciamo già, questa certezza, che possiamo patirne la mancanza».
È la lezione di Agostino. In questa tessitura dell’accettazione del29
l’incertezza, c’è l’idea della disponibilità della piena certezza solo
nella ricongiunzione con Dio, e se posso dire così, solo nel mistero
della Croce. Fuori da quella Certezza c’è un’incertezza da accettare come uomini nudi su questa terra. Non è la mia posizione: io
opto per l’impegno nel tempo e nello spazio che mi tocca di vivere, indotto e stimolato da queste grandi sollecitazioni che non
possono essere negate, se non perdendo troppo. Ma a esse non
sono in grado di dare una risposta.
Esposito dice che il nostro assenso alla verità – la certezza
– non è mai un procedimento meccanico, implica sempre la
nostra libertà. La certezza «accade» continuamente, proprio come accadono i fatti che chiedono l’assenso della nostra libertà.
Questo è un approccio «processuale» che mi trova molto d’accordo. La certezza, come la verità, sono campi di ricerca che non
possono essere espunti in nome o di un pragmatismo ottuso o di
un certezza precostituita, dogmatica. La definizione del processo è
un buon approccio metodologico, perché da un lato ricomprende
la ricerca della verità, e dall’altro gli assegna un processo dialogico
di incontro e di scontro in cui non è dato di sapere in partenza se
potrai mai arrivare.
Alla fine si dice che il bisogno infinito dell’uomo non può
essere colmato da nessuna cosa finita. All’infinito del cuore
può rispondere compiutamente solo un Infinito che si rivela
e si incarna.
È una formula troppo assolutizzante, che rispetto, ma che non fa
per me. Vi vedo un pericolo: un elemento che nega qualsiasi autonomia a questa nostra vicenda umana storica.
Ma le interessa la verità?
Avverto il bisogno di cercare la certezza, e capisco chi dice che è
una ricerca senza posa. So di non arrivarci, ma per questo non
smetto di cercare.
(Federico Ferraù)
mercoledì 24 agosto 2011
* Presidente della Fondazione della Camera dei Deputati
30
La mia certezza
ha bisogno della realtà
Intervista a Giulio Sapelli *
«L’esser-certo può essere addirittura individuato come la postura
fondamentale del nostro “io”. E come ce ne accorgiamo? Ogni qual
volta noi, incalzati dall’urgenza delle cose o dall’appello delle circostanze, chiediamo il “perché”, noi attestiamo a noi stessi di essere
fatti per una risposta». E ancora: «È solo perché in qualche modo
noi la conosciamo già, questa certezza, che possiamo patirne la
mancanza. Non si tratta di un’assicurazione o di una garanzia che
abbiamo in anticipo sulla vita, ma dell’esperienza originale che
tutti ci ha segnati: quella di essere voluti e accolti dallo sguardo
amoroso di nostra madre». Sono solo alcuni passaggi della lezione
che il filosofo Costantino Esposito ha tenuto ieri al Meeting di Rimini, in un auditorium pieno zeppo, per illustrarne il titolo. Un’ampia meditazione sulla malattia del moderno, sulle contraddizioni
che annichiliscono l’uomo quando pretende di negare la natura
delle cose, e sulla possibilità di ridiventarne certi, partendo dalla
propria esperienza. Una lezione che Giulio Sapelli, economista, ha
subito avuto piacere di commentare.
Qual è la sua prima impressione, professore?
Una relazione bella, molto impegnativa ma scorrevole. E molto
colta. Esposito ha spiegato molto bene la decostruzione del moderno e in esso la tragicità dell’uomo, che si ritrova grumo di materia senza senso. Si può aggiungere che la coscienza che sopravvive al moderno, inoltrandosi nel postmoderno, non è più la
coscienza dell’uomo reale, ma quella di una individualità raziocinante, destinata a smarrirsi nelle pieghe del «testo» che oramai
coincide con la realtà. Per il postmoderno la realtà è narrazione,
costruzione teorico-letteraria dell’intelletto.
Con quali conseguenze?
La vera incertezza che domina oggi è quella dell’incompiutezza nel
passare da individuo a persona. Si è perduta l’obbligazione morale, cifra dell’autonomia morale e con essa della trascendenza
della persona. Noi siamo reali, siamo carne, ci realizziamo nella
realtà e al tempo stesso la trascendiamo nell’obbligazione morale.
31
È questo legame tra verità e realtà che il pensiero moderno oggi
ha distrutto.
L’incertezza non ci basta perché nel nostro cuore c’è una
certezza, più grande, che la precede.
Vero. Credo però che in tempi come questi san Paolo ci sia ancora
molto d’aiuto e possa dare una grossa mano ad Agostino. Nell’escatologia di san Paolo la certezza è realmente fondata, perché
c’è il cambiamento nella verità. Sono due approcci che non si
escludono.
In altri termini?
La certezza piena prende il suo «sapore» – come dice Esposito –
quando è raggiunta nella prassi, il che vuol dire, in breve, nella
concretezza della vita. Non c’è bisogno di essere storicisti. Possiamo essere certi della resurrezione della carne, però la certezza
è certezza anche nella trasformazione della realtà. Perché se io
sono certo, ma la realtà va da un’altra parte, allora non mi serve a
nulla superare l’incertezza. Allora preferisco vivere a margine tra
certezza e incertezza. Oggi la certezza non può fare a meno di un
elemento di trasformazione. È l’«attualità» della posizione giudaico-cristiana.
Che cos’ha di così diverso?
La redenzione deve cominciare anche su questa terra, con il cambiamento della vita. Se no, francamente, passare dall’incertezza
postmoderna della realtà come narrazione alla certezza legata a
un piano salvifico che non riguarda solo la persona ma tutta
l’umanità, mi sembra una diminuzione. Come se mancasse qualcosa.
Può documentare quello che sta dicendo?
Oggi i giovani hanno bisogno non di un sogno – lasciamo stare
questa parola, figlia ormai dell’universo consumistico –, ma di un
impegno trasformatore. Cosa cercavano i giovani a Madrid? Una
certezza, non c’è dubbio, ma anche un cambiamento. La certezza
o si documenta nel cambiamento o non è. Ed è proprio questa la
cosa fondamentale che il pensiero postmoderno nega.
In altri termini, la realtà di cui sono certo mostra la sua oggettività in un impegno trasformatore.
Certamente. Passo dall’incertezza alla «vera» certezza guada32
gnando non una certezza astratta, ma una certezza che nasce
dalle buone pratiche. Mi sembra questo il punto di Archimede per
vivere meglio nel presente. Lo dice bene Esposito quando scrive
che la certezza non appartiene tanto all’assoluto, ma è piuttosto
un accaduto. Se il Fatto cristiano alimenta la mia fede, non mi lascia inerte.
Che cosa la colpisce di più pensando al titolo del Meeting,
«E l’esistenza diventa una immensa certezza»?
Quell’immensità, che non deve apparire una semplice aggiunta retorica. Che cosa vuol dire immensa? Che solo la presenza del divino riempie l’esistenza di certezza, sostenendo un cammino debole e incerto. Diciamocelo, siamo uomini tra gli uomini. Siamo
pieni di dubbi, non riusciamo a realizzare noi stessi, non riusciamo
a fare quello che vorremmo. Vogliamo l’immensità, la stessa agognata da Leopardi nel suo Infinito, ma restiamo tremolanti. Non
ne siamo capaci per la presenza del male. Il male è il peccato.
Quando citiamo Agostino, non dimentichiamo il lato oscuro, che è
quello su cui ha sempre lavorato Pascal: Dov’è Dio, come mai non
si mostra, perché mi ha abbandonato? Non dev’essere una domanda oziosa, se anche Cristo se lo è chiesto sulla croce. Il peccato è un evento fondamentale della teologia cristiana, ma siamo
portati a razionalizzarlo troppo rapidamente...
mercoledì 24 agosto 2011
* Professore ordinario di Storia economica presso l’Università degli Studi di Milano
33
Le mie quattro piccole grandi
«incertezze» sulla certezza
Maurizio Ferraris *
Ogni tendere, ogni premere
è quiete eterna nel Signore Iddio.
Ecco, nei versi di Goethe, la potente certezza che sta al centro del
discorso di Costantino Esposito, che a grandi linee procede così.
Noi viviamo in uno stato di incertezza, che paradossalmente è
stato accresciuto, e non diminuito, dai progressi tecnico-scientifici.
La modernità, che è l’epoca della massima conoscenza, è anche
l’epoca della massima inquietudine. E questa inquietudine tocca il
suo picco nella seconda metà del Novecento, cioè con il postmoderno. Per ritrovare la sicurezza è dunque necessario seguire
un’altra via. Non pensare che la pace possa venirci dalla oggettività e dalla conoscenza (le quali oltretutto ci inchiodano alla nostra
dimensione biologica, dunque – sostiene Esposito – alla disperazione). Ma viceversa puntare sulla certezza e sull’affidamento, sul
rimettersi ad altri con la fiducia che il bambino ha nei confronti
della madre. Si tratta di un discorso lucido, onesto, aperto e profondo, che però vorrei confrontare con quattro piccole o grandi incertezze rispetto alla certezza.
La modernità porta incertezza? Ne siamo certi? Ecco il primo interrogativo. Pensiamo alla vita dei nostri lontanissimi antenati nelle
savane: si viveva vent’anni, il tempo di consumare le due dentizioni, poi ancora i denti del giudizio come extrema ratio, poi la
morte per fame e reumatismi, se prima non si era mangiati dai
leoni. I nostri progenitori erano dunque ben più esposti di noi, e la
loro vita era infinitamente più breve, crudele, brutale e insensata
della nostra.
È in questo orizzonte che trovano la loro remotissima origine fede
e sapere. Nelle tombe troviamo strumenti tecnici, armi e suppellettili, e oggetti religiosi, per esempio statue di dei. Questi due tipi
di ritrovati sono evoluti in parallelo, non per accrescere, ma per
diminuire l’incertezza. Tuttavia se oggi viviamo in un mondo incomparabilmente più sicuro, se – banalmente ma decisivamente –
la nostra vita dura enormemente di più, questo non dipende dalla
fede, bensì dal sapere, che dunque a tutti gli effetti ha accresciuto
34
le nostre certezze. E se siamo così sensibili all’incertezza non è per
un qualche fallimento della modernità, ma piuttosto perché siamo
diventati più civili ed esigenti, con un processo affine a quello per
cui oggi non sopporteremmo le operazioni senza anestesia subite
dai nostri antenati.
Sicurezza emotiva o certezza oggettiva? Il secondo interrogativo
è: siamo certi che, come sostiene Esposito, la prima certezza sia
la dipendenza dalla madre in quanto affetto e non l’oggettività,
cioè la certezza sensibile con cui inizia la Fenomenologia dello
spirito di Hegel? Non solo perché la madre non l’hanno conosciuta
tutti, mentre gli oggetti sì, ma anche perché è anzitutto come certezza sensibile che si instaura il rapporto fiduciario tra il bambino
e la madre.
Ciò detto, è vero che la certezza è qualcosa che – come il coraggio
secondo don Abbondio – uno non se la dà, ma la riceve. Però, di
nuovo, la riceviamo in continuazione dal mondo, stabile e certo di
fronte a noi. L’osservazione di Newman, secondo cui noi siamo
tanto più certi quanto meno abbiamo messo in moto dei ragionamenti, è sacrosanta. Ma, come è chiaro anche da molti esempi di
Newman, è intimamente connessa con l’esperienza sensibile, perché altrimenti avremmo a che fare con il credo quia absurdum, o
addirittura con la cieca sottomissione all’autorità.
Certezza o speranza? Il terzo interrogativo è: siamo certi che la
certezza sia il sommo bene? La depressione è a ben vedere l’esperienza umana più vicina alla pace eterna e alla certezza assoluta.
È questo che rende insoddisfacente e inspiegabile anche la rappresentazione della vita eterna, quando cerchiamo di fissarla in contorni più precisi. Molto più forte della certezza, molto più decisiva,
è la speranza (che ha sempre al proprio interno un elemento di incertezza), come intuitivamente si capisce se confrontiamo la diversa gravità dei loro contrari, l’incertezza e la disperazione.
Diversamente da Esposito non credo affatto che l’essere umano,
quando abbia rinunciato a un ordine trascendente, sia necessariamente consegnato alla disperazione. Si tratterebbe anzi di capovolgere il discorso, e di notare come proprio il nostro essere
naturalmente nel mondo richieda una forma di speranza, come dimostra – anche qui – l’esperienza della depressione, ossia appunto della disperazione. Il mondo si chiude e si riapre di fronte a
noi a seconda del nostro grado di speranza, e noi abbiamo bisogno
delle endorfine proprio come abbiamo bisogno delle proteine.
Così, la speranza precede ogni rivelazione religiosa, e può evolvere sino a diventare una speranza razionale e valida per tutti gli
35
uomini. Ossia una speranza che non collide con quanto sappiamo
del nostro essere naturale, diversamente da ciò che accade per la
speranza, rispettabilissima ma valida solo per i credenti, nella resurrezione.
Certezza o verità? E qui veniamo a una quarta incertezza cruciale.
Siamo certi di poter essere certi della certezza? Dobbiamo fidarcene? Ci sono delle madri cattive, sia in senso proprio, sia in
senso figurato; ci sono mistificatori e manipolatori, sia in nome
della ragione sia in nome della fede. Inoltre, la certezza, e proprio
l’esperienza sensibile ce lo dimostra, può essere ingannevole.
Così, posso essere vittima di allucinazioni; oppure mia madre potrebbe non essere mia madre, e potrei al limite essere come le papere di Lorenz; oppure ancora, come è successo ai ragazzi della
Hitlerjugend, la mia certezza e il mio affidamento fondamentale
potrebbe chiamarsi Adolf Hitler.
Dunque la certezza da sola non basta, ha bisogno della verità,
cioè del sapere. E in questo campo piuttosto che con l’esperienza
dell’affidamento alla madre ci confrontiamo con l’esperienza opposta, con l’uscita dell’uomo dall’infanzia e con «l’osa sapere!», cioè
con i caratteri dell’Illuminismo secondo Kant. Infatti nessuno nega
che alla luce dell’affidamento, della certezza, della dipendenza, si
possa vivere e morire, e forse anche molto bene. Lo riconosce lo
stesso Kant quando, in Che cos’è l’illuminismo? osserva che «è
tanto comodo essere minorenni». E certo Edipo sarebbe vissuto
meglio se non avesse saputo la verità. Questi moventi pratici,
anzi, «eudemonistici», si sarebbe detto una volta, non ci esentano
da una considerazione: vivere nella certezza, proprio per quello
che ha detto Esposito, non è vivere nella verità. Ora, proprio in
nome della verità, dobbiamo chiederci: la promessa di pace e di
certezza, magari l’«adorare, gioire, tacere» con cui un grande filosofo, Antonio Rosmini, ha chiuso la propria esperienza terrena, dà
pace. Ma questa pace non rischia di confondersi con gli strumenti
del Grande Inquisitore, il Miracolo, il Mistero, l’Autorità?
venerdì 16 settembre 2011
* Professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di
Torino
36
Caro Ferraris, perché qualcuno
ci ha voluto nel mondo?
Eugenio Mazzarella *
E l’esistenza diventa una immensa certezza. Fin dal titolo la relazione al Meeting di Rimini di Costantino Esposito espone una
sfida e una scommessa: che l’esistenza, e la sua percepita friabilità individuale e collettiva, possa diventarla, la certezza di sé che
non avverte. Perché quale certezza può essere asseverata oggi,
l’«età dell’incertezza» di tanta autorevole sociologia contemporanea? Le analisi di Bauman ne sono un’icona concettuale: l’incertezza è la condizione del nostro tempo, esito conclamato della
guerra persa dalla modernità per affrancarsene.
Per il «progetto moderno» l’incertezza avrebbe dovuto essere una
condizione progressivamente riducibile dall’avanzamento dell’umana capacità, tramite la scienza e la tecnica, di autoassicurarsi
nel mondo. Non pare essere andata così. Gli ultimi cinquant’anni,
il postmoderno se si vuole, del progetto moderno hanno dichiarato
l’incompiutezza di principio: contingenza, casualità, ambiguità e irregolarità sono emerse come «caratteristiche inalienabili di tutto
ciò che esiste, e pertanto sono irremovibili anche dalla vita sociale
e individuale degli esseri umani» (Bauman).
Ma il sospetto che questa incertezza sia incurabile, non si traduce
in un’accettazione della necessità, in una «benedizione del fato»,
nel nietzscheano «vangelo della necessità»: l’uomo comune,
l’uomo che ha rilievo sociologico, non rinuncia a trovare assicurazioni per l’esistenza; e da tale contrasto nasce una sempre più diffusa paura.
Le ricette «neo-pagane» della saggezza (Natoli) sul filo SpinozaNietzsche restano per pochi; e a livello di massa al più esitano
nello stordimento consumistico al supermercato delle occasioni
della vita da afferrare, salvo il venir meno di questo stordimento
quando alla «cassa», sempre più spesso per tanti, scopri di non
aver più di che pagare. Come Esposito ci fa notare, crollate con la
certezza «interna» (lo spaesamento interiore di un io consegnatosi
ai paesaggi del relativismo) insieme tante surrogate certezze
dall’«esterno» (Stato e società), l’incertezza ci si presenta come
una sorta di generale «precariato» dell’esistenza.
Come è possibile allora che «l’esistenza diventi una immensa cer37
tezza»? Perché questo, né più né meno, è il percorso che Esposito
ci propone, riprendendo l’invito – l’affermazione di un’esperienza
possibile – di Giussani. Per far questo Esposito ci propone un cambiamento di direzione dello sguardo, che è in sé un’esperienza di
conoscenza: una conversione, una metanoia – un rivolgimento di
tutto lo sguardo nel cambiamento di direzione, avrebbe scritto
Heidegger –: in origine e all’origine l’esperienza umana è l’esperienza della certezza, il caldo sentire di un affidamento a un altro
che ci cura e ci ha in cura fin dall’inizio, dal nostro inizio e dall’inizio di ognuno.
Il modulo cognitivo-esperienziale che fonda il nostro esserci è
quest’originario maternage, dell’essere figli di qualcuno: noi veniamo al mondo, siamo posti nel nostro essere, da Qualcuno e con
Qualcuno, che è e resta la nostra originaria “provvista” di certezza. Noi veniamo a noi nell’assenso (Newman) che diamo a questa certezza, a questo «sentire» del tutto ragionevole e previo a
ogni razionalità discorsiva e in definitiva suo fondamento. Tener
viva questa certezza, ravvivarla nella vita di ogni giorno e di ogni
momento è riprendersi – riprendere sé – in questo originario
legame a Qualcuno che ci costituisce, vera fonte della certezza:
antropologicamente il volto e la voce della madre.
L’«incertezza della vita» in tutta la latitudine dei suoi sensi –
quella che ci appare un primum irredimibile, nel recidersi di questo legame, e da cui tenersi lontani nello stordimento della vita o
da sostenere come necessità del destino se si è capaci – viene
dopo; è la continua, strutturale «tentazione» della vita: l’esposizione a cadere fuori della certezza che originariamente è e in cui
originariamente si è: il «ruinio della vita fattizia» di cui ha parlato
una volta il giovane Heidegger. L’Altro che da sempre mi chiama, e
che nell’esperienza del venire al mondo ha il volto della madre e la
sua voce, è la risposta sempre possibile a questa tentazione, e
sempre da dare. Ma possiamo rispondere solo se sappiamo avvertirci «chiamati ad essere in ogni istante»; se teniamo fermo «che
il nostro io è vocazione, che noi siamo strutturalmente in rapporto
con quello che ci dà l’esistere e con Chi ci dona il senso dell’esistere; e questo senso non è mai una motivazione astratta ma si
gioca sempre in incontri storici, nei casi della vita».
Sul filo di quest’esperienza di chiamata, in cui l’esistenza è fin
dall’inizio coinvolta, dietro il volto della madre che chiama, è sempre lì che ci chiama, per chi sa ascoltarla, un’altra Voce, che ci invita a guardarlo in Volto: sopravanza un maternage ultrafondativo
dell’esperienza antropologica, il maternage creaturale; dietro mia
38
madre, a sostenerne le braccia che mi sostengono, c’è il Dio Padre
e Madre, anche di mia madre, e nel Figlio di ogni figlio che ci può
essere.
È solo girando su questo cardine che alla vita si apre dall’immensa
incertezza del mondo la porta dell’esistenza come certezza, l’esistenza diventa (ridiventa) quella che è nella sua origine: certezza.
Questa è la lectio che il Meeting voleva proporre, consegnandosi,
nel limpido e coinvolgente percorso mirabilmente tracciato da Costantino Esposito, al rivivimento interiore dei suoi ascoltatori.
lunedì 19 settembre 2011
* Professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università Federico II di
Napoli
39
Perché anche la fede più grande
non smette mai di cercare?
Enrico Berti *
La bella relazione di Costantino Esposito all’ultimo Meeting di Rimini ha suscitato in me una reazione di totale adesione, oltre che
di ammirazione per la profondità del pensiero e l’efficacia dell’esposizione. Essa mi ha ricordato, ma per contrapposizione, il famoso scritto di Wittgenstein Della certezza, rispetto al quale si
pone, per così dire, all’estremo opposto di un arco di considerazioni sul tema, che va dalla certezza del senso comune, illustrata
appunto da Wittgenstein, a una certezza che chiamerei metafisica
o religiosa, come quella illustrata da Esposito. La mia reazione ha
stupito anzitutto me stesso, perché, lo confesso, non ho mai
amato la certezza, forse per colpa dell’uso che ne ha fatto Descartes. Alla certezza, che considero un sentimento soggettivo, ho
sempre preferito la verità, intesa alla maniera classica di conformità alla realtà oggettiva. Ma vedo ora, grazie alla relazione di
Esposito, che le due cose, certezza e verità, vanno in un certo
senso insieme, perché la certezza presenta le stesse differenze
che mi è capitato recentemente di sottolineare a proposito della
verità.
Per chiarire quello che intendo dire mi rifaccio a uno dei passi per
me più incisivi della relazione, il richiamo che Esposito fa al libro di
Diego Marconi, Per la verità, col quale mi sono trovato anch’io in
perfetta consonanza. Esposito concorda con Marconi nell’affermare
che «si cerca per trovare», anche se oggi è molto più di moda dire
che si cerca per cercare, che la ricerca è fine a se stessa, che è
meglio cercare che trovare. Come mi è già capitato di scrivere, secondo me queste ultime affermazioni sono espressioni di ipocrisia,
perché chi cerca solo per cercare, e non è interessato a trovare,
non cerca veramente, ma soltanto finge di cercare, dato che il cercare è oggi considerato molto più «aperto», più «democratico», in
definitiva più chic, che il trovare. Come scrive invece Marconi,
«dalle chiavi di casa alla terapia efficace del carcinoma ovario, si
cerca per trovare». Tuttavia Marconi premette a queste parole le
seguenti altre: «mai mi sognerei di negare il valore della ricerca
filosofica o religiosa», col che fa capire che ci sono forme diverse
di ricerca, così come forme diverse di «trovare», e io aggiungerei
40
forme diverse di verità e forme diverse di certezza.
Ci sono infatti verità particolari, come le verità di fatto («oggi
piove») o le verità di ragione (2+2=4), oppure come le verità storiche e le verità scientifiche, e ci sono verità che chiamerei generali, come le verità filosofiche e le verità religiose. Mentre le verità
particolari, una volta trovate (attraverso l’esperienza, o il ragionamento, o ricerche più complesse), producono una certezza che elimina ogni incertezza, e quindi il loro ritrovamento estingue la
ricerca, le verità generali si comportano diversamente, perché il
loro ritrovamento produce, sì, una certezza, ma si tratta di una
certezza che si accompagna a una persistente incertezza, una certezza che non estingue la ricerca. Questo accade, secondo me, nel
caso delle verità filosofiche e delle verità religiose, o, se si preferisce, delle certezze filosofiche e delle certezze religiose.
Naturalmente, parlando di verità filosofiche, mi riferisco a quella
filosofia che personalmente considero vera, cioè una metafisica di
tipo problematico e dialettico, epistemologicamente debole ma logicamente forte, quale mi è capitato più volte di illustrare. La certezza che questa metafisica produce, cioè la certezza che il mondo
dell’esperienza, considerato nella sua totalità (realtà naturale,
umana, sociale, storica, scientifica), non spiega interamente se
stesso, ma richiede necessariamente una spiegazione che lo trascende, è sì una certezza, nel senso che è un punto di arrivo, una
scoperta, ma è una certezza che si accompagna a una persistente
incertezza, perché non estingue, anzi riafferma, la problematicità
del mondo dell’esperienza, cioè la sua non assolutezza, la sua
contingenza, la sua precarietà, la quale è fonte continua di meraviglia, cioè di bisogno di spiegazione.
Per dirla con Aristotele, il quale ha identificato la filosofia con la
meraviglia, ma ha anche affermato che bisogna arrivare al contrario, «cioè – come dice il proverbio – al migliore» (Metaph. I 2, 983
a 18-21; forse si tratta del proverbio che dice «la seconda volta è
sempre la migliore»), se per il geometra l’incommensurabilità
della diagonale col lato non fa più meraviglia, per chi invece
guarda la rotazione eterna del firmamento, questa continua a suscitare meraviglia anche dopo che si è capita la necessità di un
motore immobile..
Parlando poi di verità religiose, mi riferisco alle verità di fede, le
quali producono sì una certezza, l’«immensa certezza» che dà il titolo alla relazione di Esposito, ma non si tratta della «certezza
sensibile» di cui parla Hegel («oggi piove»), né della certezza del
sapere che 2+2=4, bensì di una certezza continuamente esposta
41
al dubbio, che viene continuamente messa in crisi dall’esistenza
del male, che bisogna riconquistare ogni giorno, con fatica e sofferenza, la fatica richiesta da una «virtù», sia pure teologale, quale
è la fede, e che si potrebbe perdere il giorno dopo. Penso che
quando Agostino afferma, con un atto di fede, perché si rivolge a
Dio, «il nostro cuore è inquieto finché non riposi in Te», intenda
dire che la stessa fede è inquietudine, cioè incertezza, ricerca, e
che la quiete è data non dal credere, ma dal «riposare in Te», cioè
dal momento in cui, come dice san Paolo, non ci sarà più bisogno
di fede, né di speranza, ma resterà soltanto la carità.
giovedì 22 settembre 2011
* Professore emerito di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi di
Padova
42
Prevarrà la Verità
o l’angoscia dello straniero?
Pietro Barcellona *
«E l’esistenza diventa un’immensa certezza». Questa frase è diventata il titolo della relazione al Meeting di Rimini di Costantino
Esposito: una complessa rielaborazione del rapporto fra la condizione umana e il senso di incertezza sul futuro che spesso la pervade attraverso le diverse forme in cui si è presentata nella storia,
dando vita a riflessioni filosofiche e a istituzioni politiche come lo
Stato sociale. La riflessione di Esposito è molto ricca e meriterebbe
una discussione analitica. È un confronto molto serrato, ma lascia
intravedere un filo conduttore sul quale si può provare a esprimere
qualche considerazione.
Per Esposito il bisogno di sicurezza è originario e rappresenta una
sorta di destino dell’essere umano a interrogare l’Altro per chiedere
accoglienza e ascolto. A questo bisogno primordiale si sono date risposte istituzionali, come lo Stato Sociale, e risposte filosofiche
come quelle della Scolastica e poi della grande filosofia tedesca.
Oggi sembra che tutte le risposte politico-istituzionali e filosofiche
siano andate in crisi e che c’è una necessità di ripartire dall’origine.
Per Esposito questa origine si rintraccia nella relazione originaria
del piccolo d’uomo con la madre che, accogliendolo e nutrendolo al
seno, produce una certezza primaria alla quale è sempre possibile
tornare per attingere risorse contro la crisi di ogni sicurezza. Questo ritorno all’esperienza originaria, però, può essere produttivo di
fiducia nella certezza dell’esistenza se ripercorre la via del Cristo
che si fa Uomo per salvare l’umanità. Nell’incontro con Cristo si può
ritrovare la certezza perduta. Nonostante la forza suggestiva di
questa proposta, penso tuttavia che il percorso seguito da Esposito
sconti alcune delle «confusioni» di piani e di esperienze che caratterizzano assai spesso la riflessione contemporanea.
Ho sempre pensato che bisogna partire dall’esperienza e dalle pratiche attuali per cercare di riformulare le domande fondamentali
sulla nostra condizione e vorrei perciò provare a delineare un percorso parzialmente diverso da quello che ha disegnato Esposito. Si
può leggere frequentemente sui giornali che un operaio licenziato si
è suicidato, sembrerebbe a causa della disperazione che ha provato
sentendosi impotente di fronte alla sua condizione di disoccupato,
43
incapace di sostenere la famiglia. Come tutti sanno, l’episodio del
suicidio, sia pure come estremo evento della crisi, non è così estraneo all’esperienza dei nostri giorni da non interrogarci sul significato che fatti così estremi hanno per la comprensione del nostro
mondo. La perdita del lavoro viene presentata su tutti i media
come una conseguenza inevitabile della crisi economica e della crisi
dello Stato sociale.
È dagli anni Settanta che la crisi dell’economia capitalistica e dello
Stato sociale scandisce i momenti della nostra vita collettiva e del
dibattito pubblico. E al di là delle spiegazioni che si possono dare, si
può sicuramente affermare che questa crisi oramai irreversibile
produce insicurezza nella vita quotidiana circa le aspettative più
elementari della possibilità di soddisfare il fabbisogno familiare, di
far parte di una comunità di lavoro e persino di essere riconosciuti
come cittadini di una nazione. Il disoccupato è un escluso per definizione dal mondo della socialità produttiva e per ciò stesso considerato un essere socialmente inutile. La domanda che mi pongo
però è se il suicidio, e cioè il No alla Vita possa essere spiegato
semplicemente con la condizione di disoccupazione ed emarginazione sociale. Penso di no, e penso che alla base di questa semplificazione sociologica ci sia una fondamentale incomprensione dei
nostri problemi epocali. Da cosa può dipendere il fatto che la perdita della certezza del lavoro produca una rottura così drammatica
con la possibilità di continuare a vivere la propria esistenza? Certo,
ci deve essere un legame più profondo di quello che riusciamo a
scorgere tra il rifiuto della vita e il sentimento di essere esclusi dal
mondo, ma questo non si spiega con un puro riproporsi dell’antico
bisogno di sicurezza che l’uomo avverte nascendo e che viene frustrato dalla società contemporanea.
Penso che questo problema della certezza come sicurezza sociale
del lavoro e dell’accesso al mondo pubblico dei consumi e della
soddisfazione dei bisogni elementari sia la conseguenza avvelenata
di una «Secolarizzazione» del problema del rapporto dell’uomo e
del senso della Verità dell’Essere che si è prodotto nella modernità
attraverso un vero e proprio salto antropologico dall’uomo della
tradizione, che abitava un mondo garantito da autorità trascendenti, a un uomo della modernità che, diventando assolutamente
arbitro del proprio destino, si trova a misurare se stesso soltanto
con il proprio «successo». Le aspettative di certezza prodotte nella
modernità sono infatti la secolarizzazione dell’antico bisogno di salvezza che l’uomo si è posto allorché ha scoperto la contingenza e la
caducità della sua esistenza. L’uomo antico, o comunque pre-mo44
derno, aveva vissuto il rischio del vivere come un Ulisse che cerca
con le sue risorse umane e sociali – il gruppo dei suoi compagni di
avventura – di raggiungere le colonne d’Ercole per scoprire il segreto del mondo: l’avventura della Verità dà il senso alla vita, giacché essa non è un’evidenza ma un mostrarsi solo a chi mette in
gioco se stesso per cercarla. L’uomo medievale aveva trovato nella
concordanza tra il progetto divino e la sua vita mortale la via provvidenziale della salvezza: la Verità è la creazione divina del mondo
e il posto che l’uomo si trova a ricoprire sulla terra in attesa di ricongiungersi al Regno di Dio. L’uomo moderno, al contrario, scarta
ogni ipotesi che il suo senso dell’Essere possa essere affidato a una
Verità Trascendente, a qualche cosa verso cui tendere attraverso
prove e dolori, dolori e fatiche, senza essere mai sicuro di raggiungere la meta, e si pone invece al centro come il padrone del sapere
che gli può consegnare la Verità dell’esistenza attraverso il dominio
sulla natura.
Avviene così la secolarizzazione della Verità che si trasforma in certezza delle conquiste scientifiche e delle conquiste politico-sociali.
Al posto della Verità si insedia il Progresso come costruzione umana
della «città felice» in cui desiderio e oggetto possano coincidere definitivamente. Questa secolarizzazione della Verità, trasformata in
certezza del risultato, ha avuto una doppia funzione nella storia
degli ultimi secoli: ha funzionato come anestetico dell’angoscia di
morte, che l’uomo pre-moderno traduceva nella ricerca dell’Ultrasensibile, e ha trasformato il bisogno di trovare risposte affettive al
proprio dolore di esistere in una richiesta di prestazioni alla Chiesa
o allo Stato che avevano il compito di attuare un nuovo tipo di maternage. La socialdemocrazia prometteva di assistere l’uomo dalla
culla alla tomba senza lasciarlo mai solo con i suoi problemi esistenziali. La Chiesa assicurava compensi ultramondani che lenivano
la sofferenza degli afflitti e avevano tuttavia il senso di una consolazione dal presente. Ma consolazione e assistenza sociale erano
sempre nella loro sostanza anestetici che negavano la profondità
dei problemi della vita e producevano perciò un’organizzazione sociale nella quale deperivano le ragioni dell’approfondimento dei rapporti tra le persone e la comprensione del sé profondo.
In questa fase noi viviamo la crisi della certezza secolarizzata e
cioè il fallimento della promessa che tutti i problemi dell’essere
umano possano essere risolti con gli strumenti che la scienza e il
sapere scientifico forniscono per addomesticare la natura e per produrre ricchezza materiale. Si è completamente dimenticata la lezione evangelica che «non di solo pane vive l’uomo» e anche la
45
lezione greca che l’uomo non ha in se stesso le risorse per diventare un Dio. Paradossalmente la secolarizzazione ha posto sul trono
divino la scienza e la Tecnica, promettendo un futuro certo sul terreno dei bisogni elementari all’intera umanità. La crisi della certezza che stiamo vivendo è dunque una crisi di un intero modello di
civilizzazione e di un modello antropologico fondato sulla totale autosufficienza dell’essere umano. Ciò che ricompare drammaticamente nell’esperienza del suicidio o della violenza assassina, nella
voglia di uccidersi e di uccidere che esplode all’interno delle nostre
società, è la negazione del bisogno di Verità che l’uomo ha avvertito sin dai primi momenti in cui ha pensato se stesso come un mistero, chiedendosi come il poeta: «perché giacendo a bell’agio,
ozioso, s’appaga ogni animale, me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?». Il mal di vivere è una rinuncia alla ricerca della Verità come
ciò che sta in se stessa di fronte a noi, nascondendosi e svelandosi
ma senza dipendere dai nostri sentimenti e dalle nostre costruzioni.
Sotto questo profilo la domanda di certezza oggi si intreccia con la
domanda di verità e per questo si può dire che ancora una volta gli
uomini hanno fame di verità e giustizia ed è certamente assai stimolante la lettura dell’enciclica del Papa sulla Verità e sulla Carità.
A differenza della certezza, infatti, che ha a che vedere essenzialmente con il calcolo razionale, con la probabilità del successo e con
la scoperta di nessi causali, ed è perciò sempre il risultato dell’azione soggettiva (qualsiasi oggettivazione della certezza non
sfugge all’imputazione a un Soggetto, Partito, Stato, Chiesa,
Scienza), la Verità esiste in sé e per sé, e si presenta solo nella relazione d’amore tra due persone.
Il riferimento che Esposito fa al rapporto fra la madre e il bambino
è da questo punto di vista interessante, ma di per sé insufficiente.
La madre, infatti, sappiamo tutti che può essere anche cattiva e,
come la psicoanalisi ci ha insegnato, il piccolo d’uomo si trova
spesso a fronteggiare un seno ostile e malvagio. Non c’è dunque
una garanzia naturalistica affidata soltanto al rapporto madre-figlio
che dispiega l’apertura dell’essere umano verso l’incontro con l’Altro e quindi verso la reciprocità amorevole nella quale abita la Verità. Perché ciò accada è necessario che un intero gruppo umano
abbia elaborato l’esperienza «indicibile» della nascita e dei primi
giorni di vita come metafora della venuta al mondo che, di per sé,
esprime una vocazione all’incontro e che solo e quando questo incontro si realizza ha veramente accesso alla propria rappresentazione come quella di un essere umano che comincia l’avventura
della vita. Il rapporto con la madre è certamente essenziale ma non
46
è di per sé una garanzia di adesione e di assenso alla vita se essa
non viene mediata dalla cultura, che la stessa madre, o anche
un’altra «nutrice», può rappresentare come incarnazione vivente
delle generazioni passate: è l’esperienza di un primo incontro amoroso con una Persona che invita all’accoglienza dei nuovi esseri
umani come garanti della vita che si riproduce attraverso l’amore.
Non penso quindi che la sola esistenza possa produrre una nuova
certezza, ma soltanto una profonda trasformazione dell’assetto
mentale e affettivo degli uomini contemporanei rispetto ai problemi
fondamentali della vita e della morte. Solo patendo fino in fondo il
dolore della mortalità gli uomini potranno recuperare il senso di
una nuova nascita. Perché mettere al mondo figli che poi bisogna
consolare? È una domanda ancora inquietante, se l’uomo non rinuncia alla volontà di potenza che gli ha fatto creare gli anestetici
verso tutti gli aspetti negativi che comunque si incontrano nella
vita. Ciò che è necessario per riconquistare il percorso della verità è
allora paradossalmente quello di rinunciare alla ricerca di certezze
illusorie, come quelle che ogni giorno ci promettono la scienza e
l’economia, e mettersi sulla strada della grande ricerca del Mistero
dell’uomo che spinge continuamente a oltrepassare i confini di ciò
che sembra acquisito una volta per tutte. Non bisogna cercare soluzioni ma nuove domande e, anzi, convincersi che spesso le soluzioni uccidono la domanda. Come ho detto a Rimini, occorre che gli
uomini, come Ulisse, trasformino i remi delle loro piccole cose in ali
verso il grande sogno di ritrovare un’armonia cosmica. La via di
questa ricerca può condurre alla ineludibile questione di Dio. La via
dei farmaci può produrre soltanto nuovi anestetici. Non so se sono
riuscito a interpretare il senso della relazione di Esposito, ma mi è
sembrato che nel suo discorso ci fosse un’oscillazione fra una nozione di certezza secolarizzata e una nozione di certezza che più si
avvicina al tema delle Verità fondamentali.
A ogni modo, ciò che bisogna approfondire è come la negazione
moderna del fondamento di verità della vita umana si rifletta poi
nell’esistenza quotidiana e nella richiesta di sicurezze parziali ed effimere che caratterizzano il nostro tempo. Capire cioè che non sarà
certamente l’espulsione degli immigrati a liberarci dall’angoscia
dello straniero che affonda nell’esperienze primordiali della vita.
lunedì 26 settembre 2011
* Professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di
Catania
47
Solo la realtà può sfidare
il nichilismo felice
Sergio Belardinelli *
E l’esistenza diventa una immensa certezza. C’è in questo titolo un
senso di compiutezza che, di per sé, è tutt’altro che scontato se
guardiamo alle diverse parole che lo compongono. Se non avessi
letto la relazione di Costantino Esposito avrei detto che si trattava
del solito titolo ben costruito confidando soprattutto nella assai
dubbia, anche se comunicativamente efficace, virtù ontologica degli aggettivi. Quell’«immensa» illumina infatti in modo del tutto
singolare due sostantivi – «certezza» ed «esistenza» –, i quali, almeno in filosofia, solitamente debbono fare i conti e quasi sottomettersi ad altri sostantivi molto più forti e rassicuranti, quali verità ed essenza.
Costantino Esposito compie invece un mezzo miracolo. Ci prende
letteralmente per mano e, alla fine della sua relazione, ci restituisce il senso di compiutezza del titolo come l’esito di argomentazioni belle e convincenti. Un po’ come ha notato anche Enrico
Berti, alla fine siamo certi che certezza e verità vanno insieme e
che la stessa esistenza può diventare appunto un’immensa certezza. Fatta questa premessa, vorrei soffermare la mia attenzione
su un punto della relazione di Esposito che mi sembra particolarmente significativo, ossia il suo tentativo di porre la certezza dell’esistenza «all’origine». In un mondo spaesato qual è quello che
abitiamo oggi, dove molti intellettuali si trastullano allegramente
col nichilismo e molti uomini, specialmente giovani, ne sentono invece i morsi laceranti sulla pelle, Esposito ci dà una salutare frustata.
All’inizio, direi quasi, in principio, abitiamo tutti una indelebile certezza: «Quella di essere voluti e accolti dallo sguardo amoroso di
nostra madre e di aver percepito il senso, magari non ancora cosciente ma certamente presente, del nostro esistere naturale suggendo il seno. La certezza che precede ogni incertezza e che a sua
volta ogni incertezza clamorosamente attesta, è il fatto che noi
siamo venuti all’essere in un rapporto, siamo di qualcuno, e in
quanto tali siamo davvero noi stessi. È in questa memoria che si
apre lo spazio di senso del nostro bisogno di certezza».
Traggo da queste bellissime parole due riflessioni strettamente
48
connesse tra loro. La prima riguarda la natura relazionale dell’uomo, anzi la sua natura familiare. L’uomo è un animale familiare
e, in quanto tale, egli ha un costitutivo bisogno di familiarizzare
col mondo, di sentircisi a casa. Vi arriva senza averlo scelto e lo
trova spesso pieno di dolore, insidie, incertezze. Grande è dunque
la tentazione di dire che vi arrivi «gettato» dal caso. Ma il seno di
nostra madre, come dice Esposito, ci salva da questa insensatezza. Quand’anche la durezza della vita ce lo faccia dimenticare,
tutti siamo stati una perla in uno scrigno. Precisamente questa relazione è la nostra certezza originaria, quella che continuamente
ricerchiamo nel mondo che abitiamo.
La costruzione di sé, di cui oggi tanto si parla, e la nostra incessante ricerca della felicità implicano in fondo questa certezza, potremmo anche dire che sono tanti modi di ricostruirla. Ma, e qui
inserisco la mia seconda riflessione, quest’opera di ricostruzione,
che è sempre una sorta di opera di «riconciliazione» con il mondo
nel quale siamo arrivati, non si realizza mai in solitudine. Abbiamo
bisogno degli altri; soprattutto abbiamo bisogno di educazione. Ne
abbiamo bisogno, non per diventare buoni cattolici, buoni cittadini
o per imparare un mestiere, ma semplicemente per ritrovare la
nostra strada nel mondo, la nostra certezza, appunto, e diventare
ciò che siamo: uomini, diciamo pure, persone, la cui irripetibile
unicità si esprime sempre in un tessuto di relazioni costitutive;
persone che tanto più avranno sperimentato la «grazia» di essere
state guardate con amore da altre persone (che cos’è l’educazione, se non questo?!), e tanto più sapranno districarsi nel mare
della vita.
Va da sé, e Costantino Esposito lo ha mostrato molto bene, stiamo
parlando di una certezza che non è quella degli «uomini sodi» di
cui parlava Pirandello, dove la durezza, le inquietudini e le contraddizioni della nostra esistenza vengono tutte sopite. Al contrario. Parliamo di una certezza che per certi versi addirittura le esaspera, consentendoci anche di affrontarle senza paura, senza
disperazione e anzi col sorriso. Non so neanche perché, ma è proprio al sorriso che mi fa pensare questa certezza.
martedì 4 ottobre 2011
* Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali presso l’Università di
Bologna
49
La nostra domanda
è una navigazione senza fine
Salvatore Veca *
La relazione di Costantino Esposito è appassionata e ricca di implicazioni filosofiche illuminanti a proposito di questioni di grande difficoltà e importanza. Essa ha, inoltre, la virtù rara della sincerità e
dell’impegno alla veridicità. Avanzando le sue tesi, che muovono
dal riconoscimento dell’incertezza come condizione saliente dell’epoca in cui ci accade di vivere le nostre vite finite, Esposito
mette in gioco al meglio la sua funzione intellettuale e, alla fine,
se stesso. E anche questa è una virtù rara della sua relazione.
Le questioni dell’incertezza, della contingenza e del «bisogno insopprimibile di certezza», di cui ci parla Esposito, mi sono molto
familiari. Ho dedicato buona parte delle mia ricerca filosofica a
queste faccende difficili, a partire almeno dalle tre meditazioni di
Dell’incertezza, sino al mio ultimo libro che consiste di quattro lezioni su L’idea di incompletezza. Per questo, leggendo Esposito, mi
sono sentito a casa. E per questo mi interessa mettere in luce almeno due punti in cui la mia ricerca mi ha indotto a vedere le cose
in modo differente e distinto, rispetto alla prospettiva favorita da
Esposito.
Il primo punto coincide con l’applicazione stessa dell’idea di incertezza. Le considerazioni di Bauman, da cui muove il primo passo
di Esposito, sono naturalmente molto note e indiscutibilmente popolari. Tuttavia, sono convinto che andrebbero prese con maggiore
cautela e sobrietà intellettuale. La questione non è quella della incertezza come condizione distintiva dei nostri tempi. Messa così, la
questione è esposta a una vasta e familiare gamma di critiche e
confutazioni. Sono convinto che tutte le volte che ci mettiamo alla
prova con l’incertezza, abbiamo l’onere di specificare: incertezza
di che cosa, o a proposito di che cosa?
E se prendiamo sul serio l’onere di una risposta plausibile, ci rendiamo facilmente conto che il nostro riconoscere incertezza a proposito di qualcosa indica che il confine fra quanto accreditiamo
come certo e quanto è esposto al vento d’incertezza è divenuto
d’un tratto mobile e sfumato.
È questa alterazione della partizione fra certo e incerto, in una essenziale varietà di ambiti, che genera per noi il problema dell’in50
certezza. Nel mio gergo, è in circostanze come queste che l’incertezza chiede teoria. In una varietà di ambiti: nell’ambito di ciò che
vi è, di come stanno le cose; nell’ambito di ciò che vale, di ciò che
conta e fa la differenza nelle nostre vite; nell’ambito in cui siamo
impegnati ad attribuzioni di identità o a riconoscere la nostra mutevole identità.
In questo senso, sono d’accordo con Esposito quando egli sostiene
una qualche priorità della certezza e rende conto della nostra persistente ricerca di una certezza perduta. Ma la priorità della certezza perduta indica semplicemente che è venuta meno la partizione stabile fra certo e incerto. Per questo non c’è bisogno della
modernità o postmodernità liquida alla Bauman. Ci bastano alcune
pagine luminose delle Pensées del grande Blaise Pascal.
Non solo: si consideri che la priorità della certezza è un ingrediente prezioso di qualsiasi replica indiretta all’obiezione scettica e
relativistica. Descartes, evocato da Esposito, aveva tentato eroicamente la via della replica diretta allo scetticismo, mirando alla
proposizione immunizzata rispetto al dubbio. Ma la tesi della priorità della certezza, nella mia versione che è coerente con la replica
indiretta, ci dice semplicemente che qualcosa deve certamente essere sottratto al dubbio perché noi possiamo, se è il caso, dubitare
di qualcosa e revocare il nostro assenso newmaniano. Il punto importante è che quel qualcosa sottratto al dubbio non è necessariamente la stessa cosa. Ma torniamo al ruolo che l’incertezza può
avere nelle nostre vite finite.
Esposito scrive in un passo eloquente e convincente: «…se guardiamo più attentamente, essa – l’incertezza – è in grado di attestare anche qualcos’altro, vale a dire il nostro essere-esposti costitutivamente a ciò che accade, che ci raggiunge, ci tocca, e per ciò
stesso ci spiazza, ci provoca, ci chiama in causa». Credo di essere
pienamente d’accordo con questa prospettiva.
Essa, nella mia idea, ha a che fare fondamentalmente con la nostra incompletezza. Noi siamo un tipo di esseri costitutivamente
insaturi. E se l’incertezza, nel senso che ho cercato di specificare,
è responsabile del nostro persistente tentativo di ridurla, alla
grande o terra terra, del nostro persistente far teorie, l’incompletezza è la caratteristica distintiva delle nostre risposte. Risposte
che mirano a dire l’ultima parola, punto e basta. E che sono destinate, ironicamente o umilmente, a convertirsi nella penultima parola. Nella scienza come nella filosofia.
Se le cose stanno grosso modo così, viene naturale tratteggiare
una modesta proposta di apologia del vecchio Lessing. Le conside51
razioni di Esposito e l’ironica valutazione di Diego Marconi a proposito della scelta fra la mano di Dio in cui risiedono le verità e la
mano in cui risiede la ricerca della verità non sono prive di buon
senso. Il che non è mai male. Tuttavia, trovo qualcosa di stridente
nella critica di Esposito. Esposito chiude la sua relazione sostenendo che «…il segreto di questa verifica, il motore del tempo, se
così posso esprimermi, è il nostro domandare. Ogni qualvolta un
uomo si chiede il perché di sé, degli eventi, delle cose accade una
novità – piccola o grande che sia – nel flusso altrimenti meccanico
o caotico degli eventi, e il tempo diventa storia: non solo un passare di accadimenti, ma l’accadere dell’io». Nella prima lezione de
L’idea di incompletezza ho insistito sull’importanza, per tipi come
noi, del nostro «durevole domandare», in un commento ad alcuni
passi del superbo Libro della Sapienza.
Ma il vecchio Lessing probabilmente ci ricorderebbe che il nostro
durevole domandare, il chiedersi il perché di sé o delle cose o del
mondo evaporerebbe e non avrebbe senso se noi avessimo il possesso delle verità su noi e sul mondo, quelle che stanno in una
delle mani di Dio. E allora? Credo che il riconoscimento del duplice
paradigma dell’incertezza e dell’incompletezza possa indurci a un
autoritratto dai contorni sfumati, provvisori e approssimativi, in
cui riconosciamo noi stessi come predatori di verità e di senso.
Come i vecchi marinai della mitica barca di Otto Neurath, costretti
a riparare la propria barca in navigazione, senza poter mai contare
nel rifugio in cantieri ospitali.
Vi sono molte altre questioni che Costantino Esposito ci offre nella
sua relazione. Posso sinceramente sperare che nella navigazione si
possa continuare a pensarci su e a discuterne assieme. Con amore
della verità e con lealtà alla veridicità. In tempi difficili.
martedì 11 ottobre 2011
* Professore ordinario di Filosofia politica presso l’Università degli Studi di
Pavia
52
Grazie a Dio, non dipendo
da nessuna verità
Gianni Vattimo *
Grazie a Dio sono incerto, o anche ateo – non idolatra, non veritàdipendente... E poi, una esistenza tutta certezza, che barba. Un
po’ come il paradiso della tradizione: tota simul ac perfecta possessio. Ma per favore. Invece, però, che cosa? La storicità aperta,
che è il vero senso del creazionismo. Non siamo manifestazioni di
una struttura geometricamente demonstrata, la razionalità che incontriamo nel mondo è solo un «fatto», un prodotto contingente,
storico, che per esser tale – con la nostra esperienza di scelte, di
alternative, di progetti con riuscite e fallimenti – di ex-sistenza,
cioè – attesta il carattere eventuale, libero, della mia provenienza.
Chiamo Dio l’atto di libertà originaria da cui proviene la mia libertà, e che certo non posso dimostrare con le cinque vie tomiste
né con qualche altro metodo deduttivo. Persino Cartesio non lo dimostra. E Kant riesce a immaginare solo la vita eterna come una
continuazione della lotta per il bene, cioè come storia.
Se storia, se l’esistenza è storia, non è mai certezza definitivamente raggiunta. Non che si sia sempre nel dubbio e non si «capisca» mai niente. Ma è la libertà, cioè in fondo l’anima, che l’uomo
non deve-vuole perdere. E la libertà originaria da cui sento di dipendere non è contenuto di una idea chiara e distinta. Mi si dà
solo come storia, racconto, mito. È l’insegnamento dell’ultimo Pareyson (Ontologia della libertà, Einaudi, Torino 1995) che pensa
l’esistere come una ermeneutica del mito. La certezza con cui mi
sento «appartenere» al mito, il mio, quello della mia storia, non è
la certezza assoluta della ragione matematica (possibile solo se
esistere significasse derivare logicamente da una struttura immutabile) che dovrebbe attestarne la «verità». È per l’appunto una
certezza esistenziale, sempre a cavallo tra la mezza luce dei ricordi d’infanzia (anche Gesù Bambino, anche Babbo Natale, come
ci rinfacciano sempre i «realisti») e quella della scommessa pascaliana.
Perché una certezza esistenziale di questo genere non dovrebbe
bastare? Già, chi lo nega, e perché? Una certezza esistenziale non
basta per comandare, molto semplicemente. Se Hitler avesse solo
avuto una profonda insofferenza verso gli ebrei – magari derivata
53
dalla sua invidia per il piccolo Wittgenstein suo compagno alla
scuola elementare di Linz, come si racconta – non ne avrebbe probabilmente operato uno sterminio così sistematico; lo ha fatto
perché aveva una «teoria», con pretese di valore «oggettivo».
Proprio come oggi si invoca la «legge di natura», universale e
dunque valida per tutti, che la conoscano o no – per vietare i matrimoni gay, per non discutere di eutanasia; solo per fortuna non
si parla più della «naturale» superiorità dei bianchi sui neri. Del
resto, non perché si sia riconosciuto, «oggettivamente», che era
una teoria sbagliata, ma solo perché i neri si sono ribellati...
Mi si obietta: ma le rivoluzioni, anche quelle dei neri, non si sono
forse ispirate a una qualche verità, anche proprio al diritto «naturale»? Ma forse che i monarchi ereditari hanno mai accettato di
concedere la costituzione perché avevano «riconosciuto» la verità
predicata dai loro sudditi? Perché anche il diritto «naturale» non
dovrebbe essere un mito-certezza esistenziale – dei neri oppressi
dai bianchi, dei poveri sfruttati dai ricchi, ecc.? Allora, se però è
solo lotta di tutti contro tutti, ha ragione chi vince e basta? Intanto, importa prendere atto che adesso, e da molto tempo, da
quando ci ricordiamo, è proprio così, quasi la sola «legge di natura» che conosciamo. E, se vogliamo ragionare da buoni democratici, la «ragione» vera starebbe comunque dalla parte dei più:
dei popoli oppressi, dei proletari sfruttati...
Il punto è che, in corrispondenza o forse a causa, delle trasformazioni politiche – la rivolta dei popoli coloniali, la fine obbligata
dell’eurocentrismo, anche la vergogna degli occidentali cristiani
per le conversioni forzate e l’appoggio all’imperialismo nei secoli
della modernità – non si può più pensare che «c’è» una verità;
giacché, se ci fosse, sarebbe necessariamente la nostra, non si è
mai vista una filosofia, o una religione, che professi l’esistenza
della verità che non le appartenga. Ciò di cui ci rendiamo sempre
più conto – ma sarà questa appunto «la verità», come ci obiettano
i cultori del vacuo argomento antiscettico? – è che la verità universalmente valida è un’idea inseparabile dal potere. Anche
quando serve ai rivoluzionari, è la base di una rivendicazione di
potere, non certo la soddisfazione di un bisogno «naturale» di sapere come stanno le cose.
Ma ancora: solo lotta di tutti contro tutti? No, una volta scoperto
questo (strano) vero, siamo finalmente liberi di negoziare alla pari
con gli altri. Non: diciamo che ci siamo accordati perché abbiamo
trovato la verità; ma che abbiamo trovato la verità perché ci
siamo accordati. Ciascuno con i propri miti e le proprie convinzioni
54
esistenziali: forse è questa versione laica e democratica della carità il vero messaggio del cristianesimo, Dio è presente fra noi
quando ci amiamo e rispettiamo. E non altrove, nemmeno nell’alto
dei cieli.
martedì 18 ottobre 2011
* Professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di
Torino
55
Caro Esposito, il nostro
destino è la ricerca senza fine
Salvatore Natoli *
Caro direttore,
il testo di Esposito è importante e molte sono le cose condivido,
anche se da altre divergo. Per questo ritengo che meritino d’essere discusse. Tra queste, la più importante – e che a mio parere
sottende tutto il testo e ne rappresenta l’intenzione latente – è
quella di dare alla certezza il suo definitivo fondamento nella fede.
Solo la fede, infatti, può soddisfare per intero il nostro bisogno di
certezza. Certo la fede non ci esonera dalle condizioni di incertezza in cui ci veniamo a trovare di volta in volta nella vita,
quando non sappiamo che fare e restiamo paralizzati nelle scelte.
Non ci garantisce neppure dall’errore, ma paolinamente, ci fa vivere tutto questo nella speranza. Qualunque cosa accada andrà a
finir bene.
Ma, se la certezza per non essere debole – come sono le certezze
mondane – deve trovare fondamento in altro da sé, non è affatto
originaria, ma, al contrario, consegue all’atto di fede o più teologicamente nell’adesione a Dio. Nel dire questo non credo di tradire
le intenzioni di Esposito, ma, caso mai, esplicito quel che si legge
nel § 4 del suo testo La certezza come rischio ove, impiegando il
sempre lucido testo di Tommaso, dice che alla certezza (certitudo
visionis) si accede a seguito dell’actus intellectus deliberantis.
Come dire, la certezza consegue dall’aver detto sì al Signore.
Stando all’argomentazione di Esposito, noi siamo in radice costituiti per quel sì e se non lo pronunciamo di fatto tradiamo quel che
siamo.
Ciò non comporta la caduta di ogni certezza – siamo certi di tante
cose – ma la privazione di quella ultima che dà senso a tutto. Ma è
ultima perché è anche prima, perché dà realizzazione e compimento a ciò per cui siamo fatti. Nel dir questo Esposito offre una
versione aggiornata e fine dell’apologetica classica che mette in
circolo ontologia e teologia. Noi siamo precostituiti per quel «sì» e
solo in esso possiamo trovare la nostra pace (la plena pax di Agostino). Di certo quella di Esposito non è una filosofia sentimentale
come tante di quelle correnti, anche se per evitare l’equivoco mortuario cui può indurre la pax aeterna adotta l’accattivante lessico
56
lacaniano del desiderio – che è infinito – e a pax preferisce appagamento, soddisfazione. Evidentemente infinita e perciò impossibile per sé privi di Dio.
Se l’argomentazione di Esposito è questa – e credo sia questa – è
serissima e indica una netta discriminante tra chi crede e chi non
crede. Non solo: suggerisce anche l’idea che senza la fede –
prima/ultima certezza – la nostra esistenza precipita nel nulla. Per
questo prende avvio da una fenomenologia del presente, dalla caduta delle certezze, o comunque dalla loro labilità. Allo scopo impiega le analisi sociologiche – Bauman e le sue vulgate – ma come
un via pedagogica per mostrare a che punto siamo arrivati, a che
esito quella presunzione di autosufficienza ha condotto la modernità. Solo l’adesione a Dio, o più esattamente a Cristo può portarci
fuori dalla deriva nichilista. Termine e metafora forte di questo è
l’incontro con l’altro che non è il «chiunque», ma il solo. Stando
alla tradizione di Esposito vien da dire: tu solus sanctus, tu solus
dominus, tu solus atlissimus Jesu Christe. Credo che il punto forte
di Esposito risieda propriamente in questo, detto peraltro in modo
del tutto esplicito: «c’era bisogno di Cristo – scrive – perché la
certezza dell’uomo... non fosse tenuta sotto scacco dalla finitezza
e dalla morte». Dato questo scarto – e dirò perché – la diagnosi
che Esposito fa del moderno per molti versi coincide con quanto in
altre sedi ho ampiamente sostenuto e scritto seppure con diverse
motivazioni.
Non le riprendo, ma qui mi sembra opportuno fare alcune osservazioni circa la differenza tra certezza e fede. In breve, la prima e
più evidente differenza è questa: alla certezza si appartiene, la
fede si concede. Detto altrimenti, la certezza è una condizione, la
fede un’adesione. Di più: la certezza è un abito, la fede una
scelta. Credo che queste coppie facciano capire a sufficienza dove
cade la differenza. Per molti versi mi sento di dare una versione
profana di una nota espressione di Paolo: «il giusto vive per la
fede», a patto che per fede s’intenda qui quel corredo di credenze
ereditate, che ogni individuo inevitabilmente possiede in quanto
appartenente a una comunità. Se la questione la si pone in questi
termini, la condizione originaria di certezza non è da confondere
con una soggettiva volontà di verità, ma piuttosto come quel terreno preliminare sottratto al dubbio e che solo lo rende possibile.
Per dirla con Wittgenstein: «94. La mia immagine del mondo non
ce l’ho perché ho convinto me stesso della sua certezza, e neanche perché sono convinto della sua correttezza. È lo sfondo che mi
è stato tramandato, sul quale distinguo tra il vero e il falso» (Della
57
certezza). E più esplicitamente: «115. Chi volesse dubitare di
tutto, non arriverebbe neanche a dubitare. Lo stesso gioco del dubitare presuppone la certezza». È a partire, dunque, da una solida
credenza che si può cominciare a dubitare.
Qui torna pur buono il materno di cui parla Esposito ma che però
non attiene strettamente al rapporto madre-figlio, bensì a quello
più largo individui-credenze. Il bambino, infatti, «impara a credere
in un sacco di cose... e ad agire secondo queste credenze». E ogni
madre fa la madre secondo i costumi e l’uso di una comunità e
della società in cui vive. Dare l’inizio a una vita non vuol dire essere in assoluto un inizio. La certezza è quindi una condizione originaria perché ereditata e non perché scelta. È così che si stabilizza la regolarità delle condotte e che si generano le morali. Di qui
inevitabile una conseguenza: l’abitudine di fidarsi e affidarsi. Se le
cose si considerano così, il credere è già di per sé un sapere.
Ora, di solito la certezza vien meno a fronte dell’insorgere di problemi che le certezze consolidate non ci permettono più di risolvere. È questa la ragione per cui, pur radicati su un terreno di certezze, viviamo nell’incertezza. L’indeterminazione del mondo ci
pone innanzi a sempre nuovi dilemmi per cui è necessario reperire
nuove soluzioni. Ma dal momento che abbiamo appreso regole ce
le sappiamo anche dare, è questo che ci permette di disegnare
trame di senso e di dare direzione al nostro movimento nel
mondo. Di questo ne è prova il fatto che a fronte di verità messe
in revoca siamo nelle condizioni di individuare altri piani di verità
che ci permettono di decidere del vero e del falso. L’incertezza
matura, dunque, sul terreno della certezza, la lacera ma non per
questo abolisce: caso mai ne ridefinisce il piano. È l’ulterius
quaerere. Per questo pur senza una certezza assoluta ci capita di
muoverci in un modo di certezze. Se così non fosse, non potremmo vivere.
E tuttavia, seppur radicati nella certezza, siamo incerti. Ma i problemi che di volta in volta si presentano sono locali e parziali e altrettanto lo sono le soluzioni. Aperto resta, però, il cammino e noi
siamo quest’apertura. Perciò non è tanto nella pretesa vana di
raggiungere contenuti assolutamente certi – o certezze ultime –
che si dissolve ogni incertezza, ma al contrario possiamo delimitare l’incerto, perché come uomini abbiamo la possibilità di misurarci con la sua dismisura. Infatti possiamo rinsaldare le nostre
certezze se apprenderemo a fronteggiare l’improbabile. Dove
sono, infatti, i confini del mondo? Ammesso che si diano, non bastano certo le nostre vite raggiungerli. A noi tocca di volta in volta
58
tracciarli. Allo scopo è necessaria quella che chiamo «etica delle
virtù» e d’altra parte la virtù altro non è che «buona abitudine».
Ringrazio Esposito per aver fatto cenno alla mia posizione, anche
se la ritiene difficile ed elitaria. Non entro qui nel merito, ma mi limito a dire: difficile forse, ma certo non è più semplice della chiamata: prendi la tua croce e seguimi. Mi si risponderà. Ma seguire
vuol dire che nel cammino non sei solo: vi è qualcuno che ti è
guida, ti è compagno, ti dà certezza della meta. Ebbene, la fede
consiste proprio in questo: è sequela. Certo, se considerate da un
punto di vista storico-antropologico, le fedi raramente sono frutto
di scelta, ma per lo più si ereditano: infatti, si nasce cristiani, buddisti, islamici o altro ancora e ogni religione ha, in genere, un suo
particolare bacino geografico, anche se globalizzazione e secolarizzazione ne stanno modificando le mappature.
Do tutto questo per scontato, per prendere invece in considerazione la fede come atto, o – per stare a Esposito – come quell’assenso in forza del quale «l’esistenza – secondo le parole di Luigi
Giussani – diventa un’immensa certezza». La fede è certamente
assenso, è un adherere Deo. Nel caso del cristiano un’adesione
all’evento Cristo e perciò anche al Dio di Gesù Cristo o più esattamente a quell’esperienza che Cristo ha fatto di Dio. Ma, l’incontro
con Cristo non è – quelle volte in cui lo è – un incontro semplicemente personale, ma è un’apertura di senso totale. Da Cristo trae
senso il prima del tempo – prima che il mondo fosse –, tutto il
tempo, la storia e con essa la vita degli uomini – dei vivi e dei
morti – e la loro sorte finale. È, infatti, promessa di vita eterna.
Tutto ciò si ricapitola in Cristo cifra del tutto e chiave di ogni esistenza.
Quanto tutto questo sia degno di fede resta del tutto sospeso,
tanto che molti sono coloro che non vi aderiscono. La risposta che
si tende a dare a questa obiezione-interrogativo è quella di mostrare che Cristo – e proprio Lui – corrisponde a ciò per cui l’uomo
è fatto e perciò è l’Unico che può soddisfare il nostro bisogno di
certezza, che ci dona il senso dell’esistere. Come dire: il nostro
vagare tra vane certezze è segno e conseguenza della rottura del
nostro rapporto con l’altro che ci chiama. Che è poi la chiamata
originaria e originante, quella che per un filosofo come Esposito è
la chiamata all’essere. Ora, la deriva del moderno consegue proprio nella tentata rottura con quell’Alterità che ci pone in essere;
una rottura che evidentemente non può che restare una pretesa,
dal momento che senza quell’Alterità che ci istituisce non esisteremmo. Per questo l’idea che sia in potere degli uomini ridurre
59
progressivamente la loro esposizione, che essi, per virtù propria,
possano esonerarsi del peso dalla loro finitezza, ha condotto il moderno al fallimento.
Di conseguenza: o cristiani o infelici. Ma l’offerta di senso cristiana
per taluni può essere accattivante, ma non è detto sia convincente. Ciò detto, il salto nella fede è del tutto plausibile, ma è appunto un salto. La natura delle cose non è, infatti, in continuità
con gli impossibila Dei ed è perciò perfettamente possibile che chi
non dà credito a quell’impossibile possieda un grado sufficiente di
certezze per vivere bene in questo mondo.
Certo Esposito è il primo a riconoscere che il processo di civilizzazione ha migliorato le nostre condizioni di vita rendendole del
tutto imparagonabili con chi ci ha preceduto: chiunque lo negasse
negherebbe un’evidenza. Far dire questo a Esposito sarebbe fraintenderlo. Ritengo, perciò, che il suo rilevo sia più profondo: infatti,
se i progressi della scienza e della tecnica ci hanno liberato dalle
primarie e lucreziane paure, oggi siamo messi a rischio dalle nostre crescenti aspettative che ci espongono costantemente a delusioni e che generano frustrazioni. Di qui la centralità del desiderio, che una pratica delle virtù ritengo possa adeguatamente
amministrare. Ora sono d’accordo con molte delle cose di cui parla
Esposito nella sua fenomenologia della contemporaneità, ma sono
persuaso che la pienezza del senso non risieda nel reperimento di
un senso ultimo, ma nelle capacità, che nell’uomo non vengono
mai meno, di saperlo cercare e trovare. In breve nella capacità
che egli ha di sapere dimorare su questa terra. Cosa, infatti, per
gli uomini può significare ultimo? E rispetto a cosa? Al tempo? Le
generazioni trascorse sono sparite per sempre e nessuno ci dà la
certezza che la specie umana duri indefettibilmente o che invece
non perisca mentre l’universo continua nel suo corso.
Noi definiamo fini per quel tanto che sappiamo tracciare confini. Il
nostro è solo un transitare e per questo il nostro compito nel
mondo è – come specie e come singoli – saperci stare, saperlo
abitare. E quindi, biblicamente, custodire e trasmettere. Possediamo, infatti, la misura del bene, ed è data dalla realizzazione
dell’ente, di ogni ente. Dobbiamo perciò sentirci corresponsabili
delle sorti comuni, dal momento che è impossibile realizzarsi da
soli. L’altro, con la a minuscola e al plurale – esattamente gli altri
– inevitabilmente ci obbliga. È un legame originario da cui non ci
possiamo esonerare, perché da soli non ci bastiamo, non siamo
sufficienti a noi stessi. Ma quest’obbligo può essere soddisfatto
davvero se c’è fede negli altri: esige concedere e ricevere fiducia
60
in un reciproco affidarsi. Nonostante tutto. In questo c’è forse
qualcosa di cristiano. Mi si permetta un’esegesi profana: Cristo
non chiede di credere in lui, ma invita ad agire come lui, portare il
regno per possedere la terra nella pace. Bisogna avere fede che
questo avverrà e agire in conseguenza. Credo sia un rischio per
cui vale la pena. Ma, di questo se ne può discutere in altra occasione.
mercoledì 9 novembre 2011
* Professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di
Milano Bicocca
61
Se l’aiuto più grande alla certezza
morale oggi viene dalla scienza...
Paolo Ponzio *
Caro direttore,
in punta di piedi mi permetto di entrare nel dialogo avviatosi, già
da metà settembre, a partire dalla relazione al Meeting di Rimini
di Costantino Esposito su «E l’esistenza diventa un’immensa certezza». In punta di piedi sia per l’autorevolezza di coloro che mi
hanno preceduto nel dibattito, sia per la vicinanza che mi lega al
collega e amico Esposito.
In particolare, collegandomi all’analisi svolta da Ferraris, mi pare
che si possa dare per accertato un punto di partenza comune
molto importante: la certezza rispetto ai dati sensibili. Sì, perché
non è affatto scontato – come dimostra il breve saggio di Vattimo
– che si possa partire da un terreno comune, e che tale terreno
possa essere rappresentato da quel mondo, quella totalità, che solitamente prende il nome di «realtà»: una realtà che c’è, esiste,
ed è tale anche senza il mio consenso.
Potremmo chiamarla, con un titolo che potrebbe sembrare persino
banale, il fondo di una «certezza comune». Di questa realtà la nostra ragione è certa, qualunque sia la sua origine e il suo destino.
Anzi, in tante occasioni, non possiamo non riconoscere l’esistenza
di una forza coercitiva della realtà che impone alla ragione un preciso rigore conoscitivo. Vi sarebbe spazio, così, non solo per una
ragione soggettiva – legata al gioco dell’interpretazione del singolo
– ma anche per una certa ragione «comune» che avrebbe il compito di oggettivare e dimostrare la fondatezza di teoremi e teorie
scientifiche. Con questo, non si vuole stabilire l’ambito di competenza di due ragioni distinte, bensì si tratta di dichiarare l’esistenza di un unico atto conoscitivo attraverso cui sancire la relazione tra pensiero e realtà sulla base di un’analogia che renda
possibile la correttezza delle risposte attraverso un numero finito
di inferenze, essendo tale requisito un’esigenza generale del nostro intelletto.
Già nella metà del XX secolo il matematico David Hilbert avvertiva
che «su questo gioco, alterno e sempre rinnovantesi, tra pensiero
ed esperienza si basano quelle numerose e sorprendenti analogie
che il matematico percepisce così spesso nelle problematiche, nei
62
metodi e nei concetti dei diversi settori della conoscenza». Si potrebbe, pertanto, affermare che non sia patrimonio specifico della
sola certezza morale quella di tener conto di «numerose e sorprendenti analogie», ma sia un’attitudine ascrivibile interamente
all’esperienza conoscitiva tout court.
Risulta, così, più che legittimo allargare anche ad altri ambiti
quanto detto da Esposito riguardo alla certezza morale o esistenziale, ambiti nei quali sembrerebbe fuorviante o, quanto meno
inutile, ricorrere ad argomentazioni non convenzionali. Eppure anche nel campo delle cosiddette scienze esatte si assiste sempre
più frequentemente al rovesciamento del paradigma moderno secondo cui la scienza avrebbe assunto, nel corso dei secoli, la
forma di una progressiva «oggettivazione» del mondo a cui
avrebbe corrisposto una sempre più chiara esclusione del soggetto. La scienza avrebbe, così, compiuto il suo itinerario giungendo a emanciparsi totalmente dalla morsa infausta e perversa
del soggetto, come se il progresso scientifico potesse effettivamente darsi in e con una conoscenza meramente addizionabile.
Nel corso del XX secolo più di uno scienziato ha invece posto il
problema epistemologico del rapporto tra conoscenza scientifica e
soggetto conoscente, tentando un rovesciamento della posizione
moderna attraverso il recupero del primato di un postulato d’intelligibilità che non escluda l’io dall’immagine scientifica del mondo e
non separi l’oggetto osservato dal soggetto che osserva. Del resto
l’idea che possa esserci una qualche certezza scientifica totalmente avulsa da una qualsiasi rielaborazione della ragione, non è
oggi una posizione che possa essere sostenuta senza essere tacciati di un ingenuo scientismo. La stesso pensiero neo-realista sa
bene che non può eliminare totalmente l’io: la sua tecnica consiste, invece, nel perseguire una sua assidua riduzione in modo da
autolimitare e mutilare la ragione e la sua pretesa conoscitiva al
solo ambito tecnico-scientifico.
E, tuttavia, è proprio la dinamica dell’esperienza scientifica a mostrare quanto sia necessario aprire nuovi spazi di comprensibilità
che colgano il mistero di un significato totale che è possibile realizzare attraverso una continua tensione tra ragione soggettiva e
ragione oggettivata che non può mai dirsi risolta in una razionalità
neutra, ma chiede costantemente di sé. Un soggetto che, come diceva Erwin Schrödinger, non appare mai come parte dell’immagine
del mondo perché è esso stesso l’intera immagine del mondo,
considerata nella sua totalità.
È per questo che Hannah Arendt poteva dire che il tessuto di tutto
63
quello che si chiama reale costituisce l’irrompere nel mondo dell’infinitamente improbabile che percorre i flussi della storia e del
cosmo, e chiede dell’uomo, vale a dire, di quell’unico attore che
può interrompere tale flusso e ricrearlo sempre daccapo e liberamente come un nuovo inizio.
sabato 17 dicembre 2011
* Professore associato di Storia della filosofia teoretica presso l’Università degli
Studi di Bari
64
Conclusione.
Può esserci una verità
senza il nostro io?*
Costantino Esposito
Il dibattito che si è svolto sul ilsussidiario.net, a seguito del mio
intervento al Meeting di Rimini sulla questione della possibile certezza per l’uomo contemporaneo, è stato per me stesso una
grande occasione. E non solo per una più serrata verifica critica
della mia proposta (come sempre accade quando interlocutori del
calibro degli intervenuti entrano nella partita), ma per rendermi
conto di quali siano le posizioni in gioco nell’odierno dibattito filosofico e culturale, e soprattutto quale sia la vera posta in gioco di
esso. E siccome ritengo che la cosa più importante per me – e la
più utile per i lettori – non sia tanto reiterare una dialettica tra le
diverse tesi, quanto cercare di capire di che esperienza stiamo
parlando quando parliamo di certezza e di verità, di realtà e di interpretazioni, di ragione e di libertà ecc., vorrei rientrare anch’io
nel dibattito per dire quello che esso finora mi ha fatto riscoprire
con maggiore evidenza. Ed è proprio a partire da quello che ha
colpito me, che mi piacerebbe riproporre alcune questioni ai miei
compagni di scoperta. A essere sincero le questioni sarebbero
tante, ma (per oggi!) mi limito a una soltanto, che nomino come
segue: verità senza certezza o certezza senza verità?
Una delle domande più provocanti emerse nel dibattito è se la certezza sia un’esperienza realmente necessaria e positiva per l’essere umano, visto che essa (come argomenta Maurizio Ferraris)
potrebbe anche coincidere con una fiducia mal riposta o addirittura con una fede in qualcosa di negativo o di malvagio. Non soltanto si potrebbe nutrire una certezza come «fede cieca» in Hitler,
ma ci si potrebbe anche fidare di una madre cattiva (secondo un
tipico caso da psicoanalisi, ricordato anche da Pietro Barcellona).
Sarebbe dunque ben più importante stare a ciò che è vero, prefe* Questo articolo è apparso prima degli ultimi due interventi del dibattito ospitati da ilsussidiario.net, quelli di Salvatore Natoli e di Paolo Ponzio. L’autore
ha ritenuto opportuno perciò integrarlo con i riferimenti anche ai due suddetti interventi, collocandolo a conclusione della presente raccolta.
65
rire la verità oggettiva dei fatti, piuttosto che inseguire una certezza soggettiva che potrebbe sempre sbagliarsi.
Ora, è vero (appunto) che noi potremmo scoprire di aver mal riposto la nostra fiducia in qualcuno che non lo meritava, ed è anche
vero (appunto) che ci possono essere casi patologici di madri che
vogliono il male dei figli: la partita dell’esistenza è sempre apertissima e noi non possiamo escludere la possibilità del male o l’inganno della ragione. Ma a me sembra che proprio il fatto di giudicare negativamente questa evenienza stia a dire che siamo fatti
per la verità (o per dirla in prosa: siamo curiosi, interessati e bisognosi di capire come stanno effettivamente le cose), e che precisamente questa condizione o apertura permanente della nostra intelligenza attesta al tempo stesso che noi siamo sempre alla
ricerca di una certezza per esistere.
Fermiamoci ancora un momento sul caso della madre cattiva: è
vero che essa è cattiva (ne abbiamo finanche le prove oggettive!),
ma lo scoprirlo non ci lascia indifferenti, tanto che da questa terribile verità potrebbero derivare carenze e traumi indelebili per
tutta la vita. Non posso allora attestarmi sulla verità senza in
qualche modo mettere in gioco tutto il mio io, perché il vero non è
una formula matematica, ma un accadimento che mi tocca, mi interpella, chiede di me. Anzi, alcuni matematici ci testimoniano che
anche una dimostrazione algebrica può essere fonte di commozione, nella scoperta stupefacente, come una volta ha scritto il
matematico Eugene P. Wigner, che il mondo risponde alle nostre
ipotesi: «(...) Il fatto miracoloso che il linguaggio della matematica sia appropriato per la formulazione delle leggi della fisica è un
regalo meraviglioso che noi non comprendiamo, né meritiamo»
(The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences, 1959). Lo stesso discorso, come ha ricordato Paolo Ponzio,
può essere fatto per la fisica e per tutte quelle discipline «esatte»
o «oggettive», in cui è sempre all’opera il lavoro dell’inferenza e
l’avventura del soggetto.
Naturalmente noi possiamo pensare – in astratto – una verità
senza certezza, ma è come se pensassimo qualcosa a prescindere
da colui che la pensa e che è chiamato a dare il suo assenso a ciò
che riconosce come vero. Già nel dire «questo è vero!» si mette in
moto la dinamica della certezza. Come ha rilevato con la consueta
chiarezza Enrico Berti, anche la certezza (come l’essere o la verità) si dice in molti modi, e non può essere affrettatamente identificata con la coerenza logica o con la durezza non modificabile
dei fatti della natura o degli accadimenti della storia. È certo che
66
io sono nato nel 1954 (benché forse avrei voluto essere un «nativo digitale» del XXI secolo); e che stamattina pioveva non ci
sono dubbi, essendo stato costretto a rimanere a casa (anche se
avevo programmato di andare al mare). Certo, è così – con o
senza di me! Ma se per esempio io mi accorgo che, essendo nato
in questo mio tempo ho avuto modo di incontrare la persona che
amo o di scoprire un mio talento grazie ai maestri che ho incontrato o al contesto in cui ho studiato (e potrei continuare molto a
lungo, come ciascuno di noi), allora scoprirei che quel fatto anagrafico porta in sé un fiume di certezza sul fatto che l’esistenza mi
è stata data perché io potessi accoglierla e rispondere alle sue occasioni.
E se prendessi sul serio il fatto meteorologico della pioggia di stamattina come un evento che mi è dato per accorgermi con gratitudine di quanto sia importante casa mia come un luogo di rapporti,
di costruzione e di cura della mia umanità? Non si tratta di un
«perché» che so già a priori, e con cui posso «giustificare» le situazioni che non vanno, ma della scoperta intelligente che c’è un
invito silenzioso che mi viene dalle cose, che attende di essere
udito. Direi che questo è l’atto più semplice e più originario della
mia libertà, cioè quello di accorgermi e di accogliere l’altro da me.
E l’altro da me non è solo ciò che è fuori di me o diverso da me,
ma è anche il «me stesso» che mi è dato, che non ho fatto io, ma
che mi trovo addosso, come una finitezza che domanda il senso di
sé e di tutto, o come una passività che è la fonte del genio. Per
questo la certezza non è mai solo una condizione o una situazione
in cui ci troviamo di fatto, per appartenenza a una storia, a una
cultura o a un «mondo» tramandato (l’abitudine a fidarsi di cui
parla Salvatore Natoli), ma è anche – o richiede anche – sempre il
mio assenso, il mio atto di coinvolgimento. Detto per inciso, è tale
partecipazione del mio «io» a ciò che è più grande di me, a rendere ragionevole l’atto di fede, e viceversa a non ridurre la fede al
«salto» di chi non è capace di gestire con la sua autonoma virtù la
vita terrena.
Per farla breve, la certezza non è il contrario della storia e della libertà (come sembra intendere Gianni Vattimo) ma è la scoperta di
un significato inesauribile della realtà nelle pieghe del tempo,
nell’esperienza di ciò che è contingente, nella mia decisione di non
archiviare ciò che accade, di accoglierlo come un dato, di assentire
a esso. Assentire non vuol dire assolutamente essere sempre d’accordo o supinamente rassegnato a ciò che c’è o è accaduto (e che
molte volte gioca contro le nostre aspettative), ma accettare la
67
sua sfida, interrogare la sua presenza, metterci in gioco. La certezza, dicevo a Rimini, è una dinamica che implica sempre il fattore-tempo, non è un acquisto fatto una volta per tutte, ma è
qualcosa che ha a che fare sempre (come ha richiamato Salvatore
Veca) con la nostra stessa incompletezza. Quest’ultima non indica
un semplice limite da superare (o in cui accomodarsi, tentando di
gestirlo nella maniera più conveniente), ma coincide con l’impossibilità di arrestare la nostra domanda di significato, e con il suo rilancio continuo alla scoperta del reale. Se noi rinunciamo a priori
all’ipotesi almeno di una certezza, prima o poi rinunciamo alla verità, oppure la «blocchiamo» come ciò che non c’entra con noi.
Tutto insomma si gioca, a mio modo di vedere, nel rapporto completamente aperto, cioè non pregiudiziale, tra la ragione e la realtà. Che questo sia il problema risulta ad esempio in una recente
disputa tra il «pensiero debole» di Vattimo (non esistono fatti, ma
solo interpretazioni) e il «nuovo realismo» di Ferraris (esistono dei
fatti oggettivi non emendabili e indipendenti dalle nostre interpretazioni). Insomma: una ragione senza realtà, da un lato, è una realtà semplicemente indipendente dalla ragione, dall’altro (ne ho
discusso con lo stesso Ferraris in un dialogo apparso sulla rivista
Tracce, ottobre 2011). Delle due l’una: o i fatti che non si lasciano
modificare, o le interpretazioni che pretendono di modificare tutto.
Ma nel gioco delle due posizioni è proprio il nesso costitutivo tra
razionalità e realtà a risultare ormai inceppato, di modo che l’interpretazione resta solo una “prospettiva” soggettivistica, mentre
l’unico senso possibile dell’oggettività del reale è quello di essere
esterno al soggetto. Nell’ermeneutica post-moderna è come se io
non chiedessi più niente alla realtà, e la mia libertà fosse solo la
bella violenza della volontà, o la (meno bella) violenza del potere;
nel realismo oggettivistico (in cui si risente un po’ l’eco del vecchio
e nuovo positivismo) è come se la realtà non chiedesse più niente
a me, se non di essere riconosciuta come ciò che non sono io. Io,
invece... beh, quello resta ancora solo il regno delle mie interpretazioni e delle mie costruzioni culturali.
Mi ha colpito quando Sergio Belardinelli, riprendendo un tema su
cui avevo insistito a Rimini, ha osservato che la certezza non solo
ci inquieta – a differenza di tutte le sicurezze che possiamo possedere e di tutte le tranquillanti giustificazioni con cui possiamo illuderci –, ma addirittura esaspera le contraddizioni della nostra esistenza: segno che la certezza fiorisce, sobriamente, nella finitezza
di questo mondo, non nella fuga in avanti verso altri mondi (che
poi non sono solo i nirvana religiosi ma anche gli stupefacenti
68
ideologici o gli eccitanti culturali). È quella condizione ontologica di
cui ha parlato Eugenio Mazzarella, e di cui noi facciamo esperienza
come di un legame originario all’essere: prima di tutte le strategie
che mettiamo in opera per costruire le nostre certezze, siamo noi
che nasciamo da una certezza – vale a dire che non ci siamo dati
l’essere ma proveniamo da una «ragione» che è infinitamente più
delle nostre rationes, cioè dei nostri calcoli, e che questa provenienza è una chiamata cui non possiamo cessare di rispondere,
perché così cesseremmo di «esistere».
Non mi resta che rilanciare la questione dunque: e non semplicemente opponendo le mie ragioni alle ragioni degli altri, ma cercando di capire se le ragioni che ciascuno matura nella sua esperienza – a condizione, naturalmente, che sia leale e non
pregiudiziale con essa – possano «stare», non dico senza le certezze che si possono costruire nella vita, ma senza quella certezza
iniziale che la realtà ci ridesta con la sua presenza, ridestando con
ciò stesso quella «realtà» cui diamo volentieri il nome di «io».
Come una volta ha scritto G.K. Chesterton (nel grande libro su
San Tommaso d’Aquino): «Non va bene dire a un ateo che è un
ateo; o attribuire a chi nega l’immortalità l’infamia di negarla; o
pensare che si possa costringere un avversario ad ammettere di
avere torto dimostrandogli che ha torto in base ai principi di qualcun altro, e non ai suoi. Dopo il grande esempio di san Tommaso,
è valido – o forse avrebbe dovuto sempre esserlo – il principio che
o non discutiamo affatto con un uomo, o dobbiamo discutere in
base alle sue ragioni e non alle nostre». Appunto io vorrei capire
nuovamente la mia «ipotesi» (o se volete, il percorso della mia
certezza) proprio prendendo sul serio le ragioni di chi non la condivide. D’altronde, come il sagace Chesterton ebbe a dire in un’altra occasione (nell’Autobiografia), «io ho discusso tutta la vita
senza mai litigare, perché la cosa brutta dei litigi è che interrompono le discussioni».
mercoledì 19 ottobre 2011
69