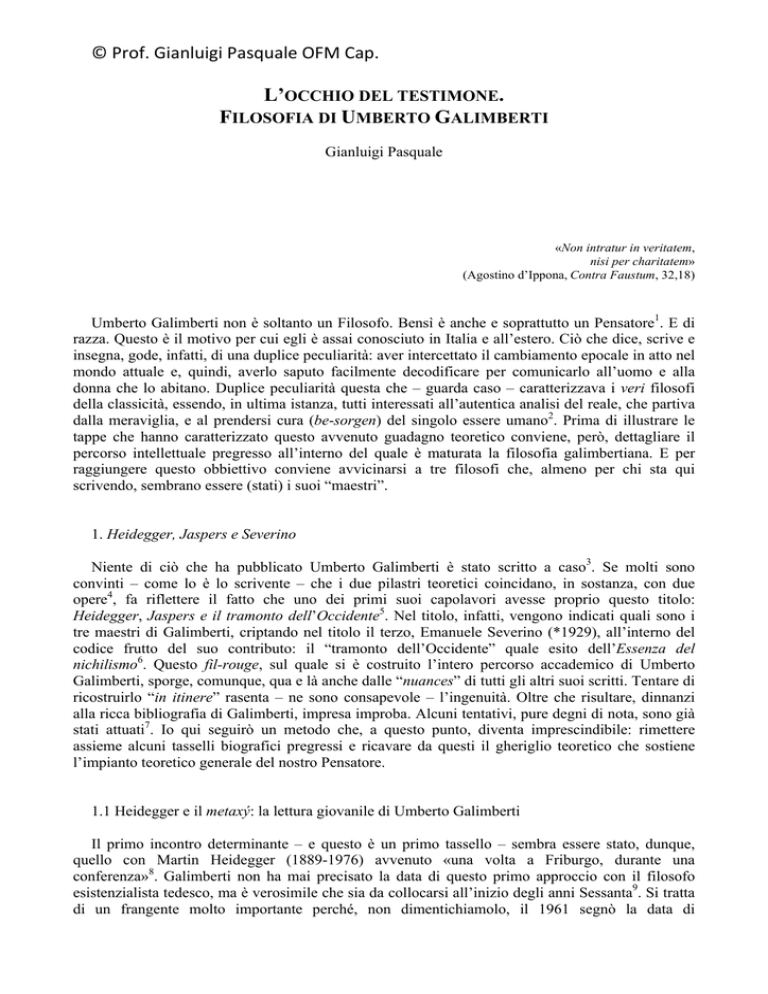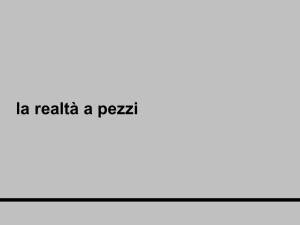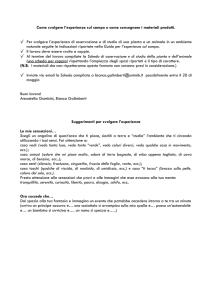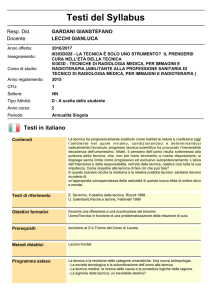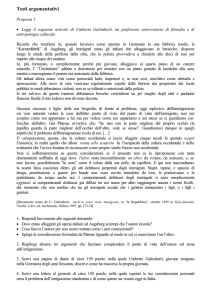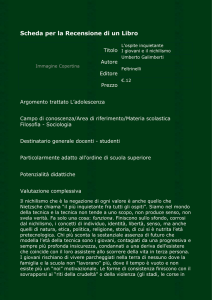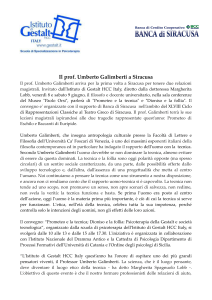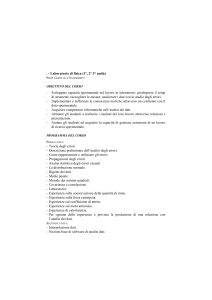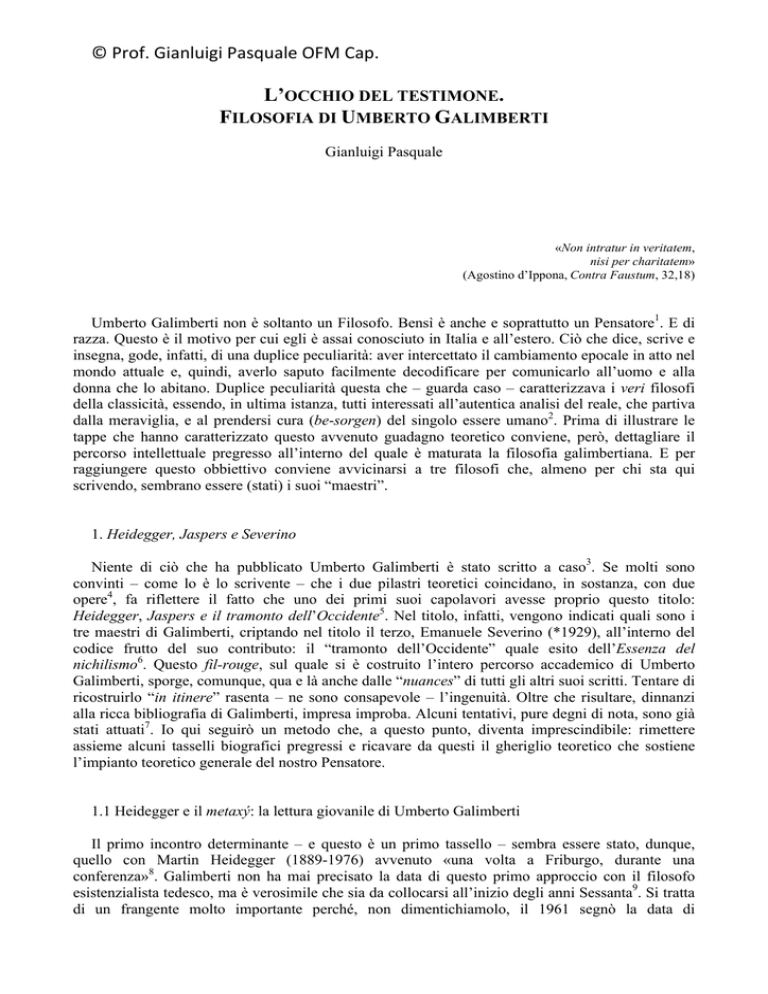
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
L’OCCHIO DEL TESTIMONE.
FILOSOFIA DI UMBERTO GALIMBERTI
Gianluigi Pasquale
«Non intratur in veritatem,
nisi per charitatem»
(Agostino d’Ippona, Contra Faustum, 32,18)
Umberto Galimberti non è soltanto un Filosofo. Bensì è anche e soprattutto un Pensatore1. E di
razza. Questo è il motivo per cui egli è assai conosciuto in Italia e all’estero. Ciò che dice, scrive e
insegna, gode, infatti, di una duplice peculiarità: aver intercettato il cambiamento epocale in atto nel
mondo attuale e, quindi, averlo saputo facilmente decodificare per comunicarlo all’uomo e alla
donna che lo abitano. Duplice peculiarità questa che – guarda caso – caratterizzava i veri filosofi
della classicità, essendo, in ultima istanza, tutti interessati all’autentica analisi del reale, che partiva
dalla meraviglia, e al prendersi cura (be-sorgen) del singolo essere umano2. Prima di illustrare le
tappe che hanno caratterizzato questo avvenuto guadagno teoretico conviene, però, dettagliare il
percorso intellettuale pregresso all’interno del quale è maturata la filosofia galimbertiana. E per
raggiungere questo obbiettivo conviene avvicinarsi a tre filosofi che, almeno per chi sta qui
scrivendo, sembrano essere (stati) i suoi “maestri”.
1. Heidegger, Jaspers e Severino
Niente di ciò che ha pubblicato Umberto Galimberti è stato scritto a caso3. Se molti sono
convinti – come lo è lo scrivente – che i due pilastri teoretici coincidano, in sostanza, con due
opere4, fa riflettere il fatto che uno dei primi suoi capolavori avesse proprio questo titolo:
Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente5. Nel titolo, infatti, vengono indicati quali sono i
tre maestri di Galimberti, criptando nel titolo il terzo, Emanuele Severino (*1929), all’interno del
codice frutto del suo contributo: il “tramonto dell’Occidente” quale esito dell’Essenza del
nichilismo6. Questo fil-rouge, sul quale si è costruito l’intero percorso accademico di Umberto
Galimberti, sporge, comunque, qua e là anche dalle “nuances” di tutti gli altri suoi scritti. Tentare di
ricostruirlo “in itinere” rasenta – ne sono consapevole – l’ingenuità. Oltre che risultare, dinnanzi
alla ricca bibliografia di Galimberti, impresa improba. Alcuni tentativi, pure degni di nota, sono già
stati attuati7. Io qui seguirò un metodo che, a questo punto, diventa imprescindibile: rimettere
assieme alcuni tasselli biografici pregressi e ricavare da questi il gheriglio teoretico che sostiene
l’impianto teoretico generale del nostro Pensatore.
1.1 Heidegger e il metaxý: la lettura giovanile di Umberto Galimberti
Il primo incontro determinante – e questo è un primo tassello – sembra essere stato, dunque,
quello con Martin Heidegger (1889-1976) avvenuto «una volta a Friburgo, durante una
conferenza»8. Galimberti non ha mai precisato la data di questo primo approccio con il filosofo
esistenzialista tedesco, ma è verosimile che sia da collocarsi all’inizio degli anni Sessanta9. Si tratta
di un frangente molto importante perché, non dimentichiamolo, il 1961 segnò la data di
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
pubblicazione di due libri che avrebbero, in diverso modo e con tempi differenti, spinto il dibattito
culturale verso il ridimensionamento del soggetto: Storia della follia nell’età classica di Michel
Foucault (1926-1984)10 e Nietzsche di Martin Heidegger11. È parimenti risaputo che quest’ultimo fu
il frutto di tormentati seminari tenuti tra il 1936 e il 1940, i quali spinsero addirittura il filosofo a un
passo dal suicidio. Nel Nietzsche heideggeriano si attribuisce alla metafisica l’aver costruito la
gabbia per un pensiero deviante, attuando il tentativo fallimentare del suo superamento, con l’esito
nefasto che la morte di Dio significò la morte dell’uomo12. Ed è probabilmente nel Nietzsche e nello
stesso Sein und Zeit13 heideggeriani che si annidano alcune intuizioni del pensiero di Umberto
Galimberti che veniamo a delineare.
Infatti, sempre in Germania, benché il Nostro si fosse sentito dire da Karl Jaspers (1883-1969)
che «“voi italiani” […] non siete ancora contaminati dalla suggestione di Heidegger, che ancora non
si è deciso a lasciar tradurre le sue opere per l’insufficienza del “vostro linguaggio”»14 comincia a
leggere Sein und Zeit. «Lo leggevo per esercitarmi in tedesco, ospite di una famiglia la cui madre
voleva imparare l’italiano, e in cambio di qualche conversazione mi traduceva le parole
incomprensibili di Essere e tempo»15. A differenza della “via veloce” scelta da alcuni lettori di
Galimberti, si deve, tuttavia, essere molto cauti nell’attribuire la “dipendenza” del Nostro da
Heidegger attraverso la sola mediazione severiniana.
Basterebbe, infatti, un’attenta lettura di due sole opere – La terra senza il male16 e Gli equivoci
dell’anima17 – per comprendere come tutta la questione ruoti attorno al lemma metacu, ovvero
all’intuizione attraverso la quale Heidegger traduce il frammento B 119 DK di Eraclito (535-475
a.C.) così: «l’uomo abita nelle vicinanze di Dio»18, intuizione fatta propria da Galimberti quando
pone l’accento sul “tra” («Zwischen») l’essere e il nulla19 tradotto, poi, nella “concentrazione” del
simbolo:
«la distruzione di questo simbolo segna la nascita dell’Occidente, dove non è più l’ordine del cosmo a dettare
legge alla città (pólis), ma è la città, come comunità dell’umano, a definire di volta in volta il cosmo.
All’orizzonte cosmo-politico si sostituisce il disegno di una politica cosmica, dove il progetto dell’uomo cancella
ogni simbolo, e i ritmi della sua storia quelle misure che, al dire di Eraclito, segnavano il “divampare e lo
spegnersi” dei cicli cosmici»20.
Non bisogna, tuttavia, dimenticare che questo registro heideggeriano importato di “prima mano”
senza alcun’altra mediazione, offre a Umberto Galimberti il terreno vergine sul quale sviluppare i
due consistenti versanti che declineranno, successivamente, tutta la sua opera: lo studio della
filosofia della storia e l’approccio alla psicologia dinamica21, discipline insegnate per tanti anni
all’Università di Venezia22. Ed è a questo livello che sporge, infatti, la figura di Karl Jaspers, pure
abilitato ad entrambe le discipline, secondo tassello che vogliamo prendere in considerazione.
1.2 Karl Jaspers e l’interpretazione degli Achsenzeit: filosofia della storia
Il nome di Umberto Galimberti è legato a quello di Karl Theodor Jaspers non soltanto perché è
stato il traduttore di alcune sue opere, quanto piuttosto perché avviene con lui il definitivo
intrecciarsi, tra gli interessi galimbertiani, di filosofia e psicologia. Cinque anni prima della morte,
«nel 1964, durante il mio soggiorno a Basilea, portai a Karl Jaspers due saggi di Emanuele
Severino: Ritornare a Parmenide, pubblicato in quell’anno, e Studi di filosofia della prassi, apparso
due anni prima»23 – ricorda Galimberti. Tuttavia, fu soltanto grazie alla mediazione del Prof. Kurt
Rossmann, il quale in quegli anni insegnava filosofia della storia all’Università di Basilea, che
Jaspers cominciò a interessarsi dei due scritti severiniani. In quel frangente, però, Galimberti capì
che «Jaspers non pensava come Severino, né Severino come Jaspers»24. E che, soprattutto, si
insinuava tra i due un alquanto diversificato approccio al già menzionato Sein und Zeit di Martin
Heidegger:
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
«a differenza di Heidegger, Severino ritiene che Platone non sia responsabile tanto dell’oblio dell’essere, quanto
del suo annullamento, avvenuto in occasione dell’affermazione del mondo. Il mondo, infatti, è il luogo in cui
Platone accetta tranquillamente che gli enti divengano, nascano e muoiano, siano e non siano»25.
In merito all’influenza operata da Karl Jaspers sul pensiero galimbertiano, si può concordare con
quanto è già stato opportunamente rilevato26, ossia che Umberto Galimberti dipenda dalla
riflessione jaspersiana sul tempo e in particolare dalla nozione di tempo assiale (Achsenzeit),
vergato dai cambiamenti fondamentali del pensiero occorsi tra il IX e il III secolo a.C., e a sua volta
ascrivibile a Max Weber27. Secondo questa concezione, il tempo assiale determina la nascita della
religione «che, come vuole l’espressione di Jaspers, è sostanzialmente “liberazione dal tragico”
(Erlösung vom Tragischen)»28. Ed ecco perché, in particolare, da Jaspers il Nostro ha mutuato la
consapevolezza che ogni realizzazione storica della verità è per l’uomo una realizzazione di ordine
simbolico29. Infatti, «Jaspers guarda con sospetto la minacciosa sicurezza (bedröhende Sicherheit)
che caratterizza l’atteggiamento di chi pretende, in filosofia, di assegnare un contenuto positivo alla
trascendenza, di chiamarla per nome e cognome»30.
Galimberti non ha dubbi, a questo proposito: se la filosofia vuole avere un futuro essa deve
smettere di pensare l’essere sul modello del dualismo fra essere ed ente, pena il rischio gravissimo
di trovarsi incagliati nell’impossibilità di (poter più) pensare31. Il futuro da venire sarà non tanto nel
recupero della differenza ontologica, perché tutto ciò è «già fatto da tempo»32, bensì nel recupero
del linguaggio dell’alienazione, il quale si stacca dalla persuasione che ente e (ni)ente siano
diversamente tali perché scanditi tra un passato, un presente e un futuro, quando, invece, abitano
forse il tempo come tale. Qui, almeno per chi scrive, Umberto Galimberti porta a saturazione il
concetto jaspersiano di “tempo assiale” e lo salda con quello del suo terzo “maestro”, Emanuele
Severino, che ora dobbiamo necessariamente, per quanto succintamente, avvicinare. Un terzo passo
non meno titanico dei precedenti.
1.3 Emanuele Severino: la sottrazione all’ontologia e il ritorno ad Atene
Abbiamo già osservato come Umberto Galimberti e il filosofo italiano Emanuele Severino33 si
siano incrociati attorno all’interpretazione da conferire all’occasus mundi, al tramonto
dell’Occidente. Nessuno oggi può più mettere in dubbio, o in forse, che la linea del sole volgente al
tramonto si scorga alquanto “al ribasso” nell’ovest del mondo, avendo quasi generato, appunto, un
“basso continuo”. Confesso che il luogo – l’Università di Toronto in Canada – dove ho maturato
queste riflessioni durante il lungo autunno del 2011 mi ha confermato assai – almeno in questa –
intuizione severiniana e, quindi, in quella galimbertiana. Non tanto per il clima atmosferico,
oltremodo più melanconico e grigio di quello britannico, quanto piuttosto per lo scenario
circostante, dipinto di solitudine abissale, congelamento dei rapporti umani in nome della privacy,
impossibilità di esprimere qualsiasi affetto perché non rientrante nella “funzionalità” richiesta dal
sistema universitario, paura di stringere qualsivoglia tipologia di rapporti umani a causa del timore
di rinvenire nell’altro l’“ospite inquietante” che si vorrebbe, comunque, evitare e viceversa. E non
credo che questo scenario sia (stato) soltanto il frutto maturato in occasione dell’anniversario
decennale dalla caduta delle “torri gemelle”.
Piuttosto, sono convinto anch’io che l’eziologia sia ben più radicata – come scrive molto
acutamente Galimberti – nell’azione di sgretolamento attuata dal nichilismo di cui l’Occidente si è
rivestito perché, anzitutto, da esso ammaliato: «Severino concorda con Heidegger nel ritenere che
alla base del nichilismo dell’Occidente c’è la volontà di potenza, ma non è d’accordo sul modo con
cui la volontà di potenza realizza la sua opera nientificante»34. Al di là di questa sottigliezza
teoretica distintiva, interessa qui a noi l’ermeneutica attraverso la quale Galimberti “importa” dal
maestro Severino il fotogramma che dell’Occidente vuole parlare, ossia il suo tramonto come il
ritorno all’età della pietra:
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
«conoscendo essenzialmente solo la volontà di potenza, l’uomo occidentale è più vicino all’uomo della clava di
quanto non sia vicino all’immagine di uomo evoluto che s’è costruito di sé. Tra la clava e la tecnologia non c’è
differenza, se a promuovere l’una e l’altra è la volontà di distruzione o assimilazione. Sotto l’una e l’altra forma,
ciò che si nasconde è l’incapacità di concepire l’uomo come altro da ciò che noi occidentali siamo divenuti [...]
L’accelerazione tecnologica non concede di lasciare questa trasformazione ai tempi millenari delle mutazioni
antropologiche»35.
In altre parole, concedendosi totalmente alla tecnica con la speranza di uscirne ulteriormente
“specializzato”, l’identità simbolica dell’essere umano – ciò che lo costituisce come un singolo
essere irrepetibile – si è lasciata assorbire dall’apparato, dal sistema, dovendo eseguire soltanto ciò
che l’apparato (pre)scrive alla creatura umana, appunto in modo imprescrittibile36. Senza tema di
smentita, oso qui affermare che la filosofia di Umberto Galimberti è forse l’unica che è riuscita a
smascherare in maniera chiaroveggente il gravissimum periculum in cui si è incagliata la persona
umana stessa senza accorgersene, persona umana che è oggetto così caro a chi si professa cristiano
e appartiene alla comunità credente. Purtroppo, però, è stata sovente quest’ultima che ha bollato
l’analisi galimbertiana come completamente allogena all’interpretazione del Nuovo Testamento.
Penso che ciò sia accaduto perché pochi hanno saputo dedicare qualche decennio allo studio delle
opere del Nostro, scevro da pregiudizi, che non fossero – kantianamente parlando – i propri.
Sporge, pertanto, all’orizzonte un grosso guadagno che la filosofia di Umberto Galimberti potrebbe
consegnare all’umanesimo cristiano e perfino alla dottrina sociale della Chiesa. A sapere: il riscatto
dell’uomo dallo scoglio della tecnica dove, suo malgrado, si trova ancora ineluttabilmente
inceppato.
La posta in gioco che, infatti, permane in tensione tra l’età tecnologica e pre-tecnologica è assai
alta. L’età della tecnica, per così dire, sta spellando l’essere umano da quel “quid” – direbbe
Aristotele – che tra tutti i viventi lo rende un “unicum”, la sua umanità:
«mentre nell’età pre-tecnologica era possibile riconoscere l’identità di un individuo dalle sue azioni, perché
queste erano lette come manifestazioni della sua anima, a sua volta intesa come soggetto decisionale, oggi le
azioni dell’individuo non sono più leggibili come espressioni della sua identità, ma come possibilità calcolate
dall’apparato tecnico, che non solo le prevede, ma addirittura le prescrive nella forma della loro esecuzione.
Eseguendole, il soggetto non rivela la sua identità, ma quella dell’apparato, all’interno del quale l’identità
personale si risolve in pura e semplice funzionalità»37.
Sembra, dunque, aver ragione Luigi Perissinotto (*1953) quando dice che
«su questa persuasione [: severiniana che l’essere è niente] sono sorte e tramontate società, ideologie, movimenti
politici e religiosi; di questa persuasione la tecnica, che pervade e invade il nostro tempo, è la più estrema e
coerente attuazione rispetto alla quale nulla valgono le resistenze della Chiesa cattolica o quelle del
marxismo»38.
Da quest’angolo visuale, è pur vero che Umberto Galimberti dipende dalla riflessione di
Emanuele Severino39 e, tuttavia, non si lascia da essa del tutto imbrigliare o meglio – come egli ama
dire utilizzando un’espressione assai plastica – gli «gira attorno come si girerebbe attorno a una
torre d’avorio»40 perché – confessa Galimberti a questo proposito –
«[mi] si muoverà l’obiezione che sempre mi è stata rivolta: “Galimberti non prende mai posizione nei confronti
del suo maestro, non lo critica dall’interno, lo contempla e lo ammira come si contempla e si ammira un’opera
d’arte”. È vero – continua Galimberti – è proprio così. Perché fin da quando, nel lontano 1960, ascoltavo le
lezioni di Emanuele Severino, ho avuto la sensazione immediata che da quel sistema di pensiero o si restava
fuori nella più assoluta indifferenza, o, se si entrava, se ne restava a tal punto incatenati da non poterne più
uscire. La forma divorava tutti i contenuti che, non appena formalizzati, perdevano la loro specificità, il carico
che la storia aveva loro assegnato, per diventare semplici occasioni per l’esercizio di un pensiero che, come un
diamante, ne enucleava l’essenza per riassorbirla nella sua formalizzazione»41.
2. La cifra dello scenario attuale
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
Grazie a questi tre “maestri” abbiamo, dunque, un pensiero nuovo di cui è a capo Umberto
Galimberti. Si diceva un pensiero che fotografa l’esistente e ne denuncia lo scoglio in cui si è
incagliato: la saldatura – per quanto a noi risulti paradossale – tra progresso e preistoria, scienza e
clava. Da un primo versante, insomma, Umberto Galimberti ha in più occasioni spiegato, fin nei
minimi dettagli, lo scenario attuale nel quale noi abitiamo, che è quello della tecnica dove «l’uomo
non è più il soggetto della storia ma è ormai diventato un funzionario dell’apparato tecnico»42. Al
suo interno, infatti, «egli deve compiere quelle azioni descritte e prescritte che compongono il suo
“mansionario”, mentre la sua persona è messa tra parentesi a favore della sua funzionalità»43.
Dall’altro, dello scenario ha denunciato la situazione di stallo. E, tuttavia, è andato oltre indicando
alcune possibili “via di fuga” ancora percorribili. A mio parere esse sono le due importanti
“precisazioni” a I miti del nostro tempo quelle che illuminano al meglio, appunto, queste vie di
uscita.
2.1 La scienza “gronda di teologia”
La prima è l’alleanza che è stata siglata tra scienza e tecnica. Quest’ultima, invece che una
«semplice applicazione della scienza, in realtà ne è l’essenza stessa»44. Il DNA epigenetico della
tecnica è, infatti, quello di continuare a riprodurre se stessa, e in questo si annida il suo protocollo di
scientificità. Detto in altri termini, la “santa alleanza” insinuatasi – secondo Galimberti – tra scienza
e tecnica procura alla scienza l’inarrestabile destino, determinato dalla tecnica, di non potersi più
arrestare, divorando funzionalmente chi alla tecnica si affida: in primis l’uomo. Sporge, quindi, la
seconda “precisazione”, addirittura più importante. A sapere: il fatto che la scienza è «figlia della
teologia medievale»45 perché «gronda di teologia»46. In realtà essa riproduce incessantemente la
scansione temporale tra passato, presente e futuro dichiarando che è dal futuro che l’uomo deve
aspettarsi quel di più e di meglio che soltanto la scienza ancora gli promette. Nessuno di noi infatti,
a meno che non sia un folle, si attende dal domani qualcosa che, rispetto ad oggi e a ieri, sia
peggiore. Non a caso “Avanti”, “Avvenire” e “la Repubblica”, più di altre, erano e sono il
“manifesto” utilizzato da tre testate giornalistiche “confessionali”, le quali, a volte, non sono state
proprio così “generose” recensendo la produzione bibliografica del Professore Galimberti.
Prima di proseguire oltre, e precisamente a questo livello, Galimberti inserisce, quindi, due
correlati i quali risultano assai utili alla nostra ricostruzione. Innanzitutto, la presa d’atto che
l’Occidente è stato, per così dire, irreversibilmente siglato dall’evento cristiano. Quella voce udita
durante la notte da Paolo di Tarso «passa in Macedonia e aiutaci» e proferita da un angelo (At 16, 9)
ha lasciato dietro di sé un segno indelebile. A breve vedremo, però, di quale portata. Poi, l’altro
correlato per cui, grondando la scienza di teologia, il cristianesimo certamente persisterà negli anni
a venire – anche se sembra sgretolarsi – proprio perché il mondo non può più fare a meno della
scienza, che a sé lo ha funzionalizzato, manipolandolo. E con quella anche l’uomo e il corpo che
l’uomo è47.
In maniera confidenzialmente interlocutoria, mi verrebbe spontaneo, tuttavia, chiedere, a questo
proposito, al Prof. Galimberti se questo “caro prezzo” che il cristianesimo sta pagando alla sua
esistenza dovendo necessariamente sopravvivere sotto mentite spoglie, quelle appunto della scienza
a se sufficiente, non sia in realtà attribuibile all’impatto creatosi con la cultura incontrata, verso
ovest, oltre la Macedonia: in Occidente48. Siano ben accorti qui, i lettori “teologi”, che non si sta
parlando affatto della questione dell’“ellenizzazione del cristianesimo”, bensì della constatazione
che se per Israele la storia è un “ascolto”, per il greco e il latino e un “videre”, una “historia”,
appunto, come avremo modo tra poco modo di dimostrare49.
2.2 L’uomo ancorato sulla soglia dell’anticamera
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
Da un altro versante, come avevo anticipato, dopo aver intercettato il cambiamento epocale in
atto, Umberto Galimberti è riuscito, altresì, a decodificarlo accorgendosi che, dinnanzi a quello,
l’uomo continua a vivere come se fosse in una preistoria. Il dramma di tutto ciò, secondo
Galimberti, sta, infatti, nella discrasia creatasi tra l’inserimento rapido della tecnica nel nostro
mondo e l’illusione che tra di noi persista ancora uno scenario umanistico:
«in questo inserimento rapido e ineluttabile portiamo ancora in noi i tratti dell’uomo pre-tecnologico che agiva in
vista di scopi iscritti in un orizzonte di senso, con un bagaglio di idee proprie e un corredo di sentimenti in cui si
riconosceva. L’età della tecnica ha abolito questo scenario “umanistico”, e le domande di senso che sorgono
restano inevase, non perché la tecnica non sia ancora abbastanza perfezionata, ma perché non rientra nel suo
programma trovar risposte a simili domande»50.
D’altro canto, lo aveva già intravisto Friedrich Nietzsche (1844-1900), secondo il quale «ogni
conformità a leggi, la quale ci fa talmente impressione nel corso degli astri e nei processi chimici,
coincide in fondo con quelle proprietà che noi stessi introduciamo nelle cose»51. Queste proprietà
iniettate nell’ente sono, appunto, i concetti, essendo consapevoli che «alla costruzione dei concetti
lavora originariamente, come abbiamo visto, il linguaggio, e in epoche posteriori la scienza»52.
Il passo, pertanto, utile a “far brillare” in un’esplosione la metafisica è, secondo Umberto
Galimberti, assai breve:
«stando così le cose, la religione non può pensare di risorgere memorando il Dio della metafisica o richiamando
la sua onnipotenza ad un uomo, quello occidentale, che la sta programmando. Ritornare sulle orme della
metafisica, sulle orme, cioè, di quella concezione che affida a un ente la produzione dell’essere e del nulla,
equivale a proseguire a passi rapidi sulla strada aperta dalla scienza»53.
Ecco perché al termine di questa mia breve entratura nell’immensa e rigogliosa produzione del
pensiero galimbertiano sembrano, dunque, sporgere due questioni “ultime” che vorrei, a questo
punto, poter dibattere con il Professore Galimberti. Si tratta di due questioni che ritengo
fondamentali: il momento della nascita della cosiddetta “storia” avvenuta – come egli ha detto54 –
con il cristianesimo, e l’appiattimento sul presente di ogni tempo che ha generato l’“ospite
inquietante”55. Saranno questi due fuochi di un’unica elisse, che possiamo già fin d’ora delineare
mediante i contorni della nascita della “coscienza storica”, che ci terranno impegnati per le pagine
che seguono.
3. Conoscenza o coscienza storica?
Qualsiasi opera di riflessione sulla storia sonda il senso dell’agire e del patire degli uomini nella
storia stessa. Se di questo era già consapevole anche il pensiero greco più modesto, spetta a
Umberto Galimberti aver compreso che la ricerca del senso della storia è, oggi, già condizionata in
partenza dal pensiero ebraico e cristiano, per i motivi che abbiamo appena enucleati. Tuttavia,
proprio se si effettua, per così dire, un “ritorno ad Atene”, Galimberti sostiene che, in merito
all’istituzione di una coscienza storica, prima le cose non stavano proprio così perché il problema
attualmente rubricabile in termini di “coscienza storica”, premeva, all’inizio, molto più sull’altro
inerente la “conoscenza storica”, ad esso collegata. Detto per converso, la ricerca del senso ha
istanziato il “problema” della coscienza storica, polarizzandosi su una comprensione della storia che
oggi ci appare essere la comprensione “universale” in modo così ovvio da renderci difficile credere
che in qualche momento non sia stato sempre così. Appunto: a e in Atene. È, dunque, necessario –
così ci sembra suggerire Galimberti – distinguere adeguatamente coscienza e conoscenza storica,
almeno per chi intende affaccendarsi con la filosofia della storia.
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
3.1 Conoscenza storica: investigato e investigatore
La conoscenza storica è strettamente connessa, dal punto di vista epistemologico, alla possibilità
di concepire la “storia” come scienza56. Tale possibilità ha subìto una critica a tutto campo da parte
del neopositivismo logico il quale – com’è risaputo – ha investito le scienze “dello spirito” in
generale, e tra queste la scienza derivante dalla conoscenza storica. È, comunque, ovvio che il suo
oggetto d’analisi non è così facilmente oggettivabile. Esso non è, infatti, avvicinabile prescindendo
dalla problematicità del presente, perché il soggetto “investigatore storico” si tuffa nel passato
portandosi appresso, inevitabilmente, il suo presente, per esempio il suo essere un ricercatore, un
viandante. E così del processo risulta rilevante non il fatto in sé, ma la conoscenza che se ne deve
avere, conoscenza che, così concepita, pone il problema della “coscienza storica” che qui a noi
interessa particolarmente.
È stato Hans Georg Gadamer (1900-2002) colui che ha chiaramente analizzato le varie
implicanze del presunto obbiettivismo del lavoro storico, mettendo in evidenza che la metodologia
critica di quest’ultimo non si può esimere dalla famosa “Wirkunsgeschichte”, ossia dall’intreccio
della storia degli effetti, in cui la conoscenza storica stessa si trova avviluppata. Essa consiste
nell’effetto generato dalla storia delle interpretazioni che interviene a condizionare la comprensione
del dato storico da parte dell’investigatore, di modo che egli è comunque – consapevolmente o
inconsapevolmente – guidato da pre-giudizi. La Wirkunsgeschichte, a sua volta, diventa un ulteriore
dato storico, il quale rafforza la consapevolezza dell’investigatore di essersi inabissato nella
distanza dall’investigato. Tutto ciò si osserva chiaramente, secondo Gadamer, nell’opera d’arte.
Uscita dalle mani dell’artista, a causa dei continui effetti della Wirkunsgeschichte, l’opera d’arte
diventa ineluttabilmente qualcos’“altro” per i diversi effetti che, nel tempo, produce lo sguardo
ermeneutico già portato su di essa57. Proprio come accade per chi scrive un libro.
Ne consegue che un pensiero autenticamente storico deve essere consapevole anche della propria
storicità e che il vero oggetto della storia non è affatto un oggetto, ma un rapporto in cui consiste –
o in-siste – sia la realtà della storia, sia, insieme, la realtà della comprensione storica58. Per
conoscenza storica si intende, in ultima analisi, quella consapevolezza di sapersi-in-situazione59,
sempre come compito ermeneuticamente impegnativo, giacché in realtà non è la storia che
appartiene a noi, ma siamo noi che apparteniamo alla storia. Vediamo nel passo successivo in che
senso, al fine di evitare che quest’ultima affermazione appaia pericolosa.
3.2 Conoscenza storica: polivalenza del termine tra Greci e Latini
Sulla comprensione del concetto di conoscenza storica pesa, infatti, la fondamentale ambiguità
della locuzione i(stori/a, a causa dell’irriducibile polivalenza del termine60. Sia per i Greci che per i
Latini vi sono tre accezioni di “conoscenza storica”. In primo luogo, la conoscenza storica è quella
specificità di conoscenza di quanto è accaduto nel passato rispetto ad altre modalità dell’esperienza
della percezione del divenire. Secondariamente, la conoscenza storica può coincidere con la
classificazione metodologicamente precisa degli avvenimenti: con questa accezione essa riveste i
caratteri di scienza, avente specifici oggetto, metodo e obbiettivo da raggiungere. In terzo luogo, la
conoscenza storica riguarda la giustificazione di quello che la coscienza comune di ciascuna epoca
culturale trattiene in riferimento al divenire degli accadimenti cui ha partecipato e di cui può essere
testimone. In generale i(stori/a ha, infatti, a che fare con il sostantivo i(store/j e con il verbo i(store/w,
il cui semantema riguarda il fatto di conoscere, rispettivamente, riguardo all’eventualità di aver
visto, all’acribia di aver ricercato o alla capacità di esporre quanto si è trovato.
Quest’ultima fattispecie di significato concerne il rapporto tra storia e narrazione, facendo
apparire la conoscenza storica come un racconto dell’uomo che si trova al mondo61. Infatti, quando
noi parliamo di conoscenza storica alludiamo a qualcosa di più del reperimento dei contingenti
eventi prammatici; ci riferiamo, piuttosto, all’intero mondo dell’uomo, al suo “mondo storico” o
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
alla realtà come storia, presupponendo, pertanto, che questa conoscenza storica promossa a mondo
e realtà sia la dimensione dell’esistenza umana, in modo diverso dal mondo naturale costitutivo del
cosmo fisico. Per sintetizzare le tre piste ermeneutiche sopra enunciate e offrire una pre-nozione
formale di ciò che qui si intende con il termine “conoscenza storica”, possiamo dire che essa è la
presa cognitiva di quanto è già accaduto e che può essere avvicinato con una ricerca
metodologicamente precisa, per essere riferita, poi, come racconto.
La ricerca di un inizio cronologico in cui ravvisare la nascita della conoscenza storica è, in
quanto tale – ovvero in quanto ricerca metodologicamente fondata –, condizionata dal limite di
trovarsi situati all’interno del bacino culturale occidentale, che tuttavia costituisce la condizione per
l’indagine nella prospettiva dell’occasus mundi, come ci ha insegnato Umberto Galimberti62. Già la
grecità classica ebbe modo di offrire diversificati schemi interpretativi della conoscenza storica.
Basti ricordare sinteticamente i tre famosi storiografi che le diedero avvio: Erodoto, Tucidide e
Polibio. Erodoto (484-430 a.C. ca.) si propose di narrare i fatti accaduti nel passato, «affinché le
azioni degli uomini non vadano perdute con il tempo e le imprese grandi e meravigliose, compiute
sia dai Greci sia dai barbari, non rimangano prive di fama, e in particolare i motivi per i quali
combatterono gli uni contro gli altri»63. In questa maniera, Erodoto fu il primo a utilizzare
l’espressione «a/po/decij i/stori/hj», ossia «ciò che si è ricevuto storicamente». Secondo lui l’indagine
dello storico consta in una ricostruzione dei fatti resa possibile, in primo luogo dalla visione diretta
(w(po/j), quindi da ciò che egli apprendeva da altri direttamente o mediatamente (a)koh/), in sostanza
dalla voce, dalla fama, dall’opinione lo/goj gnw/mh circa quanto era accaduto. Lo schema temporale
della conoscenza storica di Erodoto non è, pertanto, un processo significativo della storia
universale, che si riferisca a un fine futuro, ma è, in corrispondenza con la concezione greca del
tempo, un movimento circolare periodico, all’interno del quale l’alterna vicenda dei destini è
regolata da un “equilibrio” di u(/brij e di ne/mesij64.
Colpisce, invece, in Tucidide (460-404 a.C. ca.) la passione per la ricerca della verità, volendo
fornire alla rappresentazione degli avvenimenti un’analisi precisa dei nessi pragmatici tra i fatti
accaduti (pra/gmata). La conoscenza storica è per lui rendiconto di lotte politiche, dal quale emerge
una caratterizzazione negativa della natura umana. E poiché quest’ultima essenzialmente non muta,
ciò che è accaduto si verificherà anche nel futuro in modo analogo. Per questo, stando a Le storie di
Tucidide, il futuro non può portare nulla di completamente nuovo: può darsi che generazioni e
individui futuri, in determinate circostanze, agiscano in modo più saggio, ma la storia, in quanto
tale, non muterà mai essenzialmente. In Tucidide la sintesi tra argomento e forma storiografica è,
dunque, pregiudiziale nell’istanza di un accertamento e di una documentazione affidabile e
inequivocabile, impossibile per il passato, che storiograficamente si confondeva nella forma del
mito e della esposizione etnografica e novellistica. Perciò egli procede “ricostruendo” il passato in
funzione delle forze politiche del suo tempo. Polibio (202-120 a.C. ca.), invece, non ha questo
rigore problematico che impegna il pensiero in una coerenza intransigente nei confronti dell’idea
storica che urge e investe in profondità le res, non distraendosi mai, né concedendosi pause o indugi
nel resoconto dei fatti. La sua preoccupazione è di tutt’altra natura; si potrebbe ritenere più diligente
e accurato, attento fino allo scrupolo a ottenere una chiarezza di narrazione, tenendo in pugno tutte
le fila di un grande disegno, dove la continuità è un impegno essenziale. È vero, infatti, che Polibio
non si trova, come Tucidide, di fronte a documenti di i(stori/a che sfumavano nel mito, poiché ha a
disposizione fonti più o meno esatte, più o meno degne di fede, più o meno in accordo con le sue
intenzioni65.
Con l’ellenismo tutta la produzione storiografica greca subì, dunque, un processo di
universalizzazione, sia perché si cominciò a considerare la conoscenza storica come storia di tutti i
popoli – e non di uno soltanto in particolare – sia, soprattutto, perché si misero definitivamente per
iscritto molte fonti narrative. Conviene ricordare, infatti, come pressoché tutta la “letteratura” antica
fosse trasmessa a memoria mediante canti ritmici e risultasse, per ciò stesso, continuamente
produttiva. I poemi omerici, per esempio, erano mitici non solamente perché quello che
raccontavano era vettorialmente riferito al presente – trovando in ciò una legittimazione e
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
un’esemplarità –, ma anche perché costituivano una memorabilis traditio, variamente interpretabile
dal “traditore” in riferimento all’esistenza. A questo proposito emblematico è, per l’area latina, il
caso di Publio Cornelio Tacito (55-117). Negli Annales egli perfeziona l’arte storiografica già
sapientemente impiegata nelle Historiae. I drammi di anime che Tacito narra non mirano, infatti, a
suscitare emozioni nel lettore, bensì hanno la funzione di scavare piuttosto nell’animo stesso dei
personaggi per portarne alla luce passioni e ambiguità66. In questo modo, però, la storiografia antica
pone in evidenza la propria capacità di modellare la conoscenza del passato sulla base della
diversificata interpretazione, anche drammatica, che ne dà lo storiografo, in questo caso agli
antipodi dalla narrazione non partecipata e oggettiva di eventi67.
3.3 Conoscenza storica: l’impatto con il cristianesimo
Molto più problematico – secondo Umberto Galimberti – è il tentativo di descrivere lo sviluppo
della conoscenza storica dall’apparizione del cristianesimo alla successiva era christiana e
medioevalis68. Una prima ipotesi circoscrive questo arco di tempo dal secolo III – allorché il
cristianesimo si preparava a diventare religione ufficiale – fino alla metà circa del XIX secolo,
quando venne messa in crisi proprio tale ufficialità. Fu soprattutto il cristianesimo, diffondendo
l’idea di unità di tutto il genere umano derivante dall’atto di creazione, a conferire alla visione e alla
considerazione della conoscenza storica il principio unitario derivante da quello soprannaturale per
il quale tutta la storia mira al fine ultraterreno e metastorico69. Successivamente si osserva nello
sviluppo della conoscenza storica l’azione di altri due fattori. Da una parte, si accetta l’omogeneità
del tempo, indotta nella società medievale dalla struttura ecclesiastico-feudale della medesima: il
tempo, sia quello circolare del calendario liturgico, sia quello lineare delle storie e dei racconti,
diventa divisibile in parti eguali e meccanicamente misurabili dal potere unificante prima della
monarchia e poi degli Stati. Da un’altra prospettiva, i maestri delle scuole cittadine e delle prime
università veicolano una nuova concezione del libro: esso non è più e non soltanto la messa per
iscritto di fatti avvenuti nel passato, bensì soprattutto prova che tali fatti sono avvenuti, appunto
perché scritti su carta70. Questo elemento di novità è ulteriormente rilevante, se si considera la
dimensione di pubblicità che stavano assumendo allora i centri culturali in quel frangente storico.
La messa per iscritto in questo periodo tocca, dunque, sensibilmente la conoscenza storica per la
diffusione centrifuga di manoscritti, rotoli, libri, eccetera.
L’apparizione nel XIX secolo dello storicismo marcò, infine, un profondo cambiamento per la
conoscenza storica. Già il romanticismo aveva tentato di superare la divisione tra storie particolari e
quella universale o, se si vuole, tra finito e infinito, e aveva considerato la conoscenza storica quale
sintesi di tutte le scienze, aprendo così la prospettiva allo “storicismo” propriamente detto. Nel suo
significato più ristretto e preciso, lo storicismo indica una corrente di pensiero che si ricollega alla
storiografia tedesca del secondo Ottocento (Leopold von Ranke, 1795-1886; Johann Gustav
Droysen, 1808-1884), la quale sottopose a critica la filosofia della storia romantica in nome di un
“realismo storiografico” libero da dogmi dialettici71; questa corrente si sviluppò in due momenti
relativamente autonomi, in Germania e in Italia. Dinnanzi allo storicismo la conoscenza storica si
trovò, pertanto, assai sensibile alle spiegazioni razionali delle scienze naturali circa le relazioni
causali tra eventi succedentisi nel tempo, formulabili secondo leggi universali e necessarie. La
conoscenza storica sembrava assumere, quasi, il metodo delle scienze naturali attraverso una
ricostruzione oggettiva della causa da parte dello storico, il quale indeboliva la propria pretesa di
obbiettività assoluta a favore di una mirata imparzialità.
Nell’epoca contemporanea ci si è accorti, però, che la conoscenza storica entra in uno stato
radicale di problematicità, proprio per aver perso la sua specifica obbiettività, non considerando più
i “fatti passati”, ma i “problemi” rivolti al presente. Da qui la crisi attuale della “coscienza” storica.
Secondo Marc Bloch (1886-1944), per esempio, dinnanzi al neopositivismo logico la scienza storica
confessa il proprio imbarazzo, perché le stesse conclusioni “scientifiche” del lavoro dello storico
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
non dispongono mai di una documentazione così esaustiva, tale che da essa si possa evincere il
significato e il senso di ciò che si sta analizzando. La storia, secondo Bloch, non può essere
completamente scritta, perché essa è una rete infinitamente complessa di sviluppi, di serie causali di
volta in volta parallele, intersecate, anatomizzate72.
Gli fa eco Henri-Iréné Marrou (1904-1977) per il quale la storia, considerata nella sua totalità e
realtà profonda, è anche un mistero, nel senso che la conoscenza che possiamo acquistarne è sempre
estremamente limitata e questo allo stesso tempo per ragioni tecniche, gnoseologiche e infine
ontologiche. Non vi è ydola mentis più dannoso, a dire di Marrou, di quell’ipotesi per cui, tra le
differenti manifestazioni contemporanee della vita, esista un’unità – appunto quella storica – più o
meno paragonabile a quella di un organismo vivente. Questa testimonianza di persona esperta è «il
solenne avvertimento che lo storico indirizza al suo fratello filosofo»73. Se, dunque, fino a un secolo
fa tutto viene spiegato storicamente mediante un continuo passaggio dal “perché” al “come”, il
Novecento presenta, invece, una domanda inedita sul reale: “che senso ha?”74, segnando, così e
finalmente, il passaggio dalla conoscenza, alla coscienza storica. Due sono state finora le risposte
rilevanti date al nuovo interrogativo: il nichilismo, per il quale la coscienza storica non ha alcun
senso perché solo l’essere umano gliela può conferire, e l’ermeneutica (specialmente quella di
Ludwig Wittgenstein, 1889-1951), che afferma l’esistenza di un senso, il quale, però, deve essere
scoperto come qualcosa di personale (la “vocazione” all’esistenza)75. Secondo quest’ultima
prospettiva, nella quale rientra, in parte, anche il punto di vista di Umberto Galimberti, il mondo
come insieme può essere sensatamente conosciuto, mentre i bruta facta rimangono chiusi
all’indagine non possedendo in sé senso alcuno. Abbiamo, dunque, dimostrato che il cristianesimo,
così, ha fatto il “suo dovere” perché non è passato invano, bensì ha conferito alla storia un senso76.
Soltanto che nel periodo della tardomodernità, appunto quello attuale, questo “senso” si è
concentrato sul solo presente. Vediamo precisamente in che modo.
4. L’appiattimento sul presente, stigma della tardo modernità
Il primo dettaglio – per gli addetti ai lavori – di questo quarto pannello è già stato intercettato,
come rileva anche Umberto Galimberti77, da Reinhart Koselleck (1923-2006) quando si è accorto
che la società occidentale, sorta sulle polveri di quel cristianesimo che mirava solo alla positività del
futuro come progresso78, nata, dunque, per non durare e per presto svanire, si è, nel tempo, mutata
in organizzazione dell’attesa, fino ad affezionarsi a se stessa79. In quanto organizzazione, nota
Koselleck, essa non ha nessuna intenzione di cessare, anzi tende a durare illimitatamente. Sulla
veridicità di questa eventuale ipotesi, colui o colei che vive in Occidente e che continua a guardare
sempre più al domani “capitalizzandolo” sul presente, non può certo glissare. Per chi crede, la
domanda potrebbe addirittura suonare così: “Opero a favore del Regno di Dio conscio della sua
fine, oppure per organizzarlo con l’intento del mio permanere il più a lungo possibile nella comunità
che lo confessa?”. Al di là della provocazione di Koselleck il fenomeno che vorrei, qui, per un
attimo congelare nella sua diagnosi è ben più insidioso e non è, certo, semplicemente rubricabile
come un’opera di maquillage filosofico. La Chiesa, fin dalle sue origini, pulsava escatologicamente:
aveva sempre coscientemente presente la reale possibilità della propria fine, attendendo, quindi, di
poter ricevere la salvezza direttamente da Dio come forma della vita venturi saeculi80. Poi, è
successo che l’éschaton continuamente differito – ci troviamo per il momento ancora in questa fase,
nulla è cambiato – l’ha persuasa a dover amministrare la salvezza attuando tutte quelle virtualità al
fine di poter durare il più a lungo possibile e, quindi, di trasmettere questa salvezza, fino a
dichiarare che “Extra Ecclesiam nulla salus”.
Come non bastasse, oggi essendo la téchne, la scienza riproducente se stessa, a darci la salvezza,
talvolta con estrema certezza fino a prolungare all’inverosimile gli anni della nostra stessa vita, è
stato tolto alla Chiesa proprio quell’ultimo brevetto di salvezza che le era rimasto81. Qui Umberto
Galimberti ha colto proprio nel segno. Purtroppo con un esito quasi nefasto, esprimibile in quel
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
modo: se non c’è più nulla da attendere, nessuna fine del mondo e meno che mai un mondo liberato
definitivamente dal dolore e dalla morte, allora sorge spontanea la domanda se il cristianesimo sia
ancora plausibile. In realtà, nella storia il dilagare del male ha favorito spesso dinamiche
catastrofiche, fino al punto da elaborare – visto che questo mondo non giungeva al tramonto – un
dietro-mondo opposto a questo e contro questo. L’éschaton, continuamente differito, ha, insomma,
indotto alcuni a dubitare perfino dell’esistenza di Dio, altri addirittura a non pensarci più. La civiltà
occidentale ha conosciuto molte esperienze caratterizzate dalla delusione dell’éschaton82. Questa
delusione, per un lato ha vanificato l’attesa, per l’altro ha posto le condizioni perché si formasse e si
sviluppasse una sorta di éschaton profano, che noi qui abbiamo già designato quale
spiritualizzazione dell’éschaton stesso, una profanazione, per così dire, di primo livello.
Questa diagnosi, agli ideologi fautori della cosiddetta “nuova secolarizzazione” può dire – ne
siamo certi – ancora troppo poco. Essi, indipendentemente dall’approccio credente alla questione o
meno, scorgono il futuro del cristianesimo nella radicalizzazione degli effetti dell’incarnazione.
L’accento non andrebbe posto, dunque, né sulla risurrezione, né sulla vita eterna, ma, innanzitutto,
sull’etiam pro nobis, la carità, la donazione, la carità come donazione. Essi sembrano parafrasare
Aristotele, quando nella sua Etica Nicomachea, lo Stagirita afferma che gli amici tra di loro non
hanno bisogno di giustizia: sono, piuttosto, i giusti che hanno bisogno di amicizia83. E questo
perché la sovrabbondanza del dono esclude la relazione proporzionata di giustizia. Insomma,
basterebbe una “vita buona” per essere felici, come purtroppo incappano sovente ad affermare
anche alcuni ecclesiastici nel nostro continente europeo. Ma, lo sappiamo bene, non è così. Per
sbriciolare teoreticamente la questione, bisogna, infatti, mettere in campo il secondo elemento
radicalmente nuovo – benché anticipato – dello scenario che stiamo tentano di pennellare: si tratta
della temperie da tardo modernità (Spätmoderne), la quale ha generato una sorta di profanazione
dell’éschaton cristiano, per noi da considerarsi di secondo livello84.
4.1 Il presente storico: unico tempo per tutti i tempi
Questa temperie è quella istanziata dalla tensione globale tra il particolarismo, che si fissa solo
sul tempo finito, e l’universalismo, che rimanda, invece, all’ipotesi di un’eternità, quindi dalla
tensione esistente tra finito e infinito. A questo proposito, utilizzerò qui più volte il termine “tardo
modernità” (Spätmoderne) – nell’accezione di Anthony Giddens, Hans-Joachim Busch, Barbara
Freyer Stowasser85 – per evitare di disperdersi nella infinita querelle terminologica tra “postmodernità”, “seconda modernità”, “modernità riflessiva” o “età post-secolare”. In italiano intendo
“Spätmoderne” come “tardo modernità”. Al di là di questa “nuova oscurità” (neue
Unübersichtlichkeit)86 in cui si è terminologicamente incorsi, il termine Spätmoderne non dichiara
che l’età moderna è terminata – come affermano i post-moderni87 –, né la considera come “troppo
poco” moderna, quasi dovesse ancora giungere alle sue “vere” conseguenze – questo sarebbe il
giudizio del termine “seconda” o “modernità riflessiva” –, e nemmeno identifica “modernità” e
“secolarismo”, come fa Jürgen Habermas (*1929), quando parla dell’“età post-secolare”88.
L’accezione di tardo modernità ritiene tutte queste indicazioni utili, ma unilaterali e si limita alla
constatazione che stiamo parlando di una modernità “irritata”, “scossa”, se non addirittura
“frastornata”; in questo senso l’11 settembre 2001 portava solo alla luce quello che si può ritenere la
grande questione irrisolta dalla modernità: la conciliazione delle varie particolarità individuali e
culturali con l’idea dell’universalità storica globale. Mentre proprio a cavallo degli anni Cinquanta
del secolo scorso gli intellettuali occidentali si dividevano in merito ai natali della modernità
rispetto alla storia precedente89, la post-modernità ci ha resi consapevoli del fatto che, accanto al
discorso sull’universalità storica, è stata messa in ombra anche la corrispettiva trattazione delle
particolarità storiche, in maniera, quasi, direttamente proporzionale. Ma, mentre la spinta antimoderna della post-modernità dichiarò la “fine” delle grandi narrative, cioè delle concezioni
razionali-universali, e tratta il discorso delle particolarità a scapito di ogni possibilità di raggiungere
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
una razionalità universale, il discorso della tardo modernità si astiene da questa conseguenza
affrettata e non confonde subito “critica” con “rigetto”. Mediante questa accezione della tardo
modernità, si comprende facilmente che non vi è una “capitolazione”, come vorrebbe la postmodernità, dinnanzi a qualsiasi pretesa di un discorso razionale fatto su valori o ragioni “ultime”
della storia; viene riconosciuto, piuttosto, il bisogno di una radicalizzazione critica di questo
discorso stesso. Ma con quali conseguenze?
Esse dimorano, appunto, nel processo di radicalizzazione il quale conduce, molto
silenziosamente, a una scorta di profanazione dell’escatologia cristiana, dicevamo, di secondo
livello, che il filosofo esprime in questi termini: oggi noi abbiamo una percezione sempre meno
lineare del tempo, dove il presente sarebbe tenuto insieme al passato e al futuro; si è ammainato
l’orizzonte utopico, sono venute meno le ideologie rivoluzionarie. Peraltro, non è riemersa una
concezione ciclica del tempo. Ci troviamo, piuttosto, in una sorta di acosmismo, sperimentiamo di
continuo l’emergenza e siamo chiamati a governare la contingenza attraverso la dittatura delle
scadenze, processo dal quale nemmeno la Chiesa riesce a svincolarsi: anche la Chiesa si è data una
schedule e – da allora – la deve rispettare. Il mondo della tardo modernità è, infatti, poco interessato
alla provenienza e alla destinazione, al passato e al futuro. La nostra temperie spirituale è
un’apertura sull’indeterminato del tempo e della storia90. L’esperienza è quella di un continuo
transitare. Proprio per questo la cosa per noi importante è diventato il saper dimorare sulla terra,
governando le scadenze, blindandoci in quell’organizzazione dell’attesa – paradossalmente
assicurata dalla Chiesa – nata solo, sembra, per perdurare nel presente, appunto in un’escatologia
che la teologia della tardo modernità rubrica come profanata o, al massimo, in un’éschaton
spirituale, che non è affatto un calembour, e che ha poco a che fare con l’annuncio
neotestamentario di «cieli nuovi e terra nuova» (2Pt 3,13). Perché, in fondo, questa “valle di
lacrime” ci sta anche bene, nonostante e, paradossalmente, dopo quell’11 settembre di oltre dieci
anni or sono.
Il cristianesimo avrebbe, dunque, dato un senso alla storia: soltanto che questo all’uomo tardo
moderno, appiattitosi sul suo presente non interessa più. All’uomo interessa soltanto che la storia
non cessi di “funzionare”91. È quanto accade quando, per esempio, noi prendiamo un aereo: non ci
interessa più in che senso, verso quale direzione stia volando: noi siamo solo preoccupati che
l’aviogetto non smetta, appunto, di continuare a funzionare, cadendo magari nel vuoto. Questo
scenario corrisponde – come vedremo – a una domanda che può ripresentarsi sotto mentite spoglie
o come “principio-speranza”, o come “principio-disperazione”, o come “principio-responsabilità”, i
quali, oggi, spostano l’attenzione dalla storia alla natura. In un certo senso, riobbligandoci a
ritornare ad Atene.
4.2 L’unico possibile riscatto: il “dilagare” della natura
Giacomo Leopardi (1798-1837) nella Ginestra (1836)92 canta la fine del progresso, anticipando
il Novecento. Nel 1922 Oswald Spengler (1880-1936) termina Il tramonto dell’Occidente93. Echi
della filosofia di Nietzsche che spazza le illusioni positiviste si ritrovano in Heidegger e nella
Scuola di Francoforte. James Lovelock (*1919) teorizza la catastrofe ambientale e la fine di ogni
sviluppo sostenibile. Per Edgar Morin (*1921) «il vero progresso è aver capito che non c’è un’idea
del progresso»94. Secondo Richard Sennett (*1943) il lavoro non contiene più il concetto di
progresso.
Ecco perché dalla metà del secolo scorso si può dire che la riflessione filosofica oscilli tra due
poli opposti, senza riuscire a trovare un baricentro unitario. Il primo è quello che Ernst Bloch (18851977) definì “principio-speranza”. Pur lontano e critico verso le filosofie del progresso, egli teneva
vivo il riferimento al vettore puntato sul futuro. La verità più profonda dell’uomo è incapsulata nel
momento del “non-ancora”, in quella dimensione volta a proiettare il presente sempre al di là di se
stesso95. Benché piantato nel mondo della natura, l’essere umano è capace di trascenderlo, balzando
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
sul carro in corsa della storia. La speranza che dà senso alla nostra vita, strappandola ai suoi limiti
costituitivi, non è un’esperienza soltanto soggettiva, ma una potenza reale che piega l’essere in
direzione del divenire.
Il polo contrario che, a ondate successive, torna a polarizzare il pensiero contemporaneo, è il
“principio-disperazione” – spinto all’estremo da Günther Anders (1902-1992) nel suo libro
sull’uomo “antiquato”, perché sorpassato dalla sua medesima potenza distruttiva. Preda di un
“dislivello prometeico” tra la misura finita della sua immaginazione e la capacità illimitata del suo
potere produttivo, l’uomo si scopre esposto alla possibilità senza ritorno della propria
autodistruzione. Scritto negli anni della guerra fredda, il libro di Anders si riferisce principalmente
al rischio della bomba atomica, ma la sua diagnosi coinvolge l’intera esperienza dell’homo
technologicus. Portando al culmine la critica del progresso elaborata dai vari Thomas Mann (18751955) e Oswald Spengler (1880-1936), Nietzsche e Heidegger, egli individua la nostra malattia
nell’inarrestabile sconfinamento della tecnica nell’orizzonte, sempre più devastato, della natura96.
Come sostiene tra gli altri anche Zygmunt Bauman (*1925), la natura non soltanto ha perso la
propria aurea magica, l’antico statuto di creazione divina che ne assicura l’intangibilità da parte
dell’uomo, ma è interamente affidata al suo controllo e al suo sfruttamento intensivo. Oramai siamo
al di là anche delle pretese prometeiche dell’homo faber teorizzate da Bacone (1561-1626) o da
Voltaire (1694-1778). Oggi la tecnica non si limita ad occupare lo spazio della natura, ma arriva al
punto di volerla sostituire riproducendo in modo artificiale i suoi prodotti, compresa la stessa natura
umana. Tuttavia, io sono convinto che questo progetto non abbia fatto tutti i conti con la resistenza
del proprio oggetto di dominio: la natura. Non è, anzi, escluso che proprio la natura finisca per
rimbalzare su di esso, rovesciandosi rovinosamente su colui che l’ha messo in opera.
Rispetto a tale analisi, tutt’altro che infondata, va tuttavia osservato che la natura non è, poi, così
fragile e indifesa. A questo proposito già James Lovelock (*1919) aveva sostenuto, in quella che si
chiama “ipotesi di Gaia” (dal nome della divinità greca), che la terra costituisce un sistema vivente
autoregolato capace di mantenere le sue caratteristiche chimico-fisiche proprio grazie ai
comportamenti degli organismi viventi che lo abitano97. Ciò accadrebbe per una sorta di effetto
retroattivo che ristabilisce di continuo l’equilibrio tra ciò che vive e le condizioni entro cui si
sviluppa la vita. Così si spiega il fatto che il livello di ossidazione o il grado di salinità del nostro
ambiente naturale restino più o meno costanti anche in presenza di mutamenti strutturali.
Naturalmente ci muoviamo in un campo di ipotesi tutt’altro che certe e, anzi, contestate da altri
studiosi. Resta il fatto che la partita tra uomo e natura appare tutt’altro che chiusa.
Una linea di pensiero che ha in Giacomo Leopardi la propria punta più acuta, ha ottimi motivi
per credere che il rapporto di forza tra l’uomo e la natura rimanga largamente sbilanciato a suo
vantaggio. Come ci ricordano anche recenti terremoti e tsunami, nonostante tutti i miraggi faustiani,
di fronte alla potenza dirompente della natura, i nostri sforzi di dominarla appaiono a volte persino
patetici. E non è la morte stessa un fenomeno naturale che segna la nostra esistenza in una forma
che siamo ben lontani dal poter padroneggiare?
Ciò che possiamo fare – sospesi come siamo tra il “principio-speranza” e il “principiodisperazione” – è, forse, attivare quell’atteggiamento che Hans Jonas (1903-1993) ha chiamato
“principio-responsabilità”, sforzandoci di passare da un’etica antropocentrica ad un’etica globale, la
quale associ la cura dell’uomo a quella degli altri organismi viventi e dello stesso mondo naturale.
Tra la fede visionaria nella tecnica e la sua demonizzazione passa la sobria consapevolezza che la
scienza può essere insieme causa e risoluzione dei nostri problemi. Di questo ultimo e sottilissimo
confine se n’è accorto Umberto Galimberti, quando egli stesso riconosce che dinnanzi alla morte
non solo si sente venir meno l’occhio del testimone, ma può addirittura acuirsi il principioresponsabilità:
«a differenza dell’animale l’uomo sa di dover morire. Questa consapevolezza lo obbliga al pensiero
dell’ulteriorità che resta tale comunque la si pensi abitata: da Dio o dal nulla. Ciò fa del futuro l’incognita
dell’uomo e la traccia nascosta della sua angoscia segreta. Non ci si angoscia per “questo” e per “quello”, ma per
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
il nulla che ci precede e che ci attende. Ed essendoci il nulla all’ingresso e all’uscita della nostra vita,
insopprimibile sorge la domanda che chiede il senso del nostro esistere. Un esistere per il nulla o per Dio?»98.
1
La frase di Agostino d’Ippona, Contra Faustum, liber 32, caput 18 [in P. Migne, Patrologiae Cursus Completus.
Series Latina VIII, Garnier Imprimerie Catholique, Parisiis 1823, p. 171] è citata in U. Galimberti, L’ospite inquietante.
Il nichilismo e i giovani, (Serie Bianca Feltrinelli), Feltrinelli, Milano 2007, p. 36.
2
U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, (Filosofia. Opere IV), Feltrinelli, Milano 62000, pp. 199-200.
3
Mi concedo questa dichiarazione in base alla mia personale conoscenza con il Prof. Umberto Galimberti, come si
può leggere in: G. Pasquale, Se la parola «amore» fa rima con «libertà», in U. Galimberti, Senza l’amore la profezia è
morta. Il prete oggi, a cura di G. Pasquale, (La Stola e il Grembiule), Cittadella Editrice, Assisi (PG) 2010, pp. 5-13.
4
Cfr. U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, (Quality Paperback 42), Il Saggiatore, Milano
1996 e Id., Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, (Campi del Sapere. Filosofia Opere I-III), Feltrinelli, Milano
4
2000.
5
Cfr. U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente. Significativa, per quanto verremo a dire, è la
seguente precisazione: «Non ho mai scritto [...] commissionati» (U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia,
[I Dialoghi di Marco Alloni], Aliberti Editore, Roma 2011, p. 102).
6
Cfr. E. Severino, Essenza del nichilismo (1972), Adelphi, Milano 1982.
7
Cfr. U. Galimberti, La lampada di Psiche, a cura di P. Belli, Edizioni Casagrande, Bellinzona (CH) 2001; L.
Grecchi, Il pensiero filosofico di Umberto Galimberti, Petite Plaisance, Pistoia 2006; U. Galimberti, Senza l’amore la
profezia è morta. Il prete oggi, a cura di G. Pasquale, (La Stola e il Grembiule), Cittadella Editrice 2010; il già citato U.
Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia.
8
U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia, p. 102.
9
Ivi, pp. 90-91.
10
Cfr. M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Milano 21980 [con parti inedite aggiunte].
11
Cfr. M. Heidegger, Nietzsche, Pfullingen, Neske 1961. Il libro è uscito cinquant’anni fa in Germania, ma soltanto
nel 1994 è stato pubblicato in Italia da Adelphi di Milano a cura di F. Volpi (1952-2009): Id., Nietzsche, a cura di F.
Volpi, (Biblioteca Filosofica 11), Adelphi, Milano 32000. Utilizzerò qui la traduzione italiana.
12
Cfr. M. Heidegger, Nietzsche, pp. 93-97.
13
Cfr. M. Heidegger, Sein und Zeit. Neunzehnte Auflage, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 192006. Prima in
Gesamtausgabe. I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1914-1970, II, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1977 (tr. it.
Essere e tempo. L’essenza del fondamento, a cura di P. Chiodi, [Classici della Filosofia], UTET, Torino 1969).
14
U. Galimberti, Emanuele Severino e la filosofia della prassi. Confronto con Heidegger e Jaspers, in A. Petterlini
– G. Brianese – G. Goggi (a cura di), Le parole dell’Essere. Per Emanuele Severino, (Sintesi), Bruno Mondadori,
Milano 2005, pp. 259-269, qui p. 260.
15
U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia, p. 90.
16
U. Galimberti, La terra senza il male. Jung: dall’inconscio al simbolo, (Saggi Economica Feltrinelli. Opere VI),
Feltrinelli, Milano 22001, pp. 161-165.
17
U. Galimberti, Gli equivoci dell’anima, (Saggi Economica Feltrinelli. Opere VII), Feltrinelli, Milano 32001, pp.
260-271.
18
U. Galimberti, Gli equivoci dell’anima, p. 263. Mi sia consentita la citazione della menzione dello stesso termine
nel Nuovo Testamento, in Rm 2,15-16, dove compare come un “hapax”: cfr. V. Ricci, Il vocabolo metacu/ i in Rm 2,1516, in “Rivista Biblica”, 58/2, 2010, pp. 237-247.
19
U. Galimberti, Gli equivoci dell’anima, pp. 106-127.
20
U. Galimberti, Heidegger e la gnosi, in R. Dreon – G.L. Paltrinieri – L. Perissinotto (a cura di), Nelle parole del
mondo. Scritti in onore di Mario Ruggenini, (La Scala e l’Album 17), Mimesis, Milano 2011, pp. 65-80, qui p. 68.
21
U. Galimberti, Enciclopedia di Psicologia, (Le Garzantine), Garzanti, Torino 22001. Precedentemente pubblicato
come Dizionario di Psicologia nel 1992 dalla UTET di Torino.
22
Cfr. U. Galimberti, Heidegger e la gnosi, p. 79.
23
U. Galimberti, Emanuele Severino e la filosofia della prassi, p. 259. Si veda anche L. Grecchi, Il pensiero
filosofico di Umberto Galimberti, pp. 102-103.
24
U. Galimberti, Emanuele Severino e la filosofia della prassi, p. 260.
25
Ivi, p. 261.
26
Cfr. L. Grecchi, Il pensiero filosofico di Umberto Galimberti, p. 84.
27
Cfr. U. Galimberti, La casa di psiche. Dalla psicanalisi alla pratica filosofica, (Campi del Sapere. Opere XVI),
Feltrinelli, Milano 22005, pp. 399-401. Cfr. anche M. Weber, Wissenschaft als Beruf (1917): tr. it. La scienza come
professione, in Id., Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 1971, pp. 20-21.
28
U. Galimberti, Orme del sacro, (Serie Bianca. Feltrinelli. Opere XIII) Feltrinelli, Milano 2000, p. 67.
29
Cfr. L. Grecchi, Il pensiero filosofico di Umberto Galimberti, p. 85.
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
30
U. Galimberti, Parole nomadi, (Saggi Feltrinelli. Opere X), Feltrinelli, Milano 1994, p. 207.
A questo proposito, mi sembra che l’analisi galimbertiana operata da Luca Grecchi non abbia colto nel segno –
ovvero sia rimasta “in superficie” – perché il modello dualista al quale Umberto Galimberti si oppone non è «fra
soggetto e oggetto» (L. Grecchi, Il pensiero filosofico di Umberto Galimberti, p. 76), dal momento che «i veri progetti
appartengono a chi non ha separato l’essere dall’ente. Ogni altro spazio è già consumato e compreso nel “riso di
Zarathustra”, anche l’heideggeriana “verità dell’essere”» (U. Galimberti, Emanuele Severino e la filosofia della prassi,
p. 268).
32
U. Galimberti, Emanuele Severino e la filosofia della prassi, p. 268.
33
«Sono molto devoto a quell’uomo [Emanuele Severino]. Da lui ho imparato il metodo di catturare
immediatamente l’impianto teorico sotteso a un testo. Quando faccio le recensioni, per esempio, procedo ancora a quel
modo: guardo l’indice, leggo a caso dieci pagine all’interno, e se in quelle dieci pagine non salta fuori un’idea che
sopravanza il già saputo non recensisco il libro» (U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia, p. 91).
34
U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, p. 253.
35
U. Galimberti, Parole nomadi, (Saggi Feltrinelli. Opere X), Feltrinelli, Milano 1994, p. 135.
36
Si veda quanto accade tra i giovani ammaliati dall’ontologia del telefonino: cfr. M. Ferraris, Dove sei?
L’ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2005, pp. 268-273.
37
U. Galimberti, La lampada di Psiche, p. 172.
38
L. Perissinotto, Introduzione. Linguaggio e filosofia. La lezione di Mario Ruggenini, in R. Dreon – G.L. Paltrinieri
– L. Perissinotto (a cura di), Nelle parole del mondo, pp. 13-31, qui p. 18. Così, poi, chiosa alla nota 11 a p. 18: «Le
resistenze alla tecnica del marxismo e della Chiesa cattolica risultano incoerenti perché sia l’uno che l’altra condividono
con la tecnica la stessa persuasione fondamentale che l’essere sia niente». Si veda anche E. Severino, Heidegger e la
metafisica, Adelphi, Milano 1994, p. 127-134.
39
Sarà utile, a conferma di questa affermazione, la lettura del libro di E. Severino, La morte e la terra, (Biblioteca
Filosofica 30), Adelphi, Milano 2011, pp. 89-135.
40
Cfr. U. Galimberti, Emanuele Severino e la filosofia della prassi, p. 269.
41
Cfr. ivi, p. 268-269, con mia sottolineatura.
42
U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia, p. 27.
43
U. Galimberti, I miti del nostro tempo, (Serie Bianca. Opere XIX), Feltrinelli, Milano 22012, p. 207.
44
Ivi, p. 213.
45
Ivi, p. 213. Tenendo conto delle molte radici nietzschiane del Nostro, sarei più propenso ad affermare che la
messa in equazione tra scienza e teologia sia occorsa un po’ più tardi; più precisamente essa sembrerebbe, piuttosto,
essere figlia genuina della Riforma protestante: «Tutte le nostre speranze tendono per contro con desiderio ardente
verso quella visione secondo cui, sotto questa vita civilizzata che oscilla inquietamente in su e in giù e sotto le
convulsioni culturali, si cela una forza antichissima, magnifica e intimamente sana, che si muove invero potentemente
solo in momenti straordinari, per poi ritornare a sognare in attesa di un futuro risveglio. È da questo abisso che è
scaturita la Riforma tedesca: nel suo corale risuonò per la prima volta il canto dell’avvenire della musica tedesca.
Questo corale di Lutero risuonò profondo, coraggioso e pieno di anima, smisuratamente buono e delicato, come il primo
richiamo dionisiaco, che prorompe da un’intricata boscaglia all’approssimarsi della primavera. Gli rispose l’eco
d’emulazione di quel corteo solennemente tracotante di invasati dionisiaci, a cui dobbiamo la musica tedesca – e a cui
dovremo la rinascita del mito tedesco!» (F. Nietzsche, La nascita della tragedia greca, a cura di G. Colli e di S.
Giametta, [Piccola Biblioteca Adelphi 48], Adelphi, Milano 202000, pp. 152-153).
46
U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia, p. 31.
47
Bevendo assieme il caffè nel Convento palladiano dei Cappuccini a Venezia, il 13 Dicembre 2009, subito dopo
pranzo, il Prof. Galimberti, sollecitato da una mia domanda mi rivelò che il libro Il corpo aveva avuto qualcosa come
una cinquantina di edizioni in diverse lingue, per una vendita totale di circa 300mila copie. E pensare che Emanuele
Severino lo aveva sconsigliato a «scrivere Il corpo che, a posteriori, potrei considerare un po’ la mia rovina. Severino
mi aveva avvertito, d’altronde, che se volevo arrivare all’università un libro simile dovevo buttarlo nel cestino. Oggi se
un filosofo scrive sul corpo va infatti benissimo – anzi, è diventata un po’ una moda – ma allora, nel 1970, bisognava
ancora parlare il linguaggio dell’essere e del non essere» (U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante della filosofia, pp.
102-103).
48
Come, probabilmente, il Professore lascia intuire in U. Galimberti, Psiche e techne, p. 495.
49
Cfr. G. Pasquale, La ragione della storia. Per una filosofia come scienza, (Nuova Cultura – Introduzioni 251),
Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 258-265. Cfr. anche M. Avesani, Propedeutica alla struttura logica-genetica della
realtà e della storia, Libro 0, Metrodoralibri, Locarno (Svizzera), pp. 244-248.
50
U. Galimberti, Psiche e techne, p. 33.
51
F. Nietzsche, Su verità e menzogna, in Id., La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e scritti 1870-1873, a cura di
G. Colli e di M. Montanari, (Piccola Biblioteca Adelphi 277), Adelphi, Milano 32000, p. 240.
52
F. Nietzsche, Su verità e menzogna, p. 240.
53
U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, p. 19.
31
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
54
«Nasce la storia come attesa (Antico Testamento) o come partecipazione (Nuovo Testamento) alla redenzione.
[...] Il greco non pensava storicamente. La historìa non designava un ambito di indagine particolare, distinto dagli altri,
ma si riferiva a quanto in generale era indagabile» (U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, pp.
36-37).
55
Vicine alle riflessioni galimbertiane sono queste, altrettanto interessanti, di Ugo Sartorio: «L’uomo di oggi vuole
tutto e subito e per questo diffida del futuro. Il differimento che questi domanda alle proiezioni del desiderio e più
spesso la possibile sottrazione di ciò di cui si vorrebbe disporre in presa diretta, l’ha reso impopolare. Dopo due secoli
prepotentemente “futurocentrati”, nei quali l’accelerazione della storia ha mirato al di più e al meglio che solo il futuro
avrebbe dischiuso, oggi viviamo una stagione involutiva caratterizzata da un tempo immobile e per questo proteso a
spremere il presente e a goderne il midollo. Il “corridore fermo” che va in accelerazione sul rettangolo sempre uguale
del suo tapis roulant, sigillato dagli auricolari dell’Ipod e con lo sguardo estatico verso i cristalli liquidi di una
rappresentazione qualunque, è sintomo diffuso di una nuova percezione del futuro» (U. Sartorio, Fare la differenza. Un
cristianesimo per la vita buona, [Teologia Saggi], Cittadella Editrice, Assisi [PG] 2011, pp. 164-165).
56
Cfr. G. Pasquale, Per una filosofia della storia nella tardomodernità, in U. Perone (a cura di), Filosofia
dell’avvenire, (Dubbio & Speranza 6), Rosenberg & Sellier, Torino 2010, pp. 54-61.
57
Cfr. H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, J.C.B. Mohr, Tübingen 31972 (Verità e metodo, tr. it. di G. Vattimo,
Bompiani, Milano 1983, pp. 112-127).
58
Cfr. E. Tiezzi, Tempi storici, tempi biologici, Garzanti, Milano 1984, pp. 34-39.
59
Utile, a questo proposito, risulta l’analisi compiuta da A. Lowen, Il linguaggio del corpo, tr. it di P. Di Sarcina e
M. Pizzorno, (Saggi Universale Economica Feltrinelli), Feltrinelli, Milano 92009, pp. 280-299 (ed. or. Physical
Dynamics of Character Structure [The Language of the Body], Grune and Stratton, New York 1985).
60
Cfr. U. Galimberti, Psiche e techne, pp. 550-507.
61
Cfr. G. Pasquale, Oltre la fine della storia. La coscienza cristiana dell’Occidente, (Ricerca), Bruno Mondadori,
Milano 2004, pp. 79-84.
62
Cfr. U. Galimberti, Gli equivoci dell’anima, pp. 146-150.
63
Hérodote, Histoires [I,1]. I. Clio, texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Société d’Édition “Les Belles Lettres”,
Paris 1932, pp. 12-13.
64
Cfr. U. Galimberti, Psiche e techne, pp. 501-502.
65
Cfr. ivi, pp. 505-507.
66
Cfr. P.C. Tacitus, Annali, a cura di A. Arici, UTET, Torino 1998, pp. 134-145.
67
Cfr. G. Pasquale, Beyond the End of History. The Christian Consciousness in The Western World, (Academia
Philosophical Studies 47), Academia Verlag, Sankt Augustin 2011, pp. 205-209.
68
Cfr. U. Galimberti, Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente, pp. 180-191.
69
Cfr. U. Galimberti, Psiche e techne, pp. 507-509.
70
Cfr. J. Le Goff, La civiltà dell’Occidente medievale, Einaudi, Torino 1981, pp. 178-201.
71
Cfr. L. von Ranke, Über die Epochen der neueren Geschichte. Vorträge dem Könige Maximilian II von Bayern
gehalten. XXV. Savonarola und die florentinische Republik. Gegen Ende des Fünfzehnten Jahrhunderts, in A. Meyer –
H. Michael – J. Hashagen (Hrsg.), Leopold von Rankes historische Meisterwerke, Christensen, Wien-Hamburg-Zürich
1928, pp. 126-147.
72
Cfr. M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 71974, pp. 45-61.
73
Cfr. H.-I. Marrou, De la connaissance historique, Éditions du Seuil, Paris 1954 (La conoscenza storica, tr. it di A.
Mozzillo, Il Mulino, Bologna 1962, p. 54). Cfr. anche G. Pasquale, Il principio fondamentale della teologia cristiana
della storia: nulla è profano se tutto va santificato, in H.-I. Marrou, Teologia della storia, introduzione, revisione della
traduzione e delle note di G. Pasquale, (Già e Non-Ancora 489), Jaca Book, Milano 22010, pp. 15-45.
74
Cfr. K. Löwith, Das Verhältnis von Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes und Kant, C. Winter,
Heidelberg 1964, p. 89, con mia traduzione dal tedesco.
75
M. Heidegger, Sein und Zeit, pp. 124-126.
76
Prospettiva che non sembra essere condivisa da Luigi Perissinotto: «Questo spiega perché la tecnica costituisca
nella sua lettura non lo scacco della filosofia nata in Grecia, ma il suo trionfo e compimento. Da parte mia, [...] la storia
(così pensavo e così penso) non è mossa da un’idea, anche se ovviamente vi sono state e vi sono idee storicamente
efficaci; inoltre, non vi è qualcosa come la storia, ma tante storie e diversamente stratificate storie; di conseguenza, non
vi è nemmeno qualcosa come il senso della storia» (L. Perissinotto, Introduzione. Linguaggio e filosofia, p. 18).
77
Cfr. U. Galimberti, Psiche e techne, pp. 514-516.
78
«Il cristianesimo si è concluso. O per meglio dire: si sono conclusi sia il cristianesimo sia la metafisica. Però è
chiaro che il cristianesimo continuerà a improntare la mentalità occidentale nella forma psicologica della speranza: nel
senso che siamo tutti cristiani, anche gli atei, anche i miscredenti! E nel momento in cui guardiamo al futuro come a una
promessa o forma di riscatto, siamo tutti iscritti in questa logica di cristianità» (U. Galimberti – M. Alloni, Il viandante
della filosofia, pp. 33-34, con mia sottolineatura).
© Prof. Gianluigi Pasquale OFM Cap.
79
Cfr. R. Koselleck, Critica illuminista e crisi della società borghese, (Saggi 163), Il Mulino, Bologna 1994, pp. 1314 (ed. or. Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogene der Bürgerlichen Welt, Verlag Karl Alber, Freiburg-München
2
1972).
80
Cfr. M. Del Grosso, Logica della Rivelazione. Analisi filosofica delle condizioni di possibilità della fede, (La
Filosofia nella Teologia 1), Casa Editrice “Leonardo da Vinci”, Roma 2009, pp. 257-259.
81
Cfr. U. Galimberti, I miti del nostro tempo, pp. 192-193.
82
Cfr. Z. Stankevičs, Dove va l’Occidente? La profezia di Bernhard Welte, (Contributi di Teologia 59), Città
Nuova, Roma 2009, pp. 194-199; G. Pasquale, Beyond the End of History, pp. 128-134.
83
«E se gli uomini sono amici non c’è nessun bisogno della giustizia, ma, se sono giusti, hanno inoltre bisogno
dell’amicizia: e l’attitudine che tra tutte è la più giusta è, ad avviso unanime, un’attitudine amicale» (Aristotele, Etica
Nicomachea, VIII, 1 [1155a 22-31], II, a cura di M. Zanatta con testo greco a fronte, [Biblioteca Universale Rizzoli],
Rizzoli, Milano 1986, pp. 702-704).
84
Cfr. S. Natoli, Il crollo del mondo. Apocalisse ed escatologia, (Il Pellicano Rosso. Nuova Serie 94), Morcelliana,
Brescia 2009, pp. 52-55; Id., La mia filosofia. Forme del mondo e saggezza del vivere, (Parva Philosophica 11),
Edizioni ETS, Pisa 2007, pp. 108-109.
85
Cfr. A. Giddens, The consequences of modernity, Polity Press, Cambridge 1991 (tr. it. Le conseguenze della
modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, [Intersezioni 131], Il Mulino, Bologna 1994, pp. 188-201); H.J.
Busch, Spätmoderne Gesellschaft und Depression, in S. Hau – H.J. Busch – H. Deserno (Hrsg.), Depression – zwischen
Lebensgefühl und Krankheit, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003, pp. 195-213; Y. Yazbeck – B. Freyer
Stowasser (eds.), Islamic Law and the Challenges of Modernity, Rowman & Littlefield, London 2004, pp. 34-52.
86
Cfr. J. Habermas, Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften, V, (Neue Folge 321), Edition Suhrkamp,
Frankfurt a. M. 1985, pp. 125-141.
87
Cfr. R. Koselleck, Futuro e passato. Per una semantica dei tempi storici, (Passato e Futuro 3), Clueb, Bologna
2007, pp. 267-270 (ed. or. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M.
1979).
88
Come avevo fatto notare in G. Pasquale, Il rientro della postmodernità. Virtualità cristiane della secolarizzazione
nel mondo postsecolare, in “Ricerche Teologiche”, 16, 2005, pp. 239-257, al quale mi permetto di rimandare.
89
Classica è la contrapposizione, per esempio, tra Karl Löwith (1897-1973) e Hans Blumenberg (1920-1996): Cfr.
H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 21966-1974 (tr. it. La legittimità dell’età
moderna, Marietti, Genova 1992, pp. 70-84), un cui significativo stralcio in lingua italiana, per la traduzione di Renato
Cristin, si trova in Id., Il progresso svelato come fatalità, in “Aut-Aut. Nuova Serie”, 222, 1987, pp. 51-59, e la
successiva risposta in K. Löwith, Recensione del libro di Hans Blumenberg, ivi, pp. 60-66. Blumenberg non ammette
che Löwith assuma la categoria di “secolarizzazione” per discriminare tra tradizione cristiana ed evo moderno. Di
contrappunto, Löwith non accetta che Blumenberg legga, nella sua tesi sulla secolarizzazione, un’ipotetica «identità di
sostanza» tra la visione ebraico-cristiana della storia e quella della filosofia della storia dell’attualità, sulla quale
agirebbe come processo la secolarizzazione (cfr. H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, pp. 18-20), perché in
questo modo Blumenberg a priori addossa «al suo avversario un onere di prova che egli stesso ritiene insostenibile» (K.
Löwith, Recensione, p. 62); infatti, è ovvio che non si potrà mai concepire la continuità storica come identità di
sostanza, la quale non viene sfiorata da alcun mutamento storico. Icastico, infine, appare l’affondo di F. Büttgen,
Eschatologie, fin de l’histoire, ontologie de l’actualité. Sur quelques déplacements historiques et religieux chez Luther
et Fichte, in J. Benoist – F. Merlini (éds.), Après la fin de l’histoire. Temps, monde, historicité, Librairie Philosophique
J. Vrin, Paris 1998, pp. 61-90, qui p. 64: «la thèse de Löwith ne peut qu’apparaître abusivement généralisatrice, voire
anachronique dans sa manière de rapprocher les philosophies de l’histoire d’une théologie biblique qu’elles ne
pouvaient pas connaître dans les termes où Löwith la décrit».
90
Cfr. G. Pasquale, Tempo ed eternità. Ciò che può sillabare la filosofia, in “Credere Oggi”, 29/5, 2009, pp. 55-73.
91
«La tecnica infatti non tende a uno scopo, non promuove un senso, non apre scenari di salvezza, non redime, non
svela la verità: la tecnica funziona» (U. Galimberti, Psiche e techne, p. 33). Cfr. anche M. Marchetto, Le ali dell’anima.
Educazione, verità, persona, (Rubbettino Università), Soveria Mannelli (CZ) 2010, pp. 69-75.
92
G. Leopardi, La Ginestra, Monte Buy Società Italiana, Ancona 1989, pp. 123-131.
93
Cfr. O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale, Longanesi,
Milano 1981.
94
Cfr. E. Morin, Ripensare l’Europa, (Centro Studi e Iniziative Lucio Lombardo Radice), Laicata, Manduria (TA)
1992, p. 65.
95
Cfr. E. Bloch, Il principio speranza: scritto negli USA fra il 1938 e il 1947 riveduto nel 1953 e nel 1959,
introduzione di R. Bodei, (Saggi), Garzanti, Milano 22005, pp. 1234-1245.
96
Cfr. G. Anders, Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, (Universale Bollati
Boringhieri 526), Bollati Boringhieri, Torino 2007 (ed. or. Die Antiquierheit des Menschen, II, Beck, München 1956).
97
Cfr. J. Lovelock, Gaia: nuove idee sull’ecologia, Bollati Boringhieri, Torino 22002, pp. 97-132.
98
U. Galimberti, Le cose dell’amore, (Universale Economica Super UE. Opere XV), Feltrinelli, Milano 2004, p. 17.