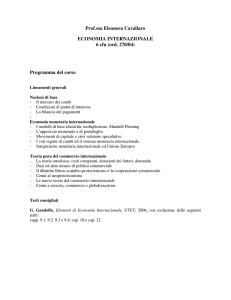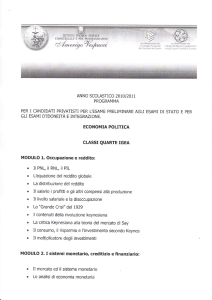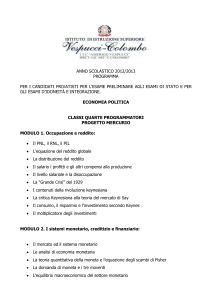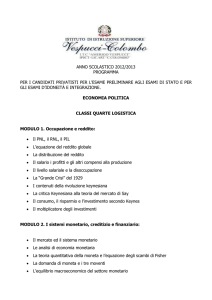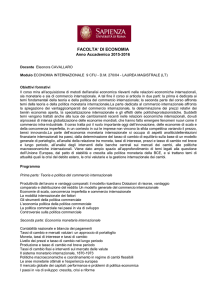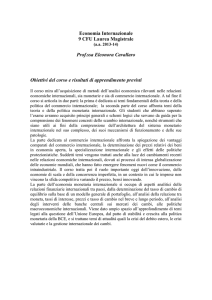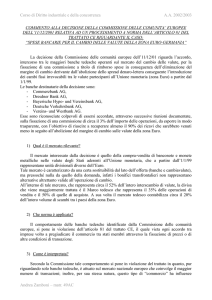Cap. 5 Il sistema
globalizzazione
finanziario
integrato:
cooperazione
e
Sommario
Le crisi petrolifere del 1973, del 1977 e del 1986, così come la crisi finanziaria del Messico all’inizio
degli anni Ottanta e del Giappone alla fine degli anni Novanta hanno posto i paesi del centro di fronte alla
necessità di riorganizzare gli indirizzi di governo nei processi di integrazione finanziaria e monetaria
mondiale. In un primo momento, alla metà degli anni Ottanta, si è rimodulato il percorso di
liberalizzazione avviato nel decennio precedente, affiancandolo così ad uno sviluppo della globalizzazione
dei mercati delle merci e dei capitali con una nuova modalità di regolamentazione che dava centralità ai
processi piuttosto che alle norme.
L’integrazione economica tra i mercati comprese, in modo crescente, l’azione di associazione di
commercio preferenziale tra privati, la creazione di aree di libero scambio, le unioni doganali e i mercati
comuni delle merci, dei capitali, del lavoro. Gli anni compresi dal 1976 al 2005 hanno così visto l’attuazione
a livelli diversi di processi di questo tipo, tra cui, principalmente, gli accordi di libero scambio tra Stati
Uniti, Canada e Messico e la creazione di un mercato comune tra i paesi europei. A questi fattori si è
aggiunta la liberalizzazione globale nel mercato dei capitali, che ha comportato l’aumento straordinario
della sovrastruttura finanziaria rispetto al mercato dei beni reali, nonché l’integrazione su questo piano tra
le economie industriali con quelle dei paesi in via di sviluppo. La rilevanza di questi processi e il ruolo che
in essi ha avuto il mercato finanziario sono la ragione per cui il sistema del periodo compreso tra il 1976 e il
2008 è definito sistema finanziario integrato, caratterizzato, appunto, da processi di globalizzazione e
cooperazione.
Gli sviluppi indicati hanno per loro stessa natura indotto a variazioni nelle politiche monetarie e fiscali
nazionali, necessarie a ottenere gli obiettivi di pieno utilizzo delle risorse nel contesto internazionale
generando effetti positivi, ma anche conflitti, tra le componenti del quartetto inconciliabile: cambi fissi;
libertà nella circolazione dei capitali; multilateralismo nei mercati di beni e servizi; autonomia delle politiche
monetarie nazionali Ne è seguita una lunga fase di gestazione negli assetti istituzionali di cooperazione e
condivisione che sono stati alla base della nuova architettura istituzionale, per arrivare poi ad un
superamento della visione insulare delle economie nazionali e alla formazione di un nuovo centro che ha
visto gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone assumere la funzione di guida nella promozione del riordino
delle istituzioni internazionali.
Questi processi di integrazione hanno interessato sia il mercato dei beni che il mercato finanziario. La
possibilità di accrescere il valore nei due mercati è però profondamente diversa: nel primo caso, i guadagni
degli operatori scaturiscono dalla realizzazione e distribuzione di nuovi beni e servizi; viceversa nel mercato
dei capitali sono possibili guadagni attraverso operazioni di arbitraggio. Negli anni Ottanta, l’arbitraggio è
stato organizzato in forme progressivamente più innovative, sia grazie al progresso tecnologico che
all’abbassamento tariffario: queste condizioni, ponendo dei problemi di credibilità, promossero una
riorganizzazione degli aspetti istituzionali preposti alla vigilanza.
1. Caratteri originali: cooperazione e condivisione
Nei primi anni Settanta le condizioni operative del sistema finanziario egemone
vennero rapidamente meno. L’aumento del valore dei pagamenti attuati sul mercato
internazionale, sia a causa dell’aumento del prezzo del petrolio, sia per la scelta dei Paesi
arabi di utilizzare la loro conseguente accresciuta capacità finanziaria nel mercato apolide
degli eurodollari. A fronte di queste condizioni, infatti, il permanere del dollaro come
unica moneta di pagamento internazionale costituiva un limite crescente per l’intero
sistema finanziario poiché l’aumento dei costi di produzione faceva si che il sistema non
potesse più essere fondato sulla produttività delle industrie statunitensi. Di concerto,
neppure la sua altra fonte, l’aumento del debito pubblico, poteva considerarsi
inesauribile, in quanto comportava una serie di conseguenze sfavorevoli: il
peggioramento del tasso di cambio, il costante deficit nella bilancia commerciale e dei
pagamenti; in ultimo la fuga di capitali e la svalutazione.
1
Il dollaro dunque, e con esso la condizione di egemonia degli Stati Uniti, finì quindi
per essere stretta tra due vincoli: la possibilità che una riduzione delle emissioni
comportasse una non adeguata disponibilità del volume dei mezzi di pagamento
necessari ai saldi di clearing internazionale; la possibilità che un aumento delle emissioni,
essendo fondato sulla spesa pubblica, comportasse una fonte di inflazione nelle
economie nazionali con cui gli Stati Uniti attuavano scambi. Questa considerazione
risulta esplicita considerando come l’economia statunitense aveva avuto nel corso degli
anni Sessanta un’inflazione dell’1%, mentre nel periodo 1968-72 il livello d’inflazione era
salito ad una media del 3,5%, mantenendo una costante tendenza ascendente. La politica
restrittiva dichiarata dalle autorità monetarie dei governi che avevano sottoscritto gli
accordi di Bretton Woods, e con essa la scelta di indirizzare la politica monetaria verso la
stabilità degli investimenti e dell’occupazione per mezzo degli indicatori di stabilità del
cambio, non risultava così essere più credibile.
Da questa situazione scaturì l’inevitabile rinuncia al mantenimento di un regime di
cambi fissi come strumento privilegiato di politica economica e l’accettazione di delegare
al mercato, cioè ad un sistema di cambi variabili, la funzione di tenere in equilibrio i
rapporti tra risorse, produzione e distribuzione dei redditi. Dalla metà degli anni Settanta
si scelse di affidare al vincolo competitivo dei mercati quella condizione di equilibrio tra
mercato interno e mercato estero che le autorità nazionale non riuscivano più a tutelare.
La scelta fu sostenuta nei contesti internazionali soprattutto dai governi europei nella
convinzione che una maggiore libertà nella leva monetaria avrebbe potuto assicurare loro
una maggiore stabilità politica, consentendo così di far crescere la spesa pubblica.
Condizione, quest’ultima, cui i governi furono obbligati sia dall’aumento dei servizi nella
componente del bilancio nazionale – di cui in primis quelli dalla spesa per sanità,
determinata dall’invecchiamento della popolazione – , sia dalle tensioni sociali imposte
dalla riorganizzazione dell’attività produttiva seguita agli shock petroliferi. A queste
ragioni principali si univano poi altre motivazioni di tipo finanziario, come ad esempio la
scelta dei paesi in via di sviluppo, tra cui il Brasile, e di alcuni paesi industriali, tra cui
l’Italia, di indicizzare il valore dei titoli emessi al tasso d’inflazione.
L’instabilità che ne derivò, che caratterizzò il periodo 1973-1976, indusse i governi
ad avvalorare la riforma istituzionale del Fondo Monetario Internazionale rivolta a dare a
quest’ultimo una funzione di freno alla variabilità dei cambi. La possibilità di interventi di
tutela delle parità valutarie per mezzo di variazioni nelle quote di riserva del Fondo fu
però respinta dalla Germania, contraria ad aumenti delle riserve del circolante che
avrebbero costretto ad importare inflazione insieme agli scambi di beni e servizi. Il
compromesso fu raggiunto nell’incontro di Kingston, siglato nel 1976, in cui si autorizzò
la modifica dell’articolo IV dello statuto del Fondo attraverso il Secondo emendamento.
Con questa riforma il Fondo veniva autorizzato a sovraintendere alle condizioni
economiche dagli Stati membri, indirizzandole verso un sistema stabile di cambi,
sostituendo il vincolo che impegnava il Fondo ad operare per un sistema di cambi stabili,
al quale i paesi aderenti si erano impegnati nei trent’anni precedenti.
L’evento costituisce l’istituzionalizzazione di un nuovo sistema finanziario, quello
definito come integrato, fondato su una duplice consapevolezza: quella del superamento
delle condizioni di insularità delle economie nazionali indipendenti le une dalle altre, ma
coordinate dallo scambio con l’economia egemone – condizioni che erano state alla base
del progetto elaborato a Bretton Woods nel 1994; e quella, speculare alla prima, della
necessità di definire un sistema, attraverso l’istituzionalizzazione di nuove regole, in
2
grado di dare credibilità alla politica monetaria nazionale anche senza che essa fosse
vincolata dal cambio fisso con un’ennesima valuta avente status di mezzo di pagamento
internazionale con controlli valutari che ne sanzionavano le condizioni di allontanamento
dalla parità di cambio.
L’obiettivo fu ottenuto attraverso due diversi momenti d’azione. Il primo periodo,
che corrisponde agli anni che vanno dal 1976 al 1987, comportò una complessa
definizione di regole di cooperazione rivolte ad assicurare la stabilità per mezzo di
iniziative pragmatiche con cui i governi perseguirono lo scopo di armonizzare e porre
sotto controllo tre diversi obiettivi ritenuti tra loro inconciliabili: la stabilità del valore di
cambio tra valuta nazionale e dollaro americano; l’espansione fiscale; e la libertà di
operare scelte di politica economica nazionale. Questo fu fatto per mezzo di azioni
comuni coordinate al fine di evitare, tramite il ruolo di supervisione assegnato al Fondo
Monetario Internazionale, che le politiche dei vari paesi entrassero tra loro in conflitto,
determinando una crisi nel sistema degli scambi internazionali e il conseguente
contraccolpo recessivo nei mercati nazionali. Queste azioni di coordinamento
internazionale si tradussero nella prammatica sequenza delle riunioni dei rappresentanti
dei governi delle maggiori economie industriali per tramite di incontri politico economici,
noti come incontri dei G5 e poi G7, che sorsero come prassi proprio al termine del
periodo considerato, tra il 1985 e il 1987.
Come indicato in figura Va Vb , in sistemi economici aperti all’esterno la
diminuzione della produzione risulta essere molto più marcata in un sistema di cambi
fissi che in un sistema a cambi flessibili. In questo secondo caso, infatti, la riduzione della
domanda sul mercato estero e la conseguente riduzione del cambio della valuta nazionale
può essere infatti contrastata assumendo come stabile il nuovo minor valore dei beni
nazionali e adeguando a quest’ultimo il livello delle attività finanziarie corrispondenti.
Ciò consente sia di favorire la vendita sul mercato interno, sia di ottenere un vantaggio,
di medio periodo, sul mercato internazionale, poiché il minor prezzo rende i beni
nazionali più competitivi. Diversamente, in un regime di cambio fisso l’autorità
monetaria dovrebbe ridurre l’offerta di moneta disponibile sul mercato interno al fine di
mantenere stabile il valore del cambio e questa condizione comporterebbe una ulteriore
riduzione della produzione dei beni nazionali e un connesso aumento della
disoccupazione.
3
Sia muovendo da questa consapevolezza, sia rispondendo alla necessità
istituzionale di un aumento della spesa pubblica, i governi delle maggiori economie
industriali sostennero dunque l’abbandono del cambio fisso e l’adeguamento a quello
flessibile, nell’idea che esso avrebbe potuto anche, per lo meno in parte, compensare la
rilevante differenza nei tassi di crescita del reddito pro capite tra i paesi sviluppati,
generati per lo più dalla disomogenea crescita nel settore dei servizi (vedi Tab. Struttura
dell’occupazione) in tutte le economie industrializzate. Questo il settore, infatti, essendo
normalmente segnato da forti differenze tra paesi nei livelli di produttività, rendeva
4
difficile il processo di convergenza e con esso quello di stabilizzazione delle economie
industrializzate.
La scelta di sostenere un sistema di cambio flessibile però, nonostante costituisse
il naturale proseguimento dell’accordo definito nel 1976, non ebbe il successo auspicato.
5
Come indicato in Tab Vxx tutte le maggiori economie subirono nel quindicennio
seguente sia aumenti dell’inflazione, che della disoccupazione. Furono proprio questi
fattori che spinsero le autorità dei diversi governi nazionali verso un superamento delle
condizioni esistenti nel periodo 1976-1987, ricercando dunque nuove regole di
coordinamento del sistema finanziario internazionale.
L’origine della scarsa efficienza del coordinamento internazionale attraverso la
politica monetaria è spiegabile a due diversi livelli d’analisi: da una parte deve essere
ricordato il margine progressivamente esiguo dei vantaggi che si potevano realizzare nella
ulteriore liberalizzazione nel mercato dei beni tramite la riduzione dei dazi doganali;
dall’altra, vi era la difficoltà di consolidare una autorità istituzionale di coordinamento –
quale il Fondo Monetario Internazionale – che non disponeva di un strumenti specifici di
intervento nella regolamentazione degli scambi. Durante gli anni Ottanta queste due
condizioni portarono, di fatto, ad un processo di integrazione delle economie e della
finanza internazionale privo di stabilità.
Si consideri, al fine di una indicazione generale di questi processi che nel 1979 si
era chiuso il Trade Reform Act – o Tokyo Round) – aperto nel 1974. Con questo nuovo
negoziato del GATT, la riduzione tariffaria dei dazi era stata dilazionata su un periodo di
otto anni, a partire da 1980, con una riduzione media del 31% negli Stati Uniti, del 27%
per il Mercato Comune Europeo e del 28% per il Giappone. Come risulta evidente dalla
figura Vxx, i margini per ottenere un beneficio dalla integrazione del mercato dei beni
con la riduzione dei dazi doganali risultavano, alla fine degli anni Ottanta,
significativamente minori di quello che era stato possibile ottenere lungo tutto il secolo.
Questa riduzione dei vantaggi nel commercio internazionali conseguibili
attraverso accordi di abbassamento tariffario finì per determinare, da un lato delle
6
aspettative decrescenti in questo settore da parte degli operatori economici, dall’altro un
orientamento delle organizzazioni produttive e dei governi a cercare di ottenere benefici
economici percorrendo altre strade, indirizzandosi verso la costruzione di barriere non
tariffarie. Con queste ultime si fa riferimento principalmente ad alcune pratiche che
esulavano, appunto, dal semplice innalzamento dei dazi doganali, come ad esempio le
limitazioni volontarie alle esportazioni, equivalenti in pratica a quote sulle importazioni,
oppure l’affinamento di regolamentazioni tecniche, quali le norme di sicurezza del
prodotto, le norme igieniche del trasporto e altre normative di questo tipo.
Una indicazione generale di questa difficoltà è data dall’esito dell’accordo
successivo a quello degli anni Settanta e Ottanta. Nel 1986 furono avviate trattative, note
come Uruguay Round, chiuse nel 1994, in cui si sottoscrissero accordi per un totale di
22.000 pagine, riguardanti mercati e prodotti, riferibili a due sottoinsiemi di categorie: la
riduzione dei dazi e le riforme amministrative.
I dazi furono ridotti di circa il 40%, ma l’esito non fu risolutivo in quanto si scese
dal 6% al 4%. considerando che nel dopoguerra si era partiti da soglie del 40% risulta
evidente quanto esiguo fosse ormai il margine di vantaggio che poteva essere ottenuto
dalle imprese attraverso questa via e, di conseguenza, quanto minimo fosse
indirettamente il vantaggio di consenso che ne potevano trarre i governi. Più rilevante fu
dunque la modifica di specifiche aree di intervento rimaste tutelate dalle barriere non
tariffarie, in particolare quelle riferite al settore tessile rimasto protetto sul mercato
statunitense dal precedente accordo multi-fibre e quello sui prodotti agricoli del mercato
europeo. Si deve considerare però che i benefici ricavati dall’aumento della concorrenza
nel mercato dei beni, che si traducono sostanzialmente in minori costi per i consumatori,
producono elementi di tensione in quello del mercato del lavoro, per cui non possono
essere considerati, di fatto, stabili. Molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, il
Giappone e la Comunità Europea, sono incorsi in infrazioni delle regole sottoscritte
aprendo contenziosi legali e suscitando misure di ritorsione quali la re-introduzione di
dazi in settori o prodotti del paese che aveva violato l’accordo. E’ il caso, per esempio,
della richiesta di intervento di Europa, Giappone e Cina contro gli Stati Uniti per la
violazione, nel 2002, degli accordi sull’acciaio, intervento che ha indotto gli Stati Uniti a
tornare in regola nel giro di un solo anno a causa della minaccia di ritorsioni doganali da
parte dei paesi Europei.
7
Il passaggio ad un regime di cambio flessibile non risultò in sé in grado di
favorire in modo duraturo i processi di stabilità finanziaria. Inoltre, il nuovo sistema non
sostituì in realtà il regime dei cambi fissi dei decenni precedenti. Ancora negli anni
Novanta i paesi con cambio flessibile erano meno della metà dei circa duecento censiti da
un ricerca del Fondo Monetario Internazionale con una percentuale che sale a oltre l’80%
se si prendono in considerazione solamente i paesi in via di sviluppo.
Se l’azione delle autorità governative nazionali non riuscì a compiere pienamente
un’integrazione mondiale sul piano della produzione e degli accordi internazionali,
l’integrazione si sviluppò in modo rapidissimo nel settore dei capitali, in particolar modo
dopo che, a partire dai primi anni Ottanta, si realizzò un generale processo di rimozione
dei controlli nel flusso dei capitali. Ancora nel corso degli anni Settanta, infatti, in quasi
tutti paesi erano presenti forme di restrizione alla mobilità dei capitali, ovvero restrizioni
all’entrata nel settore bancario. In Italia, ad esempio, non solo era richiesta
un’autorizzazione per la costituzione di una società bancaria, ma altre autorizzazione
erano necessarie anche per l’apertura o la modifica della rete degli sportelli, così come per
l’esercizio di specifiche tipologie di credito, come quello commerciale, fondiario o
mobiliare. Vi erano inoltre controlli e limitazioni sull’estensione degli aggregati creditizi,
controlli qualitativi sul credito concesso e restrizioni alla libera definizione dei tassi di
interesse attivi e passivi alla clientela. In molti paesi si registrava anche una forte presenza
nella proprietà da parte dello Stato e i controlli valutari infine risultavano essere la norma.
Williamson e Mahar hanno classificato sulla base di indicatori qualitativi questo
fenomeno di controllo dei mercati, indicando in un campione di 36 paesi, di cui 9 con
economie avanzate, in quattro categorie: represso; parzialmente represso; parzialmente
liberalizzato, liberalizzato. L’analisi è stata fatta per due diversi momenti, prima per il
1973 e poi per il 1996. Nel primo caso in nessun paese il mercato dei capitali risultava
essere liberalizzato e solo per un paese veniva giudicato in gran parte liberalizzato.
Inoltre, nei paesi in via di sviluppo, non vi è nessuna caso di eccezione, dunque veniva
operato un controllo universale. Nel 1996, invece, il mercato risulta essere stato
liberalizzato in quasi tutti i paesi e le restrizioni che risultavano essere ancora operative
erano del tutto marginali.
8
A conclusioni del tutto simili, e analiticamente fondate su regolazione, norme
legislative, interventi nella gestione amministrativa giungono Kaminsky e Schmukler nella
loro ricerca (Vedi figura Vxx) che consente di precisare – in questo trend generale – la
cesura della seconda metà degli anni Ottanta in cui i paesi in via di sviluppo che, investiti
dalla crisi dei debiti sovrani, ripristinarono controlli e sanzioni sulla mobilità dei capitali.
9
Nella ricerca di nuove modalità atte a consolidare il processo di stabilizzazione,
prese forma la prassi di stabilire un percorso che, affiancando il regime di cambi flessibili,
consolidasse una cooperazione internazionale fondata su una serie di obiettivi intermedi
comuni, come ad esempio gli accordi commerciali tra imprese di Stati diversi, le riforme
doganale e gli accordi di cambio. L’insieme delle iniziative aveva come finalità quella di
favorire il libero riallineamento dei cambi flessibili e con esso il contenimento
dell’apprezzamento del dollaro statunitense generato, dopo il 1979, dalla politica
restrittiva della Federal Reserve, dalla riduzione della spesa pubblica e delle riduzioni delle
tasse promosse dal partito Conservatore, che era uscito vincitore dalle elezioni
statunitensi. Questi fattori avevano comportato un ulteriore aumento del valore degli
scambi in eurovalute, che avevano portato ad un accresciuto aumento della volatilità dei
valori nominali delle valute europee.
A queste condizioni si unì lo shock petrolifero del 1986. La inattesa e rapida caduta
del prezzo del petrolio consentiva di disegnare una via di uscita dalla stagflazione a
condizione che i diversi governi nazionali trovassero il modo di accordarsi per ottenere
un aumento dei volumi della produzione e un contenimento della spesa. Operatori
naturali di questa nuova via pragmatica alla stabilità risultavano essere insieme al Fondo
Monetario Internazionale, ma in ultimo più di quest’ultimo, le banche centrali, in
particolar modo quelle dell’area europea che comprendeva il numero maggiore di scambi
in valute internazionali, riducendo così la volatilità del tasso di cambio con il dollaro.
10
A rafforzare la scelta di globalizzazione del mercato dei capitali contribuì anche
l’affermarsi della teoria economica delle aspettative razionali che, riferita alla bilancia dei
pagamenti di un paese, portava a ritenere che quest’ultima, dopo essere risultata
deficitaria per un certo numero di anni consecutivi, avrebbe indotto il governo a
promuovere una svalutazione della propria moneta al fine di favorire un recupero del
deficit per mezzo di un aumento dei volumi dei beni esportati, poiché questi sarebbero
risultati meno costosi per i consumatori esteri. Si ritenne pertanto che i mercati,
anticipando il deprezzamento di quella valuta, avrebbero indotto una riduzione
anticipata, rendendo così da subito le esportazioni più competitive e le importazioni più
costose, condizione che avrebbe portato a condizioni di stabilità finanziaria nel mercato
internazionale.
Il nuovo assetto comportava una revisione nei metodi della politica monetaria.
Particolare attenzione venne posta al rischio di discrezionalità delle decisioni delle banche
centrali. Si poneva, in altri termini, il problema di vincolare due elementi: l’assenza di
regole e controlli e la credibilità. L’esito fu quello di vincolare le scelte dei banchieri
centrali a dichiarare esplicitamente, in modo ufficiale, un obiettivo di inflazione cui la
loro azione era rivolta. Quest’obiettivo assunse valore di riferimento nella definizione dei
tassi di sconto e della liquidità data al sistema. Liquidità che si scelse di favorire
promuovendo profondità, accesso ed efficienza nei mercati secondari. Queste tre
condizioni possono essere rappresentate da un indice sintetiche che il è Financial
Development Index (FDI) elaborato dal Fondo Monetario Internazionale (tabella xxx)
11
La diffusione di un livello di maggiore ricchezza finanziaria netta delle famiglie (vedi Tab.
Vxx) comportava così la possibilità di generare una nuova regola di credibilità, quella
riferita alla stabilità dei prezzi, e di ancorare a questa l’azione delle banche centrali delle
maggiori economie industriali.
Quest’ultima condizione, per quanto non semplice da promuovere poiché
fondata sulla condivisione di obiettivi comuni in grado di costituire un legame duraturo
tra mercato intero e internazionale, consentì di rafforzare il percorso di credibilità
soprattutto per mezzo del sostegno dato a iniziative di maggiore integrazione
commerciale dell’area europea, che scambiava il maggior valore di beni e servizi e
sosteneva dunque un alto costo di rischio nella variabilità dei cambi di breve e brevissimo
12
periodo. Il processo per ottenere stabilità finanziaria venne così accentuato e reso
compartecipe con le scelte di promozione di una crescita del commercio transfrontaliero
per il tramite della creazione del mercato comune con l’Atto Unico Europeo firmato nel
febbraio del 1986.
A questa condizione si univa quella di una riforma nella gestione delle crisi.
Indipendentemente dal luogo in cui si aprissero, tutte le crisi fino alla fine degli anni
Ottanta avevano seguito un profilo evolutivo molto simile: da un iniziale allentamento
dei vincoli sull’attività bancaria e sui movimenti di capitale si formava un’espansione
creditizia che a sua volta alimentava i prezzi delle attività, in particolare di quelle
immobiliari. A questo punto, un cambiamento nel ciclo economico o uno shock nei
prezzi delle attività, portavano a numerosi fallimenti bancari. Nel nuovo contesto della
deregolamentazione sia le tecniche di gestione del rischio che le procedure degli organi di
vigilanza non furono idonee a gestire questi tradizionali rischi bancari. Anche il ruolo
delle banche centrali fu simile nelle varie crisi a causa dei limitati ruoli svolti da queste:
nella maggior parte dei casi le banche centrali fornirono un sostegno iniziale – il
cosiddetto bridge loans – in attesa dell’esborso di risorse pubbliche.
Il nuovo sistema finanziario ridusse la necessità di ricorrere all’intermediazione
bancaria favorendo una crescita dei mercati secondari, in particolare consentendo la
cartolarizzazione del credito bancario. In questo modo, avvicinando risparmi e
investimenti, si ottenne la riduzione dei costi di informazione e conseguentemente dei
tassi d’interesse e delle tensioni inflattive che potevano nascere dalle crisi finanziarie. Un
chiaro esempio di ciò è la crisi latino-americana, che ha spinto alla creazione di mercati
secondari del credito. La crescita del mercato secondario favorì l’affermarsi di tecniche di
vigilanza integrata per le diverse categorie di istituzioni e la maggiore integrazione anche a
livello internazionale ed il passaggio da un approccio prescrittivo, dunque formale e
normativo, ad uno basato sugli incentivi derivanti da una soft law globalmente
riconosciuta, come risulta evidente dal caso delle regole di adeguatezza patrimoniale
elaborate da Basilea I, Basilea II e Basilea III.
Si definì per questa via il processo che portò alla scelta di ottenere la stabilità per
mezzo di una condivisione di vincoli alla spesa e monetarie, come risulta evidente dal
Trattato di Maastricht del 1992, che costituisce una delle fondamenta del percorso di
progressiva integrazione europea che si concluse con l’adozione di una nuova valuta,
l’euro, che divenne, insieme al dollaro e allo yen – e in anni più recenti allo yuan cinese –
una delle principali valute di pagamento internazionale, ma anche e soprattutto la valuta
in cui si attuava il maggior volume di scambi. Quest’ultima condizione non poteva non
riflettersi sulla stabilità nel rapporto tra beni e capitali soprattutto in momenti di crisi.
L’esperienza delle crisi degli anni Novanta mostravano, dunque, la possibilità di
superare i limiti incontrati dal processo di cooperazione internazionale rafforzando un
altro tipo processo, quello di condivisione dei mercati europei. La robustezza di
un’organizzazione finanziaria fondata sulla condivisione, non prevedendo il trasferimento
di sovranità da un piano nazionale ad uno sovranazionale europeo, restava vulnerabile a
comportamenti di egoismo degli Stati membri più forti. La nascita dell’euro e della Banca
Centrale Europea permise di superare questa condizione, concludendo un percorso che
consentiva di aumentare la stabilità sui mercati finanziari.
2. Credibilità senza regole (1976-1987)
13
L’evoluzione del sistema finanziario internazionale successiva alla fine degli accordi di
Bretton Woods è certamente caratterizzata da un processo confuso e non lineare
riscontrabile nelle relazioni internazionali tra le maggiori potenze europee. La
fluttuazione dei cambi, la progressiva deregolamentazione finanziaria, la liberalizzazione
dei movimenti di capitali insieme alle crisi petrolifere e ad un rallentamento delle
maggiori economie industriali, ad un aumento dell’inflazione e, negli anni Ottanta, alla
crisi dei debiti sovrani, produsse un clima di sperimentazione continua nella gestione
delle varie problematiche economiche, finanziarie e monetarie a livello mondiale.
Nella seconda metà degli anni Settanta, uno dei risultati principali di tale processo fu
quello di favorire, da un lato, la nascita di un meccanismo di coordinamento informale
tra le maggiori economie mondiali che si concretizzò nelle forme degli incontri del
Comitato di Basilea, poi del G-5 e del G-7; dall’altro, il percorso favorì una sempre più
stringente cooperazione a livello regionale, sia per quanto riguarda gli accordi doganali e
commerciali, sia per quanto riguarda vere e proprie unioni monetarie macro-regionali, il
cui esempio più riuscito è offerto dal percorso europeo che proprio tra gli anni Settanta e
Ottanta gettò le sue basi.
2.1 Commercio internazionale e mutamenti nella competitività industriale
La seconda metà degli anni Settanta e tutto il decennio successivo furono fortemente
influenzati dalle alterazioni improvvise del prezzo del petrolio, occorse in primo luogo
nel 1973 quando i paesi esportatori di petrolio del Medio Oriente praticarono un rialzo
dei prezzi come forma di ritorsione per l’appoggio delle potenze occidentali ad Israele
durante la guerra del Kippur, e poi nel 1979, in conseguenza della rivoluzione islamica in
Iran. Essendo il petrolio il bene chiave dal punto di vista energetico per gli apparati
produttivi occidentali, quando il suo prezzo balzò improvvisamente in alto nel 1973-1974
e poi nel 1979-1980 vi fu un rallentamento della crescita economica delle maggiori
economia che portò alla stagnazione delle esportazioni delle economia dei paesi in via di
sviluppo.
Il mercato petrolifero, così vitale per le economie mondiali, non aveva visto nascere
fino al 1974 nessun tipo di struttura inter-governativa, lasciando le varie multinazionali a
trattare individualmente con i paesi produttori di petrolio e con quelli consumatori.
Questo modello fece sì che le risposte allo shock petrolifero del 1973 furono lente e
poco coordinate. Alla fine del 1973 i paesi dell’Opec – Organization of Petroleum Exporting
Countries, fondata nel 1960 a Baghdad – cominciarono a ridurre il flusso della produzione
petrolifera: solamente tra l’ottobre e il dicembre del 1973 l’offerta venne ridotta del 7%,
mentre nel marzo dell’anno dopo si registrava un livello produttivo inferiore del 5%
rispetto ad ottobre.
Gli Stati Uniti convocarono dunque una conferenza per gestire l’emergenza e nel 1974
venne fondata l’Agenzia Internazionale per l’Energia, che finalmente nel 1978 fu in grado
di facilitare la ripartizione del petrolio nei momenti di scarsità, inglobando anche compiti
di vigilanza del mercato petrolifero e di pianificazione a lungo termine nella gestione delle
risorse.
Un nuovo shock petrolifero si realizzò quando l’Iran azzerò tutte le sue esportazioni
nel dicembre del 1978 in conseguenza della rivoluzione islamica, facendo lievitare il
14
prezzo da 13 a 34 dollari al barile. Tuttavia nel corso del secondo shock petrolifero
l’unione del fronte dei paesi esportatori di petrolio non era così solida come nel 1973,
soprattutto per i nuovi contrasti tra l’Iran e l’Arabia Saudita, la quale aumentò la
produzione del 10% per limitare i danni alle economie mondiali. Ciononostante, il prezzo
al barile del giugno del 1980 era triplicato rispetto a un anno e mezzo prima. L’invasione
dell’Iran da parte dell’Iraq, iniziata nel settembre del 1980, aggravò la situazione,
riducendo la produzione dei paesi dell’Opec del 15% e facendo alzare i prezzi a 42 dollari
al barile. L’Arabia Saudita aumentò nuovamente la produzione, mentre il petrolio
cominciava a venire estratto ad un ritmo crescente anche in Messico e nel Mare del
Nord, mitigando così l’aumento dei prezzi. Nel 1983, infine, l’Opec si accordò per una
generale riduzione del prezzo al barile e per una ripartizione delle quote. Nel corso degli
anni Ottanta, poi, il problema del petrolio si fece via via meno pressante, da una parte
perché i giacimenti del Mare del Nord erano divenuti una fonte importante, riducendo
dunque la libertà di manovra dei paesi dell’Opec, sia perché i paesi industrializzati si
stavano progressivamente svincolando da una dipendenza dal petrolio.
Da un punto di vista commerciale, l’innalzamento dei prezzi del petrolio e un generale
rallentamento della crescita economica non poterono che andare ad influenzare
negativamente anche le transazioni commerciali: nel corso degli anni Ottanta, infatti, il
volume degli scambi internazionali crebbe del 50%, una percentuale di gran lunga
inferiore rispetto a quella degli anni Settanta. In particolar modo negli Stati Uniti,
all’inizio della nuova decade, il rallentamento della crescita e la recessione portarono alla
creazione di un ambiente politico sfavorevole all’espansione degli scambi commerciali,
alimentando un ripiegamento su posizioni protezioniste. Le quote delle esportazioni
mondiali d’altronde parlavano chiaro: la percentuale del Giappone passò, nel periodo
1970-1987, dal 6,6% al 9,8%, mentre quella degli Stati Uniti calò dal 14,9% al 10,6%.
Inoltre, le politiche europee legate alla Politica Agricola Comune (PAC) fecero aumentare
la quota delle esportazioni di cereali dall’Europa occidentale, la cui percentuale sul totale
passò dal 24% del 1980 al 38% del 1987.
Durante questo periodo si cominciarono a dispiegare gradualmente anche i risultati
delle liberalizzazioni concordate nel Tokyo Round degli incontri del GATT, che durò dal
1973 al 1979 e i cui accordi tariffari vennero introdotti progressivamente tra il 1980 e il
1987. Questi ultimi, tuttavia, si riferivano solamente ai prodotti industriali, mentre il
settore agricolo continuò a beneficiare di alte protezioni doganali.
In generale, ciò che emerse tra la fine degli anni Settanta e nel corso degli anni Ottanta
fu un generale rallentamento della produttività statunitense ed un’accresciuta
competitività delle industrie del Giappone, che accumulò costantemente surplus
commerciali che divennero una fonte di preoccupazione costante sia per l’Europa
occidentale, sia per gli Stati Uniti, soprattutto nei settori dell’acciaio, delle automobili e
dei macchinari industriali, dove le aziende nipponiche avevano guadagnato una grande
efficienza e un’alta produttività.
Dopo il 1973, gli Stati Uniti videro attestare la crescita della propria produttività
industriale a livelli che erano mediamente la metà di quelli registrati nel corso degli
ottant’anni precedenti. Nello stesso periodo la produttività giapponese fece un salto
davvero sorprendente, soprattutto in relazione a nuovi metodi di organizzazione della
produzione volti a superare e migliorare il modello fordista americano. Se, infatti, le
nazioni più avanzate del mondo conobbero un processo di convergenza per quanto
riguardava le tecnologie disponibili, risultavano molto diversi gli strumenti per trarre da
15
tali tecnologie i maggiori vantaggi possibili, che dipendevano dunque dall’esperienza della
forza lavoro, dagli investimenti e da un’adeguata organizzazione. In questo senso si
rivelarono estremamente efficaci i nuovi impianti giapponesi, la gestione della
tecnologica, le innovazioni tecniche e l’ampia definizione delle mansioni.
Un altro elemento essenziale che spiega la grande competitività delle industrie
giapponesi è certamente il nuovo metodo di organizzazione della produzione volto ad un
miglioramento e una razionalizzazione complessiva dell’intero processo. Ad esempio il
sistema del kanban era una parte fondamentale della nuova filosofia produttiva
giapponese e prevedeva la reintegrazione delle scorte a mano a mano che esse veniva
consumate, evitando così l’accumulazione di stock in magazzino e tutti i costi ad essa
legati. Negli anni Ottanta tale processo venne applicato anche ai prodotti finiti in uscita,
realizzando quindi una sorta di produzione sostanziale – la Toyota fu in questo senso
all’avanguardia – , riducendo, da una parte, i tempi di consegna e i rischi e i costi di una
produzione in linea con le stime di assorbimento del mercato, dall’altra i costi di custodia
e stoccaggio dei prodotti finiti.
A fronte di questi cambiamenti di produttività dei principali paesi, in Uruguay iniziò
nel 1986 l’ottavo round del GATT, che mirava soprattutto ad abbassare i costi doganali
sui servizi e sull’agricoltura. La complessità di raggiungere un accordo fu però palese,
visto anche l’alto numero di paesi partecipanti: un primo accordo venne raggiunto nel
1993, ma fu rifiutato dalla Francia, portando ad un secondo compromesso firmato nel
1994. Mentre si svolgevano questi negoziati, gli Stati Uniti approvarono, nel 1988, la
cosiddetta Super 310, una legge che permetteva di indicare quei paesi che, secondo la
valutazione statunitense, adottavano prassi commerciali scorrette. Questi paesi, una volta
individuati, venivano invitati ad un tavolo di negoziazione bilaterale per giungere ad un
cambiamento d’atteggiamento, senza il raggiungimento del quale gli Stati Uniti potevano
intraprendere azioni di ritorsione. I primi paesi ad essere identificati furono, non a caso, il
Giappone, il Brasile e l’India.
2.2 La stagflazione e lo scenario monetario internazionale
Il passaggio ai cambi fluttuanti istituzionalizzato dall’approvazione nel 1976 del
Secondo Emendamento agli Articles of Agreement di Bretton Woods fu una sorta di salto
nel vuoto per le istituzioni e le aziende nazionali e internazionali. Nessuno sapeva con
precisione cosa sarebbe successo e le ipotesi che vennero formulate furono varie, dalle
più catastrofiche alle più ottimiste. Nei fatti l’evoluzione del sistema fu meno estrema del
previsto. Il valore dei cambi, sia reale che nominale, divenne certamente più volatile
rispetto al periodo in cui erano stati fissi e anche più di quanto era stato sostenuto dalle
tesi ottimistiche dei fautori dei cambi flessibili, basti pensare che i cambi nominali
variarono spesso anche del 2% al mese. Tuttavia, però, va detto che non si realizzò
neppure un totale caos finanziario che i detrattori avevano invece ipotizzato.
Il Secondo emendamento, approvato nel marzo del 1976 e entrato in vigore
nell’aprile del 1978, inaugurò un tipo di cooperazione internazionale che si esplicò in una
forma sempre meno istituzionale e sempre più informale: fu, dunque, un percorso di
ricerca della stabilità finanziaria senza precise regolamentazioni formali, che si attuò per
tentativi successivi di collaborazione internazionale che ebbero diversi stadi e momenti di
passaggio, nonché molteplici attori e organi tecnici sovranazionali, quali il Fondo
Monetario Internazionale, la Banca dei Regolamenti Internazionali, la Banca
16
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Mondiale, il Comitato di
Basilea, il Financial Stability Forum, il G-5 – poi G-7 – , gli accordi monetari europei e
poi la Banca Centrale Europea.
Occorre tuttavia affermare che, come detto, i governi nazionali agirono in modo
diverso. Tendenzialmente, stante una crescente integrazione commerciale a livello macroregionale, è possibile affermare che a livello di politica monetaria gli Stati Uniti e il
Giappone hanno preferito l’intervento sui cambi, mentre la Germania e i paesi
dell’Europa occidentale si sono orientati verso meccanismi di cooperazione continentale,
declinati prima con il Serpente Monetario, poi con la nascita del Sistema Monetario
Europeo (Sme) ed infine con il Trattato di Maastricht e la nascita del sistema delle
banche europee e della Bce.
Tuttavia, nel periodo 1974-1976 cominciava a nascere, in conseguenza dello shock
petrolifero, il problema che avrebbe caratterizzato la seconda metà degli anni Settanta e,
in parte, le politiche monetarie a livello mondiale della decade successiva: l’inflazione.
Anche se questo fenomeno afflisse tutti i paesi industriali, le reazioni di politica
monetaria variarono in maniera anche significativa, così come le conseguenze di medio
periodo nei diversi paesi. La Gran Bretagna e l’Italia, per motivi diversi, reagirono alla
concomitanza di inflazione e stagnazione economica con politiche espansioniste,
posticipando la soluzione del problema e ampliando le problematiche legate ad un
allargamento della base monetaria nominale come mezzo per affrontare la crisi
economica.
I paesi economicamente più robusti, invece, Germania, Giappone e Stati Uniti su
tutti, riuscirono a formulare politiche di uscita dalla crisi petrolifera i cui effetti furono
decisamente rapidi ed efficaci.
La crescita tedesca si interruppe bruscamente nel 1974, ma già nel 1975 il governo
adottò un programma espansionistico che, visti i bassi livelli di indebitamento pubblico
pregresso, non produsse gli effetti destabilizzanti che si realizzarono invece in Gran
Bretagna e Italia. Ciò era essenzialmente legato ad una diversa cornice istituzionale per le
negoziazioni sull’ammontare salariale: infatti, solo un limitato numero di unioni sindacali,
ognuna responsabile per il proprio settore produttivo, veniva coinvolto nelle
contrattazioni, limitando così le possibilità di veti, e soprattutto non esisteva il
meccanismo di indicizzazione degli stipendi all’inflazione, come ad esempio in Italia.
Uno strumento fondamentale, che influenzava le contrattazioni sui salari, erano le
attese sull’inflazione futura da parte delle associazioni di categoria. Nel dicembre del
1974, la Bundesbank introdusse lo strumento dell’inflation targeting, ovvero la
pubblicazione annuale della stima d’inflazione prevista per l’anno successivo, che venne
fissato, a partire dal 1975, all’8% annuo.
In conseguenza degli shock petroliferi, il Giappone subì effetti anche più gravi sulla
propria economia rispetto alla Germania, con una diminuzione del PIL dell’1,4 nel solo
1974 dopo decenni di crescita ininterrotta mentre i prezzi raddoppiarono nel giro di un
solo anno. Inoltre, le esportazioni giapponesi, vero motore di tutto il sistema economico,
furono fortemente in difficoltà, in quanto gli altri paesi reagirono alla crisi con misure
protezionistiche. Così come la Bundesbank, anche la Banca del Giappone adottò il
metodo dell’inflation targeting per influenzare positivamente il processo di negoziazione
salariale, con i risultati di un rapido abbassamento dei livelli d’inflazione: da una
17
percentuale del 10,8% registrata nel periodo 1970-1975, essi scesero al 6,4% nel 19751980 e al 2,7% negli anni 1980-1985.
Anche negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni Settanta l’inflazione divenne un
serio problema. La pubblicazione degli obiettivi d’inflazione cominciò nel 1975, anche se
la pratica di modificare tale obiettivo ogni trimestre portò ad una scarsa credibilità nei
confronti di tale strumento da parte del pubblico. Inoltre, con l’elezione nel 1976 del
presidente Carter, la politica statunitense venne riorientata verso misure anti-austerità,
nonostante fosse cosciente che questo avrebbe avuto ripercussioni sul dollaro, che si
sarebbe indebolito. Tale linea di politica economica venne tuttavia perseguita in quanto ci
si aspettava che i paesi dell’Europa occidentale e il Giappone, perseguendo anch’essi
politiche espansionistiche, portassero ad un sostanziale controllo dei cambi a livello
mondiale. I paesi in questione però, per timore dell’inflazione, si comportarono
diversamente quando, nel gennaio del 1978, negli Stati Uniti venne varato un pacchetto
di politiche espansive pari a 25 milioni di dollari, portando ad un aumento del tasso
d’inflazione, a un indebolimento del dollaro e ad deflusso di capitali, che generò diverse
tensioni, come vedremo, in campo internazionale.
Le diverse modalità con cui la stagflazione venne affrontata nella seconda metà degli
anni Settanta dai principali paesi industriali generò una grande differenza nelle bilance dei
pagamenti dei diversi paesi e nei tassi di cambio tra le valute, ponendo dunque serie
difficoltà alla futura stabilizzazione e integrazione dell’economia mondiale.
In particolar modo, l’adozione dei cambi fluttuanti e le diverse strategie di politica
economica adottate dai maggiori paesi del mondo – soprattutto i rapporti tra Giappone,
Germania e Stati Uniti – generarono un panorama finanziario e monetario mondiale che
non fu certamente dei più promettenti. Durante i primi sei mesi in cui i cambi vennero
lasciati fluttuare il dollaro perse il 30% del suo valore verso il marco tedesco, ma ciò fu in
gran parte dovuto alla sopravvalutazione precedente della valuta statunitense, che infatti
dopo questo brusco calo si ristabilizzò. Il disallineamento delle valute nella seconda metà
degli anni Settanta fu certamente un problema, ma non diventò mai particolarmente
grave: probabilmente la sterlina risultava nel 1976 sottovalutata, mentre il dollaro era
sopravvalutato nel 1978 così come lo yen giapponese, precedentemente sottovalutato,
acquisì forse troppo valore nel 1977 e poi nel 1979.
Tra il 1977 e il 1978 divenne sempre più chiara, in particolar modo agli statunitensi,
la necessità di addivenire ad una qualche forma di cooperazione internazionale sulle
questioni dei cambi e delle politiche economiche al fine di riuscire a contrastare gli effetti
di un’inflazione che rischiava di minare il funzionamento dell’intero sistema economico
mondiale. Venne dunque auspicato il perseguimento di quella che divenne nota come
locomotive theory, secondo cui i paesi in surplus commerciale avrebbero dovuto aumentare
la propria crescita monetaria per non creare disequilibri a livello globale.
Tale prospettiva non era accolta molto positivamente nei paesi chiamati ad
aumentare la propria offerta di moneta: in particolar modo in Germania, Helmut
Schmidt si fece portavoce della sua opposizione all’idea di politiche espansive adottate
sotto pressione esterna. Tuttavia, tra il 1977 e il 1978, la pressione su Giappone e
Germania da parte dell’opinione pubblica mondiale aumentò. Questa pressione, anche se
al terzo incontro del G-7 di Londra del maggio 1977 le misure inflazionistiche venivano
ancora osteggiate, nella pratica, proprio tra il 1977 e il 1978, le autorità giapponesi e
tedesche cominciarono a muovere i primi passi in questa direzione.
18
La Banca del Giappone aveva comunque iniziato ad intervenire già tra il 1975 e il
1978, per limitare l’apprezzamento dello yen, in particolare mediante l’imposizione di una
clausola che imponeva una percentuale di riserve del 50% sui depositi bancari dei non
residenti, che aumentò al 100% nel 1978. Nella seconda metà del 1977, inoltre, il Primo
ministro giapponese Takeo Fukuda annunciò un nuovo obiettivo d’inflazione al 6-7%,
portando il Pil giapponese a crescere del 4,8% nel 1977 e del 5% nel 1978. La Germania
invece produsse una stima di crescita inflattiva del 4,5-5,5%, che tuttavia produsse un
aumento del Pil solamente del 2,5%.
Nello stesso periodo il dollaro continuò la sua perdita di valore, iniziata fin dai primi
anni Settanta: tra il settembre del 1977 e l’ottobre del 1978 la valuta statunitense si
deprezzò del 40% rispetto allo yen e del 13% rispetto al marco. Le iniziali reazioni di
politica monetaria furono quelle classiche dell’innalzamento del tasso di sconto, che
venne fissato al 6,5% nel gennaio del 1978, aumentando poi al 7,75% in agosto e al 9,5%
nel novembre dello stesso anno. La Fed aveva cominciato ad intervenire sul mercato
valutario già dal 1977 quando, con l’aiuto della Bundesbank, della Banca del Giappone e
della Banca Nazionale Svizzera venne attivata una linea di finanziamento speciale verso la
Fed. Ad esempio la Bundesbank aumentò il suo prestito dai 2 miliardi di marchi dei primi
nove mesi del 1977 fino ai 17 miliardi calcolati nel semestre successivo. La brusca caduta
del dollaro nel 1978 spinse ancora la Fed a richiedere un ulteriore finanziamento da parte
della Germania, nuovamente per un ammontare di 17 miliardi di marchi.
Alla luce delle difficoltà economiche e monetarie che si stavano palesando sullo
scenario mondiale alla fine degli anni Settanta, il biennio 1978-1979 risulta di non
secondaria importanza, in quanto vide, da una parte, il fallimento della cooperazione
internazionale tentata a Bonn tra le tre maggiori potenze industriali Stati Uniti, Giappone
e Germania; dall’altra, la nascita di un primo tentativo di integrazione monetaria a livello
regionale in Europa, con la nascita del Sistema Monetario Europeo (SME)
Dunque nel 1978, se la comunità internazionale apprezzava le politiche espansive
tedesche e giapponesi, il sentimento dominante rimaneva quello che i paesi in surplus
commerciale non stavano facendo abbastanza per far ripartire l’economia. Al quarto
incontro dei G-7, tenutosi a Bonn nel luglio del 1978, i leader di Germania, Giappone e
Stati Uniti tentarono di accordarsi sul coordinamento delle proprie politiche economiche.
Fukuda ribadì l’obiettivo di una crescita inflattiva dello yen del 7% annuo, che sarebbe
stata raggiunta attraverso un nuovo programma di lavori pubblici varato nel settembre
del 1978 per una cifra pari all’1% del Pil nazionale, mentre anche Schmidt promise un
piano simile, con un’espansione calcolata per circa l’1% del Pil.
Nello stesso biennio, però, nuovi rivolgimenti politici in Medio Oriente minarono i
tentativi di correzione concertata delle politiche monetarie dei principali attori economici
a livello globale. Nel 1979 la Rivoluzione iraniana depose lo Shah Reza Pahlavi, che
venne poi coinvolta nella guerra con l’Iraq dal settembre del 1980 mentre, l’anno
precedente, l’Unione Sovietica aveva invaso l’Afghanistan. Questi rivolgimenti politici in
un’area sensibile per l’economia mondiale ebbe certamente delle ripercussioni,
inaugurando un nuovo periodo di instabilità politico-economica a livello globale.
Tuttavia, anche se la Rivoluzione iraniana produsse un nuovo incremento dei prezzi del
petrolio, stavolta, a differenza del primo shock petrolifero, i paesi dell’OPEC non
riuscirono a coordinarsi perfettamente. In particolar modo l’Arabia Saudita, in
contrapposizione con il nuovo Iran sciita, tenne bassi i suoi prezzi aumentando la
19
produzione. Il risultato fu che il secondo shock petrolifero produsse una sostanziale
riduzione del potere economico dei paesi produttori di petrolio: se i maggiori esportatori
petroliferi sperimentarono un largo surplus nel 1980, questo si era trasformato in deficit
già nel 1983.
2.3 Le origini dell’integrazione monetaria europea: lo SME
I movimenti dei cambi nel periodo 1977-1979 e il declino del valore del dollaro
portarono ad una riscoperta nelle élite politiche ed economiche europee delle virtù della
parità fissa, tentando di spostare un difficile coordinamento a livello mondiale ad un
livello macro-regionale che culminò nella creazione del Sistema Monetario Europeo
(SME) nel 1979.
A tale prospettiva si era già pensato in realtà nel 1970, quando i paesi membri della
Comunità Europea decisero di istituire una commissione per studiare le questioni relative
alla creazione di un assetto monetario europeo, che produsse il cosiddetto piano Werner,
dal nome del presidente della commissione, il Primo ministro del Lussemburgo Pierre
Werner, che prevedeva il completamento dell’unione monetaria entro il 1980 mediante il
restringimento progressivo delle bande di oscillazione dei cambi tra le valute europee
senza ricorrere ad un’autorità monetaria sovranazionale, né ad una valuta unica. Il
prodotto di questa visione fu la nascita, tra il 1973 e il 1974, del cosiddette Serpente
monetario europeo, che prevedeva bande massime di oscillazione dei cambi del 4,5%.
Il sistema del serpente monetario fu contrassegnato da molteplici insuccessi, molto
probabilmente legati alle turbolenze economiche della seconda metà degli anni Settanta
legate all’aumento dei prezzi del petrolio e alla stagflazione. L’idea di rinforzare gli
accordi monetari europei tornò dunque in auge e venne proposta dal Presidente della
Commissione Europea nell’ottobre del 1977, l’inglese laburista Roy Jenkins, durante una
lezione tenuta all’Università Europea di Firenze.
Lo scetticismo tedesco cominciò ad attenuarsi alla fine degli anni Settanta, in
particolar modo in riferimento alla continua debolezza del dollaro e alle elezioni francesi
che, nel marzo del 1978, consegnarono la maggioranza alla destra rinforzando la
posizione del Presidente Valéry Giscard d’Estaing. L’asse Schmidt-d’Estaing divenne
l’architrave dei negoziati per una possibile piano monetario europea, come annunciato al
vertice europeo di Copenaghen dell’aprile del 1978. Entrambi si rifacevano alla propria
esperienza in qualità di ministri delle finanze dei rispettivi paesi nel corso dei primi anni
Settanta e proponevano una struttura europea molto simile al sistema di Bretton Woods
dopo le modifiche successive ai dibattiti sulla liquidità internazionale degli anni Sessanta,
con l’ECU che avrebbe giocato un ruolo simile ai DSP.
Come accadde anche ai tempi di Bretton Woods, le origini dello SME vanno
ricercate nelle trattative bilaterali tra i due principali attori della scena: Germania e
Francia. Queste ultime, come già gli inglesi e gli americani nel 1944, non detenevano due
posizioni simmetriche e, anche stavolta, il risultato finale premiava maggiormente le
necessità del paese con la bilancia dei pagamenti in surplus, anche se non va dimenticato
che esistevano degli interessi comuni. Se, infatti, la Francia cercava un’àncora esterna
contro l’eccessiva inflazione, la Germania desiderava un sistema che avrebbe limitato
l’eccessivo apprezzamento del marco in conseguenza dell’afflusso di capitali esteri.
20
I dettagli dell’accordo vennero messi a punto in una serie di incontro tra Horst
Schulmann, consigliere finanziario di Schmidt, e l’ex governatore della Banca di Francia
Bernard Clappier, che redassero una bozza approvata da un incontro franco-tedesco nel
settembre del 1978 ad Aachen. Il nodo centrale del contendere tra Francia e Germania
era se optare per una griglia di parità di cambi, oppure se di costruire un nuovo sistema
intorno ad una nuova valuta. La soluzione fu, come richiesto dalla Germania, la
definizione di parità di cambio predeterminate, stabilite dagli Accordi Europei di Cambio
(AEC), che avrebbero avuto come riferimento un’unità di conto comune denominata
European Currency Unit (ECU).
I paesi facenti all’epoca parte della Comunità Europea aderirono tutti allo SME così
come era stato pensato dalle trattative franco-tedesche, che avevano disegnato un
accordo di cambi fissi aggiustabili. Se Spagna e Portogallo rappresentano paesi con una
particolare storia politica che ne giustifica il ritardo nell’adesione al percorso di
avvicinamento europeo, il Regno Unito mantenne invece un atteggiamento decisamente
ambiguo nei confronti dello SME per almeno un decennio. Solo nell’ottobre del 1990,
infatti, le autorità inglesi hanno aderito al meccanismo dei tassi di cambio dello SME,
riflettendo la lunga diatriba interna al mondo inglese circa i pregi e i difetti di un simile
sistema di cambi che, al fine di aumentare la stabilità valutaria internazionale, sottrae
certamente autonomia monetaria. Va tuttavia ricordato che, come in altri casi del passato,
l’atteggiamento su questo questioni riflette gli interessi di diversi gruppi di pressione: un
settore industriale tendenzialmente favorevole a tassi di cambio quanto meno stabili, ed
un mondo finanziario che, vedendo i suoi profitti legati ad assicurazioni e attività di
intermediazione in mercati ad alta volatilità, può sentirsi invece danneggiato da un
sistema come quello dello SME.
Gli Accordi con cui il Sistema Monetario Europeo entrò in vigore il 13 marzo del
1979 si basavano su una griglia centrale di parità : una parità centrale per i cambi bilaterali
dei paesi aderenti veniva stabilita e, allorquando il cambio avesse raggiunto i limiti della
banda di oscillazione, la banca centrale del paese in questione sarebbe dovuta intervenire
cedendo o acquistando valuta. La banda di oscillazione fu fissata al 2,25%, con
l’eccezione dell’Italia alla quale, a causa dell’inflazione elevata, venne accordata
un’oscillazione del 6%, così come anche al Regno Uniti, al Portogallo e alla Spagna
quando questi paesi aderirono agli AEC nel 1990, stesso anno in cui l’Italia cessò di
godere di una banda d’oscillazione più ampia. Per fare un esempio di come funzionasse
la griglia di parità bilaterali dello SME, nel 1992 il cambio ufficiale tra franco e marco era
di 3,354, dunque il valore del tasso di mercato poteva variare liberamente tra 3,431 e
3,279.
Qualora il cambio di un paese fosse stato vicino a raggiungere i margini della banda
di oscillazione, le autorità del governo interessate sarebbe state obbligate ad intervenire
sui mercati attraverso i cosiddetti interventi marginali, con l’obiettivo di acquistare o
vendere valuta per far tornare il cambio all’interno della gamma d’oscillazione prevista.
Un altro tassello fondamentale del funzionamento dello SME, oltre alle facilitazioni
creditizie a breve e brevissimo termine, era la centralizzazione, presso il Fondo Europeo
di Cooperazione Monetaria (FECoM), dove ciascuna banca centrale dei paesi aderenti
doveva depositare il 20% delle proprie riserve auree e il 20% delle proprie riserve in
dollari in cambia della creazione di conti in ECU. L’ECU era una moneta scritturale,
ovvero una moneta usata inizialmente per redigere il bilancio interno della Comunità
europea e poi come valuta vera e propria, mai coniata ma utilizzata all’interno del
mercato europeo ad esempio in forma di depositi bancari. Essa veniva anche utilizzata
21
per tutte le transazioni della Comunità, per i contributi dei paesi membri e per i
trasferimenti tra le banche centrali.
Il valore dell’ECU veniva stabilito dalla media ponderata delle valute dei paesi che
facevano parte dello SME, ognuna in relazione del peso economico del singolo paese.
Nella composizione del paniere, dunque, il marco tedesco faceva certamente la parte del
leone, costituendo ad esempio nel 1988 il 34% del valore dell’ECU, seguito, in quello
stesso anno, dal franco e dalla sterlina, entrambi quasi al 19%. Poiché le monete nazionali
hanno pesi differente in questo paniere, anche la banda d’oscillazione prevista per i tassi
di cambio ne risulterà influenzata con il risultato che le valute con un peso maggiore
possono fluttuare di più intorno alla loro parità centrale con l’ECU rispetto a quelle con
un peso minore.
Il funzionamento dello SME mostrava alcune peculiarità che lo differenziavano dagli
accordi monetari che lo avevano preceduto. Inizialmente, per lo meno in teoria, non era
prevista nessuna moneta con un ruolo centrale, come era stato ad esempio il dollaro nel
sistema di Bretton Woods. Inoltre, le decisioni sui tassi di cambio dovevano essere prese
all’unanimità da parte di tutti i paesi aderenti, senza che nessuno di essi possa alterare la
sua parità nei confronti delle altre valute in modo unilaterale. Le decisioni venivano
solitamente prese durante i fine settimana quando, a mercati chiusi, si aveva abbastanza
tempo per le trattative.
Come già ricordato, le banche centrali intervenivano quando la propria moneta era
spinta da qualche disturbo finanziario al suo margine superiore o inferiore nella banda
prevista. Le possibilità erano due: agire direttamente sui mercati per mantenere il tasso di
cambio all’interno dei margini o, qualora la parità esistente non possa essere difesa in
alcun modo, ricontrattare nuove parità con gli altri paesi. Tuttavia si è registrata
l’esistenza anche di un altro tipo di intervento, quelli cosiddetti infra-marginali, attivati
quando il margine è ancora lontano al fine di evitare che sui mercati si crei l’aspettativa di
un riallineamento con possibilità di speculazione.
Osservando le diverse pratiche d’intervento delle banche centrali dei paesi aderenti
allo SME è possibile riscontrare che, la presunta simmetria operativa con cui il sistema
era stato immaginato, è rimasta in gran parte relegata alla teoria, in quanto la diversa
importanza economica mondiale dei paesi dello SME ne determinava sostanzialmente i
ruoli all’interno del sistema. La Bundesbank, infatti, ha eseguito la maggior parte dei
interventi sul mercato in dollari, con la finalità di compensare le fluttuazioni del tasso di
cambio del marco rispetto al dollaro. Le altre banche centrali europee, invece, hanno
operato spesso in valute europee o in ECU, con interventi infra-marginali utili a
mantenere le parità all’interno dello SME. Dunque la Bundesbank, per via del peso
dell’economia e delle esportazioni tedesche, ha assunto un ruolo guida del sistema nel
senso che essa stabiliva le relazioni tra le valute europee e il resto del mondo, mentre le
altre banche centrali, attraverso i meccanismi dei tassi di cambio dello SME, aggiustavano
progressivamente la propria posizione rispetto al marco.
Si possono generalmente rintracciare tre distinti periodi di funzionamento dello
SME. Nei primi anni della sua attività, l’accordo riscosse infatti notevoli successi: nel
periodo 1979-1983 si ebbero, senza tensioni degne di nota, svariati riallineamenti nei
cambi in media ogni otto mesi, mentre nei successivi quattro anni si ebbero modifiche
concordate ai cambi una volta ogni dodici mesi con crescenti difficoltà nelle
negoziazioni. In generale, nei primi undici anni di attività dello SME, sono stati calcolati
22
12 riallineamenti. Gli anni che vanno dal 1987 fino al 1992, però, videro un irrigidirsi del
sistema: si ebbero più riallineamenti valutari – il periodo del cosiddetto «Sme-duro» – in
quanto era diventato ormai troppo complicato giungere a modifiche concordate dei
cambi. Proprio sul finire degli anni Ottanta, però, il progetto di una più stringente unione
monetaria tornò alla ribalta con il Piano Delors che, come vedremo meglio nel prossimo
paragrafo, venne poi trasformato in un trattato vincolante: il Trattato di Maastricht,
firmato nel febbraio del 1992, con cui si apriva la strada all’Euro.
2.4 I flussi internazionali di capitali e la crisi dei debiti sovrani
Una delle più importanti conseguenze della fine del sistema a cambi fissi di Bretton
Woods della prima metà degli anni Settanta fu il nuovo impulso che venne dato alla
mobilità internazionale dei capitale, che era comunque cresciuta considerevolmente già
nel corso degli anni Sessanta in connessione con il ritorno alla convertibilità delle valute
europee. Lo strumento principale di questa rinnovata apertura furono gli euromercati,
che sperimentarono una crescita per tutto il periodo passando dai 177 miliardi di dollari
del 1974 ai 575 nel 1980, mentre, nello stesso periodo 1974-1980, le eurobbligazioni
aumentarono da 3,4 a 20,4 miliardi e gli eurocrediti emessi da sindacati di banche da 28,5
a 78 miliardi di dollari. Inoltre gli shock petroliferi, ed in particolar modo quello del 1973,
furono decisivi per questa enorme crescita, in quanto gli euromercati furono uno dei
luoghi privilegiati in cui i paesi esportatori di petrolio, che avevano visto crescere le
proprie liquidità tra il 1974 e il 1980 fino ad arrivare a 383 miliardi di dollari.
In questo periodo vi fu una sempre più marcata tendenza da parte dei paesi in cerca
di prestiti internazionali a rivolgersi al mercato privato che al Fondo Monetario
Internazionale, principalmente in virtù delle condizioni che il Fondo poneva sui propri
prestiti: è proprio il concetto di condizionalità che distingue, a ben vedere, i prestiti
istituzionali da quelli delle banche private, che si dimostrarono, come vedremo, in questi
anni decisamente poco rigorosi.
Il principio della condizionalità si è sviluppato nelle politiche di finanziamento del
Fondo fin dagli anni Cinquanta: inizialmente questo implicava una serie di test circa le
condizioni fiscali e creditizie del paese richiedente, così come lo stato della sua bilancia
dei pagamenti. Tra gli anni Sessanta e Settanta, le specifiche condizioni e le
raccomandazioni di politica economica da perseguire da parte del paese ricevente i
prestiti divennero progressivamente più dettagliate e stringenti. Particolare attenzione
veniva dunque posta sulle politiche di liberalizzazione del commercio, mentre venivano
richieste dettagliate relazioni sul settore pubblico, sulle spese e una particolareggiata
lettera d’intenti firmata dal ministro delle finanze.
Il Fondo produsse nel 1979 un documento intitolato Guidelines on Conditionality, che
rappresenta forse la forma più sistematica di codificazione degli obiettivi del Fondo
contenente una lunga lista di considerazioni preliminari per accordare i prestiti richiesti.
Nella Sezione 4 di questo documento, ad esempio, si affermava che, al fine di aiutare nel
miglior modo possibile il paese membro a perseguire il programma di aggiustamento con
le risorse del Fondo, quest’ultimo avrebbe prestato particolare attenzione agli obiettivi
politici, sociali ed economici, nonché alle circostanze e alle cause che aveva causato il
deficit nella bilancia dei pagamenti.
23
Infine, è opportuno fare riferimento, tra la molteplicità di fattori che favorirono
l’aumento della circolazione internazionale di capitali, alla progressiva
deregolamentazione dei mercati finanziari. Da questo punto di vista può essere
richiamata, simbolicamente, la salita al potere di Margaret Thatcher nel Regno Unito nel
1979 e di Ronald Reagan negli Stati Uniti nel 1981 che, se da una parte certificò
politicamente una tendenza già in atto, diede ad essa anche un notevole nuovo impulso.
La liberalizzazione dei movimenti dei capitali e la deregolamentazione dei mercati
finanziari ebbero tempi e ritmi diversi a seconda dei paesi, anche se la tendenza di fondo
rimase la medesima. Il Regno Unito, ad esempio, vide aboliti i controlli sui cambi con il
ritorno del Partito conservatore al governo nel 1979, mentre la Francia applicò la
direttiva europea per la liberalizzazione dei movimenti di capitale solamente nel 1990. Se,
infine, l’esportazione di capitale non era mai stata limitata in Svizzera, la Germania
rimosse le ultime normative sui cambi nel 1981 e tre anni dopo, nel 1984, abolì anche la
tassa del 25% sui rendimenti delle obbligazioni detenuti da non residenti.
Più lentamente si sviluppò anche la deregolamentazione dei mercati finanziari nelle
principali piazze mondiali, da Londra fino a Tokyo e Parigi. Queste trasformazioni, note
come «big bang», furono attuate per la prima volta in realtà a New York, nel 1975, e
presero piede a Londra nel 1986 allorché vennero abolite le commissioni fisse e la
separazione tra attività di broker e di jobber. Questi cambiamenti, che vennero attuati
anche alla borsa di Parigi e di Francoforte nel 1984-1985, furono fondamentali nel
rendere più moderni e competitivi i settori finanziari europei.
Dunque, l’abbondanza di disponibilità finanziarie delle banche commerciali, una
progressiva liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitali e una minor
regolamentazione delle piazze finanziarie mondiali, insieme alle condizioni a cui il Fondo
Monetario Internazionale elargiva i propri prestiti, fecero si che la mobilità internazionale
del capitale privato aumentasse in maniera esponenziale, dirigendosi soprattutto verso i
paesi in via di sviluppo. Questi prestiti internazionali emessi da banche commerciali
aumentarono da 40 miliardi di dollari del 1975 fino ai 160 registrati nel 1980, mentre il
debito estero dei paesi emergenti raggiunse quota 455 miliardi di dollari nel 1982
partendo da un totale di 126 miliardi del 1975.
Questo percorso di liberalizzazione finanziaria mondiale si rispecchiava in un
atteggiamento delle banche commerciali sempre più spregiudicato. Nel 1982, quando
esplose la crisi del debito sovrano del Messico, tra le 600 e le 700 banche erano
impegnate in tutto il mondo in prestiti internazionali, viste con favore dai ministri delle
finanze dei paesi debitori e da settori sempre più maggioritari delle élite accademiche.
Alla fine del 1981 una relazione del Fondo Monetario Internazionale mostrava che
l’esposizione delle banche statunitensi ai debiti sovrani dei paesi dell’America Latina era
pari al 97,3% del capitale, di cui il 33,7% nel solo Messico.
La nuova mentalità dei banchieri potrebbe essere riassunta nel motto di Walter
Wriston, direttore della banca statunitense Citicorp dal 1967 al 1984, che soleva
affermare «countries don’t go bankrupt», implicando in questo modo che il problema
d’insolvenza non sussisteva per gli stati sovrani in quanto era impossibile immaginare la
perdita da parte di questi ultimi delle proprie infrastrutture e della propria produttività.
Questa opinione, profondamente radicata nelle élite bancarie dell’epoca, portava alla
convinzione che non era necessaria nessuna particolare forma di indagine del merito di
24
credito da parte degli istituti bancari: l’analisi del rischio di credito divenne, così, un
fattore assolutamente secondario nella concessione dei vari prestiti.
L’entusiasmo con cui la finanza privata mondiale si lanciò sul settore dei prestiti
internazionali era guidato per lo più dalla certezza che i tassi d’interesse sarebbero rimasti
bassi come era stato durante gli anni Settanta in seguito all’aumento mondiale
dell’inflazione. Fu proprio su questo elemento che i primi anni Ottanta costituirono un
enorme shock, che si ripercosse poi concretamente nell’esplosione delle crisi dei debiti
sovrani dei paesi in via di sviluppo, le quali vennero favorite anche dalla caduta dei prezzi
di alcuni beni da esportazione nel periodo 1980-1986.
Proprio i primi anni Ottanta furono caratterizzati, dunque, da un’inversione di
tendenza dei tassi d’interesse negli Stati Uniti che, se, quello a breve periodo, era stato
negativo nel 1977 e nel 1978 e pari all’1,3% nel 1979, esso era poi cresciuto fino al 8,9%
del 1981 e del 8,1% del 1982. Un simile trend aveva conosciuto anche il tasso d’interesse
a lungo periodo era rimasto, nel biennio 1981-1982, tra l’8 e il 10%. L’aumento dei tassi
d’interesse generava un aumento, che si rivelò insostenibile, per i paesi debitori in quanto
la stragrande maggioranza dei prestiti erano stati contratti a tasso variabile e dunque
risentivano delle modifiche del tasso di sconto delle banche centrali, il quale era stato
aumentato nei primi anni Ottanta per rispondere all’inflazione che aveva dominato la
decade precedente.
Gli effetti di tale aumento del prezzo dell’interesse da dover pagare da parte dei paesi
che avevano richiesto i prestiti fu aggravato dalla caduta dei prezzi delle materie
d’esportazione di quegli stessi paesi che si verificò tra il 1980 e il 1986. Tale ribasso dei
prezzi fu particolarmente alto per i metalli e per alcuni prodotti tropicali: ad esempio, nel
periodo tra il 1980 e il 1982, il prezzo del rame scese del 32,2%, quello del piombo del
39,7% e quello dello stagno del 23,5%. La caduta dei prezzi di queste materie prime era
conseguenza, da una parte, del rallentamento delle economia industriali e quindi di un
calo della domanda, ma dall’altra rispondeva anche ad una modifica strutturale degli
apparati produttivi dei paesi avanzati che stavano spostandosi dai settori delle industrie
pesanti e chimiche al settore dei servizi e delle industrie leggere, che richiedevano minori
importazioni di metalli. Anche molti prezzi di beni alimentari sperimentarono una simile
caduta: il prezzo del caffè, ad esempio, calò del 25,9% nel periodo 1979-1982, mentre il
cacao addirittura del 47,1% nello stesso lasso di tempo.
Il rallentamento delle economie industriali, l’aumento dei tassi d’interesse e il calo dei
prezzi delle materie prime si rivelarono una combinazione di elementi impossibili da
superare per i paesi in via di sviluppo: attuare misure per correggere la situazione
appariva impossibile. Uno dei primi segnali che la fiducia degli investitori internazionale
nella capacità dei paesi debitori di far fronte alle rate dei prestiti contratti era la fuga di
capitali da un determinato paese. Prima della crisi del debito sovrano messicano, vi erano
stati alcuni segnali di prolungate difficoltà nella bilancia dei pagamenti, e dunque
difficoltà di ripagare le rate dei prestiti internazionali, in paesi come la Jamaica, il
Nicaragua, il Perù e la Turchia. Nell’agosto del 1982 il caso del Messico portò però
l’attenzione mondiale sull’insostenibilità di un modello, dichiarando una moratoria sul
pagamento degli interessi del debito. Per sollevare il paese e la finanza internazionale,
intervennero così le banche centrali dei grandi paesi guidate dalla Fed, con una cruciale
azione di coordinamento da parte del Fondo Monetario Internazionale, che tornava così
protagonista della scena. Nel novembre del 1982 venne firmata una lettera d’intenti da
parte del Fondo e del Messico che prevedeva un prestito straordinario da parte dell’FMI,
25
che in cambio chiedeva riforme strutturali e una riduzione sostanziale del deficit
messicano tra il 1981 e il 1985.
Inizialmente, tuttavia, la crisi del debito messicano venne vista come un caso a sé
stante, che non avrebbe contagiato altri paesi, tanto che anche durante gli incontri del
Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale subito dopo l’agosto del 1982 i
ministri delle finanze sembrava particolarmente fiduciosi che non ci sarebbe stata
un’esplosione di crisi dei debiti. Tuttavia, nel giro di poco tempo, crisi simili si
manifestarono anche in altri paesi debitori, per le medesime ragioni: dunque fu il caso
dell’Argentina, che dovette anche far fronte alla guerra con la Gran Bretagna nell’aprile
del 1982 per il controllo delle Malvinas/Falkland, del Brasile, delle Filippine, del Cile,
della Bolivia e di altri paesi. Era ormai chiaro che la crisi dei debiti sovrani dei paesi in via
di sviluppo aveva dimensioni globali e dunque necessitava di soluzioni di sistema.
Il problema venne cominciato ad essere discusso, inizialmente con poco entusiasmo,
negli incontri del G7 di Williamsburg del 1983 e di Londra del 1984, per poi prendere il
centro della scena a partire dal 1986 in poi, quando la situazione cominciava a divenire
insostenibile. Già a Londra, nel 1984, venne però indicata una prima soluzione palliativa,
che prevedeva una rinegoziazione dei debiti sovrani con le banche commerciali per una
ripartizione delle rate in un tempo più lungo, proposto da Paul Volcker, presidente della
Fed, e Jacque De Larosiére, direttore dell’FMI, con il nome di Multi-Year Rescheduling
Agreement, che iniziò a funzionare nel giugno del 1984. Nel caso del Messico, ad
esempio, si arrivò ad una rinegoziazione delle rate del debito su un tempo di 14 anni con
conclusione fissata al 1990.
La crisi dei debiti sovrani fu dunque risolta con una serie di misure ad hoc dettate dal
pragmatismo e dalla creatività delle autorità finanziarie nazionali e mondiali. Alla fine del
decennio, precisamente nel 1989, si arrivò alla consapevolezza che il debito dei paesi in
via di sviluppo, soprattutto quelli del Sud America, doveva in qualche modo essere
ridotto. Questa soluzione venne proposta da Nicholas Brady – da cui il nome di Piano
Brady e Brady Bonds – che era succeduto a James Baker alla guida del Tesoro americano.
In una conferenza tenuta il 10 marzo del 1989 Brady suggerì, appunto, la necessità di una
volontaria riduzione del debito da parte dei creditori con il supporto finanziario del
Fondo Monetario Internazionale. Tale proposta venne accettata e formalizzata
all’incontro del Comitato di sviluppo del Fondo nell’aprile del 1989, e le prime tre
negoziazioni si conclusero entro la fine dell’anno con la nuova strategia del debito
applicata al Messico, alle Filippine e al Costa Rica, seguite nel 1990 da accordi con
Marocco, Venezuela e Uruguay e nel 1992 da Niger, Mozambico, Argentina e Brasile,
che formalizzò l’accordo nel 1994.
2.5 Verso una nuova cooperazione internazionale: gli incontri del G-5 (1985-1987)
La crisi dei debiti sovrani degli anni Ottanta fece ricomparire sulla scena quella
necessità di cooperazione e coordinamento degli interventi che era mancata dopo il
tentativo promosso durante l’incontro di Bonn del 1978, quando l’esperimento di
reflazione coordinata a livello internazionale per accelerare l’inflazione mondiale fallì.
Tuttavia, il mercato finanziario lasciato libero di agire a livello mondiale, frutto della
liberalizzazione e deregolamentazione dei primi anni Ottanta, generò la crisi dei debiti
sovrani, che venne risolta con interventi mirati e parziali, i cui effettivi giovamenti erano
tuttavia in dubbio. Nella seconda metà degli anni Ottanta, dunque, venne ripresa l’idea di
26
cooperazione internazionale, che si concretizzò negli incontri del Plaza, a New York, del
settembre 1985 e poi del Louvre, a Parigi, del febbraio del 1987.
Dalla conclusione del sistema di Bretton Woods fino alla fine degli anni Ottanta,
soprattutto in conseguenza delle crisi petrolifere e poi dei debiti sovrani, il principio di
cooperazione internazionale era stato declinato nella necessità di una miglior capacità di
supervisione degli istituti bancari attivi a livello internazionale. Già nel 1974, dunque due
anni prima del secondo emendamento agli Articoli dell’Accordo dell’FMI, le banche
centrali del G-10 avevano fondato lo Standing Committee on Banking Regulations and
Supervisory Practices, meglio noto come Comitato di Basilea. Tale organo informale, pur
non essendo dotato di alcun potere legale, divenne negli anni il luogo più importante di
negoziazione e cooperazione finanziaria internazionale per lo più a causa della sua
autorevolezza e della competenza tecnica espressa.
La forza del Comitato di Basilea è fondata su quella che è divenuta nota come soft
law. Le indicazioni prodotte a Basilea, infatti, pur non avendo natura normativa,
costituiscono un percorso di negoziazione informale di intese internazionali che, proprio
attraverso le istruzioni del Comitato, vengono poi traslate nelle giurisdizioni dei diversi
paesi. Si tentava, in tal modo, di conciliare i cambiamenti regolamentari elaborati a livello
internazionale con un necessario consenso a livello nazionale.
Il successo di questo tipo di cooperazione si basa su elementi legislativamente meno
vincolanti dal punto di vista internazionale, ma spesso sostanzialmente più influenti:
principalmente gli strumenti utilizzati sono la sorveglianza tra pari (peer pressure),
l’annuncio pubblico dei paesi non aderenti alle regole (name and shame) ed infine gli
incentivi finanziari, ovvero quei criteri di condizionalità con cui abbiamo visto operare il
Fondo Monetario Internazionale. Il Comitato di Basilea conseguì risultati notevoli
attraverso il principio della vigilanza su base consolidata, in riferimento alle attività
internazionali e, con l’inizio della crisi dei debiti sovrani nei primi anni Ottanta, venne
incaricato dal G-10 di sviluppare un sistema di misurazione del rischio di credito e di
requisiti minimi di capitale per gli istituti finanziari per operare a livello internazionale. Il
risultato di questi lavori fu l’Accordo sul Capitale di Basilea, del 1988, poi rivisto con gli
accordi di Basilea II nel 2004 e Basilea III nel 2011.
La prima metà degli anni Ottanta fu caratterizzata da crisi finanziarie, instabilità e
rallentamento della crescita economica. Le esportazioni mondiali caddero del 11,2% tra il
1980 e il 1983, mentre il 1982 fu l’anno che fece registrare il più basso tasso di crescita
del Pil mondiale, pari allo 0,3% ma con un tasso di crescita negativo dello 0,2% per i
paesi industrializzati. Contestualmente, la mobilità internazionale dei capitali aveva reso,
nella prima metà della decade, non sempre corrispondente ai tassi di cambi reali.
Sull’onda di queste crisi, dunque, tornarono lentamente in auge progetti di cooperazione
internazionale tra le maggiori potenze economiche – in particolar modo Stati Uniti,
Germania e Giappone – votate soprattutto a stabilizzare i cambi tra le valute.
L’alto tasso di sconto praticato dalla Fed per tutta la prima metà degli anni Ottanta
produsse un incremento dei capitali in entrata negli Stati Uniti – che passarono dai 6
miliardi di dollari del 1982 ai 160 del 1987 – , portando ad un aumento del valore del
dollaro, che si apprezzò, tra il luglio del 1980 e il marzo del 1985, del 18,1% rispetto allo
yen, del 94,5% nei confronti del marco e del 122,6% rispetto alla sterlina.
Contestualmente, vi fu un declino degli investimenti nelle economie dei paesi europei. A
partire dal 1982 cominciarono a svilupparsi i primi tentativi di addivenire ad un’analisi e
27
una soluzione comune e coordinata dei problemi monetari mondiali. Prima il vertice
franco-americano di Rambouillet dell’aprile del 1982 e poi gli incontri del G-5 a partire
da quello di Versailles del giugno dello stesso anno posero le basi per un coordinamento
continuativo tra le politiche economiche delle principali potenze mondiali.
Gli alti tassi di sconto della Fed e l’aumento del valore del dollaro cominciavano a
produrre però un intenso dibattito negli Stati Uniti, in particolar modo in conseguenza
delle rimostranze delle grandi industrie esportatrici che erano le maggiori danneggiate
dalle politiche monetarie restrittive. Nel febbraio del 1984, ad esempio, la National
Association of Manufacturers si dichiarò nettamente contraria alle politiche che
favorivano un apprezzamento della valuta statunitense. Queste rimostranze si tradussero
in un cambio al vertice del Dipartimento del Tesoro americano, quando James Baker
sostituì Donald Regan nel gennaio del 1985. Al primo incontro del G-5 a cui Baker
partecipò, nel gennaio del 1985, egli si dichiarò favorevole ad un comune sforzo per
addivenire ad una maggiore stabilità dei cambi.
Le banche centrali iniziarono dunque a intervenire per far calare il prezzo del
dollaro, che raggiunse il suo apice nel febbraio del 1985 quando veniva scambiato a 263
yen e 3,47 marchi. Già a metà aprile, però, il suo valore di scambio era sceso del 15% nei
confronti delle valute europee e del 6% rispetto allo yen. L’impegno condiviso di lavorare
per un deprezzamento del dollaro venne ribadito in una conferenza monetaria mondiale
proposta dallo stesso Baker, tenutasi all’hotel Plaza di New York tra il 20 e il 21
settembre del 1985. Anche se non venne fissata nessuna parità auspicabile tra il dollaro,
lo yen e il marco, l’effetto psicologico del comunicato congiunto dei banchieri centrali
riuniti a New York fu rilevante, portando il dollaro a deprezzarsi del 13% rispetto allo
yen e del 10,5% nei confronti del marco in un solo mese.
La debole crescita economica del biennio 1986-1987 produsse un maggior desiderio
di coordinamento delle politiche economiche nazionali. L’incontro de G-5 tenutosi il 21
e il 22 febbraio del 1987 al Louvre di Parigi vide formalizzarsi un nuovo accordo
monetario che fissava le parità auspicabili del dollaro a 1,8 marchi e a 153,5 yen. Nel
frattempo il Fondo Monetario Internazionale e poi anche le autorità statunitensi
cominciarono a enfatizzare la necessità di una strategia mondiale espansiva per ridurre il
deficit dei paesi in difetto nella bilancia commerciali, il principali dei quali era gli Stati
Uniti. Il dibattito si fece particolarmente intenso nel 1987, soprattutto per le resistenze
della Germania, provocando un generalizzato allarme nei mercati finanziari che si
tradusse nel crollo di Wall Street del 19 ottobre, quando la borsa americana perse in una
sola sessione il 22,6%. Il crollo ebbe, come detto, le sue cause principali nel panico
generato dalle tensioni tra Stati Uniti e Germania, ma fu peggiorato da programmi di
compra-vendita automatizzata, generando quello che è conosciuto come il primo panico
elettronico.
Le intense discussioni internazionali che seguirono il crollo di Wall Street nel G-5 e
nel G-7 ebbero come risultato un accordo conseguente a un non-meeting telefonico
avvenuto tra il 22 e il 23 dicembre del 1987, che produsse un comunicato congiunto che
prometteva una continuata cooperazione per la stabilizzazione dei mercati valutari e un
accordo per ridurre le fluttuazioni e per contenere il declino del dollaro. Questo
comunicato, insieme all’idea ormai diffusa di incontri temporalmente prefissati da parte
dei maggiori paesi mondiali con l’intento di supervisionare e mantenere stabile il valore
delle valute, produsse come risultato principale una maggiore stabilità dei cambi: tra il
28
1987 e il 1994, infatti, i tassi di cambio furono molto più stabili rispetto a quanto fossero
stati tra il 1971 e l’incontro al Plaza di New York.
3. La globalizzazione finanziaria (1987-2008)
Alcuni importanti mutamenti sono avvenuti a partire dalla fine degli anni Ottanta,
contribuendo a modificare il volto dell’economia e della finanzia a livello mondiale. La
liberalizzazione dei commerci a cui si è assistito nell’ultimo quindicennio del secolo,
infatti, ha condotto contestualmente ad una sorta di inversione di tendenza ultra-secolare,
portando allo sviluppo di aree fino a quel momento assolutamente periferiche nel sistema
economiche mondiale. Come il Giappone negli anni del dopo-guerra, furono i paesi
dell’Asia orientale, le tigri asiatiche, poi la Cina e l’India a sperimentare un aumento della
produzione e delle esportazioni, iniziando un percorso di convergenza con le economie
più sviluppate che ha vissuto un momento per così dire simbolico con l’introduzione
dello yuan cinese tra le valute di riserva dell’FMI nel 2016. A questo percorso di
rimodellamento delle geometrie economiche mondiale, si sono accompagnati, da una
parte, processi di estrema finanziarizzazione dell’economia, la quale – grazie alle
innovazioni tecnologiche, alla deregolamentazione, alla liberalizzazione dei movimenti di
capitale e alla crescita di piazze finanziarie fino a quel momento periferiche – si è sempre
più allontanata dal settore reale; dall’altra, l’instabilità monetaria internazionale ha fatto si
che nascessero e si concretizzassero progetti di integrazione e unione monetaria a livello
macro-regionale, il cui esempio migliore è certamente quello dell’euro.
3.1. La liberalizzazione del commercio internazionale (1987-2008)
Il periodo che va dall’ultimo quindicennio del Novecento all’inizio del nuovo
millennio è stato contraddistinto da notevoli cambiamenti, intervenuti a più livelli.
Tuttavia, questi ultimi hanno riguardato in particolar modo la crescita complessiva
dell’economia mondiale, riflettendosi poi in mutamenti strutturali della geografia
industriale mondiale e del commercio internazionale.
Se prendiamo come riferimento al seconda metà del XX secolo, dunque gli anni che
vanno dal 1950 al 2000, si registra un aumento complessivo del PIL mondiale pro-capite
pari al 185%, per una media del 2,1% annuo: contando che siamo in un periodo di
spettacolare crescita demografica, pari al 140%, si comprende come le prestazioni
economiche sono state davvero senza precedenti nel corso della storia. Un altro
elemento importante che non può non essere evidenziato, è il fatto che tale crescita
spettacolare non si sia realizzata in realtà nel paese che, all’indomani della Seconda guerra
mondiale, occupava il ruolo di leader a livello mondiale. Gli Stati Uniti, infatti, crebbero
certamente, ma lo fecero ad un tasso annuo del 2,2%, molto vicino alla media mondiale.
Il vero progresso mondiale si ebbe, dunque, in altre regioni del mondo esterne agli
Stati Uniti, mediante una serie di miracoli economici che coinvolsero, in ordine
cronologico, l’Europa occidentale e il Giappone, che come abbiamo visto raggiunsero i
livelli produttivi statunitensi tra gli anni Cinquanta e Sessanta; poi fu la volta dei paesi
dell’Asia orientale, le tigri asiatiche, come Hong Kong, Corea, Singapore e Taiwan, negli
anni Sessanta, Settanta e Ottanta; infine, la Cina, a partire dagli anni Settanta ma con
ritmo crescente alla fine del millennio, e l’India, che crebbe ad un ritmo sostenuto tra gli
anni Ottanta e Novanta del secolo.
29
A fronte dello sviluppo di queste aree economiche vi furono, però, altre zone che
conobbero un andamento decisamente diverso, con alterne fortune se non puramente
negativo. I paesi appartenenti al blocco sovietico, ad esempio, registrarono livelli di
crescita economica convergenti con gli Stati Uniti fino al 1975, dopodiché
sperimentarono un forte crollo destinato a protrarsi anche dopo il crollo dell’Unione
Sovietica nel 1989 per via della condizione di estrema arretratezza con cui tali paesi si
affacciavano alla fine del millennio. Nei casi dell’Africa e dell’America Latina, poi, non vi
fu nella seconda metà del secolo nessuna stabile convergenza con i paesi più ricchi: a
parte un timido accenno nel corso degli anni Cinquanta, entrambi i continenti
registrarono rallentamenti economici dagli anni Settanta in poi, con una situazione
particolarmente negativa per quanto riguarda il continente africano, dove il tasso medio
di crescita annuo fu minore dell’1% per tutto il periodo 1950-2000.
La crescita generalizzata del PIL mondiale si riflette in alcune condizioni che
riguardano la produzione industriale e il commercio internazionale che sono rapidamente
mutate a partire dagli anni Ottanta, quando un sempre maggior numero di paesi in via di
sviluppo optò, o fu costretto a optare, per un abbassamento delle barriere
protezionistiche volte ad assicurare una generalizzata liberalizzazione dei commerci a
livello globale. Questi cambiamenti di politica commerciale si accompagnarono a delle
trasformazioni delle geometrie produttive tra i vari paesi del mondo, in particolar modo
tra le economie più sviluppate e i paesi in via di sviluppo.
Un momento chiave del percorso di crescita e relativa convergenza fu determinato
dall’Uruguay Round, ottavo e ultimo accordo di liberalizzazione commerciale del GATT,
lanciato a Punta del Este, in Uruguay, nel 1986 e firmato dopo sette anni di negoziazioni
il 15 dicembre 1993 a Ginevra, in Svizzera, da parte di rappresentanti di 117 diversi paesi
del mondo. Gli accordi, che prevedevano inoltre l’istituzione di una nuova forma di
cooperazione internazionale sul commercio, ovvero la World Trade Organization
(WTO), estendevano gli accordi precedenti del GATT sull’abbassamento dei dazi
doganali a nuove importanti settori economici, come ad esempio i servizi e la proprietà
intellettuale, e facevano enormi passi in avanti per liberalizzare quei settori industriali che
negli anni precedenti si erano rivelati i meno inclini a tale politica economica, come
l’agricoltura e il settore tessile.
Queste tendenze mondiali ebbero importanti ripercussioni sulla distribuzione
globale delle esportazioni in prodotti industriali e, ovviamente, sui flussi di scambi
commerciali.
Negli anni Cinquanta del Novecento, le economia sviluppate dei paesi dell’Europa
occidentale, degli Stati Uniti, del Giappone e dell’Unione Sovietica fornivano, da sole, il
90,6% della produzione manifatturiera mondiale, un dato incredibilmente vicino
all’89,8% registrato nel 1913, segno che non vi era stato, nella prima metà del secolo,
nessun processo di allargamento delle aree industriali e produttive nel mondo. Nel 1953,
ad esempio, escludendo i paesi del blocco sovietico, le nazioni più industrializzate
esprimevano ancora più del 90% delle esportazioni complessive a livello mondiale,
producendo uno squilibrio produttivo che si rispecchiava in uno squilibrio politico
evidente.
Il cinquantennio che inizia nel 1960, e che dunque arriva fino ai giorni nostri, ha
dunque conosciuto un rapido dissolvimento di queste divisioni tra paesi sviluppati e resto
del mondo, tra Nord e Sud, conducendo ad una riduzione della quota di produzione
30
manifatturiera dei paesi industrializzati, che è passata dall’88% calcolato ancora nel 1970,
fino all’80& del 1995, mentre la percentuale dei paesi in via di sviluppo è passata dal 12%
al 20%. Tale crescita è riscontrabile anche nella crescita della quota degli occupati in
settori industriali dei paesi dell’Asia sud-occidentale e del Nord Africa, che è passata nel
periodo 1960-2000 dall’8% al 15%, e dell’Asia meridionale, che è salita dal 9% al 14%
nello stesso arco temporale.
Le cifre mostrano chiaramente come i paesi industrializzati mantengano ancora una
posizione di gran lunga maggioritaria nella produzione industriale. Tuttavia, l’inversione
di tendenza che si è registrato alla fine del Novecento ha un sapore storico, in quanto è la
prima volta che si registra un aumento del peso della manifattura di queste parti del
mondo che erano state distanziate in quella che è stata definita la grande divergenza
settecentesca e ottocentesca.
Complessivamente, suddividendo i paesi in tre categorie – paesi sviluppati, in via di
sviluppo e paesi comunisti dell’Europa centro-orientale – notiamo come un
cambiamento repentino è avvenuta nel corso degli anni Ottanta. La progressiva
industrializzazione dei paesi in via di sviluppo aveva infatti portato ad un aumento sia
delle quote nelle esportazioni sia nella percentuale del commercio manifatturiero
mondiale. Se, infatti, la quota sul totale delle esportazioni era pari al 10% nel 1955 ed era
cresciuta fino al 20% nel 1980, nei successivi vent’anni essa era destinata a crescere ad un
ritmo ancora maggiore, superando alla fine della decade le esportazioni dei paesi
comunisti e raggiungendo il 55%
del totale nel 1990 e il 65% nel 2000.
Contemporaneamente, la quota sugli scambi di prodotti manifatturieri dei paesi del sud
del mondo passò dal 5% del 1955 fino al 28% del 2000: tale tendenza si specchia,
ovviamente, in una riduzione della percentuale in capo ai paesi più sviluppati, che passò
dall’85% al 70% nello stesso lasso di tempo.
Va tuttavia osservato che questa tendenza generale in un recupero di posizioni
industriali e commerciali dei paesi in via di sviluppo rispetto alle economia più progredite
era da una parte relativa, in quanto i paesi più ricchi rimanevano indiscutibilmente tali;
dall’altra era molto disomogenea e registrava prestazioni diverse in base all’area
geografica. Significativi progressi vennero dunque fatti registrare in particolar modo dai
paesi dell’America Latina, la cui quota d’esportazione di prodotti manifatturieri sul totale
delle merci esportate passò dal 20% al 56% nel periodo 1970-2000, e dai paesi dell’Asia
meridionale, la cui percentuale di esportazioni definite come prodotti manifatturieri
passò, nel medesimo periodo, dal 56% del totale esportato al 77%. Se, comunque, tutte le
economie del mondo avevano raggiunto almeno il 50% della quota di merci esportate
costituita da prodotti manifatturieri, il Medio Oriente e il Nord Africa rimaneva ancora al
di sotto di questa percentuale, in particolar modo per via della loro dipendenza dalle
esportazioni petrolifere. Ancor più indietro in questo settore rimaneva l’Africa subsahariana, dove i prodotti manifatturieri costituivano solamente il 30% del totale dei beni
esportati all’estero.
Dunque questi dati restituiscono un mondo in rapido cambiamento, da un punto di
vista sia produttivo che dei flussi commerciali. Alla fine del XX secolo, infatti, si
realizzava un’inversione di rotta, un cambio di tendenza rispetto ai tradizionali luoghi
produttivi e movimenti di merci. Si riduceva quell’orientamento degli scambi che aveva
fatto si che, fin dall’Ottocento, i paesi ricchi esportassero beni manufatti in cambio dei
prodotti di beni alimentari e materie prime prodotti dai paesi più poveri. Questo assetto,
dunque, veniva a scomparire negli ultimi due decenni del XX secolo, sostituito da nuove
31
strutture degli scambi, che vedevano nel commercio bilaterale la propria forma
caratteristica: un commercio bidirezionale di scambi di prodotti manifatturieri non solo
tra i paesi sviluppati, ma anche tra le economie più ricche e quelle più povere, nonché tra
gli stessi paesi in via di sviluppo.
3.2 Il tumultuoso sviluppo finanziario di fine Novecento: flussi, innovazioni e piazze
Gli anni Ottanta costituirono dunque una cesura importante nella vita economica a
livello globale, con importanti ripercussioni nel mondo finanziario, dove si verificarono
una serie di cambiamenti sia quantitativi, ovvero un incredibile aumento del volume delle
transazioni, sai qualitativi, attraverso una progressiva innovazione finanziaria declinata
nella creazione ininterrotta di nuovi prodotti grazie anche ai progressi realizzati nel
campo della telematica, dell’informazione e del calcolo computerizzato.
Dunque, la quantità, qualità, accessibilità e disponibilità dei nuovi mezzi di
comunicazione, nelle tecnologie dell’informazione e nelle nuove reti di
telecomunicazione hanno permesso una trasformazione delle tecniche finanziarie a livello
mondiale, inaugurando al tempo stesso nuovi strumenti e metodi operativi. Un segnale
dell’apertura verso una nuova globalizzazione dei capitali, che non ha eguali nella storia
per numeri e velocità di circolazione, è riscontrabile nei flussi internazionali di capitali.
Nel 1980, la stima totale del capitale investito all’estero era all’incirca di 2.800
miliardi di dollari. Nel corso degli ultimi trent’anni questa cifra è cresciuta a un ritmo
sostenuto, quasi di venti volte in soli vent’anni, arrivando a 15.500 miliardi nel 1995 e a
29.000 miliardi nel 2000. Più significativamente, se rapportiamo la quota delle attività
sull’estero al totale del PIL mondiale, si vede che esse n costituivano appena il 6% nel
1960, per crescere poi al 25% nel 1980 fino al 62% del 1995 e, infine, al 92% nel 2000.
Gli Stati Uniti sono ancora il paese leader nell’esportazione all’etero di capitale, seguiti da
Gran Bretagna, Giappone, Germania e Francia. Tuttavia, tra la fine del XX e l’inizio del
XXI secolo è avvenuto un importante mutamente per quanto riguarda la geografia dei
paesi debitori: se, infatti, fino agli anni Ottanta del XX secolo i beneficiari maggiori dei
flussi di capitali erano prima le colonie e poi i paesi in via di sviluppo, all’inizio del XXI
secolo la maggior parte dei capitali è affluita verso i paesi ricchi dell’Europa occidentale,
del Nord America e in Giappone, che, in totale, assorbono più dell’80% degli
investimenti esteri.
Come già accennato in precedenza, gli anni Ottanta furono il decennio in cui si
verificò un tumultuoso processo di innovazione finanziaria che, proseguito anche negli
anni Novanta, presenta aspetti interessanti sia per quanto riguarda i volumi delle
transazioni, sia per quanto riguarda gli strumenti e le tecniche d’investimento.
Il simbolo di tali innovazioni fu certamente il prodotto derivato, che fornisce la
possibilità di contrattare separatamente i rischi generati da un investimento di qualsiasi
natura, finanziario o industriale, realizzando dunque una sorta di mercificazione dei rischi
che opera in maniera indipendente dalle specifiche dell’investimento originale che tali
rischi ha generato. Dunque i prodotti derivati costituiscono la maggiore innovazione
finanziaria dell’ultima parte del Novecento: essi sono contratti il cui valore, appunto,
deriva dall’attività sottostante e ne esistono di due diverse tipologie, i future e le options.
32
Questi prodotti derivati si sono affermati con una rapidità notevole. Sebbene essi
fanno la loro comparsa sui mercati nella piazza di Chicago, il secondo mercato
finanziario statunitense e la principale piazza mondiale dei mercati a termine, nel 1975
con future sui buoni del Tesoro statunitense, essi hanno il loro periodo di successo a
partire dai primi anni Novanta. Infatti, secondo una stima della Banca dei regolamenti
internazionali, nel 1994 il totale dei derivati scambiati sui mercati mondiali aveva
raggiunto quota 20.000 miliardi di dollari, per aumentare poi ancora negli anni successivi
fino ad arrivare alla fine del 2001 ad un volume pari a 85.000 miliardi di dollari e a
184.000 miliardi nel 2004.
L’effetto combinato, dunque, della deregolamentazione finanziaria degli anni
Ottanta, della liberalizzazione dei flussi di capitali, dello sviluppo di nuove tecniche e
strumenti d’investimento come i derivati, ha fatto si che la sovrastruttura finanziaria e i
volumi degli scambi finanziari crescessero ad un ritmo estremamente più rapido rispetto
a quella dell’economia reale. Un’ulteriore caratteristica, di tipo culturale, si è inoltre
aggiunta in questo periodo: la comunità economica ha sembrato attribuire all’attività di
intermediazione non più solamente o principalmente un ruolo di sostegno all’economia
reale, ma anche come fonte di produzione autonoma di ricchezza, che deve essere
incoraggiata e sostenuta.
Valutato in termini del volume degli scambi finanziari il fenomeno appare in tutta la
sua inusitata ampiezza. Nel 1992, ad esempio, secondo un rapporto delle banche centrali
del G-10, il volume netto sui mercati valutari era pari a 900 miliardi di dollari, un
ammontare maggiore del 300% rispetto a quello del 1986. Le operazioni sui cambi esteri
aumentarono già subito dopo l’abbandono dei cambi fissi ma ebbero una crescita
enorme soprattutto negli anni Novanta del secolo. Se, infatti, nel 1982 la media
giornaliera di questo tipo di transazioni era pari a 60 miliardi di dollari, nel 1998 venivano
registrato un volume di 1.490 miliardi di dollari al giorno, che divennero poi 1.880
miliardi nel 2004.
Un altro indicatore che è utile nel fornire la misura di questa crescita è il Financial
Interrelations Ratio (Fir), proposto da Goldsmith negli anni Sessanta, che risulta essere
l’indicatore più affidabile nel calcolo dello spessore della dimensione finanziaria
mondiale. Secondo queste stime lo sviluppo, oltre ad essere senza precedenti, è stato
anche registrato sia in paesi storicamente meno attivi in campo finanziario, come Italia,
Germania e Francia, sia nei paesi leader del settore con Gran Bretagna e Stati Uniti. Il
Fir, infatti, raddoppia in Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia nel periodo 1980-1998 e
aumenta del 50% in Germania, Italia e Giappone.
Questo impetuoso sviluppo non fu senza battute d’arresto: a partire infatti dalla già
menzionata crisi di Wall Street dell’ottobre del 1987, quando il Dow Jones perse 500
punti, ovvero il 20%, nella sola seduta del 19 ottobre, ulteriori momenti di crisi si
susseguirono anche nel decennio successivo: la crisi del Sistema monetario europeo del
settembre del 1992, che portò sterlina e lira ad abbandonare il sistema; quella del Sud-Est
asiatico nel 1997, quando le valute di Thailanda, Malaysia, Indonesia, Filippine e Corea
del Sud si svalutarono velocemente provocando il crollo dei mercati azionari in quei
paesi; infine, nell’agosto del 1998, fu la volta della Russia, che fu costretta a svalutare il
rublo, innescando reazioni a catena che finirono per coinvolgere anche l’America Latina,
dove il paese più colpito fu, nel 2001, l’Argentina.
33
La crescita della sovrastruttura finanziaria degli ultimi due decenni del Novecento si
verificò anche in una costante tendenza al rialzo del mercato borsistico, in particolar
modo nel settore dei titoli tecnologici. Se tra la metà degli anni Ottanta e i primi anni
Novanta, con l’eccezione del crollo di Wall Street del 1987, la crescita fu abbastanza
regolare, con tutti gli indici che aumentarono di 4,5 volte, a partire dal 1995 la situazione
cominciò a mutare, con un ritmo di crescita delle borse che, ad eccezione dei due
momenti di crisi asiatica e russa, raggiunse livelli altissimi tra l’autunno del 1999 e il
marzo del 2000, quando esplose la bolla delle nuove tecnologie, in particolar modo in
connessione con imprese legate ad internet. Nel momento di massimo valore, i titoli
azionari francesi, tedeschi e svizzeri avevano raggiunto un valore di 16 volte superiore a
quello del 1980, mentre quelli britannici e statunitensi di 14 volte superiore. Dopo i fatti
dell’11 settembre 2001 i prezzi precipitarono, ma si ripresero abbastanza rapidamente,
tanto che nella primavera del 2005 la maggior parte degli indici aveva eguagliato i livelli
del 1997.
Anche la struttura dirigente e professionale degli operatori finanziari e degli istituti
bancari è andata incontro ad importanti mutamenti. In primo luogo va sottolineato come
l’élite finanziaria mondiale si sia andata progressivamente ampliando nel numero, come è
dimostrato dai consigli di amministrazione e le direzioni generali delle principali banche
internazionali. Queste si riorganizzarono, a partire dagli anni Settanta e Ottanta,
seguendo modelli multi-divisionali: le prime a muoversi in questa direzione furono la
Citibank e la Westminster Bank, rispettivamente nel 1967 e nel 1970; nel 2005 l’UBS, una
delle maggiori banche multinazionali con sede in Svizzera, aveva un consiglio di
amministrazione composto da dieci membri, da un comitato esecutivo di otto membri e
da una direzione generale con più di cinquanta dirigenti.
Dal punto di vista dei centri finanziari, la complessiva apertura dell’economia
mondiale ha sicuramente favorito il loro giro di affari. New York mantenne per tutto il
periodo la sua supremazia, conseguenza diretta della potenza economica statunitense, ma
fu affiancata, oltre che da Londra, da altri centri finanziari come Tokyo, Francoforte,
Parigi, Zurigo, Hong Kong e Singapore. La rivalità, dunque, che era stata fino a quel
momento un gioco sostanzialmente a due tra Londra e New York, si era trasformata in
una rivalità tra tutte le più importanti piazzi finanziarie globali. Questo ha portato alla
creazione di un sistema gerarchico, nel quale si è affermata la supremazia di un centro
finanziario in ogni parte del globo – New York nell’America del Nord, Londra in Europa
e Tokyo in Asia – , ognuno dei quali era circondato da altri centri continentali la cui
importanza non deve però essere sottovalutata.
New York era certamente il centro finanziario più importante a livello mondiale,
dominando in tutti e quattro i principali indicatori usati per definire il peso delle piazze
internazionali: transazioni bancarie internazionali; asset management; mercato dei capitali; e
altri mercati, come ad esempio quello dei cambi. Tuttavia, se in tre di questi quattro
elementi la distanza con gli altri centri mondiali non è enorme, è sul settore del mercato
dei capitali che la preponderanza di Wall Street è netta: il livello di capitalizzazione del
New York Stock Exchange è cinque volte maggiore rispetto a Tokyo e Londra.
Il settore bancario è dominato da due enormi istituti finanziari, la Citigroup e la J.P.
Morgan Chase, entrambe con sede a New York. Esse sono il risultato del processo di
fusioni e acquisizioni che si è affermato nel mondo bancario statunitense a partire dagli
anni Ottanta, guidato dalla convinzione diffusa che gli interessi degli azionisti di una
società sarebbero stati meglio garantiti dall’operato di manager mediocri se questi ultimi
34
avessero operato sotto il costante rischio di subire una scalata che li avrebbe privati del
loro ruolo direttivo.
Negli Stati Uniti l’ondata di fusione caratterizzò soprattutto gli anni Novanta, in
particolar modo in seguito al 1994, con l’approvazione del Riegle-Neal Interstate Banking
and Efficiency Act, con il quale le banche vennero autorizzate a formare reti di filiali e
dipendenze in tutto il paese: il volume delle fusioni superò i 1600 miliardi di dollari nel
1998, partendo da una quota poco maggiore ai 200 miliardi del 1989.
Seguendo questo trend, dunque, si arrivò alla fusione tra la Citigroup e il Travelers
Group, nel 1998, e quella tra la J.P. Morgan, erede della storica casa finanziaria, e della
Chase Manhattan, che era a sua volta la risultante dell’acquisizione della Chemical e della
Manufacturers Hanover, due delle più grandi banche americane, avvenuta nel 1999. Il
nuovo gruppo si allargò ancora nel 2004 attraverso l’acquisizione della Bank One, sesta
banca statunitense, anch’essa il risultato di numerose fusioni precedenti.
A differenza di New York, che ha potuto contare per tutta la seconda metà del
Novecento del peso dell’economia più grande al mondo, la City di Londra ha dovuto
perseguire, con eccellenti risultati in realtà, una politica di progressiva e inesorabile
internazionalizzazione per poter continuare ad occupare un ruolo leader nel mondo
finanziario globale. Tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio è possibile
afferma che questa posizione era stata raggiunto. La City, infatti, poteva vantare il
primato in alcuni dei più importanti settori d’attività finanziaria sul piano internazionale:
innanzi tutto essa dominava il ramo dei prestiti bancari all’estero, detenendo il 19,5% del
mercato, contro l’11% di Tokyo; in secondo luogo, era prima per il volume delle
transazioni in valute estere, con il 32% del totale di esse, seguita da New York con il
18%; era poi la piazza finanziaria con il maggior numero di banche e uffici stranieri; e
infine, era ovviamente leader nel settore delle eurobbligazioni, il 60% delle quali venivano
trattate a Londra, rappresentando il 90% di tutte le emissioni internazionali.
Come si nota, dunque, la rinascita della City di Londra – collocabile proprio negli
anni Sessanta grazie all’insieme di una serie di fattori, tra cui lo sviluppo degli
euromercati, solide tradizioni, competenze in campo bancario e autorità liberali ma
lungimiranti – e il mantenimento di posizioni centrali nel mondo finanziario mondiale,
furono dovute proprio alla sua apertura e attività in campo internazionale, che si riflesse
nella sempre maggiore rilevanza delle attività di banche straniere sulla piazza londinese.
Quest’ultima può essere registrata anche osservando il declino delle storiche merchant
bank inglesi che, inadatte ad affrontare la crescente competizione degli istituti stranieri,
finirono per sparire lentamente dal panorama bancario della City come dimostra il
fallimento della Baring Brothers nel 1995.
Viceversa, le banche commerciali britanniche rimanevano tra le maggiori al mondo,
come ad esempio il gruppo Hsbc che, erede della Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation, aveva acquisito nel 1991 la Midland Bank diventando la seconda banca al
mondo per capitalizzazione di borsa dietro la Citigroup; oppure la Royal Bank of
Scotland che, dopo aver acquisito la National Westminster Bank nel 2000, era la settima
banca al mondo, seguita dalle britanniche Lloyds Tbs e dalla Barclays.
Tokyo, infine, cominciò ad affermarsi come piazza internazionale di primo livello
alla fine degli anni Ottanta, quando sembrava potesse superare anche New York in
conseguenza del successo dell’economia giapponese e del relativo declino di quella
35
statunitense. Nella primavera del 1987, infatti, la capitalizzazione della Borsa di Tokyo
superò quella del New York Stock Exchange, mentre, simbolicamente, i profitti della
società di brokeraggio e banca d’investimenti Nomura Securities avevano superato quelli
della Citibank e della Merrill Lynch. Tuttavia, l’economia statunitense recuperò il terreno
perduto già negli anni Novanta, quando invece quella giapponese cominciò ad avvitarsi
in un prolungata fase recessiva. Queste tendenze ebbero grandi ripercussioni sulle attività
e sulla posizione internazionale della Borsa di Tokyo, che tuttavia rimase la seconda
piazza mondiale dietro a New York per capitalizzazioni e prestiti esteri emessi dagli
istituti finanziari nipponici.
Un’ultima osservazione deve essere fatta circa il rapporto tra gli Accordi di Basilea e
le banche giapponesi. Queste ultime, infatti, per far fronte al nuovo regolamento
internazionale di Basilea che imponeva un rapporto tra capitale e passività dell’8% – a
fronte di una media di capitale e passivo di bilancio del 2% – , convinsero le autorità a
permettere loro di calcolare le proprie partecipazioni azionarie in altre imprese come
capitale sociale e non come plusvalenze potenziali. Non appena esplose la bolla
speculativa nel 1991, la situazione delle banche si deteriorò molto rapidamente in quanto
il proprio capitale andava prosciugandosi. Il risultato fu la riduzione delle attività, in
particolar modo quelle di rilevanza internazionale, ed un ripiegamento nei confini
nazionali degli istituti finanziari giapponesi, fattibile grazie al fatto che la legislazione
nazionale prevedeva un indice di solvibilità del 4%.
Alle spalle delle piazze finanziarie con rilevanza mondiale di New York, Londra e
Tokyo, vi è una serie di centri che possono essere considerati minori solamente in virtù
della loro specializzazione regionale o settoriale, tra cui troviamo Francoforte, Parigi,
Zurigo e Ginevra, Singapore e Hong Kong.
La crescita di Francoforte è certamente legata allo sviluppo economico della
Germania, soprattutto durante gli anni Novanta quando vi furono prima la riunificazione
tedesca, superata con inattesa facilità dalle autorità tedesche, sia la nascita dell’Unione
Europea, che vide la sede della BCE essere fondata proprio a Francoforte. Nonostante
un mercato degli strumenti derivati molto sviluppato, Francoforte non è riuscita però a
superare il suo status di piccola città molto legata alla zona del Reno, rimanendo tuttavia
il quarto centro finanziario mondiale. Nello stesso periodo la piazza finanziaria di Parigi
era stata rivitalizzata dalla deregolamentazione degli anni Ottanta, portando il rapporto
tra capitalizzazione della borsa e PIL nominale a crescere notevolmente, salendo al 65%
nel 2004, superando dunque quello tedesco, fermo al 40%, ma molto distante da quello
inglese, che si attestava al 125% del PIL.
La liberalizzazione dei flussi di capitale; la deregolamentazione finanziaria a cui si
assistette a livello mondiale a partire dagli anni Ottanta; la caduta dell’inflazione, la
stabilità delle valute europee e infine l’entrata in vigore dell’euro: tutti questi fattori hanno
certamente arrecato dei danni alle piazze svizzere di Zurigo e Ginevra, che vedevano
affievolirsi le ragioni della propria attrattiva per i capitali internazionali. Ciononostante, la
lunga tradizione bancaria, una forza lavoro estremamente qualificata e la stabilità politica
e monetaria, rendono ancora Zurigo e Ginevra dei punti di forza per alcune nicchie
dell’attività finanziaria, in particolar modo per la clientela privata. Zurigo, infatti, gestisce
ben il 35% dei patrimoni privati offshore, mentre Ginevra è riconosciuta all’unanimità
come la capitale globale del private banking.
36
Infine, come l’ascesa di Tokyo aveva rispecchiato lo sviluppo economico giapponese
negli anni Settanta, l’emergere dei paesi del Sud-Est asiatico ha portato all’aumento di
importanza delle piazze di Singapore e Hong Kong. È utile notare, tuttavia, che nessuna
delle due partiva da zero, in quanto dotate di istituzioni bancarie di una certa solidità
grazie soprattutto all’eredità lasciata dalle overseas bank britanniche che operavano nella
zona, come ad esempio la Hongkong and Shangai Banking Corporation. La posizione
geografica di entrambi i centri, inoltre, è sicuramente favorevole, grazie ad ottimi
collegamenti nei trasporti aerei e nelle reti di telecomunicazioni mondiali.
Tra gli anni Ottanta e Novanta Singapore si è specializzata, attraverso il suo Asian
Dollar Market, nato per volontà delle autorità politiche nel 1968, nel mercato degli
eurodollari, che passò da un volume di 86 miliardi di dollari nel 1982 a 350 miliardi
registrati nel 1990, e delle euroobbligazioni. Le attività della piazza di Hong Kong,
invece, si focalizzarono sulle emissioni di eurocrediti, diventando in poco tempo la terza
piazza mondiale per questo tipo di attività, dietro a Londra e New York.
3.3 L’avvento dell’euro: dalla crisi dello SME alla BCE
Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, dalla fine degli anni Ottanta le autorità
europee si mossero nella direzione di disegnare un’unione monetaria e politica a livello
più stringente. Quest’esigenza, che avrebbe dovuto permettere alla Comunità di crescere
e diventare contemporaneamente più solida e credibile a livello internazionale, si
concretizzò in un primo momento il 28 febbraio del 1986 quando, in Lussemburgo,
venne firmato l’Atto Unico Europeo, che entrò in vigore l’anno successivo emendando il
Trattato di Roma attraverso alcune modifiche che avrebbero permesso la piena
costruzione del mercato interno.
Seguendo questa tendenza, il Consiglio Europeo istituì nel 1988 la già ricordata
commissione guidata da Jacque Delors, presidente in quel momento dalla Commissione
Europea, con il compito di elaborare un programma per la realizzazione dell’unione
monetaria. Il Rapporto Delors riprendeva la definizione di unione monetaria formulata
dal comitato Werner già nel 1970, che prevedeva la compresenza di tre condizioni: valute
pienamente convertibili, libertà di movimento dei capitali e tassi di cambio fissi. A questi
elementi, il comitato Delors aggiungeva, per raggiungere una piena unificazione, altri due
punti interessanti: la piena liberalizzazione dei servizi bancari e finanziari e il passaggio da
politiche monetarie nazionali indipendenti ad un’unica politica monetaria comunitaria.
Dunque, a partire da queste conclusioni, il Rapporto Delors elaborò una tabella di
marcia articolata in tre fasi per raggiungere un’unione monetaria europea. In una prima
fase, inaugurata ufficialmente nel luglio del 1990, si sarebbe completata la liberalizzazione
della mobilità dei capitali tra gli Stati membri, specialmente attraverso l’aumento della
cooperazione delle banche centrali; nella seconda fase, iniziata il 1 gennaio del 1993, si
sarebbero delineate le caratteristiche tecniche della costituenda unione con l’Istituto
Monetario Europeo (IME) a fare il ruolo di apripista per la Banca Centrale Europea
(BCE), ufficialmente creata nel 1998; infine, nella terza fase, a partire dal 1 gennaio 1999,
si sarebbe arrivati all’ultimo stadio dell’unificazione con l’adozione della moneta unica,
l’euro.
Tra la prima e la seconda fase della progressiva costruzione dell’unione monetaria
europea, questa venne sostenuta, attraverso il recepimento di molte delle idee espresse
37
dal Rapporto Delors, nel Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio del 1992 dai dodici
Paesi membri della Comunità Europea ed entrato in vigore il 1 novembre del 1993, che
fissava le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l’ingresso dei vari
Stati nell’Unione. Erano, questi, i cosiddetti parametri di convergenza, che riguardavano
principalmente il tasso d’inflazione, il tasso d’interesse a lungo termine, il tasso di cambio
e la finanza pubblica, nella quale il rapporto tra debito pubblico e PIL non doveva,
all’atto della selezione dei paesi candidati, superare il 60% – o in caso doveva manifestare
chiare tendenze alla riduzione – , mentre il rapporto tra disavanzo e PIL non doveva
essere superiore al 3%.
Il Trattato di Maastricht si rivelò da un lato particolarmente innovativo, disegnando
le linee fondamentali del sistema di coordinamento e vigilanza reciproca tra i paesi
europei, e dall’altro fu essenziale nel dare credibilità politico al nascente edificio europeo
e, soprattutto, alla nuova moneta, della quale veniva promossa e salvaguardata la fiducia.
I risultati della serie di accordi europei degli anni Novanta fu la costruzione di un edificio
che poggiava, da un lato, su un inedito modello di banca centrale federale e, dall’altra, su
un complesso sistema di coordinamento delle politiche economiche dei paesi europei
certificato con il Patto di stabilità e crescita firmato nel giugno del 1997 dai paesi aderenti
alla UEM in aggiunta al Trattato di Maastricht.
L’impegno dei paesi firmatari a Maastricht di evitare disavanzi pubblici eccessivi,
dunque eccedenti appunto il 3% del Pil, in maniera permanente, venne posto
giuridicamente sotto controllo da un’azione di vigilanza degli organi europei. Lo scopo
ultimo era quello di far si che i paesi membri perseguissero una posizione di bilancio
pubblico in avanzo, o per lo meno prossima all’equilibrio, nel medio periodo. Il Patto di
stabilità e crescita sottoscritto da Consiglio europeo nel giugno del 1997 aveva il compito
di rendere effettivi tali impegni attraverso un equilibrio di poteri tra sfera nazionale e
sfera europea. Il delicato problema del trasferimento della sovranità, dunque, veniva
affrontato mediante un ponderato ricorso a meccanismi di prevenzione e dissuasione con
un costante ricorso al dispositivo della peer pressure, già sperimentato con il Comitato di
Basilea nei decenni precedenti.
In primo luogo il Patto impegna i paesi membri a presentare annualmente al
Consiglio europeo, alla Commissione e ad uno specifico organo con compiti economici
composto dai ministri delle finanze dei paesi membri, il Consiglio Ecofin, un piano
triennale, definito di stabilità, nel quale devono essere descritti gli obiettivi di bilancio nel
medio periodo. Lo scopo principale di questi programmi triennali è quello di stabilire un
percorso di gestione della finanza pubblica volto a scoraggiare un uso strumentale degli
eventuali avanzi di bilancio. Inoltre, per quanto riguarda le eventuali infrazioni, sia la
definizione delle stesse – il considerare, cioè, il superamento della soglia del 3% come
eccezionale e temporanea o meno – , sia l’avviamento della procedura di infrazione sui
disavanzi eccessivi, sono demandati ad una complessa procedura istituzionale che
coinvolge sia il Consiglio Ecofin che la Commissione Europea. Qualora avviata, inoltre,
essa prevede anche livelli diversi di intervento da parte della struttura sovranazionale, che
vanno dalla richiesta al paese in disavanzo di attuare di misure correttive, fino
all’imposizione di sanzioni pecuniarie nel caso che il disavanzo oltre il 3% non sia stato
riassorbito nell’arco di due anni.
Non è un caso che il Patto di stabilità e crescita sia stato elaborato alcuni anni dopo
il Trattato di Maastricht. Tra il 1992 e il 1997, difatti, lo SME venne investito da una
importante crisi di fiducia allorché la Danimarca, nel giugno del 1992, respinse con un
38
referendum popolare il Trattato e i mercati vennero colpiti da una crisi valutaria che colpì
prima la lira e la sterlina, costrette a sospendere la propria partecipazione agli Accordi
Europei di Cambio, e poi, nei mesi successivi, Spagna, Portogallo, Finlandia, Norvegia,
Svezia e Irlanda, dove la moneta venne svalutata del 10% nel gennaio del 1993. Nel luglio
del 1993 i paesi ancora aderenti allo SME decisero di modificare le bande di oscillazione,
che passarono dal 2,25% al 15%, il che equivaleva di fatto a far cessare l’operatività degli
accordi di cambio.
La crisi dello SME tra il 1992 e il 1993, dunque, operò come un dispositivo culturale
che portò le autorità europee ad agire per costruire un capitale istituzionale credibile, che
avesse gli strumenti necessari per sorreggere la fiducia nella nuova valuta europea, l’euro,
e dunque per dare credibilità economica a tutto l’edificio unitario in costruzione. Nella
seconda metà degli anni Novanta, quindi, proprio sull’onda dell’esperienza del 19921993, le autorità europee hanno incrementato i propri sforzi di costruire un sistema di
interdipendenze tra le banche centrali nazionali per realizzare le previsioni del Trattato
sui parametri di convergenza, portando così alla nascita nei tempi previsti della Banca
Centrale Europea: un esperimento di banca centrale federale sovranazionale senza
precedenti nella storia del central banking e che sorse con lo scopo principale di sorreggere
la fiducia nella nuova valuta europea e di tutta la struttura comunitaria.
I modelli più vicini al nuovo sistema europeo di banche centrali, al cui vertice vi è la
BCE, sono ovviamente la Federal Reserve statunitense e la Bundesbank tedesca.
Tuttavia, numerose sono le differenze tra una banca centrale federale che deve operare
su un unico territorio nazionale, seppur formato da stati federali, ed un’altra che, invece,
si trova a dover funzionare in un sistema di Stati-nazione con politiche monetarie e
economiche fino a quel momento autonome.
Osservando la definizione degli obiettivi, dei compiti, del grado di autonomia
istituzionale e della struttura di governo ci si può rendere conto immediatamente degli
aspetti innovativi dell’esperienza di banca centrale federale europea della BCE. La
stabilità dei prezzi, come indicato dal Trattato, diventa l’obiettivo primario, al quale
devono essere subordinati tutti gli altri eventuali scopi dell’azione della banca. La politica
monetaria, dunque, ha un ruolo privilegiato, mentre non viene assegnata alla BCE nessun
compito di vigilanza bancaria, segno evidente che non in tutti i paesi aderenti tale
compito è di pertinenza della banca centrale.
Sul piano istituzionale la BCE gode di un’ampia autonomia rispetto sia alle
istituzioni europee, sia a quelle nazionale: essa, infatti, ha il divieto sia di sollecitare che di
accettare istruzioni da uno qualsiasi degli Stati membri o da organi comunitari, come
anche risulta vietato concedere finanziamenti monetari in qualunque forma ai governi dei
paesi membri. Per quanto riguarda il governo della nuova istituzione bancaria federale, è
stato creato quello un sistema composito definito come Sistema europeo di banche
centrali, composto dalle banche centrale dei vari paesi aderenti e da un organo monetario
centrale con sede a Francoforte. L’organo supremo è il Consiglio direttivo, costituito dai
governatori delle banche centrali nazionali facenti parte del sistema e dai sei membri del
Comitato esecutivo della BCE, nominati attraverso una complessa procedura intergovernativa.
Questa complessa struttura del sistema delle banche centrali europee, unita
all’intricato insieme di organismi europee, è certamente caratterizzato da una scarsa
flessibilità e dalla presenza di numerosi vincoli istituzionali soprattutto nella decisione
39
della politica monetaria unitaria e, di concerto, delle politiche di bilancio dei singoli paesi
membri. Tuttavia, questi sembrano i costi che un sistema che si sta sviluppando deve
essere costretto a sostenere per produrre e sostenere la fiducia, che è un bene scarso,
degli operatori economici in una banca centrale sovranazionale e in tutto il regime
monetario dell’esperienza dell’Unione Europea.
Come visto, il Trattato di Maastricht e la moneta unica vanno a risolvere il problema
dei pagamenti intra-europei, legati in passato ai rischi di cambio che rendevano instabile il
sistema, come visto nei primi anni Novanta. In questo senso la BCE cominciò ad
operare, ed opera tuttora, come garante dell’unione monetaria e, come da statuto, della
stabilità dei prezzi, ma in questo modo il problema si spostò dai cambi valutari ai tassi
d’interesse sui debiti pubblici dei paesi aderenti all’edificio europeo. L’adozione della
moneta unica, se da una parte ha tolto agli Stati membri la sovranità monetaria, ha dato
loro in cambio, fin quando ci si è trovati in una situazione di espansione economica, bassi
tassi d’interesse sul debito pubblico e possibilità di gestire direttamente la spesa pubblica
e la bilancia dei pagamenti.
Quest’equilibrio ha sostanzialmente retto fino alla recessione del 2008, quando si
ruppe quella convergenza dei tassi d’interesse sul debito pubblico proprio in
corrispondenza dalla crisi statunitense, incrinando la situazione di equilibrio dell’ultimo
decennio e portando alla luce l’altra faccia della medaglia dell’unione monetaria europea:
eliminati i rischi sui cambi valutari, questi stessi rischi, in una congiuntura economica
sfavorevole – con un abbassamento delle esportazioni che varia tra il 15% e il 25% negli
anni dopo il 2009 – , si sono trasferiti sui tassi di interesse dei debiti pubblici, riflettendo
in ultima istanza gli squilibri tra i differenziali dei paesi membri: gli squilibri, quindi, tra i
paesi più ricchi e i paesi più poveri all’interno dell’Unione Europea.
4 – Quadri di approfondimento
4.1 La Soft Law sovranazionale: il Comitato di Basilea e il Financial Stability Forum
Quando negli anni Settanta le crisi petrolifere modificarono lo scenario economico
globale e, parallelamente, i flussi internazionali di capitale crebbero con molta rapidità,
divenne evidente che vi era una forte necessità che si iniziasse un processo di
affinamento e miglioramento nelle tecniche di supervisione dell’attività degli istituti
bancari più attivi a livello mondiale. Più in generale, in seguito anche alla fine degli
accordi di Bretton Woods, il cui funzionamento venne interrotto, o radicalmente
modificato, tra il 1971 e il 1976, le grandi potenze economiche dovettero escogitare
nuove metodologie di cooperazione internazionale per gestire un movimento di capitali
che stava diventando sempre più veloce con una tendenza destinata, come abbiamo
visto, a crescere esponenzialmente nelle ultime due decadi del Novecento.
Lo strumento individuato per porre le basi di una nuova tipologia di cooperazione
internazionale, caratterizzata, come vedremo, da un basso grado di formalità normativa,
fu quello che verrà poi conosciuto come Comitato di Basilea, fondato alla fine del 1974
dalle banche centrali dei paesi del G-10. Il Comitato, noto inizialmente come Standing
Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices, veniva creato all’interno della
Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), istituita nel 1930 con l’obiettivo di rendere
operativo il Piano Young, elaborato dalle potenze uscite vincitrici dalla Prima guerra
40
mondiale al fine di facilitare il pagamento da parte della Germania delle riparazioni di
guerra, con uno statuto giuridico che, sebbene la sede fisica fosse situata in Svizzera,
permetteva alla Banca di non essere soggetta alle leggi bancarie o al diritto commerciale
elvetico, mantenendo dunque i privilegi e le immunità di un organismo internazionale.
L’input alla creazione di quello che sarà noto come Comitato di Basilea venne
sostanzialmente dal fallimento di una serie di banche con una considerevole esposizione
internazionale. Si trattò, in particolare, del fallimento della Bankhaus Herstatt di Colonia,
della British-Isreal Bank, con sede a Londra, e della Franklin National Bank di New
York. La Bankhaus Herstatt, attiva sul mercato dei cambi, una banca in realtà di medie
dimensioni, venne chiusa d’autorità dall’organo di vigilanza bancaria tedesca il 26 giugno
del 1974, con ripercussioni che si materializzarono nella cancellazione di versamente per
circa 600 milioni di dollari a banche operanti su Wall Street, che avevano già però
regolato alla banca tedesca il versamento in valute europee, principalmente in marchi.
L’asincronia della regolamentazione tra i mercati in dollari e in marchi – fenomeno che
venne da quel momento conosciuto come «Herstatt risk» – provocò notevoli problemi
sul mercato dei cambi, portando al fallimento di altri istituti finanziari.
Dunque il Comitato di Basilea nasceva per tentare di porre una comune vigilanza
sovranazionale sulle banche che svolgessero attività estere. Il primo incontro del nuovo
organismo si tenne nel febbraio del 1975 e da quel momento si sono tenuti incontri
regolari tre o quattro volte all’anno con lo scopo di implementare e rafforzare i
meccanismi di vigilanza bancaria a livello internazionale. Il Comitato divenne in breve
tempo uno dei fori più autorevoli in campo di regolamentazione finanziaria, sia per la
competenza tecnica espressa, sia per il ristretto numero di membri di cui era composto,
tutti comunque provenienti dai paesi più industrializzati al mondo, dunque da quei paesi
che più contava anche a livello finanziario. Anche, essendo un comitato di natura
informale, la sua forza legale era limitata o quasi del tutto assente, il Comitato di Basilea
riuscì a divenire un centro di fondamentale importanza nella cooperazione finanziaria
internazionale, soprattutto attraverso l’uso pratiche informali di pressione sulle varie
autorità nazionali.
Uno dei primi risultati degli incontri fu il Report on the Supervision of Banks’ Foreign
Establishments, meglio noto come il Concordato, datato settembre del 1975, attraverso il
quale veniva stabilito il principio di responsabilità condivisa circa le attività finanziarie di
una banca all’estero dalle autorità di vigilanza del paese ospitante e di quello di
provenienza della banca stessa. Tale Concordato venne più volte aggiornato nel corso dei
decenni successivi, in primo luogo con il Principles for the supervision of banks' foreign
establishments del maggio del 1983, al quale venne aggiunto un supplemento, dell’aprile del
1990, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni prudenziali tra autorità di
vigilanza bancaria dei diversi paesi.
Sempre nella direzione di progressiva rimozione degli impedimenti nazionali ad una
cooperazione internazionale nel settore della vigilanza bancaria andava anche il rapporto
dell’ottobre del 1996, intitolato The Supervision of Cross-Border Banking, redatto da un
gruppo di lavora inter-governativo nel quale vennero coinvolti rappresentanti anche di
paesi non facenti parte del G-10. Il rapporto fu poi recepito da ben 140 paesi del mondo,
rafforzando così enormemente le relazioni internazionali tra le autorità preposte alla
vigilanza bancaria e ai flussi di capitali.
41
L’inclusione di paesi esterni al G-10 ha avuto un ruolo centrale anche nella stesura del
Core Principles for Effective Banking Supervision, pubblicato nel 1997, che stilava una lista di 25
principi base per la creazione di un efficiente sistema di vigilanza internazionale. Tali
principi sono stati poi posti sotto una ulteriore fase di revisione e sono diventati 29
nell’ultima versione del settembre del 2012, includendo temi quali poteri di supervisione,
tempismo e necessità d’intervento, nonché la necessità di avere degli standard comuni a
livello globale.
In seguito alla crisi dei debiti sovrani degli anni Ottanta che interessò i paesi del terzo
mondo e le maggiori banche mondiali, il G-10 incaricò il Comitato di Basilea di
sviluppare un sistema di misurazione del rischio di credito e di fissare dei requisiti minimi
nel livello di capitalizzazione degli istituti bancari per operare nei mercati esteri. Il
risultato di questo indirizzo fu lo International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards, meglio noto come Accordo sul Capitale di Basilea del luglio del 1988, che
prevedeva un rapporto tra capitale e solvibilità dell’8%. A questo accordo furono fatti
diversi emendamenti e aggiornamenti nel novembre del 1991, nell’aprile del 1995 e nel
gennaio del 1996, fin quando, nel giugno del 1999, il Comitato decise per una completa
revisione dell’Accordo del 1988, in quanto Basilea I – così divenne poi noto l’accordo del
1988 – rifletteva una situazione bancaria internazionale e un grado di rischio delle
aziende notevolmente semplificato rispetto allo scenario degli anni Novanta.
Si arrivò dunque, nel giugno del 2004, alla firma del Nuovo Accordo sul Capitale,
generalmente noto come Basilea II, che rivede i concetti di vigilanza prudenziale alla luce
delle innovazioni tecnologiche della finanza degli anni Novanta. Fondato su tre pilastri –
requisiti patrimoniali, controllo delle autorità di vigilanza e disciplina di mercato e
trasparenza – l’accordo, che entrò in vigore nel giugno del 2007, prevede requisiti
particolarmente stringenti per le banche operanti in contesti internazionali, le quali sono
obbligate ad accantonare quote di capitale in proporzione al rischio assunto, quest’ultimo
valutato con un apposito rating più sofisticato di quello adottato in precedenza. In
seguito alla crisi finanziaria globale del 2008 si è reso necessario un ulteriore
aggiornamento degli accordi di Basilea, che ha portato alla firma, tra il 2010 e il 2011, del
cosiddetto Basilea III, la cui entrata in vigore era inizialmente prevista tra il 2013 e il 2015
ma che è stata poi rinviata al 2019.
Ma come è possibile spiegare l’incisività di una normativa stipulata all’interno di un
organo internazionale informale come quello di Basilea, privo di una effettiva forza
legale? A ben guardare, i codici di condotta e gli standard definiti a Basilea dipendevano
nella loro attuazione dalla ricezione delle autorità governative nazionale, che però
venivano stimolate ad adeguarsi a ciò che veniva deciso a livello sovranazionale da una
serie di incentivi, noti con il termine di soft law.
Attraverso questo approccio, lontano sia dalla stringente forza della legge ordinaria sia
dalla debolezza delle convenzioni internazionali, ci si è orientati verso un’armonizzazione
delle norme che disciplinano e vigilano sui diversi sistemi finanziari nazionale con il
bisogno di definire standard regolamentari e di comportamento condivisi a livello
sovranazionale. Dunque, tale processo lega indissolubilmente le intese sui regolamenti
prese a livello internazionale con l’esistenza di un adeguato consenso nei confronti degli
stessi regolamenti.
Alla fine degli anni Novanta, al Comitato di Basilea di è affiancato, o piuttosto
sovrapposto, il Financial Stability Forum (FSF), il quale è composto da oltre quaranta
42
membri in rappresentanza dei ministeri economico-finanziari, delle banche centrali e
delle autorità di vigilanza e regolamentazione dei paesi del G-7 più Australia, Olanda,
Hong Kong e Singapore, ai quali si aggiungono rappresentanti delle istituzioni finanziare
internazionali, come l’FMI e la Banca Mondiale, della BCE e degli organismi informali,
tra cui anche il Comitato di Basilea.
L’FSF – che ha mutuato il suo nome in Financial Stability Board nel 2009 – si pone
come suo obiettivo prioritario quello di raccogliere e diffondere le indicazioni
comportamentali, quelle che vengono definite le good practices, elaborate da associazioni
specializzate di settore – come la International Organization of Securities Commissions
(IOSCO), cioè la federazione dei regolatori degli intermediari in valori mobiliari – al fine
di facilitarne una più rapida e vasta adozione.
Queste forme di regolamentazione sovranazionale informale si poggiano, da un lato,
su un’interpretazione del governo di questi stessi forum flessibile, che ricerca il consenso
dei suoi membri per assicurarsi il buon funzionamento della cooperazione, in quanto i
risultati di quest’ultima dovranno poi essere recepiti dalle normative nazionali. Dunque,
nel tempo, è risultato necessario ampliare sempre più i membri dei principali fori
internazionali, proprio per dare ad essi più possibilità di incisione.
Tuttavia, la partecipazione allargata, da solo, non è garanzia di successo. Particolare
efficacia hanno avuto invece i meccanismi di incentivi che sono stati messi in opera al
fine di rendere il più possibile effettive le decisioni prese a livello mondiale. Tali incentivi
possono essere ricondotti a tre categorie principali: la sorveglianza tra pari, dunque la peer
pressure; l’annuncio pubblico dei paesi che divergono da una normativa comune con il
metodo del name and shame; infine, gli incentivi finanziari.
La peer pressure è il metodo maggiormente applicato dal Comitato di Basilea, laddove
essa ha più possibilità di successo quando è applicata ad una comunità di paesi che
condividono già in partenza alcune caratteristiche strutturali e culturali. Il name and shame
è, invece, certamente un metodo più severo, dato che espone all’opinione pubblica i paesi
o le imprese finanziari che non rispettano alcuni codici comportamentali, facendo quindi
un forte danno d’immagine, quindi economico, al deviante. Ad esempio, l’FSF ha
pubblicato, nel marzo del 2001, una serie di centri finanziari, i cosiddetti paradisi fiscali,
che attraggono fondi proprio per via della loro leggera regolamentazione finanziaria
molto e di un livello di tassazione molto basso. Infine, per quanto riguarda gli incentivi
finanziari, uno dei metodi più ovvi è includere gli standard elaborati a livello
internazionale all’interno dei criteri di condizionalità con cui l’FMI vincola i suoi aiuti
finanziari.
Se, dunque, la soft law e il sistema di incentivi su cui essa si pone sembrano costituire
un edificio precario su cui basare la vigilanza sulla stabilità finanziaria e sulla libera
circolazione di capitali, va ricordato che sia il Comitato di Basilea che il Foro sono sorti al
fine di ovviare all’assenza, all’interno degli Articles of Agreement del Fondo Monetario
Internazionale, di qualsiasi riferimento a compiti di vigilanza sulla stabilità dell’organismo
più importante a livello mondiale nel settore finanziario.
4.2 Il mercato dei derivati e gli hedge fund
43
Il processo di rapida crescita della finanza internazionale iniziato negli anni Ottanta e
proseguito poi con ritmi sempre maggiori fino al nuovo millennio ha avuto certamente
nello strumento finanziario dei derivati la sua più importante innovazione tecnologica,
nonché il simbolo della finanziarizzazione contemporanea. Deve tuttavia essere
osservato che il prodotto derivato non è in sé un’invenzione recente, essendo negoziato
almeno fin dagli inizi dell’Ottocento come sorta di titoli assicurativi che permettevano al
venditore e al compratore di fissare un prezzo per una compravendita futura tutelandosi
da una sua possibile variazione a causa di eventi esterni, come il clima o le carestia.
Nella seconda metà del Novecento, in particolar modo nell’ultimo quarto del secolo,
essi si sono tuttavia profondamente trasformati. Gli strumenti finanziari derivati moderni
sono infatti particolari tipologie di contratto o titoli il cui valore dipende – deriva,
appunto – dall’andamento del valore di mercato di un’altra attività sottostante, nota come
underlying asset. Quest’ultima può essere costituita da un’attività finanziaria, come i tassi
d’interesse o le valute; da un’attività reale, come ad esempio le materie prime, nel caso si
parla di commodity derivatives; da un evento complesso, come la solvibilità di un
determinato gruppo di creditori o di uno Stato; infine, da un evento atmosferico, che dà
luogo ai cosiddetti weather derivatives.
La particolarità degli strumenti derivati è dovuta alla loro caratteristica di non
raccogliere risorse sui mercati in cambio di un rendimento, come nel caso dei titoli
azionari o delle obbligazioni, ma rappresentano una forma di gestione, o di speculazione,
rispetto al rischio. Si rintracciano tre utilizzi principali degli strumenti derivati: il primo è
quello di copertura da un rischio finanziario, detta hedging; il secondo è l’arbitraggio,
dunque acquistare un prodotto in un mercato e rivenderlo ad un prezzo maggiore in un
secondo mercato; il terzo è l’utilizzo puramente speculativo.
I derivati possono essere racchiusi in due grandi categorie: quelli simmetrici e quelli
asimmetrici. Nel primo caso sia l’acquirente che il venditore sono obbligati dal contratto
ad effettuare una certa prestazione alla data pattuita, mentre nei contratti asimmetrici è
solamente il venditore che si trova nella posizione di soddisfare le volontà del
compratore, il quale tuttavia quest’ultimo ha anche il diritto di decidere se concludere o
no la compravendita dell’attività sottostante.
Utilizzati come strumento finanziario di copertura del rischio, i prodotti derivati
vengono solitamente stipulati per controbilanciare i rischi insiti in una posizione lunga,
come ad esempio l’acquisto di una certa quantità di materie prime a tre mesi, attraverso
un contratto derivato che, mediante il pagamento di un premio, possa impegnare un
secondo soggetto a riacquistare la stessa quantità di merce ad un prezzo poco superiore a
quello fissato nel primo contratto. In tal modo l’impresa che deve acquisire grano si
tutela dal rischio di un deprezzamento della materia prima in oggetto. Questi contratti
sono dunque prodotti derivati nel senso che essi, pur avendo un loro mercato,
dipendono nel loro valore da variazioni del prezzo del bene sottostante, che determina
quindi eventuali guadagni e perdite
Proprio per questa caratteristica, il prodotto derivato si presta ad un forte utilizzo
speculativo, soprattutto stante la caduta dell’obbligo di acquisto o vendita del bene
sottostante. Come dimostrato dagli eventi degli ultimi quindici anni, gli strumenti derivati
sono stati contrattati sempre più spesso per garantirsi, con un investimento minimo, un
enorme guadagno giocando, ovvero scommettendo, sulla variazione del prezzo
44
dell’attività sottostante, che ricordiamo può non essere una merce ma piuttosto titoli
azionari, obbligazioni del debito pubblico, valute o tassi d’interesse.
Lo speculatore sfrutta, così, il cosiddetto effetto della leva finanziaria – il leverage – che
consiste nel prendere impegni a comprare e vendere, contando su un arbitraggio sul
prezzo, investendo somme di capitale che ammontano a percentuali contenute rispetto al
valore del sottostante, solitamente oscillanti tra il 2% e il 7%. Contando su un aumento
del prezzo del valore dell’attività sottostante, lo speculatore acquisterà opzioni call, il cui
prezzo è un percentuale minima rispetto al prezzo dell’attività sottostante, che lo
impegnerà a comprare quell’attività ad un determinato prezzo ad una determinata data,
scommettendo che, in quella data, l’attività medesima potrà essere rivenduta ad un
prezzo che sarà aumentato nel periodo intercorso tra l’acquisto dell’opzione e
l’effettuazione della compravendita.
I moderni prodotti derivati apparvero per la prima volta nel 1972 sulla piazza
finanziaria di Chicago, seconda solo a New York per importanza negli Stati Uniti ma
primo mercato a termine del mondo in funzione del Chicago Board of Trade e del
Chicago Mercantile Exchange, due grandi mercati delle merci. La prima esperienza di
contratti derivati, l’International Monetary Market, venne inaugurata nella capitale
dell’Illinois con contratti sulle valute come garanzie contro le fluttuazioni dei cambi esteri
successive allo sganciamento del dollaro dall’oro dell’anno precedente e dunque all’inizio
della fine del sistema a cambi fissi di Bretton Woods.
L’iniziativa fu ripresa l’anno successivo, nel 1973, quando nacque il Chicago Board
Options Exchange, dove si negoziavano opzioni derivate su titoli azionari, mentre
l’International Monetary Market cominciò ad introdurre, nel 1975, i primi strumenti
derivati che avessero come attività sottostante i buoni del Tesoro statunitensi, dunque i
primi basati sui tassi d’interesse. Nuovi mercati dei derivati vennero aperti negli anni
successivi a New York, dove venne fondato nel 1980 il New York Futures Exchange, e
poi in Europa, in primo luogo nella City di Londra, dove nel 1982 aprì i battenti il
London International Financial Futures Exchange (LIFFE). Pochi anni dopo fu la volta
di Parigi, dove aprì il Marché à Terme des Instruments Finaciers nel 1986, seguita da
Zurigo con lo Swiss Options and Financial Futures Exchange del 1986 e il Deutsche
Term Borse a Francoforte nel 1990. Questi ultimi due sarebbero poi stati fusi nell’Eurex,
nel 1998, che, inglobando anche il LIFFE inglese nel 2002, nel 2003 divenne la principale
piazza per la negoziazione di contratti derivati.
Tuttavia, se l’investimento di capitale proprio è molto basso rispetto ai possibili
guadagni derivanti da un apprezzamento dell’attività sottostante, il rischio opposto,
ovvero se il bene su cui è basato il contratto derivato si deprezza, è quello di subire
enormi perdite, dovute sostanzialmente al fatto che l’investimento è effettuato
sostanzialmente ricorrendo all’indebitamento per una larga parte dell’ammontare
dell’investimento stesso.
A partire dagli anni Novanta la creazione di prodotti derivati sempre più specifici,
quindi sempre più slegati dalla economia reale e con capacità di influenzare il prezzo di
un determinato bene, ha fatto si che l’ammontare complessivo del valore nominale dei
derivati nel mondo fosse, nel 2007, pari a 750.000 miliardi di dollari, mentre il PIL
globale, nello stesso anno, era di 57.000 miliardi di dollari. La sproporzione evidente,
dunque, rappresenta lo scollamento avvenuto tra finanza e produzione, iniziato negli anni
Ottanta.
45
Già però nei due decenni precedenti la crisi del nuovo millennio, i rischi annessi alla
speculazione attraverso i derivati avevano determinato, alternativamente, le fortune e le
sfortune dei nuovi fondi a gestione alternativa, i cosiddetti hedge fund, che apparvero nel
corso degli anni Ottanta specializzandosi in operazioni a breve, spesso attraverso l’uso
massiccio di contratti derivati mediante il meccanismo della leva finanziaria. Questi fondi,
inoltre, mantengono la propria sede in un centro offshore, sono organizzati sotto forma di
fondi chiusi, dunque con scarse possibilità di uscita, e garantiscono elevate gratifiche ai
loro gestori, che spesso investono il proprio capitale nel fondo stesso.
Gli hedge fund crebbero molto rapidamente soprattutto nel corso degli anni Novanta,
quando passarono dai 2000 del 1990 agli 8000 circa nel 2003, con un parallelo aumento
anche dei fondi gestiti, che divennero 750 milioni di dollari sempre nel 2003 contro i 60
di un decennio prima. Uno dei più famosi fondi d’investimento di questa tipologia è
certamente il Quantum Fund inizialmente fondato dal finanziere George Soros nel 1969,
con sede a Curaçao, nelle Antille Olandesi e alle Isole Cayman. Il fondo di Soros divenne
molto famoso nel 1992 quando egli riuscì, con una massiccia vendita di sterline contro
marchi iniziata il 15 settembre, a «rompere la Banca d’Inghilterra», come disse l’opinione
pubblica, forzando di fatto una svalutazione della valuta inglese il 16 settembre e
un’uscita della stessa dallo SME. Con questa operazione si calcola che Soros guadagnò, in
un solo giorno, un miliardo di dollari, continuando le sue fortune anche in futuro con un
rendimento del 100% annuo.
Tuttavia, al fianco dei grandi successi si sono registrati anche enormi fallimenti degli
hedge fund. Il Long-Term Capital Management (LTCM), infatti, fondato nel 1994 da John
Meriwether, precedentemente alla Salomon Brothers, fu colpito, dopo tre anni di grandi
profitti, dalle inadempienze del governo russo nel pagamento dei proprio debiti e si trovò
sull’orlo della bancarotta nel settembre del 1997, quando venne salvato solamente da un
intervento della Federal Reserve, che si attivò in quanto temeva le ripercussione che un
fallimento dell’LTCM avrebbe avuto sui mercati finanziari.
Dunque, grazie all’introduzione dei moderni strumenti finanziari derivati, è stato
possibile, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, negoziare separatamente i diversi
rischi generati da un investimento, di qualsiasi tipo, finanziario o reale, raggiungendo
quella che è stata definita come una mercificazione del rischio. Il nuovo concetto
consentì la creazione di prodotti finanziari sempre più particolareggiati sull’investitore,
ma al contempo sempre più indipendenti dalle caratteristiche dell’investimento che ha
generato i rischi, la cui effettuazione passa in effetti in secondo piano rispetto ad un
mercato, quello appunto dei derivati, che genera, da sé, profitti o perdite.
4.3 Le valute di riserva del Fondo Monetario Internazionale
Come ricordato nel capitolo precedente, per far fronte ai crescenti problemi di
liquidità internazionale del dollaro degli anni Sessanta, con gli accordi di Giamaica
all’interno del Fondo Monetario Internazionale, siglati il 28 luglio del 1969, vennero
introdotto i Diritti Speciali di Prelievo (DSP), una sorta di valuta internazionale
collocabile al bisogno dall’FMI presso le banche centrali dei paesi richiedenti ulteriori
liquidità. Lo scopo delle autorità monetarie internazionali era, in tal modo, far fronte alla
richiesta di liquidità delle crescenti economie mondiali senza far ricadere il peso su
un’unica valuta, il dollaro statunitense, e sfuggire così in questo modo al dilemma Triffin.
46
Inizialmente il valore dei DSP era fissato a 1:1 con il dollaro statunitense, dunque era
pari a 0,88 grammi d’oro, ma dopo la fine della convertibilità aurea della valuta
americana, nel 1973 si passò ad un paniere di valute – nel gergo tecnico del Fondo le
Freely Usable Currencies – per stabilire il valore dei DSP. Queste valute venivano definite,
nell’articolo XXX comma (f) degli Articles of Agreement, come quelle maggiormente usate
nei pagamenti per le transazioni internazionali e maggiormente scambiate sui mercati
internazionali delle valute, senza alcun riferimento, quindi, alla possibilità di fluttuazione
o meno delle valute scelte nel paniere di base. Anche i prestiti dell’FMI, dunque,
sarebbero avvenuto in queste Freely Usable Currencies, in quanto questi finanziamenti erano
destinati ad aiutare i paesi richiedenti per rimettere in pari la bilancia dei pagamenti,
quindi dovevano essere usati principalmente per le transazioni internazionali.
Proprio a causa di queste caratteristiche, intrinsecamente mutevoli nel tempo, la
composizione del paniere era prevista già in origine, come in effetti fu, soggetta a
cambiamenti che avrebbero rispecchiato i cambiamenti a livello produttivo e
commerciale delle economie mondiali. Da qui la necessità di prevedere una revisione
della composizione del paniere, sia rispetto alle percentuali interne di ciascuna moneta,
sia rispetto all’ingresso di nuove valute, con cadenza quinquennale.
Dal 1974 al 1981, il paniere che costituiva il valore dei DSP era composto dalle sedici
valute emesse dai sedici Stati con le maggiori quote d’esportazioni al mondo. Nel 1980 il
paniere fu ulteriormente aggiornato e venne costituito, fino alla nascita dell’euro nel
1998, dal dollaro statunitense, dal marco tedesco, dal franco, dalla sterlina e dallo yen
giapponese, con quote che venivano riviste ogni cinque anni, ma che si mantennero su
percentuali relative stabili, con il dollaro a costituire la moneta più rilevante, per il 3942% del paniere tra il 1981 e il 1998, il marco tra il 19% e il 21% e le altre tre valute tutte
oscillanti sul 10%.
Con l’entrata in vigore della nuova moneta unica europea, che andò a rimpiazzare il
marco e il franco, vi fu anche la modifica del paniere delle valute di riserva ufficiali del
Fondo Monetario Internazionale, che erano costituite, al 2009, per il 44% da dollari, per
il 34% da euro, 11% per la sterlina e un altro 11% per lo yen, riflettendo dunque la nuova
situazione monetaria ed economica che si era venuta a creare con la nascita dell’Unione
Europea e dell’euro.
Oltre all’ingresso dell’euro in sostituzione di franco e marco, nel 2000 il Board del
Fondo decise anche per una leggera revisione dei criteri di composizione del paniere delle
riserve di valuta per la definizione del valore dei DSP. Fermo restante il concetto di Freely
Usable Currencies, venivano ora ammesse, come appunto nel caso dell’euro, valute emesse
da Stati o unioni monetarie che ricoprissero le maggiori quote delle esportazioni mondiali
nell’ultimo quinquennio. Nel primo quindicennio del nuovo millennio il peso dell’euro è
progressivamente cresciuto, passando dal 32% del 1999 al 37% del 2015, soprattutto a
spese dello yen giapponese, che passò dal 18% del peso nel paniere registrato nel 1999 al
9% del 2015.
La composizione del valore dei DSP riflette, dunque, i mutamenti monetari ed
economici che avvengono a livello mondiale. In questo contesto è interessante notare
come un ultimo grande cambiamento sia avvenuto il 1 ottobre del 2016, quando il Fondo
ha ammesso la valuta cinese, lo yuan, tra le valute di riserva e nel paniere dei DSP,
riconoscendo da un lato l’enorme volume delle esportazioni cinesi dell’ultimo
47
quinquennio, e dall’altro certificando che le autorità cinesi avevano raggiunto gli standard
monetari necessari per essere integrati nell’economia mondiale attraverso l’azione del
Fondo. Lo yuan è, attualmente, pari al 10,9% del paniere, togliendo quote
rispettivamente all’euro (-6,5%), alla sterlina (-3.2%) e allo yen giapponese (-1,1%).
48