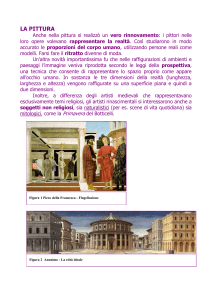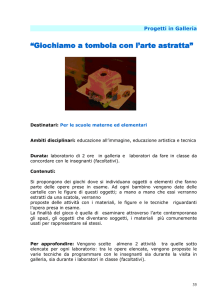Labirinti esistenziali
Conversazione con Dario Ballantini
a cura di Nicola Davide Angerame
Colori accesi, pennellate violente, sensibilità incandescente, iconografia tesa alla denuncia: la
tua pittura sembra fatalmente attratta dall’Espressionismo…
Prima, però, fra i miei ricordi d’infanzia viene mio padre, che mi spiegava perché quel viso di
Picasso era fatto così. Il mio primo innamoramento verso questo genere di artisti c’è stato a scuola,
così come ho seguito con interesse il discorso atipico di Modigliani, artista di Livorno che mi
attraeva in adolescenza anche per la sua vita di artista maledetto. Negli anni adolescenziali è tipico
condividere quella disperazione che lui ha vissuto, credo. Un sentire che poi ti trascini nella vita. A
scuola ho imparato e studiato tutti i tipi di arte ma sono rimasto innamorato di questi grandi esempi.
Nella tua produzione non mancano mai i volti, una fascinazione che subisci da sempre?
Io ho sempre studiato e ritratto i volti, fin dall’infanzia. Da quando disegnavo fumetti o facevo
scarabocchi sui diari, che colmavo di visi ed espressioni. La mia è una passione per la bellezza del
volto. Non ho mai fatto opere dove non ci fosse un essere umano.
Sono volti ma sono anche maschere. Possiedono fattezze “negre”, robuste e primitive come
quelle delle maschere. Ci leggo quasi un omaggio alla negritudine di primo Novecento, quella
dei primi scrittori africani anticolonialisti e che ha fatto innamorare l'Europa di Josephine
Baker, senza contare il debito di Picasso... Cosa leggi nei volti?
Tante cose. È una mia passione atavica, che alimenta anche l’altra mia attività. Io sono un lettore di
volti. E' vero, i miei volti sono anche maschere, perché ciascun volto lo è in fondo. La maschera
svela il dramma dell’esistenza mentre cerca di coprire la debolezza umana. E quando leggi la
maschera è ancora peggio.
Mi fai venire in mente la straordinaria poetica di Luigi Pirandello: uno, nessuno e
centomila...
Lo avrei citato ora. Io conosco molto bene Pirandello, poiché mio fratello, che è un appassionato
maniacale della sua opera, mi ha passato i libri. Nella maschera c’è questa verità filosofica e c’è il
teatro. In passato ho anche collezionato maschere africane. Mi hanno sempre attratto, ma non so
perché.
La tua arte si potrebbe definire una ritrattistica mascherata. Ci vedo, ribaltata di 180 gradi,
l'idea ossessiva di Rembrandt di rivolgere la propria pittura verso se stesso, producendo la
più vasta e significativa autoritrattistica della storia dell'arte. Tu lo fai per interposti
personaggi, ma alla fine quelle maschere sono le tue...
Le maschere vengono fuori da sé. Sono sempre venute, già dai primi anni di lavoro, quando a
Livorno ero accusato di essere triste e macabro. Ma credo che i miei personaggi possano essere
piuttosto definiti come maschere tragicomiche. Erano facce che io attingevo dal fumetto. Una volta
Vittorio Sgarbi ha detto che sono un incrocio tra Picasso e i Simpson. Mi pare vero. Se guardi gli
occhi dei miei personaggi ti accorgi che sono vicini a quelli di Matt Groening: in fondo si rivelano
disperati, tristi e tragicomici. Non ho mai saputo farli diversamente.
Nella tua produzione c’è spesso la città in sottofondo. Che rapporto hai con lei?
Io ho avuto un’esperienza direi negativa con le città. Ora questo modo di viverle è un po’
scomparso, ma ritengo che la città sia una costruzione dell’uomo che mi ha sempre un po’
angosciato. I palazzi, ad esempio, li ho sempre identificati come luoghi in cui le vicende umane
scorrono e si alternano mentre loro rimangono lì a fissarti con le finestre che sembrano tanti occhi.
Dentro di loro la vita delle persone trascorre e passa. E loro restano lì, minacciosi. I paesaggi
industriali invece sono per me il simbolo dell’alienazione dell’uomo rispetto ad un progresso
forzato. Se vuoi, si può affermare che nella mia pittura realizzo un “futurismo alla rovescia”. Invece
di inneggiare alla macchina la esalto come causa della decadenza dell’essere umano.
Eppure, ribaltando il discorso, si potrebbe sostenere che, a differenza della tetra
rappresentazione che ne ha dato Mario Sironi, la tua città è sì opprimente e incombente, ma
viene tratteggiata con una tale esplosione cromatica, e con una graffiante paletta post fauvista,
che si direbbe essere una città vitale, luminosa, sgargiante, piena di rumori e di vita. Lo si
vede bene ne “Il giorno davanti” (2006) o in “Ferma un attimo” (2007).
Senz’altro quello che mi ha spaventato della metropoli è anche quello che mi ha affascinato e che
mi ha permesso di attuare una svolta professionale. Soltanto con il mio trasferimento a Milano, e
soltanto nel confronto con le persone che la città ha reso possibile, ho realizzato quanto desideravo.
Quello che sono professionalmente lo devo alla metropoli. Vi si fa un vita diversa, una vita che
cerco disperatamente di evidenziare nei miei colori e che coinvolge la vitalità e l’angoscia
provocata dall’urbanizzazione selvaggia. La città è un coacervo di stimoli ma è anche una pressa.
Per quel che mi riguarda, sono uscito bene dal rapporto con la città, ma non ci si può nascondere
che la sua nascita abbia cancellato tante cose, nel mio passato come in quello delle persone che un
tempo, prima di noi, trovavano nella dimensione paesana altri nuclei di aggregazione, ormai
scomparsi.
Lo racconta bene il film di Fritz Lang “Metropolis”: la città che macina esseri umani ridotti a
schiavi senz’anima a persone de-individualizzate. Ma la città è anche una risposta. Italo
Calvino ha scritto: “D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta
che dà a una tua domanda”.
La metropoli offre anche una buona occasione a certi individui di mostrare la forza dell’essere
umano. In queste condizioni vengono fuori i messaggeri di qualcosa di più alto, anche se
tristemente la maggior parte soccombe.
Vorrei parlare di alcune opere selezionate per questa mostra: dopo molti anni di produzione
rivolta alla tematica della figura immersa o pressata nella città, Due mondi (2009) lascia da
parte lo sfondo urbano, che si trasforma in pura pittura d’azione, brutale e divertente come
quella di un maestro assoluto come Jean Dubuffet.
Quella dell’Art Brut era un direzione che mi suggeriva tempo fa Achille Bonito Oliva. Ma io non
considero i miei quadri un divertimento per il pubblico, anche se per me lo sono. Mi diverte usare
una pittura “brutta” o “brutale”, mi affascina deformare i volti e le cose, ma lo faccio più per
riflesso o per istintivo. Non seguo uno stile specifico già codificato dalla storia dell’arte.
I titoli delle tue opere sono spesso evocativi, sembrano frammenti caduti da un discorso
interiore oppure con un “tu” così intimo da far pensare ad una relazione esclusiva, alla quale
lo spettatore viene ammesso affinché conosca la propria distanza. Ad esempio, nell’opera
“Cosa ho visto” (2008), l’uomo si tiene con le mani il capo. Ricorda “L’urlo” di Munch. La
domanda è: che cosa hai visto?
Ho visto quanto può diventare abisso il vivere umano e quale direzione sbagliata può prendere.
Anche se in fondo è riferito a un mio vissuto personale, riguarda tutta l’umanità. Il quadro ritrae un
grido muto di spavento ed è una esortazione a non finire nell’abisso. È il rischio del libero arbitrio,
dal quale voglio metter in guardia. Grazie a lui si possono commettere atti sublimi o miserrimi.
Nelle tue opere c’è spesso un singolo personaggio oppure una coppia. Mai più di due persone,
come se la dimensione della comunità, della vita sociale intesa come aggregazione di più
persone, fosse uno scenario a te estraneo. Tanto più singolare in quanto la tua seconda natura
ti dichiara “personaggio pubblico”. In “Dalla tua parte” (2009) una coppia si mostra intenta
in una delicata relazione.
La mia scelta, come tu hai appena fatto notare, ha a che fare con le relazioni in generale, che ritengo
debbano essere preziose, quasi segrete, intime e approfondite. È bello il dialogo fra due amici, fra
persone con le medesime affinità. Se le persone sono tre è già troppo. Puoi scoprire che uno si
distrae, guarda da un’altra parte. Siamo soli al mondo, va tenuto presente, ma sento che su certi
argomenti, sulle affinità come dicevo, ci si può ritrovare e unire. Ciò vale tanto più per il singolo,
per il quale il dialogo può avvenire tra le diverse sfaccettature della sua personalità. Anche se ci
illudiamo di essere un tutt’uno non possiamo fare a meno di essere una molteplicità in cerca di
dialogo con se stessa.
Un dialogo non sempre risolutivo...
Un dialogo destinato a fallire spesso. L’angoscia dell’isolamento credo che dipenda dalla esigua
possibilità di aiutare se stessi, di farcela da soli con la propria personalità, con le proprie forze.
Nella mia pittura voglio rendere meno drammatico questo aspetto.
Parliamo ancora dei titoli delle tue opere. Sono evocativi, ma anche indeterminati. Lasciano lo
spettatore sull’uscio eppure lo chiamano dentro un tentativo di relazione tra lui e te...
Non so cosa sia l’arte, ma so che deve emozionare. L’arte attinge ad un mondo un po’ inspiegabile.
Grazie al titolo io posso dialogare con l’opera, dando al pubblico un’indicazione di ciò che ho
sentito al termine della realizzazione. Uso molto distacco. Un collega mi disse che avrei dovuto
scrivere in grande i titoli su ciascuna opera, ma per me il titolo deve restare un suggerimento.
Altrimenti impedisce a chi guarda di trovare la propria interpretazione.
Veniamo alla tua multipla identità. Come dialogano il pittore con l'attore, il trasformista e
l'imitatore?
Le mie due attività sono sempre state parallele, ma ho rinforzato quella di trasformista perché in
essa c’era una maggiore facilità. Era più appagante essere capito. Arrivavo da una situazione in cui
ero un pittore a Livorno macabro e triste, che nessuno capiva bene cosa volesse dire, mentre l’altra
attività risultava più facile e remunerativa. Era più immediato far scattare la risata. Tutto si basava
su qualcosa di meno imprevedibile. Con la pittura mi era sorto una specie di senso di colpa. Quando
non hai la risposta del pubblico significa che hai sbagliato tu e per una persona sensibile può
rappresentare una crisi. Fortunatamente, grazie al supporto di Massimo Licinio ho ricominciato a
dipingere e oggi la pittura occupa un ottimo posto all’interno della mia vita quotidiana. Mi è tornata
una gran voglia di creare, che ricordo di avere da quando ero piccino. Era un desiderio che avevo
addirittura dalle elementari. Alle medie riempivo i miei diari di facce. Molti saranno esposti nella
mia retrospettiva alla Triennale di Milano, subito dopo la mostra di Alassio. La necessità di
disegnare volti è per me una ossessione. Ora che c’è la risposta del pubblico e l’apprezzamento
della critica, la mia ossessione non ha più ostacoli.
Se ho ben capito, quindi, la tua attività di esuberante imitatore, conosciuto e amato da milioni
di persone, nasce in realtà dal silenzio della pittura, dalla solitudine contemplativa dello
studio, tra tele, colori e pennelli. Una vecchia storia, come quella della maschera del clown,
che ne cela la personale angoscia esistenziale, che deve piangere per far ridere...
Sì, nasce da lì la mia attività di trasformista. Studio le facce per lavoro, ma lo faccio con tutte le
persone che incontro. Nella pittura quei volti ritornano assorbiti nei tratti essenziali. Osservare le
rughe d’espressione o la luce degli occhi è un esercizio infinito.