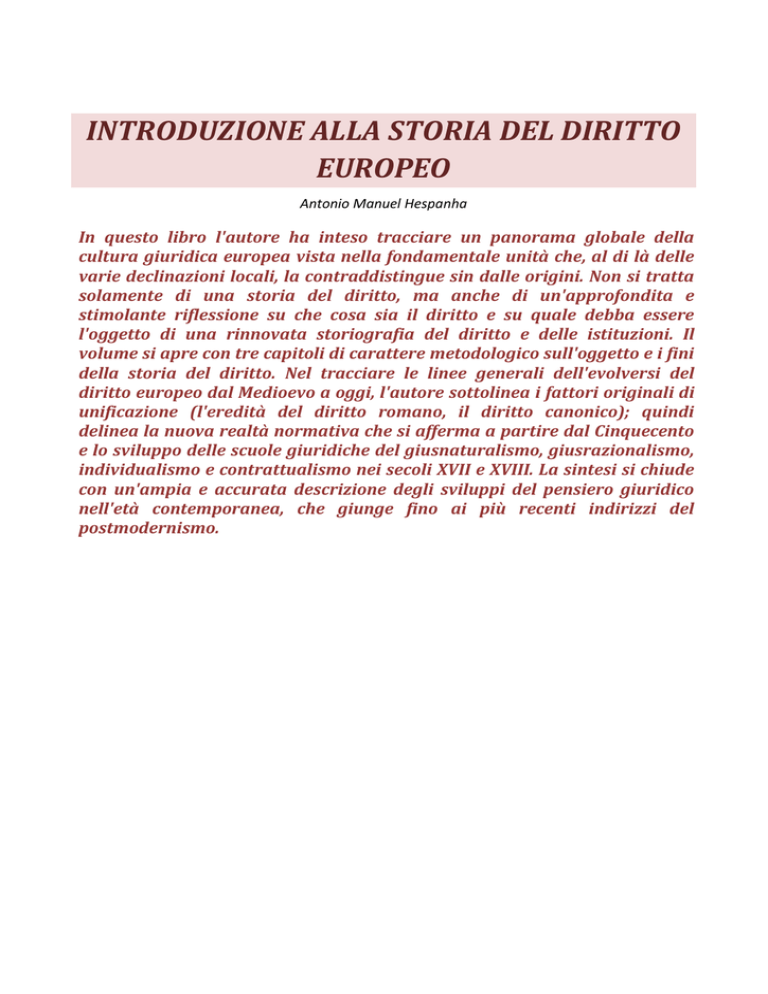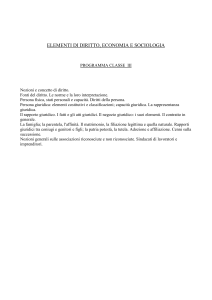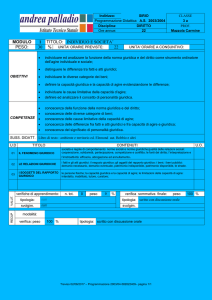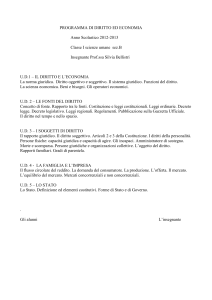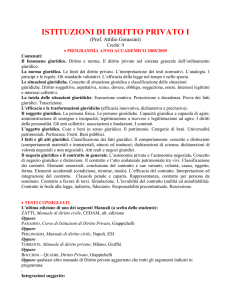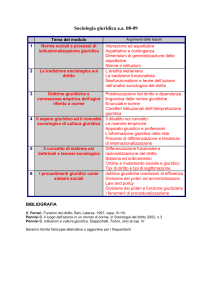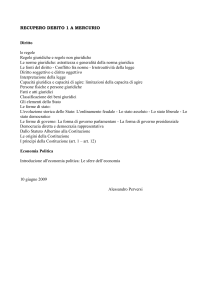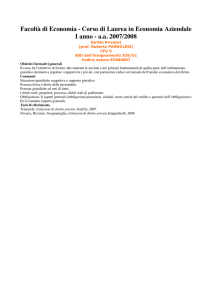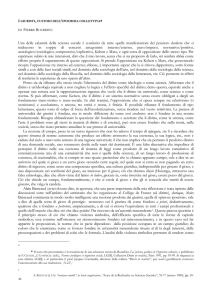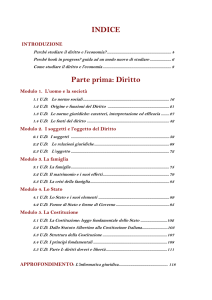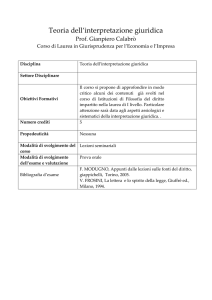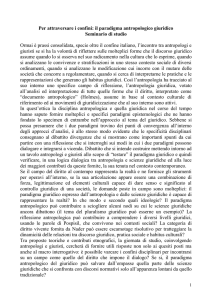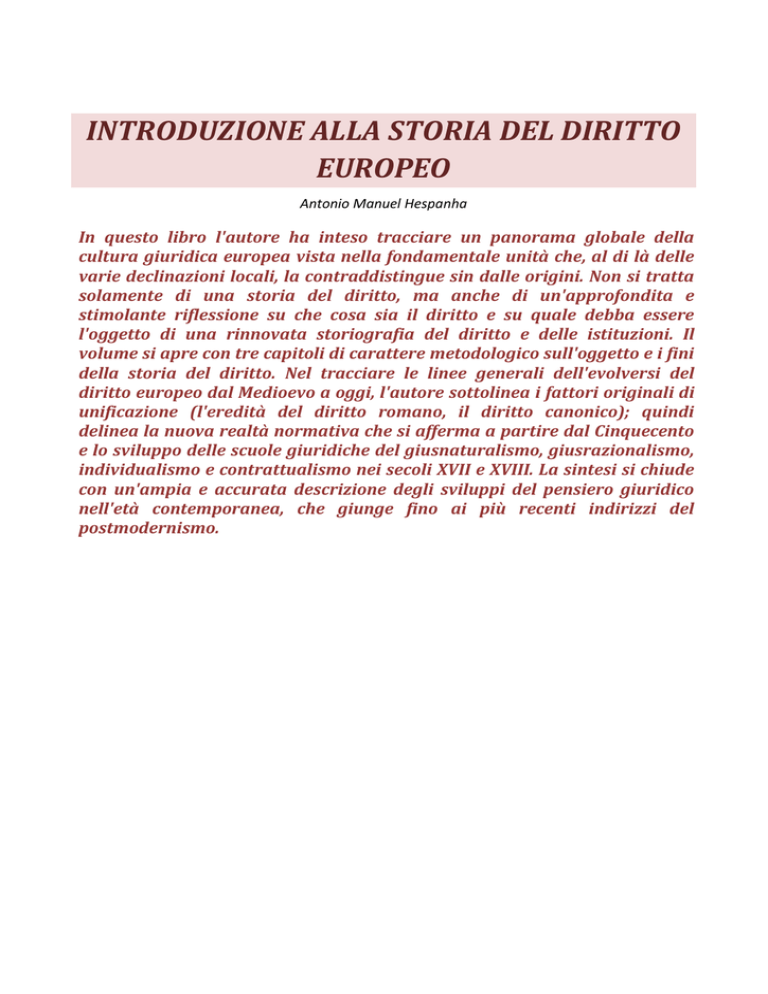
INTRODUZIONE ALLA STORIA DEL DIRITTO
EUROPEO
Antonio Manuel Hespanha
In questo libro l'autore ha inteso tracciare un panorama globale della
cultura giuridica europea vista nella fondamentale unità che, al di là delle
varie declinazioni locali, la contraddistingue sin dalle origini. Non si tratta
solamente di una storia del diritto, ma anche di un'approfondita e
stimolante riflessione su che cosa sia il diritto e su quale debba essere
l'oggetto di una rinnovata storiografia del diritto e delle istituzioni. Il
volume si apre con tre capitoli di carattere metodologico sull'oggetto e i fini
della storia del diritto. Nel tracciare le linee generali dell'evolversi del
diritto europeo dal Medioevo a oggi, l'autore sottolinea i fattori originali di
unificazione (l'eredità del diritto romano, il diritto canonico); quindi
delinea la nuova realtà normativa che si afferma a partire dal Cinquecento
e lo sviluppo delle scuole giuridiche del giusnaturalismo, giusrazionalismo,
individualismo e contrattualismo nei secoli XVII e XVIII. La sintesi si chiude
con un'ampia e accurata descrizione degli sviluppi del pensiero giuridico
nell'età contemporanea, che giunge fino ai più recenti indirizzi del
postmodernismo.
CAP. I – LA STORIA DEL DIRITTO NELLA
FORMAZIONE DEI GIURISTI
Come tutte le discipline giuridiche anche la storia del diritto è un sapere formativo,
ma a differenza delle altre discipline dogmatiche non mira a creare certezze
riguardo al diritto vigente, bensì a problemizzare il presupposto implicito e acritico
di queste discipline e cioè che il diritto è razionale, necessario e definitivo.
La storia del diritto realizza questo compito situando il diritto nella “società”, di
talché anche le soluzioni giuridiche sono connesse con un dato ambiente e in questo
senso sono anch’esse sempre locali.
La storia del diritto svolge questa funzione critica in luogo di altre discipline, quali la
sociologia o l’antropologia giuridica, che non sono accolte nelle facoltà di
giurisprudenza in quanto – a detta dei giuristi - potrebbero trasformare lo studio
delle norme, di cui il giurista dovrebbe occuparsi in maniera esclusiva, in uno studio
dei fatti sociali.
Poiché l’idea della rigorosa separazione tra i fatti e le norme, provieniente dalla
teoria giuridica del Novecento, continua a formare il nucleo dell’ideologia spontanea
dei giuristi, l’intromissione del sapere sociale empirico nel mondo dei valori
giuridici è ancora largamente considerate inaccettabile.
La storia del diritto come discorso legittimante
La storia del diritto può svolgere un ruolo opposto a quello delle scienze sociali, e
cioè può contribuire a legittimare il diritto statuito: in effetti il diritto è già di per sé
un sistema di legittimazione perché induce all’obbedienza coloro la cui libertà viene
limitata dalle norme. Tuttavia anche il diritto ha bisogno di essere legittimato, cioè
richiede che si formi un consenso sociale sul fondamento della sua obbligatorietà.
Già Max WEBER (1864-1920) aveva ricondotto la legittimazione dei poteri politici a
vari insiemi di credenze, orbitanti intorno a valori come la tradizione, il carisma e la
razionalizzazione. Nel mondo giuridico, la legittimazione ad opera della tradizione
opera soprattutto attraverso argomentazioni di carattere storico: infatti, la storia del
diritto ha svolto un ruolo legittimante durante un lungo periodo della storia europea.
Nell’Ancien Régime il diritto giusto veniva identificato nel dirittto statuito e
lungamente praticato, come i costume consolidati (“prescritti”), l’opinione degli
specialisti, le pratiche di routine (gli stili dei tribunali), i diritti acquisiti (iura radicata).
L’argomento storico svolgeva dunque un ruolo decisivo nelle soluzioni giuridiche.
Anche oggi si ricorre alla storia giuridica per definire l’identità giuridica e politica
della nazione. La filosofia giuridica tedesca all’inizio del XIX secolo (cfr. Cap. VII.3.2)
affermava che il diritto sorge dallo “spirito” della nazione, che riposa nelle tradizioni
culturali e giuridiche e la storia giuridica svolgeva quindi una funzione protettiva
dalle innovazioni legislative arbitrarie o comunque antinazionali. Negli anni ’30 e ’40
nel Novecento tali tesi sono state recuperate per reagire contro i principi liberali in
nome dei valori nazionali di giustiza e di benessere (cfr. Cap. VIII.6.1.).
Oggi l’idea del “progresso” ha fatto perdere alla storia giuridica tale funzione di
legittimazione.
D’altronde l’idea dello “spirito nazionale” è difficilmente sostenibile dinanzi
all’evidente pluralismo dei valori delle società odierne.
Comunque, la storia più che descrivere crea (aiuta a capire ma non a spiegare): ciò
che lo storico crede di trovare come “anima di un popolo” è in realtà ciò che egli
stesso pone con le sue credenze e i suoi preconcetti.
Ad ogni modo l’argomento storico può ancora essere inserito nel ragionamento
giuridico con riferimento a diversi aspetti:
In primo luogo, per dimostrare che certe categorie del discorso giuridico, come
lo Stato, il diritto pubblico e privato, la persona giuridica, appartengono alla
“natura delle cose” e derivano dalle categorie eterne della giustizia e della
ragione giuridica. Ciò nonostante, occorre rilevare che molti concetti e principi
giuridici sono più moderni di quanto generalmente si pensi. Infatti, alcuni
concetti esistono da molto tempo con il loro valore facciale, ma a fronte di
tale continuità terminologica esistono rotture nel loro significato semantico:
questo è legato al contesto sociale o testuale di ciascuna occorrenza, per cui il
significato di una parola è sempre relazionale o locale.
Alcuni esempi di questa falsa continuità sono rappresentati dai concetti di:
-
-
-
Famiglia, che nel diritto romano si estende anche ai non parenti – come i domestici
o gli schiavi – e persino ai beni della casa.
Obbligazione, che nel diritto romano era inteso come vincolo giuridico in senso
materialistico, cioè come vincolo del corpo del debitore al debito, tant’è che in caso
di inadempimento le conseguenze ricadevano sul corpo del debitore e sulla sua
libertà (carcerazione per debiti).
Stato (status), parola utilizzata in relazione ai detentori del potere, ma non
conteneva in sé nessuna delle caratteristiche concettuali moderne dello Stato
(esclusivismo e sovranità piena)
Proprietà, che dai romani era intesa come facoltà di “usare e abusare delle cose”,
laddove più tardi la proprietà capitalistica ha escluso la piena libertà di disporre
(esiste solo un uso normale e legittimo dei beni).
La storia giuridica può essere usata nell’ambito di una strategia di
legittimazione diversa, cioè per dimostrare la linearità del progresso: in questa
storia progressiva l’elemento legittimante è il contrasto tra il diritto storico,
rozzo e imperfetto e quello dei nostri giorni, cioè il risultato di un lavoro
cumulativo di perfezionamento. Ma anche questa idea di progressività deriva
dal fatto che l’osservatore legge il passato dalla prospettiva di quanto è
accaduto in seguito, e spesso non guarda a ciò che a causa del progresso non
ha avuto la possibilità di svilupparsi (es. equilibrio dell’ambiente e i sentimenti
di solidarietà sociale): la storia “progressista” promuove una sacralizzazione
del presente ed ha ispirato la c.d. teoria della modernizzazione, che promuove
una politica del diritto basata su un parametro universale di evoluzione.
Le suddette teorie, sia la “naturalizzatrice” sia la “progressista”, si basano su un
diverso modo di raccontare la storia, che viene riportata tramite una prospettiva
deformata da una visione contemporanea degli oggetti e delle questioni specifiche
delle rispettive epoche storiche. Così il presente si impone al passato.
Vincolare il passato all’immaginario contemporaneo non solo non consente di
rispondere ai quesiti del presente, ma conduce ad errori di interpretazione e ad una
incomprensione del diritto storico.
Ad esempio, quando si scorge nell’inviolabilità del domicilio del medioevo – espressione territoriale
del potere domestico – un’anticipazione delle moderne garanzie costituzionali di tutela della
privacy individuale: allora si intendeva proteggere l’autonomia della sfera domestica di fronte alla
sfera politica della “respublica” nell’ambito di un’organizzazione politica pluralistica in cui i poteri
periferici erano in competizione con il potere centrale. Altro errore sarebbe dare alle antiche
istituzioni parlamentari un contenuto di “rappresentatività” nel senso che intendiamo oggi oppure
applicare la sistematizzazione contemporanea del diritto civile nel descrivere il diritto antico.
Infine, sarebbe del tutto assurdo proiettare nel passato le attuali frontiere
disciplinari fra diritto, morale, teologia e filosofia, isolando il primo dai restanti
complessi normativi.
In generale, la rilevata dipendenza dei racconti degli storici dai concetti e dalle rappresentazioni del
presente è stata molto discussa fin dal secolo XIX. Mentre alcuni ritengono che questa sia una
situazione inevitabile che impedisce una conoscenza storica obiettiva, altri ritengono – suscitando
non poche obiezioni - che una lettura “attualizzante” della storia è la condizione perché i fatti
storici ci dicano qualcosa, siano intellegibili, permettano di trarre degli insegnamenti.
Un’ultima strategia legittimante negli usi della storia del diritto è quella che si
rivolge non alla legittimazione immediata del diritto ma a quella dei giuristi
accademici, e del loro ruolo di quotidiano nelle decisioni giuridiche. Una
strategia di difesa di tale ruolo è quella di presentare il verdetto giuridico
come un’opzione puramente tecnica e scientifica, separata dai conflitti sociali
sottostanti. Infatti una storia giuridica formalistica, erudita e aliena dalle
questioni sociali, politiche ed ideologiche, che si occupa solo di ere remote ha
dominato le facoltà giurisprudenziali del continente fino agli anni ’60 del
Novecento: ciò ha contribuito a legittimare per mezzo della scienza
l’immagine dei giuristi esattamente in un epoca di fortissimi conflitti politicoideologici in cui i giuristi dovettero svolgere un’importante funzione
“arbitrale”.
La storia critica del diritto
Per improntare un discorso storico rigoroso e coerente si può far ricorso a due
strategie:
La prima è quella di avere consapevolezza della artificialità della realtà storica
e del carattere poietico (creatore) dell’attività intellettuale degli storici del
diritto che creano i fatti storici, selezionando la prospettiva in relazione alle
radici sociali e culturali di tale processo creativo. Non esiste, infatti, la verità
storica, tant’è che alcuni autori classificano la storiografia tra i generi letterari;
il rigore storico risiende più nella sua coerenza interna che in un suo
adeguamento alla realtà esterna.
La seconda strategia è quella di scegliere come oggetto della storia giuridica il
diritto in società. Questa linea domina la storiografia contemporanea a
partire dalla scuola delle Annales e porta a legare la storia del diritto a quella
dei diversi contesti culturali, sociali e religiosi con i quali e nei quali il diritto
funziona. Tale progetto può essere scomposto in una serie di linee di
orientamento.
2.1
Antistatalismo e autorganizzazione
Secondo una prima linea, il diritto ha un significato esclusivamente
relazionale (o contestuale): infatti esso può essere compreso solo se
integrato negli innumerevoli sistemi normativi che organizzano la vita sociale
(dalla morale alla routine, dalla disciplina domestica all’organizzazione del
lavoro). Si tratta di forme di disciplinamento minimali, persuasive, invisibili
che vivono al livello più basso dei rapporti quotidiani (famiglia, circoli di
amici, routine, intimità, usi linguistici). Possono essere visti come il diritto del
quotidiano, che però manifesta una resistenza che manca alla generalità
delle norme e delle istituzioni del diritto ufficiale.
Questa visione antistatalista di una società autorganizzata in uno schema
pluralistico di ordinamenti giuridici nasce alla fine dell’Ottocento dal pensiero
reazionario (cfr. Cap. IV.2) e viene ripreso anche nel Novecento tanto dalle
correnti antiliberali e antidemocratiche quanto dalle correnti liberali.
Anche la teoria politica più recente è tornata ad un immaginario pluralista
dell’ordine politico, decentrando il diritto ufficiale nell’ambito dei meccanismi
di disciplina della vita quotidiana.
Da qui proviene l’attuale tendenza degli storici del diritto a studiare le forme
più evanescenti e più diffuse dell’ordinamento, in particolare nella società e
nella politica di antico regime, così come a studiare il diritto informale, il
diritto delle comunità rustiche e contadine, l’amore e l’amicizia, la disciplina,
la carità e l’assistenza.
2.2
Il diritto come prodotto sociale
Considerare il diritto “in società” significa non solo valutare il suo ruolo
nell’ambito dei processi sociali ma anche nel considerare la produzione del
diritto (valori e testi giuridici) essa stessa un processo sociale.
L’idea dunque è di collegare il diritto e i suoi effetti con gli spazi sociali
(campi, pratiche discorsive dei giuristi, dispositivi); in ogni caso l’idea è quella
dell’autonomia del diritto rispetto ai momenti non giuridici dei rapporti
sociali.
I valori giuridici sono prodotti una volta e durano nel tempo, tuttavia sono
continuamente (ri)letti e recepiti con significati concordanti col nuovo modo
con cui esso è integrato nell’universo intellettuale ed emozionale del lettore.
Essi subiscono continuamente modifiche di significato che ha sempre quindi
una natura contestuale.
2.3
Contro la teleologia
Una terza linea è quella di insistere sul fatto che la storia del diritto non ha
uno sviluppo lineare, in quanto nella storia c’è discontinuità e rottura: idea
questa che trova il consenso degli storici ma non dei giuristi, che tendono a
ritenere che il diritto sia un’antica tradizione aggregante.
Se si accoglie l’idea della discontinuità il ruolo della tradizione assume
un’altra funzione legata alla natura contestuale (relazionale) del significato
dei valori giuridici, di talché ogni mutamento del contesto del diritto esclude
che il significato sia legato alla tradizione precedente. In altri termini, il diritto
si ri-compone di continuo e nel ricomporsi ricompone la lettura della sua
storia.
A sua volta la tradizione è un fattore di costruzione del diritto attuale, in
quanto il lavoro di produzione dei nuovi effetti giuridici (nuove norme, nuovi
valori, nuovi dogmi) è portato avanti con strumenti ricevuti dalla tradizione:
strumenti istituzionali (istituzioni, ruoli sociali) discorsivi (linguaggio, tecnica,
temi, concetti, dogmi) di comunicazione (biblioteche, reti). E’ in questo modo
che il passato modella il presente, non attraverso l’imposizione di valori e di
norme, ma mettendo a disposizione una gran parte degli utensili sociali e
intellettuali con cui sono prodotti i nuovi valori e le nuove norme.
E se il passato non può essere letto nella prospettiva di quanto è accaduto
dopo il passato è liberato dal presente e la sua logica e le sue categorie
guadagnano spessore e autonomia.
CAP. II – LA STORIA ISTITUZIONALE COME
DISCORSO STORICO
La storia giuridica ed istituzionale recupera oggi terreno come disciplina storica, in
relazione alla centralità e all’onnipresenza assunta dal potere e dalla politica.
Infatti la teoria politica medievale e moderna è espressa fondamentalmente con i
termini della teoria giuridica: l’idea che la società e la stessa vita fossero costruzioni
giuridiche aveva impregnato persino la cultura popolare. Se per i letterati la teoria
politica era contenuta nella teoria della giurisdizione, per i profani la manifestazione
più visibile del potere era l’amministrazione della giustizia. Per questo il processo e i
tribunali erano considerati il modello più fedele dell’esercizio del potere politico. Le
situazioni sociali – patrimoniali, ma anche personali, come la gerarchia e il titolo –
erano regolate giuridicamente (come iura quaesita o iura radicata, diritti quesiti o
radicati) e potevano essere oggetto di ricorso giudiziario.
La centralità del diritto si spiega con la stretta relazione esistente fra l’ordine
giuridico e gli altri ordini normativi: il primo sistema quasi giuridico era la religione e
il diritto divino (ius divinum) – derivante direttamente dalla rivelazione – era così
integrato nel diritto secolare (ius civile) che quest’ultimo non poteva contrastare i
comandamenti del primo. Ne scaturivano le limitazioni etico-religiose del diritto
secolare e la confusione tra crimine e peccato: in sintesi, la religione legittimava il
diritto secolare, quest’ultimo proteggeva la religione e imponeva doveri religiosi (cfr.
Cap. V.1.2.2).
Il diritto manteneva un rapporto stretto anche con la morale, non solo religiosa, ma
anche con l’etica secolarizzata nelle virtù sociali, come la beneficienza, la liberalità o
la gratitudine. In questa prospettiva donare diventava quasi un’obbligazione
giuridica (quasi debitum) creando un quasi-diritto per i beneficiari dell’offerta: ad
esempio l’elemosina, che nasceva dalla virtù della carità, era considerata come
dovuta al povero e lo stesso accadeva per il dovere di compensare i servizi
(gratidudo) e per i doveri di solidarietà (liberalitas).
Il diritto poteva incorporare anche contenuti antropologici molto profondi, come
accadeva per il diritto naturale (ius naturale), ovvero il diritto proveniente dalla
“natura delle cose” cioè da immagini evidenti della società e dell’umanità; tali
immagini venivano evocate dai giuristi con riferimento ai caratteri naturali di
differenti ruoli sociali (il re, il padre, la donna) o di istituti (come i contratti e la
proprietà); sempre evocando tale immaginario, i giuristi richiamavano la buona e
retta ragione (bona vel e recta ratio) così come l’equità (aequitas) quali criteri
supremi per valutare la giustizia di una situazione (il senso comune del buon ordine e
della giustizia).
Tuttavia il diritto e la dottrina giuridica non si limitavano a recepire il senso comune
ma provvedevano ad esplicitarlo convertendolo in norma di azione, svolgendo un
ruolo importante nella riproduzione dei parametri culturali e nella costruzione di
schemi mentali destinati a rimanere attivi per secoli nella cultura europea.
E’ per questo che la storia del diritto è essenziale per comprendere l’antica società
europea.
CAP. III – UNA NUOVA STORIA POLITICA E
ISTITUZIONALE
L’oggetto della storia politico-istituzionale.
“politico”
La precomprensione del
Oggi viene messo in discussione l’oggetto della storia politico-istituzionale come
individuato dalla vecchia teoria liberale, che lo ha sempre collegato con il potere
politico e quindi con lo STATO in quanto istituzione e organizzazione costituita.
1.1.
La crisi politica dello statalismo
Già nel 1979 lo storico Ruffilli evidenziava nell’ambito della storia politica
contemporanea – quale storia del potere – la crisi delle istituzioni dello Stato liberale
rappresentativo in Italia e la conseguente dissoluzione delle forme statuite di
esercizio del potere ufficiale (il suffragio, i partiti, la legge, la giustizia ufficiale) e
l’abbandono da parte dello Stato dell’immaginario politico che prevedeva:
La rigorosa separazione tra società politica (Stato e relativa potestà d’imperio)
e società civile e la distinzione tra la natura dei poteri rispettivamente
esercitati (poteri pubblici e poteri privati);
L’istituzione di meccanismi di rappresentanza attraverso i quali i cittadini
(vivendo nella società civile) partecipavano alla società politica;
L’identificazione del diritto con la legge, concepita come espressione della
volontà generale dei cittadini;
L’istituzione di una giustizia ufficiale come unica istanza di soluzione dei
conflitti.
Tale modello viene ora criticato perché il gigantismo della politica a livello di Stato
renderebbe impossibile la partecipazione dei cittadini, che non si riconoscono più nei
rappresentanti eletti; pertanto cresce l’astensionismo elettorale esprimendo una
mancanza di adesione ai modelli rappresentativi. Si disconosce e si froda la legge in
nome di interessi particolari e si mette in dubbio la giustizia ufficiale pretendendo di
sostituirla con altre forme di composizione delle liti. Quindi emerge dietro
l’immaginario statalista del liberalismo tutta una serie di meccanismi multipli di
organizzazione e di disciplina sociale (senso comune, routine, organizzazione del
lavoro, la famiglia etc.).
1.2
La precomprensione postmoderna del potere
Questa antipatia per le forme “macro” del modello politico liberale porta ad una
rivalutazione delle componenti personali della vita quotidiana e la preferenza per
un’etica del piacere al posto di un’etica della responsabilità.
Alla fine degli anni '60 tali forme di dissoluzione non erano ancora visibili, mentre
svolse un ruolo determinante la critica alla “familiarità” con la quale la storiografia
giuridico-politica tradizionale entrava in contatto con il passato.
1.3
Contro una storia politico-istituzionale attualizzante.
1.3.1 La politica implicita nell’idea di “continuità”
Il passato (cioè il diritto storico) letto con le categorie del presente (il diritto del
presente) implicitamente comporta la continuità dei dogmi, dei concetti, delle
classificazioni, dei principi giuridici: tale processo ha assicurato la naturalizzazione
del diritto e dei modelli consolidati di potere, assegnando un carattere atemporale
ad alcune categorie che si trovano ovunque nella storia
cioè “Stato”,
“rappresentanza politica”, “persona giuridica”, “pubblico/privato”, “diritto
soggettivo”. Ma tale continuità viene vista anche come evoluzione, in quanto se il
sapere giuridico prosegue il passato senza disperdere i suoi insegnamenti, si
perfeziona proseguendo linearmente per accumulazione. Questo uso legittimante
progressista della storia del potere e del diritto serviva a spiegare il fine ultimo di
tutti i processi di modernizzazione, cioè il compimento dello Stato rappresentativo
liberale e il diritto legislativo (ovvero codificato).
Il sapere del presente trova la sua giustificazione e si arricchisce in questo dialogo
con il sapere del passato da cui riceve le categorie fondamentali (idea della
continuità).
La chiave del successo della tradizione romanistica, dai glossatori alla pandettistica
tedesca, consisteva proprio in questa fede nella atemporalità del contesto giuridico,
che copriva il carattere innovatore della recezione e che conduceva ad un
appiattimento e ad una negazione della profondità storica.
1.3.2 La critica dell’atemporalismo.
Già negli anni ’20 e ’30 nel Novecento alcuni romanisti avevano denunciato l’errore
di ignorare il lavoro creativo, poietico, delle varie recezioni dei testi romanistici
(duplex interpretatio) e il loro progressivo distacco dai significati originari.
Ma la critica decisiva è avvenuta più tardi, negli anni ’70, quando da varie parti si è
tentato di liberare il passato slegando la storiografia giuridico-istituzionale dallo
sviluppo dello Stato liberale rappresentativo con il suo diritto legislativo (vedi Otto
Brunner, la cui fortuna deve parecchio alla recezione da parte della storiografia politico
istituzionale italiana degli anni ’70 e al rilievo dato da Rotelli, Schiera e Musi).
Nell’ambito della storia del diritto la critica alla continuità trovava ostacoli nell’idea
della ratio iuris e nei dispositivi tecnici razionali come la “regola del precedente” e
l’”interpretazione storica”: infatti, tali dispositivi richiedono che il passare del tempo
e l’evoluzione del contesto non pregiudichino la somiglianza (ovvero la “continuità”)
delle situazioni (l’idea della continuità sorregge l’essenzialismo che a sua volta
sorregge il diritto).
Fu con la comparsa di un volume di J.M. Scholz del 1977 che si aprì la tensione sul
culto della “continuità” laddove l’autore sostiene che occorre “storicizzare la storia
del diritto” applicando la metodologia della scuola delle Annales e cioè promuovere
il diritto nel suo contesto sociale introducendovi quindi una dimensione temporale.
Il passato doveva essere letto in relazione al carattere “locale” dei problemi, delle
soluzioni e degli strumenti tecnico-dogmatici utilizzati ossia del modo con cui tali
elementi dipendevano da condizioni storiche concrete.
Tale invito ad uno scambio più intenso con la storia sociale, a recuperare i significati
autentici (locali) delle istituzioni del passato provocava un certo malessere in una
storiografia che viveva sull’idea della separazione tra diritto e società.
Il programma tracciato da Scholz stava per essere realizzato nell’ambito della storia
del diritto privato dallo storico del diritto fiorentino Paolo Grossi, il quale rifiutava di
vedere nei testi storici del diritto e nelle loro figure discorsive gli antecedenti della
storia futura: non dando importanza alle apparenti continuità formali (cioè alle
parole o elementi normativi isolati dal contesto) egli apre la strada per un nuovo
modo di trattare la dogmatica giuridica medievale e moderna. Egli parte dalla
dogmatica medievale relativa ai rapporti tra gli uomini e le cose per scoprire che tali
rapporti non sono biunivoci come quelli tipici del modello liberale (es.: la proprietà),
evidenziando quindi la natura culturale sia dei concetti della dogmatica medievale
sia del diritto contemporaneo. Così facendo Grossi mette in pratica una lettura dei
testi con gli occhi di chi li ha scritti, cercando l’origine dei quadri dogmatici
nell’ambito del discorso teologico-giuridico ed evidenziandone le conseguenze sul
piano della percezione dei rapporti sociali.
Questo tipo di “lettura partecipe” si trova anche in un allievo di Grossi - lo
storiografo Pietro Costa – che in un celebre saggio degli anni ’60 ricostruisce nella
sua alterità il sistema medievale del sapere relativo al potere, mostrando che il
discorso politico, in una società che si considerava fondata sulla giustizia, era
collocato nel luogo in cui si illustrava la capacità di rendere giustizia, ossia nel
discorso dei giuristi sulla giurisdizione (considerava di conseguenza luogo centrale
della pratica politica il tribunale); rivela poi come nei giochi linguistici (definizioni e
classificazioni intorno a parole come iurisdictio e imperium) utilizzati nei testi
giuridici si racchiuda tutta la realtà sociale nel cui ambito svolgevano una funzione
politica.
1.4 La scoperta del pluralismo politico
La problematizzazione dell’immaginario politico liberale ha portato agli inizi
dell’Ottocento all’abbandono dei punti di vista storiografici che consideravano
solo il livello statale del potere e il livello ufficiale (legislativo e dottrinale) del
diritto.
Comunque già prima l’Europa aveva vissuto un universo politico e giuridico
pluralista dove coesistevano diversi centri autonomi di potere cui
corrispondevano diversi livelli gerarchici di normazione sociale (ordini divini,
complessi normativi inferiori particolari). Tale pluralismo d’altronde non era
specifico dell’antico regime, esistendo tuttora nell’odierno mondo politico (vedi il
proliferare di centri di potere, come la burocrazia, creati dalle rivoluzioni del
secolo XIX).
L’idea che la normazione sociale si effettua a molti livelli è stata sviluppata
recentemente dallo storico del diritto Bartolomé Clavero che descrive l’universo
politico di antico regime dove non si parlava mai di Stato, ma piuttosto di una
pluralità di giurisdizioni e di diritti dipendenti da altri ordini normativi (come la
morale religiosa o i doveri di amicizia). Clavero si sofferma su due punti:
1) che l’ordine giuridico dell’antico regime ha un carattere naturale-tradizionale,
2) che la iurisdictio, cioè la facoltà di dire il diritto assicurando equilibri stabili è
dispersa nella società.
L’influenza di questo modello intellettuale del mondo politico è stata molto forte,
tant’è che esso oggi viene ripreso in Italia, Spagna e Portogallo, soprattutto tra i
modernisti. Gli effetti di questa lettura giuridico-politica sono: l’autonomia dei
corpi non statali (famiglia, comunità, chiesa, corporazioni), le limitazioni ai poteri
della corona da parte dei diritti particolari esistenti, la dipendenza del diritto dalla
religione e dalla morale.
Questa visione pluralista del potere e del diritto si contrappone a quella visione di
una storia giuridica, istituzionale e politica che insiste sulla centralizzazione dello
Stato e che ha caratterizzato le monarchie europee dell’età moderna. Per
esempio in Spagna questa immagine ha sostenuto il centralismo politico
dell’epoca di Franco (Espana una, grande, libre).
Riguardo ai corpi non statali, la famiglia e la chiesa sono fonti di tecnologie
disciplinari e di modelli di legittimazione (basti pensare per la chiesa ai
meccanismi tipici di coercizione ecclesiastica, come la confessione, l’inquisizione o
le visite parrocchiali e al nucleo di legittimazione del discorso giuridico
canonistico, la fraterna correctio o amor).
La lettura pluralista del potere e della disciplina nella società di antico regime va
oltre il diritto com’è concepito oggi: il diritto costituisce un ordine minimo di
disciplina intrecciato con altri più efficaci e più quotidiani (norme di
comportamento che costituivano anche il parametro di soluzione dei conflitti).
Ad ogni modo la normazione e la disciplina sociale sono garantite dalla funzione
svolta dai meccanismi di interiorizzazione (addomesticamento dell’anima) della
morale tradizionale. La capacità disciplinante della morale trazionale è stata
dimostrata dal Clavero con riferimento a istituzioni oggi così “amorali” e
formalmente discipllinate, come il prestito di denaro e l’attività bancaria, che
all’epoca riposavano sulle norme morali della beneficienza e non su norme
giuridiche.
Si parla quindi di disposizioni sentimentali che non possono essere osservate
direttamente. Ma anchq la letteratura giuridica si occupa in alcuni ambiti dei
sentimenti, delle emozioni e degli stati d’animo: esempi classici sono, nel diritto
penale e in quello civile, gli stati psicologici come la colpa, il dolo, lo stato di
necessità, la menzogna e così via, che costituiscono presupposti per l’applicazione
di norme giuridiche.
Una lettura densa delle fonti
Dopo aver trattato sulla definizione dell’oggetto della storia del potere, occorre
definire la metodologia da seguire per affrontare tale oggetto, richiamando gli
insegnamenti di Paolo Grossi e di Pietro Costa sulla lettura delle fonti giuridiche:
evitando, cioè, di svalutarle come metafore e di leggerle attraverso le categorie del
presente.
2.1
Rispettare la logica delle fonti
I testi giuridici hanno formato oggetto nel tempi di un costante lavoro di
reinterpretazione che ha portato da un lato una tradizione centenaria di giuristi ad
“innovare” tali testi e dall’altra una tradizione di storici del diritto a “recuperarli” allo
scopo di trovare conferma ai dogmi attuali.
L’oera di Grossi ha cercato di rintracciare i “nuovi” significati antichi di tali testi, che
negli ultimi duecento anni erano stati offuscati da strati successivi di innovazioni e
recuperi. In particolare Grossi ha cercato di recuperare il significato autentico del
diritto di proprietà, perduto negli anni a causa della preoccupazione di provarne il
carattere tradizionale o addirittura naturale. Lo storico dovrebbe invece interpretare
“cum grano salis” restituendo al pensiero dell’autore il significato autentico.
Anche la lettura dei riferimenti continui contenuti nei testi giuridici alle sfere
superiori dell’etica e della religione, oggi del tutto estranei all’attuale concezione del
diritto e del potere, deve tener conto nel caso dei testi giuridici medievali e moderni
di quel legame ontologico tra il diritto e la religione senza il quale i testi stessi non
possono essere compresi.
Il lavoro di recupero dei significati originari è sicuramente difficoltoso, perché occorre
recuperare la stranezza di quanto è detto, non la familiarità, evitando di lasciarsi
fuorviare dalle letture pacifiche: occorre leggere e porsi dei perché cercando le
risposte non già nella nostra logica, ma in quella propria del testo.
2.2
La letteratura etico-giuridica come via per un’antropologia politica dell’epoca
precontemporanea
La letteratura etico-giuridica dell’epoca moderna permette di rilevare la logica
politica della società precontemporanea.
Infatti la teologia morale e il diritto costituisono, fino al secolo XVIII, i saperi più
importanti relativi all’uomo e alla società, con una letteratura che aveva una carica
precettiva enorme, sia perché le sue proposizioni erano ancorate ad un tempo nella
natura e nella religione, sia perché il suo intento non era descrittivo del modo ma di
trasformazione dello stesso: essa presentava modelli obbligati di condotta, garantiti
a monte dalla inderogabilità della natura e a valle dalla minaccia della perdizione.
Questi testi hanno, a livello di società, una struttura simile a quella dell’habitus, che
è l’elemento centrale della riproduzione sociale e culturale, in grado di generare
comportamenti regolari e attesi che condizionano la vita sociale degli individui in
relazione alla loro classe di appartenenza.
Pierre BOURDIEU ne La Distinction (1979), analizza la società industriale moderna e i meccanismi della sua
riproduzione. La sua ricerca attesta l’esistenza di numerosi habitus (insieme di modi e di comportamenti caratterizzati
dalla permanenza e dalla sistematicità) e di gusti relativamente ben tipizzati, appartenenti alle diverse classi o
categorie sociali che compongono la società. Egli parla così di gusto piccolo-borghese (il distinguersi in maniera
ostentatoria, opportunista o arrivista), di gusto aristocratico (caratterizzato dalla sicurezza del gusto, dalla
discrezione), di gusto popolare (ispirato al buon senso, al senso della misura). L’esistenza di tali habitus di classe fa sì
che il consumo appaia come un fenomeno culturale “non al di sopra del mercato, ma intrinseco in esso”. In altri
termini, nello schema di Bourdieu ciò che distingue le classi sociali non è solo la loro posizione economica (il reddito) o
la loro posizione politica (il potere), ma anche il loro capitale culturale o simbolico. Quest’ultimo gioca un ruolo
importante nella riproduzione sociale: i membri delle classi sociali i cui habitus sono più vicini al gusto legittimo, cioè
alle diverse espressioni della cultura legittima – quella che, attraverso vari meccanismi, si impone come tale per tutti
gli attori sociali, in un momento dato della dialettica sociale – possiedono maggiori chances di mantenere la loro
posizione nella gerarchia sociale e di riprodurla di generazione in generazione
Gli appelli a valori universali come la natura e la religione favorivano la diffusione dei
modelli mentali e pragmatici contenuti nei testi tra una vasta varietà di auditori
soprattutto attraverso interfacce di volgarizzazione molto efficaci (liturgia,
confessione, iconogrfia sul versante della teologia e formule notarili, brocardi,
decisioni dei tribunali sul versante del diritto).
E’ questo processo secolare che ha reso la morale e il diritto dei saperi consensuali:
consenso che proveniva innanzitutto dalle stesse modalità di produzione della
tradizione letteraria nella quale si erano cristallizzate acquisizioni condivise in
“topoi” (sistema di schemi percettivi, di azioni e di pensiero, acquisiti in modo duraturo o generati da
condizioni oggettive, ma che tendono a persistere anche dopo il mutamento di queste condizioni),
brocardi, dicta, regole, opiniones communes; nella letteratura etico-giuridica si
erano cioè depositate le opinioni più comuni e più durevoli dell’immaginario
sull’uomo e la società.
2.3 “Calcoli pragmatici” conflittuali e appropriazioni sociali dei discorsi
La descritta vocazione al consenso della letteratura teologico-giuridica non
escludeva che nella società moderna convivessero rappresentazioni diverse dei valori
che a loro volta governavano pratiche di differenti significati e persino apertamente
conflittuali. Infatti è ovvio che la società moderna non era una società unanime
inquanto le persone non agivano alla stessa maniera poiché i loro sistemi di
apprendimento e di valutazione del contesto non erano sempre gli stessi.
Nell’ambito del sistema discorsivo del diritto le diverse tesi argomentative (schemi
topici) non fuoriuscivano tuttavia dalla sistematicità dello stesso sistema, così come
le posizioni contraddittorie delle parti in un processo non rompono con le norme di
decisione processuale (così come le opposte strategie di due giocatori non alterano il
patrimonio comune delle regole del gioco).
Ciò non significa erigere a modello globale il modello culturale soggiacente allo
spirito delle istituzioni e della relativa letteratura dottrinale; infatti esistono modelli
di rappresentazione estranei al discorso dei giuristi e dei teologi, come quelli dei
politici, agli inizi dell’età moderna, fondati su valori – come l’opportunità e l’efficacia,
concepiti da un unico punto di vista, cioè quello della corona, trascurando invece i
punti di vista di altri interessi, la cui considerazione congiunta ed equilibrata
costituiva la giustizia – chiaramente contrari all’immaginario della società che
informa il discorso della teologia morale e del diritto.
Per tutta l’età moderna tali discorsi alternativi alla teologia morale e al diritto furono
minoritari e per questo, pur dovendo essere presi in considerazione dallo storico per
tracciare il quadro dei paradigmi di organizzazione sociale e politica della società
moderna, sono importanti solo per spiegare le resistenze ai poteri costituiti e i
processi di rottura dell’universo culturale moderno che condussero a sostituirlo con
quello contemporaneo.
2.4 Testo e contesto. Modelli politici e condizionamenti pratici. La sociologia
storica delle forme politiche.
La prospettiva qui proposta per una lettura della storia mira a reagire contro le varie
forme di meccanicismo oggettivista, che tendono a spiegare l’agire umano a partire
da una serie di determinanti puramente esterne, come le necessità fisiologiche o le
leggi del mercato.
Occorre invece ribadire che le pratiche di cui si occupa la storia sono pratiche umane,
derivanti da atti di cognizione, di affettività, di valutazione e di volizione, cioè tutte
operazioni che appartengono alla sfera del mondo interiore. Si tratta infatti di
operazioni intellettuali (griglie di apprendimento e di classificazione), basate su
rappresentazioni costruite dall’agente a partire da stimoli di varia natura ricevuti
dall’esterno.
Quando Karl Polanyi insiste sul carattere “intriso di antropologia” del mercato, pone
in evidenza il fatto che “le leggi del mercato” non costituiscono logiche di
comportamento obbligato, derivanti dalle cose o da una ragione economica, ma
modelli di azione fondati su sistemi di credenze e di valori situati in una cultura
determinata (di un’epoca o di un gruppo sociale). Allo stesso modo quando Bachtin
sostiene che il mondo non può essere appreso se non come testo, perché tutto il
contesto dell’agire umano è qualcosa che è già passato per una fase di attribuzione
di senso (è stata consumata come rappresentazione) che lo ha trasformato in
“testo”, cioè in realtà significativa, dominata da un codice.
2.5 Interpretazione densa dei discorsi, storia dei dogma e storia delle idee
Il processo di interpretazione dei testi si distingue dai metodi delle discipline
tradizionali, come la storia delle idee politiche o la storia dei dogmi giuridici, per
quella distanza dello storico dal suo oggetto di studio. In verità la critica che si può
fare alla storia giuridica tradizionale non è tanto il suo formalismo ma soprattutto il
suo dogmatismo: infatti se il primo si può giustificare dalla necessità di
salvaguardare l’autonomia del livello giuridico-istituzionale il secondo impedisce
ogni contestualizzazione storica, poiché le istituzioni e i dogmi dottrinali vi appaiono
come modelli necessari (e dunque astorici) derivanti dalla natura delle cose o dalla
evidenza razionale.
Di contro, l’orientamento proposto relativizza i modelli giuridico-istituzionali,
invitando ad una lettura della storia delle forme culturali nel loro contesto e nel loro
radicarsi in contesti pratici.
2.6
Una nota su “relativismo metodologico” e “relativismo morale”
In conclusione, con questa introduzione metodologica sul diritto e sulla storia si
suggerisce il ricorso al più assoluto relativismo: non vi sono valori permanenti, poiché
la giustizia e l’ingiustizia delle situazioni è un prodotto di valutazioni “locali” o
“contestuali”. Non vi è progresso storico, poiché storia in generale e quella giuridica
in particolare, scorre lungo un percorso segnato dall’arbitrarietà e dalle rotture.
Ciò non significa che non sussistano spazi per un qualsiasi progetto di
“razionalizzazione” della società, in quanto il relativismo di cui si parla è un
“relativismo metodologico” , che si basa sulla convinzione che non si possono
fondare i valori giuridici sulla “natura” o sulla “scienza”.
Questo tipo di relativismo è molto antico e radicato nella tradizione culturale
europea, oggi pienamente condiviso dalla teoria delle scienze, non solo sociali: infatti
le stesse scienze fisico-naturali hanno abbandonato l’idea di verità a vantaggio
dell’idea di “coerenza”, di “paradigma”, di “universo di credenze”.
Il punto di vista relativistico non impedisce l’adesione personale a valori come pure
l’accettazione pragmatica di valori consensuali: tutto sta nel modo come si
intendono i vari parametri di condotta. Infatti le certezze che ci fanno agire non
devono essere necessariamente verificabili con metodo scientifico (quelle quotidiane,
come la fede, gli affetti e le regole del gioco, non si possono fondare in modo
obiettivo e condivisibile). Ma sono proprio tali certezze, le c.d. ragioni del cuore
disconosciute dalla ragione, che in un’epoca di grande incertezza permettono di
affrontare senza dubbi le maggiori questioni personali.
Il relativismo metodologico non ha nulla a che fare con il relativismo morale, ma
contiene una forte carica etica.
In primo luogo perché promuove l’auto-responsabilizzazione nell’affermare i propri
valori e, nel caso dei giuristi, obbliga a cautele sulle valutazioni circa la giustizia e
l’ingiustizia delle situazioni o sulle proposte di politica del diritto.
In secondo luogo il relativismo metodologico è un principio di tolleranza, perché le
opzioni e i valori sono solo evidenze personali e non si possono imporre facendoli
passare per valori universali o naturali: è proprio questa esclusione di una certezza
oggettiva a lasciare spazio a certezze soggettive, per le quali non è richiesto di
morire per esse. Infatti, nella storia del diritto le epoche ossessionate da una ragione
unica e unidimensionale furono epoche di violenza sulla pluralità delle ragioni di
ognuno, di violenza del diritto sui diritti. A ciò si aggiunga che la violenza sulle
coscienze non proviene solo dallo Stato attraverso la legge, ma può venire dalla
società stessa, attraverso l’imposizione di canoni oppressivi di comportamento
(regole del parlare, di decenza, del tratto, dell’abbigliamento).
Infine il relativismo, essendo fondamento della tolleranza, è anche il fondamento del
dialogo, poiché il raggiungimento di posizioni comuni che permettono la convivenza
delle differenze individuali, può ottenersi dal confronto delle opinioni.
CAP. IV – L’IMMAGINARIO DELLA SOCIETA’ E
DEL POTERE
Immaginari politici
Secondo una concezione ingenua il diritto consiste in un sistema di norme destinato
a regolare le relazioni sociali attraverso parametri minimi di comportamento che
rendano possibile la convivena: in sintesi, il diritto si limiterebbe ad accogliere valori
sociali prodotti da altre sfere dell’attività culturale e a conferire loro una forza
vincolante garantita dalla coercizione.
Invece il diritto ha una forza creatrice e poietica maggiore, in quanto non assicura
solo la pace e la sicurezza ma crea anche i valori sui quali esse si fondano: è in
sostanza un’attività creativa al pari dell’arte, dell’ideologia o dell’organizzazione
della produzione economica.
Prima di organizzarla, il diritto immagina la società, genera modelli mentali
dell’uomo e delle cose, dei vincoli sociali, dei rapporti giuridici e politici. Poi da un
corpo istituzionale a questo immaginario offrendo anche strumenti concettuali
adeguati. Concetti come Stato, persona, sovranità, contratto e così via non
esistevano prima che i giuristi li immaginassero, li definissero concettualmente e ne
traessero le conseguenze dogmatiche.
In questo senso il diritto crea la realtà in cui opera: il fatto non esiste prima e
indipendentemente dal diritto (i fatti giuridici non sono innati,ma sono socialmente
costruiti), perché i “casi giuridici” non hanno nulla a che vedere con i “casi della vita”.
Il diritto come sistema “autopoietico” è stato sottolineato sia da antropologi come
Clifford Geertz, sia da sociologi come Niklas Luhmann.
Per questo si procederà alla descrizione delle grandi tappe dell’evoluzione del sapere
giuridico occidentale dopo aver descritto il panorama dell’immaginario che da senso
alla creazione giuridica, immaginario che in tutta la storia del pensiero sociale e
politico europeo è stato in buona parte di competenza dei giuristi, nella veste di
pensatori della società e del potere.
La concezione corporativa della società
II pensiero sociale e politico medievale è dominato dall'idea di ordine universale
(Cosmos) che comprende uomini e cose e orienta tutte le creature verso il Creatore. Il
riconoscimento di tale fine (télos o causa finale) era indispensabile come fondamento di
qualsiasi proposta politica.
2.1
Ordine e creazione
In una società cristiana la Creazione, operata da Dio, appariva come una forza
ordinatrice: le cose vengono ordinate per un fine specifico (l'erba per gli animali, gli
animali e i frutti per l'uomo, l'uomo e la donna l'uno per l'altro ed entrambi per Dio).
La narrazione della Genesi ispirò il pensiero sociale medievale e moderno fondando
le gerarchle sociali: i ruoli sociali trovano giustificazione e legittimazione nella
Creazione/Ordinamento (Es. : il Re che non è tenuto a comportarsi in modo uguale, le
gerarchie politiche e sociali, e così via).
Anche la filosofìa greca e romana concepiva il carattere ordinato dell'universo
naturale e umano: per Aristotele il mondo era organizzato finalisticamente in
quanto le cose avevano nella loro natura una iscrizione che ne indicava il posto
nell'ordine del mondo e che ne condizionava la vita in vista della finalità del tutto. Era
come un gene che crea nelle cose stimoli inferiori che le indirizzano a occupare il loro
posto e a svolgere la loro funzione nel tutto, come la tessera di un mosaico. Nel caso
dell'uomo questo gene determinava l'espletamento dei suoi compiti in seno alla
società organizzata in vista del bene comune (attraverso il suo istinto associativo e
la sua natura essenzialmente politica). In tal senso era legittimo parlare di un
equilibrio naturale o di un “giusto per natura”.
Il pensiero medievale eredita tutto questo, infatti Il diritto aveva come
fondamento l'ordine divino della Creazione: i giuristi identificavano la giustizia con la
natura e questa con Dio. Perciò i giuristi erano considerati alla stregua dei sacerdoti.
Un celebre testo del Digesto (opera giuridica redatta da Triboniano su ordine
dell'Imperatore Giustiniano) spiega che il “diritto naturale” è quello che la natura ha
insegnato a tutti gli animali e un glossatore medievale chiarisce che la parola “natura”
non è altro che Dio (natura, id est Deus). In un altro testo del Digesto il sapere pratico
giuridico è definito come “nozione delle cose umane e divine, scienza del giusto e
dell’ingiusto”.
2.2
Ordine occulto, ordine apparente
Prima di essere una norma di diritto, l'ordine era una norma spontanea di vita (tra
le parole centrali nel linguaggio politico e giuridico troviamo onestà, onore, verità,
bontà): vivere onestamente significava aderire all'ordine naturale del mondo e il
comportamento rendeva manifesta la natura degli uomini (retta o deviata). L’onestà
e la verità erano le qualità più apprezzate e da esse derivavano l’importanza
attribuita ai dispositivi miranti a rendere visibile l’ordine essenziale delle cose e delle
persone (titoli, trattamenti, gerarchia, etichetta) nonché le condanne anche penali
per tutte le forme di falsità (falsificare documenti, moneta, ma anche usare nomi e titoli
altrui).
2.3
Ordine e volontà
Dall’idea dell’esistenza di un ordine obiettivo e indisponibile delle cose
discendeva anche il carattere naturale della costituzione sociale (legge
fondamentale di una società o di un regno), dipendente anch’essa dalla natura delle
cose e, pertanto, sottratta al potere dispositivo della volontà: i popoli possono
scegliere le forme di governo (monarchia, democrazia) così come pure possono
adattare allae condizioni della comunità, tramite il diritto civile, i principi giuridici
derivanti dalla natura delle società umane (ius naturale), ma la costituzione naturale
si conserva sempre come criterio superiore per inferire la legittimità del diritto
statuito dal potere.
In questo senso tutto il diritto (ma soprattutto il ius naturale) svolge una funzione
costituzionale e si impone ad ogni potere, perché si fonda su principi necessari,
propri di ogni convivenza umana (affectio societatis).
In virtù di tale funzione costituzionale del diritto tutta l’attività politica appare
fondata su principi di giustizia, vale a dire che tutta l’attività dei poteri superiori è
vista coma orientata alla soluzione dei conflitti tra sfere di interessi che risolve
“facendo giustizia”: in caso contrario il governo diviene tirannide ed essere oggetto di
resistenza.
Il principe può agire in modo difforme dal parere dei consiglieri, degli esperti, dei
letterati, ma solo eccezionalmente (quale ultima ratio), così come rari sono i miracoli
di Dio.
2.4
Ordine e disuguaglianza
Nel concetto medievale di destino cosmico ogni parte (gruppo o corpo sociale)
cooperava in modo diverso alla realizzazione degli obiettivi della creazione. In tale
sistema gerarchizzato la differenza di funzioni non comportava una sottomissione
funzionale ad altri elementi, ma solo una collocazione peculiare nell’ordine. La
subordinazione non rappresentava, quindi, minore dignità: gli stessi angeli, esseri
perfetti, non sfuggivano a questa logica, essendo organizzati in nove gradi distinti.
Tuttavia, la compatibilita tra perfezione dell'uomo e l'esistenza di disuguaglianze non
cessava di generare un paradosso che può essere superato con una visione
escatologica del Creato.
L’ordine e la conseguenza disuguaglianza, di status così come di governo politico
(soggezione politica derivante dalla necessità di governo), erano compatibili con la
perfezione, che in Dio si trova in modo semplice ed uniforme “ma che nelle cose di
natura, nella universalità delle creature, non si può trovare se non in modo difforme
e molteplice” (Tommaso d’Aquino, Summa theol.).
Questa idea che gli esseri si integrano con uguale dignità nell’ordine divino spiega
la relazione tra umiltà e dignità che domina il pensiero sociale e politico dell’Europa
medievale e moderna. L’umile deve accettare la propria posizione subordinata sul
piano dell’ordine e del governo politico mantenendo tuttavia una dignità uguale a
quella del potente: questo pensiero – che si ritualizza nella cerimonia della lavanda
dei piedi – spiega la presenza, accanto ai mezzi di discriminazione sociale, giuridica e
politica dei più umili, di una particolare protezione giuridica che include una tutela
del principe sui loro interessi (foro speciale, il “favor” in materia di esimenti penali, di
prova, di presunzione di innocenza e di buona fede)
2.5
Ordine e status
L'idea di ordine suggeriva anche la prospettiva secondo cui l'universo è come un
corpo nel quale a ciascun ordine compete una funzione. Le funzioni sono
gerarchizzate per l'importanza che rivestono nella sussistenza del tutto: questa
visione legittimava una distinzione tra le persone e le cose in termini di dignità. Gli
uomini, quindi, erano degni in rapporto alla dignità dell'ufficio che naturalmente
competeva loro. Ad es. se l’uomo, creato “a immagine e somiglianza di Dio”, aveva
natura di specchio divino, la dignità della donna era minore ( il suo volto doveva
essere velato)e fra gli stessi uomini alcuni – i nobili e illustri – avevano una speciale
dignità, costituendo la parte più sana della società e spettando loro il governo.
Sul piano del diritto le differenze tra le persone erano tradotte nelle nozioni di
Status e di privilegio (Diritto Particolare). Lo status è la condizione dell’uomo comune a più
d’uno e in principio corrisponde ad un luogo nell’ordine, ad un compito o dovere sociale (officium). Nella
società europea si individuavano tre uffici sociali: la milizia, la religione, il lavoro.
Questa classificazione tripartita (sono i tre stati che Dio pose perché si mantenesse il
mondo) si mantenne nel sistema rappresentativo dei parlamenti sino alla fine
dell’antico regime. Ma in altri ambiti della realtà giuridica e politica (diritto penale,
processuale, fiscale, ecc.) gli status erano molto più numerosi e, soprattutto,
personificati e corrispondenti agli statuti giuridici (ai privilegi) dei gruppi di
appartenenza. Ciò condusse a ritenere che un individuo possegga vari status e che in
lui coincidano varie persone, come se in un individuo convivessero varie persone.
L’esempio teologico era il mistero della Santissima Trinità, in cui tre persone
coesistevano in una sola e lo stesso accadeva per il fenomeno dei “corpi del re”, cioè
della coesistenza nella persona fisica del monarca di una “persona privata” e una
persona pubblica”. Di fronte alla molteplicità di status la materialità fisica e
psicologica dell’uomo sparisce: persona è l’uomo considerato in un certo stato, cioè
sotto una certa qualità in ragione della quale gode di diritti diversi da quelli di cui
godono gli altri uomini. In definitiva, così come nel significato originario del termine
(persona designava nell'antichità la maschera teatrale con la quale un attore si
trasformava in un ruolo) persona è l’uomo (o la donna) in quanto ricopre un ruolo
sociale.
Sono infatti le “qualità” (i ruoli sociali) a contare come soggetti di diritti e di
obbligazioni e grazie al diritto la società si riempie di una pletoria infinita di “persone”,
di status, la cui mobilità rispetto ai supporti fisici ne consente la continuità (come la
persona del defunto che dopo la morte si incarna nell’erede o il padre che si incarna nei
figli mantenendo la propria identità personale).
La vera persona giuridica è lo status, che è permanente, e non gli individui, che ad
essa conferisono momentaneamente un volto (Clavero). L’uomo senza status non è
persona, come lo schiavo che non possiede alcuna qualità giuridicamente rilevante
(come lo status civilis, civitatis, familiae) e perciò in diritto romano è tenuto come cosa.
Questa è la società di status, la società per ceti che caratterizzerà l'antico regime
e precede l'attuale società di individui.
2.6
Ordine e pluralismo politico
In una società per ceti il potere era per sua natura ripartito: perché tutti gli organi
della società erano considerati indispensabili e quindi la suddivisione naturale dei
compiti si traduceva nell’autonomia politico-giuridica (iurisdictio) dei corpi sociali. La
funzione della testa (caput) era quella di rappresentare all’esterno l’unità della
società e di mantenere l’armonia fra tutti i suoi membri realizzando la giustizia. Solo
la realizzazione della giustizia – che i giuristi e i teorici della politica tardo-medievale
considerano la principale finalità del potere – garantiva il mantenimento dell’ordine
sociale e politico costituito.
La dissoluzione del corporativismo e l’avvento del paradigma individualista
L'origine del Paradigma Individualista moderno della società e del potere deve
ricercarsi nella Scolastica Francescana del Trecento (Guglielmo d’Ockham). Mettendo
in dubbio i corpi sociali come istituzione per la comprensione della società, spoglia la
persona del suo status per trovare la vera essenza: le qualità (status: pater familias,
scolaro, plebeo) divengono superflue mettendo in luce l'individuo non caratterizzato,
astratto e uguale. Nello stesso modo in cui uscivano di scena “le persone concrete”,
essenzialmente legate le une alle altre da vincoli naturali, sparivano i gruppi e la società.
Questa rivoluzione intellettuale della teoria politica moderna portò anche ad una
piena laicizzazione della teoria sociale, grazie ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra
il Creatore e le sue creature – sviluppatosi soprattutto con la “teoria delle cause seconde”
(teologia tomista) – che porta ad una certa indipendenza del sapere temporale rispetto alla
fede.
La laicizzazione della teoria sociale – realizzata nel pensiero politico e giuridico del
secolo XVII da Ugo Grozio a Thomas Hobbes – libera gli individui da tutti i vincoli che non
siano le loro evidenze razionali e i loro impulsi naturali. Tutto ciò si riflette sulla
comprensione del potere, che non può più essere fondato su un ordine oggettivo delle cose,
ma sulla volontà: Può trattarsi della volontà sovrava di Dio, che si manifesta sulla terra
attraverso il suo luogotenente, il principe (diritto divino dei re), oppure della volontà degli
uomini, i quali, spinti dai pericoli o dal desiderio di felicità e benessere, istituiscono la
società civile mediante un accordo di volontà, un patto (Contrattualismo).
La volontà – e non un equilibrio, una ratio prestabilita – sta all’origine anche del diritto.
Una volta laicizzata la teoria giuridica, Russeau definirà la legge come "una dichiarazione
pubblica e solenne di volontà generale".
Ovviamente di fronte al volontarismo cedono tutte le limitazioni derivanti da un ordine
superiore alla volontà (ordine naturale e soprannaturale) e quindi la costituzione e il diritto
si rendono disponibili e alterabili dagli uomini in un dato momento storico e che tutto il
diritto positivo, in quanto prodotto diretto e indiretto di patti, è giusto al pari di tutte le
convenzioni (positivismo giuridico).
Il Paradigma Individualista e Volontarista nella concezione della società si sdoppia
in alcune correnti:
Provvidenzialismo : il potere è concepito come espressione della volontà divina
esercitata sulla terra dalle dinastie regnanti, investite di una dignità quasi sacra;
II Contrattualismo Assolutista: concepisce il patto sociale come trasferimento
definitivo nelle mani dei governanti di tutti i poteri dei cittadini.
Il contrattualismo liberale: in questo caso il contenuto del contratto sociale
incontra un limite nella natura stessa dei suoi obiettivi, che sono quelli di
instaurare un ordine sociale e politico che soddisfi gli istinti edonistici degli
uomini e pertanto i diritti naturali restano efficaci anche dopo l’instaurazione
della società civile. Invece, nelle due precedenti correnti i diritti naturali si
riversano su quelli trasferiti .
Nel campo del Diritto Privato l'Individualismo genera delle conseguenze: innanzitutto
la dissoluzione della sostanza indisponibile dei contratti, legata alla loro natura di cose.
Così la proprietà subisce dei limiti in quanto potrebbe essere oggetto di abuso (l'abuso si
palesa nel privare la comunità delle utilità derivanti dall'uso normale, di privarla della loro la
funzione sociale).
CAP. V – LA FORMAZIONE DEL “DIRITTO
COMUNE”
La dottrina giuridica dei secoli a partire dal XV al XVIII è stata denominata in vari
modi: Bartolismo, Scolastica Giuridica, Mos Italicus. Il termine più corretto è però
Diritto Comune (lus Commune), termine che verrà utilizzato per i secoli XIII e XIV. Il
Diritto Comune trasmette l’idea della sua unità, in quanto:
unifica le varie fonti del diritto (Diritto Giustinianeo, Diritto Canonico e Diritti
Locali);
rappresenta un oggetto unico di tutto il discorso giuridico europeo;
si fonda su metodi e stili di ragionamento comuni;
viene insegnato in maniera identica in tutta Europa;
divulgato in una lingua universale , il latino.
La formazione di una comunità giuridica europea è da ricercare nella tendenza
all’unità dei vari ordinamenti, sul piano sia politico (ricostituzione dell’impero con
Carlo Magno nel IX secolo e del Sacro Romano Impero germanico nel X secolo) sia
religioso, dovuta alla presenza sul territorio di una Chiesa che riuniva tutta la
cristianità.
Sia l'Impero che la Chiesa avevano ordinamenti giuridici unificati che coesistevano
parallelamente (da qui la triade una religione, un impero, un diritto). La spinta
all’unità del diritto proveniva anche dall’omogeneità dei giuristi colti che insegnavano
nelle università dell’Europa centrale e occidentale (da Cracovia a Lisbona, da Uppsala a
Napoli) il diritto romano e canonico; omogeneità dovuta all’uso della stessa lingua
tecnica e, conseguentemente, al ricorso ai medesimi testi di riferimento (la tradizione
letteraria romana) e alla stessa metodologia.
E’ dall’azione combinata di questi fattori che sorge il diritto comune.
Fattori di unificazione dei diritti europei
Esaminiamo da vicino la prima serie di fattori, cioè l’unificazione degli ordinamenti
giuridici europei.
1.1. La tradizione romanistica
1.1.1. Diritto romano classico, diritto bizantino e diritto romano volgare
Il principale fattore di unificazione dei diritti europei fu la memoria del diritto di
Roma: tra il I secolo a.C. e il III secolo d.C. l’impero romano si estese a tutta l’Europa
meridionale, toccando anche il Nord (la parte settentrionale della Gallia e il sud
dell’Inghilterra), mentre nell’Europa orientale esso abbracciava i Balcani e la Grecia,
prolungandosi fino all’Asia minore
In questo periodo di massima estensione dell’impero il diritto conobbe un'epoca
aurea.
Sul fondamento di poche leggi (la legge delle XII Tavole/metà del V sec. a.C., le leggi
votate nei comizi dell’ultimo periodo della Repubblica nei secoli I e II a.C.) e delle
legis actiones (concesse per garantire certe pretese giuridiche), il pretore sviluppò
un sistema completo e flessibile di azioni (actiones praetoriae), basato sulla verifica
dei fatti e sull’ideazione di rimedi giudiziari per dare soluzioni adeguate al caso. Con
quest’opera di estensione e affinamento dell’arcaico diritto civile i pretori crearono
un diritto proprio, il ius praetorium. Inizialmente essi si avvalsero dei loro poteri di
magistrati (imperium)dando alle parti ordini che modificavano le circostanze di
fatto rendendo possibile l’applicazione di una norma più adeguata alla giustizia
materiale del caso (vedi la stipulatio praetoria, la restitutio in integrum, la missio in possesionem, gli
interdicta: in questo modo il pretore creava situazioni di fatto).
Più tardi, con la “lex Aebutia de formulis” (149 a.C.), il pretore acquisì la possibilità di
creare azioni non previste dalla legge (actiones praetoriae): L'azione pretoria
consisteva nella verifica dei fatti e nella loro valutazione giuridica mediante una
formula prestabilita. Era pertanto la formula e non la legge a dettare la soluzione al
caso concreto. Con ciò la giurisprudenza dei pretori diventò essa stessa una fonte
immediata di diritto. Successivamente (ca. 125-138 d.C.) il Diritto Pretorio venne
codificato con l'Edictum Perpetuum. Si sviluppa una enorme produzione letteraria di
giuristi che consigliano le parti e lo stesso pretore per trovare le soluzioni più adatte al
caso.
Fuori Roma, specie nelle provincie più lontane (come la Germania e certe zone
della Gallia e della Hispania), il diritto colto e ufficiale aveva scarsa applicazione o
arrivava a stento, mentre vigevano usi locali e modi tradizionali di risolvere le liti.
Pertanto la diffusione del diritto romano non è dovuta alla vastità dell'impero ma al
tesoro letterario al quale si ispirarono nei secoli successivi i giuristi.
La crisi dell’impero romano, a partire dal III secolo d.C., e la successiva caduta
dell’impero d’occidente (nel 476) trascinarono con sé il sapere giuridico. Proprio a
causa della vastità dell'impero, mal fornito di tecnici del diritto e lontano dall’azione
dei pretori di Roma, vennero acquistando progressivamente sempre maggiore
importanza le leggi imperiali (constitutiones principum): il diritto si amministrativizza,
diventa tecnica burocratica e ne guadagna in generalità e automatismo, diventa
accessibile anche ai profani. Il diritto si volgarizza, specie nelle provincie, sotto
l’influenza dei diritti locali (diritto romano volgare).
Nell'impero d'oriente, il diritto classico subisce l'influenza culturale ellenistica e del
diritto locale: molti commentatori scrivono in greco, lingua ufficiale della corte
Bizantina (Ellenizzazione). Tuttavia il gusto per la riflessione intellettuale non scompare,
tanto che intorno alla metà del VI secolo d. C. l'imperatore Giustiniano – un
nostalgico dell’antica grandezza di Roma - fece raccogliere le opere dei giuristi
classici romani in una compilazione chiamata Digesto (riassunto, selezione) o
Pandette (opera enciclopedica; 533 d.C.). Inoltre fece raccogliere la legislazione
imperiale dei suoi predecessori in un Codice (cioè libro, 529 d.C.), completata da un
manuale di introduzione, chiamato Istituzioni (530 d.C.). Successivamente, nel 565
d.C., furono raccolte le “ costituzioni nuove” (Le Novelle) promulgate dallo stesso
Giustiniano dopo l’uscita del “Codice”.
Questo insieme di libri – che a partire dal XVI secolo venne chiamato Corpus Iuris
Civilis – era destinato a costituire la memoria medievale e moderna del diritto romano in
quanto tutte le opere dei giureconsulti classici, che ancora esistevano nelle grandi
biblioteche del medio oriente, andarono poi perdute con la conquista araba di quei centri
(delle migliaia di opere scritte dai giuristi romani oggi ci resta solo un manoscritto,
scoperto all’inizio dell’Ottocento, le c.d. Institutiones di Gaio).
1.1.2 Gli studi romanistici nel quadro della formazione dei giuristi.
Lo studio del diritto romano come disciplina “dogmatica” è sempre stato
giustificato in ragione della sua perfezione, intesa con riferimento alla speciale
sensibilità per il diritto dei romani, che ha portato a creare concetti e soluzioni
caratterizzati da esattezza (nel senso di adeguatezza alla natura delle cose e dei
rapporti umani) e senso di giustizia (nel senso di conformità a un parametro ideale
del giusto).
Da un punto di vista materiale, tale perfezione riposa sulla convinzione che
esistono parametri universali di giustizia nel regolare le relazioni umane, e da un
punto di vista formale che esistono tecniche atemporali nell’affrontare le questioni
giuridiche (valutazione del giudice nella decisione, il ragionamento); ma l’esistenza di
tali parametri universali ed eterni della giustizia presuppone l’esistenza di una natura
umana transtemporale e transculturale.
Tuttavia le correnti di pensiero che sottolineano il carattere costruito, culturale e
locale dei valori dominanti in ciscuna epoca hanno rilevato la difficoltò di individuare
valori giuridici, principi e tecniche che abbiano vinto il tempo o la diversità culturale:
ad esempio, l’attuale principio di reciprocità delle prestazioni (do ut des) non valeva
in società in cui il buono e giusto era dare senza nulla chiedere in cambio, distribuire
“liberamente e arbitrariamente”. Non vigeva neanche il principio del carattere sacro
e inviolabile della vita umana, al quale veniva anteposta la sicurezza sociale e la
retribuzione del male fatto
Concetti fondamentali del diritto odierno, come quelli di diritto soggettivo, persona
giuridica, rapporto giuridico, generalità della norma, irretroattività della legge,
uguaglianza giuridica e politica, primato della leggge e dello Stato, sono relativamente
recenti nella cultura giuridica europea e non esistono affatto in altre culture.
Spesso è la stessa maniera di fare storia che porta ad una lettura del diritto passato
nella prospettiva attuale, per cercare in esso l’origine di alcuni principi e istituti odierni,
mentre basterebbe un approfondimento della logica originaria del concetto, così come
del suo integrarsi nel contesto culturale ed istituzionale dell’epoca, per mostrare che se
si rispetta l’autonomia del concetto storico esso non corrisponde in alcun modo a
quello odierno.
Inoltre occorre tenere presente che termini giuridici del diritto romano designati
con lo stesso nome evocano, a dispetto della continuità delle parole, idee e immagini
diverse ,cui oggi non pensiamo neppure(obligatio, repraesentatio, matrimonium).
E’ vero che il diritto attuale è l’erede, nei termini, nei concetti e negli istituti di
una lunga tradizione in cu i testi del diritto romano hanno avuto un posto centrale,
ma in questa lunga tradizione questi ultimi hanno formato oggetto di continue
reinterpretazioni, che hanno permesso di farlo sopravvivere alle enormi
trasformazioni sociali e culturali della società europea durante oltre due millenni.
Infatti, l'equità (aequitas) romana classica non è la stessa dei diritti cristianizzati,
postclassici, medievali e moderni, né la stessa del diritto individualista e laicizzato dei
nostri giorni.
Ogni istituto e ogni concetto giuridico fa parte di un contesto o sistema dal quale
riceve il proprio significato: solo perché si è perso il significato originale, è possibile
riadattare concetti ed istituti alle varie epoche.
Infatti, facciamo riferimento a parole o concetti romani dimenticandone il significato originario,
come: “obbligazione” (da obligare, legare intorno), “soluzione” (pagamento; deriva da solvere, cioè
sciogliere), “paterfamilias” (nonché familia) e actio. La stessa idealizzazione della “iurisprudentia” o
dell’attività del pretore prescinde dal contesto politico e sociale in cui veniva svolta: infatti oggi non
potremmo accettare una totale discrezionalità da parte dei giuristi nel dar forma al diritto oppure
un’autonomia di decisione come quella del pretore nel garantire o meno protezione giuridica
attraverso la concessione delle “actiones praetoriae” o con altri espedienti basati sull’imperium.
Nell’immediato dopoguerra si guardò ad un ritorno al diritto romano come
possibile modello capace di evitare il “totalitarismo della legge”, ma tale progetto fu
visto come problematico da contestuali correnti di pensiero che proponevano altre
vie di superamento della crisi del diritto.
Resta il fatto che il diritto romano abbia un innegabile interesse storico, ma come
cultura giuridica “diversa”, nei suoi presupposti, nella sua tecnica di affrontare i
problemi, nei suoi concetti e nei suoi principi, nei suoi istituti e nel modo di
organizzare la pratica giuridica. In sintesi le diversità possono riassumersi:
Il diritto consisteva nella dottrina;
Il diritto nel vero senso della parola era solo il diritto privato;
La sua elaborazzione si concentrava sul momento processuale;
La “sistematizzazione germanica” del diritto civile era sconosciuta.
Diritto romano
Credenza in un diritto immanente
Diritto attuale
Concezione positivistico-volontaristica del diritto:
- il diritto come volontà (arbitraria, artificiale) del
potere espressa in dichiarazioni solenni (leggi)
Casistica: la giustizia come soluzione appropriata
di un caso concreto:
Normativismo (la giustizia come criterio generale
ed astratto):
- il diritto come norma generale ed astratta
Carattere giurisprudenziale o dottrinale: il diritto
come creazione dei giuristi, a partire dal loro sapere pratico.
Autonomia dell'autorità dei giuristi (ex propria
auctoritate)
Il diritto come sapere pratico (come prudentia o
arte d'agire).
- il giusto come criterio generico
Carattere legale.
Dipendenza dei giuristi dall'autorità (ex auctoritate
principis):
- il giudice come braccio della legge
- il giudice come esecutore della legge
- il sapere giuridico come tecnica di applicazione
della legge
Il diritto come espressione della volontà o come sapere speculativo:
- il diritto come scienza delle leggi (positivismo
legalista)
- il diritto come scienza dei principi generali (positivismo concettuale)
1.1.3 La recezione del diritto romano.
Con la restaurazione dell'impero in occidente (impero carolingio di Carlo Magno
nell’800 d.C.; il Sacro romano impero germanico di Ottone I nel 962 d.C.) sorse l’idea
che l’antico impero romano fosse tornato a viveve e che l’universalità del potere si
fosse trasferita nei nuovi imperatori. L’impero veniva inoltre considerato come una
creazione provvidenziale, destinata a fare da supporto politico alla Chiesa,
corrispondendo l’universalità dell’impero alla cattolicità di essa.
I resti del diritto romano (riscoperti nel nord Italia nel secolo XII), vengono
considerati il diritto dell'impero, a vocazione universale, come il diritto comune.
Ma nelle piccole comunità, nei giovani regni medievali, nelle città, nelle signorie,
nelle corporazioni religiose e artigiane, vigevano e si perfezionavano diritti
derivanti da tradizioni giuridiche romano-volgari, canonistiche e germaniche (queste
ultime di natura consuetudinaria, raccolte poi in compilazioni denominate più tardi “leggi dei
barbari”, come le “leges Visigothorum”, dei regni visigoti di Francia e della penisola iberica), o
da stili locali di soluzione delle liti: così la pretesa di validità universale del diritto
comune dell'impero non poteva non generare tensioni
La vigenza dei diritti locali fu inizialmente consentita (permissio) con
autorizzazione o con tacito consenso (tacitus consensus) dell'imperatore. Alla fine,
basandosi su un testo del Digesto – che diventerà centrale nel modo di concepire i
rapporti tra diritto comune e diritti particolari - si riconobbe che i popoli hanno per
natura la capacità di stabilire il proprio diritto, stabilendo la compatibilita della
vigenza del diritto comune con gli altri diritti. Nel loro campo di applicazione i
diritti propri (quelli dei corpi politici interni all’impero) hanno la supremazia sul
diritto comune: quest'ultimo però ha vigore non solo come Diritto Sussidiario, ma
anche come Diritto Modello, basato cioè sui valori permanenti e generali della
ragione umana (ratio scripta, ratio iuris) rendendolo applicabile a tutte le situazioni
non previste dai diritti particolari.
A partire dal XIII secolo il diritto romano si integra nel sistema delle fonti della
maggior parte dei regni europei, anche di quelli che non riconoscono la
supremazia dell’imperatore, dove acquista la forza di diritto sussidiario.
La recezione del diritto romano negli ordinamenti dei regni europei si spiega
con il decollo dell'economia mercantile e monetaria europea che caratterizza quel
periodo (secoli XIII e XIV). Infatti, lo sviluppo di tale tipologia di rapporti
economici richiedeva l’esistenza di tre presupposti giuridici:
1. Un diritto stabile che garantisse la sicurezza giuridica necessaria alla
previsione e al calcolo mercantile;
2. Un diritto unico funzionale ad un commercio intereuropeo;
3. Un diritto individualista, che fornisse una base giuridica adeguata
all’attività dell’imprenditore, libera dalle limitazioni degli ordinamenti
giuridici medievali.
Il diritto romano rispondeva a tutte queste caratteristiche in ragione della sua
astrattezza (a fronte della casistica dei diritti dell’alto medioevo), della sua validità
sussidiaria in tutte le piazze commerciali europee e, soprattutto, dei suoi principi che
coincidevano, nella sostanza con una visione capitalistica dei rapporti mercantili:
cioè libertà di azione negoziale, garantita dal principio dell’autonomia della volontà,
possibilità di associazioni elastiche, consentita dalla figura rimanistica della
personalità giuridica collettiva (universitas, corpus, ecc.), estensione illimitata del
potere di trasferire i beni e capitali, favorito da un diritto di proprietà che non
conosceva limiti sociali o morali all’uso delle cose.
In verità, il diritto romano non possedeva, al pari del diritto comune, un
carattere astratto e né garantiva quella comunicazione giuridica nelle materie del
commercio fra le grandi piazze europee (dove invece il diritto comunemente usato, a
titolo principale o sussidiario, era la “lex mercatoria” più che il diritto romano).
Pertanto le cause della recezione sono da ricercarsi su altri piani, primo fra tutti
l’idea che la restaurazione dell’impero occidentale nel secolo IX richiedesse accanto
all’unità politica e religiosa anche una unità giuridica. Inoltre il diritto romano
continuava ad imporsi anche laddove non discendeva dall’autorità dell’imperatore
(perché non era dovuto vassallaggio) in virtù della sua perfezione: infatti le sue fonti
erano più complete e sofisticate di quelle dei diritti germanici o dei diritti locali e la sua
ricchissima casistica ricopriva tutte le situazioni ed era oggetto di elaborazioni
dottrinali. Le sue soluzioni erano dunque spiegate dai giuristi che avevano elaborato
una serie di argomenti generali (quali l’aequitas, la ratio iuris, l’utilitas) che
costituivano linee di orientamento del sapere giuridico e che permettevano di dare
coerenza alle soluzioni casistiche. Per questo il diritto romano rispondeva alla
generalità delle questioni e per questa sua perfezione poteva aver vigore non solo in
virtù di una sottomissione (in ragione dell’impero) ma anche per accettazione
volontaria (imperio rationis, ovvero per imperativo della ragione).
Infine la fiducia nella perfezione del diritto romano era potenziata dalla
presenza nelle più elevate cerchie del potere (imperiale, papale, reale, cittadino) di
giuristi colti formatisi all’interno del sapere universitario basato sul diritto romano.
1.1.4
L’influenza del diritto romano nella legislazione locale.
L’influenza del diritto romano cominciò a manifestarsi anche a livello di diritto
locale per il tramite di principi romanistici accolti dal legislatore: ne è un esempio il
“Breviario di Alarico”, una raccolta di diritto romano realizzata per ordine di un re
visigoto all’inizio del VI per la popolazione romanizzata del suo regno. Ma anche alcuni
notai cominciarono ad utilizzare formule negoziali tratte da testi di diritto romano.
Tutte queste formule vennero raccolte in collezione e circolarono in tutta l’Europa
occidentale secolo. Queste raccolte costituirono, nei secoli dal V al X, gli unici documenti
di una cultura giuridica scritta in un mondo in cui dominava l’analfabetismo. Più tardi la
recezione del diritto romano avvenne anche ad opera dei cancellieri reali, che usavano
le sue formule per far valere le pretese politiche del re e dell’imperatore. Sorsero così,
soprattutto a partire dal secolo XIII, fonti di diritto regio fortemente impregnate di
principi romanistici (come il “Liber Augustalis” del 1231 di Federico II di Svevia, la
legislazione inglese di Edoardo I).
1.2. Il diritto canonico
Un altro fattore di unificazione dei diritti europei è rappresentato dalla influenza
omogeneizzante del Diritto Canonico, cioè il diritto della Chiesa Cristiana.
1.2.1.
La tradizione canonistica
La Chiesa come istituzione ha sempre avuto un diritto che inizialmente derivava
dalla volontà divina rivelata nei Libri Sacri (Antico e Nuovo Testamento) e al quale i
cristiani si rivolgevano per risolvere sia i problemi interni sia i rapporti fra i credenti:
del resto il carattere clandestino del cristianesimo nei primi tre secoli rendeva
inevitabile l’inesistenza di un apparato giuridico e giudiziario.
Il tutto si modificò con la concessione della libertà di culto da parte
dell’imperatore Costantino nel 313 d.C. e con la riserva alla giurisdizione
ecclesiastica di giudicare sulle infrazioni puramente religiose: a partire dal V secolo
l’impero – e in seguito gli altri poteri temporali – riconosce alla Chiesa il privilegio
del foro, attribuendole una giurisdizione esclusiva sui chierici e nel secolo X la chiesa
si arroga la giurisdizione su tutte le materie relative ai sacramenti, e soprattutto sul
matrimonio.
Tale espansione giurisdizionale procede di pari passo con il rafforzamento
culturale e istituizionale della chiesa conseguente alla caduta dell’impero romano di
occidente (476 d.C.) che porta la chiesa ad egemonizzare i meccanismi politici e
giuridici, imponendosi ai re e tutelando le organizzazioni politiche periferiche (città e
comunità locali).
L'espansione istituzionale obbliga la chiesa a costruire un sistema normativo più
complesso in quanto i precetti contenuti nei libri sacri non si prestano più a regolare
la molteplicità di conflitti generati da una società con cultura e problemi diversi da
quelli della società ebraica della Bibbia o della comunità giudaico-romana dei tempi
di Cristo.
Le fonti della nuova regolamentazione sono i decreti dei Concili, ecumenici,
regionali, provinciali o diocesani (assemblee di vescovi di tutta la cristianità), le
determinazioni papali (decretales o costituzioni pontificie) racchiuse in encicliche,
bolle, o brevi.
Il diritto scritto della chiesa, una volta raggiunta una certa corposità, comincia ad
essere compilato su iniziativa privata nei secoli VI e VII; in particolare nel secolo XII un
monaco professore di teologia a Bologna, Graziano, realizza una compilazione – nota
come Decretum Gratiani - che rimane ancora oggi un grande deposito di diritto
canonico (essa riunisce quattromila testi organizzati commentati da “dicta” , che
corrispondono alle glosse del Corpus iuris civilis).
Seguono poi altre collezioni: il Liber Extra di Gregorio IX nel 1234, il Liber Sextus di
Bonifacio VIII nel 1298, le Clementinae, le Extravantages Communes alla fine del
quattrocento. L’insieme di queste collezioni verrà poi chiamato Corpus iuris
canonici, a somiglianza del nome dato alla compilazione giustinianea del diritto
civile e sarà mantenuto in vigore fino al 1917, data di pubblicazione del Codex iuris
canonici.
1.2.2 Il ruolo del diritto canonico nel diritto comune
Il diritto comune fu fondamentalmente un diritto romano-canonico, anche se al
suo interno iI diritto canonico aveva un peso minore rispetto a quello romano. Ad
ogni modo il diritto canonico influenzò anche alcuni punti non legati alla chiesa e
alle cose sacre in ragione del fatto che il nuovo diritto della chiesa era più recente
del diritto romano e conteneva in sé anche una parte del diritto romano riformato.
L’influenza canonistica emerge infatti in diversi campi:
nella materia riguardante i rapporti tra i coniugi,
nella valorizzazione della volontà (invece della forma) nel diritto dei contratti;
nella de-formalizzazione dei diritti sulle cose (valorizzazione del possesso
rispetto alla proprietà),
nella valorizzazione della successione testamentaria e nella deformalizzazione del testamento,
nell’esigenza della buona fede per la prescrizione,
nella valorizzazione delle soluzioni di equità (aequitas) contro le decisioni di
stretto diritto (strictum ius, rigor ius, apices iuris)
nella materia processuale civile, con la promozione della composizione
amichevole e dell’arbitrato,
nella materia processuale penale, con l’istituzione del processo inquisitorio ed
una maggiore preoccupazione per l’accertamento della verità materiale
(in particolare si fondano sull’aequitas: l’interpretazione non letterale della legge, a partire
dalla ratio legis, l’esigenza della colpa nei delitti, la valorizzazione della buona fede e
dell’intenzione delle parti nel diritto negoziale, l’ammissione del carattere giuridico e
azionabile dei nuda pacta, cioè dei contratti informali).
1.2.3 Il diritto canonico come limite di validità dei diritti temporali
La teoria canonista delle fonti del diritto proclamava la subordinazione dei diritti
umani (diritto secolare ed ecclesiastico) al diritto divino, rivelato dalle Scritture o dalla
Tradizione (insieme di abitudini o scritti dei Padri della chiesa che interpretano le verità rivelate nelle Sacre
scritture).
I diritti umani erano considerati come due modi complementari di realizzare
l’ordine voluto da Dio.
Tuttavia il precario equilibrio tra i due diritti terreni cessò con le lotte che opposero
l’imperatore e il papa (secoli X-XII, culminate con la contesa tra l’imperatore Enrico IV e papa Gregorio
VII a proposito delle investiture, lotta conclusasi con la sottomissione, anche se temporanea, dell’imperatore),
dove il primo reclamava la tutela sulla chiesa tramite l’investitura e la deposizione dei
vescovi e il secondo invece cercava di salvaguardare l’autogoverno ecclesiastico.
La teoria canonistica delle fonti affermava una supremazia del diritto canonico, in
quanto più prossimo al diritto divino, e perciò Gregorio VII stabilì il primato del papa
sui vescovi e, punto più importante, l’autonomia della chiesa e dei chierici di fronte ai
poteri temporali che aveva come conseguenza la richiesta di un foro speciale o
“privilegio di foro” per gli ecclesiastici. La sottomissione del potere temporale al
potere ecclesiastico attribuiva al papa il potere di deporre i re o di liberare i loro
sudditi dal dovere di obbedienza.
La supremazia del diritto canonico venne messa in discussione nel secolo XIII, quando
la teologia individuò nella sfera temporale fini propri, che non riguardavano la
salvezza post mortem, ma solo il buon ordine terreno, e fu chiaro che un intevento
correttivo del diritto canonico poteva giustificarsi solo quando la regolamentazione
temporale metteva in causa aspetti decisivi dell’ordine soprannaturale.
Così canonisti e civilisti, pur
riconoscendo l'indipendenza reciproca degli
ordinamenti canonico e civile (né il papa deve interferire nelle cose temporali, né l’imperatore in
quelle spirituali), stabiliscono che nei casi di conflitto grave l'ultima parola spetta
all'ordinamento della chiesa: in sintesi, Il diritto canonico deve avere vigore, come
parametro superiore, nel caso in cui l'applicazione delle fonti giuridiche terrene risulti
peccato (criterio del peccato).
Tutti questi fattori contribuirono ad uniformare i diritti locali all’ombra di un diritto
unico, rappresentato formalmente dal diritto canonico ma di fatto dal romano, in
quanto era quest’ultimo che forniva l’ossatura al primo.
1.3 Diritto recepito e diritto tradizionale
Il processo di romanizzazione dei diritti dei popoli europei non eliminò i contrasti
esistenti durante l’alto medioevo delle consuetudini generali e locali (iura propria)
con il diritto romano. In sintesi, le aree normative in cui si verificavano tali contrasti si
possono identificare:
Nell’ambito del diritto delle persone: la società di status, censitaria, tipica
dell’alto medioevo si caratterizzava per la diversità degli statuti giuridici
personali, legati alla dignità (nobili vs. villani), alla religione (chierici vs. laici)
alle professioni, al sesso e all’età, mentre al contrario il diritto romano – pur
conoscendo l’istituto della schiavitù e distinguendo tra stranieri e cittadini –
era fondamentalmente egualitario;
Nell’ambito dei diritti patrimoniali, i diritti locali europei si distinguevano per le
forti restrizioni alla disponibilità del patrimonio, che si traducevano in vincoli
posti a carico del proprietario del bene nel porre in essere liberamente atti di
alienazione inter vivos (la libertà contrattuale e testamentaria relativa ai beni
immobili era fortemente limitata, specie quando su di un bene esistevano più
poteri di disposizione e quindi il dominio era “diviso”). Di contro, il diritto
romano attribuiva al proprietario una capacità di disposizione piena,
definendo il “dominium” come il diritto di usare e abusare di una cosa (ius
utendi ac abutendi). Inoltre il diritto medievale aveva introdotto la c.d.
“patrimonializzazione” dei diritti politici (diritti di comando, giurisdizionali e
fiscali): esisteva cioè una stretta relazione tra il dominio sulle cose e il dominio
politico sulle persone. I diritti politici erano incorporati nel patrimonio dei
signori e a sua volta la titolarità dei diritti sulla terra incorporava
frequentemente attribuzioni di natura politica (non esisteva proprietà senza
signoria e ogni terra aveva un signore). Al contrario, il diritto romano
manteneva una distinzione netta tra le prerogative pubbliche –
dell’imperatore, del senato e del popolo romano – e i diritti dei privati sui beni.
Le difficoltà di recezione del diritto romano provenivano inoltre dall’assenza di una
sistematicità dello stesso che ne impediva una recezione globale: esso consisteva in
una collezione di soluzioni casistiche e poco connesse che richiedevano una
incorporazione atomizzata, cioè caso per caso, non praticabile tramite un atto del
potere politico. Tali soluzioni giuridiche potevano essere accolte solo attraverso un
paziente lavoro dottrinale e giurisprudenziale.
Un ordine giuridico pluralistico
Nella società europea medievale convivevano, quindi, diversi ordini giuridici: il
Diritto Comune Temporale (diritto romano reinterpretato), il Diritto Canonico
(diritto comune nelle materie spirituali), i Diritti Propri. Questa coesistenza di ordini
diversi in seno ad uno stesso ordinamento giuridico è detta Pluralismo Giuridico:
distinti sistemi di norme, con legittimità e contenuti distinti, che coesistono nello
stesso spazio sociale (situazione che differisce da quella attuale, in cui l’ordinamento
statuale rivendica il monopolio nella definizione di tutto il diritto lasciando alle altre
fonti, come la consuetudine e la giurisprudenza, una legittimità solo derivata).
Nella visione medievale del mondo l’ordine era un dono originario di Dio: Tommaso
d’Aquino trattò questo tema affermando che l’ordine si manteneva grazie
all’esistenza di quelle forze interne che attraggono le cose umane le une verso le altre
e che individua con l’emore e gli affetti. Questa idea di un ordine globale autosostenuto da impulsi naturali spiega il ruolo del diritto umano (civile) nel correggere
dall’esterno le deficienze occasionali di questo sistema ma anche la sua relazione con
gli altri meccanismi disciplinari (diritto, religione, affetti e amore). Il ruolo dei giuristi
non è di creare o correggere l’ordine ma solo di cercare il giusto a partire dalla natura
e traendolo dalla sensibilità umana.
2.1 Una costellazione di ordini normativi
Il cemento dell’ordine del mondo e della società era individuato negli amori, ognuno
dei quali corrispondeva ad un tipo di relazione sociale (amore familiare, filiale o
parentale, amore dei vassalli, dei concittadini, dei commilitoni). Tutti questi amori
creavano obbligazioni, cui si aggiungevano quelli nascenti dalla religione (amore di
Dio e di tutte le sue creature). Fra loro esisteva una gerarchia, che Tommaso d’Aquino
traccia nella sua Summa theologica secondo il criterio decisivo della prossimità alla
fonte dell’ordine (Dio, la natura). Pertanto la rivelazione e il diritto divino si trovavano
al primo posto nell’insieme degli ordini normativi; seguiva il diritto canonico
“positivo”, perché più esterno e dipendente dalla volontà degli uomini.
Dopo il diritto divino venivano gli ordini normativi in cui la natura “parla forte”, come
l’ordinamento domestico, parzialmente sottoposto al diritto divino a causa del
carattere sacramentale del matrimonio: qui le norme derivavano dalla natura.
Ma, al pari della famiglia, anche altre relazioni umane avevano pretese “naturali” di
fronte al diritto, come nel caso dei contratti (che la cultura attuale considera invece
arbitrarie e disponibili): qui il concetto coniato per esprimere le norme implicite ed
obbligatorie era quello di “natura” del contratto o “veste” dei patti (vale a dire che
senza cttributi formali i nudi patti non potevano avere valore).
I canali di comunicazione tra i diversi ordini erano costituiti dall’esistenza di concetti
generici, mentre le gerarchie fra gli stessi erano sensibili al contesto: invece di un
sistema fatto di livelli normativi già definiti, come nel sistema delle fonti del diritto
contemporaneo, il diritto comune costituiva una costellazione aperta e flessibile di
ordinamenti la cui architettura poteva essere fissata solo di fronte ad un caso
concreto.
In questa costellazione ciascun ordine normativo aveva la soluzione e i suoi principi
generali:perciò toccava al giudice fornire una soluzione arbitrale, intorno alla quale
potesse crearsi armonia (guidato degli usi del tribunale nel giudicare casi simili).
2.2 Una costellazione di ordini normativi
GERARCHIA DELLE FONTI:
1. Diritti Propri o lura Propria (Diritto dei Regni, Statuti delle Città,
Consuetudini Locali, Privilegi Territoriali e Corporativi);
2. Diritti Particolari (Diritto Canonico, Diritto Mercantile o Lex Mercatoria);
3. Diritto Comune o lus Commune (Diritto Sussidiario: si applicava a tutte
le situazioni non previste dai Diritti Propri e Particolari).
La successione delle leggi nel tempo non implicava, come accade oggi, la
cessazione della loro vigenza quando fossero sopravvenute nuove leggi a regolare la
stessa materia: diritto nuovo e diritto antico, anche se divergenti, potevano essere usati
per risolvere un determinato caso.
L'insegnamento del Diritto Giustinianeo presso l'università di Bologna (metà
del secolo XII), diede origine alla. Scuola dei Glossatori il cui fondatore fu Irnerio. Il
metodo dei giuristi che compivano l'analisi del testo giuridico consisteva nel dare
spiegazione del Corpus luris oscuro e di difficile interprelazione. Si ottenne una
semplice interpretazione (Glossa), una sintesi (Summa), regole dottrinali (Regulae),
disquisizione di questioni controverse (Disputae), elenchi di argomenti utilizzabili
durante il dibattito giuridico (Argumenta), l'analisi di casi pratici (Casus).
Ai Glossatori deve essere riconosciuto il merito di avere ricreato il linguaggio
tecnico del diritto: la giurisprudenza. Con l'avvento dell'economia mercantile e
l'espandersi dei centri urbani nei secoli XIII e XIV divenne necessario che i principi
del diritto (lura Propria, lus Commune, lus Volgare, lus Canonici) si trasformassero
in un solo diritto. Questo fu il compito di una nuova generazione di giuristi
chiamati Commentatori. Il fondatore della Scuola dei Commentatori fu Cino da
Pistola ma il più influente fu Bartolo da Sasso/errato il quale creò un'opera
monumentale. Per tale motivo venne creato il detto NEMO IURISTA NISI
BARTOLISTA (nessuno è giurista se non è Bartolista). I commentatori costituirono
una categoria di giuristi ai quali venne affidato il compito di risolvere i conflitti
facendo ricorso a una tecnica razionale: il conflitto tra fede e ragione provocò
difatti il ristabilirsi della fiducia nella ragione e la ripresa delle scienze profane. Si
instaura un atteggiamento fìlosofìco Realista (che indaga sulla natura delle cose)
e Razionalista (che usa i procedimenti razionali). La categoria dei giuristi ha un
ruolo determinante per l'equilibrio politico e sociale. L'origine del diritto ha
sempre costituito, in tutte le epoche e tutte le società, fonte di dibattito: le
posizioni dei giuristi hanno oscillato tra Volontarismo (il diritto è prodotto della
volontà divina, volontà del legislatore, volontà generale, guidata da principi arbitrar
i) e Razionalismo (il diritto è un ordine prestabilito insito nella natura umana e
delle cose, accessibile con l'uso della ragione). Sostenitore del Volontarismo è
Sant'Agostino (354-430 d. C.) il quale asseriva che l'unica fonte del diritto e la
volontà di Dio e i poteri costituiti hanno autorità per una sorta di mandato divino.
Con l'avvento della Scolastica (sapere delle scuole) e la rinascita
dell'insegnamento laico (secolo XII) il Diritto Divino (contenuto nelle Sacre
Scritture) e il Diritto Positivo (emanato dal monarca) non rappresenta la soluzione
giusta.
Tommaso D'Aquino, sostenitore di questa teoria, ritiene che il diritto risiede
nella ragione (Recta Ratio) e la soluzione giuridica non può considerarsi pronta
nelle fonti, ma deve essere trovata attraverso una specifica e precisa tecnica di
investigazione.
Riepilogando si può affermare che i Glossatori sostenevano il Volontarismo
(erano inclini ali'acccttazione dell'autorità religiosa e giuridica), mentre i
Commentatori sostenevano il Razionalismo (erano inclini alla logica della
scolastica). La scolastica basava l'interpretazione delle leggi (Ratio Legis) sulla
dialettica (arte di discutere) aristotelica-ciceroniana (Topica), ovvero la tecnica di
trovare punti di vista (Topoi) a partire dai quali una qualsiasi questione poteva
essere affrontata. I giuristi acquistarono la capacità di individuare le prospettive
dalle quali un istituto giuridico può essere studiato:
D Prospettiva della Definizione: indicazione della categoria di
appartenenza dell'oggetto (Genus) e delle caratteristiche che lo
distinguevano dagli altri appartenenti alla stessa categoria (Species); D
Prospettiva della Comparazione: ragionamento per analogia; D
Prospettiva dell'Autorità: si fondava sulla presunzione che l'autore
invocato, che aveva commentato il Corpus luris, fosse un profondo
conoscitore della materia e per tale motivo autorevole.
8
CAP. VI – LA CRISI DEL CINQUECENTO E GLI
ORIENTAMENTI METODOLOGICI SUCCESSIVI
Si possono individuare TRE FASI:
Secoli XII e XIII: predominio del diritto romano e canonico su tutte le altre fonti
concorrenti, ammesse solo se non contrastanti con il diritto comune
Secoli XIV e XV: affermazione degli IURA PROPRIA come fonte primaria degli
ordinamenti particolari, il cui valore si equilibria con il diritto comune, nel
senso che vengono pienamente integrati nel IUS COMMUNE romanogiustinianeo
Secolo XVI: crisi nella dottrina giuridica europea che segna un’aperta
supremazia del diritto dei regni e delle città sul IUS COMMUNE elaborato dai
giuristi del trecento, relegandolo nella posizione di diritto sussidiario.
Secoli XVII e XVIII: In Europa le dottrine giusnaturalistiche assumono
un’importanza rilevante, fortemente influenzate dal razionalismo, nonostante
l’origine di tali dottrine sia riconducibile all’antichità classica. Si sviluppano le
scuole di diritto naturale: giusnaturalismo della tomistica, declino con
volontarismo vs. razionalismo, scuola iberica del diritto naturale e
giusnaturalismo moderno.
La crisi del Cinquecento
Tale crisi riguarda soprattutto quei settori in cui il diritto romano era carente sotto il
profilo del contributi teorici e pratici e cioè:
il diritto pubblico
il diritto penale
il diritto commerciale (soprattutto per questo
LE SCUOLE GIURIDICHE DEL SEI E
SETTECENTO
Il pensiero scolastico di S. Tommaso d’Acquino contrappone alla volontà di Dio, unica
fonte del diritto accettata dalla teoria agostiniana, il diritto naturale, anteriore al
diritto positivo e iscritto in un ordine naturale stabilito da Dio, al quale egli stesso
obbedisce secondo la teoria delle “cause seconde”: cioè Dio, causa prima di tutto,
imprime nella natura - per economia di mezzi – leggi naturali, cause seconde,
funzionali al mantenimento dell’ordine. L’uomo stesso avrebbe una determinata
natura che risponderebbe a regole serventi all’ordine e al destino cosmico: tali regole
costituirebbero il diritto naturale e sarebbero formulate in parte nelle Scritture
(diritto divino) e altre rese manifeste dallo stesso ordine del mondo e conoscibili
dall’uomo con un uso corretto della ragione (recta ratio).
Tale conoscenza poteva ottenersi facendo ricorso a facoltà razionali (ragione) e a
facoltà morali (virtù), cioè possedendo anche la virtù della bontà che permetteva di
distinguere il giusto dall’ingiusto (lo iustum ovvero la soluzione giusta, che
costituisce lo scopo del diritto e che è scritto nell’ordine naturale stabilito da Dio). La
ragione quindi doveva avere una qualificazione morale per essere efficace: doveva
essere un “buona ragione” ossia un recta ratio.
Tuttavia la mobilità delle cose umane che si riflette nella libertà dell’uomo, non
consentiva la formulazione di un codice di regole permanenti e quindi alla pretesa di
una scienza del diritto naturale S. Tommaso sostituisce la proposta di un ‘arte di
trovare il giusto caso per caso, rifacendosi agli insegnamenti di Aristotele.
LA SCUOLA IBERICA DI DIRITTO NATURALE
La scuola iberica di diritto naturale costituisce uno sviluppo locale della scolastica di
S.Tommaso in quanto nasce nelle università ispaniche della Controriforma, specie
Salamanca, Valladolid, Coimbra ed Evora. I protagonisti – quasi tutti gesuiti e
domenicani - sono:
Francisco de Vitoria (1492-1546)
Domingo de Soto (1494-1560)
Luis de Molina(1535-1600)
Francisco Suarez (1548-1617)
(vedi schede)
Nonostante la fedeltà dichiarata a S.Tommaso questa scuola si allontana,
reinterpretandole in funzione moderna, dalle posizioni tomistiche, specie proprio
dalla dottrina del diritto naturale.
I contributi più significativi della scuola iberica si possono così sintetizzare:
Laicizzazione del diritto: la teoria tomistica delle “cause seconde” viene
estremizzata, nel senso che la natura è considerata talmente autoregolata che
tale regolazione sussisterebbe anche se Dio non esistesse (tale aspetto, che poi
verrà ripreso da Grozio, non è presente in tutti i rappresentanti laddove,
infatti, SUAREZ – sulla scia di Ockham (vedi scheda sull’occamismo) - adotta
un orientamento volontaristico esaltando il potere costitutivo della volontà
arbitraria di Dio);
Radicamento del diritto nella ragione
individuale con conseguente
promozione a fonte del diritto della recta ratio : riprendendo le affermazioni
del giusnaturalismo stoico gli iberici sostengono la conoscibilità delle leggi
naturali da parte della ragione individuale (purché sia “retta”).
Logicizzazione del diritto: attraverso la ragione e i suoi meccanismi logici si
perviene al diritto per via deduttiva (SUAREZ introduce quella che sarà la
metodologia giuridica moderna e cioè dedurre le regole con un contenuto
preciso, eterne e immutabili, dai principi razionali del diritto: dalla legge
naturale, che contiene principi morali generali si deducono regole che con
questi hanno un nesso necessario ed evidente)
IL GIUSNATURALISMO RAZIONALISTA (GIUSRAZIONALISMO)
Se le specie vegetali e animali sono destinate a vivere ed agire secondo leggi
biologiche e istintive, la natura dell’uomo è quella di essere un animale razionale che
per potere agire deve determinare i propri obbiettivi e i mezzi con cui raggiungerli.
Dunque l’agire umano per essere efficace deve inevitabilmente fare ricorso a una
capacità prettamente umana, la razionalità.
La legge di natura va ricavata dalla natura dell’uomo, visto geneticamente e
dinamicamente nella predisposizione verso i fini propri, riconoscibili tramite la
ragione umana. La ragione, come il suo utilizzo, non rappresenta il fine dell’uomo,
ma solamente lo strumento di indagine della natura della ragione medesima.
La teoria moderna postula l’esistenza di un complesso di regole autoevidenti di
giustizia e di valori etici universali che hanno il loro fondamento nella natura
razionale dell’uomo.
Per gli stoici il concetto di natura, da cui discendeva il diritto naturale, era inteso
diversamente dalla tradizione aristotelica (la natura rappresentava il fine verso il
quale tendono le cose e, in particolare, gli esseri viventi la cui natura li porta ad
associarsi con gli altri essendo soggetti “naturalmente politici”), in quanto
considerata come causa del cosmos (cioè dell’ordine del mondo) e negli uomini tale
logos è costituito dalla ragione.
Ne discende che per gli stoici la natura è fonte del diritto, cioè il diritto positivo deve
seguire i dati naturali o comunque deve fondarsi sui comandi della ragione.
Tale dottrina ha origine nell’opera di Cicerone che definisce il diritto naturale, ossia
la legge naturale, una legge concordante con la natura, diffusa in tutti, immutabile
ed eterna, che identifica nella retta ragione , i cui precetti e proibizioni l’uomo buono
(honestus) rispetterà sempre; qualsiasi modifica di tale legge sarà sacrilega.. è
l’unica e medesima legge, immutabile, eterna, che abbraccia in tutti i tempi tutte le
nazioni. Un Dio unico, signore e imperatore di tutte le cose, la deliberò e la
promulgò.
In sintesi possono riassumersi le seguenti idee:
1. Esiste una legge naturale, eterna, immutabile, promulgata dall’Ordinatore del
mondo;
2. Tale legge può essere conoscibile da tutti purché si segua la retta ragione,
ossia la ragione dell’uomo che rispetta le proprie inclinazioni naturali (homo
honestus, qui honeste vivit);
3. Il diritto naturale è costituito da norme precise, da leggi generali e chiare,
sicché non è necessario un tecnico per interpretarle, trattandosi di regole del
vivere che la buona ragione suggerisce a ciascuno.
Per Cicerone non c’era contrapposizione tra diritto naturale e diritto positivo, in
quanto il secondo costituisce il coagulo del primo che tende a concretizzarsi nel
diritto positivo.
IL GIUSRAZIONALISMO MODERNO
Dalle componenti di origine stoica nasce la dottrina moderna del diritto naturale che
fu influenzata, nell’opera concettuale di un diritto naturale stabile come la ragione
stessa, anche dall’idealismo cartesiano. Cartesio influenzò soprattutto i giuristi che
cercavano la certezza, definendo per le discipline giuridiche (fino ad allora carenti di
fondamenti fermi e solidi) un metodo che fornisse basi solide come quelle
matematiche, fondato sulle seguenti regole:
1. L’evidenza razionale, che non ammetteva come verità nulla che non sia
evidente per lo spirito
2. L’analisi, che richiede di dividere ogni problema in tanti elementi minori quanti
sono necessari a risolverlo
3. La sintesi, che porta ad iniziare dagli elementi più facili per progredire via via
verso quelli più complessi
4. La revisione generale, che permette di controllare eventuali omissioni nel
corso della ricerca
Riepilogando tale metodologia ricorre all’evidenza razionale dei principi primi del
diritto e alla loro estensione tramite la deduzione, cioè al potere della ragione
individuale di scoprire le regole del giusto, di un giusto radicato in un ordine
razionale, quasi matematico, della natura di cui era partecipe la ragione.
ALCUNE SCUOLE GIUSNATURALISTICHE
L’idea del diritto naturale, nella sua nuova accezione, si impose in maniera decisiva –
grazie anche alla scuola iberica - nella cultura giuridica europea del secolo XVII. Il
moderno diritto naturale fondato sulla ragione ebbe la stessa rilevanza di quello
antico fondato sulla teologia; sul processo di laicizzazione del pensiero sociale e
giuridico influì il venir meno dell’unità religiosa europea a seguito della Riforma che
portò a individuare il fondamento del diritto nei valori laici, comuni a tutti gli uomini,
come le evidenze razionali.
I moderni giusnaturalisti accedono all’ordine della natura tramite l’osservazione –
della storia e della vita contemporanea al fine di rilevare i caratteri permanenti della
natura umana e le differenze locali – ma soprattutto tramite la ragione. Questa, al
pari della matematica e della fisica identificava gli assiomi sulla natura dell’uomo
(es: l’uomo è governato dall’istinto di conservazione; ha un diritto naturale
all’autodifesa e alla punizione delle ingiurie; la volontà generale è maggiore della
somma delle volontà particolari) e definiva i procedimenti intellettuali
(corrispondenti ai ragionamenti della fisica e della matematica) capaci di dedurre
altre norme dagli assiomi.
La giustizia – scrive LEIBNIZ – segue regole certe di uguaglianza e di proporzionalità
che non sono meno fondate nella natura immutabile delle cose dei principi
dell’aritmetica e della geometria.
Con tali modelli matematici di argomentazione ROUSSEAU (1712-1778) costruisce
ampi passi del Contratto sociale , in particolare le relazioni fra Stato, sovrano e
governo.
Pertanto il modello complessivo della natura è meccanicistico, ispirato dalla fisica del
tempo, che prescinde dalla dimensione sovrannaturale e si concentra quindi sulle
spiegazioni di livello temporale (fisico): in tale mondo la natura dell’uomo non è
identificata riflettendo sul suo fine ultimo (Dio, la salvezza, la vita in comune) ma
sulle cause delle sue azioni (la volontà e l’istinto). L’individuo diventa il punto
d’appoggio di tutte le costruzioni del diritto naturale anche se cambiano le visuali da
autore ad autore: alcuni pongono in evidenza l’impulso alla conservazione
individuale, altri il desiderio di felicità, altri ancora l’istinto della proprietà o la ricerca
dell’utilità o, infine, la dipendenza dell’individuo dalla società per garantirsi la
sopravvivenza individuale.
Negata l’esistenza di un ordine sociale naturale, si sviluppa l’idea che la creazione
dell’ordine politico avviene mediante un accordo di volontà guidato sempre dalla
ragione
Riportiamo di seguito i diversi orientamenti giusnaturalistici
1. I giusnaturalismi individualistici
Appartengono a questa corrente i pensatori che costruiscono i propri sistemi
giusnaturalistici partendo dagli istinti innati dell’individuo
CAP. VIII - IL DIRITTO DELL’ETA’
CONTEMPORANEA
1. IL CONTESTO POLITICO
Sul piano giuridico la fase successiva al giusrazionalismo è caratterizzata dal
movimento legalista e dalla tendenza alla codificazione (quest’ultima introduce una
tecnica normativa fondata sulla generalità e sistematicità funzionale alle esigenze di
certezza e prevedibilità del diritto richieste dalla quotidianità).
Nei cento anni che vanno dal 1750 al 1850 si assiste all’affermazione di un nuovo
ordine politico e giuridico che si usa chiamare liberalismo. Presupposti
dell’ordinamento giuridico liberale sono, sotto il profilo dell’organizzazione politica
uno Stato liberale rappresentativo e sotto quello dell’organizzazione sociale un
liberalismo proprietario, cioè l’individuazione della proprietà come condizione di
libertà e cittadinanza attiva.
Sul piano dei grandi principi il nuovo diritto stabilisce la libertà, la proprietà e
l’uguaglianza di fronte alla legge. L’affermazione di tali principi, in particolare della
libertà personale, aveva conseguenze nel diritto costituzionale, con il riconoscimento
dei diritti politici e civili e della libertà di lavoro e d’impresa, nell’ambito dei diritti
privati con la costruzione giuridica della proprietà come diritto illimitato ed
inviolabile, nel diritto dei contratti dove si promuoveva il volontarismo con
conseguente eliminazione di ogni limitazione dettata dall’etica.
La garanzia della proprietà – estensione della garanzia della libertà personale – era
intesa come un diritto sacro ed inviolabile, naturale ed assoluto, liberamente fruibile
e liberamente disponibile non limitato da altri diritti (signorili, comunitari o
familiari).
La garanzia dell’uguaglianza assicurava in linea di principio la partecipazione di tutti
alla vita politica tramite il suffragio universale e l’uguaglianza nell’applicazione indipendente dallo statuto personale del singolo - della legge, specie in campo
processuale e penale.
Tuttavia, in fase di concretizzazione costituzionale e legislativa, ciascuno di questi
principi subì limitazioni, specie il principio di eguaglianza con riferimento non solo
all’applicazione solo formale e non sostanziale di tali libertà, ma anche alla
persistenza delle discriminazioni specie di genere.
2. TRA VOLONTA’ E RAGIONE
2.1 Democrazia rappresentativa e legalismo
Tutte le rivoluzioni politiche dell’epoca (nel 1976 nell’America del Nord, nel 1789 in
Francia e nel 1848 nella maggior parte dei paesi europei) sono alimentate dal
principio democratico secondo il quale l’unica legittimazione politica (con
conseguente esercizio del potere) era quella derivante dalla volontà popolare
manifestata dai rappresentanti eletti negli organi rappresentativi: l’egemonia del
parlamento e della conseguente facoltà di creare il diritto discendeva dal principio
della sovranità del popolo. Tale egemonia – propugnata dal giacobinismo garantiva sia la degenerazione democratica tramite il controllo sull’esecutivo
(controllo democratico) sia il perseguimento dell’interesse generale.
Conseguenza del principio democratico era la considerazione della legge quale fonte
prima, in quanto espressione della volontà popolare, depurata da interessi
particolari, e che esprimeva quindi un interesse generale volto al perseguimento
della felicità. Di fronte alla legge parlamentare anche la consuetudine doveva cedere
pur se non eliminata, in quanto espressione di un “consenso tacito del popolo”; così
pure la giurisprudenza, in quanto la magistratura fondava la sua legittimità solo
indirettamente dalla costituzione che prevedeva tale potere. In particolare in Europa
si assiste ad una rivoluzione politica contro i giudici - i quali, stante il carattere
casistico e flessibile del diritto tradizionale, rendevano il diritto imprevedibile e
incontrollabile dai cittadini – che portò a considerare la necessità che i verdetti dei
giudici non si discostassero dalla stretta applicazione della legge (ad essi veniva
negato pertanto quel ruolo attivo di creazione del diritto e di controllo della
legittimità delle leggi che troviamo ai nostri giorni).
A rafforzare questa ultima affermazione si richiamava il principio della separazione
dei poteri formulato da Montesquieu (accolto dai nuovi Stati costituzionali) che
richiedeva l’assenza di interferenze tra i tre poteri (esecutivo, legislativo e
giurisdizionale) e in particolare del potere giudiziario nei confronti del potere
legislativo cui spettava in via esclusiva il potere di emanare il diritto, quale
manifestazione della volontà generale.
La perdita di autonomia nella creazione del diritto riguarda anche la dottrina, che nel
nuovo Stato democratico si occupa solo di descrivere le leggi ed interpretarle, ma in
modo il più possibile conforme alla volontà del legislatore storico (c.d.
interpretazione soggettiva) integrando la norma solo in modo coerente con le linee
del legislatore; in alcune situazioni estreme si giunse anche a proibire
l’interpretazione dottrinale - che fino ad allora aveva prodotto costruzioni autonome
fondate sulla natura delle cose o sui principi della ragione - ricorrendo al ricorso
dell’interpretazione autentica dell’organo legislativo (c.d. référé législatif).
Tale filone legalista-democratico, che è il riflesso sul piano giuridico del volontarismo
politico-filosofico, riconosce solo la legge quale fonte di tutto il diritto in
contrapposizione al filone opposto che sottolineava i limiti posti alla legge dai “diritti
originari” e dalla natura delle cose.
In tale contesto legalista l’idea del codice è ambivalente: da un lato, lo stesso
garantisce, grazie alla sistematicità dei precetti normativi, la conoscenza della legge
da parte dei cittadini e il loro controllo sul diritto, dall’altro costituisce un corpo che
tende a durare e resistere al tempo e ai mutamenti di regime (vedi i grandi codici del
secolo XIX come il codice napoleonico del 1804 e il codice tedesco del 1900),
collocandosi ad un livello superiore a quello della legislazione ordinaria.
2.2 “Ragione giuridica” e “ragione popolare”
Ciò che caratterizza il pensiero giuridico degli ultimi due secoli è la reazione contro la
riserva esclusiva della produzione del diritto in favore delle assemblee
rappresentative e la connessa espropriazione del potere costituente di una intera
élite culturale che aveva avuto fino ad allora il monopolio di “dire il diritto”.
In proposito Benjamin Constant (1767-1830) illustra i vantaggi di un sistema di
rappresentanza politica che, rispetto alla libertà degli antichi, sollevava la comunità
dei cittadini dal preoccuparsi degli interessi collettivi, la cui cura veniva delegata ad
alcuni politici di professione scelti dal popolo. Per Constant si trattava, peraltro, non
di esonerare i cittadini da un compito gravoso, ma di una vera e propria incapacità
del cittadino comune di decidere dell’interesse generale.
2.2.1 La tradizione
Numerosi filoni di pensiero politico contemporaneo hanno cercato di spiegare i
motivi che impediscono al popolo di statuire liberamente (attraverso i propri
rappresentati eletti) il diritto.
Uno di questi filoni valorizza la Costituzione e il diritto come eredità della
tradizione, che non sono modificabili dai processi di evoluzione “naturale” delle
società. In proposito, sul piano della filosofia politica, il difensore più antico è
l’irlandese Edmund Burke (1729-1797) che, avendo come esempio la rivoluzione
francese, ritiene illegittima una modifica decisionista e rivoluzionaria della
costituzione, che non deve essere concepita come il prodotto di un contratto, ma
della tradizione a garanzia delle leggi e delle libertà; tali concetti sono legati ad
una diversa concezione della sovranità, vista non come proprietà di una
generazione, ma di una tradizione di molte generazioni e, quindi, una sovranità
che risiede nella nazione, cioè una realtà storica, fatta di passato, presente e
futuro, in cui la generazione attuale appare sprovvista di poteri costituenti.
Idee simili si sviluppano anche nel continente tedesco con Friedrich Carl von Savigny
(1779-1861), che individuava l’origine del diritto nello “spirito del popolo” espresso
nelle sue istituzioni e manifestazioni culturali e afferrabile con l’ascolto della storia
giuridica affidata ad èlites colte e cioè il diritto di tradizione colta, giudiziaria o
accademica.
L’idea che le istituzioni, i fatti e gli assetti concreti della vita sociale rappresentino la
vera costituzione e il vero diritto si trova sotto varie vesti lungo tutto il secolo XIX e
XX, come base di dottrine critiche verso le idee del contratto sociale e di sovranità
popolare: secondo tali scuole sociologiche e realiste (Bentham,Marx) il diritto deve
essere cercato nella vita, negli aggregati sociali sorti spontaneamente dalla divisione
del lavoro e dalla solidarietà (istituzioni).
2.1.2. I diritti individuali
Per altre correnti le forze creatrici del diritto, che resistono alla libera formazione da
parte della volontà del popolo, sono i valori e le idee: innanzitutto i diritti naturali
degli individui, preesistenti alla legge positiva e la cui protezione costituiva la ragion
d’essere della società civile e quindi dello Stato e della legge.
Si tratta delle idee espresse da John Locke (1632-1704) e da Montesquieu (16891755): per tali autori la vera costituzione e quindi il nucleo fondamentale del dirittto
risiedeva nella combinazione spontanea dei diritti individuali, anteriori e indipendenti
da qualsiasi potere costituito, e qualsiasi legge non compatibile con tali regole
veniva considerata dispotica e abusiva.
In virtù di tali idee i coloni del Nord America risposero al parlamento inglese che
voleva imporre le tasse senza il consenso delle assemblee legislative locali: tale
intromissione fu considerata abusiva non solo per l’assenza di rappresentanza (no
taxation without representation) ma perché violava il libero gioco dei diritti
individuali. Pertanto nell’assetto costituzionale nordamericano risulta evidente l’idea
dello Stato minimo necessario a garantire i diritti preesistenti (la società civile è
composta di individui singoli, separata rispetto allo Stato e gelosa della sua
autonomia) che limita l’altra idea centrale della sovranità popolare:la compatibilità
fra tali due idee fu realizzata dal principio repubblicano del governo limitato. Cioè
l’obiettivo fondamentale era di creare un governo forte e autorevole espressione
diretta del consenso popolare ed al contempo di porre robusti argini all’abuso del
potere. Quest’ultimo obiettivo veniva perseguito attraverso la previsione di una serie
di poteri e contropoteri al vertice dello Stato (separazione dei poteri nell’ambito di un
sistema di freni e controlli reciproci, controllo giudiziario di costituzionalità della
legge) e dalla divisione “verticale” del potere tra i distinti livelli territoriali di governo.
Tale modello introdusse nel mondo giuridico-politico l’idea del controllo
costituzionale della legge affidato a giudici - ai quali spettava l’ultima parola sul
diritto statuito – appartenenti ad una magistratura elettiva che operava nei limiti di
una Costituzione approvata democraticamente (1787).
Il liberalismo nordamericano influenzò il pensiero giuridico e la politica del diritto
dell’Europa continentale specie con riguardo al problema dei limiti del governo:
Montesquieu ribadiva l’equilibrio che doveva esistere sia tra Stato e corpi intermedi
sia fra i poteri costitutivi dello Stato (teoria della separazione dei poteri).
L’esperienza francese postrivoluzionaria dell’asemblea generale nella quale erano
stati accentrati tutti i poteri ravvivò l’esigenza di evitare un nuovo dispotismo
riaffermando il prevalere dei diritti originari sulla volontà degli eletti del popolo
(governo liberale). Quest’ultimo tema venne affrontato criticamente Tocqueville in
relazione alla crescita della burocrazia statale che invadeva e condizionava la libertà
dei singoli e al contenuto di stampo socialista della costituzione francese del 1848
che consacrava il diritto al lavoro e all’assistenza pubblica.
La diffidenza nei confronti dello Stato che caratterizza tutte le varie forme di
liberalismo si fonda sul presupposto che la società sia naturalmente giusta perché il
diritto nasce spontaneamente dalle transazioni sociali tra individui anch’essi
naturali, cioè che agiscono secondo regole razionali: ovviamente il modello
originario dell’antropologia liberale è chiaramente quello dell’uomo d’affari e, per
estensione, dei proprietari e, in genere, delle persone abituate a calcolare
razionalmente i rischi e i proventi delle loro imprese. Il modello liberale si basava sui
gentlemen’s agreement e quindi faceva riferimento al carattere sociale e politico
della gentry (classe sociale inglese del XVII secolo intermedia tra l’aristocrazia e la borghesia,
costituita dai grandi e dai piccoli proprietari terrieri e dai piccoli ereditieri, detti gentlemen) .
La sua estensione ad altri campi e ad altri strati sociali doveva avvenire attraverso
un’opera di ricostruzione da parte dello Stato della società civile al fine di stimolare
l’adozione di modelli razionali di condotta anche in quei settori che nulla hanno a che
vedere con l’economia, come l’educazione, la salute, la sicurezza sociale: questo
aspetto “costruttivo” dello Stato ha caratterizzato il neoliberalismo proposto dopo la
seconda guerra mondiale dalla “scuola di Chicago” in America.
___________________________________________________________________________________________________________________________
_
Il neoliberismo
Friedman vs Keynes
Il neoliberismo è una costola del capitolo globalizzazione, incredibilmente sottovalutata nella storia
contemporanea. Nei libri di storia, specialmente nei manuali scolastici, la questione è trattata en
passant riferendosi a Ronald Reagan e Margaret Thatcher: i leader conservatori che ai primi anni
ottanta hanno introdotto, in politica interna, radicali riforme in senso liberista. In realtà i
protagonisti di questa storia, dalle radici profonde e dagli effetti globali, sono molti di più, anche se
meno “popolari”.
Friederich von Heyek e Milton Friedman per esempio. I guru ideologici di questa dottrina economica.
Oppure John Maynard Keynes, il padre fondatore della politica di intervento statale coordinata su
scala mondiale che ha dominato la scena della ricostruzione del dopoguerra. Ma anche Augusto
Pinochet, il dittatore cileno che l’11 settembre 1973 prese il potere con un golpe sanguinoso, così
come fecero pochi anni dopo i generali argentini e i militari in Brasile. La lista può contare anche
volti noti per la politica come Boris Eltisn, Carlos Menem e Donald Rumsfield, fino ad arrivare a
esponenti dei vertici delle istituzioni finanziarie sovranazionali (BM, FMI, WTO) decisamente
sconosciuti per l’opinione pubblica, come Jeffrey Sachs e John Williamson.
Tutto iniziò nel XVIII secolo con Adam Smith e la sua teoria della “mano invisibile”; David Ricardo
formulò la teoria del libero scambio partendo dalla condizione dell’Inghilterra della prima
rivoluzione industriale: un paese dominante nel mondo, all’avanguardia tecnologicamente e con un
vasto impero coloniale da sfruttare. Su quella base teorica furono abolite le corn laws (dazi doganali
a protezione del grano britannico) e propugnato il laissez-faire (nessuna ingerenza dello stato
nell’economia e nella società) come ricetta universalmente valida per lo sviluppo industriale. La
coincidenza con il progresso politico - Usa e Gb erano le democrazie più avanzate - indusse
intellettuali, studiosi, politici e osservatori a utilizzare come logico e consequenziale il connubio tra
libertà di mercato e libertà individuale. Malgrado la crisi di fine Ottocento e i primi interventi dello
stato in economia e nella società, ancora tra le guerre il laissez faire appariva come il “modello” di
riferimento.
Fu la crisi del 1929 e la grande depressione che seguì (“Great Slam”) a porre in agenda una modo
diverso di gestire le economie su grande scala, per armonizzare al meglio lo sviluppo interno di uno
stato, i commerci internazionali e il valore delle monete che, in estrema sintesi, determina la capacità
delle varie nazioni di scambiare ricchezza.
Pioniere di un’altra economia possibile fu il britannico John Maynard Keynes con il fondamentale
testo The General Theory of Employment, Interest and Money (1936). L’esperienza politica della
socialdemocrazia svedese stava già elaborando piani di profonda integrazione tra libero mercato e
azione socio-economica dello stato; il crollo dell’economia americana del 1929 segnò la fine della
fiducia nel sistema del libero scambio e la nuova amministrazione di Frank Delano Roosevelt ideò il
“New Deal”. Il “nuovo corso” significò grande impegno da parte dello stato per promuovere lavori
pubblici, mettere a punto piani di assistenza sociale, sviluppare politiche economiche orientate al
progresso in tutti gli aspetti per l’intera popolazione. L’obiettivo fu sostenuto da una prassi, da un
metodo di lavoro che ancora oggi illumina gli occhi di chi lo ha vissuto: “Quando Sachs parla con
tono appassionato di “lavoro serio”, evoca i giorni del New Deal, della Grande società e del Piano
Marshall, quando i giovani laureati dell’Ivy League sedevano attorno a tavoli di quercia a
Washington, in maniche di camicia, circondati da tazze di caffè vuote e documenti, impegnati in
lunghi e accaniti dibattiti sui tassi di interesse e il prezzo del grano. È così che agivano gli strateghi
politici ai tempi d’oro del keynesianesimo (…).
Le macerie della seconda guerra mondiale offrirono l’occasione per ricostruire su basi nuove.
Sancito il fallimento del sistema di laissez-faire e con la necessità di contrastare l’espansione del
movimento comunista guidato dall’Urss, tutto l’occidente abbracciò politiche di ispirazione
keynesiana.
Non è vero che dalla storia non si impara. A differenza del 1919 gli Stati Uniti furono in prima linea
per la ricostruzione: promossero e accolsero la sede ONU (a New York), vararono il Piano Marshall
per sostenere le economie di ricostruzione dell’Europa occidentale, concordarono a Bretton Woods
(cittadina americana nello stato del New Hampshire) un sistema finanziario basato sul cambio fisso
con il dollaro e l’istituzione di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale: tutte misure prese
esplicitamente per aiutare lo sviluppo dei paesi poveri e per evitare crisi economiche devastanti.
La storia del neo-liberismo nasce come opposizione al meanstream degli anni d’oro ’50 -‘70, che era,
come abbiamo visto, profondamente ispirato alle teorie economiche di Keynes. Malgrado la crescita
record delle economie una piccola cerchia di professori e studenti sviluppò una nuova dottrina antikeynes. Il centro di questa corrente di pensiero fu l’Università di Chicago e il grande ideologo fu
l’economista di scuola austriaca Friederich von Heydek. Le sue lezioni propugnavano un mondo
ideale totalmente regolato dalle leggi economiche, senza interferenze da parte dello stato. Un mondo
ovviamente irreale; nella realtà invece milioni di persone in Europa e in America, negli anni ’50
poterono curarsi gratuitamente, percepire reddito anche in situazioni di malattia, infortunio, ferie,
disoccupazione; accedere a una pensione di anzianità; usufruire di strutture decenti per l’istruzione,
l’assistenza all’infanzia; usufruire di efficienti sistemi di trasporto ferroviario, strade nuove e
scorrevoli, quartieri finalmente vivibili…eccetera eccetera. Le economie “aiutate” dai capitali statali,
spesso da aziende nazionalizzate, fornivano servizi essenziali a prezzi irrisori: luce, acqua, gas
diventarono comuni nelle abitazioni delle principali cittadine dei paesi industrializzati. Tutti gli indici
economici e sociali segnavano progressi più o meno sensibili. La ricchezza complessiva aumentava e
– in parte – questa crescita era condivisa dall’intera popolazione.
Il quadro è certo complesso e molto si potrà dire delle deficienze dell’età compresa tra i ’50 e i ’70.
Resta il dato di fatto che nessun altro periodo nella storia dell’umanità abbia conosciuto un
progresso così forte per un numero così ampio di persone. Ovunque, il grande balzo in avanti da un
sistema semi-feudale a una società industriale, è avvenuta con l’impegno dello stato, sia nella forma
mista (keynesiana) che nella forma a pianificazione totale tipica delle società comuniste.
Il dipartimento di Chicago diventò “Scuola di Chiacago” grazie a un allievo di Heyek
particolarmente carismatico e fortemente deciso a scuotere le fondamenta della teoria economica:
Milton Friedman.
In cosa consiste questa nuova dottrina? Consiste nella riproposizione del liberismo puro, un “nuovo
liberismo” – il neoliberismo appunto - dopo quello visto a inizio Ottocento. Un’ideologia costruita
intorno ad un fine e ad un mezzo e con una premessa.
La premessa è la “visione” di un mondo ideale in cui domanda, inflazione, disoccupazione
funzionano alla stregua di forze naturali. Il mercato - visto come un ecosistema in grado di
l’autoregolarsi - avrebbe dato vita all’esatto numero di prodotti al prezzo esattamente adeguato,
realizzati da lavoratori che percepivano salari perfettamente sufficienti a comprare quei prodotti: un
mondo perfetto di piena occupazione, creatività e, soprattutto, crescita perpetua.
Questa “visione” rende la dottrina economica più una ideologia che un modello scientifico con
qualche evidenza storica. Una caratteristica importante perché altrimenti non sarebbe comprensibile
il fondamentalismo con cui è stata portata avanti da poche centinaia di economisti e tecnocrati, di
grande e crescente influenza.
Il fine è quello di promuovere a tutti i livelli (diffondere il credo forse si addice meglio) una presunta
scientificità nell’assioma per cui se gli individui agiscono secondo i propri egoistici interessi, creano
benefici massimi per tutti. Se qualcosa va storto – inflazione sale, la crescita diminuisce – l’unica
spiegazione è che il mercato non è abbastanza libero. La soluzione, ovvero i mezzi per creare la
società perfetta, è un’applicazione più rigida e più completa delle norme fondamentali.
Al di là delle teorie la ricetta di Friedman è indicata nel suo Capitalismo e libertà e rappresenta la
mappa di riferimento per le politiche che hanno dominato il mondo dagli anni ’80 a oggi.
La ricetta di Friedman
1) Deregulation.
Riprendendo la teoria di Ricardo sull’abolizione dei dazi doganali, e più in generale delle tasse
protezionistiche, viene auspicato l’annullamento di tutte quelle regole e norme che limitano
l’accumulazione del profitto.
2) Privatizzazione.
È la pietra angolare del neoliberismo. Partendo dal dogma della maggiore efficienza dei privati
rispetto al pubblico, viene auspicato la sostituzione dei servizi pubblici con servizi privati e
privatizzati. Friedman proponeva la privatizzazione della Sanità, delle Poste, della Scuola, delle
Pensioni e dei Parchi Nazionali.
3) Riduzione spese sociali.
Per ripulire l’economia inquinata dall’attività dello stato occorre ridurre drasticamente le spese
sociali. Tagliare i fondi per il sistema pensionistico, l’assistenza sanitaria, il salario di
disoccupazione eccetera.
Friedman insisteva molto sulla riduzione delle tasse; devono essere basse e con tassazione fissa
indipendente dal reddito.
(Questa misura sarebbe servita, in seguito, da cavallo di troia per ottenere consenso politico anche
nelle fasce sociali pesantemente danneggiate da tale provvedimento).
La ricetta, che passerà all’opinione pubblica come neoliberista, era presentata da Friedman e i suoi
seguaci come una vera e propria “scienza esatta”. Qui sta il clamoroso successo di una pratica
economica disastrosa a qualunque verifica empirica: presentare con l’aurea della “imparzialità
scientifica” modelli matematici del tutto privi di coerenza con la realtà, ma di straordinario beneficio
per i settori più dinamici della finanza e della imprenditorialità mondiale. Argomentazioni
improponibili per manager e politici, apparivano in tutt’altra veste se presentati da un matematico e
brillante oratore come Milton Friedman. La possibilità di contrastare le politiche keynesiane con
posizioni pseudo-accademiche portò alla Scuola di Chicago, a partire dagli anni Sessanta, donazioni
a valanga e grandi opportunità di propaganda (certamente sproporzionati in confronto al numero dei
suoi esponenti).
Per capire l’aria nuova che circolava nell’ambiente basti ricordare che il premio nobel per
l’economia andò nel 1974 a Heyek e nel 1976 a Friedman.
Messa a punto la teoria e innescato il circolo virtuoso del finanziamento, occorreva trovare
l’occasione adatta per applicare finalmente i modelli matematici alla realtà economica e avviare così
la controrivoluzione anti-keynes.
N.B. La retorica del liberismo utilizzò spesso la propaganda anticomunista, ma il vero nemico era il
keynesismo, ovvero il sistema misto. Gli Stati Uniti non erano ancora usciti dal sistema del New Deal,
l’Europa sembrava avviata verso un modello socialdemocratico, mentre buona parte del mondo in via
di sviluppo stava abbracciando sistemi misti regolati dallo stato. Il neoliberismo è nato e si è diffuso
per contrastare tutto questo.
Esattamente come il marxismo, il neoliberismo appariva una ideologia tanto accattivante quanto
irrealizzabile (a prezzo, per entrambi, di tragici effetti collaterali); l’utopia degli imprenditori al
posto dell’utopia dei lavoratori; il mercato perfetto anziché lo stato proletario; per entrambi felicità
universale e soluzione di tutti i problemi
__________________________________________________________________________________
2.1.3. L’elitismo sociale
I presupposti antropologici dell’equilibro sociale del primo liberalismo si basavano
sull’accettazione delle diseguaglianze sociali – d’intelligenza, d’iniziativa, di ricchezza
– che la società civile non doveva correggere ma bensì ratificare con l’attribuzione di
un potere politico e sociale proporzionale alla qualità del cittadino. Essere
proprietario e ricco era in rapporto con le questioni di libertà e di responsabilità
civica: la proprietà e la ricchezza erano viste come una condizione di libertà perché
garantivano indipendenza e istruzione ma soprattutto costituivano fattori di
responsabilità, in quanto il rischio legato a tali condizioni portava a ponderare
meglio le decisioni politiche nonché ad essere destinatari - in ossequio ad una pura
giustizia commutativa (chi detiene maggiore ricchezza paga più imposte) - di
maggiori diritti di partecipazione politica.
Questi punti di vista sono stati teorizzati da Bentham e Constant, ma soprattutto da
Kant (Nella Metafisica dei costumi, 1798, egli individua gli attributi giuridici dei cittadini dello Stato (cives) nella
libertà legale, cioè la facoltà di non obbedire ad altra legge che non sia quella cui hanno dato il consenso,
nell’uguaglianza civile, cioè nel non riconoscere altro superiore nel popolo, e nell’indipendenza civile, da cui deriva la
personalità civile, cioè nel far dipendere la propria esistenza dai propri diritti e non dall’arbitrio di altri. Solo la capacità
di votare qualifica lo status di cittadino, capacità che presuppone la personalità civile, attributo che invece manca ai
cittadini c.d. passivi (il servo, il pupillo, tutte le donne e in generale tutti coloro che fanno dipendere la loro esistenza
dai comandi o dalla protezione di altri), la cui esistenza è in certo qual modo soltanto inerenza perché non possiedono
dando origine ai sistemi costituzionali di democrazia limitata,
basata sull’esclusione del voto delle donne, dei domestici, dei funzionari inferiori, dei
religiosi (perché mancanti di libertà), dei nativi delle colonie e all’instaurazione
alcuna indipendenza civile),
nella maggioranza delle costituzioni europee del XIX di un sistema censitario che
restringeva i diritti di partecipazione politica ai proprietari.
2.2.4 Statualismo e “diritto eguale”
E’ necessaria una speciale preparazione per creare diritto valido (legittimo): il diritto
è qualcosa di più della volontà, è un’idea di giustizia e deve essere pensato in forma
adeguata. Per il primo liberalismo questa speciale preparazione consisteva nel
pensare le norme sociali in generale, in modo uguale e astratto, anche le situazioni e
in particolare i conflitti giuridici, cioè pensare la società in modo “legalistico”. A
questa visione generalizzante e uguagliatrice come condizione dell’ordine della
società civile fanno appello Rosseau, Kant, Tocqueville e Constant.
Il diritto diviene strumento indispensabile per parlare di libertà,
concepito come presupposto dell’uguaglianza: l’esercizio della sovranità per essere
legittimo deve fondarsi sul diritto eguale (la legge) e pertanto lo Stato liberale si
trasforma in Stato di diritto. In questo modo la ragione dei giuristi recupera
l’egemonia sulla volontà dei detentori della sovranità.
2.2.5 Il “metodo giuridico”
La supremazia del sapere giuridico sulla volontà politica nella creazione del diritto
deriva dal suo metodo nell’affrontare le questioni e risolverle che avviene in modo
razionale e indipendente dal legame esistente tra norma giuridica e volontà
costituente. Infatti, la soluzione giuridica ai conflitti si ritiene giusta quando segue
una regola corretta e non quando segue la regola richiesta dal potere costituente del
popolo: per istituire la giustizia non basta volere, ma bisogna volere correttamente.
Tra volontà e correttezza spetta alla seconda, al rigore metodologico e concettuale
di un sapere specializzato, l’ultima parola.
Riferendosi al detto comune “ciò può essere giusto in teoria, ma non vale per la
pratica”, KANT (1793) sostiene invece che una buona teoria vale più della pratica e
che solo il popolo ingenuo può pensare il contrario. La costituzione politica è infatti il
risultato della riflessione teorica diretta a trovare la corretta combinazione del
principio di libertà con il principio di uguaglianza e una volta individuata e applicata
sistematicamente, la costituzione è giusta indipendentemente dal tipo di regime
vigente (monarchico, aristocratico o democratico).
Un altro filosofo tedesco, HEGEL (1770-1831) va anche oltre perché attribuisce alla
ragione giuridica una legittimità costitutiva propria. Il suo discorso parte dalla
riflessione sulla mancanza nella propria patria del “Senso dello Stato” derivante
dall’assenza di uno Stato unitario e dalla presenza di una costituzione e di un diritto
che sono il prodotto solo di contratti tra individui tendenti ad una maggiore garanzia
dei loro privati interessi. Lo Stato invece è l’incarnazione trans-individuale della
nazione; la costituzione è l’insieme dei principi sui quali si fonda l’esistenza della
nazione e quindi sono al di sopra degli interessi particolari degli individui e solo in
casi eccezionali al di sotto di quelli dello Stato; il diritto è la concretizzazione dei
diritti dello Stato-Nazione e dei sacrifici e condizionamenti che esso può esigere dai
singoli.
Sul piano del regime politico questa concezione totale dello Stato mette in risalto
l’importanza degli organi che ne incarnano l’unità (il re) e che perseguono l’interesse
pubblico (burocrazia, l’esercito, l’amministrazione).
Sul piano del diritto Hegel sostiene che la legge deve valere non come prodotto della
volontà popolare ma per tradurre la volontà dello Stato, in quanto portatrice della
totalità degli interessi pubblici. Il diritto, che è una norma corretta che agisce in
funzione dello Stato (dell’interesse collettivo), è concepito come metodo razionale
per costruire le norme sociali e sviluppare in dettaglio la legittima pretesa dello Stato
sovrano a orientare la società verso il suo fine razionale. Insomma il diritto è
l’emanazione di una teoria, la teoria dello Stato.
2.2.6 Positivismo “scientifico” e “Stato costituzionale”
Quindi il diritto pubblico non appare come uno sviluppo del contratto sociale ma
come diretta emanazione della sovranità dello S tato e del suo diritto a regolare la
vita sociale in funzione dell’interesse pubblico imponendo diritti e doveri. Allo stesso
modo la costituzione non è l’emanazione di una sovranità popolare costituente, ma
solo lo statuto giuridico dello Stato, comprendente gli organi supremi, la loro
composizione, le relazioni reciproche e le garanzie che lo Stato concede. Poiché tutti i
detentori del potere sono suoi organi, limitati e guidati nella loro azione
dall’interesse pubblico, lo Stato ha bisogno di una costituzione che formalizzi le loro
attribuzioni e, quindi non si ha Stato senza costituzione e viceversa.
La volontà ordinatrice dello Stato si esprime nella legge (affidata al potere
legislativo), che fissa limiti di attuazione dei diritti soggettivi pubblici e privati, e al di
sotto della legge e ad essa subordinata sta l’amministrazione che agisce in
conformità (principio di legalità). Al vertice non stanno i poteri costituenti del popolo
né i diritti individuali originari, ma solo la volontà dello Stato che deve esprimersi
secondo la legge, cioè obbedire alla distribuzione delle competenze stabilita nella
costituzione (costituzionalità formale).
Anche la dottrina diviene “pura”, scienza positiva: “positiva” perché si fonda sugli
elementi obiettivi della legge statale e non su astrazioni metafisiche come il
contratto sociale o i diritti individuali originari, “scienza” perché generalizza i dati
sotto forma di concetti.
I concetti prodotti dalla dottrina rappresentando, per il carattere della generalità ed
astrattezza, un fatto permanente nella cultura giuridica di una nazione sono
trascritti in codici, come accade nel 1900 con il codice civile tedesco.
Questo mondo entra in crisi con l’inflazione legislativa determinatasi a seguito
dell’esigenza di dare una risposta legislativa alle imponenti trasformazioni sociali e
politiche degli inizi del Novecento e con la ri-politicizzazione della vita giuridica
(specie per l’affermazione dei principi democratici dopo la prima guerra mondiale):
la legge non esprime più i motivi perenni del consenso, ma ha natura contingente, e
quindi perde la posizione di riferimento per il sistema dogmatico del diritto che si
deve rivolgere ad un livello superiore, a quello della Costituzione. Questa non viene
più intesa, a partire dalla Costituzione di Weimar (1919), come lo statuto dello Stato,
ma come deposito di valori consensuali posti al vertice delle formalizzazioni
costituzionali concrete (costituzione “materiale” vs. costituzione “formale”), che
rappresentano valori inderogabili dallo Stato, opponibili alla legge ordinaria e alla
stessa legge costituzionale.
Tutto ciò segna l’avvento dello “Stato Costituzionale” caratterizzato: 1.dalla
supremazia della Costituzione e dei valori in essa consacrati su tutta l’attività dello
Stato, anche legislativa, 2. ma soprattutto da un sistema di controllo giudiziario di
costituzionalità della legge che presuppone la distinzione tra potere costituente e
potere legislativo (subordinato al primo).
La statuizione di valori permanenti, consensuali e materialmente giusti da un lato
limita il legislatore e dall’altro attribuisce di nuovo ai giuristi il ruolo di “oracoli della
giustizia”. La valutazione della costituzionalità delle leggi viene attribuita ad una
élite di giuristi assistiti in un tribunale speciale, la Corte Costituzionale.
2.2. Positivismo e scientismo
Il discorso politico dell’800 è stato condizionato anche le idee dominanti sul sapere influenzate a partire dalla fine del secolo XVIII dall’evoluzione delle scienze naturali che volendo acquisire la
dignità di scienza doveva basarsi
anch’esso
sull’osservazione delle cose, della realtà empirica (posta “positiva”) e non muoversi
da argomenti di autorità (teologica o accademica come nel periodo del diritto
comune) o da speculazioni filosofiche astratte (come nel periodo del
giusrazionalismo).
Il sapere doveva essere diretto verso le “cose positive”, anche se le varie scuole di
pensiero che si alternarono intesero diversamente queste cose positive.
1. Per taluni positiva era solo la legge, che il sapere giuridico doveva solo
spiegare ed interpretare (positivismo legalista).
2. Per altri positivo era il diritto plasmato nella vita, nelle istituzioni o nello spirito
del popolo (positivismo storico).
3. Positivo era anche lo studio del diritto in conformità delle regole delle nuove
scienze sociali apparse nella seconda metà dell’800 (positivismo sociologico,
naturalismo)
4. Infine per altri positivi erano i concetti giuridici, generali ed astratti,
rigorosamente costruiti e validi indipendentemente dalla variabilità della
legislazione, conformemente ad un modello di scienza come discorso di
categorie teoriche stabilito da Kant (positivismo scientifico o concettuale).Il
sapere giuridico conseguiva in tal modo la certezza e l’universalità
caratteristiche delle altre scienze.
Tutte queste forme di positivismo hanno in comune il rifiuto di ogni sorta di
soggettivismo o di moralismo perché la scienza giuridica deve coltivare metodi
oggettivi e verificabili, restando escluse ogni considerazione di valore politiche e
morali (i giudizi di valore si trovano nella filosofia o nella politica del diritto).
3.
LE SCUOLE CLASSICHE DELL’OTTOCENTO
3.1. La scuola dell’esegesi. L’origine del legalismo.
A partire dalla metà del ‘700 la legge statale tese a monopolizzare l’attenzione dei
giuristi, anche se temperato dall’idea giusrazionalista dell’esistenza di un diritto
meta-positivo originato dalla ragione.
Ma fu soprattutto in Francia, attraverso la codificazione, che si arrivò alla
identificazione del diritto con i nuovi codici (il Code Civil nel 1804 e poi i codici di
procedura civile, commerciale e penale..). Infatti i codici napoleonici costituivano da
un lato, l’approdo di un movimento dottrinale di stampo giusrazionalista
rappresentando in un certo senso la positivizzazione della ragione e dall’altro la
concretizzazione della volonté générale essendo il risultato di un processo legislativo
condotto dagli organi rappresentativi della nazione francese. Quindi essendo
democraticamente legittimati di fronte ad essi non poteva essere fatta valere
nessun’altra fonte del diritto: non quella dottrinale, razionale, perché incorporata nei
codici, non il diritto tradizionale, perché la rivoluzione aveva tagliato i legami con il
passato, non il diritto giurisprudenziale, perché ai giudici non competeva statuire il
diritto ma solo di applicarlo. La forza che la Magistratura aveva acquistato durante
l’antico regime in virtù della struttura casistica dell’ordinamento giuridico dello ius
commune viene meno al punto di introdurre il divieto dell’interpretazione e il
correlato obbligo per i tribunali di ricorrere al potere legislativo “ogni volta che
ritenessero necessario interpretare una legge” (il référé législatif introdotto da una legge francese
del 1790 che diede origine alla creazione di un tribunale speciale con il compito di verificare la legalità delle
interpretazioni della legge da parte dei tribunali, la Cour de Cassation).
Questo indirizzo fu detto legalismo o positivismo legale, cioè la legge, specie quella
compendiata e sistematizzata nei codici, aveva il monopolio di manifestare il diritto;
la dottrina aveva invece il ruolo solo ancillare di interpretare la legge attenendosi il
più possibile alla volontà del legislatore storico ricostruita attraverso i lavori
preparatori.
I giuristi si limitano a fare un’esposizione e un’interpretazione (esegesi) dei nuovi
codici: è la scuola dell’esegesi. Essa è legata alla nascita di uno Stato nazionale
rivoluzionario che ha tagliato i legami con il passato, che si è dotato di organi
rappresentativi e che ha compiuto un importante lavoro di codificazione.
L’idea di un codice “civile” generale (cioè dei cittadini) rifletteva l’affermazione del
principio di eguaglianza tipica dei nuovi stati post rivoluzionari, uguaglianza che i
codici intendevano garantire attraverso la loro generalità e la subordinazione dei
giudici ai precetti in essi contenuti.
Ma a questi elementi positivi si aggiungono quelli negativi, riconducibili alla scarsa
trasparenza democratica dello Stato dovuta essenzialmente al carattere ristretto
della base sociale delle democrazie rappresentative nonché la drastica limitazione
all’innovazione dottrinale, che poteva prodursi solo dal legislatore. Il potere politico,
poco attento ai limiti della regolazione sociale mediante la legge, si sostituisce
all’autorità scientifica nella legittimazione del diritto, che ora dipende dalle
maggioranze parlamentari, diventando pericolosamente contiguo alla politica e
perdendo di prestigio.
3.2
La scuola storica tedesca: il versante organicista e tradizionalista.
Alcune nazioni europee come la Germania e l’Italia, che occupavano una posizione
centrale nel panorama del sapere giuridico europeo non conobbero uno Stato
nazionale – la cui esistenza costituisce il presupposto politico del legalismo – fino
all’ultimo quarto dell’800. In tali casi, l’assenza di un ruolo di demiurgo della società
giunse a valorizzare le forme tradizionali e spontanee di organizzazione politica e la
storia serviva evidentemente come punto di partenza per progetti di organizzazione
politica e giuridica rivolti al presente e al futuro (vedi in Portogallo dal municipalismo
partono proposte fi ricostituzione di una struttura politica decentrata della società).
Una tale sensibilità culturale (di radici nazionaliste) non accettava inoltre il carattere
universale e artificiale delle forme di “Stato” e di “codice”, entrambe indifferenti alle
particolarità culturali e nazionali e portatrici di una teoria costituzionale statalista
che attribuiva i destini nazionali alla volontà politica del sovrano e delle assemblee
rappresentative presenti, libere dall’autorità della tradizione.
Nasce in questo ambiente culturale e politico la scuola storica tedesca che nel suo
sviluppo pandettistico influenzerà il panorama del sapere giuridico fino agli inizi del
Novecento. Il programma di tale scuola era appunto cercare fonti non statuali e non
legislative del diritto, in una concezione della società come un tutto organico
soggetta ad un’evoluzione simile a quella degli esseri viventi in cui il presente reca i
segni del passato il quale a sua volta condiziona naturalmente anche ciò che segue.
Uno dei concetti più caratteristici della scuola storica è il concetto di “spirito del
popolo” (anima della nazione), all’origine di tutte le manifestazioni della vita (di
“alta cultura”), del diritto, dei costumi, dell’arte, del linguaggio, ecc....
Le conseguenze di tale movimento sono in primo luogo l’antilegalismo e la rezione
contro il movimento per la codificazione: il diritto è unità organica che si forma
attraverso l'intero passato della nazione e non viene creato dall'arbitrio del
legislatore. La legge non è costruzione del diritto perché è legata a momenti
congiunturali (decisioni prese da un governo e da un’assemblea) in un modo di
norme organiche, indisponibili e durevoli (tali sono quelle di emanazione dello spirito
del popolo). Inoltre la legge e i codici congelano l’evoluzione naturale del diritto
come tutte le tradizioni è una realtà viva, in permanente trasformazione spontanea.
Queste posizioni furono significamente espresse all’epoca nella famosa polemica tra
Savigny e Thibaut.
La polemica Thibaut Savigny: La concezione propriamente storicistica del diritto appare per la prima volta precisata
da un giurista dell'epoca romantica, Savigny, che risentì profondamente del pensiero di Hugo, in quanto accolse da lui
la critica al giusnaturalismo. Ed è il Savigny che si può ritenere il vero iniziatore di quella che fu chiamata la scuola
storica del diritto, il cui indirizzo si manifesta per la prima volta in un opuscolo del 1814 “Sulla vocazione del nostro
tempo per la legislazione e la scienza giuridica”. I numerosi piccoli Stati in cui era diviso il territorio tedesco seguivano
tutti, tranne la Prussia, il diritto giustinianeo modificato qua e là da norme locali; e la scienza giuridica tedesca si
atteneva al cosiddetto usus modernus Pandectarum, che nel tentativo di ricondurre al diritto romano i superstiti istituti
giuridici nazionali tedeschi, alterava sia il diritto germanico che quello romano, creando confusione di concetti e
disordine negli studi. In questa situazione nacquero nei paesi tedeschi correnti favorevoli ad un'unificazione legislativa
ispirata al modello francese, ma a queste se ne opposero altre in nome della difesa dei caratteri nazionali germanici.
Del movimento propugnatore della codificazione la figura più importante fu quella di Thibaut, il cui indirizzo dottrinale
fu detto, in contrapposizione alla scuola storica, scuola filosofica; anche se il Thibaut non rifiutava il metodo storico,
limitandosi a sostenere che la realtà storica non può essere compresa se non rapportandola alla ragione.
Nell'atteggiamento del Thibaut si perfezionava una tendenza che era già stata del giusnaturalismo pre-kantiano,
quella cioè di servirsi del diritto naturale per dare una forma sistematica al diritto positivo. Una filosofia così intesa,
cioè un ordine razionale e sistematico, Thibaut voleva che si usasse nello studio scientifico del diritto positivo.
Nonostante la sua sensibilità riguardo la storia, il suo atteggiamento rimaneva però giusnaturalistico. Dopo aver difeso
la codificazione napoleonica in una recensione anonima ad uno scritto del Rehberg, nello stesso anno 1814 scrisse
l'opuscolo “Sulla necessità di un diritto civile generale per la Germania”. Pur mosso da una fondamentale ispirazione
nazionalistica, vi accoglieva, con qualche contraddizione, l'istanza illuministica di una codificazione generale, sul
presupposto dell'universalità del diritto, in quanto fondato nel cuore e nella ragione dell'uomo. La giustificazione
giusnaturalistica della codificazione era evidente e ciò spiega l'immediata reazione degli storicisti antigiusnaturalisti.
La “Vocazione” del Savigny è una risposta all'opuscolo di Thibaut, mentre riconosce la validità degli scopi che questo
perseguiva e dichiara di condividerli, Savigny sostiene che il mezzo per raggiungerli non è un codice, ma una scienza del
diritto organica e progressiva, che può essere comune all'intera nazione, mentre per la diversità della situazione storica
dei vari paesi tedeschi, un codice non può essere comune a tutta la Germania. Da questa occasionale presa di posizione
del Savigny nacque la scuola storica del diritto.
Savigny: Il Savigny è una tipica espressione del romanticismo nel campo giuridico, egli non solo si contrappone alle
idee di chi voleva nuovi codici, che con la completezza dell'amministrazione della giustizia, garantissero una certezza
meccanica, in modo che il giudice esonerato da ogni giudizio proprio si limitasse all'applicazione letterale della legge,
secondo l'ideale legislativo illuministico; ma egli cercò di riconoscere i presupposti filosofici delle teorie illuminstiche
per quanto riguarda la legislazione e l'interpretazione del diritto e li ritrovò in quella cultura del diciottesimo secolo in
cui si era perso il senso della storia e si credeva la propria epoca destinata alla realizzazione della perfezione assoluta.
Alle tesi dell'illuminismo riguardanti il diritto, cioè alla teoria di un diritto naturale immutabile ed universale dedotto
dalla ragione, il Savigny si oppone decisamente, per lui il diritto è proprio di ciascun popolo, come il linguaggio, i
costumi, l'organizzazione politica, sono tutti elementi connessi tra di loro e come per il linguaggio cosi per il diritto non
vi è un attimo di sosta assoluta, esso cresce con il popolo, prende forma con esso e alla fine muore quando il popolo ha
perso la sua personalità. Con l'evolversi del popolo si evolve anche il diritto, che si manifesta dapprima con atti in cui si
esprimono i sentimenti della collettività, e vive come consuetudine che del diritto è la prima spontanea forma. Più tardi
a questo diritto spontaneo si sovrappone quello elaborato scientificamente dai giuristi, che tuttavia continua a
partecipare all'intera vita del popolo. Savigny definisce elemento politico la connessione del diritto con la vita sociale
del popolo, ed elemento tecnico la sua separata vita scientifica, e ha cura di fare osservare come in entrambi i casi ciò
che crea il diritto non è mai l'arbitrio di un legislatore ma è sempre una forza interiore che opera tacitamente. Il diritto
legislativo, secondo Savigny, dovrebbe fornire solo un sussidio alla consuetudine, diminuendone l'incertezza e
l'indeterminatezza e portando alla luce e conservando puro il vero diritto, che è l'effettiva volontà del popolo. Agli
inconvenienti del diritto comune il Savigny propone come rimedio non la codificazione, ma l'elaborazione scientifica del
diritto. Nella polemica con il Thibaut a proposito della codificazione riemerge costantemente quella che è la posizione
propriamente storicistica del Savigny e questa si ritrova anche a proposito della trattazione del diritto naturale, che
viene considerato il diritto che si attua nella storia , spontanea creazione dei popoli. Per conseguire gli
apprezzabilissimi fini propostisi dai fautori della codificazione, primo fra tutti la certezza del diritto, lo strumento
adatto non è il codice, ma la scienza giuridica. Delle tre forme in cui il diritto si manifesta, diritto popolare spontaneo,
diritto legislativo e diritto scientifico, la forma più valida è quella del diritto scientifico proprio delle società già mature
ma non ancora avviate alla decadenza. La Vocazione conserva i caratteri dello scritto polemico d'occasione, e sembra
ingannevolmente, riferirsi più alla situazione attuale della Germania che al problema generale della natura del diritto;
lo storicismo giuridico non si presenta ancora come una vera e propria dottrina, anche se Savigny ha cura di fare
osservare frequentemente come le sue asserzioni si inquadrino in quella che era la cultura nuova, cioè la cultura
romantica. Ma già l'anno dopo con la presentazione della rivista, egli contrappone la scuola che ormai si diceva storica
alle dottrine giusnaturalistiche e illuministiche, da lui riunite sotto l'appellativo di scuola non-storica, e dichiara che il
contrasto fra le due scuole riguarda tutte le cose umane. Per la scuola non-storica ogni epoca crea il suo mondo
liberamente ed arbitrariamente ed al passato si rivolge come ad un mero elenco di esempi dei quali non è essenziale
tenere conto, per la scuola storica invece ogni epoca è il proseguimento e lo svolgimento dei tempi passati; un'epoca
non crea il suo mondo liberamente ed arbitrariamente, ma in comunione con l'intero passato.
Una seconda conseguenza è la valorizzazione dell’elemento consuetudinario e
dottrinale del diritto. La consuetudine è la forma in cui il diritto si manifesta
spontaneamente e il diritto legislativo, secondo Savigny, dovrebbe fornire solo un
sussidio alla consuetudine, diminuendone l'incertezza e l'indeterminatezza e
portando alla luce e conservando puro il vero diritto, che è l'effettiva volontà del
popolo. Il corpo dei giuristi e dei magistrati colti ha una funzione determinante nel
trattamento organico (sistematico) del diritto. In effetti fin dal ‘600 la scienza
giuridica tedesca si atteneva al cosiddetto usus modernus Pandectarum, che nel
tentativo di ricondurre al diritto romano i superstiti istituti giuridici nazionali
tedeschi, alterava sia il diritto germanico che quello romano, creando confusione di
concetti e disordine negli studi. Ciò spiega l’attenzione del Savigny alle fonti classiche
e alla tradizione romanistica medievale nell’intento di pervenire ad una ricostruzione
sistematica di tutto il diritto privato romano e perché il risultato di tale scuola verrà
più tardi denominato come “pandettistica”, per via del suo oggetto specifico (cioè
“pandette”, il diritto romano, che questa scuola tornò a valorizzare, fondando su di
esso la costruzione sistematica e dogmatica che aveva già segnato la cultura
giuridica tedesca degli ultimi due secoli).
Altre conseguenze sono la rivalutazione della storia del diritto e del suo ruolo
dogmatico ma, soprattutto, la sistematicità e l’organicità della giurisprudenza.
3.3
La scuola storica tedesca: il versante formalista o concettualista.
La giurisprudenza dei concetti e la pandettistica.
Una delle componenti della scuola storica tedesca, presente nel suo ramo principale,
la pandettistica o giurisprudenza dei concetti (il cui principale rappresentante è G.F.
PUCHTA 1789-1846), è la costruzione sistematica del diritto, conseguenza
necessaria perché il diritto è l’emanazione di un tutto organico, cioè lo spirito del
popolo. Il diritto nazionale (cioè l’insieme degli istituti giuridici) viene condotto ad
unità attraverso un’esposizione organica e sistematica organizzata per principi
generali – scoperti per induzione a partire dall’osservazione di norme giuridiche
concrete – dai quali si estraggono per deduzione altri principi inferiori e le soluzioni
per i casi concreti (la c.d. “piramide concettuale” di cui parla Puchta).
L’idea del sistema concettuale del diritto come essere vivo, organico e produttivo si
inquadra in un contesto in cui prevaleva la visione di un mondo di concetti afferrabili
con l’osservazione e l’induzione, secondo il metodo “storico naturale” delle nuove
scienze della vita.
Quindi il lavoro dei giuristi consiste nella costruzione di un sistema di concetti
ottenuti per induzione dalle massime del diritto positivo – cioè dalle norme positive
isolate – e non attraverso una riflessione astratta come avveniva nel
giusrazionalismo.
Il contenuto del sistema è la legislazione (cioè le norme giuridiche)
Il sistema è la forma attraverso la quale si organizza la connessione logica tra
le diverse norme che consente la formulazione di concetti essenziali per la
conoscenza del diritto
Rudolf von Jhering distingue due fasi:
Giurisprudenza inferiore: studia la lettera della legge e si interessa unicamente
ai comandi
Giurisprudenza superiore: tratta il diritto in forma di corpi giuridici viventi
sviluppando di concetti.
La funzione dei concetti è:
1. Facilitare l’apprendimento del diritto perché essi sono sintetici ed intuitivi;
2. Rendere possibili nuove soluzioni giuridiche grazie al potere generatore dei
concetti. Il metodo dei giuristi è simile a quello degli scienziati della natura, i
quali dall’osservazione del reale estraggono principi generali che, combinati
logicamente producono nuovi principi e nuove teorie
I concetti ottenuti con il trattamento formale del materiale storico (spicca tra questo
il materiale di diritto romano, dal quale la pandettistica ricava quadri concettuali e
dogmatici sfruttabili trans-temporalmente) e legislativo di un diritto nazionale sono:
Il principio di volontà nel campo dei negozi giuridici: ne consegue che deve
essere garantita la libertà negoziale, che nessuno può essere rappresentato da
altri senza mandato specifico
Il principio di elasticità nel campo della proprietà: quindi l’estinzione di un
diritto reale limitato (come una servitù o un usufrutto) ritorna a favore del
proprietario della cosa sulla quale incideva
Il principio di irrecuperabilità di un atto giuridico annullato, che non può avere
quindi conseguenze di alcun tipo, né avere un’efficacia ridotta o collaterale.
Tutte le suddette soluzioni non sono solo formalmente logiche, ma anche
materialmente giuste, perché i principi dai quali derivano esistono nella realtà
culturale in cui il diritto si alimenta.
Al giurista compete formulare tali principi - che sono impliciti in una miriade di
norme – scientificamente attraverso il formalismo senza invischiarsi in considerazioni
di carattere etico, politico o economico.
La giurisprudenza dei concetti segue il metodo formalistico, il quale portò a
concepire il diritto come un' entità definita concettualmente, da comprendere e da
spiegare entro se stessa ricercando il fondamento delle norme, dei rapporti e degli
istituti giuridici in formulazioni concettuali che costituiscono un organismo logico
autonomo e autosufficiente. Una delle tesi più caratteristiche del positivismo
giuridico è quella che afferma la completezza dell'ordinamento giuridico, cioè
l'impossibilità in esso di lacune, dal momento che l'ordinamento giuridico si
autointegra mediante un processo logico che si compie totalmente al suo interno,
senza eterointegrazioni come il ricorso al diritto naturale o a simili principi.
Il ruolo riservato al diritto nel sistema etico di Kant corrisponde ai valori del
formalismo, che esalta il fondamento etico-formale del diritto (contro quello etico-
materiale del periodo giusrazionalista): al diritto non compete stabilire parametri
etici di condotta, ma garantire la libertà che rende possibile una valutazione etica dei
comportamenti. In questo modo emergono le due anime del formalismo
concettualista:
1. Quella individualista perché i suoi principi (esistenza dei diritti soggettivi,
autonomia della volontà..) rispondono alla logica di una società composta da
individui liberi e titolari di un diritto originario alla libertà (a differenza della
prima scuola storica, per la quale la società era un sistema organico di
istituzioni)
2. Relativista e formalista perché la pandettistica non prescrive principi eticogiuridici materiali che guidino l’esercizio della libertà ma attribuisce al potere
la funzione di stabilire la forma di organizzazione politica che meglio
garantisca la libertà individuale (liberalismo)
A fronte dei contrastanti progetti politici della borghesia tedesca, i quadri politicoideologici della pandettistica erano molto ampi e tali da garantire la neutralità e
l’obiettività del diritto: tali erano l’ampia accezione del liberalismo (difesa della
libertà e uguaglianza formale degli individui, tutela della proprietà quale estensione
della libertà). Il formalismo e la scientificità della pandettistica consentivano di
giudicare in modo obiettivo le differenti soluzioni politico-sociali.
Per gli stessi motivi il formalismo reagiva contro ogni strumentalizzazione del diritto
operata dalla politica e dallo Stato: la legge, ossia la volontà del potere politico, era
solo la materia che consentiva indipendenti elaborazioni da parte dei giuristi. Il
diritto dottrinale riacquistava così la sua tradizionale indisponibilità di fronte al
potere reclamando il ruolo di arbitro fra governanti e governati.
Ebbe origine qui l’immagine odierna di uno Stato governato dai giudici come ideale
di organizzazione: l’idea di neutralità e indipendenza del diritto e dello Stato portate
dalla pandettistica – garantite dal rigore formale nel processo di decisione – è stata
determinante per la cultura politica e giuridica fino ai nostri giurni.
La pandettistica ebbe una grande espansione in Europa (vedi codice civile tedesco
del 1900) e fuori (persino in estremo oriente con i cinque codici della repubblica di
Nanchino- Cina).
3.3.1 I dogmi del concettualismo
La pandettistica ha portato alla definizione di alcuni importanti risultati:
1. La teoria della sussunzione. Si tratta del procedimento di valutazione per la
realizzazione della giustizia nei casi concreti (applicazione della norma al
fatto): questa è assicurata secondo lo schema del sillogismo giudiziale e cioè
sussumendo la fattispecie concreta (premessa minore) in un principio di diritto
(premessa maggiore). La teoria della sussunzione – che nella versione legalista
ha come premessa maggiore la legge – tende a limitare l’arbitrio e il
soggettivismo giurisprudenziale. [ La sussunzione spetta a quell'operatore del diritto chiamato
a verificare appunto, nell'ambito delle sue competenze, la rispondenza del caso concreto con la previsione
generica. Ad esempio il giudice, riconoscendo nella fattispecie che sta specificamente esaminando quegli
elementi che consentano di ascriverla ad una categoria di atti o fatti genericamente previsti da una norma,
nel momento in cui ravvisi che la fattispecie specifica (concreta, storica, fenomenica) verifica la fattispecie
(teorica, astratta) descritta nell'assunto teorico generale, applicherà pertanto la norma al caso di specie
poiché questo vi rientra, ed in questo porre in correlazione pratica e teoria (con la conseguenza di dar corpo
alla teoria su un caso pratico) consiste la sussunzione tipicamente intesa. Per migliore chiarezza, si consideri il
caso di un individuo tratto dinanzi al giudice penale perché sorpreso a rubare: una volta definita con adeguate
modalità la fattispecie del soggetto trovato a rubare, questa fattispecie concreta (uomo che ha rubato) sarà
da valutare con riferimento alla regola (fattispecie astratta) che indica che rubare è vietato e che se si ruba si
va soggetti ad una data pena. Compito tipico del giudice è in primo luogo accertare che effettivamente l'uomo
che ha di fronte abbia rubato, ed una volta che ciò fosse accertato, verificare che la condotta accertata
riguardi proprio la previsione generale contenuta in quella norma che vieta il furto, e se così fosse applicare la
norma stessa. In tal caso la sussunzione operata dal giudice riconoscerà la fattispecie concreta come
ascrivibile a quella teorica, segnalerà perciò l'acclarato avveramento dell'ipotesi teorica nel fatto concreto, e
si completerà con l'applicazione del disposto imperativo della norma. ]
2. Il dogma della completezza dell’ordinamento giuridico. Una delle tesi
caratteristiche della pandettistica si fonda sulla concezione dell’ordinamento
giuridico come sistema concettuale, il quale sarebbe in grado di coprire ogni
lacuna legislativa esistente grazie al carattere generale ed elastico dei concetti
che consente di ricavarne altri con operazioni logiche. Pertanto nell’ipotesi di
lacuna legislativa il giudice – che non può rifiutarsi di decidere (principio jura
novit curia) – dovrà valutare il caso concreto, mai secondo criteri autonomi,
ma estendendo per deduzione e combinazione concettuale il sistema
normativo in modo da coprire il caso sub judice.
3. L’interpretazione oggettivistica. Poiché il diritto formava un sistema coerente
di concetti estratti dal materiale empirico disponibile, comportava che il
significato decisivo delle norme giuridiche fosse quello sistematico. Mentre il
positivismo legalista sostiene un’interpretazione della legge conforme alle
intenzioni del legislatore, il positivismo concettualista propone il ricorso ad alla
“fictio” di un legislatore razionale, cioè di un legislatore che reinterpreta
continuamente ogni norma in modo che l’ordinamento giuridico – di fatto
costituito da una miriade di norme contraddittorie – conservi sempre la sua
unità e la sua coerenza
4.
LE SCUOLE ANTICONCETTUALISTE E ANTIFORMALISTE: NATURALISMO,
VITALISMO E ORGANICISMO
Riepilogando, la costruzione logico-concettuale del diritto elaborata dalla
pandettistica si appoggiava:
Sotto il profilo formale, alla teoria Kantiana delle scienze, perché la verità
equivaleva al rigore logico e alla coerenza concettuale;
Sotto il profilo materiale, ai valori tipici del liberalismo borghese, in particolare
la libertà (concepito come potere della volontà) e alla sua estensione, cioè la
proprietà.
La sensibilità culturale e sociale cambia nella prima metà dell’800 per due ordini di
motivi:
L’ascesa di un nuovo modello di scienza proveniente soprattutto
dall’immagine dell’evoluzionismo darwiniano: il formalismo kantiano viene
superato dall’empirismo e dallo sperimentalismo e da un nuovo tipo di
spiegazione finalistica dell’evoluzione biologica governata appunto dal fine
della sopravvivenza.
Sul piano dell’ambiente sociale e politico, i movimenti socialisti del 1848 in
Germania e del 1870 in Francia spezzano l’unità del primo liberalismo mentre
lo sviluppo del capitalismo fa sorgere la “questione operaia”. Di fronte ad una
società segnata da conflitti d’interesse e di gruppi (conflitti sociali), vacilla
l’ideale del diritto “separato dalla società” inseguito dalla pandettistica.
Il contrasto tra discorso giuridico e contesto pratico nonché il nuovo modello di
scienza portarono ad un nuovo approccio del sapere giuridico più consono a quello
delle scienze naturali, tant’è che tale tendenza è detta “naturalismo giuridico”. Esso
tratta il diritto come un fatto sociale che può essere spiegato solo ponendolo in
relazione con la società e seguendo i procedimenti utilizzati dalle scienze naturali,
ovvero:
Il modello meccanicista in cui il diritto appare come variabile dipendente, cioè
come la conseguenza di cause efficienti di natura psicologica (sociologismo
meccanicista)
Il modello biologico in cui il diritto è visto come funzione di una “logica della
vita” dominata da interessi e finalità (sociologismo funzionalista o finalista).
4.1. La giurisprudenza teleologica
Il modello biologico sottende al pensiero vitalistico di Rudolf von Jhering (1818-1892)
ne “Lo scopo nel diritto”, 1877-1883, dove è dominante l’idea che la finalità e
l’interesse sono le entità generatrici del diritto. Secondo tale tesi:
Il diritto è organismo vivo (cioè creazione organica della società) che aspira
alla preservazione della vita sociale (vedi darwinismo) equilibrando gli
interessi che promuove;
Nella valutazione di tali interessi o finalità sottostanti, il diritto non parte
dalla volontà, infatti
La volontà è la causa genetica delle azioni umane di cui si occupa il diritto
Il diritto considera gli interessi perseguiti dagli individui nella misura in cui
sono degni di essere protetti e, soprattutto, gli interessi sociali oggettivi, che
non fanno parte delle volizioni individuali (buona fede contrattuale, funzione
sociale della proprietà, ecc..)
In conclusione:
Si passa da una concezione del diritto volta alla protezione assoluta dei poteri
della volontà, ad un'altra in cui il diritto serve a garantire interessi socialmente
utili:
LOGICA VOLONTARISTICA E CONTRATTUALISTICA VS. LOGICA UTILITARISTICA E
TRANS-INDIVIDUALE
Il pensiero di Jhering fu determinante sul piano dogmatico, per l’introduzione della
nozione di interpretazione teleologica, ossia di un’interpretazione delle norme e dei
negozi giuridici congruente con le finalità o interessi in gioco. Tuttavia egli non negò
mai allo Stato il monopolio nella emanazione del diritto e ciò spiega perché le
asserzioni della scuola si situano nell’ambito della teoria dell’interpretazione e non
su quello della teoria delle fonti del diritto.
Più tardi questa tendenza sfociò in due diverse correnti:
1. La scuola del diritto libero che si proponeva di sganciare il diritto dallo Stato e
la dottrina dall’esegesi legislativa
2. La giurisprudenza degli interessi che affrontò il problema dell’interpretazione
criticando la giurisprudenza dei concetti tipica della pandettistica.
4.2. La scuola del diritto libero
ll movimento del diritto libero è una tendenza, un atteggiamento, che assunse forme
diverse. Parte dalla tesi che la legge non produce diritto, ma lo prepara, mentre a
creare il diritto è la sentenza del giudice. Il primo esponente vero e proprio fu un
sociologo del diritto, Ehrlich (1862-1922), che in una conferenza del 1903 parlò per la
prima volta di una libera scienza del diritto affermando il valore di una libera ricerca
del diritto di contro al principio dell'applicazione meccanica del comando del
legislatore ai fatti concreti. Egli non sostiene che sia il giudice a creare il diritto, ma
dichiara che è un'impresa vana quella di escludere la sua personalità nella decisione
giudiziaria. Ma la tesi veramente innovatrice fu quella sostenuta dallo storico
polacco Kantorowicz (1877-1940), il quale in un battagliero manifesto, La lotta per la
scienza del diritto, sostiene che accanto al diritto statuale, anzi prima di esso, esiste il
diritto libero, prodotto dall'opinione giuridica dei membri della società, dalle
sentenze dei giudici e dalla scienza giuridica: esso vive indipendentemente dal diritto
statuale, ed è anzi il terreno dal quale quest'ultimo nasce. Il libretto di Kantorowicz
diede l' avvio a un movimento a cui aderirono molti giuristi tedeschi, si devono
ricordare quelli che sono i principi fondamentali: il primo di questi è il rifiuto del
dogma legalistico delle scuole cosiddette classiche dell'ottocento per il quale il diritto
era solo la norma costituita dalla legge, e non era dato all'interprete di ricorrere ad
argomenti extralegali. Dal rifiuto del dogma legalistico discende poi
necessariamente il rifiuto di un altro principio essenziale del positivismo giuridico, la
completezza dell' ordinamento positivo. Il movimento del diritto libero non sostiene
che il giudice può giudicare anche in contrasto con la legge, o che il diritto legislativo
deve essere soppiantato dal diritto giurisprudenziale, ma sottolinea che in qualsiasi
ordinamento giuridico permane uno spazio vuoto che spetta all'interprete colmare
vale a dire - al contrario di quanto sosteneva il positivismo giuridico - che le lacune
nel diritto esistono. Il positivismo giuridico era una teoria del diritto vigente in
un'epoca di staticità della società, che consentiva altrettanta staticità nella vita
giuridica; il diritto positivo poteva essere considerato il vero e l'unico diritto perché
rimanevano costanti le condizioni nelle quali era stato emanato. Ma verso la fine
dell'800, divenendo sempre più rapido lo sviluppo dell'economia, e quindi il
trasformarsi delle strutture sociali, il divario tra legislazione e realtà sociale diveniva
sensibile; né poteva colmarlo l'aggiornamento delle leggi, sotto pena di togliere a
queste, a causa della loro conseguente instabilità, la certezza: cioè proprio quello che
del diritto legislativo è il massimo pregio. Quando anche la Germania, nel 1900, si
decise di adottare il diritto codificato, il codice civile tedesco aveva accolto i principi
del positivismo giuridico, ma era stato costretto a fare posto a concetti che
avrebbero fatto inorridire i codificatori del primo ottocento, come il concetto di
buona fede, buon costume, abuso del diritto, forza maggiore, giusta causa ecc.... Gli
assertori del diritto libero sostengono quello che il legislatore aveva sempre
avvertito, cioè l'incompletezza di qualsiasi legislazione di fronte alla realtà sociale.
4.3. La giurisprudenza degli interessi
Jhering maturo quindi abbraccia una concezione teleologica e pragmatica del diritto,
il quale veniva visto come il coordinamento e la garanzia degli interessi dei membri
della società. Si può quindi fare risalire a lui l'inizio di quella corrente di pensiero
giuridico che fu detta giurisprudenza degli interessi, che fece capo alla scuola di
Tubinga, rappresentata principalmente da Filippo Heck e da Max von Rumelin e si
estese in tutta la Germania. La giurisprudenza degli interessi si pone come antitesi
della giurisprudenza dei concetti. Il primato della logica che la giurisprudenza dei
concetti ha fatto valere nel lavoro della scienza giuridica, deve essere soppiantato,
secondo Heck, dal primato dello studio e dalla valutazione della vita. Scopo della
scienza giuridica e dell' attività dei giudici è l'appagamento dei bisogni della vita, dei
desideri e delle tendenze che esistono nella comunità giuridica, sia materiali sia
ideali: a questi interessi guarda la giurisprudenza degli interessi, la quale cerca di
tenere presente questo scopo finale anche in ogni singola operazione, in ogni
costruzione di concetti, e considera le leggi le risultanti degli interessi di carattere
materiale, nazionale, religioso ed etico che in ogni comunità giuridica si affrontano e
lottano per essere riconosciuti. La giurisprudenza degli interessi è in contrasto con il
positivismo giuridico, cioè con il formalismo, e questo contrasto si rivela più netto a
proposito delle lacune dell'ordinamento giuridico. Il positivismo giuridico infatti
sostiene la tesi secondo la quale l'ordinamento giuridico non ha lacune, Heck
respinge decisamente questa tesi, sostenendo che in caso di lacuna si debba
compiere uno sviluppo assiologico del comando del legislatore, tenendo cioè presenti
gli interessi in gioco e valutandoli in modo autonomo integrandoli in base a giudizi di
valore: giudizi che devono di regola essere quelli a cui si è ispirato il legislatore, ma
che, nel caso in cui questi non possano essere identificati, possono essere formulati
dal giudice con una sua valutazione autonoma. I positivisti considerarono queste
idee giusnaturalistiche, in realtà non si trattava del giusnaturalismo del seisettecento, ma della necessità e possibilità di andare oltre il dettato formale del
legislatore, integrandolo, però senza contraddirlo, col ricorso a principi non ricavati
meccanicamente dalla logica astratta del sistema, ma dalla logica storica:
economica, etica, sociologica. Se si vuol parlare di giusnaturalismo a proposito di
questa e delle altre tendenze antiformalistiche del tardo ottocento e del novecento,
bisogna aver presente che si tratta solo di non-positivismo giuridico, e che ci si
muove sempre su un terreno fondamentalmente positivistico.
La giurisprudenza degli interessi mantiene fondamentalmente i presupposti del
positivismo giuridico nel tentare di risolvere il problema delle lacune
dell’ordinamento che andavano emergendo a seguito dei grandi mutamenti sociali e
politici di fine Ottocento e inizi Novecento. Infatti secondo tale movimento la
soluzione dei casi giuridici – che rappresentano un conflitto di interessi – andava
risolta mediante una adeguata ponderazione degli interessi, valutazione da fare
secondo i criteri espliciti o impliciti nella legge e non sulla deduzione concettuale,
tipica della pandettistica. I concetti suggerivano un approccio al problema da
risolvere, ma non avevano nessuna funzione decisiva nella determinazione della
soluzione giuridica. Il giudice deve, nell’individuazione della soluzione giuridica,
obbedire solo alla legge, anche se si tratta di un’obbedienza “intelligente”, nel senso
che quando la legge non prevede il caso, la decisione non deve attenersi alla lettera
della legge ma deve rispettare la valutazione degli interessi legalmente riconosciuti,
dando luogo ad un nuovo costruttivismo: quello della estensione dei criteri legali ai
casi non previsti.
4.4. Il positivismo sociologico e l’istituzionalismo
L’idea che il diritto è indissolubilmente connesso con la società era presente anche
nella versione oggettivistica del giusnaturalismo classico (Aristotele e San
Tommaso), che legava il diritto alla natura delle cose (umane e sociali) e alla
giustizia; diritto e giustizia volti a perseguire il bene comune, cioè il mantenimento
degli equilibri sociali costituiti. Montesquieu aveva sottolineato il radicamento
sociale del diritto e nell’Ottocento Savigny individua il fondamento del diritto nei
valori della cultura nazionale.
Tuttavia, la prima manifestazione di un positivismo sociologico “scientifico” – ossia
che segue i modelli epistemologici delle nuove scienze sociali della seconda metà del
XIX secolo – risale al sociologismo di Auguste Compte (1798-1857). La sociologia è
una creazione di Comte, egli la intende come una fisica sociale, una forma di
conoscenza dei fenomeni sociali che ha gli stessi caratteri della scienza della natura,
fondata esclusivamente sull'osservazione dei fatti. La sociologia è una scienza
onnicomprensiva e sintetica e tutto il sapere è ridotto ad unità perché rivolto alla
società quale complesso globale di relazioni fra gli individui. Il positivismo sociologico
di Compte costituisce una critica diretta all’individualismo – oggetto di attenzione sia
dell’economia classica, sia del giusrazionalismo, sia della pandettistica – al
volontarismo e al contrattualismo. L’individuo, infatti, non viene visto come essere
libero ed autodeterminato ma bensì come un’astrazione metafisica inesistente nella
realtà, dove rilevano invece le relazioni interindividuali forzose ed indisponibili
(perché l’individuo sopravvive solo grazie alla solidarietà sociale: siamo in un epoca
dove emerge la specializzazione, la divisione e la complementarità del lavoro),
indipendenti dalla loro volontà; l’ordinamento sociale e politico non si fonda su un
accordo di volontà volto a garantire meglio i diritti degli individui, ma sulle esigenze
oggettive della vita sociale che si realizzano in istituzioni quali la famiglia, la
parrocchia, il comune, la provincia, la nazione, la federazione di popoli e, infine,
l’Umanità.
Nel campo del diritto la metodologia del comptismo fu applicata da Emile Durkheim
(1858-1917) prima e in seguito da Léon Duguit (1859-1928) – costituzionalista e
amministrativista - il quale effettuò una critica serrata ai dogmi della teoria liberale
dello Stato (l’uomo naturale che nasce libero e indipendente e ha diritti costituiti dalla libertà è un’astrazione dalla
realtà, in quanto l’individuo è prigioniero nei lacci della solidarietà sociale: essi nascono membri di collettività e
soggetti perciò a tutti gli obblighi che comporta il mantenimento e lo sviluppo della vita collettiva).
Le conseguenze del realismo politico-sociale di tale corrente sono:
In primo luogo lo sviluppo del particolarismo giuridico con il conseguente rifiuto:
del carattere eterno ed immutabile del diritto, in quanto le forme della
solidarietà sociale variano da società a società
del dogma dell’uguaglianza giuridica assoluta degli uomini, che hanno statuti
giuridico-politici diversi correlati ai diversi ruoli rivestiti nella rete della
solidarietà sociale
del primato della norma generale ed astratta sulla soluzione casistica e
concreta, in quanto il giurista deve determinare quale regola applicare al caso
concreto a fronte delle diverse forme di solidarietà sociale
In secondo luogo viene meno il primato del diritto soggettivo sul diritto
oggettivo, quest’ultimo si fonda sulla solidarietà sociale e dallo stesso derivano
i diritti soggettivi, che proprio nella solidarietà sociale e nella divisione dei
compiti trovano il principio e, al tempo stesso, i limiti al loro esercizio
Un’applicazione interessante del principio del carattere derivato dei diritti
soggettivi è il nuovo concetto di proprietà, intesa non più come diritto assoluto,
ma come diritto limitato dalla sua funzione sociale.
In terzo luogo anche il concetto di sovranità dello Stato diviene funzionale alla
legge generale della solidarietà sociale e della divisione dei compiti: infatti i
limiti del potere dello Stato non derivano da nessuna delega delle volontà
individuali operata con il suffragio universale, ma dalla legge oggettiva della
solidarietà sociale. Il compito dello Stato, ovvero dei governanti, è quello di
imporre l’ordine destinato a conservare tale solidarietà.
Su tale linea anti-individualista del potere Maurice Hauriou (1856-1929) descrive con
la Teoria dell’istituzione un ordinamento giuridico (come complesso di istituzioni)
bifronte, consistente da un lato in norme positive esistenti (istituzioni-cose), dall’altra
in idee direttrici che si sviluppano progressivamente verso nuovi obiettivi (istituzioni
persone). Tale contrapposizione tra diritto statuito e diritto in divenire si può
considerare un primo indirizzo verso una critica al positivismo.
La critica positivista alla pandettistica influenzò il sapere giuridico alla fine
dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento:
Sul versante antiformalista, attraverso il suo accostamento alle scienze sociali,
il positivismo dà origine a discipline giuridiche nuove, come la sociologia del
diritto, l’antropologia giuridica e la criminologia, che permettono la
comprensione del ruolo del diritto nei processi di normazione e di disciplina
sociale, e che richiamano i giuristi al diritto vivo, praticato. Questa
“socializzazione” del positivismo è evidente nel campo del diritto penale, dove
si procede ad identificare le “cause” del crimine, cioè i fattori criminogeni
oggettivi, che vengono ricondotti alle caratteristiche antropologiche
(anatomico-fisiologiche, psico-biologiche) o da fattori sociali e ambientali;
riguardo alla pena, si individuano soluzioni funzionali alla prevenzione, sia
generale sia rieducativa. In generale erano considerate metafisiche le idee che
il crimine sia un atto libero, sottoposto a censura morale e che la pena ptesse
includere una finalità di espiazione o di retribuzione sociale del male arrecato.
Sul versante antistatalista e antilegalista, il positivismo rifiutò l’identificazione
fra legge e diritto, riconducendo la genesi di quest’ultimo nelle istituzioni
sociali, staccandolo quindi dalla volontà espressa nella legge. Tuttavia il
riconoscimento che il positivismo postula della funzione regolatrice dello Stato
attenua l’atteggiamento antilegalista, fino a portare alcune correnti
riconducibili al positivismo a concedere alla legge un ruolo determinante nella
costituzione del diritto (vedi lo statalismo autoritario del fascismo).
Sul versante anti-individualista il positivismo contestava i fondamenti
individualistici e contrattualistici della pandettistica in entrambi i campi del
diritto pubblico e del diritto privato.
Nel diritto pubblico la critica è orientata verso la forma individualista,
democratica e liberale dello Stato basata sul suffragio e sui diritti
naturali degli individui, a fronte della quale viene proposta una forma
di organizzazione politica fondata sui gruppi, in primo luogo lo Stato,
come emanazione degli interessi generali del corpo sociale. Una di
queste forme è il corporativismo, che parte dall’idea che le entità
politiche naturali (famiglia, impresa, comune) devono stare alla base
dell’organizzazione statale ed essere esse presenti (non i singoli
individui), tramite propri rappresentanti, nelle assemblee
rappresentative. Inoltre la solidarietà sociale esige che la conflittualità
tra le forze economiche e politico-sociali venga appianata attraverso
forme di organizzazione economica e politica che promuovano la
coesione (concertazione, Stato forte, partito unico, proibizione dello
sciopero e della serrata).
Nel diritto privato il positivismo attenua il primato del principio di
volontà, ponendo limitazioni all’autonomia della volontà nel diritto dei
contratti e della proprietà, in linea con le tendenze politiche
antiliberali, di matrice socialista. Il diritto soggettivo non è più definito
come un “potere della volontà”, ma come un “interesse
giuridicamente protetto”, che ha come fine la realizzazione di un
determinato ordine sociale e che quindi trova i propri limiti nella
funzione sociale.
La questione della “socializzazione” del diritto privato assunse un grande rilievo
politico con l’avvento delle idee socialiste, ma anche l’antilegalismo con
l’affermazione della vigenza di fonti extralegali vigenti nella comunità si prestò ad un
uso politico.
Infatti, il positivismo sociologico subì appropriazioni politicamente contraddittorie.
Nell’Ottocento ebbe valore di movimento di idee, non rivoluzionario, ma critico verso
le istituzioni e i valori costituiti, in nome del divenire della società e quindi in
opposizione a qualsiasi forma di conservatorismo: in questo senso si deve al
positivismo la laicizzazione della vita pubblica, la critica agli eccessi del liberismo
economico e un certo coinvolgimento nei movimenti socialisti allo scopo di
migliorare le condizioni delle classi lavoratrici in nome della solidarietà sociale.
Ma proprio la posizione ambigua del positivismo nei confronti del demo-liberalismo
ha fatto in modo che tale movimento diventasse il punto di appoggio delle ideologie
autoritarie dei primi quarant’anni del Novecento. Infatti, il dissolvimento
dell’individuo nella società ha permesso estrapolazioni di carattere autoritario
attraverso la negazione del suffragio come forma di rappresentanza politica in
favore di una casta di politici: emblematico è il movimento tedesco del “socialismo
cattedratico” che si sviluppò sotto l’autoritarismo del Secondo Reich (1870-1917) in
cui il principe, coadiuvato da scienziati, introduce riforme sociali che proteggono i più
deboli. Del resto la funzione dello Stato “scientifico” era di tipo paternalista, cioè
regolare l’inevitabile potere dei più forti (governanti) sui più deboli (governati) in
funzione dell’interesse generale.
______________________________
Otto von Bismarck unificò la Germania imponendo al resto del paese il carattere militaristico-autoritario delle
istituzioni prussiane. Il re di Prussia, un Hohenzollern, divenne così l'imperatore tedesco, la capitale della
Prussia, Berlino, divenne la capitale tedesca, mentre le istituzioni e la mentalità prussiane cominciavano a
pervadere tutti gli aspetti della coscienza della nazione, con il predominio dei militari sui civili. Lo spirito
prussiano di sottomissione all'autorità, simboleggiato dallo status semidivino ancora accordato all'imperatore,
permeò molti aspetti della vita del Secondo Reich (1781 - 1918).
Da un punto di vista politico, il nuovo Reich era caratterizzato da molte anomalie e voci discordanti. La
costituzione di Bismarck istituiva un'autocrazia appena mascherata in cui l'imperatore, in quanto titolare del
potere esecutivo, aveva ampi poteri discrezionali, che forse potevano essere appropriati nell'età
dell'assolutismo, ma che non erano adatti a un epoca industriale in cui la divisione del potere o quanto meno
il bilanciamento dei poteri si rivelavano più efficaci nello smorzare i conflitti sociali. Per quanto in pratica la
vita politica della Germania imperiale fosse relativamente libera e la democrazia sociale facesse progressi
costanti, come risulta dal fatto che il Partito socialdemocratico divenne nel 1912 il partito di maggioranza
relativa al Reichstag, la reale partecipazione alla vita pubblica era ancora controllata esclusivamente da un
élite ristretta che anche nel XX secolo continuava a perpetrare il suo potere. Coloro che avevano creato il
Secondo Reich, per quanto si inclinassero al fronte alla sovranità popolare, dichiaravano senza tema di
errore che il potere doveva rimanere nelle mani delle classi feudali.
Subito dopo l'unificazione della Germania, lo Stato cominciò a gestire il processo industriale dall'alto,
concedendo prestiti senza interesse, tollerando grandi sindacati, concentrazioni e cartelli e possedendo
vaste proprietà e imprese (miniere di carbone , fornaci , servizi). Lo Stato amministrava queste imprese
attraverso una complicata rete di funzionari statali efficienti e ben preparati. In Germania dunque la libera
impresa fu sostituita dall'impresa di Stato; l'espansione industriale, la più dinamica dell'Europa del tempo, fu
il risultato della pianificazione del controllo statale. Un paternalismo di questo genere, tuttavia, finisce per
condizionare la popolazione, abituandola all'obbedienza e alla dipendenza, alimentando l'illusione che non si
possa realizzare niente di grande senza l'intervento statale e che l'individuo a prescindere dallo Stato sia
insignificante. In questo senso, lo scopo prussiano, era quello di promuovere sia il nazionalismo sia il
socialismo, in una curiosa prefigurazione del nazionalsocialismo. Da ogni cittadino ci si attendeva
obbedienza e lealtà incrollabili allo Stato; in cambio, quest'ultimo ricompensava questa dedizione totale con
generosi interventi sociali come pensioni di vecchiaia, sussidi di disoccupazione, assicurazione infortuni e
assistenza sanitaria. Tutti i tedeschi avrebbero cioè dovuto essere tedeschi obbedienti, che erano pronti a
servire lo Stato e che a loro volta sarebbero stati giudicati dallo Stato secondo il loro rendimento, il loro
talento e la loro lealtà. Queste convinzioni rimasero tuttavia più desideri, perché di fatto l'élite conservatrice
al potere non era disposta a spartire con la maggioranza una quota maggiore delle risorse in espansione, e
non vi era paternalismo che potesse cancellare le disparità di giustizia distributiva esistenti nel Secondo
Reich.
_______________________
In definitiva l’ambivalenza del positivismo dette luogo ad adattamenti all’origine sia
dello Stato sociale, sia dei regimi autoritari antidemocratici come il fascismo e lo
Estado Novo portoghese (all’origine del nazismo troviamo invece movimenti ideologici più
specificamente tedeschi,
contrattualistico).
anche
se
caratterizzati
anch’essi
dall’anti-individualismo
La critica all’uguaglianza formale di tipo pandettistica e il riconoscimento di una
disuguaglianza naturale degli uomini porta ad elaborare giustificazioni giuridiche
per taluni fenomeni quali le differenze di genere, il razzismo e il colonialismo.
Nel campo del diritto privato il positivismo portò a politiche di protezione delle parti
più deboli dei rapporti giuridici (lavoratori, bambini) permettendo la formazione di
soggetti collettivi destinati a rafforzarne il potere negoziale (sindacati), ma sempre
nell’ambito di una concezione organicistica che tendeva ad annullare l’individuo di
fronte al gruppo o ad uno Stato concepito come garante dell’armonia sociale; con lo
sviluppo corporativistico di tali idee – cioè sotto i regimi conservatori e autoritari
dell’Europa centrale e meridionale – i sindacati furono posti sotto la tutela dello
Stato e la stessa famiglia (cellula sociale di base nei regimi fascista e portoghese)
formò oggetto di attenzioni pubbliche al fine di garantirne il benessere economico
ma, soprattutto, la salute morale.
Per quanto riguarda le fonti del diritto se da un lato il sociologismo valorizza le
istanze normative della società contro il monopolio statale nella creazione del diritto,
dall’altro riconosce il ruolo regolatore dello Stato nella sua missione di garante della
solidarietà nazionale e quindi finisce per attribuire alla legge il carattere di fonte
ultima e decisiva del diritto.
La politica di sacralizzazione dello Stato influenza anche la regolamentazione della
giustizia attraverso: l’introduzione di statuti che vincolano completamente il giudice
alla legge; l’assorbimento dell’autonomia degli ordini professionali degli avvocati
attribuendo loro poteri di natura pubblica (legge del 1934 in Italia) e assoggettandoli
a tutela legale; l’introduzione di meccanismi di disciplina della giurisprudenza da
parte di tribunali superiori, e così via.
Infine il positivismo, malgrado avesse introdotto molti elementi validi per l’analisi del
diritto come fenomeno sociale, tendeva a reificare l’uomo ignorandone la
dimensione interiore, la capacità di scelta e, di conseguenza, l’etica della libertà e
della responsabilità. Ciò fu particolarmente chiaro nel diritto penale, dove la figura
del delinquente ne esce deresponsabilizzata e allo stesso tempo privata di dignità
autonoma: da soggetto libero che aveva scelto viene trasformato in malato
bisognoso di cure.
In generale, la reificazione dell’uomo e delle relazioni sociali instaurò uno
strumentalismo giuridico in cui il diritto poteva essere messo al servizio di una
politica qualsiasi: ne rappresentano un drammatico esempio i regimi totalitari
europei del Novecento e, forse, anche le tecnocrazie contemporanee.
______________________
Scrive Marx ne Il Capitale: «Le persone esistono solo come maschere economiche. E, solo come
personificazioni di rapporti economici, esse trovano l’una di fronte all’altra». Di lavoro si può morire, come
accade in Francia. Manager che si suicidano sul posto di lavoro, come se il fallimento dell’azienda fosse il
fallimento della loro vita. Ci si identifica talmente con l’azienda che il suo fallimento crea una crisi
esistenziale. Ma suicida anche per mancanza di lavoro: sono due facce legate al lavoro, così osannato da
certo capitalismo. Ma perché proprio ora? Perché la crisi ha messo a nudo la grande questione del lavoro.
Marx messo in soffitta rispunta drammaticamente a ricordarci che il lavoro che diviene alienazione può
distruggere l’uomo, il lavoro che ha come fine solo il profitto crea alienazione, l’uomo diviene un’altra cosa da
sé. Ma anche la sua mancanza riduce l’uomo a cosa. Ma non è solo Marx a impostare questo problema. Se
prendete San Tommaso, così come lo legge Vittorio Tranquilli nel suo monumentale Il concetto di lavoro da
Aristotele a Calvino, vi dice, arrivato a San Tommaso, che il lavoro fisico ha la stessa dignità di quello
intellettuale e che ambedue hanno come fine l’uomo, creato da Dio. Vecchia riflessione, ma
drammaticamente attuale. Marx nell’Ottocento e Heidegger nel secolo scorso (due filosofi dalle idee
politiche radicalmente opposte) segnalavano la progressiva riduzione dell’uomo alla sua funzione
“mercantile”, nel senso che l’individuo è costretto a presentarsi con quella maschera (Charakter Maske, dice
Marx) in cui sono scolpiti i tratti del suo impiego o, come dice Heidegger, del suo essere «impiegato (bestellt)
al fine di assicurare l’impiegabilità (Bestellbarkheìt)», a cui l’economia, regolata dalle leggi di mercato,
destina uomini e cose. Con la maschera in volto l’uomo non è più in rapporto con il mondo, ma esclusivamente con le leggi che governano il sistema mercantile in cui il singolo si trova ad operare. Il suo agire
non lo esprime, ma esprime la razionalità dell’apparato economico che determina non solo la sua azione, ma
anche la relazione con i suoi simili, mediata dalle leggi che connettono la produzione, lo scambio e il
consumo delle merci. Tutto ciò, e questo è il tragico, non è “oppressione’, ma “sistema”. Di oppressione si
poteva parlare prima dell’avvento dell’economia di mercato oggi globalizzata, dove la reificazione dell’uomo,
la sua riduzione a cosa, avveniva per la volontà di un altro uomo, sia che questi si esprimesse come
individuo o come classe, per cui era possibile da parte dei “reificati individuare, nell’abbattimento di quella
‘volontà“, la condizione della loro liberazione. E tutte le rivoluzioni che hanno scandito i passaggi d’epoca
nelle età precedenti la globalizzazione erano praticabili, perché accadevano all’interno dell’umano, tra una
volontà opprimente e una volontà oppressa, o come dice Hegel. «tra un servo e un signore».
Perché le rivoluzioni esplodessero era sufficiente quella «presa di coscienza», secondo l’espressione di
Marx, capace di segnalare la base irrazionale dell’oppressione e la conseguente razionalità della successiva
liberazione. Ma quando la reificazione, la riduzione dell’uomo a cosa, non è più l’effetto di una volontà, quindi
di un evento irrazionale, ma l’effetto della razionalità dei mercato, allora non avremo più, come nelle età che
hanno preceduto la globalizzazione del mercato, il dominio dell’uomo sull’uomo, ma il dominio della
razionalità del mercato su tutti gli uomini, servi o signori che siano, i quali non si trovano più contrapposti
l’uno all’altro, ma entrambi dalla stessa parte, avendo come controparte la razionalità che regola le leggi di
mercato, contro cui ogni rivoluzione è impraticabile. Per questo i giovani accettano con rassegnazione
qualsiasi lavoro temporaneo o in nero, per questo chi perde il lavoro va in crisi d’identità e non sa come
uscire dalla notte buia della disperazione. E questo non perché si sono identificati con il loro lavoro, ma
perché non hanno una controparte dal volto riconoscibile con cui confrontarsi. Il mercato, infatti, non ha
volto, il mercato è nessuno. Ed è vero, come ci ricorda Romano Madera in Identità e feticismo (Moizzi
editore) che «Nessuno, come già ci segnalava Omero, è sempre il nome di qualcuno», ma questo qualcuno,
nel mercato globalizzato, è invisibile. Di qui la rassegnazione e la disperazione che affliggono sia la classe
imprenditoriale sia la classe dei subordinati, per la prima volta nella storia non più in contrapposizione, ma
entrambi sottomessi alla dura legge della razionalità” del mercato.
_______________
4.5. La reazione antinaturalista: valori e realtà
Dalla metà degli anni ’10 si notano segnali di reazione verso la sociologia, specie nel
campo della filosofia del diritto, dove si sottolinea la specificità della conoscenza
giuridica rispetto alle scienze sociali.
Un punto di partenza di tale reazione fu la distinzione tra scienze della natura- cui
appartengono le scienze sociali - e scienze della cultura – cui appartiene il diritto,
con la rivendicazione per queste di un oggetto e metodo proprio.
In un’attività come il diritto i comportamenti non sarebbero descrivibili né spiegabili
solo dall’”esterno”, dovendo guardare anche ai significati che gli uomini
attribuiscono alle cose, ai dati interiori, che danno senso ai comportamenti.
In buona sostanza, gli uomini in una società obbediscono a norme (giuridiche) che
non appartengono alle cosiddette “leggi naturali” - alle quali gli uomini obbediscono
passivamente sotto impulso esterno - ma al regno dello spirito, della coscienza
(ovvero socialmente al regno della cultura); sono quindi “leggi finali”, cioè regole che
egli propone a se stesso in vista di scopi che egli stesso vuole e determina.
Rispetto alle scienze che descrivono la realtà sociale, il diritto è una disciplina
culturale, che ha a che fare con norme, impone valori alla realtà o riferisce la realtà a
valori.
Mentre le scienze della natura, tra cui le scienze sociali, trattano i fenomeni umani in
una prospettiva puramente esterna (guardando i comportamenti) riducendoli a leggi
generali, il mondo della cultura, cui appartiene il diritto, non può essere ingabbiato
in leggi generali, perché ogni atto possiede significati unici che vanno ricercati a
partire dall’attività spirituale interna che li ha prodotti e non dal comportamento
esterno. Qualsiasi tentativo di individuare i valori giuridici nella realtà del diritto
costituirebbe un salto insostenibile tra il mondo del dover essere e il mondo
dell’essere.
Le conseguenze dogmatiche di questi punti di vista furono varie, specie sul piano
metodologico, come l’introduzione di modelli intellettuali diversi da quelli delle
scienze fisico-naturali, più adeguati al diritto. Ad es.: approccio casistico il luogo del
metodo deduttivo; interpretazione teleologica o finalistica degli atti giuridici (cercare
di interpretare gli atti in conformità con i loro fini sociali e non con il contenuto delle
volontà degli agenti).
Inoltre la tendenza era quella di “purificare” il sapere giuridico distinguendo
accuratamente gli aspetti giuridici delle questioni dagli aspetti politici, sociali e
psicologici: fu questo l’obiettivo della teoria pura del diritto formulata dal giurista
austriaco Hans Kelsen.
Hans Kelsen (1881-1973), grande storico e teorico del diritto, si è proposto di liberare il diritto stesso da tutte le sovrastrutture, che si
erano mescolate ad esso nel corso dei secoli (giusnaturalismo, concezione sociologica del diritto). Del suo impegno per l’autonomia
del diritto è testimonianza la sua opera fondamentale La dottrina pura del diritto (1933, ripubblicata nel 1960). La dottrina pura del
diritto consiste in un approccio scientifico al diritto in quanto tale. Ciò è possibile solo se si purifica il diritto dagli elementi che gli sono
estranei.
4.6. L’apogeo del formalismo: la teoria pura del diritto
Per il Kelsen il diritto è uno speciale sistema di norme che non trova fondamento
negli altri sistemi normativi come la religione e la morale: una norma giuridica, cioè,
è valida solo perché conforme al diritto, laddove per conformità si intende obbligare
in virtù del comando di una norma superiore. Il diritto quindi è rappresentato da una
piramide normativa alla cui sommità si trova la costituzione; quest’ultima a sua
volta deve avere un fondamento giuridico, cioè una “norma fondamentale” che la
convalidi, il cui contenuto si può così definire: “Ogni norma giuridica legittima (cioè
statuita in conformità al diritto) deve essere osservata”. Una norma del genere è
autoreferenziale, cioè si applica a se stessa e in tal modo legittima se stessa e tutte le
altre.
La teoria pura del potere ebbe il pregio di sottolineare l’autonomia del sapere
giuridico da ogni progetto di potere, in quanto si accettò l’idea che non tutto ciò che
è voluto dal potere, utile ad un popolo o ad una classe o funzionale ad uno scopo
sociale è automaticamente accettato come giusto. La giuridicità deriva da valori
interni al discorso del diritto, valori che né la volontà politica né l’utilità sociale
possono sostituire.
Tale teoria rappresenta un manifesto contro i totalitarismi politici del tempo i quali
cercavano di rendere il diritto funzionale alle convenienze del potere (vedi lo
stalinismo con il dominio di classe ed il nazionalsocialismo con l’esaltazione della
razza). In generale, questo manifesto viene considerato utile contro le tendenze a
presentare come giuste tutte le misure (formalmente corrette) di un potere
legittimato dal voto e dirette al conseguimento di finalità di sviluppo sociale ed
economico e a considerare qualsiasi controllo giuridico delle misure economiche
come manifestazione di un formalismo antiprogressista.
5.
LE SCUOLE CRITICHE
Le scuole critiche hanno come assunto fondamentale la tesi che le norme giuridiche
non costituiscono proposizioni universali, necessarie o politicamente neutre, ma per
essere comprese (unitamente al sapere giuridico) occorre guardare al loro
funzionamento nella società.
5.1. Il sociologismo marxista classico
Karl Marx (1818-1883) è stato dall’Ottocento ad oggi l’ispiratore più continuo della
critica al pensiero giuridico dominante. Egli non fu un giurista ma uno scienziato
sociale ed un pensatore politico che si pronunciò anche sul diritto, nel quadro di
un’interpretazione globale della società critica verso lo status quo.
Nel suo studio scientifico della società, Marx spiegava tutte le manifestazioni della
storia umana con l’esistenza di un perenne conflitto fra i gruppi sociali (“classi”),
generato dalla disuguale ripartizione fra gli uomini del controllo sulla produzione dei
beni materiali.
La lotta di classe scaturiva dal fatto che la classe dominante tentava di mantenere la
propria posizione egemonica contro gli sforzi di emancipazione della classe
dominata, e in questa lotta tutti i mezzi erano utilizzati, dal potere economico
all’ideologia.
La soluzione individuata per porre fine a tale tensione è la modifica del “modo di
produzione” verso una ripartizione egualitaria del controllo della produzione,
garantita da un’appropriazione collettiva dei mezzi di produzione (socialismo). Con
ciò si realizza una società senza classi dalla quale è escluso il dominio degli uni sugli
altri.
Dal punto di vista politico il marxismo, oltre ad una teoria sociale, è una proposta
politica rivoluzionaria, centrata sulla critica al capitalismo, caratterizzato
dall’appropriazione privata dei mezzi di produzione e dalla distribuzione del prodotto
sociale per mezzo dei meccanismi di mercato.
E’ in questo quadro che si inserisce la critica rivolta al pensiero giuridico costituito,
sia dal punto di vista della natura sociale del diritto sia su quello del contenuto del
diritto capitalista (o “borghese).
Riguardo alla natura sociale del diritto, questo rifletterebbe l’organizzazione
sociale e gli interessi delle classi dominanti, rappresentando quindi un mero
strumento attraverso il quale queste ultime esercita il loro potere sulla
maggioranza. Tale visione si contrappone all’idealismo e al formalismo delle
scuole classiche del pensiero giuridico che invece presentavano il diritto come
un sistema di principi e concetti prodotti dalla ragione e perciò liberi dalle
contraddizioni sociali, portatore di soluzioni tecniche e di risposte neutre e
scientifiche ai conflitti sociali; in tale contesto Lo Stato, padre della legislazione
e garante del diritto, sarebbe l’incarnazione dell’interesse generale, governato
dalla legge-volontà generale, generalmente ed astrattamente applicata a
tutti.
Invece secondo Marx il carattere classista del diritto si rivelerebbe, da un lato
dall’imposizione di norme di condotta che favoriscono i gruppi dominanti e
soggiogano i dominati, presenti specie nel diritto politico, penale, del lavoro e
della proprietà, dall’altro occultati sotto il mantello dell’uguaglianza giuridica
garantita dalla generalità ed astrattezza; infatti, il diritto borghese dava
un’immagine falsificata delle relazioni di potere, nascondendo le
disuguaglianze sociali con la libertà negoziale. In realtà gli individui erano
condizionati dalle costrizioni economico-sociali, negoziando in posizioni
squilibrate e l’esempio tipico era il lavoro salariato (tra domanda e offerta di
lavoro, si trova un lavoratore economicamente debole a fronte di un padrone
con una grande possibilità di scelta ed economicamente forte).
Riguardo alle alternative di contenuto il marxismo si batteva per un diritto che
proteggesse le classi lavoratrici e gli strati più indifesi. Sotto l’influenza del
movimento operaio cominciò a nascere nel campo del lavoro alla fine
dell’Ottocento e più tardi, con l’avvento dell’Unione Sovietica nel 1917, fu
creato un diritto a tutela delle classi lavoratrici, assoggettando per converso i
“nemici di classe” alla “dittatura del proletariato”. Il diritto viene ad assumere
un carattere strumentale per la costruzione del socialismo, esaltato nel
periodo dello stalinismo (1924-1953).
Riguardo alle alternative sul piano della “forma” si accentuò la diffidenza,
tipica dei regimi socialisti, verso qualsiasi formalizzazione giuridica generale –
essendo considerato il carattere generale ed astratto della norma di matrice
borghese – e la preferenza per una regolamentazione casistica e
decisionistica. Il rifiuto verso una normazione generale nei paesi socialisti è da
porre in relazione anche con la concezione del carattere puramente
strumentale del diritto rispetto alla politica.
5.2. Il marxismo occidentale degli anni ‘60
Il marxismo occidentale si distanziò chiaramente, a partire dalla fine degli anni ’60
dal marxismo ufficiale della Terza Internazionale, confermato anche dalla presenza
di un relativo pluralismo politico-sociale.
Infatti, lo Stato e il diritto erano considerati strumenti di classe, ma la loro
funzionalizzazione politico-sociale non era assoluta, perché le classi dominanti non
riuscivano ad estendere il loro controllo su tutti i settori della vita sociale. Ne sono
una dimostrazione l’esistenza di logiche e visioni differenti dal mondo dei dominanti,
materializzate nel movimento operaio e nelle sue organizzazioni politiche, il
movimento di contestazione studentesco e i movimenti femministi ovvero, sul piano
della politica internazionale, l’esistenza di un blocco di stati socialisti, il movimento
dei paesi “non allineati”, i movimenti anti-imperialisti dell’America Latina (Fidel
Castro e Che Guevara) e del Vietnam e i movimenti anti-apartheid in Sud Africa
(Nelsen Mandela).
Tale contesto pluralista viene spiegato da autori marxisti (influenzati anche da
Antonio Gramsci) con una nuova concezione del condizionamento della vita sociale
da parte della logica delle relazioni economiche (modo di produzione), nel senso che
queste determinerebbero la logica globale del sistema solo “in ultima istanza”,
permettendo che nei restanti livelli (politico, giuridico, culturale, delle relazioni fra i
sessi) si sviluppino logiche autonome e anche contrastanti con la logica globale.
Ad ogni modo l’evoluzione del marxismo occidentale nel campo del pensiero sociale
e politico ha permesso di non ridurre l’analisi della società solo a livello economico e
di introdurre l’idea di sistemi sociali con centri diversi, aperti all’ambiente e non
determinati.
Sul piano giuridico questa corrente valorizza di nuovo il diritto, in modo da non
considerarlo come mero riflesso inerte delle determinazioni economiche, ma come
livello autonomo che deve essere spiegato in sé e mediante il quale si può influire
sulle relazioni sociali e politiche.
5.3. La “critica del diritto”
I movimenti di “critica del diritto” si ispirano, oltre alla critica marxista del diritto, al
pensiero della scuola di Francoforte, che negli anni ’60 iniziò uno smontaggio dei
presupposti ideologici della cultura occidentale.
Sul piano giuridico il diritto viene visto come il risultato di una produzione locale,
arbitraria, storica da parte di gruppi sociali ma, soprattutto lo strumento per la
creazione di rappresentazioni (il soggetto del diritto, il contratto, la proprietà, lo
Stato), di categorie (il pazzo, il delinquente, la donna, il negro) e delle gerarchie
sociali corrispondenti.
La funzione della critica del diritto è da un lato svelare i contenuti sociali che stanno
all’origine delle rappresentazioni giuridiche al fine di smitizzare il carattere razionale
e neutrale dell’ordinamento giuridico, dall’altro svelare il processo attraverso il quale
il diritto collabora alla costruzione dei rapporti di potere (ad esempio alla creazione
della donna come essere debole, alla marginalizzazione del pazzo o del delinquente).
_______________________
La Scuola di Francoforte si propone di elaborare una teoria critica della società attuale, guidata dall'ideale
rivoluzionario di una umanità futura libera e non alienata.
In vista di questi obiettivi i francofortesi si riallacciano a tre autori fondamentali: Hegel, Marx e Freud.
Dalla tradizione hegelo-marxista, la Scuola di Francoforte deriva la tendenza filosofica ad impostare un discorso
dialettico e totalizzante intorno alla società. Dialettico perché volto ad evidenziarne le contraddizioni intrinseche;
totalizzante perché invece di fermarsi alla constatazione analitica e statistica di ciò che essa è, cerca di metterla in
discussione nella sua globalità, esprimendosi nel frattempo su ciò che dovrebbe essere.
Della costruzione freudiana utilizza in primo luogo gli strumenti analitici per lo studio della personalità e dei
meccanismi di "introiezione" dell'autorità, come pure i concetti di "ricerca del piacere" e di libido, considerati come
istinti creativi che devono essere liberati dalle imposizioni autoritarie della società repressiva.
Da un punto di vista storico-sociale, il progetto filosofico della Scuola di Francoforte si muove lungo tre direttive
principali:
1) l'avvento del nazismo e del fascismo, con i relativi problemi legati all'autorità e alla struttura della società
industriale moderna;
2) l'affermazione del comunismo sovietico, utilizzato come esempio negativo di "rivoluzione fallita";
3) il trionfo della società tecnologica ed opulenta.
___________________________
5.4. L’”uso alternativo del diritto”
Il neomarxismo, basandosi sul carattere pluricentrico del sistema politico-sociale, ha
condotto a pensare il diritto come un ordinamento non vincolato in maniera assoluta
agli interessi delle classi dominanti, ma passibile di usi politici diversi. Tale carattere
contraddittorio del diritto discenderebbe da due aspetti.
In primo luogo, l’egemonia delle classi dominanti sarebbe sempre incompleta,
perché i gruppi dominanti riuscirebbero a far valere i propri punti di vista in spazi
limitati. Anche lo Stato e il diritto, benché funzionalizzati dagli interessi dei poteri
socialmente costituiti, rifletterebbero i compromessi ai quali i gruppi dominanti sono
obbligati. Ne sono un esempio i rami del diritto in cui i movimenti progressisti sono
riusciti ad imporre norme a tutela dei più deboli: è il caso del diritto del lavoro e delle
garanzie fissate in favore dei lavoratori, delle garanzie e libertà individuali, delle
tutele giuridiche a favore dei più indifesi stabilite dalla legislazione del welfare state
a partire dagli anni ’30. Tutti questi casi rappresentano un esempio dei compromessi
esistenti in seno al diritto imposti dal contraddittorio tra classi dominanti e classi
dominate.
L’idea del carattere compromissorio del diritto porta ad immaginare il diritto come
la ponderazione giusta (razionale) di interessi politici contraddittori e il giurista come
un agente neutrale di tale ponderazione.
Nello svolgere tale compito il giurista (la dottrina e la giurisprudenza) dispone di un
ampio margine di libertà che – dato il carattere generico, ambiguo e spesso
contraddittorio delle proposizioni giuridiche – viene utilizzato per contrastare,
correggere e compensare (come il pretore romano che rimediava - adiuvandi,
correggeva-corrigendi e sopperiva-supplendi ai difetti del diritto civile in vista
dell’utilità pubblica) i presupposti classisti del diritto (specie di quello che ha origine
dal potere politico).
Queste sono le idee che stanno alla base della proposta formulata in Italia all’inizio
degli anni ’70 di un “uso alternativo del diritto” e che ha trasformato la
magistratura italiana in agente di riforme della vita civile e politica negli anni ’80 e
’90.
Tale uso presuppone l’esistenza di condizioni metodologiche e istituzionali:
Sul piano metodologico occorre che il giurista acquisisca una visione più chiara
e più critica del diritto, in particolare del funzionamento non neutrale delle
istituzioni giuridiche, includendo nella formazione giuridica discipline come la
sociologia, l’antropologia e l’epistemologia critica. Inoltre la metodologia
dovrebbe garantire un’indipendenza del giurista dal potere politico costituito
nella definizione di soluzioni dottrinali e giurisprudenziali alternative: ciò si
ottiene ricorrendo a metodi non positivi, come la sussunzione, che valorizzino
la libertà della giurisprudenza , e affermando la natura inevitabilmente
individuale della soluzione giuridica.
In tal modo si valorizza la funzione dottrinale e giurisprudenziale contro il
diritto legislativo, fenomeno da porre in relazione con due impostazioni: la
prima è la maggiore facilità di imporre visioni progressiste nella dottrina e
nella giurisprudenza piuttosto che tramite la legislazione.
Per spiegare tale percorso occorre tener presente il contesto politico italiano degli anni ’70 nel quale la sinistra - che
non aveva accesso al potere politico bloccato dal dominio della Democrazia Cristiana e dalle costrizioni della politica
internazionale - aveva una posizione di egemonia nell’ambiente intellettuale attraverso la quale condizionava le nuove
generazioni di giuristi e di magistrati i quali, tra l’altro, negli anni ’80 e ’90 si sono distinti, a volte a prezzo della loro
vita, nella lotta contro la mafia e la corruzione, trasformandosi spesso in eroi dell’opinione pubblica.
Inoltre tale passaggio si spiega anche con la scelta di una nuova via
democratica per la riforma delle istituzioni. La democrazia si fonda
sull’uguaglianza, necessario presupposto della libertà: ma se nelle democrazie
popolari tale uguaglianza aveva compromesso la libertà, nelle democrazie
rappresentative, l’accento sulla libertà politica ha fatto sì che gli interessi
economici e partitici soggiogassero completamente il funzionamento delle
istituzioni, instaurando una nomenklatura politico-partitica, economicofinanziaria e mediatica che governava soprattutto in favore dei propri
interessi, mortificando l’uguaglianza in una rete di corruzione politica, di
scambio di favori e di violenza.
Pertanto i magistrati - protetti di fronte al governo dalla loro indipendenza
istituzionale e liberi in virtù del loro sistema di nomina dalle influenze dei
partiti, guidati da un ideale di giustizia come uguaglianza ed equilibrio,
formati in un ambiente intellettuale progressista – sembravano in condizioni di
realizzare un “diritto uguale”, anche in una società di classe.
Sul piano istituzionale occorreva: 1. garantire l’indipendenza del giudice di
fronte al potere governativo, in particolare quella degli organi di gestione delle
carriere dei magistrati giudicanti ed inquirenti; 2. Dotare i giudici di mezzi
efficaci per realizzare il loro compito, quali l’accesso alle informazioni e
controllo dell’azione di polizia.
A sua volta il carattere inevitabilmente individuale della soluzione giuridica è il
riflesso di una visione del diritto dinamica e critica, che si coglie osservando la
realtà, così come era stato proposto dalle correnti antipositivistiche. Il giurista,
cioè, considera la realtà sociale non ancora perfetta, come qualcosa che
occorre regolare in vista di obiettivi politicamente libertari e progressisti.
In alcuni paesi come la Germania e gli Stati Uniti questo uso alternativo del
diritto e della giustizia si è combinato con la creazione di forme alternative al
diritto , proposte queste che partono dalla constatazione dell’attuale crisi
istituzionale e di legittimità del diritto e della giustizia.
La crisi istituzionale si manifesta con l’inefficace utilizzo della legge come
strumento di normazione sociale e con la conseguente apparizione di zone che
sfuggono al diritto ufficiale (zone di a-legalità, dove si preferisce ricorrere a
strumenti di regolazione informale quali accordi e arbitrati, e zone di illegalità
in cui si sfugge o si rifiuta la disciplina legale, come i mondi sommersi della
mafia o del lavoro nero).
Anche la giustizia ufficiale, fondata sulla risoluzione dei conflitti per mezzo dei
tribunali statali classici, attraversa una crisi profonda dovuta alla lentezza
della macchina giudiziaria e ai costi generati proprio dalla politica di
“democratizzazione della giustizia” intrapresa negli anni ’60 e ’70 nell’ambito
delle politiche tipiche dello Stato assistenziale.
Ma purtroppo la crisi non è solo istituzionale, ma anche di fiducia da parte dei
cittadini nelle istituzioni giuridiche e giudiziarie. I cittadini non solo ignorano il
diritto, ma lo vedono lontano dai problemi reali delle persone e, quanto alla
giustizia, appare a loro come un gioco caro e dai risultati aleatori.
Tutti questi sintomi di crisi sono alla base delle proposte di forme alternative di
diritto e di giustizia: per alcuni la regolamentazione dello Stato deve far posto
alla concertazione privata. Ma quest’ultima presuppone che le parti abbiano
un identico potere negoziale per evitare che la libera concertazione delle
norme di condotta in seno alla società civile conduca ad uno schiacciamento
dei più deboli da parte dei più forti. Appare quindi assai improbabile che lo
Stato, incaricato di compensare le disuguaglianze nella società civile, cessi di
regolare materie come i rapporti di lavoro, la vendita di servizi medici e
farmaceutici, la qualità dell’insegnamento, la sicurezza dei consumatori, la
difesa dell’ambiente etc.. Sul piano della composizione dei conflitti viene
proposta l’istituzione di organismi spontanei, creati dalla società civile, i quali,
se dotati di mezzi e assitenza di giuristi e tecnici sociali, potrebbero risolvere in
forma più rapida una vasta gamma di controversie; tali soluzioni, tuttavia,
implicano un nuovo modo di ragionare sul diritto ed una stretta cooperazione
tra il sapere giuridico e gli altri saperi.
6.
LE SCUOLE ANTILEGALISTE
Il legalismo è stata un’eredità giuridica del XIX secolo sviluppatasi nella cultura
politica europea dello statualismo e successivamente con l’avvento della democrazia
rappresentativa. Entrambe oggetto di critica da parte di coloro che non
riconoscevano allo Stato la legittimità di definire in termini assoluti le norme della
giustizia o, comunque, di parlare in nome del popolo. Inoltre, le critiche al legalismo
si rivolgevano alla forma statale del diritto (generale ed astratta, coattiva,
centralizzata, omogenea) alla quale non veniva riconosciuta la capacità di regolare
in modo giusto l’inesauribile varietà delle situazioni e dei conflitti della vita.
6.1. Aspetti generali dell’antilegalismo contemporaneo
L’antilegalismo presenta diversi aspetti:
1) Il primo è l’affermazione dell’incapacità della volontà dello Stato di definire
criteri di giustizia, e il conseguente rifiuto di un diritto assoluto e senza
appello. Tale approccio riprende un tema sempre presente nella storia del
diritto europeo, costituito dall’esistenza di un diritto naturale indisponibile da
parte dei poteri politici e perciò superiore ad essi. Il tema riprende vigore in
un’epoca di estrema estensione del potere di regolazione dello Stato a tutti i
settori della vita sociale; dalla conseguente necessità di porre dei limiti formali
e materiali all’attività dello Stato ebbero origine alcuni orientamenti filosoficimetodologici come il giusnaturalismo laico e il giusnaturalismo cristiano.
2) Il secondo aspetto sottolinea il carattere artificiale del diritto statale di fronte
alla naturale regolazione della vita, condannato ad osservare principi esterni
di giustizia immanenti nelle relazioni sociali. In questo punto confluiscono sia
le correnti sociologiche e istituzionalisti che, sia alcune correnti critiche.
3) Il terzo aspetto riguarda l’inadeguatezza delle tecniche disciplinari legalistiche
e statualistiche rispetto alla regolazione della vita sociale, insistendo sulla
varietà delle situazioni e delle istanze sociali.
6.2. Alla ricerca di una giustizia “materiale”
Alla fine della seconda guerra mondiale si generò un movimento spontaneo di
rifondazione del diritto su valori sovrapositivi, indisponibili da parte del legislatore.
Infatti, il tragico epilogo dei totalitarismi politici aveva portato a ripensare la
funzione del diritto, che non aveva frapposto nessun ostacolo ai progetti politici e
giuridici negatori dei valori fondamentali della cultura europea: il nazionalsocialismo
salì al potere rispettando sostanzialmente la forma e una volta al potere ne instaurò
una nuova che a sua volta legittimava l’azione politica.
Questo fu possibile perché la legittimità del diritto (e del potere) si fondava
esclusivamente sul fatto di essere statuito in conformità con i processi
costituzionalmente prescritti: i suoi valori di riferimento erano privi di contenuto e
puntavano solo sulla necessità di osservare una forma, in linea con l’etica
formalistica e neutrale del Kantismo e della pandettistica.
Il riconoscimento al diritto di una funzione di garanzia dei valori di civiltà avviene nei
processi ai criminali di guerra (Norimberga e Tokyo) che presupponevano già
l’esistenza di un diritto sovrapositivo, di fronte al quale potessero considerarsi
criminali azioni consentite dai singoli ordinamenti giuridici.
Nel 1949 la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca vincolò
espressamente il legislatore al diritto, inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza
come il diritto non scritto insito nella coscienza collettiva che si imponeva anche alla
Costituzione.
Ma non era facile fondare filosoficamente questo nuovo diritto naturale, perché la
cultura europea aveva cessato di credere in sistemi religiosi o filosofici di validità
generale, e di conseguenza anche di riconoscere principi giuridici di valore assoluto e
universale.
Perciò il nuovo giusnaturalismo venne ad articolarsi in tre orientamenti:
1) Il primo riconosceva, nell’ambito dell’evoluzione progressista della storia,
l’acquisizione di principi etico-giuridici irreversibili dell’umanità legati alla
dignità umana, che non possono essere messi in discussione dalla legge
positiva.
2) Un altro orientamento faceva appello alla “natura delle cose” da cui scaturisce
il “diritto naturale concreto”, che resiste alle intenzioni normative “artificiali”
del legislatore. Le cose si trasformano in una fonte che non consiste però solo
nella realtà sociale empiricamente osservabile ma anche nella dimensione
interna (la logica interna, l’aspettativa degli agenti).
3) Infine un terzo orientamento fu quello di coloro che ritenevano che i valori
“naturali” posti a limitare l’arbitrio del legislatore dovessero essere i valori
“consensuali”. Il consensualismo è tipico di un’epoca in cui la massificazione
della cultura e dell’informazione riduce i dissensi e crea una cultura di base
espressa dal senso comune, che si può riassumere nell’idea che “si deve vivere
nel consenso”.
Le correnti consensualistiche hanno avuto un impatto maggiore nella teoria
della legittimazione politica e giuridica mentre alcune, come la topica giuridica
o teoria dell’argomentazione si sono poste vicino al giurista, sul piano
dell’applicazione del diritto e della soluzione delle controversie giuridiche.
In particolare, nella decisione del caso concreto la legittimità della soluzione
trovata dal giudice (o dal giurista) non deriva tanto dalla validità delle
premesse sulle quali essa si basa, quanto dal consenso suscitato nel pubblico:
in questo contesto la legge è solo uno degli argomenti, non si colloca più –
come dettato dal normativismo – al principio di un processo di sussunzione
che conduce al ritrovamento del diritto. Al contrario la topica sostiene che è il
caso, con il suo carattere concreto e localizzato, a suggerire gli argomenti o i
punti di vista rilevanti.
In generale la topica permette di analizzare anche l’odierna funzione
giudicante, laddove il giudice spesso dipende, oltre che dai criteri di
valutazione dello Stato espressi nella legge, anche dal controllo dell’opinione
pubblica, potenziato dai media.
6.3. I giusnaturalismi cristiani
Per i giusnaturalisti cristiani il diritto indisponibile dall’organizzazione sociale e
politica non è altro che un diritto sovrapositivo proveniente dai disegni di Dio.
Nel medioevo il giusnaturalismo cristiano si basava sul diritto divino e sul diritto
canonico imponendosi solo sui credenti. Nell’età moderna – con la progressiva
laicizzazione della società - tale separazione tra il piano religioso e il piano
temporale si accentuò e la chiesa cristiana cessò di insistere sulla subordinazione del
diritto temporale al diritto e alla morale religiosa.
Fanno eccezione le componenti integraliste, presenti sia nel mondo protestante sia in quello cattolico, che continuano
a sostenere che la dimensione religiosa copra integralmente la vita umana; ne deriva la condanna verso tutte le forme
di liberalismo (ad es. libertà religiosa, carattere laico e non confessionale dello Stato) e l’idea secondo la quale il diritto
è limitato dai principi della religione.
Per converso, le chiese cristiane hanno cominciato ad insistere sul fatto che il nucleo
dei principi religiosi avesse un carattere “naturale” e pertanto obbligatorio per tutti
gli uomini, indipendentemente dalle loro credenze.
Dopo aver tentato, nella prima metà dell’Ottocento, di combattere frontalmente il
“modernismo” e il liberalismo (quest’ultimo fu condannato nel 1864 dall’enciclica di Pio IX e dal concilio
Vaticano I, anche se ciò non impedì lo sviluppo di un movimento cattolico liberale che è all’origine della Democrazia
la Chiesa assunse una
posizione più riservata, basata sull’idea di una posizione di sussidiarietà dello Stato
rispetto ai diritti naturali della persona e della famiglia. Infatti a queste cellule sociali
di base spetterebbe il compito principale nella realizzazione delle finalità umane,
mentre allo Stato spetterebbe, per diritto naturale, solo proteggere e sostenere lo
sviluppo personale e familiare, senza altra intromissione. Sostanzialmente la chiesa
voleva garantire ai cattolici uno “spazio libero” dallo Stato per salvaguardarne
l’ambito dell’insegnamento, della politica della famiglia ecc.
cristiana; il modernismo fu invece condannato dall’enciclica di Pio X nel 1907),
La “rinascita del diritto naturale” si fondava sulla rilettura di Tommaso d’Aquino
compiuta dai teologi dell’Ottocento (“neotomismo”), che ne sottolineava gli aspetti
personalistici e cioè la centralità della persona, nella sua duplice sfera fisica e
spirituale (apertura all’umanità e alla trascendenza).
Le principali linee di forza di tale giusnaturalismo erano le seguenti:
In primo luogo l’idea che il diritto debba servire valori etici superiori, derivanti
dalla dignità della persona, dalla dignità di tutto il genere umano e dalla
dignità del soprannaturale.
Sul piano della libertà personale, compete allo Stato proteggere la persona
umana, nella sua dimensione fisica (inclusa la proprietà) e spirituale mentre i
diritti personali inerenti alla dignità umana (diritto alla vita, alla libertà
personale, all’integrità fisica ecc..) furono definiti diritti naturali che, in quanto
tali, si imponevano allo Stato e al suo diritto: tra i diritti naturali furono inclusi
– oltre alla libertà dello spirito, in particolare la libertà di pensiero e di
espressione – la libertà religiosa e la libertà dell’insegnamento cattolico (con il
conseguente dovere da parte dello Stato di sovvenzionarlo).
Anche la proprietà privata, considerata un’estensione della libertà personale,
e messa in discussione dalle correnti socialiste (condannate in nome della “dottrina sociale
della Chiesa” dalle encicliche del 1891 di Leone XIII e del 1931 di Pio XI), aveva la dignità di diritto
naturale. Ma il giusnaturalismo cattolico insiste molto sul fondamento
naturale dell’istituto familiare con la statuizione di precetti che stanno al di
sopra della legge quali l’indissolubilità del matrimonio (con la conseguente
condanna del divorzio e dei matrimoni civili), la libertà di procreare
(considerando illegittima qualsiasi politica di pianificazione delle nascite) e di
educare i figli (questo spiega la continua lotta della chiesa per il
riconoscimento del diritto all’insegnamento privato, ma anche la sua reazione
contro le organizzazioni giovanili di orientamento totalitario o dirigistico).
Sul piano del diritto pubblico le idee guida sono tre.
1. La prima è la limitazione dello Stato e del suo diritto da parte della
morale e del diritto naturale.
2. La seconda è la funzione sussidiaria dello Stato, che non può avere come
fini se stesso o la società; ciò portò a condannare tutte le forme di
totalitarismo del Novecento, che subordinavano il destino personale a
obiettivi collettivi.
3. La terza è che l’attività dello Stato deve essere orientata verso il bene
comune, limitando gli eccessi dell’individualismo, ma anche azionando
strumenti di protezione dei più indifesi. In questo contesto la dottrina
sociale della chiesa si orientò nella direzione di uno “Stato sociale” (o
“assistenziale” c.d. welfare State).
6.4. Il postmodernismo giuridico
L’idea di una inevitabile limitazione del diritto statale è presente anche nello stile
culturale degli ultimi decenni del Novecento, ossia nel postmodernismo. Esso
rappresenta una reazione alla generalizzazione e alla razionalizzazione tipiche della
“modernità”. la modernità può essere definita come un paradigma socio-culturale,
emerso tra il XVI secolo e la fine del XVIII, cioè in quell’età della cultura europea che,
dall’illuminismo allo scientismo trionfante della nostra epoca, pone la conoscenza e
l’organizzazione su livelli globali e generali i soli in grado di superare l’irrazionalità e
il disordine. Infatti i valori centrali della modernità sono la generalità e l’astrattezza,
la razionalità, la pianificazione, l’eterodisciplina, la funzionalità. Il postmodernismo,
invece, oppone al generale il particolare, alla visione macro una prospettiva micro, al
sistema il “caso”, all’etero-regolazione l’auto-regolazione, al funzionale il ludico,
all’oggettivo il soggettivo, alla “verità” la “politica” (cioè la testimonianza,
l’impegno).
Su questo spirito, all’inizio degli anni ’80, confluiscono molte influenze, tra cui
Nietzsche e Foucault, che caratterizzano il postmodernismo di un relativismo
radicale rispetto alla validità della conoscenza e dei valori, che porta ad un
atteggiamento di critica ironica per i problemi esistenziali, verso i quali non ci
sarebbero più certezze (da Foucault è ripresa l’idea che i paradigmi culturali ed
epistemologici hanno un carattere storico ed aleatorio, sono solo “universi di
credenze”).
Sul piano dei saperi sociali, il postmodernismo porta al rifiuto dei valori e dei metodi
universali, ai quali vengono contrapposti: la molteplicità culturale, il pluralismo e la
conflittualità di paradigmi e valori ma anche un nuovo apprezzamento del
quotidiano e del senso comune.
In tale contesto si realizza una “svolta linguistica” nella cultura postmoderna, dal
diritto alla storia, che porta ad un’attività critica ossessiva, chiamata
“decostruttivismo”, volta a smontare tutte le costruzioni di verità, di rigore, di
giustizia, cioè tutti i saperi e i sistemi di valori e i modelli di comportamento, per
svelare l’arbitrio che ne è all’origine. Emblematica la critica, a partire da Foucault,
contro la nozione di “soggetto”, cioè contro l’esistenza di un sostrato personale
unitario razionale e cosciente che sorregge i nostri atti dando loro coerenza e
continuità.
Con Foucault la critica del soggetto e dell’identità si coniuga alla riflessione sul potere. La sua “archeologia del sapere”
ha lo scopo di ricercare nella storia le formazioni discorsive che mediano e organizzano l’esperienza che le persone
hanno del mondo. Esse danno luogo a precise “politiche generali” della verità che regolano ciò che deve essere
considerato vero o falso, che decidono quali discorsi accogliere e quali ripudiare. Tali organizzazioni di sapere
interagiscono con e sono intrinsecamente collegate ai rapporti di potere: il discorso è per Foucault il luogo
dall’articolazione produttiva di potere e sapere.
Soggetto, follia, sessualità, si rivelano tra le costruzioni discorsive più potenti, messe a punto dal potere in un preciso
momento della nostra storia per disciplinare e controllare in senso economico e produttivo il corpo sociale.
La nascita del soggetto coincide con la comparsa di un preciso discorso sull’uomo – quello delle scienze umane, che
nascono appunto in epoca moderna -, con la volontà di creare un discorso che, parlandone, istituisce il “l’individuo”
come concetto. Il processo di soggettivazione caratteristico dell’epoca moderna è visto da Foucault come estensione,
come tecnica principale del potere; una forma di potere che “è rivolta all’immediata vita quotidiana che categorizza
l’individuo, lo segna della sua individualità, lo fissa alla sua identità, gli impone una legge di verità che egli deve
riconoscere e che altri devono riconoscere in lui”. Rendere le persone soggetti, legandole ad una identità precisa – e
l’oggettivazione di un’identità sessuale sarà indagata nelle sue ricerche come una delle tecniche più efficaci a questo
scopo – è dunque un modo per assoggettarle ad un regime di governabilità: il soggetto è una forma di potere che
soggioga, che crea il miraggio e la necessità di una coscienza–conoscenza di sé per legare l’individuo alla propria
identità.
La ricerca di Foucault si concentra su i modi attraverso i quali gli esseri umani vengono resi soggetti: oltre al ruolo
fondamentale delle scienze che parlano dell’uomo, si rivelano determinanti quelle che Foucault chiama “pratiche di
divisione”, che creano il soggetto attraverso l’atto di separarlo da una serie di “altri”. Implicata con la nascita della
soggettività è, ad esempio, l’istituzione della follia: il potere-discorso ha bisogno della figura del folle come antagonista
a cui contrapporre il potere della razionalità nascente, che si può definire, così, come norma, in contrapposizione alla anormalità del folle. E se nelle epoche precedenti la pazzia era considerata come qualcosa di misterioso ma anche di
prodigioso e talvolta sacro e ai folli era permessa la vita di comunità, con la nascita dell’era moderna essi vengono
medicalizzati, la follia diventa malattia da curare, deviazione dalla norma da recuperare. I “malati” mentali vengono
rinchiusi in apposite strutture, osservati, studiati, indagati. Nasce la clinica psichiatrica e nasce un preciso discorso, un
nuovo sguardo medico, che ha istituito l’oggetto stesso della sua indagine: la follia.
La svolta linguistica ha avuto un parallelo nello studio delle culture, nel cui ambito
emerge il carattere “locale” dei valori culturali: rappresentazioni, credenze,
disposizioni emotive, da identificare attraverso una sorta di “psicanalisi della vita
quotidiana”. Al rifiuto dei valori universali cui si contrappongono i valori legati a
contesti culturali e discorsivi locali corrisponde la teoria dei sistemi autopoietici
(auto poiesi è un termine di origine greca che significa autocreazione).
Infine, sul piano sociologico, il capitalismo consumistico e l’impatto delle nuove
tecnologie della comunicazione hanno creato una cultura massificata capace di
modellare la cultura delle élites, che a sua volta si è dovuta adattare alle aspettative
del pubblico consumatore assumendo i valori della cultura popolare: infatti, i
principali creatori delle opinioni (politici, giornalisti e intellettuali) sono obbligati ad
assume i valori del senso comune quali risultano dai sondaggi e dai volumi di
vendita. Ciò che è buono, bello e vero deve essere al tempo stesso facile, popolare,
prevedibile ed accessibile.
L’egemonia della periferia sul centro, del ricevente sul produttore porta a criticare
tutto ciò che appare un’imposizione nei confronti del quotidiano e del senso
comune; nel campo del diritto ciò si dispiega in una svalutazione del diritto dello
Stato, generale, astratto, eteronomo e pianificatore (sia nel senso di appianare la
realtà sia in quello di imporre dei fini in nome di un’evoluzione naturale).
6.4.1 Il diritto del quotidiano
Nelle concezioni giuridiche tradizionali la vita quotidiana era il mondo dei fatti che
bisognava regolarizzare, ma ora il punto di vista è quello di:
1. Un mondo di produzione di norme: alcune completamente autonome, sorte
dai meccanismi della vita di tutti i giorni, altre prodotte a partire da norme del
diritto ufficiale, ma trasformate, adattate reagendo contro di esse (i cittadini e
i consumatori fanno delle leggi loro imposte qualcosa di molto diverso da ciò
che gli autori avevano in mente);
2. Un mondo incorerete di norme, perché le prassi umani generano un’infinità di
modelli di comportamento autonomi e non trasferibili né generalizzabili,
accettati ed adeguati si contesti “locali”;
3. Un mondo di norme “non intenzionali”, fatte di automatismi, quali la routine e
il senso comune, che indirizzano l’azione ma non sono pensate e funzionali
bensì solo accettate come tali.
6.4.2 Il diritto come universo simbolico
Nell’ambito del sapere giuridico esistono numerose norme e concetti che non hanno
alcuna efficacia regolativa diretta sul piano della disciplina delle relazioni sociali,
svolgendo in cambio un importante ruolo simbolico (ad esempio la maggior parte
delle leggi che regolano l’aborto, la prostituzione, l’accattonaggio o quelle che
riconoscono un diritto alla casa di abitazione, alla salute, e così via) in termini di
affermazione di valori e di strumenti atti a modellare l’immaginario sociale.
Allo stesso modo il diritto ufficiale, colto (il sapere dei giuristi di professione) diventa
anch’esso “quotidiano”, radicato nella pratica: infatti il diritto ufficiale e dottrinale se
non è capace di regolare intenzionalmente la vita di tutti i giorni (di svolgere una
funzione strumentale), tuttavia la regola indirettamente, come fonte delle immagini
di buon senso che orientano i nostri comportamenti (c.d. funzione costitutiva del
diritto)
6.4.3 Un diritto flessibile
L’idea di un diritto flessibile deriva da due correnti centrali della sensibilità
postmoderna.
Da un lato l’attenzione per l’identità particolare, l’individualità e la differenza
alla quale corrisponde un rifiuto della massificazione, dell’indistinzione e della
generalità e, pertanto, di quella politica del diritto - che ha dominato gli ultimi
decenni - sostenuta dall’idea della generalità delle soluzioni, soprattutto per
ragioni politico-ideologiche, giacché il primo corollario della democrazia è la
generalità della legge, una forma per garantire un trattamento uguale e non
discriminatorio.
Dall’altro le idee di sostituire la struttura burocratica e centralizzata tipica
delle società industriali con un’organizzazione più flessibile coerente con il
cambiamento apportato dalla “comunicativa” civiltà post-industriale. In tal
senso il sociologo Alvin TOFFLER, partendo dal ruolo di produzione della
ricchezza e del potere assegnato alla conoscenza, ha contrapposto alle
organizzazioni tradizionali - nelle quali il modello generale ed astratto e la
gerarchizzazione con un unico centro decisionale comporta perdita di
informazioni - una nuova struttura organizzativa “a rete” in cui:
o ogni polo è gestito autonomamente,
o la flessibilità e l’adattabilità sono garantite dall’inesistenza di un polo
centrale,
o la comunicazione non si basa su modelli generali ed astratti, ma su
descrizioni personalizzate
Il diritto tradizionale è il prodotto di un’organizzazione gerarchizzata e cioè lo Stato;
si esprime attraverso comandi generali ed astratti; costruisce situazioni depurate di
ogni contenuto emozionale, ridotte solo agli elementi razionali e, infine, sviluppa
tecniche di soluzione dei conflitti basate sull’intervento neutrale e distante di un
terzo non emotivamente coinvolto.
Per contro, secondo il nuovo tipo di organizzazione, il diritto dovrebbe prescindere
dalla generalità e dall’astrattezza e dovrebbe essere prodotto “localmente”; ma
dovrebbe anche slegarsi dal modello di giustizia garantita da un terzo indipendente e
neutrale, promuovendo forme di composizione patteggiata: infatti la giustizia
“neutrale” perde quell’informazione – costituita da elementi non razionali, come le
emozioni e gli affetti – che potrebbe garantire una soluzione più efficace e adeguata
al caso concreto (e non solo al suo scheletro concettuale, generale ed astratto).
6.4.4 Il pluralismo giuridico
Con il termine di pluralismo si intende una situazione di coesistenza di una
molteplicità di sistemi giuridici (o ordinamenti, o livelli, o insiemi ordinati di regole)
che interagiscono [su di un medesimo territorio] Secondo una distinzione classica,
questa definizione è formulata da una prospettiva di diritto oggettivo. Da una
prospettiva soggettiva possiamo definire il pluralismo giuridico come la situazione in
cui uno stesso individuo è soggetto a più di un sistema giuridico (o ordinamento, o
livello, o insieme ordinato di regole).
La storia insegna che i vari tentativi di esportare modelli politici e giuridici o
economici al di fuori dell’Europa hanno prodotto sul piano pratico fallimenti
clamorosi, e gli attuali rigurgiti fondamentalistici di certe culture non europee –
sottoposte per decenni a processi intensivi di “modernizzazione” – stanno a
dimostrare quali siano i risultati del perdere di vista la specificità, l’alterità e la
resistenza dei modelli culturali propri di ogni società.
Sul piano giuridico il trasferimento delle tecnologie giuridiche dall’area europea ad
aree culturali diverse solleva problemi sociali e culturali complessi se tale
esportazione non è preceduta da un’analisi scrupolosa delle culture giuridiche dei
paesi destinatari e dallo studio degli effetti perversi derivanti dalla trasposizione di
modelli giuridici occidentali.
Il pluralismo giuridico si trova in qualsiasi società, non è solo un fenomeno delle
società postcoloniali o etnicamente plurime. Il diritto o il suo sapere sono sempre
fenomeni locali, perché dipendono dalle strutture mentali proprie di ogni contesto
pratico. Talvolta le culture locali sono legate a differenze culturali di base (come nel
caso di gruppi etnicamente e culturalmente diversi); altre volte sono legate a
differenze sociali; altre volte a differenti livelli o scenari delle pratiche umane nei
quali le persone si muovono. Poiché in ognuno di questi contesti della pratica si
nascondono discipline e pratiche di comportamento diverse, in ognuno di essi è
possibile rinvenire un diritto “locale”.
Ciò spiega come anche i principi nati e legati ad una tradizione giuridica e politica
locale (quella europea) pretesi universali (come i diritti contenuti nelle dichiarazioni
universali dei diritti dell’uomo) sono “letti” in maniera diversa nei diversi contesti
culturali del mondo, nonostante che una certa globalizzazione culturale li abbia
diffusi universalmente.
6.4.5 Il costruttivismo autoreferenziale
Il tema del pluralismo viene analizzato unitamente alla teoria dei sistemi autopoietici, ispirata dai lavori dei biologi cileni Varela e Maturana e sviluppata nel
campo delle scienze sociali e giuridiche soprattutto da Luhmann (1927-2000).
Tale teoria tenta di descrivere il funzionamento dei sistemi che si producono da sé,
ossia:
I.
II.
III.
IV.
definiscono la propria identità in opposizione all’ambiente esterno fissando le
regole delle transazioni tra il sistema e l’esterno;
costruiscono i propri elementi;
costruiscono la grammatica del proprio ciclo di funzionamento;
costruiscono la meta-grammatica che governa le trasformazioni della
grammatica stessa.