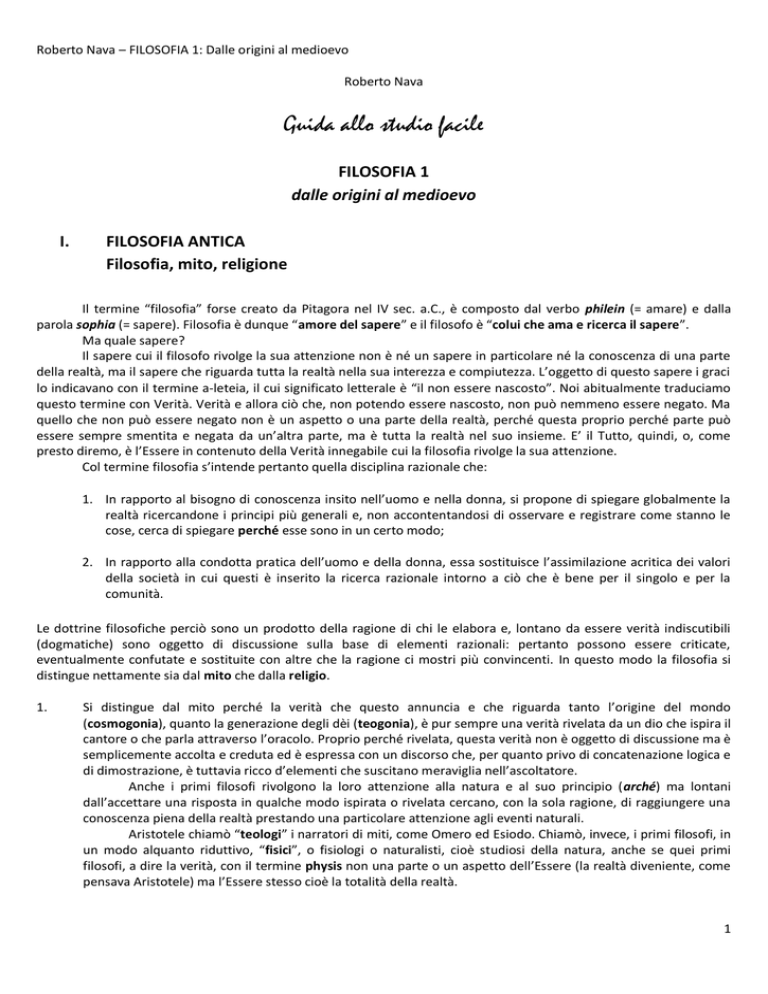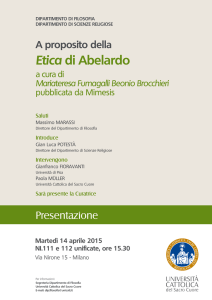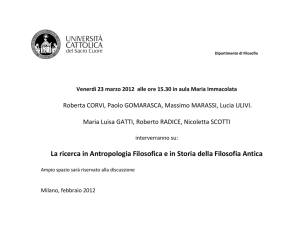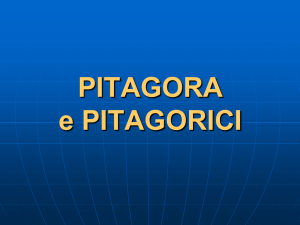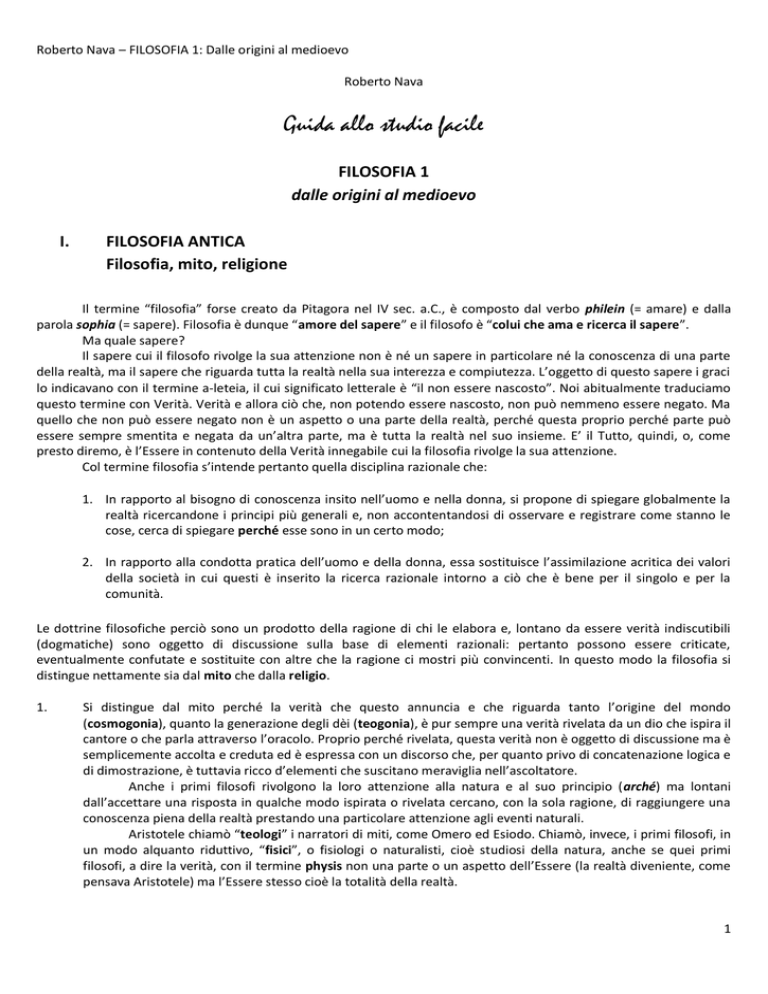
Roberto Nava – FILOSOFIA 1: Dalle origini al medioevo
Roberto Nava
Guida allo studio facile
FILOSOFIA 1
dalle origini al medioevo
I.
FILOSOFIA ANTICA
Filosofia, mito, religione
Il termine “filosofia” forse creato da Pitagora nel IV sec. a.C., è composto dal verbo philein (= amare) e dalla
parola sophia (= sapere). Filosofia è dunque “amore del sapere” e il filosofo è “colui che ama e ricerca il sapere”.
Ma quale sapere?
Il sapere cui il filosofo rivolge la sua attenzione non è né un sapere in particolare né la conoscenza di una parte
della realtà, ma il sapere che riguarda tutta la realtà nella sua interezza e compiutezza. L’oggetto di questo sapere i graci
lo indicavano con il termine a-leteia, il cui significato letterale è “il non essere nascosto”. Noi abitualmente traduciamo
questo termine con Verità. Verità e allora ciò che, non potendo essere nascosto, non può nemmeno essere negato. Ma
quello che non può essere negato non è un aspetto o una parte della realtà, perché questa proprio perché parte può
essere sempre smentita e negata da un’altra parte, ma è tutta la realtà nel suo insieme. E’ il Tutto, quindi, o, come
presto diremo, è l’Essere in contenuto della Verità innegabile cui la filosofia rivolge la sua attenzione.
Col termine filosofia s’intende pertanto quella disciplina razionale che:
1. In rapporto al bisogno di conoscenza insito nell’uomo e nella donna, si propone di spiegare globalmente la
realtà ricercandone i principi più generali e, non accontentandosi di osservare e registrare come stanno le
cose, cerca di spiegare perché esse sono in un certo modo;
2. In rapporto alla condotta pratica dell’uomo e della donna, essa sostituisce l’assimilazione acritica dei valori
della società in cui questi è inserito la ricerca razionale intorno a ciò che è bene per il singolo e per la
comunità.
Le dottrine filosofiche perciò sono un prodotto della ragione di chi le elabora e, lontano da essere verità indiscutibili
(dogmatiche) sono oggetto di discussione sulla base di elementi razionali: pertanto possono essere criticate,
eventualmente confutate e sostituite con altre che la ragione ci mostri più convincenti. In questo modo la filosofia si
distingue nettamente sia dal mito che dalla religio.
1.
Si distingue dal mito perché la verità che questo annuncia e che riguarda tanto l’origine del mondo
(cosmogonia), quanto la generazione degli dèi (teogonia), è pur sempre una verità rivelata da un dio che ispira il
cantore o che parla attraverso l’oracolo. Proprio perché rivelata, questa verità non è oggetto di discussione ma è
semplicemente accolta e creduta ed è espressa con un discorso che, per quanto privo di concatenazione logica e
di dimostrazione, è tuttavia ricco d’elementi che suscitano meraviglia nell’ascoltatore.
Anche i primi filosofi rivolgono la loro attenzione alla natura e al suo principio (arché) ma lontani
dall’accettare una risposta in qualche modo ispirata o rivelata cercano, con la sola ragione, di raggiungere una
conoscenza piena della realtà prestando una particolare attenzione agli eventi naturali.
Aristotele chiamò “teologi” i narratori di miti, come Omero ed Esiodo. Chiamò, invece, i primi filosofi, in
un modo alquanto riduttivo, “fisici”, o fisiologi o naturalisti, cioè studiosi della natura, anche se quei primi
filosofi, a dire la verità, con il termine physis non una parte o un aspetto dell’Essere (la realtà diveniente, come
pensava Aristotele) ma l’Essere stesso cioè la totalità della realtà.
1
Roberto Nava – FILOSOFIA 1: Dalle origini al medioevo
2.
La filosofia si distingue anche dalla religio perché questa risponde alle domande che l’uomo si pone appellandosi
all’autorità della Scrittura ispirate direttamente dalla divinità e richiede all’uomo un chiaro atteggiamento di
fede cioè un’incondizionata accettazione delle verità rivelate. Come vedremo nella parte dedicata alla filosofia
medievale, a differenza del mito, la religio non rifiuta a priori la ricerca razionale puerché questa però non vada
contro la rivelazione.
NASCITA DELLA FILOSOFIA
Si è spesso parlato di una derivazione del pensiero filosofico dalle culture orientali, riducendo così l’importanza
della Grecia. A tal fine tuttavia dobbiamo precisare che:
a) Se anche si presume (ma non ci son prove) che alcune dottrine della Grecia antica siano derivate
dall’Oriente, questo non implica affatto l’origine Orientale della filosofia greca;
b) Mentre la sapienza orientale è essenzialmente religiosa ed il suo solo fondamento è la tradizione, la
filosofia greca è, invece, essenzialmente ricerca e come tale nasce da un atto fondamentale di libertà di
fronte alla tradizione e alla credenza accettate come tali. Il suo solo fondamento p che l’uomo non
possiede la sapienza, ma deve cercarla: essa perciò non è sophia, ma filosofia;
c) Mentre in Oriente il sapere è patrimonio di una casta privilegiata, in Grecia la filosofia è alla portata di
ogni uomo, perché ogni uomo è «animale razionale». Scrive Aristotele: «Tutti gli uomini tendono per
natura al sapere», il che significa che essi non solo desiderano il sapere ma che possono anche
conseguirlo;
d) Le culture orientali, pur avendo sviluppato forme di pensiero anche originali e significative, non hanno
affatto raggiunto quella forma di concettualizzazione che ha in seguito permesso alla civiltà occidentali di
produrre la scienza e la tecnica e di dare parametri concettuali (categorie) identici a tutto il mondo
odierno.
NATURA, DÈI E CONOSCENZA
Nel mondo della civiltà micenea, in cui tutti vivono all’ombra del palazzo del Signore e del tempio, la natura e la
divinità non costituiscono un problema. Infatti l’uomo vive a contatto con la natura, è immerso in essa e i ritmi di questa
sono i suoi ritmi di vita (es. l’alternarsi delle stagioni condiziona la pratica dell’agricoltura).
Ugualmente la divinità consiste nella presenza e nell’azione di una pluralità di dèi, con i quali l’uomo entra in
contatto con i riti, le parole e i gesti di culto.
Ben preso questa unità si rompe: nei secoli VII-VI l’uomo, nel mondo ionico, dà vita alla città le cui mura di fatto
lo separano dalla campagna. Egli vive ora in un ambiente artificiale da lui stesso creato provocando così una frattura tra
il naturale e l’umano. La natura, pur passata come qualcosa di omogeneo e globale, viene sempre comunque vista come
separata dall’umano.
Questa scissione è poi accentuata anche dallo sviluppo, all’interno della città, di tutta una serie di tecniche
(navigazione, fabbro, vasai) non strettamente legate all’agricoltura che è la massima espressione di collaborazione tra
uomo e natura.
Allo stesso tempo si pone un altro problema: quello della divinità. Nella vecchia società la divinità è proprietà,
attraverso la gestione dei templi, della casta sacerdotale, casta che è abilitata ad interpretare il volere degli dèi e quindi
a dettare le leggi che regolano la vita della comunità.
Questo potere dei sacerdoti viene ora messo in discussione dai nuovi ceti sociali (artigiani, commercianti) e nel
mettere in discussione questo potere viene messa in discussione anche la divinità.
La divinità diventa quindi un problema: come tale essa viene sottratta al tempio e viene a coincidere con la
natura stessa, esprimendosi nei suoi fenomeni e nelle sue leggi e vivendo nei suoi ritmi.
Se la divinità coincide con la natura, è interrogando la natura stessa che noi ne scopriamo le leggi. Il nuovo
sacerdote dunque è lo scienziato, cui spetta il compito di indagare la natura e di estendere il controllo umano su di essa.
Per fare ciò però occorre scoprire i pochi principi sufficienti a spiegarne tutti i fenomeni e i mutamenti. Scoprire
quel principio è di fondamentale importanza perché vuole dire scoprire l’origine, la matrice, la ragione del tutto. Questo
2
Roberto Nava – FILOSOFIA 1: Dalle origini al medioevo
sforzo della ricerca del principio rivela l’audacia con la quale si crede di poter ridurre col pensiero la sconfinata varietà
del mondo naturale alla semplicità di un principio e poi di nuovo far derivare da questo quella varietà. E’ il tentativo più
importante di dominare e possedere la natura con il pensiero.
Con questo primitivo sforzo della ragione, compiuto dagli Ioni, la filosofia:
Nasce intorno al VI sec. a.C nelle colonie greche dell’Asia minore e precisamente a Mileto con Talete,
Anassimandro e Anassimene e ad Efeso, con Eraclito;
Si sviluppa successivamente nelle colonie greche della Magna Grecia: a Crotone con Pitagora; ad Ele
con Senofane; ad Abdera con Democrito;
Approda ad Atene, infine, nel V secolo durante la splendida età periclèa con Anassagora e i suoi seguaci.
Le ragioni per cui la filosofia nasce e si sviluppa nel mondo greco possono essere così brevemente sintetizzate:
1. Il clima di libertà, individuale e collettiva, propria delle poleis (città) greche, favorisce il confronto tra idee e
ipotesi che sono alla base della ricerca filosofica;
2. L’assenza di una religio centralisticamente organizzata, di un patrimonio di dogmi e di una casta
sacerdotale, favorisce una ricerca senza pregiudizi sulle questioni importanti come l’origine del mondo e
dell’uomo;
3. Le profonde trasformazioni economiche intervenute in molte realtà della Grecia (passaggio da una
economia esclusivamente agricola a un’altra mista con una presenza di attività industriali e commerciali)
comportano la nascita di nuovi soggetti politici ai quali il sapere tradizionale non è più sufficiente.
SOCIETA’ E CULTURA IN GRECIA (VII-VI SECOLO)
Nei secoli XI, a causa delle continue invasioni dei Dori, crolla la civiltà micenea la cui popolazione, chiamata poi
degli Ioni, migrava verso le coste agee dell’Asia Minore. Non abbiamo nessuna notizia importante su questo popolo fino
al VII sec., invece, vengono introdotte dall’Oriente le seguenti innovazioni tecnico-economiche destinate ad avere
profonde ripercussioni sociali.
a) All’uso del bronzo si sostituisce quello del ferro la cui lavorazione è più semplice,e gli utensili e le armi
sono più resistenti.
b) Si introduce l’uso della moneta metallica (oro, argento) che favorisce e semplifica gli scambi
commerciali. Effetti sociali di questa economia monetaria sono:
L’indebolimento dei medi e piccoli coltivatori che usavano commerciare mediante il baratto e lo
scambio dei prodotti;
La formazione dei ceti meno legati alla terra: commercianti, cambiavalute, usurai: le loro
prestazioni erano pagate in denaro e non più in beni, doni e cibo.
Il risultato fu la trasformazione delle iniziali comunità agricole in città ed economia mista.
1. La città ionica
Fondata e diretta dall’aristocrazia, la città ionica è all’inizio:
Centro di mediazione e di interessi delle grandi famiglie.
Punto di controllo del territorio e dei traffici.
Punto di contatto dell’economia monetaria e i suoi agenti sociali.
La struttura sia sociale che urbanistica di questa città è fondamentalmente bipolare:
Vi troviamo infatti:
a) Un polo aristocratico che ha la sua sede nell’Acropoli, luogo a carattere religioso (vi sono i templi), politico (vi
risiede il senato e vi si amministra la giustizia) e militare (è una vera fortezza che sovrasta la polis).
b) Un polo popolare che si riunisce, invece, nell’Agorà (la piazza, il mercato)dove si muove una folla di
commercianti al minuto, esportatori e importatori e di contadini. Questa folla forma il demos, il popolo urbano
che lentamente ma sempre più coscientemente viene opponendosi all’aristocrazia.
3
Roberto Nava – FILOSOFIA 1: Dalle origini al medioevo
2. La scrittura alfabetica
Fra l’VIII e il VII sec. questa scrittura arriva in Grecia dalla Fenicia. Perduta la scrittura micenea con la scomparsa
di quel popolo, per tre secoli i greci non avevano conosciuto altra forma di scrittura e la cultura era stata
trasmessa in forma orale ad opera di sacerdoti e poeti.
La scrittura alfabetica, di facile apprendimento ed uso, diviene utile strumento per la diffusione della cultura
tradizionale e per la creazione di nuove forme di cultura.
Ben presto le tensioni sociali, politiche ed economiche, scoppiate tra aristocrazia e popolo, tra acropoli e agorà
si manifestano anche a livello culturale, facendo emergere l’opposizione tra:
a) La cultura sacerdotale, ramificata certo in ogni città ma avente il suo centro ideale nel santuario Delfo,
b) La nuova cultura in formazione e a carattere prevalentemente tecnico-scientifico che risponde ai
problemi posti dal demos nell’Agorà (Mileto nel VI sec. e Atene nel V sec.).
4