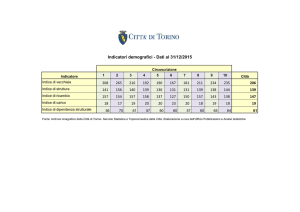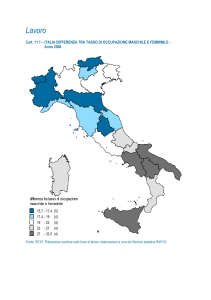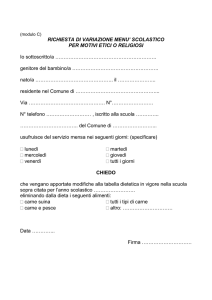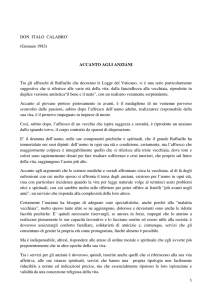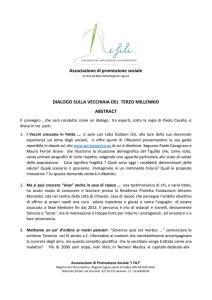Un corpo per vivere l'alleanza
Riflessioni sul ritorno alla centralità del corpo
di Bruno Secondin
In principio Dio creò il corpo dell’uomo e della donna: e lo fece non come per le altre cose create, cioè
dicendo: «Sia la luce… siano gli astri... sia il firmamento… la terra brulichi…». Dio si inginocchiò e «plasmò
l’uomo con il fango della terra e soffiò nelle sue narici un alito di vita…» (Gen 2,8). E anche per la donna:
«Dio plasmò con la costola… una donna e la condusse all’uomo» (Gen 2,22).
Se il nostro corpo è frutto di questo lavoro con le mani di un Dio inginocchiato e plasmatore, come mai
questa secolare tradizione del disprezzo del corpo nel cristianesimo? E ancora, se la stessa redenzione ha
per fondamento il “farsi carne del Verbo eterno”, perché tutta questa diffidenza per ciò che richiama la
carnalità: bellezza, pulsioni fisiche e psichiche, sessualità, relazioni corporee?
Agli occhi di Dio la carne non può essere volgare, se anche il suo Figlio ha voluto assumerla, viverla,
esaltarla, portarla con sé – per di più eternamente “piagata” – nel mistero più segreto della vita trinitaria.
Nell’identità corporea si è realizzata la redenzione, non in una parvenza di corpo. Il corpo di Gesù – il Figlio
eterno venuto ad abitare fra noi – è fatto per ricevere e dare, per accogliere e per cercare, per dire e per
ascoltare: luogo per eccellenza di incontro e di scontro, di alleanza e di promessa.
Nel suo corpo scheletrico e ignudo, inchiodato alla croce, noi oggi contempliamo il Redentore dell’universo:
in quel corpo si riflettono milioni di corpi nudi, sfigurati, irriconoscibili, e si proclama un giudizio severo sulla
società che li ha resi tali. Il ritorno al corpo nella riflessione teologica e nella cultura attuale si presta per
tutti noi a nuove e originali considerazioni sul corpo che abbiamo e soprattutto sul “corpo che siamo”.
Noi siamo corpo
Dire che “noi abbiamo un corpo” significa guardare all’umano come a una situazione dove si uniscono due
entità separate: l’anima come elemento nobile e privilegiato, senza bisogno di spazio né rischio di
corruzione. E poi il corpo, sottoposto alla finitezza, alla fragilità, quasi un involucro che protegge l’anima,
ma anche la deve lasciare andare quando sarà il momento di morire.
Si tratta di una visione che al cristianesimo è stata prestata dalla filosofia greca, ma che poi nel decorso dei
secoli è diventata così assoluta, che oggi sembra impossibile scuoterla. Tanto più che attorno a questa
visione dicotomica si sono costruite quasi tutte le scuole di spiritualità, le utopie popolari, i grandi schemi
antropologici della grazia, perfino la stessa concezione della Chiesa. Si pensi alla distinzione fra la parte
visibile e quella invisibile, la realtà sociale e quella del mistero, tutte categorie che segnalano la
trasposizione globale di una concezione dualistica nata attorno al corpo come elemento fragile e di minore
valore.
Strana contraddizione: eppure la nostra è la religione dell’incarnazione. Anzi, possiamo affermare che non
esiste altra religione così radicata nella carne umana quanto quella cristiana. La stessa promessa della
risurrezione, che altro è se non l’affermazione di una grande dignità della corporeità, dell’esperienza
Fondamentale intessuta di corporeità?
Come diceva Guardini: «solo il cristianesimo ha osato mettere il corpo nelle profondità più nascoste di
Dio».
Per questo dobbiamo dire che “noi siamo corpo”: forma fisica e relazioni intessute di atti corporei (corpo
che vede, sente, parla, gusta, tocca). E tutto ciò che è “corpo” e manifesta “corpo”, deve ridiventare
esperienza cosciente, assunta, appropriata. Anche la stessa differenza corporea – maschio e femmina – sta
diventando fonte e ispirazione di nuova coscienza, e non solo di nuova curiosità.
E questa nuova coscienza non è solo un “rumore di organi”, ma un rumore di pensieri e di valori, che ci
fanno vivere come “persone corporee”, e chiedono una nuova appropriazione.
Il corpo nella cultura contemporanea
L’emergenza del corpo è un dato recente1 praticamente è andato apparendo attraverso il secolo appena
trascorso, consolidandosi negli ultimi decenni in forme variegate e a volte anche neo-pagane. Lo prova
l’ultima propaggine narcisista e dionisiaca del corpo bello, raffinato, “nuovo”, esposto all’ammirazione. Da
una nuova cultura del corpo, si è così passati a un nuovo “culto del corpo”.
Possiamo forse considerare come vero esploratore della nuova coscienza sul corpo F. Nietzsche: per primo
si è reso conto che il capitalismo progressista e onnivoro, finiva per negare il corpo, rendendolo solo
strumento di produzione. Per questo il filosofo esaltò il corpo come portatore di gioia, di autoelevazione, di
valori alternativi. Certamente nella società capitalistica il principio era la funzionalità e la produzione: e il
corpo ne veniva schiacciato. La reazione a questa repressione è stata fatta attraverso la rivalutazione
dell’esperienza, dei desideri, del “personale” che è anche “politico”. Alla precarietà anteriore si è sostituito
il primato dell’individualità: un movimento di controcultura, che ha cambiato molte cose dal ’68 in poi.
Ma su questa posizione si era avvicinato anche il neo-marxismo, che ha spostato il primato dalla specie
(come faceva il marxismo classico) all’individuo, riconoscendo che la civiltà tecnologica finiva per alienarlo,
e soprattutto per negare il corpo nei consumi di massa. Di qui l’ insistenza sugli aspetti ludici (come la
danza), sulla liberazione dalla “logica del dominio”, che prevale nelle lotte di classe e che rinchiude
ideologicamente il corpo nelle strutture repressive.
Un altro campo dove il corpo ha fatto la sua irruzione rivoluzionaria è quello della fenomenologia: al di là
della visione ottocentesca che concepiva il corpo come un fascio di meccanismi fisici, si è scoperta la
capacità del corpo di significare contenuti psichici rimossi, e quindi di essere un “corpo vissuto” come
impulso, desiderio, bisogni. In altre parole, per dirla con la filosofia esistenzialista – che pure ha influito su
questo punto – si tratta dell’assunzione del dramma del mondo che mi attraversa e di confondermi con
esso attraverso la coscienza del corpo. Il corpo diviene così la cifra della totalità della persona.
Conseguenze e nuovi orizzonti
Varie possono essere le conseguenze di queste nuove letture sul senso del corpo: sia il narcisismo, come
nuovo stadio dell’individualismo, come “muscolazioni dirette” per ottenere un “corpo” secondo le esigenze
dell’apparire e della “body experience”. Sia – in maniera più sofisticata – l’esplorazione delle possibilità
comunicative del corpo, considerato come una riserva di segni e di gestualità legati alla cultura e anche alla
ricerca di trascendenza. Sia il vasto campo delle psicoterapie a mediazione corporea che quello non meno
esteso della medicalizzazione del corpo nella pratiche mediche ufficiali e non ufficiali.
In tutte domina comunque una visione olistica, che richiede anche il superamento – pensiamo per esempio
nella medicina come scienza del corpo – delle mire monopolizzatrici e della visione puramente mutilatrice
(il corpo, un pezzo tra gli altri). Merita un accenno particolare lo sviluppo di queste conseguenze in alcuni
ambiti. Anzitutto la nuova coscienza femminile del corpo.
Scrive S. Spinsanti in un libro non proprio recente: «La donna si riferisce al corpo in modo diverso
dall’uomo. Nell’insieme di ruoli e compiti che costituiscono le attese sociali legate allo stereotipo femminile
il rapporto col corpo è prioritario. Essere donna rimanda al corpo. A quello degli altri, anzitutto. E’ la donna
che pensa alle necessità del corpo dei membri della famiglia: nutre, pulisce, veste i bambini; accudisce i
vecchi; cura i malati. Tutte le necessità fisiche sono legate tacitamente alla donna, in particolare all’interno
del nucleo familiare… A differenza del maschio la donna è tenuta a rivolgere una attenzione privilegiata al
corpo proprio. Anche questo è un imperativo legato allo stereotipo sessuale. L’immaginario della nostra
civilizzazione è modellato sul corpo della donna».
Non c’è dubbio che la cultura che abbiamo ereditato e che anche oggi dilaga fa del “corpo della donna”,
della sua bellezza o anche del suo fascino misterioso o conturbante, una piattaforma del convivere. Ma
proprio su questo punto è esplosa nell’ultimo secolo una ribellione, o forse anche una rivoluzione, che ha
portato le donne a reclamare altri criteri di relazioni sociali e di valutazione culturale. Riappropriarsi del
corpo è stata una delle grandi battaglie: realizzate e condotte con passione e a volte anche con scandalo. Si
pensi al diritto di abortire, alla responsabilità nelle questioni relative alla gravidanza, alla nuova concezione
della sessualità come una delle varie espressioni dell’intimità, e non tanto come strumento di procreazione.
Ma si pensi anche alla tendenza a creare una cultura femminile separatista rispetto a quella “maschilista”
dominante: con punte di fanatismo e una grinta che rende talune donne antipatiche e arrabbiate per
principio. Non sempre questo è segno positivo e fruttuoso: anche se si deve riconoscere che la nuova
coscienza femminile impone agli «uomini di rivedere il loro schemi mentali, il loro modo di
autocomprendersi, di collocarsi nella storia e di interpretarla, di organizzare la vita sociale, politica,
economica, religiosa, ecclesiale» (VC 57).
Per quanto riguarda il corpo poi il maschio si comporta con molta più noncuranza della donna. Per
qualcuno – come la psicanalista Christiane Olivier – la causa è l’eccessivo attaccamento della madre al
maschietto bambino. Per sfuggire a questo desiderio possessivo, scrive Olivier, «il bambino rifiuterà tutto
ciò che riguarda il proprio corpo», proprio perché era il punto di attrazione della madre. Per questo si
concentra sulla fisicità esibita e strumentalizzata: perdendo così un giusto rapporto anche con la fonte dei
suoi sentimenti e delle sue pulsioni, il corpo. Per questo gli uomini si ammalano e muoiono prima, rifiutano
di essere malati, stanno a disagio nei gesti di tenerezza, misurano se stessi con la categoria del dominio e
della prepotenza (anche nella sessualità).
Due situazioni spia: ammalarsi e invecchiare
E’ quando siamo malati, che ci rendiamo conto che noi siamo corpo, e non soltanto che abbiamo un corpo:
e ad ammalarsi non è una parte di noi, ma tutta la nostra identità entra in crisi. E ritornare sani non è
soltanto riportare alla giusta funzionalità un organo o una parte del corpo: ma è il senso di godimento, di
fruizione, di unità della persona. La salute è una condizione di benessere globale, e non soltanto assenza di
imperfezioni o di malattie. E la malattia oggi si tende a descriverla come un “viaggio”, attraversando
angosce e tunnel oscuri, oppure come una “lotta” non solo contro la carne ferita e umiliata, ma anche
contro gli orrori della fragilità e della morte che sopravviene.
La medicina tante volte tratta invece malati e malattie come casi clinici, come incidenti da risanare, come
occasioni per mettere alla prova le proprie cognizioni e le abilità tecniche. E così la persona malata viene
dimenticata come persona, e trattata come un fascio di reazioni meccaniche, prevedibili, manipolabili. E’
questa “espropriazione” della propria dignità e della propria persona che oggi fa orrore nelle strutture
ospedaliere, ma anche nelle situazioni più semplici in casa. Il famoso sociologo Ivan Illich accusava la
medicina di essere la più grande minaccia per la salute, perché affida a una corporazione professionale un
potere assoluto e tecnico sui corpi malati. E così si travolgono le risorse naturali dell’individuo e gli
espedienti terapeutici della tradizione, come anche tutte le risorse di umanità e di tenerezza che risvegliano
sensazioni vissute e aiutano a sentire il proprio corpo e a gestirlo come compito.
Altro settore in grande evidenza nella nostra cultura è quello dell’invecchiare. Di fatto in Occidente
aumentano in misura inedita le persone anziane, si prolunga la media della vita, specie per le donne, si fa di
tutto per sfuggire alla vecchiaia, quasi fosse una malattia contagiosa. Invecchiare non è un incidente di
percorso, ma fa parte della naturale evoluzione della vita: anche se l’apparire dei “segni” della vecchiaia
dipende dallo stile di vita, dalla mentalità, dai contesti sociali. Anche nella vecchiaia il corpo sembra
prendere connotazioni diverse a seconda che si tratti di una donna o di un uomo.
Per la donna la cultura sembra sottolineare di più la perdita della bellezza, il deterioramento proprio di quel
corpo che invece nella giovinezza ne faceva il pregio. Proprio nel suo corpo la donna iscrive la sua vecchiaia:
con la fase della menopausa divenuta oggi oggetto di medicalizzazione accanita, con la fine di quella che è
considerata il vero motivo di prestigio, la fecondità, con una letteratura che parla delle donne vecchie
raramente come belle (piuttosto si trovano le figure di streghe col corpo contorto). La vecchiaia femminile
sembra più penalizzata. Invece per l’uomo c’è un immaginario di maggiore dignità: si parla di vegliardo, di
saggio, di autorità, di un corpo pieno di fascino, proprio perché vecchio.
Eppure anche questa fase della vita del corpo conosce una nuova ricognizione: in mille modi si cerca di dare
dignità e agilità ai corpi degli “anziani”, di conservare il più a lungo possibile le risorse, i sentimenti,
l’autonomia, anche il diritto alla cultura, alla vita sociale, agli affetti e alla affettività, sessuale compresa. Ma
mentre l’uomo in genere si preoccupa della immortalità – una discendenza, una scoperta scientifica,
un’opera letteraria, un ruolo di prestigio ricoperto – la donna non ha questa ossessione, si concentra meglio
sulla “formazione” delle persone, sulla vita ben riuscita e non sui prodotti esterni. Per questo la donna è
mentalmente più flessibile, anche nella vecchiaia, rispetto all’uomo.
Lo stesso morire può acquisire nuovi significati, come scrive C. Molari: «Se non si raggiunge questa
disposizione oblativa, l’uomo subisce la morte come un furto che gli sottrae le cose che egli ritiene sue. In
realtà nulla appartiene all’uomo se non il suo nome, quello che fissa la sua identità definitiva: il nome
scritto nei cieli (cf Lc 10,20). Ma questa disposizione non si acquisisce se non attraverso l’esercizio di un
amore gratuito e disinteressato. La morte chiede a ogni uomo di aver imparato ad amare al punto di non
trattenere nulla per sé, neppure il proprio corpo e da sapere, quindi, consegnare tutto. L’esistenza perciò è
palestra per imparare ad amare in modo così oblativo da diventare capace, nella morte, di offrire senza
riserve ciò che la vita ci aveva consegnato perché diventassimo definitivamente viventi».
Istituto per il LogoCounseling – www.logocounseling.org – www.paologiovanni.it