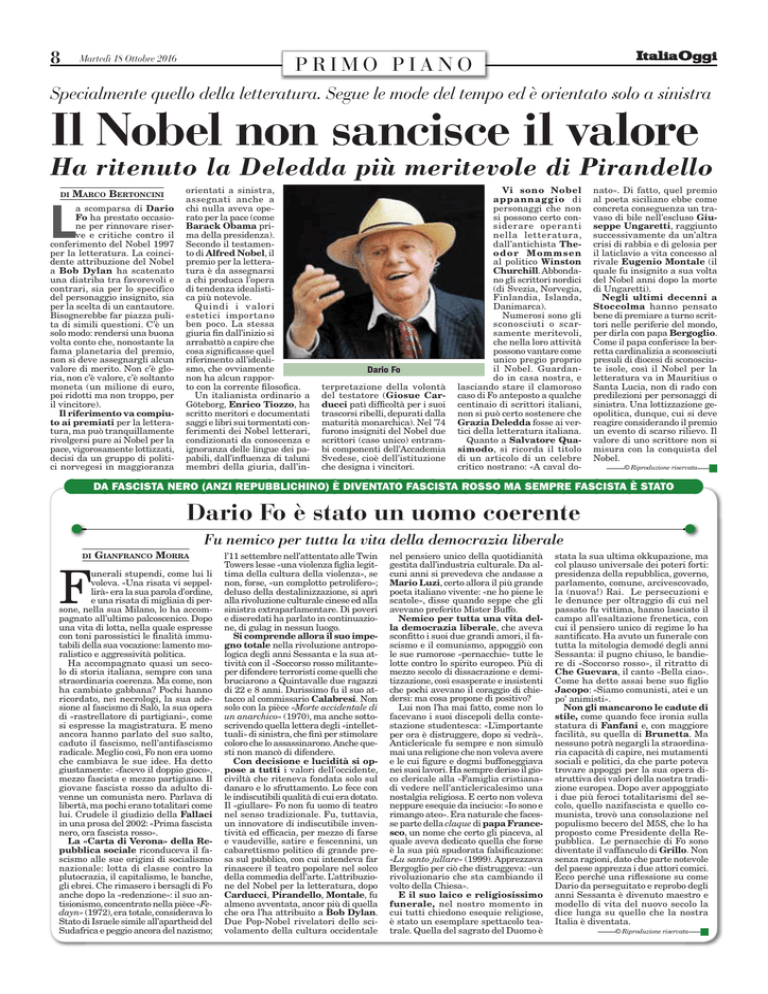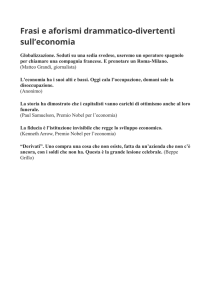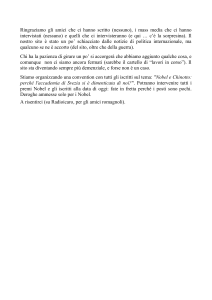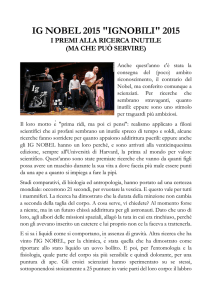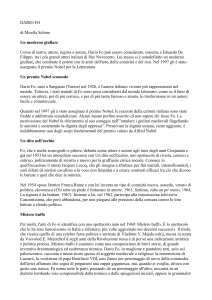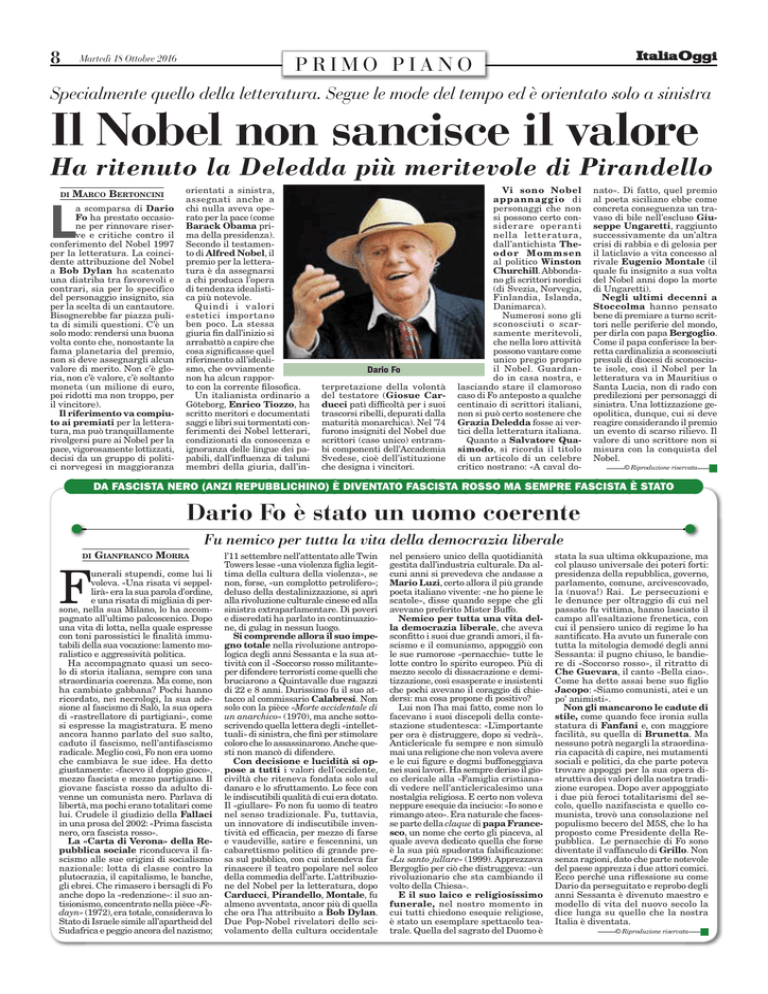
8
PRIMO PIANO
Martedì 18 Ottobre 2016
Specialmente quello della letteratura. Segue le mode del tempo ed è orientato solo a sinistra
Il Nobel non sancisce il valore
Ha ritenuto la Deledda più meritevole di Pirandello
DI
MARCO BERTONCINI
L
a scomparsa di Dario
Fo ha prestato occasione per rinnovare riserve e critiche contro il
conferimento del Nobel 1997
per la letteratura. La coincidente attribuzione del Nobel
a Bob Dylan ha scatenato
una diatriba tra favorevoli e
contrari, sia per lo specifico
del personaggio insignito, sia
per la scelta di un cantautore.
Bisognerebbe far piazza pulita di simili questioni. C’è un
solo modo: rendersi una buona
volta conto che, nonostante la
fama planetaria del premio,
non si deve assegnargli alcun
valore di merito. Non c’è gloria, non c’è valore, c’è soltanto
moneta (un milione di euro,
poi ridotti ma non troppo, per
il vincitore).
Il riferimento va compiuto ai premiati per la letteratura, ma può tranquillamente
rivolgersi pure ai Nobel per la
pace, vigorosamente lottizzati,
decisi da un gruppo di politici norvegesi in maggioranza
orientati a sinistra,
assegnati anche a
chi nulla aveva operato per la pace (come
Barack Obama prima della presidenza).
Secondo il testamento di Alfred Nobel, il
premio per la letteratura è da assegnarsi
a chi produca l’opera
di tendenza idealistica più notevole.
Quindi i valori
estetici importano
ben poco. La stessa
giuria fin dall’inizio si
arrabattò a capire che
cosa significasse quel
riferimento all’idealismo, che ovviamente
non ha alcun rapporto con la corrente filosofica.
Un italianista ordinario a
Göteborg, Enrico Tiozzo, ha
scritto meritori e documentati
saggi e libri sui tormentati conferimenti dei Nobel letterari,
condizionati da conoscenza e
ignoranza delle lingue dei papabili, dall’influenza di taluni
membri della giuria, dall’in-
Dario Fo
terpretazione della volontà
del testatore (Giosue Carducci patì difficoltà per i suoi
trascorsi ribelli, depurati dalla
maturità monarchica). Nel ’74
furono insigniti del Nobel due
scrittori (caso unico) entrambi componenti dell’Accademia
Svedese, cioè dell’istituzione
che designa i vincitori.
Vi sono Nobel
appannaggio di
personaggi che non
si possono certo considerare operanti
nella letteratura,
dall’antichista Theodor Mommsen
al politico Winston
Churchill. Abbondano gli scrittori nordici
(di Svezia, Norvegia,
Finlandia, Islanda,
Danimarca).
Numerosi sono gli
sconosciuti o scarsamente meritevoli,
che nella loro attività
possono vantare come
unico pregio proprio
il Nobel. Guardando in casa nostra, e
lasciando stare il clamoroso
caso di Fo anteposto a qualche
centinaio di scrittori italiani,
non si può certo sostenere che
Grazia Deledda fosse ai vertici della letteratura italiana.
Quanto a Salvatore Quasimodo, si ricorda il titolo
di un articolo di un celebre
critico nostrano: «A caval do-
nato». Di fatto, quel premio
al poeta siciliano ebbe come
concreta conseguenza un travaso di bile nell’escluso Giuseppe Ungaretti, raggiunto
successivamente da un’altra
crisi di rabbia e di gelosia per
il laticlavio a vita concesso al
rivale Eugenio Montale (il
quale fu insignito a sua volta
del Nobel anni dopo la morte
di Ungaretti).
Negli ultimi decenni a
Stoccolma hanno pensato
bene di premiare a turno scrittori nelle periferie del mondo,
per dirla con papa Bergoglio.
Come il papa conferisce la berretta cardinalizia a sconosciuti
presuli di diocesi di sconosciute isole, così il Nobel per la
letteratura va in Mauritius o
Santa Lucia, non di rado con
predilezioni per personaggi di
sinistra. Una lottizzazione geopolitica, dunque, cui si deve
reagire considerando il premio
un evento di scarso rilievo. Il
valore di uno scrittore non si
misura con la conquista del
Nobel.
© Riproduzione riservata
DA FASCISTA NERO (ANZI REPUBBLICHINO) È DIVENTATO FASCISTA ROSSO MA SEMPRE FASCISTA È STATO
Dario Fo è stato un uomo coerente
Fu nemico per tutta la vita della democrazia liberale
DI
F
GIANFRANCO MORRA
unerali stupendi, come lui li
voleva. «Una risata vi seppellirà» era la sua parola d’ordine,
e una risata di migliaia di persone, nella sua Milano, lo ha accompagnato all’ultimo palcoscenico. Dopo
una vita di lotta, nella quale espresse
con toni parossistici le finalità immutabili della sua vocazione: lamento moralistico e aggressività politica.
Ha accompagnato quasi un secolo di storia italiana, sempre con una
straordinaria coerenza. Ma come, non
ha cambiato gabbana? Pochi hanno
ricordato, nei necrologi, la sua adesione al fascismo di Salò, la sua opera
di «rastrellatore di partigiani», come
si espresse la magistratura. E meno
ancora hanno parlato del suo salto,
caduto il fascismo, nell’antifascismo
radicale. Meglio così, Fo non era uomo
che cambiava le sue idee. Ha detto
giustamente: «facevo il doppio gioco»,
mezzo fascista e mezzo partigiano. Il
giovane fascista rosso da adulto divenne un comunista nero. Parlava di
libertà, ma pochi erano totalitari come
lui. Crudele il giudizio della Fallaci
in una prosa del 2002: «Prima fascista
nero, ora fascista rosso».
La «Carta di Verona» della Repubblica sociale riconduceva il fascismo alle sue origini di socialismo
nazionale: lotta di classe contro la
plutocrazia, il capitalismo, le banche,
gli ebrei. Che rimasero i bersagli di Fo
anche dopo la «redenzione»: il suo antisionismo, concentrato nella pièce «Fedayn» (1972), era totale, considerava lo
Stato di Israele simile all’apartheid del
Sudafrica e peggio ancora del nazismo;
l’11 settembre nell’attentato alle Twin
Towers lesse «una violenza figlia legittima della cultura della violenza», se
non, forse, «un complotto petrolifero»;
deluso della destalinizzazione, si aprì
alla rivoluzione culturale cinese ed alla
sinistra extraparlamentare. Di poveri
e diseredati ha parlato in continuazione, di gulag in nessun luogo.
Si comprende allora il suo impegno totale nella rivoluzione antropologica degli anni Sessanta e la sua attività con il «Soccorso rosso militante»
per difendere terroristi come quelli che
bruciarono a Quintavalle due ragazzi
di 22 e 8 anni. Durissimo fu il suo attacco al commissario Calabresi. Non
solo con la pièce «Morte accidentale di
un anarchico» (1970), ma anche sottoscrivendo quella lettera degli «intellettuali» di sinistra, che finì per stimolare
coloro che lo assassinarono. Anche questi non mancò di difendere.
Con decisione e lucidità si oppose a tutti i valori dell’occidente,
civiltà che riteneva fondata solo sul
danaro e lo sfruttamento. Lo fece con
le indiscutibili qualità di cui era dotato.
Il «giullare» Fo non fu uomo di teatro
nel senso tradizionale. Fu, tuttavia,
un innovatore di indiscutibile inventività ed efficacia, per mezzo di farse
e vaudeville, satire e fescennini, un
cabarettismo politico di grande presa sul pubblico, con cui intendeva far
rinascere il teatro popolare nel solco
della commedia dell’arte. L’attribuzione del Nobel per la letteratura, dopo
Carducci, Pirandello, Montale, fu
almeno avventata, ancor più di quella
che ora l’ha attribuito a Bob Dylan.
Due Pop-Nobel rivelatori dello scivolamento della cultura occidentale
nel pensiero unico della quotidianità
gestita dall’industria culturale. Da alcuni anni si prevedeva che andasse a
Mario Luzi, certo allora il più grande
poeta italiano vivente: «ne ho piene le
scatole», disse quando seppe che gli
avevano preferito Mister Buffo.
Nemico per tutta una vita della democrazia liberale, che aveva
sconfitto i suoi due grandi amori, il fascismo e il comunismo, appoggiò con
le sue rumorose «pernacchie» tutte le
lotte contro lo spirito europeo. Più di
mezzo secolo di dissacrazione e demitizzazione, così esasperate e insistenti
che pochi avevano il coraggio di chiedersi: ma cosa propone di positivo?
Lui non l’ha mai fatto, come non lo
facevano i suoi discepoli della contestazione studentesca: «L’importante
per ora è distruggere, dopo si vedrà».
Anticlericale fu sempre e non simulò
mai una religione che non voleva avere
e le cui figure e dogmi buffoneggiava
nei suoi lavori. Ha sempre deriso il gioco clericale alla «Famiglia cristiana»
di vedere nell’anticlericalesimo una
nostalgia religiosa. E certo non voleva
neppure esequie da inciucio: «Io sono e
rimango ateo». Era naturale che facesse parte della claque di papa Francesco, un nome che certo gli piaceva, al
quale aveva dedicato quella che forse
è la sua più spudorata falsificazione:
«Lu santo jullare» (1999). Apprezzava
Bergoglio per ciò che distruggeva: «un
rivoluzionario che sta cambiando il
volto della Chiesa».
E il suo laico e religiosissimo
funerale, nel nostro momento in
cui tutti chiedono esequie religiose,
è stato un esemplare spettacolo teatrale. Quella del sagrato del Duomo è
stata la sua ultima okkupazione, ma
col plauso universale dei poteri forti:
presidenza della repubblica, governo,
parlamento, comune, arcivescovado,
la (nuova!) Rai. Le persecuzioni e
le denunce per oltraggio di cui nel
passato fu vittima, hanno lasciato il
campo all’esaltazione frenetica, con
cui il pensiero unico di regime lo ha
santificato. Ha avuto un funerale con
tutta la mitologia demodé degli anni
Sessanta: il pugno chiuso, le bandiere di «Soccorso rosso», il ritratto di
Che Guevara, il canto «Bella ciao».
Come ha detto assai bene suo figlio
Jacopo: «Siamo comunisti, atei e un
po’ animisti».
Non gli mancarono le cadute di
stile, come quando fece ironia sulla
statura di Fanfani e, con maggiore
facilità, su quella di Brunetta. Ma
nessuno potrà negargli la straordinaria capacità di capire, nei mutamenti
sociali e politici, da che parte poteva
trovare appoggi per la sua opera distruttiva dei valori della nostra tradizione europea. Dopo aver appoggiato
i due più feroci totalitarismi del secolo, quello nazifascista e quello comunista, trovò una consolazione nel
populismo becero del M5S, che lo ha
proposto come Presidente della Repubblica. Le pernacchie di Fo sono
diventate il vaffanculo di Grillo. Non
senza ragioni, dato che parte notevole
del paese apprezza i due attori comici.
Ecco perché una riflessione su come
Dario da perseguitato e reprobo degli
anni Sessanta è divenuto maestro e
modello di vita del nuovo secolo la
dice lunga su quello che la nostra
Italia è diventata.
© Riproduzione riservata