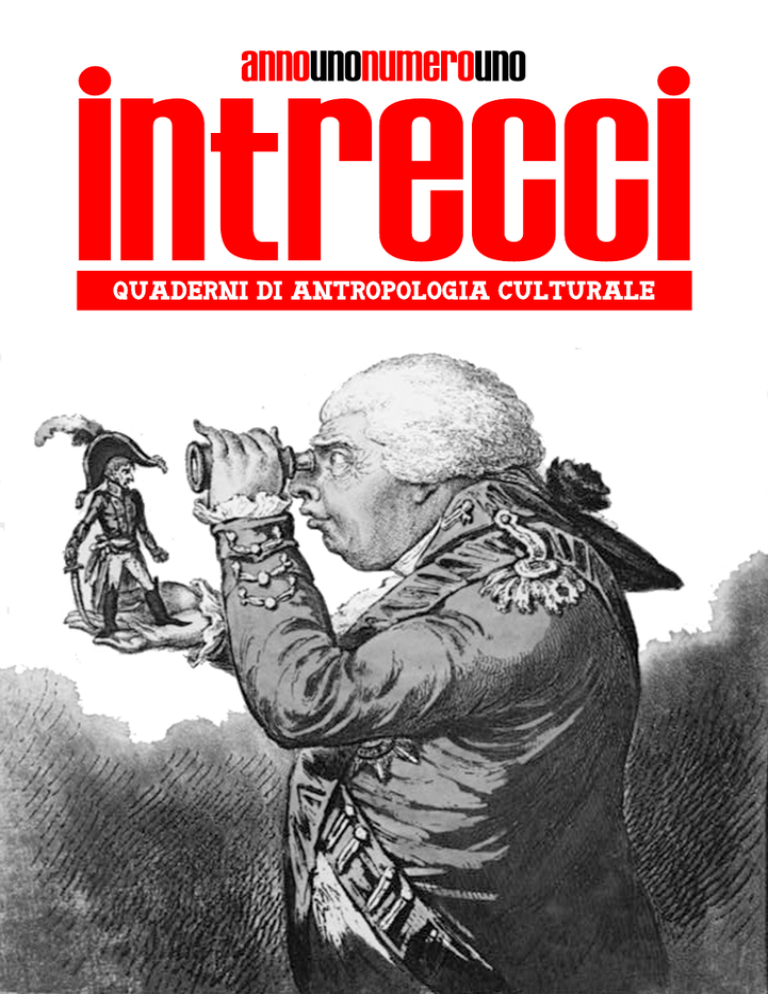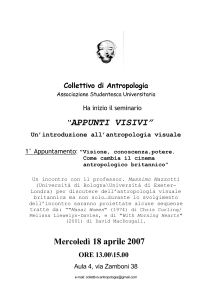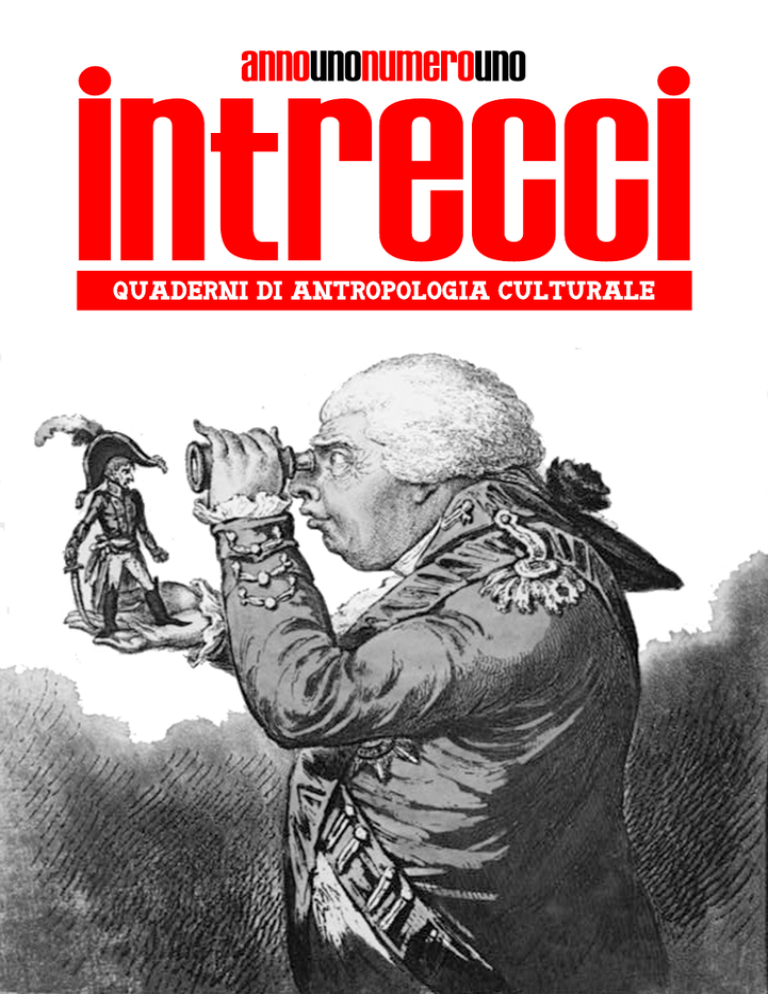
a
n
n
o
u
n
o
n
u
me
r
o
u
n
o
I
N
T
R
E
C
C
I
quadernidiantropologi
a culturale
a
n
n
o
u
n
o
n
u
me
r
o
u
n
o
I
N
T
R
E
C
C
I
quadernidiantropologi
a culturale
I
N
T
R
E
C
C
I
quadernidiantropologi
a culturale
Pe
r
i
odi
c
or
e
gi
s
t
r
a
t
opr
e
s
s
oi
lTr
i
buna
l
ediSa
s
s
a
r
i
R.
G.
S.
n°
2
/2
0
1
1
VG1
8
0
/2
0
1
1
Indice
5
Intrecci. Due righe di presentazione.
Proposte
9
Domenico Branca
La globalizzazione nell’interazione con le culture native.
Linee di tendenza.
Ricerche
35
Alessandro Pisano
La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione.
59
Manuela Casu
Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione
interculturale bilingue.
83
Valentina Mura
La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
Riflessioni sul rapporto con i Rom.
105
Emiliano Branca
Charivari. Condanna e repressione.
127
Stefano Pau
Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Lavoro
153
Davide Stocchero
Riflessioni sull’antropologia culturale
professionale’.
in versione ‘applicata e
183
Moreno Tiziani, Lucia Galasso
La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
L'attività di Antrocom onlus.
201
Gli autori
Intrecci. Due righe di presentazione.
Questo che state – virtualmente – sfogliando è il primo numero
di una nuova rivista di antropologia culturale.
Molti di voi si chiederanno il senso di un’iniziativa simile in un
momento come questo. La crisi dell’antropologia in Italia è sotto
gli occhi di chiunque la voglia vedere: chiusura dei corsi, sbocchi
professionali praticamente nulli, neanche quelli, come
l’insegnamento nei licei delle Scienze Umane o come l’impiego
come funzionario per i beni DEA nelle Soprintendenze, che
sembrerebbero fuori discussione. Anche le scuole di dottorato si
sono drasticamente ridotte, così come le borse di studio nelle
poche che sono rimaste.
Sui forum e sui blog che si occupano di antropologia il ritornello
è sempre uno: l’Italia non è un paese per antropologi. Ma può
essere questa la soluzione? Al di là della libera scelta di ognuno,
può la fuga dei cervelli essere l’unica prospettiva per chi vuole
proseguire in questo campo? Certo, le politiche che gli ultimi
governi hanno portato avanti sono a dir poco avvilenti. “Dalla
cultura non si mangia”, ha detto l’ex ministro Giulio Tremonti.
Eppure la risposta che diamo è un risoluto NO!
È urgente – ed è in atto – una riflessione sulla nostra disciplina e
su come possa inserirsi nelle dinamiche della società nel quale
viviamo, non solo dal punto di vista lavorativo. Nella
valorizzazione del patrimonio culturale, nelle policy nel campo
delle migrazioni, nella pianificazione urbanistica: sono tanti i
settori in cui potremo intervenire con competenza e cognizione
di causa. A queste tematiche abbiamo scelto di dedicare una
rubrica fissa all’interno della rivista – Lavoro – in cui raccontare
esperienze di antropologia applicata e professionale o proporre
riflessioni di carattere più generale, anche fortemente critiche,
come quella pubblicata in questo numero, contro la formazione
accademica e i suoi limiti.
QUADERNI DI ANTROPOLOGIA CULTURALE, vol. 1, n° 1,
Ma l’intento di Intrecci va oltre, offrendo la possibilità a studenti
alle prime armi di confrontarsi con i meccanismi delle
pubblicazioni scientifiche ben più autorevoli della nostra. Una
delle cose che manca nella formazione antropologica italiana è la
pratica di scrittura, soprattutto nella forma di articolo. Eppure è
principalmente attraverso questo strumento che avviene la
comunicazione scientifica, nel settore antropologico come in
qualunque altro. Alla domanda “Che cosa fa l’antropologo?”
Clifford Geertz rispondeva “Scrive”. È ovvio che c’è molto altro,
ma è anche indiscutibile che mettere al corrente del lavoro fatto –
o che si sta facendo – deve essere un obbligo, così come quello di
sottoporsi al giudizio “tra pari”. Per questo le prime due rubriche
di cui è composto Intrecci – Proposte e Ricerche – presentano
contributi inediti e sottoposti a peer review, attraverso il
procedimento del double blind.
Quella che proponiamo è un’idea di antropologia culturale
ampia, inclusiva, che superi certi steccati che le scienze sociali e
umanistiche hanno artatamente costruito e che costituiscono
spesso un ostacolo alla comprensione delle pratiche culturali. In
questo senso, il sottotitolo “Quaderni di antropologia culturale” è
da intendere in senso lato. Già in questo primo numero potrete
leggere un articolo di storia sociale ed uno al confine dei cultural
studies.
Insomma, Intrecci vuole essere uno strumento di crescita per chi
si affaccia al mondo dell’antropologia in Italia e vuole crescere a
sua volta, dotandosi già dal prossimo numero di un comitato
scientifico e aprendosi a contributi anche internazionali.
Le nostre intenzioni non possono essere che delle migliori.
Associazione Demo Etno Antropologica Ass.D.E.A.
QUADERNI DI ANTROPOLOGIA CULTURALE, vol. 1, n° 1,
PROPOSTE
წინ
ა
და
დე
ბა
πρότ
ασε
ι
ς
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
Domenico Branca
La globalizzazione nell’interazione con le culture native.
Linee di tendenza.
Abstract
This article analyses the debate about globalization as cultural uniformity. The
interconnection between places, people, technology, economy, information, is
commonly considered as a process of cultural levelling. This point of view asserts that
cultural and social diversities will disappear inexorably in a brief period of time,
because of Western and U.S. Imperialism. Conversely, the article states that although
distances are increasingly reduced, and contacts become more frequent and pervasive,
fear of homogenization appears to be unfounded. Messages, objects, practices are not
automatically accepted by groups, communities, society; it’s the latter who decide
whether to use the former [or not] and how. Messages, objects, practices are
indigenized, creolized in a coherent and creative way, making them indigenous.
Key words
Globalizzazione; uniformazione culturale; indigenizzazione; ibridazione; creatività
culturale.
La globalizzazione, come oramai noto, ha originato una serie
di dinamiche indagate in prospettiva interdisciplinare e da
studiosi di differente orientamento teorico e metodologico (Sklair
1991, Featherstone 1996, Clark 1997, Giddens 2000, Friedman
2007). Tra le valutazione mosse, vi è quella che la considera un
processo tendente all’omologazione delle differenze culturali,
una sorta di ‘metodologia dell’uniformità’ che annienta le
differenze e le peculiarità locali a favore di un appiattimento
culturale. Hannerz, a questo proposito, afferma che oggi esiste
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
9
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
una cultura mondiale, ma che questa sia lontana dall’essere “una
replica uniforme dei modelli unici”; appare, invece, come
“un’organizzazione
della
diversità,
un’interconnessione
crescente di culture locali differenti” (Hannerz 2001: 129). Per
Bauman (2001: 4) “i processi di globalizzazione non presentano
quella unicità di effetti generalmente loro attribuita”, e Friedman
specifica che “i processi globali che stanno trasformando la vita
dei popoli in ogni parte del mondo non sono semplicemente una
questione di diffusione della Coca-cola, sitcom e internet”, ma
vanno visti in maniera molto più articolata e complessa, dal
momento che sono frutto “di movimenti culturali” che
producono ideologie transnazionali (Friedman 2002: 1). Come
sintetizzano Breidenbach e Zukrigl in un loro interessante lavoro:
Come cambia la cultura nell’era della globalizzazione? La discussione
condotta finora cementa o il cliché di una fusione culturale mondiale o
lo scenario di una frammentazione di società intatte. Opere come Jihad
vs McWorld (Guerra Santa contro il McMondo) di Benjamin R. Barber
[1996] vedono la frammentazione e l’omogeneizzazione come due poli
di una evoluzione che si condizionano reciprocamente. Il termine Jihad,
usato da Barber non solo per designare la guerra santa islamica ma ogni
particolarismo locale, è così definito come reazione al livellamento
mondiale dovuto a un mercato dominato dall’Occidente. Nel processo
di fusione delle culture sorgerebbe una «monocultura americana» su
scala planetaria, la quale mescolerebbe la varietà delle culture nazionali
cresciute in un «omogeneo parco tematico globale» alla Disneyland
(Breidenbach, Zukrigl 2000: 14).
E ancora, più avanti:
Per molti «globalizzazione» significa omogeneizzazione. I contatti
crescenti tra società che in passato vivevano non avendo conoscenza le
une delle altre e le loro reciproche dipendenze sembrano distruggere
intere culture, o quanto meno appiattire la loro diversità. A questa
10
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
rappresentazione contribuisce il fatto che sempre più numerosi sono
coloro che consumano le stesse cose e sono condizionati durevolmente
dal consumo di massa. In un mondo in cui dappertutto si vede Dallas, si
lavora con Microsoft e si gioca con bambole Barbie, le persone
sembrano diventare sempre più simili (Ivi: 35).
In realtà, continuano le studiose, la situazione reale è
decisamente diversa. La globalizzazione non diviene strumento
di omologazione, per lo meno a livello culturale, di
appiattimento totale in un’ottica di americanizzazione e/o
occidentalizzazione temuto da più parti, “non si manifesta
dunque attraverso l’indebolimento delle diverse culture né tanto
meno attraverso il conflitto tra segmenti culturali sparsi che
sarebbero rimasti intatti nel corso della storia” (Amselle 2007:
88): come afferma il biochimico Kauffman,1 “inventeremo nuove
forme culturali più velocemente di quanto non ci
omogeneizzeremo” (De Biase 2001: 245). Al contrario, quindi, le
resistenze a questa ‘metodologia dell’uniformità’ appaiono più
vive che mai.
La paura dell’Americanizzazione
Quando si parla di globalizzazione culturale, ci si riferisce alla
forza egemonica che riveste l’Occidente e, nella fattispecie, gli
Stati Uniti. Questa considerazione tuttavia non tiene conto di
diversi fattori, senza i quali l’analisi risulterebbe semplicistica e
1
Stuart Kauffman (1939) è un biochimico, teorico e ricercatore americano. Fra i
suoi interessi principali, lo studio della ‘teoria della complessità’. Nel suo A
casa nell'universo. Le leggi del caos e della complessità (2001), lo studioso dedica
l'ultimo capitolo ad ‘Una civiltà globale emergente’. In questa parte l’autore
applica la teoria della complessità anche a campi non strettamente legati ai
propri interessi.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
11
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
incompleta. È vero che, come scrivono Berger e Huntington
(2002), il quadro è complicato, e che sia indubbio che esista “una
emergente cultura globale, con un’origine davvero molto
americana” e come sottolinea Friedman, ci sia una “crescente
egemonia di certe culture prevalenti; la diffusione dei valori, dei
beni di consumo e dello stile di vita americani” (1994: 195).
Nonostante questo, diamo ragione a Tomlinson – a livello
sostanziale – quando afferma che si è molto lontani dall’emergere
di una cultura unica, egemonica e globalizzata (2001: 104):
I dati più evidenti a sostegno di quest’affermazione sono la
‘convergenza’ e la standardizzazione, a livello mondiale, dei beni
culturali. Qualunque settore si prenda in esame, dall’abbigliamento agli
alimenti, alla musica, al cinema e alla televisione (e a tutto ciò che si
intende per ‘culturale’), non si può ignorare il fatto che oggi certi stili,
marchi, gusti e pratiche abbiano una diffusione globale e possano essere
riconosciuti praticamente ovunque nel mondo. […] Gli aeroporti
internazionali – presunte vie d’accesso alla diversità culturale – sono
esempi perfetti (anche se particolari) di questa sorta di
‘sincronizzazione culturale’: quasi identici in ogni parte del mondo, essi
presentano stili di arredamento uniformi, offrono una ‘cucina
internazionale’ e propongono nei duty-free shop un’intera gamma di
noti marchi internazionali. In effetti, alcuni marchi globali e icone della
cultura di massa sono diventati cliché – la Coca-Cola, i McDonald’s,
Calvin Klein, la Microsoft, la Levi’s, Dallas, la IBM, Michael Jackson, la
Nike, la CNN, la Marlboro, Schwarzenegger – alcuni persino sinonimi
della stessa omogeneità culturale
occidentale: ‘McMondo’,
‘cocacolonizzazione’,
‘mcdonaldizzazione’
e
addirittura
‘mcdisneyzzazione’ (Ibidem).
Ma – continua lo studioso – “il problema, rispetto
all’argomento dell’imperialismo culturale, è che dà per scontata
tale influenza, che compie un salto logico dalla semplice
presenza dei beni culturali – ma che effettivamente risultano
essere ‘marchi’ culturali – all’attribuzione di effetti culturali o
12
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
ideologici più profondi” (Ibidem). In definitiva per Tomlinson
“semplicemente la cultura non si trasmette in questo modo
unilaterale. Lo scambio tra regioni culturali e regioni geografiche
comporta sempre l’interpretazione, la traduzione, la
trasformazione e l’adattamento, e comporta ‘l’indigenizzazione’”
nel caso in cui “la cultura ricevente fa valere le proprie risorse
culturali, in modo dialettico, sui prodotti culturali
d’importazione” (Ivi: 105). L’analisi di Tomlinson appare
puntuale, anche se suscettibile di alcune doverose precisazioni:
in primo luogo, l’autore si riferisce alla presenza nei “nostri
aeroporti” di prodotti esclusivamente Occidentali e di massa.
Questo non corrisponde a verità, dal momento che negli
aeroporti sardi, italiani – ma anche irlandesi ed Europei in
generale – si tende alla differenziazione nella vendita dei
prodotti, puntando sulla promozione di cibi e vini locali, o altri
prodotti tipici (a Dublino, ad esempio, si possono comprare
prodotti tradizionali irlandesi dentro l’aeroporto, non reperibili
in altri luoghi). Il secondo passaggio si riferisce alla nota serie
televisiva statunitense Dallas; “diffusa a livello mondiale, è stato
evidenziato che non necessariamente si è trattato del primo
lampante esempio di americanizzazione televisiva, dato che in
vari paesi il suo successo non è stato altrettanto unanime” (Lai
2006: 67).
Ciò che appare indubbio, è l’egemonia culturale esercitata
dall’Occidente e, soprattutto, dagli Stati Uniti d’America. “Fra le
due guerre il suo principale strumento di diffusione era stata
l’industria cinematografica, la sola che avesse una distribuzione
mondiale di massa. I film americani venivano visti da un
pubblico di centinaia di milioni di persone”, (Hobsbawm 2000:
parte X); quindi “non è [...] sorprendente che la potenza di
Hollywood rifletta, in un certo senso, la potenza economica,
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
13
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
finanziaria, politica, militare degli Stati Uniti. In altri termini, il
cinema hollywoodiano riflette l’imperialismo americano”
(Bourget 1985: 182).2 Tra i diversi modi in cui la potenza culturale
statunitense si esprime, il cinema rappresenta di sicuro uno dei
mezzi più potenti. Come afferma Noam Chomsky, intellettuale
assai critico nei confronti della politica statunitense, ci troviamo
nell’”anomala condizione [di un] pianeta unificato sotto un’unica
superpotenza” (2001:10). L’America
può in questo modo sapientemente amplificare la propria forza,
peraltro smisurata, declinando congiuntamente un’egemonia
economico-industriale, un’egemonia finanziaria data dall’identità della
propria divisa con la moneta mondiale di pagamento, un’egemonia
schiacciante sul piano tecnologico- militare [...], un’egemonia culturale
data non tanto dalla penetrazione dell’immaginario americano di
Hollywood e dintorni, quanto dalla pressione secolare alla
monetizzazione e mercificazione di qualsiasi cosa e valore, figlia del
primato del mercato liberale di genesi anglosassone che continua a
coniugare secolarizzazione con capitalismo, modernità con statualità
(Ivi:10-11).
I messaggi, citando Hall (cfr 1973), vengono, è vero,
decodificati dai membri di una data cultura, ma è indubbio che
questi messaggi provengano – non sempre, chiaro – da una
stessa fonte. La resistenza a questo tipo di logica consiste,
dunque, nel risemantizzare, creativamente, questi segni,
riconducendoli a qualcosa di noto al proprio orizzonte culturale
o inventandone un senso e un significato nuovi. Questa
egemonia culturale Occidentale e, soprattutto statunitense, non
implica una uniformazione incondizionata dei tratti culturali
2
Per quanto riguarda il cinema non bisogna dimenticare potenze quali
Bollywood (in India) e Nollywood (Nigeria), superiori come produzione di
film anche agli Stati Uniti.
14
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
delle diverse società. Una tale preoccupazione era già avvertita;
infatti, la prima antropologia ‘di campo’ si accorse che la
colonizzazione aveva mutato in modo radicale e spesso violento
le strutture socio-culturali e politiche delle popolazioni
assoggettate e lavorò per cercare di salvare (la cosiddetta salvage
anthropology) da un oblio imminente le peculiarità delle diverse
comunità (Mead 1980, Malinowski 2004, Lévi-Strauss 2008,
Benedict 2010; per una critica cfr. Geertz 1990, Sahlins 1993,
Favole 2010).
Senza voler criticare degli approcci teorici che sono
esclusivamente riconducibili ad un preciso contesto storicoculturale, e senza assolutamente voler chiudere gli occhi di fronte
alle nefandezze del colonialismo e dell’imperialismo – colpevole
di essersi lasciato alle spalle decine di milioni di vittime, durante
la sua avanzata (Bodley 1990, 1992: 37) – vogliamo, invece, porre
l’accento sulla capacità che hanno gli uomini e le donne, di
qualunque cultura, di resistere, nel senso di riuscire,
creativamente, a ricostruire, combinare fra loro, i cocci di un
sistema dotato di senso. È in quest’ottica che l’antropologia
abbandona la despondency theory (Sahlins 2000) alla volta di un
approccio che finalmente restituisca anche agli Altri la capacità e
la dignità di progredire, in opposizione alla cristallizzazione in
cui l’Occidente le ha relegate.
Dunque, la considerazione omologante scarta, in maniera
troppo semplicistica, le reali dinamiche che operano nel
cosiddetto sistema-mondo (Wallerstein 1979), in ottica
macrosociologica, e l’effettiva potenzialità delle popolazioni nonoccidentali di essere responsabili di un proprio, peculiare e
cosciente progresso, come ‘agenti’ e non come ‘agiti’. Una
considerazione di questo tipo, infatti, non è esente da
implicazioni che ancora evocano tracce di una subalternità
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
15
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
culturale da parte delle popolazioni Altre. È possibile rintracciare
storicamente, in seno all’antropologia, la convinzione che
l’Occidente avesse agito prima da carnefice, salvo poi, mosso dai
propri valori ‘indiscutibilmente’ alti, redimersi e tentare di
salvare, quasi musealizzandole (Scheper-Hughes 2005), le culture
in pericolo di estinzione. Ma ad oggi – come allora, naturalmente
– le comunità indigene fanno parte della Storia, e in maniera
consapevole. Sarebbe etnocentrico e fallace pensare che gli
stimoli esterni vengano accettati in maniera passiva e identica in
contesti culturali lontanissimi fra loro ed eterogenei. Si pensi alla
tesi di Roger Bastide (1960) in merito alla ri-costruzione di una
storia, a partire da brandelli, pezzi sparsi di cultura, da parte
degli uomini e delle donne brutalmente resi schiavi e trasportati
in modo forzato dall’Africa3 all’America e lì protagonisti di una
re-invenzione creativa insieme agli indigeni americani, anche
loro vittime di brutali forme di violenza (Taussig 2005); ancora,
alle forme di consumo studiate da de Certeau (2010), ad esempio,
che vede nel consumatore un selezionatore nella giungla dei
migliaia di prodotti e messaggi da cui deve difendersi.
Quel fenomeno definito come globalizzazione culturale,
quindi, non si presenta come livellatore della diversità, come
fenomeno omogeneizzante e distruttivo per la differenza della
peculiarità locale. Le comunità – che siano quelle ‘esotiche’ di
Futuna4 (Favole 2010) o quelle della Sardegna – non sono
contenitori vuoti da riempire; la globalizzazione muta ma non
appiattisce e “non implica necessariamente e neppure
frequentemente omogeneizzazione o americanizzazione”
3
Vedi Schramm (2009) per le attuali dinamiche relative alla ricerca delle radici
da parte degli afroamericani che si recano in Africa.
4
L’isola di Futuna è, insieme a Wellis, un territorio insulare francese
nell'Oceano Pacifico, ubicato tra le isole Samoa e le Figi.
16
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
(Appadurai 2001: 34), una “occidentalizzazione del mondo”
(Latouche 1992). Le culture, lungi dall’essere cassetti chiusi a
tenuta stagna, interagiscono scontrandosi e incontrandosi, dando
luogo a fenomeni sorprendenti, ma che poi risultano, in effetti,
comprensibilmente umani. Citando Breidenbach e Zukrigl si può
affermare che
si possono addurre molti esempi del fatto che, a seconda della
situazione storica, della struttura sociale e della cultura della società
interessata, le influenze esterne vengono accolte, interpretate e fatte
proprie in maniera estremamente diversa. Gli etnologi hanno enucleato
due strategie principali nel modo di trattare le merci e le idee estranee,
per lo più occidentali: la resistenza e l’appropriazione (Breidenbach,
Zukrigl 2000: 42).
Per ‘resistenza’ le due autrici intendono una forma di non
adesione politicamente ponderata a ciò che è esterno. Il
panorama globale, a livello economico, politico, culturale, appare
talmente complesso e variegato che proporre una visione delle
cose che teorizzi una artificiale ed ingenua divisione dei
fenomeni in bianco o nero, appare quantomeno bizzarra ed
antistorica. La complessità del mondo, ad esempio, non permette
di poter dire che si sta giungendo ad una omologazione senza via
di fuga da una parte all’altra del mondo. Gli individui possono
adottare e adattare – o rifiutare – ciò che è esterno in base alle
proprie esigenze. Ma c’è un altro livello, quello statale, che per
ponderate scelte politiche opera resistenze che si rilevano di
molteplice natura. Si va dalla lotta contro l’imperialismo
linguistico condotta su tutti da Francia e Spagna, alla invocazione
da parte delle destre radicali e xenofobe europee della tutela di
presunti valori culturali sempiterni che, in virtù delle ‘nuove
invasioni barbariche’, sono oggi in pericolo.
Come afferma Ulf Hannerz: ”vi è ora una cultura mondiale,
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
17
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
ma faremmo meglio ad essere sicuri di capire ciò che questo
significa”. Continua l’antropologo svedese: “È caratterizzata
da una organizzazione della diversità piuttosto che da
una replica di uniformità” (cit. in Cesareo 2007: 71). Per Sahlins,
“la lotta dei popoli non-Occidentali per creare le proprie versioni
culturali della modernità annulla la ricevuta opposizione
Occidentale della tradizione vs cambiamento, ‘cultura’ vs
tradizione, e più in particolare la sua versione del XX secolo,
tradizione vs sviluppo” (Sahlins 1999: XI). L’ultimo paragrafo
dell’articolo porta il paradigmatico titolo di Culture is not
disappearing. La cultura non sta scomparendo. Anzi,
‘cultura’ – la parola stessa o qualche equivalente locale – è sulla bocca di
tutti. Tibetani ed hawaiani, ojibway, kwakiutl ed eschimesi, kazaki e
mongoli, nativi australiani, balinesi, kashmiri e Maori della Nuova
Zelanda: tutti scoprono di avere una ‘cultura’. Per secoli possono
appena averlo notato. Ma ora, come l’abitante della Nuova Guinea ha
detto all’antropologo, “se non avessimo kastom5 saremmo proprio come
gli uomini bianchi” (Sahlins 1993: 3).
“Ora tutti hanno una cultura, solo gli antropologi potrebbero
dubitarne”, afferma Sahlins (1999: XX) col suo particolare e
ironico linguaggio. L’antropologo americano rende bene l’idea di
come le culture, tutte le culture, siano sempre in grado di
riprodurre se stesse, di esserci anche loro, con le proprie
modalità e specificità, nel mondo moderno.
Alcuni esempi etnografici
Friedman definisce il concetto di indigenizzazione come “un
5
Kastom nelle aree anglofone, coutume in quelle francofone del Pacifico. Favole
propone come traduzione il termine "cultura" (2010: 88, nota 4).
18
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
processo di radicamento [...], un generale processo di
identificazione [...] che non dipende o meno dall’essere indigeno
in termini standard di definizioni” (2000: 650). Classico, a questo
proposito, è l’esempio della risemantizzazione (cfr Favole 2010)
della Coca-Cola:
Nessun oggetto importato, compresa la Coca-Cola, è completamente
immune da fenomeni di ibridazione. In realtà, si scopre che la Coca,
all’interno di certe culture, è spesso dotata di significati e usi diversi da
quelli immaginati dai produttori. Per esempio può distendere le rughe
(Russia), può resuscitare una persona (Haiti), e può trasformare il rame
in argento (Barbados) [...]. La Coca può anche essere indigenizzata, il
che accade quando viene mescolata con altre bevande: nei Caraibi con il
rum, per ottenere il Cuba Libre; in Bolivia con l’aguardiente, per produrre
il Ponche Negro. Infine, sembra che la Coca sia percepita come ‘prodotto
locale’ in molti luoghi diversi: spesso, cioè, si troveranno persone
convinte che la bevanda sia un’invenzione del loro paese, e non degli
Stati Uniti (Howes 1996: 6).
Si potrebbero aggiungere ancora altri esempi: il calimocho,
bevuto in Spagna dai giovani perché poco caro, è un miscuglio di
vino e Coca-Cola. Ancora, Amselle (2001) cita l’impiego che gli
agricoltori Luo del Kenya fanno della Coca-Cola: questa viene
utilizzata – indigenizzata – come bevanda rituale nelle cerimonie
di iniziazione maschile (Guigoni 2004). Anche Friedman scrive a
questo proposito, analizzando il comportamento dei Sapeurs, in
Congo, “giovani del proletariato urbano che amano vestirsi bene
e ostentare i loro stili di consumo con l’abbigliamento e altri
beni” (Lai 2006: 59). Scrive Friedman:
Il consumo di Coca-cola a Brazzaville è localmente significativo. Per
essere qualcuno o per mostrare il proprio status basta mostrare la
lattina importata sul parabrezza della propria macchina. La differenza
non è semplicemente ostentazione, bensì un vero e proprio ‘cargo’ che
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
19
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
proviene sempre dall’esterno, una forma di benessere e fertilità, un
segno di potere (Friedman 1996: 183, cit. in Lai 2006: 60).
Un altro dei ‘segni’ enumerati come esempio della società
capitalista occidentale che tutto appiana è il McDonald’s. Il
sociologo George Ritzer (1993) scrisse un saggio sul fenomeno
cosiddetto della McDonaldizzazione del mondo, ma riferendosi
soprattutto all’aspetto inerente il lavoro. In ogni caso, la paura
che spesso viene fuori da conversazioni, articoli, programmi
televisivi, è che presto il mondo mangerà da McDonald’s,
perdendo quella enorme ricchezza di diversità culturale che è il
cibo. A smentire fortemente questa preoccupazione è la notizia
recente che in Bolivia McDonald’s ha chiuso.
Tutti gli sforzi impiegati dalla catena di hamburger ‘McDonald’s’ per
inserirsi nel mercato boliviano sono risultati infruttuosi. A nulla è
servito preparare la salsa ‘llajwa’, favorita nel paese latinoamericano, né
portare i migliori complessi musicali locali dal vivo. Dopo 14 anni di
presenza nel paese, e malgrado tutte le campagne effettuate, la catena si
è vista obbligata a chiudere gli otto ristoranti che aveva aperto nelle tre
principali città del paese: La Paz, Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra.
Si tratta del primo paese latinoamericano senza ‘McDonald’s’ e il primo
paese nel mondo dove la multinazionale chiude per avere i conti in
rosso per più di un decennio. L’impatto per i ‘creativi’ e responsabili di
marketing è stato così forte che è stato realizzato un documentario dal
titolo “Perché McDonald’s ha fallito in Bolivia”, dove si cerca in qualche
modo di spiegare le ragioni che hanno portato i boliviani a preferire le
empanadas (piatto locale composto da pane di farina o mais, ripieno
all’interno) agli hamburger. Rifiuto culturale. Il documentario include
interviste a cuochi, sociologi, nutrizionisti, educatori, storici ed altri,
tutti concordi su un punto: il rifiuto non è degli hamburger né del loro
gusto, il rifiuto è nella mentalità dei boliviani. Tutto indica che il ‘fastfood’ è, letteralmente, l’antitesi della concezione che ha un boliviano nel
20
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
preparare il cibo.6
Ma, paradossalmente, dall’altro lato andare al McDonald’s è
una forma di resistenza politica:
In Stati politicamente repressivi, i beni di consumo globale sono
impiegati come segno della resistenza contro il proprio regime. I
propugnatori della democrazia indonesiani vanno provocatoriamente al
McDonald’s: «Mio figlio e io ci vendichiamo di Suharto andando ogni
giorno a mangiare da McDonald’s» (Breidenbach, Zukrigl 2000: 52).
Non necessariamente, quindi, viene accettato in maniera
passiva
qualunque
prodotto
o
fenomeno
culturale.
L’imposizione egemonica esiste, certo; resta, però, fermo il fatto
che gli individui e le comunità accettano o meno i messaggi e i
prodotti esterni, e lo fanno esclusivamente in base alle proprie
esigenze. Dall’altro lato, il prodotto egemonico diventa
strumento politico, di resistenza al regime oppressore,
capovolgendo l’idea secondo cui il prodotto globalizzato sia
obbligatoriamente oppressore.
Spesso, quindi, i fenomeni e/o i prodotti vengono
indigenizzati. Si pensi al Natale a Trinidad, isola caraibica:
Ovunque si ripuliscono e tinteggiano le case, si comprano mobili nuovi
e si lavano le fodere di quelli vecchi. La casa viene decorata con rami di
agrifoglio e Babbi Natale; alberi di plastica vengono ornati con
ghirlande di carta, fili d’argento e altri accessori conosciuti in tutto il
mondo. Completano i preparativi la neve artificiale, contenuta in
barattoli e le cartoline natalizie spedite a parenti e conoscenti. Il giorno
che precede la festa vengono confezionati i regali, per esempio
asciugamani o un nuovo apparecchio stereo, spesso già acquistati molto
6
Consultato il 16/01/2012 su
http://europeanphoenix.com/it/component/content/article/3-societa/210
lascia-la-bolivia-per-disinteresse-clienti-e-chiude-tutti-i-suoi-ristoranti.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
mcdonalds-
21
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
tempo prima e tenuti nell’armadio fino a quel momento. Si cucina e si
frigge abbondantemente, si preparano le bevande, costate cifre notevoli.
Alla buona riuscita della festa contribuiscono puncha cream, birra allo
zenzero, black cake (simile al pudding natalizio inglese cotto al vapore),
whiskey Johnny Walker, prosciutto, mele e uva (Ivi: 166).
Anche se il Natale non è, evidentemente, una festa che abbia
avuto origine a Trinidad, ciò non significa che sia meno autentica
o meno sentita rispetto al Natale in Italia o in Europa. Per
indigenizzazione si intende quel processo per cui un fenomeno
e/o un oggetto vengono dotati di caratteri nuovi, peculiari della
società che lo modifica; l’oggetto o il fenomeno diventano
indigeni.
Questo interessante e denso strumento concettuale è
applicabile a diversi fenomeni della contemporaneità, ad
esempio il calcio, lo sport internazionale; nel senso che il calcio è lo
sport nazionale di una moltitudine di Paesi ma, com’è noto,
nasce in Inghilterra nel XIX secolo e da lì si viene diffondendo
nelle maniere più disparate per il pianeta (Gibbons 2001,
Giulianotti, Robertson 2009), venendo ad assumere significati
identitari profondi (Burdsey, Chappell 2001, Branca 2012).
Un altro caso di indigenizzazione “sportiva” viene analizzato
da Arjun Appadurai. Il concetto di ‘indigenizzazione’ di cui si
serve l’antropologo si incentra, sostanzialmente, sulla
trasformazione del cricket in India da espressione della società
coloniale a sport nazionale indiano, in un complesso processo di
interiorizzazione e ridefinizione dei significati sia interni che
esterni. Il capitolo di ‘Modernità in polvere’ che tratta di questo è
paradigmaticamente intitolato ‘Giocare con la modernità’.
Dunque, siamo ad un primo livello di contestualizzazione: la
situazione – si potrebbe dire quasi emotiva – di una ex-colonia
nei confronti della madre-patria è spesso ambivalente; permane,
22
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
in ogni caso, un retaggio più o meno scomodo, una ricalibrazione
nel periodo della decolonizzazione e del pieno raggiungimento
dell’indipendenza: come afferma lo stesso Appadurai, in merito
alla situazione indiana, per cui “in qualsiasi dibattito [...] un
filone sotterraneo riguarda sempre la questione di cosa fare con i
frammenti sparsi del retaggio coloniale: alcuni di questi
frammenti sono istituzionali, altri sono ideologici ed estetici”
(2001:119). Continua l’antropologo indiano individuando le
modalità di separazione della ex-colonia dalla madre-patria: nel
caso in esame, la fine dell’Impero comporta una ridefinizione
anche per la ex-madre-patria, che si snatura; il suo essere
permane però nelle ex-colonie le quali introiettano, in maniera
diversa il retaggio. Ecco che l’India, che si volge ora al MedioOriente, all’Asia, agli Stati Uniti, conserva, riattualizza, rende
indiano, un materiale spiccatamente inglese, anzi uno dei pilastri
dimostranti la subalternità indiana verso la potenza coloniale;
quello che c’è oggi nella cultura indiana “che sembra essere
fortissimamente inglese, [...] è il cricket”, afferma Appadurai
(Ibidem).
Come è avvenuto, però, questo processo di indigenizzazione
del cricket? A livello metodologico Appadurai pone due concetti;
distingue tra ‘società morbide’ e ‘società dure’, volendo intendere
con le prime “quelle forme culturali che si presentano con un
insieme di collegamenti fra valori, significati e pratiche incarnate
che risulta difficile da sciogliere e resistente alla trasformazione”
(Ivi: 120). Al contrario, per forme ‘morbide’ egli individua quelle
forme culturali “che consentono una separazione relativamente
facile della pratica incarnata, del suo significato o valore, e
consentono inoltre con relativa facilità una trasformazione a
qualunque livello” (Ibidem). Nell’esplicazione dei processi
secondo cui questo sport si è indianizzato, l’antropologo ipotizza
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
23
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
“che il cricket sia una forma culturale dura che modifica coloro
che la vivono come forma socializzante più di quanto non muti
essa stessa”. Ma allora – continua Appadurai – “il cricket [...] in
quanto forma culturale dura, avrebbe dovuto resistere
all’indigenizzazione e invece, in modo del tutto sorprendente, è
diventato profondamente indigenizzato e decolonizzato”
(Ibidem). Ciò deriva, secondo lo studioso indiano, dal fatto “che
l’indigenizzazione è spesso il risultato di collettivi e spettacolari
esperimenti con la modernità, e non è quindi necessariamente il
prodotto di affinità sottostanti tra le nuove forme culturali e i
modelli esistenti nel repertorio culturale tradizionale” (Ibidem). È
interessante, per finire, notare quanto il cricket si sia
indigenizzato non solo in India, ma in generale in tutte le ex
colonie della Gran Bretagna. Nell’albo d’oro del campionato
mondiale per nazioni, che si gioca dal 1975 ogni quattro anni,
compaiono le vittorie di: Australia, quattro volte; Indie
Occidentali Britanniche,7 2 volte; India, 2 volte; Pakistan e Sri
Lanka, 1 volta. L’Inghilterra non ha mai vinto la competizione,
ma è arrivata tre volte in finale, sconfitta – evidentemente –
sempre dalle sue ex colonie. Questo fatto è indicativo di quanto il
movimento del cricket – partito dall’Inghilterra e poi diffusosi
nelle ex colonie – si sia indigenizzato fino a diventare forse più
importante nelle ex colonie di arrivo piuttosto che nella madrepatria.8
L’indigenizzazione del cricket, l’India e la sua esperienza
coloniale; la diffusione a livello globale di Halloween, la
risemantizzazione della Coca-Cola. Ma si potrebbero aggiungere
numerosi altri esempi; come già affermato la globalizzazione non
è quel temuto strumento di appiattimento culturale, le culture
7
8
Sarebbero i territori anglofoni dei Caraibi.
Consultato il 21/01/12 su http://it.wikipedia.org/wiki/Cricket_world_cup.
24
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
resistono, modificano, rendono propri i segni dotandoli di un
nuovo significato; le culture non sono spettatrici passive di
programmi egemoni, ma decodificano e selezionano elementi
‘esterni’ adattandoli (cfr Hall 1973).
L’indigenizzazione è dunque l’adattamento di un fenomeno o
di un fatto sociale, originariamente estraneo all’orizzonte
culturale di un determinato gruppo, entrato a far parte delle
strutture sociali, culturali, politiche o economiche del gruppo
stesso in conseguenza di una scelta ponderata e adattato nei suoi
tratti e caratteri che rispondono a determinate esigenze
contestuali. Solitamente si identifica il termine ‘indigenizzazione’
come l’adattamento di un fenomeno e/o tratto culturale
trasmesso da una cultura egemone ad una subalterna, per dirla
con Gramsci. L’antropologo argentino García Canclini (2001) ha
proposto
il
termine
‘ibridazione’
per
descrivere
l’interconnessione, il contatto, la liminarità a livello culturale che
caratterizzano la contemporaneità. Ma l’ibridazione non è
peculiarità dell’oggi, afferma García Canclini. È chiaro che dalla
sua comparsa sulla terra l’uomo si sia incontrato e scontrato con
altri gruppi umani, producendo culture che sono il risultato di
sovrapposizioni e meticciamenti, dal momento che la dinamicità
e la fluidità sono caratteristiche strutturali di ogni cultura. Gli
esseri umani scambiano, rubano, prendono, prestano ad altri
esseri umani, e fanno proprio talmente tanto un determinato
cibo, un capo d’abbigliamento, una credenza, un’abitudine che la
utilizzano, la brandiscono come emblema della propria cultura,
della propria identità, da sempre esistente, da sempre uguale,
per sempre uguale simbolo culturale. Basti pensare al kilt, il
‘gonnellino’ scozzese, emblema identitario della Scozia, simbolo
identificativo e distintivo dagli inglesi, creato – paradossalmente
– per celebrare un re inglese (cfr Trevor-Roper 1987) e,
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
25
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
nonostante questo, ad oggi uno dei simboli che identifica
immediatamente la Scozia nel mondo, e abito orgogliosamente
esibito dagli indipendentisti.
Conclusioni
Dagli esempi etnografici citati emerge una forte autonomia – e
in diversi contesti geografici – per quanto riguarda la scelta di
determinati
oggetti
culturali
che
sarebbero
imposti
dall’Occidente egemone e, soprattutto, dagli Stati Uniti. È emersa
relativamente di recente in antropologia una nuova modalità di
interpretazione, nota come ‘creatività culturale’, la quale afferma
che gli individui e le comunità decidono, in primo luogo, se
accettare ciò che gli viene proposto/imposto e, in secondo luogo,
le modalità con cui farlo. Siamo molto lontani dalla concezione
omologante secondo cui tutti diventeremo americani. Il pericolo
che una cosa del genere possa accadere, credo, non è molto
realistico. Certo, è innegabile che ci siano degli Stati nel mondo
economicamente, politicamente, militarmente, culturalmente più
forti. Ma, allo stesso tempo, affermare che tutto il resto del
mondo diventerà culturalmente come l’Occidente risulta davvero
insostenibile. Gli individui elaborano secondo le proprie
necessità, mischiano, tagliano e incollano, stravolgono il senso ed
il significato rendendo un prodotto, un fenomeno od un oggetto
completamente irriconoscibile, fino a renderlo qualcosa di
proprio, di indigeno.
26
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
Bibliografia
AMSELLE J.L.
2001
Branchements: anthropologie de l’universalité des cultures, Paris,
Flammarion.
2007
“Dal métissage alla connessione”, in La società di tutti. Multiculturalismo e
politiche dell’identità, a cura di F. Pompeo, Roma, Meltemi, pp. 79-94.
APPADURAI A.
2001
Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Roma,
Meltemi (ed. or. 1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of
Globalization, Minneapolis-London, University of Minnesota Press).
BASTIDE R.
1960
Les religions africaines au Brésil: vers une sociologie des interpenetrations de
civilisations, Paris, Presses universitaires de France.
BAUMAN Z.
2001
Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma-Bari,
Laterza (ed. or. 1998, Globalization. The Human Consequences,
Cambridge-Oxford, Polity Press-Blackwell Publishers).
BENEDICT R.
2010
Modelli di Cultura, Roma-Bari, Laterza (ed. or. 1934, Patterns of Culture,
New York, Mentor).
BERGER P. L. – HUNTINGTON S. P.
2002
Cultural Diversity in the Contemporary World, Oxford, Oxford
University Press.
BODLEY J. H.
1990
Victims of Progress, Mountain View, CA, Mayfield Publishing Co.
1992
“Anthropology and the Politics of Genocide”, in The paths to domination,
resistance, and terror, a cura di C. Nordstrom, J. A. Martin, Berkeley,
University of California Press, pp. 37-51.
BOURGET J. L.
1985
Il cinema americano. Da David W. Griffith a Francis F. Coppola, Bari,
Dedalo (ed. or. 1983, Le cinéma américain, 1895-1980, Paris, Presses
Universitaires de France).
BRANCA D.
2012
“Serás eterno come el tiempo y florecerás en cada primavera. La
squadra di calcio come fenomeno identitario”, in ANUAC, 1 (1), pp 59-69.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
27
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
BREIDENBACH J. – ZUKRIGL I.
2000
Danza delle culture. L’identità culturale in un mondo globalizzato, Torino,
Bollati Boringhieri (ed. or. 1998, Tanz der Kulturen. Kulturelle Identität
in einer globalisierten Welt, München, Kunstmann).
CESAREO V.
2007
Società multietniche e multiculturalismi, Milano, Vita e Pensiero.
CHOMSKY N.
2001
Egemonia americana e ‘stati fuorilegge’, Bari, Dedalo (ed. or. 2000, Rogue
States. The Rule of Force in World Affairs, Cambridge, MA, South End
Press.
CLARK I. – DE BIASE L.
1997
Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni internazionali nel XX secolo,
Bologna, Il Mulino (ed. or. 1997, Globalization and Fragmentation.
International Relations in the Twentieth Century, Oxford, Oxford
University Press).
DE BIASE L.
2001
In nome del popolo mondiale. La globalizzazione dopo l’undici settembre,
Roma, Fazi Editore.
DE CERTEAU M.
2010
L’invenzione del quotidiano, Roma, Edizioni Lavoro (ed. or. 1980,
L’invention du Quotidien: Arts de Faire, Paris, Gallimard).
FAVOLE A.
2010
Oceania. Isole di creatività, Roma-Bari, Laterza.
FEATHERSTONE M.
1996
Cultura globale. Nazionalismo, globalizzazione e modernità, Roma, SEAM
(ed. or. 1990, Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity: A
Theory, Culture & Society Special Issue, Thousand Oaks, CA, SAGE).
FRIEDMAN J.
1994
Cultural Identity and Global Process, London, SAGE.
2000
“Globalization, Class and Culture in Global System”, in Journal of WorldSystem Research, 6 (3), 636-656.
2002
“Globalization and the making of a global imaginary”, in Global Encounters:
Media and cultural transformation, a cura di G. Stald, G. Tufte, Luton,
Luton University Press.
2007
The Anthropology of Global Systems: Modernities, Class and the
Contradictions of Globalization, Walnut Creek, Altamira Press.
28
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
GARCÍA CANCLINI N.
1998
Culture ibride. Strategie per entrare e uscire dalla modernità, Milano, Ed.
Angelo Guerini (ed. or. 1989, Culturas híbridas: estrategias para entrar y
salir de la modernidad, Buenos Aires, Paidós).
GEERTZ C.
1990
Opere e vita: l’antropologo come autore, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1988,
Works and Lives: The Anthropologist as Author, Stanford, Stanford
University Press).
GIBBONS P.
2001
Association Football in Victorian England - A History of the Game from
1863 to 1900, S.L., Upfront Publishing.
GIDDENS A.
2000
Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna le nostre vite,
Bologna, Il Mulino (ed. or. 1999, Runaway the World. How Globalization
is Reshaping Our Lives, London, Profile Books.
GIULIANOTTI R – ROBERTSON R.
2009, Globalization and Football, London, SAGE.
GUIGONI A. (a cura di)
2004
Foodscapes. Stili, mode e culture del cibo oggi, Monza (MI), Polimetrica.
HALL S.
1973
Encoding and Decoding in the Television Discourse, Birmingham, Centre
for Contemporary Cultural Studies.
HANNERZ U.
2001
La diversità culturale, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1996, Transnational
Connections: Culture, People, Places. London, Routledge).
HOBSBAWM E.J.
2006
Il secolo breve 1914-1991, Milano, Rizzoli (ed. or. 1994, Age of Extreme.
The Short Twenty Century 1914-1991, London, Pantheon Books).
HOWES D. (a cura di)
1996
Cross-Cultural Consumption. Global Markets, Local Realities, New York,
Routledge.
LAI F.
2006
La creatività sociale: una prospettiva antropologica sull’innovazione, Roma,
Carocci.
LATOUCHE S.
1992
L’occidentalizzazione del mondo. Saggio sul significato, la portata e i limiti
dell’uniformazione planetaria, Torino, Bollati Boringhieri (ed. or. 1989,
L’Occidentalisation du monde: Essai sur la signification, la portée et les
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
29
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
limites de l’uniformisation planétaire, Paris, La Découverte).
LÉVI-STRAUSS C.
2008
Elogio dell’antropologia. Lezione inaugurale al Collège de France, Torino,
Einaudi (ed. or. 1960, Éloge de l’anthropologie).
MALINOWSKI B.
2004
Argonauti del Pacifico Occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società
primitiva, Torino, Bollati Boringhieri (ed. or. 1922, Argonauts of the
Western Pacific: an Account of Native Enterprise and Adventure in the
Archipelagoes of Melanesian New Guinea, London, Routledge & Sons).
MEAD M.
1980
L’adolescenza in Samoa, Firenze, Giunti Barbera (ed. or. 1928, Coming of
Age in Samoa. A Psychological Study of Primitive Youth for Western
Civilization, New York, William Morrow).
RITZER G.
1997
Il mondo alla McDonald’s, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1993, The
McDonaldization of Society, Thousand Oaks, Pine Forge Press).
SAHLINS M.
1993
“Goodby to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World
History”, in The Journal of Modern History, 65 (1), pp. 1-25.
1999
“What is anthropological Enlightenment? Some lessons of the Twentieth
Century”, in Annual Review of Anthropology, vol. 28, I-XXIII.
2000
“On the Anthropology of Modernity; or, some Triumphs of Culture over
Despondency Theory”, in Culture and Sustainable Development in the
Pacific, Edited by A. Hooper, Canberra, Anu and Asia Pacific Press,
pp. 44-61.
SCHEPER-HUGHES N.
2005
“Questioni di coscienza. Antropologia e genocidio, in Antropologia della
violenza”, a cura di F. Dei, Roma, Meltemi, pp. 247-302 (ed. or. 2002,
“Coming to our Senses: Anthropology and Genocide”, in Annihilating
Difference. The Anthropology of Genocide, a cura di A.L. Hinton,
Berkeley, University of California Press, pp. 348-381).
SCHRAMM K.
2009
“«Voi ce l’avete, la vostra storia. Giù le mani dalla nostra!». Dell’essere
respinti sul campo”, in Vivere l’etnografia, a cura di F. Cappelleto,
Firenze, SEID (ed. or. 2005, “«You have your own history. Keep your
hands off ours!». On being rejected in the field”, in Social Anthropology, 13,
(2), pp. 171-183).
30
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca D., La globalizzazione nell’interazione con le culture native. Linee di tendenza.
SKLAIR L.
1991
The Sociology of the Global System, Baltimore MD, Johns Hopkins
University Press.
TAUSSIG M.
2005
“Cultura del terrore e spazio della morte”, in Antropologia della violenza, a
cura di F. Dei, Roma, Meltemi, pp. 77-124, (ed. or. 1984, “Culture of
Terror – Space of Death. Roger Casement’s Putumayo Report and the
Explanation of Torture”, in Comparative Studies in Society and History, 26,
(3), pp. 467-497.
TOMLINSON J.
2001
Sentirsi a casa nel mondo, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1999, Globalization
and Culture, Chicago, University of Chicago Press).
TREVOR ROPER H.
1987
“The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland”, in The
Invention of Tradition, a cura di E.J. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge,
Cambridge University Press.
WALLERSTEIN I. – GARCÍA CANCLINI N.
1979
The Capitalist World-Economy, Cambridge, Cambridge University
Press.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
31
ri
cerche
კ
ვ
ლე
ვ
ა
έ
ρε
υν
α
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Alessandro Pisano
La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Abstract
Far from generating cultural homogeneity, globalization has started a renewed
appreciation and enhancement of local productions, especially in the food. The
requirements of endogenesis and archaism are not essential for the acquisition of an
identity valency and a connotation of typicality. In this dynamic of autopoiesis, the
process of ‘indigenization’ is costantly working, as we analyze in this paper in respect
of production and consumption of farinata in the town of Sassari, Sardinia. Born in
the Genoese, spread throughout the western Mediterranean as a result of population
movements, the farinata arrived in Sassari, probably at the turn of the nineteenth and
twentieth century, following the initiative of some entrepreneurs and then spread
widely throughout the urban area. As a result of a ‘bottom-up’ globalization, in these
consumption choices the connection between food and society soldered in an active
process of construction of a collective identity.
Key words
Farinata; Sassari; identità; globalizzazione; indigenizzazione.
Che i due macrofenomeni noti in letteratura come
‘globalizzazione’ e ‘identità’ siano intimamente connessi è ormai
appurato. Gli studi sulle dinamiche culturali connesse alla
globalizzazione hanno da tempo messo in evidenza la presenza
di processi di differente natura e dimensione, strettamente
interrelati (Amselle 1999; Appadurai 2001; Giddens 1994;
Hannerz 1987, 2001; Nederven Pieterse 2009; Robertson 1999;
Schiller 1992). Va in primo luogo riscontrata la costante
risemantizzazione, la continua negoziazione di significati, frutto
dell’azione critica e dell’agency degli attori sociali, che bilancia la
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
35
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
spinta omologante che si supponeva inevitabile conseguenza
della diffusione della produzione industriale occidentale, sia
culturale che di beni di consumo (Campbell – Davies – McKay
2004;
Lewellen 2002: 94; Tomlinson 2001). È, inoltre,
documentata (Breidenbach – Zukrigl 2000; Köstlin 2008), accanto
a queste forme culturali massificate e probabilmente come
reazione alla loro pervasività, l’azione volta a riscoprire e
valorizzare pratiche a ragione o a torto etichettate come
‘tradizionali’, a volte frettolosamente abbandonate e altrettanto
frettolosamente ricostruite, a volte reinventate (Boissevain 1992;
Hobsbawm – Ranger 2002) in obbedienza ad un autocostruito
‘noi’ “di cui entrare a far parte” (Baumann 2003: 25) da proporre
come paradigma identitario e da opporre a processi di
uniformizzazione. Il cibo, in quanto terreno di incontro tra
pratiche individuali e collettive, in quanto “metodo simbolico per
sottolineare la propria appartenenza” (Secondulfo 2004: 50) e,
attraverso pratiche di consumo, affermare identità socialmente
costruite (Lupton 1996; Guigoni 2004a; Featherstone 2007;
Montanari 2006; Bourdieu 2010) non si sottrae a questo vero e
proprio processo di autopoiesi.
I soli requisiti di endogenesi o arcaicità si rivelano non
sufficienti alla comprensione delle modalità mediante le quali
solo alcune tra le molteplici pratiche che un gruppo pone in atto
nella propria vita sociale e culturale vengano connotate come
identitarie, come cercherò di dimostrare in questo articolo a
partire da un esempio etnografico. Analizzerò qui una pratica
alimentare, la produzione e il consumo di fainé nella città di
Sassari, in cui l’esogenesi rispetto al contesto analizzato e
l’introduzione in tempi relativamente recenti non hanno
impedito l’acquisizione di un marcatore identitario attraverso un
processo di indigenizzazione (Sahlins 1993).
36
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
È necessaria però anzitutto, per una più efficace comprensione
del fenomeno, una descrizione etnografica delle pratiche di
consumo e della trasmissione dei saperi legati all’alimento in
questione, integrata con una ricostruzione storica che utilizzi le
fonti orali e scritte disponibili ed una comparazione con gli
alimenti simili diffusi in tutto il Mediterraneo occidentale.
La farinata tra storia e leggenda
La farinata, come è nota la fainé al di fuori del contesto
sassarese, è una focaccia salata, preparata con una miscela di
quattro ingredienti: farina di ceci, olio, sale e acqua. Se tre delle
componenti
sono
facilmente
reperibili
in
loco,
l’approvvigionamento di farina di ceci ci fornisce subito
importanti informazioni sull’origine del piatto:
La farina di ceci continua a venire da Genova, sempre da Pegli. Ci sono
dei mulini in Italia, a Pegli e a Torino. Il resto degli ingredienti è locale. 1
La farinata viene cotta al forno in teglie di rame di forma
circolare fino ad assumere un colore dorato. Anche per quanto
riguarda le teglie la provenienza è per lo più ligure:
Le teglie le vendono anche qua ma non è che siano molto buone… le
prendiamo a Savona e da Isili qualche volta perché c’è un ramaio
abbastanza bravo.2
È quindi alla Liguria, e all’area del genovese in particolare, che
dobbiamo rivolgerci per individuare il vero e proprio centro di
diffusione della farinata in tutto il Mediterraneo occidentale.
1
2
Intervista a Mario Marongiu il 22/05/2010.
Intervista a Mario Marongiu (22.05.2010).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
37
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Genova ha rivestito un ruolo di assoluto primo piano come
potenza marinara e commerciale durante il Medio Evo, subendo
successivamente un ridimensionamento in un primo tempo dalla
concorrenza di rivali quali Pisa e Venezia e successivamente
dallo spostamento del baricentro delle rotte commerciali verso
l’Atlantico come conseguenza delle esplorazioni geografiche
(Braudel 1982).
Sulla nascita della farinata è stato elaborato un corpus di
leggende, reperibili in rete, che legano l’invenzione del piatto ad
episodi storici particolarmente significativi.
La prima ha come cornice storica un cruciale avvenimento
della storia medievale europea, la battaglia della Meloria del
1284, in cui i genovesi sconfissero i rivali pisani assumendo
temporaneamente il controllo del Mediterraneo:
Le galere genovesi, cariche di vogatori prigionieri si trovarono coinvolte
in una tempesta. Nel trambusto alcuni barilotti d'olio e sacchi di ceci si
rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata. Poiché le provviste erano
quelle che erano e non c'era molto da scegliere, si recuperò il possibile e
ai marinai vennero date scodelle di una purea informe di ceci e olio. Nel
tentativo di rendere meno peggio la cosa, alcune scodelle vennero
lasciate al sole, che asciugò il composto in una specie di frittella.
Rientrati a terra i genovesi pensarono di migliorare la scoperta
improvvisata, cuocendo la purea in forno. 3
La seconda presenta una situazione più drammatica:
Tale Guglielmo di Pegli, console dei genovesi a Famagosta nel 1277, di
ritorno nelle natie terre di Laviosa in Pelii trovò la landa in preda alla
carestia. Poiché nel periglioso viaggio per mare si scontrò vittorioso con
un barco saraceno saccheggiandone come d’uso il carico e traendone
schiavi i remiganti, mise a disposizione delle plebi affamate le granaglie
3
Consultato il 03.05.2012 su <http://www.tanti.it/italiano/index_ita.html>.
38
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
ivi trovate, ovvero 80 giare di ceci. Li ceci furono macinati al molino
Lomellini sul Varenna, e non adattandosi bene l’impasto a forma di
pane, furono utilizzati per la cottura, a guisa di schiacciata, i tondi scudi
saraceni.4
I due racconti concordano, quindi, nel consegnare le origini
della farinata all’età dell’oro della città di Genova, quel periodo,
tra l’XI e il XIV secolo, in cui la Repubblica Marinara ebbe un
ruolo da protagonista nelle vicende politiche europee ed esercitò
la propria influenza in larga parte del Mediterraneo. In
quest’ottica diventa sostanzialmente irrilevante il fatto che le due
leggende differiscano sulle modalità pratiche di invenzione del
piatto. È molto più importante il fatto che in entrambi i casi
l’origine sia collocata in un ambito mitologico: in un caso perché
legata all’apogeo del potere genovese conquistato sui mari della
Meloria, nell’altro perché determinato dall’intervento di un vero
e proprio deus ex machina di ritorno da terre lontane che risolve la
tragedia della carestia nella madrepatria.
Furono inizialmente i mercanti i primi a diffondere la farinata
anche in quelle zone, come il litorale toscano e la città di Pisa, che
hanno conteso alla città ligure il predominio sui mari:
Sembra che l'origine della cecina [nome locale della farinata, ndA] in
tempi lontani sia ligure, arrivata in Toscana con i commerci via terra
attraverso la Lunigiana, e via mare attraverso le soste delle navi da Pisa
fino a risalire l'Arno fino a Firenze dove si ritrova la ‘farinata
fiorentina’.5
Consultato il 03.05.2012 su
<http://www.ponentinopegli.org/article.php?story=20050425230857575> .
5 Consultato il 03.05.2012 su
<http://germoplasma.arsia.toscana.it/pn_prodtrad/modules/MESI_Menu/
Prodotto.php?ID=182>.
4
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
39
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Al movimento delle merci talvolta è corrisposto un
trasferimento di popolazione. Questi gruppi di provenienza
ligure hanno portato con sé nei luoghi di nuova destinazione
pratiche culturali ed abitudini alimentari consolidate. È a queste
migrazioni che si deve la presenza di varianti della farinata
nell’area provenzale e a Gibilterra, destinazione di flussi
migratori da Genova nel XVI secolo (Archer 2006). L’arrivo della
farinata a Carloforte, nell’isola di S. Pietro a sud ovest della
Sardegna, è databile al 1738, quando una parte dei pegliesi
residenti nella città di Tabarka, nell’odierna Tunisia, migrò verso
l’isola (Tiragallo 2008). La città tunisina era stata concessa alla
famiglia genovese dei Lomellini, legata al potentato dei Doria,
per la pesca del corallo nel 1544, anno della migrazione dei primi
pegliesi che possiamo considerare terminus ante quem per quanto
riguarda l’invenzione del piatto nella madre patria.6
La farinata, a cavallo tra Ottocento e Novecento, ha
oltrepassato l’oceano Atlantico arrivando in Argentina e in
Uruguay, ancora una volta trasportata da migranti genovesi in
cerca di fortuna. La farinata è diventata col tempo una
«istituzione gastronomica» (Manzitti 2008: 11) nei due paesi
sudamericani.
In vari siti internet si trovano altri dettagli storici che
rimandano a decreti emessi dalle autorità genovesi nel 1447 con
l’intento di disciplinare la preparazione del piatto, se non ancora
più indietro nel tempo alla ricerca di origini greche e latine.7
Consultato il 03.05.2012 su <http://www.pegli.com/sto_colo.php>
(14.11.2010). Cfr. anche Guigoni 2004.
7 Si veda la voce “Farinata” in Guarnaschelli Gotti 1990: 373, nella quale è
inclusa la ricetta tratta da La vera cucina genovese di Emanuele Rossi, pubblicato
nel 1865 e la voce “Farinata di ceci” su Wikipedia che raccoglie tutte le
informazioni non verificabili sull’argomento.
6
40
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Queste informazioni, pur se da accogliere con cautela in assenza
di rimandi bibliografici o d’archivio verificabili, sono comunque
di un certo interesse e degne di segnalazione, in quanto
testimonianza di un rapporto tra popolazione e cibo ormai
consolidato.
Quando la farinata diventò la fainé
Come è difficile, se non impossibile, determinare con esattezza
il periodo di elaborazione della ricetta della farinata, altrettanto
complesso risulta dare un’indicazione precisa della sua
introduzione a Sassari. Un informatore, intervistato
sull’argomento, appare al contrario molto risoluto:
La fainé a Sassari fa parte della storia. È genovese di nascita però a
Sassari la fainé c’è dal 1700.8
Se la prima parte dell’affermazione può essere condivisibile, la
seconda non è suffragata da prove documentali certe. È noto che
l’origine delle relazioni di natura commerciale e politica tra le
città di Sassari e di Genova si colloca nel Medio Evo ed è
verosimile che i rapporti tra i due centri siano proseguiti anche
dopo la fine della supremazia genovese, ma il campo delle
ipotesi è l’unico su cui sia lecito avventurarsi.
È opportuno quindi concentrarsi sulla storia del XX secolo, per
il quale disponiamo di un maggior numero di fonti, specialmente
orali, a cui attingere. È infatti ancora vivo il ricordo di molti dei
personaggi legati al mondo della fainé. Molti sono di origine
ligure, come gli Ottonello, Baciccia o Ambrogino Pelle, altri
invece sardi, come i fratelli Valentino, Carlo e Zizzu Pira,
8
Intervista a Mario Marongiu (22.05.2010).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
41
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
provenienti da Dorgali. È interessante notare il fatto che tra le
prime figure legate alla produzione di farinata non ci siano
sassaresi.
Nella loro opera Storia popolare della città di Sassari Franco Enna
e Pino Pomata (2008: 16) hanno proposto una datazione per
l’introduzione della fainé a Sassari all’immediato dopoguerra,
basandosi su ricordi personali propri e su quelli dei loro amici
(Enna – Pomata 2009). Una lettera, pubblicata su La Nuova
Sardegna a firma di Antonio Luiu (2009), ha segnalato
l’inesattezza dell’informazione, retrodatando la diffusione della
fainé a Sassari almeno alla fine dell’Ottocento.9
L’esame delle fonti orali al momento disponibili permette di
concordare con la tesi di Luiu ma non di identificare con certezza
né quale fu il primo forno inaugurato né chi ne fu l’artefice. Chi
ha vissuto gli anni a cavallo tra le due guerre ha, infatti, dato
versioni cronologicamente contrastanti sui protagonisti
dell’arrivo della fainé.
Due forni si contendono il primato: il primo è ancora attivo ed
è situato in via Usai; il secondo, ormai chiuso da tempo, si
trovava in una traversa di via Luzzati. Entrambi si collocano
nella parte alta del rione storico, in prossimità del centro
cittadino (v. fig.1).
Per quanto riguarda il forno di via Usai non c’è accordo sui
Luiu argomenta così la sua proposta di datazione: “La presenza a Sassari
della fainé va, però, oltre il ricordo delle persone che oggi frequentano ancora
questo mondo, perché è attestata proprio con l’indicazione del grido di
richiamo dei venditori, in una pubblicazione del 1899 nella quale Ignazio
Longiave riporta appunto i ‘gridi’ con i quali i venditori ambulanti e quelli
operanti nel mercato civico in quegli ultimi anni del XIX secolo invitavano
all’acquisto dei loro prodotti”. Tra i testi dell’autore, conservati nella
Biblioteca Universitaria di Sassari, non c’è però alcun riferimento
all’informazione.
9
42
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
primi proprietari. Stando a quanto sostenuto da una nipote
(Moirano Ottonello Griva 2005), fu Emanuele Ottonello ad aprire
la rivendita. Questa sarebbe poi stata ereditata dai figli: “dopo la
seconda guerra mondiale i miei zii, Mario e Gerolamo (‘Gerumin’
per gli intimi), proseguirono l’attività fino ai primi anni Sessanta
per poi venderla” (ivi). L’acquirente fu la famiglia Sassu, che
rinnovò il locale ed installò l’insegna ancora presente nella via.
La famiglia Marongiu, imparentata con i Sassu, è l’attuale
proprietaria dell’attività.
Tino Grindi10 invece attribuisce l’apertura dell’attività ad un
certo Baciccia:
La fainé, antica pietanza tradizionale genovese e carlofortina, agli inizi
del secolo scorso, per iniziativa di un imprenditore genovese, di cui
ricordo il soprannome ‘Baciccia’, approdò a Sassari in un antico
magazzino di via Usai» (Grindi 2005).
Sostiene la tesi del forno di via Luzzati Carlo Pira: il ristoratore,
intervistato sull’argomento, riporta però informazioni di seconda mano
apprese dal fratello Valentino e da non meglio precisati articoli di
giornale:
La fainé a Sassari, come mi ha detto mio fratello e qualche volta che ho
sentito, ho letto qualche pezzo di giornale, molti molti anni fa… la fainé
è stata portata da Genova, dai genovesi ed era nata in un vicolo chiuso
in via Luzzati che adesso c’è un negozio di vernici lì.11
Al di là del disaccordo tra le fonti, trattandosi principalmente
di ricordi personali, si va definendo un processo di inserimento
della fainé a Sassari non ad opera di un singolo pioniere ma per
Gli interventi qui riassunti si riferiscono ad un acceso dibattito sull’origine
della fainé, sviluppatosi tra alcuni intellettuali locali sulle pagine del
principale quotidiano sassarese, La Nuova Sardegna.
11 Intervista a Carlo Pira (8.06.2010).
10
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
43
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
44
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
azione di più soggetti accomunati dalla stessa provenienza, la
‘famiglia di genovesi’ a cui fanno riferimento Enna e Pomata
(2008: 217). È probabile che l’interesse per il nuovo alimento
dimostrato dai sassaresi abbia attirato verso la città l’attenzione
di ristoratori genovesi, spesso improvvisati e alla ricerca di
soluzioni per sbarcare il lunario. Emblematica a riguardo è la
figura di Ambrogino Pelle: “D’estate Ambrogino vendeva gelati,
ma d’inverno rischiava la fame, perciò si inventò questa
soluzione, che fece la sua fortuna” (ibid: 216).
Accanto ai genovesi anche persone di altra provenienza
iniziano ad interessarsi alla fainé, a dimostrazione di come la
vendita di fainé fosse diventata una reale opportunità
commerciale. I fratelli Pira di Dorgali arrivarono a Sassari in
tempi diversi: il primo a giungere in città e ad avvicinarsi al
settore della ristorazione fu Valentino:
Un mio zio se l’aveva portato e aveva iniziato a lavorare come
cameriere in uno di questi grossi bar in piazza d’Italia ai portici. Lì poi
lui ha conosciuto un certo Terzo Proietti, un continentale, e ha imparato
a fare la fainé. Non so di dov’era questo. 12
Valentino, nella descrizione che ne fornisce il fratello, appare
come un uomo molto intraprendente e disposto anche a tentare
imprese commerciali pionieristiche: una volta appresa la ricetta
della fainé ha provato a produrla anche in altri comuni, alla
ricerca di mercati ancora privi di concorrenza come Carbonia o
La Maddalena. L’insuccesso di questi tentativi lo ha riportato a
Sassari nel secondo dopoguerra, dove è stato raggiunto dagli
altri fratelli e dove ha aperto un altro forno di fronte a quello
storico di via Usai. Il secondo forno è rimasto sino al 1987,
12
Intervista a Carlo Pira (8.06.2010).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
45
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
quando Carlo Pira ha venduto ai Marongiu per trasferirsi in
un’altra zona lontano dal centro storico. I Marongiu hanno
tenuto aperta l’attività trasformandola però in un ristorante
pizzeria.
Gli anni Cinquanta e Sessanta sono gli anni della definitiva
affermazione della fainé, con l’apertura di numerose rivendite in
tutto il centro storico sassarese (v. fig.1). Accanto ai forni storici,
con tavolate che permettevano agli avventori di consumare la
fainé direttamente all’interno del locale, molti nuovi esercizi
scelgono la formula della sola vendita. Si innesca così una
dinamica che permetterà alla fainé di legarsi ad un altro settore
della ristorazione in ascesa, quello delle pizzerie da asporto e
delle consegne a domicilio, che le permetterà di espandersi
parallelamente allo sviluppo urbanistico di Sassari in tutti i nuovi
quartieri residenziali di più recente costruzione. Ai giorni nostri
la quasi totalità delle pizzerie da asporto offre, tra i prodotti a
disposizione del cliente, anche fainé di varie dimensioni e con
vari condimenti. Il prodotto risulta, almeno a detta di un
intervistato, più scadente:
Praticamente oggi dove c’è pizzeria c’è fainé… uno si alza la mattina e
dice “Oggi mi apro una pizzeria” e l’altro “Oggi mi apro la fainé”,
perché danno questi contributi facilmente… poi cosa fanno… si
mettono i soldi in tasca, non pagano né fornitori né nessuno e se ne
vanno così… la fainé non lo so come la fanno. 13
Un elemento rimasto costante ancora oggi è la stagionalità della
produzione. La fainé è un prodotto sostanzialmente invernale e
le rivendite di fainé aprivano solo durante quel periodo:
Gli Ottonello vivevano a Genova e si trasferivano qua il periodo della
13
Intervista a Carlo Pira (8.06.2010).
46
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
fainé, da novembre fino a febbraio, facevano due o tre mesi l’anno. Il
resto dell’anno rimaneva chiuso. 14
Altri commercianti diversificarono la loro offerta rimanendo
aperti nella restante parte dell’anno come gelateria. Oltre al già
citato Ambrogino Pelle, anche Carlo Pira affiancava le due
attività per rimanere attivo anche nei periodi in cui il forno
rimaneva chiuso.
La fainé tra case, strade e ristoranti
Pur con le medesime origini liguri, alle tipologie della farinata
sono associate modalità di preparazione e di consumo differenti.
Nelle varie località in cui è presente, la farinata è andata incontro
ad un processo di adattamento ai gusti dei soggetti che la
consumano, innescando un mutamento sia nella dimensione
spaziale che temporale. Anche gli ingredienti base possono
variare per venire incontro alle preferenze dei consumatori: a
Savona esiste una variante, denominata farinata bianca, che è in
tutto simile alla classica ma impiega farina di frumento al posto
di quella canonica di ceci, dandole il colorito più chiaro da cui
deriva il nome.15
Per quanto riguarda il contesto sassarese le modalità di
preparazione variano da ristoratore a ristoratore. I produttori
attivi hanno appreso come miscelare gli ingredienti attraverso
due distinte forme di trasmissione che presuppongono un
diverso rapporto tra ‘maestro’ e ‘allievo’.
La prima si attua mediante cessione di una ricetta già
pienamente codificata, in cui le quantità relative ad ogni
Intervista a Mario Marongiu (22.05.2010).
Consultato il 03.05.2012 su <http://www.buttalapasta.it/articolo/cucinaligure-la-farinata-bianca-o-farinata-di-grano/20701/> .
14
15
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
47
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
ingrediente sono fisse e stabilite dal maestro; in questa forma può
non esserci alcuna fase di apprendistato: l’allievo può iniziare la
produzione immediatamente dopo l’acquisto della ricetta.
Loro ci hanno dato la loro ricetta… loro quando hanno venduto a noi ci
hanno dato il locale e la ricetta, con il personale che c’era allora… dopo,
pian piano, abbiamo cambiato.16
La seconda invece presenta necessariamente una fase di
formazione: il forno diventa una bottega e l’apprendista, in una
dinamica del tutto simile ad ogni bottega artigiana, acquisisce le
tecniche osservando e riproducendo il lavoro del maestro
(Angioni 1986):
non peso sale né farina né misuro acqua. Una volta che ho imparato io
col mestolo controllo se andava bene o andava male. Se c’usciva la
mano dell’acqua allora bisognava aggiungere farina, però togliere
acqua non puoi. Se molto denso piano piano aggiungi farina, regoli,
stando attenti perché se troppo denso non viene bene, se troppo liquida
non lega, quindi bisogna regolarsi. 17
Un’altra caratteristica che presenta una notevole variabilità è
la farcitura, aggiunta all’impasto base appena prima di essere
infornato. A Genova è molto frequentemente condita con i
cipollotti, con i bianchetti18 o con il rosmarino. A seconda del
gusto del consumatore si può inoltre spolverare la farinata con il
pepe, che spesso viene fornito dallo stesso ristoratore.
A Sassari l’introduzione dei condimenti sembra essere recente:
Intervista a Mario Marongiu (22.05.2010).
Intervista a Carlo Pira (8.06.2010).
18 Bianchetti è il nome dialettale con cui vengono chiamati in Liguria gli
avannotti di pesce azzurro.
16
17
48
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Prima la fainé era solo normale, al massimo con cipolle… i condimenti
sono recenti.19
L’innovazione si è affermata con un tale successo che, accanto
alla fainé semplice, tutti i produttori accostano anche quella
condita. Le aggiunte più comuni sono le cipolle e la salsiccia, ma
si possono trovare anche con acciughe, pancetta, funghi, carciofi,
peperoni o zucchine. Uno dei ristoranti storici ancora attivi a
Sassari propone una fainé ‘alla Benito’, dal nome del fondatore
dell’attività, farcita con molti degli ingredienti elencati.
In alcune località la produzione di farinata è legata a quella di
altri alimenti. A Carloforte la si trova nei tascelli, attività
specializzate nella vendita di pizza al taglio. In Uruguay il
consumo è associato a quello della pizza: tradizionalmente la si
mangia a caballo, “distesa su una fetta di pizza con la mozzarella
fumante” (Manzitti 2008: 11). A Livorno è, invece, prodotta dai
tortai insieme alla focaccia:
Il modo tradizionale di mangiarla è il “cinque e cinque“, come si chiama
qui da noi: in questo caso la sottile torta di ceci viene messa calda
dentro una focaccia morbida. Il nome deriva dal fatto che parecchi anni
fa il suo costo era di cinquanta centesimi per la focaccia e cinquanta per
la torta di ceci.20
Queste modalità di consumo classificano la farinata come
street food a tutti gli effetti (Guigoni 1994). La fetta acquistata
veniva incartata per poi essere mangiata, per l’appunto, in
strada, creando quindi una netta separazione tra il luogo di
produzione e il luogo di degustazione. A Sassari la realtà appare
Intervista a Mario Marongiu (22.05.2010).
Consultato il 03.05.2012 su <http://www.gingerandtomato.com/itinerarigastronomici/cecina-farinata-torta-di-ceci-cinque-e-cinque-molti-nomi-peruna-sola-specialita/>.
19
20
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
49
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
molto più sfaccettata. Durante il secolo di storia documentata
della fainé si possono individuare almeno tre distinte pratiche
legate all’alimento, collegate ad altrettante tipologie di
ristorazione, come indicato nella tabella seguente:
PRATICA DI CONSUMO
TIPOLOGIA DI RISTORAZIONE
acquisto e consumo all’interno
dell’esercizio
→
ristorante attrezzato con tavole e panche
acquisto nell’esercizio e consumo in altri
luoghi, perlopiù abitazioni
→
forno da asporto, con o senza servizio di
consegna a domicilio
acquisto e consumo in strada
→
venditore ambulante
È da notare il fatto che la fainé non è mai stata, perlomeno a
Sassari, un cibo di produzione casalinga: la produzione di questo
alimento è sempre stata prerogativa esclusiva dei professionisti
della ristorazione. In rete è facile trovare siti che spiegano
chiaramente la ricetta ed è lecito pensare che qualcuno abbia
provato a realizzarla autonomamente, ma si tratta di casi del
tutto marginali.
Se la prima modalità indicata è legata ai ristoranti storici
ancora attivi, la seconda, pur
essendo oggi associata
prevalentemente al consumo domestico, ha permesso in passato
forme di consumo differenti, molto simili a quelle tradizionali
livornesi:
Alle 6 del mattino stavo già cucinando la fainé in via Mercato… allora
c’era, e l’hanno chiuso da poco, un panificio in via Rosello… allora c’era
il bar Campari aperto al macello che era un ritrovo la mattina di quelli
che andavano a strillare in giro, vendevano i giornali in giro. Alle 5.30 /
6 lì si trovavano gli spazzini, che allora passavano casa per casa a
ritirare la spazzatura, tutti gli operai del mercato, che arrivavano i
mezzi a scaricare la frutta e la verdura… cosa facevano… andavano al
panificio e si compravano una focaccia calda calda, venivano da me e
50
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
mi dicevano “Valentì, mettimi due fette d’affainé!” e così mangiavano. 21
Solo l’ultima delle tre tipologie permette di associare
inequivocabilmente la fainé agli altri cibi da strada. L’ambulante
ha rappresentato per lungo tempo una comune modalità di
accesso alla fainé, percorrendo le strade cittadine alla guida di
«carretti trasportatori a pedali, simili a quelli americani dei gelati;
solo che al posto del congelatore c’era un fornello con la brace
sempre accesa, che teneva calde le fette di fainé» (Enna – Pomata
2008: 217). Alle grida di questi personaggi si devono anche molti
dei nomi con cui la farinata è nota: Calentita, Belecauda,
Abbrusgenti22 sono i richiami con cui gli ambulanti attiravano i
potenziali clienti. In genere si riforniva dai ristoranti,
acquistando ad un prezzo ridotto l’alimento già pronto:
per esempio venivi tu che avevi la licenza di ambulante, avevi il
carrettino a tre ruote col fuoco sotto e la teglia sopra… io per esempio ti
davo 10 chili d’affainé… se io per esempio la vendevo a 100 lire a te
perché me la prendevi così te la davo a 60 lire, 50 lire anche, poi quello
che ricavava era a lui. Gli davo la fainé già fatta. Loro mettevano le
teglie una sopra l’altra, anche dieci teglie una sopra l’altra. 23
Il prodotto era di qualità inferiore rispetto a quello
acquistabile nei ristoranti e questo aveva conseguenze
soprattutto sul prezzo di vendita, ma l’ambulante sopperiva a
questo fornendo il servizio di consegna a domicilio che, almeno
inizialmente, i forni storici non prevedevano. La concorrenza
rappresentata dalla vendita di fainé nelle pizzerie da asporto ha
finito per causare la crisi di questa forma di commercio, ormai
del tutto scomparsa. Il ruolo degli ambulanti è stato comunque
Intervista a Carlo Pira (8.06.2010).
Abbrusgenti è un altro nome con cui è conosciuta la farinata a Sassari.
23 Intervista a Carlo Pira (8.06.2010).
21
22
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
51
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
fondamentale per due motivi: da una parte hanno fatto conoscere
il piatto anche tra quegli strati della popolazione che non
potevano permettersi la frequentazione dei ristoranti; dall’altra
hanno anticipato di qualche decennio quella che è la modalità di
consumo più diffusa ai giorni nostri, quella a domicilio.
Si può sostenere quindi che, almeno a Sassari, la farinata ha
abbandonato la connotazione di street food che ne aveva favorito
l’affermazione, diventando un cibo da mangiare seduti ad un
tavolo di casa o di ristorante.
La fainé come cultura
La riduzione delle forme di consumo ha proceduto di pari
passo all’incremento della rilevanza con cui la popolazione
sassarese ha percepito l’alimento. Questa dinamica potrebbe
apparire paradossale: più le modalità tradizionali lasciavano
spazio a quelle oggi dominanti, più la fainé faceva proprio quel
marcatore identitario cui accennavo in apertura. In realtà questo
processo non ha nulla di paradossale ma è anzi perfettamente
coerente con le dinamiche della globalizzazione presentate
inizialmente:
Il mcdonaldismo non ha solamente prodotto l’unificazione del gusto in
tutto il mondo, ma ha anche riacceso i sentimenti di un moderno
regionalismo. Bisogna accettare il fatto che la crescita della cultura
regionalistica (e non solamente nel cosiddetto mondo occidentale) si è
realizzata in quanto contropartita della unificazione (Köstlin 2008: 172).
Le leggende sulla farinata citate in precedenza sono
un’applicazione in ambito locale di un processo molto più
generale: è ampiamente documentata in letteratura la tendenza a
rivestire di un velo di arcaicità anche alcuni tratti culturali privi
52
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
di alcun radicamento nel passato (Clemente – Mugnaini 2008;
Trevor-Roper 1983). In questo senso il fatto che i racconti
possano essere spuri e nati in epoca contemporanea non fa che
rafforzare quanto detto. L’alimentazione, infatti, in quanto carica
“di significati culturali, sociali e simbolici” (Guigoni 2009: 13), fa
proprie le stesse dinamiche e va incontro agli stessi processi cui
sottostà qualsiasi altro aspetto della cultura umana, di cui essa è
componente fondamentale, diventando “snodo centrale nella
costruzione dell’identità, sia individuale, sia di gruppo, etnica”
(Guigoni 2006).
Questo processo autopoietico ingenera forme identitarie
esternate (Fabietti 1998: 139) e performativamente costruite
(Bromberger 1993), risultato di “strategie attivamente articolate”
(Malighetti 2007: 8), attraverso le quali un gruppo si rappresenta
e si percepisce. L’identità performativa si manifesta, quindi,
come un processo di auto-percezione selettiva, consapevole e
dinamica che un gruppo ha di sé stesso: è ‘selettiva’ perché non
tutte le pratiche culturali sono considerabili ‘identitarie’; è
‘consapevole’ perché il gruppo sceglie in maniera chiara i tratti
culturali attraverso i quali intende descriversi; è infine ‘dinamica’
perché, analizzato in una dimensione diacronica, il carattere
‘identitario’ risulta storicamente determinato e presenta un
continuo mutamento che lo rende perennemente in evoluzione.
L’antropologia contemporanea ha analizzato in maniera
puntuale l’impiego strumentale che di questo carattere fanno
alcuni movimenti politici (Aime 1999; Biorcio 1997; Bowen 2005),
arrivando però alla conclusione che “il fatto che alcuni individui
affermino di appartenere a un certo gruppo è un dato di fatto che
nessuna operazione di decostruzione dell'etnia, per quanto
giustificata scientificamente, può eludere” (Fabietti 1998: 134).
Se questo “dato di fatto” si rende drammaticamente evidente
quando diventa giustificazione per guerre e genocidi (Hayden
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
53
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
2005; Remotti 1996, 2010) lo rimane anche in circostanze non
conflittuali. È questo il caso della fainé. Gli interventi di
intellettuali locali sulla questione della tutela (Grindi 2005) o
l’inserimento dell’alimento all’interno delle iniziative turisticogastronomiche proposte dal Comune di Sassari24 sono conferma
del fatto che “l’appartenenza e l’identità non sono scolpite nelle
roccia, non sono assicurate da una garanzia a vita, che sono in
larga misura negoziabili e revocabili” (Baumann 2003: 6) e indici
di una ormai avvenuta “appropriazione culturale adattativa”
(Breidenbach – Zukrigl 2000: 167; Tomlinson 2001: 105).
Pur senza avere alle spalle un forte potere politico, economico
o mediatico, come è avvenuto per altre pratiche ‘indigenizzate’,
ampiamente analizzate nella letteratura antropologica, quali il
cricket in India (Appadurai 2001), Halloween (Bonato 2006), il
Natale (Breidenbach – Zukrigl 2000: 166) o il consumo di Coca
Cola (Howes 1996), la farinata è andata incontro ad un processo
di de/riterritorializzazione: da localmente determinata come
genovese, è divenuta globale per divenire, in una fase successiva,
la fainé sassarese ed entrare nel novero dei prodotti alimentari
‘tipici’. Una forma di globalizzazione ‘dal basso’, resa possibile
dalla sua peculiare diffusione, sempre al seguito di persone e non
attraverso strategie commerciali o battage pubblicitario, che ha
permesso alla fainé di affermarsi non in antitesi ma in armonia
con quanto elaborato autonomamente dalla società sassarese,
sino a diventare intimamente connessa con essa.
Consultato il 03.05.2012 su <http://www.taribari.org/taribari/wpcontent/uploads/2007/12/faine.pdf>.
24
54
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Bibliografia
AIME M.
1999
“Identità etniche o politiche?”, in J.L. Amselle, Logiche meticcie.
Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Torino, Bollati Boringhieri,
pp. 7-28.
AMSELLE J.L.
1999
Logiche meticcie. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Torino,
Bollati Boringhieri (ed. or. 1990, Logiques métisses. Anthropologie de
l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot & Rivages).
ANGIONI G.
1986
Il sapere della mano, Palermo, Sellerio.
APPADURAI A.
2001
Modernità in polvere, Roma, Meltemi (ed. or. 1996, Modernity at Large.
Cultural Dimension of Globalization, Minneapolis – London, University
of Minnesota).
ARCHER E.G.
2006
Gibraltar, Identity and Empire, New York, Routledge.
BAUMANN Z.
2003
Intervista sull’identità, Bari, Laterza.
BIORCIO R.
1997
La Padania promessa. La storia, e idee e la logica d’azione della Lega Nord,
Milano, Il Saggiatore.
BOISSEVAIN J. (a cura di)
1992
Revitalising European Rituals, London, Routledhe.
BONATO L.
2006
Tutti in festa. Antropologia della cerimonialità, Milano, Franco Angeli.
BOURDIEU P.
2010
La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1979,
La distinction, Paris, Les éditions de minuit).
BOWEN J.R.
2005
“Il mito del conflitto etnico globale”, in Antropologia della violenza, a cura
di F. Dei, Roma, Meltemi (ed. or. 1996, “The myth of global ethnic
conflict”, in Journal of Democracy, 7 (4)).
BRAUDEL F.
1982
Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi (ed.
or. 1949, Le Méditerranée et le monde mediterrnéen à l’époque de Philippe II,
Paris, Armand Colin).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
55
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
BREIDENBACH J. – ZUKRIGL I.
2000
Danza delle culture. L’identità culturale in un mondo globalizzato, Torino,
Bollati Boringhieri (ed. or. 1998, Tanz der Kulturen. Kulturelle Identität
in einer Globalisierten Welt, München, Kunstmann).
BROMBERGER C.
1993
“L’ethnologie de la France et le problème de l’identité”, in Civilisation, 42
(2), pp. 45-63.
CAMPBELL N. – DAVIES J. – MCKAY G. (a cura di)
2004
Issues in Americanisation and Culture, Edinburgh, Edinburgh University
press.
CLEMENTE P. – MUGNAINI F. (a cura di)
2008
Oltre il folklore, Roma, Carocci.
ENNA F. – POMATA P.
2008
Storia popolare della città di Sassari (e dintorni), Genova, Fratelli Frilli
Editori.
2009
“A proposito di fainé, il riferimento nel libro riguarda soprattutto la rinascita
in città”, in La Nuova Sardegna, 26 marzo 2009, p. 31.
FABIETTI U.
1998
L’identità etnica, Roma, Carocci.
FEATHERSTONE M.
2007
Consumer Culture and Postmodernism, London, Sage.
GIDDENS A.
1994
Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo,
Bologna, Il Mulino (ed. or. 1990, The Consequences of Modernity.
Cambridge, Polity).
GRINDI T.
2005
“Necessario il marchio doc per la vera fainé sassarese”, in La Nuova
Sardegna, 23 novembre 2005, p. 24.
GUARNASCHELLI GOTTI (a cura di)
1990
Grande enciclopedia illustrate della gastronomia, Milano, Selezione del
Reader’s Digest.
GUIGONI A.
2004
“La cucina di strada. Con una breve etnografia dello street food genovese”, in
Mneme. Revista Virtual de Humanidades, 9 (3), consultato il 20/12/2011
su
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view
/178/168.
2006
“L'alimentazione mediterranea tra locale e globale, tra passato e presente”, in
56
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Saperi e Sapori del Mediterraneo, a cura di A. Guigoni – R. Ben Amara,
Cagliari, AM&D, pp. 81-92.
2009
Antropologia del mangiare e del bere, Torrazza Coste (PV), Edizioni
Altravista.
GUIGONI A. (a cura di)
2004
Foodscapes. Stili, mode e culture del cibo oggi, Monza (MI), Polimetrica.
HANNERZ U.
1987
“The World in Creolization”, in Africa. Journal of the International African
Institute, 57 (4), pp. 546-559.
2001
La diversità culturale, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1996, Transnational
Connections. Culture, People, Places, London – New York, Routledge).
HAYDEN R.M.
2005
“Comunità immaginate e vittime reali: autodeterminazione e pulizia etnica
in Iugoslavia”, in Antropologia della violenza, a cura di F. Dei, Roma,
Meltemi (ed. or. 1996, “Imagined Communities and Real Victims; Selfdetermination and Ethnic Cleansing in Yugoslavia”, in American
Ethnologist, 23 (4)).
HOBSBAWM E. – RANGER T. (a cura di)
2002
L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi (ed. or. 1983, The Invention
of Tradition, Cambridge), Cambridge University press).
KÖSTLIN K.
2008
“Prospettive per un’etnologia europea”, in Oltre il folklore, a cura di P.
Clemente e F. Mugnaini
LEWELLEN T.C.
2002
The Anthropology of Globalization. Cultural Anthropology Enters the 21 st
Century, Westport – London, Bergin & Garvey.
LUIU A.
2009
“La fainé arrivò in città alla fine del 1800”, in La Nuova Sardegna, 14
marzo 2009, p. 28.
LUPTON D.
1996
Food, the Body and the Self, London, Sage.
MALIGHETTI R.
2005
“Politiche identitarie e lavoro sul campo”, in Politiche dell’identità, a cura di
R. Malighetti, Roma, Meltemi.
MANZITTI F.
2008
“Storia e tradizioni della fainà”, in La gente d’Italia, IX, 7 agosto 2008.
MARTELL L.
2011
Sociologia della globalizzazione, Torino, Einaudi (ed. or. 2010, The
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
57
Pisano A., La farinata diventa fainé. Un esempio di indigenizzazione
Sociology of Globalization, Cambridge, Polity press).
MOIRANO OTTONELLO GRIVA L.
2005
“Fu Emanuele Ottonello a far conoscere la fainé”, in La Nuova Sardegna, 29
novembre 2005, p. 26.
MONTANARI M.
2006
Il cibo come cultura, Roma-Bari, Laterza.
NEDERVEN PIETERSE J.
2009
Globalization and Culture. Global Mélange, Boulder, Rowman and
Littlefield.
REMOTTI F.
1996
Contro l’identità, Roma – Bari, Laterza.
2010
L’ossessione identitaria, Roma – Bari, Laterza.
ROBERTSON R.
1999
Globalizzazione, teoria sociale e cultura globale, Trieste, Asterios (ed. or.
1992, Globalization: social theory and global culture, Thousand Oaks,
Sage).
SAHLINS M.
1993
“Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World
History”, in The Journal of Modern History, 65 (1), pp. 1-25.
SCHILLER H.
1992
Mass Communications and American Empire, Boulder, Westview Press
(ed. or. 1969).
SECONDULFO D.
1993
“Dimmi come mangi e ti dirò con chi sei. Cibi, luoghi e relazioni nel menù
del sociologo”, in Foodscapes. Stili, mode e culture del cibo oggi, a cura di A.
Guigoni, pp. 49-67.
TIRAGALLO F.
2008
“Da oltremare. La storia della colonizzazione come forma di identità a
Carloforte”, in Cooperazione mediterranea, 6, pp.171-181.
TOMLINSON J.
2001
Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene globale, Milano, Feltrinelli
(ed. or. 1999, Globalization and Culture, Cambridge, Polity press).
TREVOR-ROPER H.
2002
“L’invenzione della tradizione: la tradizione delle Highlands in Scozia”, in
L’invenzione della tradizione, a cura di E.J. Hobsbawm – T. Ranger,
Torino, Einaudi, pp. 19-44 (ed. or. 1983, “The Invention of Tradition: the
Highland Tradition of Scotland”, in The Invention of Tradition,
Cambridge, Cambridge University press, pp. 16-42).
58
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
Manuela Casu
Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso
l’educazione interculturale bilingue*
Abstract
This article demonstrates the intimate relationality that exists between bilingualintercultural education and the revindicating socio-political processes of Indigneous
peoples in the Peruvian amazon. A description of FORMABIAPs core curriculum
allows us to observe and examine the path of self-representation/determination
undertaken by students and future teachers of bilingual-intercultural education. The
final analysis of this educative process makes clear that interculturality is interpreted
in different ways depending on the referential positioning of people/s that engage with
it.
Key words
Educazione
interculturale
bilingue,
Formabiap,
autorappresentazione indigena, oralità e scrittura.
Amazzonia
peruviana,
L’esperienza di FORMABIAP
Formabiap (Programa de Formación de Maestros Bilingües de la
Amazonía Peruana) nasce nel 1988 in una congiuntura temporale
favorevole che vede da un lato la crescita della partecipazione
politico sociale da parte della popolazione indigena e dall’altro
l’interesse della cooperazione internazionale per il tema
dell’interculturalità e dell’educazione bilingue. Il Programma,
Il presente articolo è stato prodotto durante la frequenza del corso di
dottorato in Studi filologici e letterari dell’Università degli Studi di Cagliari, a.a.
2011/2012 - XXVI ciclo, con il supporto di una borsa di studio finanziata con le
risorse del P.O.R. SARDEGNA F.S.E. 2007-2013.
*
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
59
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
frutto dell’accordo tra l’ISPP( Instituto Superior Público Pedagógico)
di Loreto e AIDESEP (Asociación Interétnica de desarrollo de la selva
peruana), fu elaborato in primo luogo con lo scopo di soddisfare
le necessità educative di una regione plurilingue e multiculturale
come quella amazzonica.1
È necessario infatti tenere conto che all’epoca erano
fondamentalmente due le istituzioni che si occupavano della
formazione di maestri in educazione interculturale bilingue:
l’ILV (Instituto Lingüístico de Verano) con sede a Yarinococha e la
Escuela Bilingüe dell’UNAP (Universidad Nacional de La Amazonía
Peruana) (Trapnell-Calderón-Flores 2008: 35). Formabiap si
occupa della formazione docente iniziale, rivolta ai ragazzi che
hanno terminato la scuola secondaria e intraprendono la
formazione per diventare maestri interculturali bilingui e della
formazione docente continua, che consiste nel monitoraggio del
lavoro dei maestri già formati che lavorano nelle comunità. I
ragazzi che accedono a Formabiap sono membri di comunità
appartenenti alle 65 Federazioni indigene riconosciute da
AIDESEP2 e situate nell’intera area amazzonica peruviana; per
questa stessa ragione gli alunni a seconda dell’area geografica di
provenienza presentano situazioni linguistico culturali e
esperienze scolastiche differenti.
L’obiettivo di Formabiap è offrire una proposta educativa
culturalmente pertinente nel rispetto della cultura e dei valori
indigeni e per questa ragione fin dagli inizi furono contrattati
degli specialisti indigeni, conoscitori della cultura e della lingua
del popolo a cui appartenevano, in modo da favorire
l’introduzione del sapere e della lingua indigeni all’interno
Si stima che nell’Amazzonia peruviana il numero di lingue indigene parlate
siano 39 (Sichra 2009 :317).
2 Consultato il 15/04/2012 su http://www.aidesep.org.pe/
1
60
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
dell’aula e permettere agli studenti di ampliare il proprio
universo cognitivo (Gasché 2002). Dunque l’approccio
interculturale e rispettoso della diversità viene garantito anche
dalla natura multidisciplinare del corpo docente di cui sono parte
integrante gli specialisti indigeni (Trapnell 1990, 2008).
L’intenso lavoro di ricerca ha permesso anche l’elaborazione
di un curriculum alternativo per la scuola primaria3 atto a
favorire un cambiamento decisivo nel tipo di educazione imposta
ai bambini di etnia indigena e permettere allo stesso tempo ai
maestri formati da Formabiap di poter applicare la metodologia
interculturale appresa nella scuola. Uno degli aspetti più
problematici oltre all’introduzione dei contenuti culturali
autoctoni è stata la sistematizzazione e l’adattamento degli stessi,
alla struttura curricolare che riflette un’impostazione del sapere
di tipo occidentale. Ci basti pensare al rapporto tra uomo e
natura nelle culture autoctone e come questo non corrisponda
affatto alla visione ‘occidentale’ che è alla base dei curricula
scolastici. La concezione dell’uomo come essere privilegiato e
separato dalla natura e dagli animali, che gli studenti
apprendono a scuola, è esattamente opposta al modello culturale
proprio della loro cultura in cui ″Los humanos y los no humanos
(plantas, animales, tierra, etc.) estaban relacionados entre sí en un
universo moral compartido″ (Bowers 2002: 51). Alla visione
occidentale di una natura che deve essere dominata e sfruttata
come risorsa produttiva (Ibidem) si contrappone ″una visión de
«sociedad» que trasciende las relaciones entre humanos e
incorpora a diversos «seres» y «fuerzas» de la naturaleza con los
cuales se establecen relaciones de cooperación e intercambio″
(Trapnell 1996:7) propria delle culture indigene amazzoniche.
Programa Curricular Diversificado elaborato da Formabiap agli inizi degli
anni 90.
3
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
61
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
A causa di un sistema educativo che segue modalità impostate
secondo il pensiero scientifico occidentale, lo studente indigeno
riceve una serie di messaggi e nozioni che non corrispondono
alla propria visione del mondo e all’ambiente che lo circonda. Ne
deriva dunque anche una diversa concezione dell’uomo che
influenza la crescita dei bambini come individui. Il maestro in
questo contesto gioca un ruolo importantissimo come conoscitore
della realtà in cui va a insegnare e come mediatore tra ciò che
impone il Ministero e le esigenze degli studenti. È anche
possibile che nel processo di rielaborazione e riadattamento del
curriculum debba discostarsi dal contenuto dei libri, come
testimonia una ricerca condotta sul lavoro svolto da due
insegnanti formati all’interno del Formabiap.
[…] las trabas que encontraron los maestros al tratar de darle un
enfoque intercultural a los contenidos planteados en el currículo, en la
medida que éstos formaban parte de una matriz organizada a partir de
categorías hegemónicas, que condicionan la manera de aproximarse al
estudio de la realidad. En algunas oportunidades el maestro tuvo que
dejar de lado el PCD (Programa Curricular Diversificado) para trabajar
desde las visiones y aproximaciones de su pueblo y ésto lo hizo
consciente de lo limitada que resulta la estrategia de incluir contenidos
indígenas dentro de una matriz organizada desde categorías
ocidentales (Trapnell, Calderón, Flores 2008: 77).
Il maestro quindi avrà il compito di adattare il curriculum a
seconda del patrimonio linguistico-culturale dei propri studenti
non solo a livello contenutistico ma anche nella struttura, in
modo tale da favorire l’applicazione di un’educazione realmente
interculturale. Il curriculum infatti non è da intendersi come un
prodotto finito ma come una base che lo stesso maestro di EIB
dovrà costruire nella pratica pedagogica insieme agli studenti e
agli altri membri della comunità (Trapnell 1996).
62
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
In altri termini più l’educazione è coerente e pertinente con la
realtà in cui vive il bambino più semplice e lineare sarà lo
sviluppo cognitivo. Purtroppo la maggioranza degli studenti
indigeni si ritrova ad affrontare due realtà completamente
diverse se non spesso contrapposte: l’ambiente familiare e il
contesto scolastico. Il difetto di fondo dell’educazione è la
scissione netta che si verifica tra i contenuti appresi a scuola e la
realtà sociale in cui gli studenti vivono. I risultati sconfortanti
della ECE (Evaluación Censal Escolar) effettuata nel 2011 dal
Ministero dell’Educazione e che ha riguardato gli alunni del 2˚ e
del 4˚ anno della scuola primaria nelle aree di matematica e
comprensione del testo4 sono la prova evidente di un sistema
educativo che non funziona in maniera efficiente soprattutto in
determinate zone del paese. La valutazione ha rivelato lo scarso
livello raggiunto dagli studenti nell’area amazzonica: la regione
di Loreto infatti occupa l’ultima posizione della graduatoria
nazionale.
Secondo un’ottica interculturale il sapere indigeno non deve
essere solo il punto di partenza per l’insegnamento ma dovrà
essere parte integrante del processo educativo in modo tale da
permettere la costruzione di un curriculum che rifletta e rispetti
la visione del mondo degli studenti indigeni. L’educazione
scolastica dovrà dunque mirare contemporaneamente a due
obiettivi: la valorizzazione e il recupero del sapere e dei valori
indigeni e l’acquisizione del sapere e delle tecniche occidentali
(Gasché 1997).
L’interculturalità non dev’essere intesa come una somma di
Patricia Salas O’Brien, Ministra de Educación, Resultados de la Evaluación
Censal
de
Estudiantes
2012
consultato
il
04/05/2012
su
http://www.scribd.com/cochepi/d/87672631-Conferencia-de-PrensaMinistra-ECE-2012.
4
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
63
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
contenuti indigeni e occidentali senza nessuna attenzione alle
due differenti visioni del mondo che rispecchiano: questo
atteggiamento, derivante dalla tendenza nazionale a subordinare
il sapere indigeno e relegarlo a un passato mitico e statico, da
una parte comporta il rafforzamento della dicotomia
tradizione/modernità e dall’altra ripropone la costante
gerarchizzazione del sapere. Nella maggioranza dei casi
l’interculturalità applicata dalle politiche educative ufficiali ha
orientato il dialogo tra le culture verso un’unica direzione ossia
l’inclusione del sapere indigeno nella cultura ufficiale senza che
quest’ultima sia modificata o messa in discussione. Come
sostiene Trapnell (1996:6) “Lo que ha venido dándose hasta la
fecha, con el apoyo cómplice de la escuela, ha sido una sola
mirada acrítica hacia lo que ha venido de fuera” Al contrario
l’interculturalità dev’essere assunta come un impegno non solo
da parte della popolazione indigena ma anche dal resto della
società affinché le varie componenti culturali possano realmente
dialogare determinando un cambio e una risistemazione della
cultura egemonica (Walsh 2007).
Il patrimonio culturale della regione amazzonica non deve
essere omogeneizzato a quello nazionale, ma al contrario la
scuola deve diventare strumento per garantire il rafforzamento
di una realtà multiculturale e plurilingue come quella peruviana.
La diversità deve essere percepita come ricchezza e non come un
ostacolo verso la modernità. Parlare di interculturalità implica un
impegno costante nel conoscere e capire l’altro, sforzandosi di
abbandonare l’atteggiamento di discriminazione che ha sempre
caratterizzato non solo l’attività educativa ma i rapporti tra lo
Stato e la componente indigena del paese.
Ritornando all’esperienza di Formabiap risulta evidente che
elaborare un progetto educativo che incorpori la cultura indigena
64
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
e che soprattutto risponda alle esigenze degli studenti, sia
un’impresa ardua in cui è necessario valutare di volta in volta gli
aspetti positivi e negativi delle scelte adottate. A questo
proposito
appare
esemplificativo
il
rischio
della
decontestualizzazione della formazione docente, dal momento
che i futuri maestri vengono formati nella sede di Zungarococha,5
lontano dalle loro comunità d’origine. Dunque l’apprendimento
pratico all’interno della comunità viene bloccato durante la loro
permanenza nella scuola. Con lo scopo di ovviare questo
problema il Programma prevede l’alternanza di periodi nella
scuola a periodi nelle comunità in cui gli studenti svolgono anche
lavori di ricerca e documentazione. Allo stesso modo la decisione
di lavorare attraverso dei progetti che nel limite della coerenza si
articolano nelle varie aree, testimonia la volontà di riprodurre il
più fedelmente possibile le condizioni della comunità. Così mi
viene spiegato in occasione di un’intervista dal professor Carlos
Panduro:
Trabajamos con proyectos que buscan recrear acá en Zungarococha, en
las condiciones que tenemos […] y con la participación de los
especialistas, una actividad socio productiva que se desarrollase en una
comunidad, y entorno a esa desarrollamos todo el trabajo académico.
Esa misma dinámica se plantea también para las comunidades en el
caso de los niños en la escuela primaria intercultural bilingüe […] Hay
un exercicio en la Formación para luego ver su aplicación en la
Primaria.6
Questa metodologia presenta vari aspetti positivi: unione di
Comunidad Educativa de Zungarococha, sede del Formabiap dal 1998, si
trova a 40 minuti dalla città di Iquitos.
6 Intervista realizzata a Carlos Panduro Bartra, docente di storia (Área de
Naturaleza y Sociedad), presso Formabiap sede di Zungarocha, Iquitos,
08/09/2011.
5
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
65
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
teoria e pratica, apprendimento di tecniche e dinamiche culturali
tradizionalmente trasmesse al di fuori dell’ambiente scolastico,
recupero delle stesse nel caso in cui sia venuta a mancare la loro
trasmissione all’interno delle comunità. Molti studenti giungono
a Formabiap con la convinzione che per diventare maestri sia
necessario ripudiare le conoscenze e il sapere della propria
cultura a favore di una formazione ‘occidentale’; si ritrovano
invece a esercitarsi concretamente per la pratica docente futura
osservando e determinando l’articolazione dei contenuti e delle
conoscenze all’interno della dinamica educativa.
L’obiettivo è ricreare all’interno di Zungarococha le stesse
condizioni della comunità. È un modello d’istruzione che viene
sviluppato per poi essere applicato dai maestri, nel momento in
cui torneranno alle loro comunità per insegnare nella scuola
primaria. Il maestro dovrà cercare di integrare il lavoro di tutte le
aree in funzione dell’attività selezionata. Dunque nonostante il
rischio della decontestualizzazione nel riprodurre certe
situazioni in un contesto che è senz’altro differente dalla
comunità, questo metodo possiede comunque un forte potenziale
per la pratica docente futura.
Il ruolo della scrittura
La scrittura è apparsa fin dagli inizi del Programma come una
priorità soprattutto in relazione al processo di rivalorizzazione
delle lingue indigene e nella convinzione che attraverso la
scrittura si possa conservare il patrimonio culturale e allargare le
aree d’uso delle lingue autoctone. Scrivere in lingua indigena
permetterebbe di promuovere, diffondere e salvaguardare la
ricchezza culturale amazzonica, contribuendo in maniera
determinante alla crescita dell’identità culturale indigena. In un
paese in cui la scrittura ha rappresentato e in alcuni contesti
66
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
rappresenta ancora oggi un simbolo del potere, appropriarsene
può significare legittimare la propria cultura e poter accedere
agli ambienti in cui vengono prese le decisioni più importanti.
Per questa ragione appare necessario operare una distinzione tra
scrittura in lingua indigena e scrittura in lingua spagnola. Il
discorso della scrittura appare ancora oggi abbastanza complesso
se si considera che il mancato ricorso alla scrittura da parte delle
popolazioni autoctone non è dovuto esclusivamente alla
mancanza di un alfabeto, soprattutto nel caso di popolazioni che
hanno un alfabeto da parecchi decenni. La motivazione di chi
scrive è forse l’elemento chiave per comprendere il mancato
ricorso a questa pratica e la scuola non può e non deve essere
certamente l’unico ambiente in cui si stabilisce la necessità di
questo mezzo di comunicazione.
[…] se puede afirmar que si los pueblos indígenas no se han apropiado
de la escritura es porque esta se ha introducido en las comunidades sin
tomar en cuenta cómo esta podría relacionarse con las prácticas sociales
existentes de la comunidad. Así, no es necesario ser muy inteligente
para darse cuenta de que un programa de alfabetización o una campaña
de lectura en lenguas indígenas está condenado al fracaso en las
comunidades donde los comuneros no le ven ninguna utilidad para el
desarrollo de su pueblo, o donde la escritura no tiene ninguna conexión
con las prácticas sociales de la comunidad (Vigil 2006).
Nel momento in cui si incoraggia lo sviluppo di una
tradizione scritta in lingua indigena bisogna anche tener conto
del fatto che le lingue indigene sono state usate prevalentemente
solo in forma orale e il ricorso alla scrittura, quasi sempre in
lingua spagnola, era limitato ai contatti col mondo dell’ufficialità
che faceva riferimento alla classi al potere. Inoltre a livello
scolastico anche l’uso della scrittura in lingua indigena spesso ha
comportato esclusivamente una traduzione dei concetti e dei
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
67
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
contenuti della cultura dominante generando un’altra forma di
acculturazione. È necessario che la scrittura venga incorporata
alle pratiche sociali delle popolazioni autoctone nel rispetto della
loro visione del mondo e senza che ciò comporti necessariamente
la perdita di valore dell’oralità (Ivi:2006). All’interno di
Formabiap la lingua, scritta e orale, è considerata un elemento di
identità nella misura in cui gli studenti se ne appropriano e
promuovono azioni di recupero e rivalorizzazione.
Il bilinguismo coordinato è difficilmente raggiungibile ma ci si
impegna affinché gli studenti raggiungano un buon livello di
comprensione e produzione in entrambe le lingue. Gli studenti
che arrivano a Zungarococha possono avere la lingua indigena
come L1 e lo spagnolo come L2 o viceversa e nella maggior parte
dei casi hanno livelli di scolarizzazione piuttosto bassi. Per
esempio gli studenti kukama, che hanno lo spagnolo come lingua
materna, giungono a Formabiap con una conoscenza della lingua
indigena minima a causa sia di un percorso scolastico
esclusivamente in lingua spagnola sia a causa del processo di
discriminazione che ha portato le intere comunità ad
abbandonare l’uso della propria lingua. Anche gli anziani che
conoscono la lingua indigena spesso evitano di usarla perché si
vergognano e pensano che non abbia alcun valore, determinando
la perdita del sapere proprio della comunità e della stessa lingua
con cui veniva trasmesso. A maggior ragione dunque risulta
determinante un impegno costante che favorisca e incoraggi la
valorizzazione e il recupero del patrimonio linguistico e culturale
indigeno.
Un aneddoto del professor Carlos Panduro mette in luce il
ruolo della scuola sia nel determinare il rapporto che gli studenti
indigeni (in questo caso di etnia Tikuna) hanno con la scrittura sia
nel differenziare le aree e le funzioni d’uso delle due lingue.
68
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
Teníamos un grupo de alumnas en educación inicial del pueblo tikuna
y estaban trabajando conmigo un módulo relacionado con la historia de
la comunidad y les he planteado que desarrollen un trabajo utilizando
la lengua tikuna. […] De catorce que estaban en el grupo solo dos
escribieron en lengua tikuna todas las demás en castellano. Yo les
pregunté porque y me dijeron que era mucho más complicado escribir
en tikuna que hacerlo en castellano, por la práctica de la lectoescritura
que en la escuela había sido sólo y unicamente en castellano. 7
Tuttavia lo scarso uso della scrittura non significa che le
popolazioni indigene non abbiano sistematizzato il loro sapere;
in realtà lo classificano e organizzano in base a una visione
diversa del mondo che risulta altrettanto valida quanto il
pensiero occidentale. Anche l’attitudine a utilizzare il termine
‘pensiero scientifico’ in riferimento al mondo occidentale e invece
‘sapere tradizionale’ in riferimento al mondo indigeno riflette
chiaramente una visione etnocentrica della cultura (Montoya
1990). A differenza della logica occidentale, il pensiero indigeno
non concepisce il sapere come una realtà isolata bensì come parte
attiva nella vita dell’uomo, orientata a garantire lo sviluppo e il
benessere della società (Vásquez Medina 2008).
È questo un altro punto da prendere in considerazione nel
momento in cui vengono elaborati dei programmi scolastici
interculturali, in modo che i contenuti non vengano organizzati
secondo schemi e concezioni propri della logica occidentale.
La cultura non è neutra anzi è sempre orientata secondo una
visione/prospettiva ideologica (Sotil García 1997). Qualsiasi
sistema educativo risponde a una precisa concezione dell’uomo e
della società ed è quindi impostato ideologicamente e mai
Intervista realizzata a Carlos Panduro Bartra, docente di storia (Área de
Naturaleza y Sociedad), presso Formabiap sede di Zungarocha, Iquitos,
08/09/2011.
7
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
69
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
neutrale come potrebbe sembrare a prima vista. È dunque
evidente la discrepanza tra l’educazione impartita nella regione
amazzonica e le reali esigenze degli studenti che la ricevono, i
quali non hanno né le stesse esigenze né le stesse prospettive o
modelli di riferimento di uno studente che vive in un contesto
‘occidentalizzato’. Tutte le forme attraverso cui vengono
trasmessi i contenuti educativi comunicano oltre alla nozione o
norma esplicita anche dei messaggi impliciti, che sono frutto
della selezione che i maestri o il Ministero compiono
nell’elaborare il curriculum e i libri di testo. Questi stessi
messaggi impliciti hanno degli effetti concreti e duraturi nella
costruzione
dell’identità
dell’individuo.
Si
pensi
all’insegnamento della storia nella regione amazzonica. I bambini
apprendono una serie di avvenimenti storici che riflettono una
cronologia storica nazionale: i riferimenti alla storia regionale
sono sporadici e decontestualizzati e ignorano completamente il
periodo storico di sviluppo autonomo delle culture native,
precedente alla Conquista. L’insegnamento della storia rivela
dunque un’impostazione etnocentrica facilitando l’imposizione
della visione del mondo propria della cultura egemonica e
ignorando le realtà regionali in cui vivono gli studenti.
Quest’atteggiamento ha una chiara ripercussione sulla
formazione gli studenti perché la scarsa rilevanza che viene data
alla storia locale influisce nel processo di identificazione con la
propria cultura (Sotil García 1997).
Nei libri di testo l’unica storia presente è quella scritta e
occidentale che riflette una visione degli avvenimenti non
indigena e basata essenzialmente su una concezione del tempo
lineare. Non viene presa neppure in considerazione l’idea che
ogni popolo abbia una propria storia e che esista una tradizione
orale che interpreta la storia dal proprio particolare punto di
70
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
vista.
L’educazione appare come uno dei settori fondamentali per
incoraggiare la rivalorizzazione della cultura indigena e
soprattutto per favorire la creazione di un modello di sviluppo
alternativo a quello imposto dallo Stato. In passato lo Stato ha
sempre delegato la gestione del settore educativo a ong o
istituzioni straniere come l’ILV (Instituto Lingüístico de Verano)
(Stoll 1985, Montoya 1990, Greene 2009) dimostrando in questo
modo un totale disinteresse per un settore chiave del paese.
Nonostante la legislazione nazionale e internazionale
garantiscano alle popolazioni autoctone il diritto di ricevere
un’educazione pertinente e nella loro lingua materna, la condotta
prevalente è stata quella di omologare e omogeneizzare la
popolazione sulla base della lingua spagnola, nella convinzione
che questo portasse alla formazione di un’identità nazionale. Il
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes della OIT (Organización Internacional de Trabajo) del
1989, nella parte VI Educación y Medios de Comunicación (articoli
26-31) stabilisce che le popolazioni indigene debbano ricevere
un’educazione che risponda alle loro necessità, che garantisca
l’apprendimento nella loro lingua materna e il raggiungimento
di un buon livello della lingua nazionale, che membri della
comunità
vengano
formati
e
possano
partecipare
nell’elaborazione e messa in pratica del programma scolastico
(Brañas 2010), ma come spesso accade le leggi vengono
puntualmente ignorate.
Affermazione dell’identità indigena
In un momento storico in cui le popolazioni autoctone lottano
per la propria autodeterminazione e per vedere riconosciuti i
propri diritti, l’educazione interculturale si colloca all’interno di
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
71
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
un processo di rivendicazione che non è solo culturale ma anche
ideologico e politico. L’interculturalità concepita come strumento
a favore della coesione sociale e del dialogo continuo nel rispetto
della diversità culturale appare come condizione fondamentale
per la consolidazione di una società che sia realmente
democratica, a maggior ragione in paesi come il Perù,
caratterizzati da conflitti e relazioni fortemente asimmetriche tra
lo Stato e le comunità indigene (Zúñiga, Ansión 1997). Lo stesso
Formabiap non si limita a formare maestri indigeni interculturali
bilingui ma forma in primo luogo maestri che siano impegnati
nella difesa e nella rivendicazione dei diritti della propria
popolazione. Appena giunti a Zungarococha gli studenti
affrontano un percorso per molti difficoltoso che li porta ad
accettare e riconoscere la propria identità indigena. Per
moltissimo tempo le popolazioni indigene hanno dovuto subire
politiche discriminatorie che avevano come obiettivo
l’eliminazione del loro patrimonio culturale a favore di un unico
modello nazionale ‘occidentale’ e monolingue spagnolo. Questo
spiega come soprattutto agli inizi Formabiap incontrasse la
disapprovazione dei genitori o degli anziani delle comunità, che
ritenevano la rivalorizzazione della cultura tradizionale un
ostacolo al progresso e pensavano all’istruzione in termini di
formazione scientifica occidentalizzata. La maggioranza dei
ragazzi che entrano a Formabiap all’inizio non si identificano
come indigeni, soprattutto nel caso in cui come i Kukama abbiano
ricevuto una formazione scolastica di tipo occidentale,
esclusivamente in lingua spagnola, che li ha portati al completo
abbandono della loro cultura.
Prendere consapevolezza del proprio essere indigeno è un
processo difficoltoso, soprattutto in una realtà in cui l’elemento
indigeno è sempre stato contrapposto in maniera negativa alla
72
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
cultura spagnola/occidentale e le stesse popolazioni autoctone
hanno spesso assimilato in maniera anche inconscia questa
presunta inferiorità. La perdita della lingua e delle pratiche
culturali da parte di alcuni gruppi etnici dimostra come
l’atteggiamento discriminatorio abbia portato nel tempo ad un
impoverimento culturale del paese e ad un sentimento di rifiuto
nei confronti del mondo indigeno amazzonico; in questo
processo ha avuto un ruolo preponderante il disinteresse
dimostrato dallo Stato, permettendo che iniziative private
gestissero il settore educativo (Montoya 1990).
L’impostazione acculturante ed etnocentrica della scuola ha
comportato l’interiorizzazione e la trasmissione di generazione in
generazione di atteggiamenti quali: la vergogna nel dichiararsi
indigeno, il ricorso unicamente alla lingua spagnola davanti a
persone non indigene e in generale un sentimento di inferiorità.
Nel peggiore dei casi l’interiorizzazione di questi atteggiamenti
ha comportato da parte dello stesso individuo il rifiuto e il
disprezzo nei confronti della propria cultura d’origine e il
relativo abbandono (Gasché 2008). Al contrario l’interculturalità
opponendosi alla tendenza omogeneizzante praticata a favore
della cultura dominante mette in luce l’impossibilità e
l’impraticabilità di una realtà in cui la diversità culturale non
venga percepita come ricchezza (Zúñiga, Ansión 1997).
La scuola ha agito spesso secondo un’ottica etnocentrica, da
una parte eliminando completamente il sapere indigeno dai
programmi scolastici e dall’altra impartendo le lezioni
esclusivamente in lingua spagnola, anche nei casi in cui i
bambini fossero monolingue indigeni. Non ci deve stupire allora
che un adolescente (ma questo discorso vale anche per gli adulti)
giunga al punto di negare la propria identità indigena, dopo aver
ricevuto per tutta la vita messaggi negativi in relazione a tutto
ciò che è indigeno.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
73
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
In questi casi il sapere scolastico e quello locale hanno fatto
riferimento a due realtà completamente diverse e contrapposte e
la scuola è stata la causa di vari cambiamenti che hanno portano
all’abbandono della cultura e dell’identità indigena a favore di
una presunta ‘civilizzazione’ occidentale. Come dimostrato dalla
ricerca condotta da Laura Rival (Rival 2000) presso la comunità
degli Huaorani nell’Amazzonia ecuatoriana l’introduzione di un
simile modello scolastico attraverso l’ILV, le missioni
evangeliche e lo Stato ha generato: divisioni etniche, abbandono
delle pratiche culturali tradizionali, dipendenza da modelli
sociali esterni e occidentali, sedentarizzazione.
Nelle occasioni in cui è stato ammesso l’uso della lingua
indigena a scuola si è trattato spesso dell’applicazione di un
metodo di transizione (Montoya 1990, Pozzi-Scott 1991 ) in base
al quale l’uso della lingua indigena era limitato ai primi anni
della scuola primaria, durante i quali lo studente raggiungeva
una discreta padronanza della lingua spagnola, la quale
successivamente diventava l'unica lingua usata in ambito
scolastico. Nei casi in cui la scuola sia stata una delle cause
principali dell’abbandono delle pratiche culturali indigene a
favore della cultura nazionale dominante, appare evidente che la
riaffermazione dell’identità indigena non possa avere la
dimensione scolastica come luogo d’azione ma cercherà altri
spazi e altri canali. É il caso degli Huaorani citati
precedentemente o degli Arakambut di Madre de Dios studiato
da Sheila Aickman (Aickman 2003) i quali tendono a mantenere
separati l’ambito scolastico da quello comunitario con lo scopo di
ridurre l’influenza negativa che la scuola nazionale ha sulle loro
pratiche socio culturali. Come scrive l’autrice ”La separación de
dominios culturales […] es un aspecto de su defensa contra la
colonización”(Aickman 2003:256). Allo stesso tempo in risposta a
74
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
questo modello di scuola omogeneizzante le stesse popolazioni
indigene amazzoniche, attraverso le loro federazioni,
rivendicano il diritto a ricevere un’educazione bilingue
interculturale, in modo che la scuola possa favorire la
valorizzazione della cultura autoctona e l’affermazione
dell’identità indigena (Paredes 2001, UNICEF, Eibamaz 2008).
L’educazione interculturale bilingue contribuisce allo sviluppo
negli studenti di un sentimento positivo di autoaffermazione
personale, grazie al riconoscimento che la scuola attribuisce al
loro patrimonio linguistico e culturale. Una scuola che miri al
recupero e alla valorizzazione della cultura dei propri studenti
deve in primo luogo superare l’ostacolo rappresentato dalla
percezione negativa che hanno di sé stessi e del mondo indigeno
(Gasché 1997). L’eib rappresenta uno spazio strategico, seppur
non l’unico (Montoya 1990), per offrire alla società indigene
elementi di inclusione e favorire l’affermazione di un’identità
etnica. Altri paesi latinoamericani come Ecuador e Bolivia in
questi ultimi anni sono lo scenario di una forte partecipazione e
attivismo politico da parte delle popolazioni indigene, le quali
rivendicano i propri diritti e mettono in discussione
l’atteggiamento dello Stato (UNICEF, Eibamaz 2008). Tra le altre
rivendicazioni emerge, come in Perù, il diritto a un’educazione
che sia realmente interculturale bilingue e che includa le stesse
federazioni indigene e i propri leaders come parte attiva nelle
fasi di organizzazione e gestione del processo educativo.
L’esperienza dei paesi sopra citati e del Formabiap
nell’Amazzonia peruviana dimostrano come la partecipazione
indigena possa favorire il raggiungimento di risultati di qualità e
coerenti con la cultura degli studenti ( Vásquez et al. 2009). Al
contrario un’eib che non consideri come parte attiva la
componente indigena è destinata al fallimento perché, come le
esperienze passate, si rivela il prodotto di una visione occidentale
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
75
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
che viene imposta dall’esterno, generando una serie di conflitti
identitari, processi di abbandono e omogeneizzazione culturale .
Ma su che basi definire indigena una comunità? In base alla
cultura? All’eredità genetica? Al luogo in cui vivono i suoi
membri? Alla lingua? Ai sensi dell’articolo 2 della legge 27811
sono considerati indigeni:
Pueblos indígenas-Son pueblos originarios que tienen derechos
anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una cultura
propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales. En éstos
se incluyen los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados así
como a las comunidades campesinas y nativas. La denominación
“indígena” comprende y puede emplearse como sinónimo de
“originarios”, “tradicionales”, “étnicos”, “ancestrales”, “nativos” u
otros vocablos.8
Anche a livello legislativo il tentativo di individuare ciò che
può essere considerato indigeno ha varie conseguenze.
Rimanendo nell’ambito educativo si pensi in tutti questi anni
all’atteggiamento negativo da parte dello Stato nell’ammettere
l’esigenza di una scuola EIB a favore di comunità che non sono
monolingui indigene, non riconoscendo l’importanza della
rivalorizzazione della lingua, della storia e della cultura di una
comunità anche nei casi di bilinguismo o monolinguismo
spagnolo. Fino a qualche tempo fa in Perù una scuola poteva
essere considerata EIB per la sola presenza nel corpo docente di
un maestro di EIB e cessare di operare come tale nell’eventualità
in cui lo stesso maestro fosse trasferito (Zúñiga 2008). Questo
aspetto è stato recentemente oggetto di attenzione da parte del
Ministero dell’Educazione che attraverso la Risoluzione
Consultato il 12/03/2012 su
http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/ley_27811.pdf.
8
76
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
Ministeriale 0008 del 09/01/2012 ha stabilito i criteri sulla base
dei quali una scuola può essere riconosciuta come interculturale
bilingue: lingüístico e cultural y de autoadscripción.9 Se da una parte
questa decisione rappresenta a mio avviso un segnale di
cambiamento e di maggiore interesse da parte del Ministero nei
confronti del settore educativo dall’altra è pur vero che non
sempre le leggi vengono applicate e che l’educazione continua ad
essere strettamente vincolata agli interessi politico-economici.
Come dimostra la relazione della 48 sessione del Consiglio dei
diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite10 lo stato
peruviano continua a portare avanti delle politiche che non
rispettano i diritti delle popolazioni indigene permettendo
l’estrazione mineraria e petrolifera in territori ancestrali a danno
sia delle condizioni ambientali sia del patrimonio culturale
autoctono.
Conclusioni
Ancora oggi uno dei pregiudizi più diffusi è quello di
considerare le comunità indigene come statiche e primitive
negandogli in modo totalmente arbitrario la possibilità di portare
avanti e diffondere un concetto di modernità differente ma non
per questo meno valido di quello occidentale.
Pero para esa percepción “europea” u “occidental” en plena formación,
esas diferencias, esas diferencias fueron admitidas ante todo como
desigualdades, en el sentido jerárquico. Y tales desigualdades son
percibidas como de naturaleza: sólo la cultura europea es racional,
Consultato il 25/05/2012 su http://www.minedu.gob.pe.
United Nations, Economic and Social Council, Committee on Economic,
Social and Cultural Rights 48th Session, (30 April - 18 May 2012).
Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and
9
10
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
77
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
puede contener “sujetos”. Las demás no son racionales. No pueden ser
o cobijar “sujetos”. En consecuencia, las otras culturas son diferentes en
el sentido de ser desiguales, de hecho inferiores, por naturaleza. Solo
pueden ser “objetos” de conocimiento o de prácticas de dominación. En
esa perspectiva, la relación entre la cultura europea y las otras culturas
se estableció y desde entonces se mantiene como una relación entre
“sujeto” y “objeto” (Quijano 1992: 443).
Il modello di modernità diffuso dalla capitale continua ad
essere considerato dalla maggioranza come l’unico valido
nonostante la sua totale incoerenza e impraticabilità in una parte
considerevole
del
paese,
dimostrando
una
costante
incomunicabilità tra la periferia e il centro. Lo stesso concetto di
interculturalità non viene percepito dallo Stato come un discorso
rivolto a tutta la popolazione, a favore della crescita di
un’identità nazionale in cui tutti i peruviani possano riconoscersi,
bensì come un percorso che solo la popolazione indigena deve
compiere per uniformarsi alla realtà della capitale. Come spiega
Mignolo “[…] cuando la palabra "interculturalidad" la emplea el
Estado, en el discurso oficial el sentido es equivalente a
"multiculturalidad." [...]En cambio el proyecto "intercultural" en
el discurso de los movimientos indígenas está diciendo toda otra
cosa, está proponiendo una transformación (Walsh 2002: 7)”.
Bibliografia
ABANTO A.
2011
“Educación Intercultural Bilingüe en el Perú. Supervisión de la Defensoría
del Pueblo”, in Tarea, 76, pp. 17-20.
AICKMAN S.
2003
La educación indígena en Sudamérica. Interculturalidad y bilingüismo en
Madre de Dios, Lima, IEP (ed. or. 1999, Intercultural Education and
Literacy, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company).
78
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
BALLÓN AGÜIRRE F.
2002
Introducción al derecho de los pueblos indígenas, Lima, Defensoría del
Pueblo.
BOWERS C.A.
2002
Detrás de la apariencia. Hacia la descolonización de la educación, Lima,
Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas.
BRACK A.
1997
Amazonía Peruana. Comunidades Indígenas, conocimientos y tierras
tituladas. Atlas y Base de Datos, Lima, GEF,PNUD, UNOPS.
BRAÑAS M.M (a cura di)
2010
Conociendo nuestros derechos. El Convenio de la OIT y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Iquitos,
Aecid, Proyecto Araucaria XXI Nauta, Ministerio del Ambiente.
ESCOBAR A. - MATOS MAR G. - ALBERTI G.
1975
¿Perú país bilingüe?, Lima, IEP.
FORMABIAP
1998
Programa Curricular Diversificado Educación Primaria Intercultural
Bilingüe para los Pueblos Indígenas Amazónicos, Iquitos, Aidesep, ISPP Loreto.
2004
Lineamientos curriculares diversificados de formación magisterial en la
especialidad de la educación primaria intercultural bilingüe, Iquitos,
Aidesep, ISPP Loreto.
FREIRE P.
1971
La pedagogia degli oppressi, Milano, Mondadori (ed. or. 1970, Pedagogia
do oprimido, Rio de Janeiro, Edições Paz e Terra).
FULLER N. (a cura di)
2002
Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades, Lima, Red para el
Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
GASCHÉ J.
1997
“Más allá de la cultura: lo político. Teoría y práctica en un programa de
formación de maestros indígenas amazónicos del Perú” in Indígenas en las
Escuela, a cura di Bertely Busquets M., Robles Valle A., México,
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pp. 219-244, consultato
il 12/03/2012 su http://test-red.pucp.edu.pe/ridei/wpcontent/uploads/biblioteca/mas_alla_cultura.pdf.
2002
“El difícil reto de una educación indígena amazónica: alcances y abandonos”
in Interculturalidad, Sociedad Multicultural y Educación Intercultural,
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
79
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
Alcaman E. et al., México, Castellanos Editores, Asociación Alemana
para la Educación de Adultos, Consejo de Educación de Adultos de
América Latina, pp. 119-158, consultato il 15/05/2012 su
http://www.opech.cl/educsuperior/alternativas/dificil_reto_educaci
on_indigena_amazonica.pdf
2008a “Niños, maestros, comuneros y escritos antropológicos como fuentes de
contenidos indígenas escolares y la actividad como punto de partida de los
procesos pedagógicos interculturales: un modelo sintáctico de cultura” in
Educando en la diversidad. Investigaciones y Experiencias educativas
interculturales y bilingües, a cura di Bertely M., Gasché J., Podestá R.,
Quito, Abya-Yala, CIESAS, pp. 279-366.
2008b “La motivación política de la educación intercultural indígena y sus
exigencias pedagógicas. ¿Hasta dónde abarca la interculturalidad?”, in
Educando en la diversidad. Investigaciones y Experiencias educativas
interculturales y bilingües, a cura di Bertely M., Gasché J., Podestá R.,
Quito, Abya-Yala, CIESAS, pp. 367-397.
GREENE S.
2009
Caminos y carreteras. Acostumbrando la indigenidad en la selva peruana,
Lima, IEP (ed. or. 2009, Customizing indigenity:paths to a visionary
politics in Peru, Stanford, Stanford University Press).
MONTALUISA CH.L.
1993
Comunidad, escuela y currículo IV, La Paz, UNICEF.
MONTOYA R.
1990
Por una educación bilingüe en el Perú. Reflexiones sobre cultura y
socialismo, Lima, CEPES, mosca azul editores.
PAREDES OPORTO M.
2001
“Hay una fuerte agresión a los pueblos amazónicos”. Entrevista con
Guillermo Ñaco in Revista Quehacer, 132, pp. 90-95.
PÉREZ C. - ECHEVERRI J. A. (a cura di)
2010
Memorias. I Encuentro Amazónico de Experiencias de Diálogo de Saberes,
Leticia, Editorial Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia.
POZZI-SCOTT I.
1991
“Ideas y planteamientos propuestos en el desarrollo y debate de la educación
bilingüe en el país” in Educación bilingüe intercultural. Reflexiones y desafíos, a cura
di Zuñiga M., Pozzi-Scott I., Lópes L. E., Lima, FOMCIENCIAS, pp. 121-147.
QUIJANO A.
1992
“Colonialidad y modernidad/racionalidad” in Los conquistados. 1492 y la
80
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
población indígena de las Américas, a cura di Bonilla H., Quito, Libri
Mundi, Tercer Mundo, pp 437-447.
RIVAL L.
2000
“La escolarización formal y la producción de ciudadanos modernos en la
Amazonía ecuatoriana” in Etnicidades, a cura di Guerrero A., Quito,
Flacso, ILDIS, Serie Antología, pp. 316-336.
SICHRA I. (a cura di)
2009
Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, Ecuador,
AECID, FUNPROEIB Andes, UNICEF.
SOLÍS FONSECA G. – LÓPEZ E. L.
2003
Pueblos y lenguas de frontera, Lima, UNMSM.
SOTIL GARCÍA G.D.
1997
Hacer educación en la selva. Reflexiones en torno a la educación regional
amazónica, Iquitos, CETA.
2004
La educación para el desarrollo de la región Loreto, Iquitos, CETA.
STOLL D.
1985
¿Pescadores de hombres o fundadores de imperio?, Philadelphia, DESCO.
TRAPNELL L.
1990
“El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana”
in Amazonía Peruana, XI, 18, pp. 103-115.
1996
“Pueblos indígenas, educación y currículo. Una propuesta desde la
Amazonía” in Educación e interculturalidad en los Andes y la Amazonía, a
cura di Godenzzi Alegre J, Cuzco, CBC, pp. 165-185 consultato il
03/04/2012 su
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/trapnell.pdf.
2008
“Conocimiento y poder: una mirada desde la educación intercultural
bilingüe” , in Revista Argumentos, 2 (4), consultato il 07/04/2012 su
http://www.revistargumentos.org.pe/conocimiento_y_poder__una_
mirada_desde_la_educacion_intercultural_bilingue.html.
TRAPNELL L. - CALDERÓN A. - FLORES R.
2008
Interculturalidad, Conocimiento y Poder. Alcances de un Proceso de
Investigación-Acción en DOS Escuelas de la Amazonía Peruana, Lima,
Instituto del Bien Común, Fundación Ford, Oxfam America.
UNAP - IDEA
2004
II Congreso Educativo Amazónico Internacional, Iquitos, UNAP-IDEA.
UNICEF - EIBAMAZ
2008
Visibilidad e invisibilidad de las culturas de los pueblos indígenas :
Estereotipos y posible racismo en los libros de textos escolares, Lima, Unicef.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
81
Casu M., Formabiap. Riscoperta dell’identità indigena attraverso l’educazione interculturale bilingue.
VÁSQUEZ E. - CHUMPITAZ A. - JARA C. – LÓPEZ L.E.
2009
Niñez indígena y Educación Intercultural Bilingüe. Estadísticas recientes,
preguntas (i)resueltas y tareas pendientes, Lima, Care Perú, Educa, Save
the Children, Tarea, Unicef.
VÁSQUEZ MEDINA J.A.
2008
“Demanda, necesidad y desafíos de la formación de maestros interculturales”,
in Docencia y contextos multiculturales. Reflexiones y aportes para la
formación de docentes desde un enfoque intercultural, Hidalgo et al., Lima,
Tarea, ISPP Tupac Amaru de Tinta, pp. 71-95.
VIGIL N.
2006
“Pueblos indígenas y escritura”, in Interculturalidad, 3, consultato il
20/02/2012 su http://interculturalidad.org/numero03/2_07.htm.
WALSH C.
2002
“Las geopolíticas de conocimiento y la colonialidad del poder. Entrevista a
Walter Mignolo” in Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del
conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino, a cura
di Walsh C., Schiwy F., Castro-Gómez S., Quito, Universidad Andina
Simón Bolívar, Abya Yala, pp. 17-44, consultato il 21/03/2012 su
http://waltermignolo.com/txt/publications/interviews/EntrevistaW
alsh.pdf.
2007
“Interculturalidad, colonialidad y educación”, in Revista Educación y
Pedagogía, 19 (48), pp.25-35.
ZÚÑIGA M.
1993
Educación bilingüe III, La Paz, UNICEF.
2008
La educación intercultural bilingüe: el caso peruano, Buenos Aires, Fund.
Laboratorio de Políticas Públicas.
ZÚÑIGA M. – ANSIÓN J.
1997
Interculturalidad y Educación en el Perú, Lima, Foro Educativo.
82
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
Valentina Mura
La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
Riflessioni sul rapporto con i Rom.
Abstract
In this article I’ll try to explicate the question of cultural diversities, in particular
about Roma people, trying to define the most important links between Roma and
political, social and scholastic institutions. I start speaking about the concepts of
diversity and race from 1500 to the most recent studies that treat about the
importance of education against racism and discrimination. I try to describe the
situation of the Roma group of San Nicolò Arcidano, at school and with the other
inhabitants. The situation oscillates between integration policies and segregation
policies trying the difficult way of school education but carrying on with the
segregation trough the construction of gypsies camp.
Key words
San Nicolò Arcidano, rom, alterità, intercultura, processi formativi.
In questo articolo cercherò di trattare il discorso sull’alterità
prima in generale, poi focalizzando l’attenzione sul rapporto
della società e delle istituzioni con i Rom. Parte dell’articolo
prende spunto dal mio lavoro di ricerca sul campo per la tesi di
laurea magistrale1 che prevedeva, appunto, lo studio del
rapporto tra le istituzioni e i Rom e l’attivazione di politiche di
inclusione scolastica in contrasto con le politiche di esclusione
urbana.
La produzione dell’altro esiste in quasi tutte le società umane
1
2012, La comunità Rom a San Nicolò d'Arcidano. Esempi di intercultura e
integrazione.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
83
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
(Aime – Severino 2009: 9) “le quali si autodefiniscono buone
creando entità cattive che stanno al di fuori: un buon modo per
incanalare pulsioni e tensioni” (ivi: 10). Se da una parte ciò
contribuisce a creare coesione interna, dall’altro produce alterità,
necessaria soprattutto in un periodo in cui l’affermazione
dell’identità è sinonimo di negazione dell’altro, del diverso
(ibid.).
Il fatto di definire se stessi come rappresentanti dell’umanità, ad
esclusione di tutti gli altri, di erigere il “Noi” (io e i miei simili, i miei
prossimi, ecc.) come l’Uomo stesso, in opposizione al “non-Noi”m
corrisponde all’atteggiamento che classicamente viene definito come
etnocentrico. Esso consiste nel porre una distinzione fondamentale tra
due categorie opposte e di valore diverso: “Noi, i civilizzati” contro
“loro, i selvaggi”, in cui possiamo riconoscere l’opposizione tra natura e
cultura (barbarie, primitività). (..) l’etnocentrismo porta alla
disumanizzazione dell’altro (…). Nella modernità, la disumanizzazione
dell’altro si compie attraverso la creazione politico-scientifica di
categorie di “sotto-uomini”, cioè di quasi-bestie (Taguieff 1999:11-12)
Un ruolo attivo nella costruzione dell’altro lo ha avuto il
concetto di razza, termine che troviamo usato “a partire dal
Cinquecento per indicare una discendenza, una schiatta, quello
che in antropologia si chiamerebbe un lignaggio” (Dei 2011).
Nell’Ottocento ha però assunto un significato diverso, ossia “un
gruppo umano caratterizzato da specificità sia somatiche sia
intellettuali e comportamentali che si suppongono fondate
biologicamente e trasmesse per via ereditaria” (ibid.). La
diffusione del termine tra XIX e XX secolo è andata di pari passo
con quella delle dottrine razziste e la più famosa fu quella
sostenuta nell’Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855)
del conte francese Arthur de Gobineau. Le conseguenze estreme
di queste teorie si sono viste nell’Europa nazifascista a metà del
84
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
Novecento e, nonostante la fine della del Nazismo e il crollo del
muro di Berlino, anche in epoche più recenti e in più parti del
mondo. Oltre ad essere presenti in tutte le società, “(…) i
pregiudizi razziali possano essere «altrettanto antichi quanto la
storia a noi nota»” (Taguieff 1999: 9). L’antropologia culturale, da
tempo, ha sottoposto i concetti di etnia e di razza a una critica
lucida rispetto a ciò che era stato prodotto dall’evoluzionismo
prima (Bindi – Faedda 2004: 13) e dai processi di dominazione
politica, economica e ideologica:
Il termine «etnicizzazione», che Amselle e Mbokolo (1985) propongono,
intende proprio sottolineare come le etnie siano state molto spesso
l’invenzione comune di amministratori coloniali ed etnologi (Fardon
1987) (…). I processi di rivendicazione nazionalistica da parte delle
etnie (le quali, spesso prendendo a prestito il linguaggio degli
antropologi, hanno invocato i loro diritti come soggetti politici,
economici e culturali autonomi) hanno messo in luce come l’ETNICITÀ
sia uno strumento positivo di identificazione e dall’altro il ruolo che gli
antropologi hanno ricoperto e ricoprono (oggi quasi a richiesta) nella
creazione di IDENTITÀ e tradizioni locali (Fabietti – Remotti 2009:271).
Già con la Scuola di Manchester si misero in discussione i
termini etnia e razza. Ad esempio, secondo Barth - il quale segue
il pensiero di Narroll - il concetto di gruppo etnico è usato
dall’antropologia per indicare una popolazione che:
1. is largely biologically self-perpetuating;
2. shares fundamental cultural values, realized in overt unity in cultural
forms;
3. makes up a field of communication and interaction;
4. has a membership which identifies itself, and is identified by others,
as constituting a category distinguishable from other categories of the
same order. (Barth 1969)
Nonostante la biologia abbia dimostrato la non scientificità
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
85
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
della divisione razziale, l’uso del linguaggio razzista è ancora
forte, per due motivi:
il primo – ipotizzando una buona fede – individua un semplice residuo
linguistico; il secondo – non vi è più la buona fede – riconosce una
precisa scelta linguistica e concettuale di tipo ideologico e politico. Si
parla di etnie e razzismo, culture e intolleranza (…). Da ciò che si vede e
si sente si è diventati intolleranti a tutto ciò che non rientri strettamente
nella propria sfera identitaria (…). (Bindi – Faedda 2004:14)
Inoltre, nel 1950, l’UNESCO dichiarò la non scientificità della
classificazione in razze degli esseri umani. Le Dichiarazioni sulla
razza e i pregiudizi razziali sono state poi approvate nel 1978 a
Parigi.2
Sappiamo “ogni cultura si è costruita una propria identità solo
mediante un confronto, talvolta anche conflittuale, con altre
culture” (Pasqualotto 2007: 17). Ciò sta a significare che “nessuna
cultura (…) può arrogarsi il diritto di una priorità cronologica o
quello di una superiorità qualitativa” (ibid.).
L’Italia, paese quasi esclusivamente di emigrazione fino a
qualche decennio fa, è diventata, dagli anni ’70 anche paese di
immigrazione (Pugliese 2006; Signorelli 2006; Ambrosini 2008).
Questo cambiamento ha portato “a uno sfasamento della
memoria storica (…) e oggi ci fa paura quel che noi eravamo solo
fino a qualche decennio fa” (Aime – Severino 2009: 10). Lo
stereotipo de ‘l’italiano brava gente’ viene smentito dall’arrivo
dello straniero:
La consapevolezza che «ormai gli extracomunitari ci sono», che «non se
ne andranno tanto facilmente» e dunque «bisogna farci i conti»,
«imparare a conviverci» tanto più che «in fondo sono esseri umani
come noi» e «noi siamo civili, mica siamo degli schiavisti», «gli italiani
2
http://www.arpnet.it/ahs/DICH-RAZZA-PREGIUD.htm
86
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
non sono razzisti, diamine!»; e al tempo stesso un sentimento profondo,
che sembra invincibile, soffocato ma sempre pronto a riemergere, un
sentimento di disagio, di diffidenza, di estraneità, addirittura di paura
di un pericolo, di una minaccia confusamente avvertita: una sorta di
tensione tra questi due atteggiamenti sembra molto diffusa e sembra
fonte appunto di una certa angoscia (ibid.) (Signorelli 2006: 104).
Ma chi è l’altro? E perché se ne ha paura? Roland Barthes, nel
tentativo di definire l’altro si trova dentro una contraddizione:
Io sono il prigioniero di questa contraddizione: da una parte, credo di
conoscere l’altro meglio di chiunque e glielo dichiaro trionfalmente («Io
sì che ti conosco! Solo io ti conosco veramente!»); e dall’altra, sono
spesso colpito da questa evidenza: l’altro è impenetrabile, sgusciante,
intrattabile; non posso smontarlo, risalire alla sua origine, sciogliere il
suo enigma. Da dove viene? Chi è l’altro? Mi esaurisco in sforzi inutili:
non lo saprò mai. (Barthes 1979: 107)
Albert Memmi prova a dare una risposta a questa domanda
sostenendo che “ogni volta che un individuo si trova a contatto
con un altro individuo, o un gruppo diverso o a lui poco
familiare, egli reagisce in un modo che preannuncia il razzismo”
(Memmi 1989: 19). Ma prima del razzismo c’è il pregiudizio
dovuto alla mancanza dell’esperienza dell’altro:
Avere più esperienza dell’alterità significa avere più capacità di
comparazione, cioè avere più capacità di relativizzare i modi di vita
locali, cioè più expertise di prenderli per quello che sono, cioè delle
costruzioni culturali e non delle verità valide per tutti (Piasere 2011: 54)
La mancanza di esperienza ci porta a relegare qualcuno in un
ruolo preciso e ciò ci permette di star dentro dei confini
predefiniti che lasciano poco spazio alle alternative, perché ci
danno la sicurezza di poter dire che l’altro è fatto in un certo
modo e quindi possiamo prevederlo e conoscerlo senza doverci
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
87
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
però avere a che fare. L’altro ha quelle caratteristiche dettate dai
luoghi comuni i quali, se rovesciati, provocano nel razzista uno
spaesamento:
Conoscere un genovese spendaccione, un napoletano triste o uno
svizzero ritardatario (…) fa immediatamente pensare alle eccezioni che
confermano la regola. Né fa cambiare idea conoscerne più d’uno.
Insomma, il buon senso, necessario per sbrigare problemi della vita di
tutti i giorni, può irrigidire o addirittura paralizzare la nostra capacità
di comprendere tempestivamente con chi abbiamo a che fare (Barbujani
– Cheli 2010: 29)
Questo irrigidimento si rispecchia poi nella concezione
dell’identità stessa, la quale viene vista come un’entità stabile,
ma:
Se fosse troppo dire che fortunatamente il mondo è sempre stato dei
bastardi (e purtroppo, ma secondariamente, dei leghisti di ogni tempo),
gli antropologi amano dire che i frutti puri, se mai ci sono o ci sono
stati, quelli, i frutti puri, o che si vogliono e credono puri, impazziscono
(Angioni: 2012)
Nonostante le società presuppongano una dipendenza reciproca3
“la paura, l’ostilità e l’aggressione sono ugualmente presenti
nelle relazioni tra gli uomini” (Memmi 1989: 21). Lo stesso
Memmi definisce il razzismo come una “deficienza nelle
relazioni con gli altri” come se si fosse allergici (ibid.), e infatti la
3
Secondo Memmi, “le nostre relazioni con gli altri possono essere di due tipi:
imposte, basate cioè sulla sete di potere, sulla ricerca del dominio sugli altri per potere
realizzare propri bisogni o propri desideri, oppure negoziate, fatte di un’intesa per
reciproche forniture, di offerta di reciproche soddisfazioni. E affermò che «usciremo
dalla barbarie il giorno in cui, riconosciute le nostre dipendenze, smetteremo di essere
dei predatori e degli assassini dei nostri simili. Allora negozieremo i nostri scambi
reciproci»” (Karli 1990, cit. in Memmi 1999.
88
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
parola ‘allergia’4 significa ‘reazione all’altro’. L’altro che è
portatore di diversità simboleggia l’ignoto verso cui si è
totalmente diffidenti o affascinati, che dà un senso di esotico. Da
una parte c’è la paura, il terrore che sfocia anche in forme di odio
e violenza, e dall’altra c’è una curiosità e un fascino per ciò che
non si conosce. La mancanza di esperienza, la paura, l’incapacità
di relazionarsi sono quindi tra i fattori principali della creazione
del razzismo, il quale nasce:
nel contesto di tensioni interculturali o interetniche, dove può
innescarsi una dialettica delle identità: infatti, qualsiasi affermazione di
identità o di appartenenza a una determinata comunità, da parte di un
gruppo anche decisamente minoritario, rischia di esasperare il senso
dell’identità di altri gruppi, primo fra tutti quello dominante o
maggioritario (Wieviorka 2000).
Per attenuare tali tensioni è necessario ragionare in termini di
approccio interculturale, il quale:
si propone in realtà come dialogo interculturale, dove ‘dialogo’ va fatto
valere non nel senso banale del termine, ossia intendendolo come
semplice confronto tra opinioni già definite e consolidate, ma nel senso
più autentico, quello socratico del termine, ossia come incontro tra due o
più interlocutori disposti a mettere in discussione tutti i loro
presupposti e, se necessario, persino se stessi (Pasqualotto 2007: 20).
Questo non significa dover “abbandonare i propri valori (…)
ma comporta la capacità di mettere in discussione i modelli
culturali con cui siamo cresciuti” (Balboni 1999:17). E “per capire
un’altra tradizione, devo prima di tutto mettere in questione ciò
che su di essa è stato detto nell’ambito della tradizione cui
appartengo” (Leghissa 2002:91).
4
Allergia, dal greco antico ἀλλεργία, derivato di ἄλλος e di ἔργον.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
89
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
L’educazione interculturale
Un buon laboratorio di interculturalità va visto, prima di tutto,
all’interno delle scuole. È raro, infatti, trovare una scuola nella
quale non siano presenti alunni e studenti di origini straniere.5 La
Scuola, nonostante i numerosi tentativi di imporre le “classi
separate” o le “quote” di un certo numero di stranieri per classe,6
ha spesso, al suo interno, docenti che lavorano per insegnare ai
propri alunni l’importanza della diversità e il rispetto dell’altro
tramite l’attivazione di progetti, anche extrascolastici, che
prevedono sia attività ludiche che di ascolto attraverso le quali
gli alunni vengono portati a riflettere e a confrontarsi.
Dal punto di vista culturale, una scuola inclusiva persegue
fondamentalmente due obiettivi: superare la mentalità etnocentrica e
prendere coscienza della varietà delle risposte culturali. Il metodo
possibile è quello del contrasto, utile a “sbanalizzare l’esperienza
quotidiana”: il confronto con realtà diverse dalla propria può stimolare
i ragazzi a vedere con occhi diversi il proprio modo di vita e a non darlo
per scontato. Dal punto di vista sociale, una scuola inclusiva può
diventare il centro di una rete di relazioni interne e territoriali che
possano articolare un progetto di ricostruzione di legami e relazioni,
ripensando se stessa come laboratorio sociale per imparare a gestire i
conflitti e a costruire e valorizzare il capitale sociale (Martin 2010: 55).
Una delle questioni più sentite dalla scuola è l’uso della
lingua madre dei figli di migranti: “alcuni di essi parlano e
comprendono la lingua o le lingue della propria famiglia, i più la
comprendono, ma non la parlano bene o volentieri” (Modesti
2011: 151). L’insegnamento di più lingue nelle scuole è
5
http://www.csa.fi.it/area_interculturale/alunni_stranieri_2.html (consultato il
14/03/2012).
6
http://www.stranieriinitalia.it/attualita- classi_ponte_per_i_bambini_stranieri_6040
.html (consultato il 14/03/2012).
90
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
incoraggiato già da tempo dall’Europa, ma in Italia, sia per una
mancata preparazione didattica degli insegnanti sia per
mancanza di risorse e di personale, le scuole sono ancora indietro
nell’adeguamento dei bisogni linguistici dei figli degli stranieri
(ibid.). Ovviamente la questione linguistica è strettamente legata
all’educazione interculturale. Modesti fa riferimento alla
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 nella quale si
legge che:
Gli Stati parti concordano sul fatto che l’educazione del fanciullo deve
tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi
talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l’arco delle sue
potenzialità;
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della
sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle
civiltà diverse della propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici,
nazionali e religiosi e persone di origine autoctona;
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l’ambiente naturale (art.
29, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989).
Nel rapporto della Commissione Cultura ed educazione del
Parlamento Europeo sull’educazione dei figli di migranti del
2009, dal titolo Istruzione per i figli dei migranti (Risoluzione del
Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sull'istruzione per i figli dei
migranti (2008/2328(INI))7 si sostiene l’importanza del saper
7
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
(consultato il 14/03/2012)
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
91
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
comunicare la propria cultura e comprendere quella altrui, ma
affinché ciò accada è necessario che vengano riconosciuti i diritti
di ciascuno. La conoscenza dello straniero deve avvenire in
chiave dialettica:
all’uguaglianza degli esseri corrisponde in parallelo il diritto alla
manifestazione delle differenze, evitando sempre accuratamente che
queste stesse non entrino in opposizione tra loro, che non prevalga,
cioè, la tipica logica binaria occidentale, secondo la quale speculare al
bianco vi è necessariamente il nero (Bindi – Faedda 2004: 15)
È quindi importante che l’educazione interculturale preveda la
lotta alla xenofobia, della quale sono vittime anche i minori nati
in Italia da genitori stranieri. Il colore della pelle, il cognome, ne
indicano l’origine ‘diversa’ e possono essere fonte di
discriminazione, tra i bambini.
Una formazione efficace dovrebbe tener conto dei meccanismi
di potere che si sono avuti tra gli stati nazionali e i popoli
(Modesti 2011: 155). In Italia, come denunciato sia dalle
istituzioni politiche,8 sia dal mondo dell’associazionismo9 il
problema del non riconoscimento dello Ius Soli10 fa parte di quei
meccanismi di potere propri del razzismo istituzionale. Il diritto
alla cittadinanza per i figli degli immigrati che nascono in Italia e
che qui frequentano le scuole, è una questione fondamentale per
la lotta alle discriminazioni anche in ambito scolastico.11
8
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0001:
0005:IT:PDF (consultato il 14/03/2012).
9
http://www.corriere.it/politica/11_novembre_22/napolitano-politicaimmigrazione_3dad5690-14fa-11e1-9140-38f81e7faa5e.shtml
(consultato
il
23/11/2011)
10
L’ultima proposta di legge sul passaggio dallo Ius Sanguinis allo Ius Soli è quella
firmata dai due deputati Sarubbi (PD) e Granata (FLI) nel 2009 e prevede le modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
11
http://www.litaliasonoanchio.it (consultato il 17/02/2012).
92
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
I primi due riferimenti normativi sull’educazione
interculturale in Italia sono: la c.m. n. 301 dell’8 settembre 198912
e la c.m. n. 205 del 26 luglio 1990.13 Nel secondo, al secondo
comma del VI capitolo, si precisa in che senso debba essere intesa
tale educazione:
L'educazione interculturale -si osserva- avvalora il significato di
democrazia, considerato che la "diversità culturale" va pensata quale
risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle
persone. Pertanto l'obiettivo primario dell'educazione interculturale si
delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un
tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo
l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento
della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di
comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco
arricchimento (ibid.).
Nella circolare ministeriale n. 73 del 2 marzo 199414 si dà
rilievo a un relativismo che porti a considerare la ‘nostra’ cultura
non sempre portatrice di valori positivi, così come nelle ‘altre’
culture. I valori:
consentono di valorizzare le diverse culture, ma insieme ne rivelano i
limiti, le relativizzano, rendendo in tal modo possibile e utile il dialogo
e la creazione della comune disponibilità a superare i propri limiti e a
dare i propri contributi in condizioni di relativa sicurezza (Modesti
2011: 155).
12
Nel docufilm “18 Ius Soli – Il diritto a essere italiani” viene denunciato più volte il
fatto che, per poter partecipare a una semplice escursione scolastica, un alunno figlio
di immigrati, nato in Italia, deve ogni volta fare richiesta dei documenti relativi al
permesso di soggiorno. Più volte si rinuncia alla gita per le lungaggini della burocrazia
finendo, così, discriminati.
13
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm301_89.html (consultato il
14/03/2012).
14
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html (consultato il
14/03/2012).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
93
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
Una delle parole più usate nei processi educativi di
intercultura è il concetto base dell’antropologia: la cultura.
Modesti sottolinea come l’uso di questo termine sia stato in
qualche modo frainteso dagli educatori i quali oscillano “tra la
tendenza a relativizzare le culture, o a renderle invisibili […] e la
tendenza al culturalismo, ovvero alla riduzione della ricchezza
dei percorsi di vita e delle esperienze dei ragazzi ad etichette o
attribuzioni stereotipate” (ivi: 156). Il rischio di riscontrare quindi
casi di razzismo istituzionale (Cozzi 2007; Bartoli 2012) è alto.
Infatti non è raro trovare nei progetti delle scuole dedicati
all’inserimento di alunni stranieri frasi che ricordano le teorie di
Lombroso o il ‘mito del buon selvaggio’. In particolare vorrei
portare come esempio una frase che si trova spesso nei progetti
scolastici15 dedicati all’inclusione e alla scolarizzazione dei Rom,
approvati in alcune scuole. Alla fine di un discorso sulla diversità
tra la ‘nostra’ e la ‘loro’ cultura si legge: “Se ormai essi possono
essere considerati semisedentari o sedentari, il nomadismo
rimane come condizione mentale, sebbene in crisi di identità”.
Innanzitutto è bene precisare che generalizzare sul nomadismo
dei Rom16 è, oltre che fuorviante, pericoloso, in quanto nasconde
un alibi tipico, o quasi, delle istituzioni che hanno a che fare con
questi gruppi. Spesso le culture Rom vengono fatte risalire a uno
stile di vita nomade, anche qualora si parli di persone che vivono
stabilmente in un dato posto, come se si dovessero giustificare
politiche intrise di precarietà e sgomberi forzati perché “tanto
sono Rom”, sono nomadi, ed è nella loro cultura muoversi. Il
voler per forza chiudere un certo gruppo di persone in canoni
15
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm073_94.html (consultato
14/03/2012).
16
http://utenti.quipo.it/Sportello/pgtnomadi.htm (consultato il 14/03/2012).
94
il
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
prestabiliti richiama, a mio parere, comportamenti propri dei
coloni che costringevano gli indigeni a condurre una vita povera
e di miseria, “perché tanto sono selvaggi ed è così che vogliono
vivere”. Altra frase che si può leggere in questi progetti è la
seguente:
Nella comunità zingara la regola non nasce da un accordo comune per
la convivenza, ma da un continuo processo di adattamento a realtà che
mutano. I bambini crescono inventandosi la vita sulla base degli
impulsi, degli istinti, dei bisogni. Appare evidente che l’incontro con la
nostra società e con la scuola sia per loro difficile perché richiede
l’adattamento ad una realtà completamente fondata e strutturata sulle
regole e sul loro rispetto. Il bambino zingaro, quando viene a scuola,
vive questo dualismo.
Insomma, i bambini ‘zingari’ vivono come l’Émile di
Rousseau, vivrebbero senza regole e agiscono solo tramite
l’istinto. Per limitare certi atteggiamenti etnocentrici, che
pongono la “nostra cultura” al di sopra dell’ “altro”, sarebbe
opportuno dare un supporto agli insegnanti tramite mediatori
linguistico-culturali che conoscano le culture di provenienza dei
figli di migranti. Sempre nell’esempio dei Rom, mi è capitato di
notare, durante alcune interviste, che gli alunni rom che sono
stati in classe con certe maestre hanno continuato il loro percorso
di studi anche alle superiori, altri invece arrivano alle medie che
non sanno né leggere né scrivere. Questo dato è imputato da
alcuni insegnanti al fatto che molti colleghi partono dal
presupposto che se un bambino cresce in una data cultura – e
basta leggere la citazione del progetto sulla scolarizzazione dei
rom per rendersene conto – non ha voglia di imparare, è nella
sua ‘indole’ e quindi nella ‘sua’ cultura rifiutare qualsiasi tipo di
insegnamento. La cultura ‘altra’, la sua diversità e i pregiudizi
legati a essa vengono usati come un alibi dalle istituzioni per
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
95
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
ovviare alla loro incapacità, o semplicemente alla loro
noncuranza, nello svolgere il proprio ruolo nella società. La
Scuola, parte di essa, lo fa nel non insegnare, i Comuni nel non
creare spazi di incontro e creare spazi di segregazione.
Anche quando l’obbligo scolastico viene adempiuto, e quasi per un
miracolo la scuola viene completata, rimanendo dentro il ghetto degli
analfabeti si ritorna ad essere analfabeti: l’istruzione da sola non riesce a
strappare da una maniera di vivere – e si rinnega, allora, il poco di
istruzione ricevuto, per potere così, almeno, ritornare a un modo di
essere che aiuta a vivere (Callari Galli – Harrison 1997:74).
L’abitare interculturale
Legato all’accesso alla scuola è il discorso sull’alloggio. Non
solo la scuola deve essere vista come un luogo di incontro e di
dialogo. Anche la città e il vivere e convivere all’interno di essa
svolge un ruolo importante. Se non si può parlare di
segregazione in senso stretto, si può invece parlare di segregazione
policentrica:
che coinvolge un numero maggiore di aree (anche molto piccole) della
città che attraggono un determinato gruppo socio-culturale – è il caso,
ad esempio, dei Pakistani a Prato [Radini, infra] -, ma così presentata,
essa non dà conto delle peculiarità protettive contenute dalla vicinanza
delle reti parentali e amicali di connazionali (Bressan – Tosi Cambini
2011:19).
“L’abitare è una dimensione cruciale della vita in società”
(Vitale – Brembilla 2009: 163) e la condizione abitativa di molti
gruppi zingari influisce sia sulla qualità di vita degli autoctoni
sia degli stessi abitanti dei campi nomadi. La dimora è “il luogo
in cui si apprende a ‘sapersi mantenere in pubblico’ e al tempo
stesso in cui ci si può ‘riposare’ dalla scena pubblica ed è
96
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
nell’abitare che la persona si singolarizza e costituisce la sua
personalità”(ivi: 165). Inoltre, “l’abitare è la palestra in cui si
apprendono le didattiche elementari del vivere insieme” (ibid.).
L’esclusione da un luogo idoneo in cui abitare “conduce a una
spersonalizzazione e a un’umiliazione dell’individuo stesso”
(ibid.) e ciò avviene soprattutto in quei casi di precarietà abitativa
propria delle tante baraccopoli che si sono sviluppate nelle
periferie delle città. Nel raccontare una delle sue prime
esperienze con i Rom, Leonardo Piasere racconta della ricerca di
un posto in cui accamparsi:
Ma una volta trovatone uno ritenuto idoneo (…), il permesso veniva
puntualmente rifiutato da chi di competenza adducendo motivi igienici.
Per quello strano modo di procedere del cervello umano noto come
“inversione”, lo zingaro che voleva allontanarsi dalle discariche altrui si
sentiva negare uno spazio, perché accusato di essere una discarica
ambulante. Ironia della sorte (…) in quei rari casi in cui veniva concessa
la sosta in luoghi indicati da chi di competenza, succedeva che quei
luoghi erano giusto privi di un punto d‟ acqua potabile (Piasere 1991:
182).
La soluzione che in Italia viene attuata maggiormente è quella
che prevede la costruzione dei campi: “L’allestimento, in
positivo o in negativo, dei campi-sosta è dettato da motivi di
ordine protezionistico verso i centri rituali o i centri abitati in
genere ed è una forma di quello che Liégeois (1987a) ha chiamato
‘rigetto indiretto’” (Piasere 1991: 193).
Loin de la Constitution, loin des réglementations protectrices, loin des
institutions nationales et de leurs discours théoriques, c’est avec une
réalité locale bien concrète – populations, collectivités, pouvoirs locaux
– que doit quotidiennement composer le Rom. Un souci prioritaire est
de trouver le meilleur compromis possible en matière de logement, qui
permette de continuer à mener une vie sociale cohérente et d’exercer
des activités économiques en évitant d’être l’objet trop marqué du rejet
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
97
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
de son entourage (Liégeois 2007: 145)
Si concedono i campi sosta per tutelare i rom, poi, con i campi,
ci si tutela dai rom (Todesco 2004: 103).
Giorgio Agamben in Homo sacer afferma che il campo è diventato “il
paradigma biopolitico dell’occidente” ed evidenzia, in modo
convincente, come il campo sia lo spazio che si apre quando lo stato di
eccezione comincia a diventare la regola intendendo come stato di
eccezione una zona di in distinzione fra esterno e interno, tra esclusione
ed inclusione (ibid.)
Il campo diventa il simbolo dell’ambiguità delle politiche di
tutela che si dividono tra assistenzialismo e ghettizzazione. I
campi producono alterità e diventano “un ottimo strumento per
destrutturare e ricostruire l’identità rom da parte dei non-rom. E
quindi per ricostruire l’identità non-zingara” (ivi: 104). La scelta
del campo è, quindi, prettamente politica. Ogni qualvolta si parli
di alloggi per i Rom si scatenano tensioni e conflitti i quali
potrebbero emergere anche dalla probabile installazione di
campi sosta. Nascono comitati contro la presenza zingara nelle
città in quanto il loro stile di vita potrebbe intaccare alla
sicurezza dei quartieri vicini. Questa segregazione e questo
rifiuto hanno portato i rom a instaurare un meccanismo di autosegregazione e alla creazione dei rapporti con i gage (19)
strettamente strumentali (Vitale – Brembilla 2009: 166).
Ciò che emerge è sempre il discorso sulla sicurezza e
l’emergenza quotidiana. Vari fatti di cronaca lo dimostrano,
come, ad esempio, il pogrom di Torino (20). Nel Rapporto Il paese
dei campi. La segregazione razziale dei Rom in Italia, pubblicato
dall’European Roma Rights Center nel 2000, si denunciano molte
situazioni di degrado e di razzismo contro i Rom da parte delle
forze politiche, della stampa e dell’opinione pubblica:
98
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
La separazione fisica tra Rom e non Rom in Italia è tanto forte da
lasciare quasi in ombra tutti gli altri aspetti. Molte altre questioni legate
ai diritti umani prenderebbero altre proporzioni se i Rom non fossero
ghettizzati nei campi autorizzati o completamente esclusi da qualsiasi
altra decente soluzione abitativa. Gli abusi commessi durante le
sistematiche azioni di polizia sarebbero inconcepibili senza la
vulnerabilità derivante dall’indecenza della vita nei campi. La
discussione sul diritto all’educazione sarebbe ben diversa se la
frequenza dei bambini non fosse ostacolata dalla separazione fisica
dagli istituti scolastici. Tuttavia, la condizione estrema di segregazione
dei Rom in Italia, che non si limita alla presenza di un recinto e di un
guardiano, ha forse messo in ombra gli altri problemi con cui si
confrontano i Rom. Messe da parte le drammatiche insidie della
segregazione, il nocciolo della questione emerge in primo piano:
razzismo e discriminazione a sfondo etnico (ERRC 2000).
Tutti questi aspetti sono stati spesso oggetto di denuncia da
parte di organizzazioni internazionali e della stessa Unione
Europea, in particolare per quanto riguardo la politica degli
sgomberi. La segregazione è innanzitutto un processo che causa
tre tipi di meccanismi: concentrazione spaziale di disagio e degli
svantaggi sociali; separazione spaziale del contesto abitativo del
gruppo considerato; svalutazione della rendita immobiliare nel
contesto abitativo (Vitale – Brembilla 2009: 168). La segregazione
viene poi mantenuta da altri meccanismi: la stigmatizzazione nella
sfera mediatica; la diseguaglianza di istruzione; la diffusione di
un’economia informale (ibid.). L’insieme di tutti questi meccanismi
ha contribuito al mantenimento dello status di segregazione e:
Se è vero che alcune istituzioni totali separano i propri abitanti dal
flusso della socialità urbana, è pur vero che il campo nomadi è l’unico
dispositivo di azione pubblica residenziale che ha riprodotto i suoi
svantaggi di generazione in generazione, cumulando effetti sempre più
negativi sulle coorti dei più giovani (ivi: 168-169).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
99
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
La segregazione produce, in chi la subisce, un rafforzamento
dell’identità e dell’appartenenza al gruppo e delle forme di
socialità nel campo. Di contro si ha la creazione di un confine più
forte noi/loro, confine simbolico-identitario che produce “nel
rapporto con l’esterno un forte senso di alterità che risale in
generalità in termini di ingiustizia, come sentimento di
discriminazione misto a molto fatalismo” (ibid.). Anche in
situazioni di convivenza pacifica l’esclusione urbana è causa di
deficit nei rapporti, nella partecipazione alla vita cittadina e al
raggiungimento delle scuole e degli uffici. Ci sono due frasi,
ascoltate durante la mia ricerca, che sintetizzano in maniera
chiara questo rapporto di tolleranza, più che rispetto da parte dei
gagè, e del rapporto di rassegnazione e, contemporaneamente, di
giustificazione all’esclusione e all’autoesclusione. Una è di un
gagè che, all’inaugurazione di un villaggio rom disse “Ormai ce li
abbiamo e li dobbiamo tenere”. L’altra è di una ragazza rom che,
parlando di campi, di razzismo, mi disse “Siamo zingari”, tra
rassegnazione e giustificazione.
Conclusioni
Se da una parte dalle istituzioni persistono manifestazioni di
razzismo, di diffidenza e vera e propria fobia, dall’altra esistono
comunque sforzi per abbattere le barriere sia mentali che fisiche –
lotta culturale al razzismo e sensibilizzazione per superare l’idea
del campo. Esistono sia fondi europei per l’inclusione dei Rom
che nazionali o regionali, come la legge regionale 9/88,
cosiddetta legge “Tiziana”(Melis 1995:177) ma, secondo quanto
denuncia Spinelli,
i politici fanno credere all’opinione pubblica che essa (l’integrazione)
passa attraverso le tasche degli italiani. Assurdo. Pur esistendo
associazioni e intellettuali delle comunità romanès, non vengono né
100
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
interpellati né coinvolti nelle questioni che li riguardano (…). Un
esempio concreto riferito a Ziganopoli: al settore scolastico sono stati
destinati, negli ultimi decenni, ingenti finanziamenti di cui i bambini e i
ragazzi appartenenti alle comunità rom non hanno visto benefici,
perlomeno non pari ai mezzi impiegati (Spinelli 2012:145).
Bibliografia
A IME M.
2009
La macchia della razza. Lettera alle vittime della paura e dell’intolleranza,
Milano, Adriano Salani Editore.
2009
Una bella differenza. Alla scoperta della diversità nel mondo, Torino,
Einaudi.
A IME M. – SEVERINO E.
2009
Il diverso come icona del male, Torino, Bollati Boringhieri.
A NGIONI G.
2012a Fare, dire, sentire. L’identico e il diverso nelle culture, Nuoro, Il Maestrale.
2012b “Il mondo è dei bastardi Nei percorsi dei migranti le vie del nostro futuro”, in
La
Nuova
Sardegna,
consultato
il
14/01/2012
su
http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2012/01/14/news/ilmondo-e-dei-bastardi-nei-percorsi-dei-migranti-le-vie-del-nostrofuturo-1.3637708
BALBONI P.
1999
Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale,
Venezia, Marsilio.
BARBUJANI G. – CHELI P.
2008
Sono razzista, ma sto cercando di smettere, Roma-Bari, Laterza.
BARTH F.
1969
Ethnic Groups and Boundaries, consultato il 14/03/2012 su
http://www.bylany.com/kvetina/kvetina_etnoarcheologie/literatur
a_eseje/2_literatura.pdf
BARTHES R.,
1979
Frammenti di un discorso amoroso, Torino, Einaudi.
BINDI L. – FAEDDA B.
2001 Luoghi di frontiera: antropologia delle mediazioni, Cagliari, Punto di Fuga.
BRESSAN M. – TOSI CAMBINI S.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
101
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
2011
Zone di transizione. Etnografia urbana nei quartieri e nello spazio pubblico,
Bologna, Il Mulino.
CALLARI GALLI M. – HARRISON G.
1997
Né leggere, né scrivere, Roma, Meltemi.
COLOMBO A. – GENOVESE A. – CANEVARO A. (a cura di)
2005
Educarsi all’interculturalità. Immigrazione e integrazione dentro e fuori la
scuola, Gardolo (TN), Erickson.
DEI F.
2010
Introduzione all’antropologia culturale: strumenti metodi, campi di ricerca
consultato il 15/03/2012 su
http://www.fareantropologia.it/sitoweb/index.php
DEI F. (a cura di)
2005
Antropologia della violenza, Roma, Meltemi.
EURRC
2000
Il paese dei campi: la segregazione razziale dei Rom in Italia, Roma,
European Roma Rights Center.
FABIETTI U. – REMOTTI F.,
2001
Dizionario di antropologia: etnologia, antropologia culturale, antropologia
sociale, Torino, Zanichelli.
FAVARO G.
2011
A scuola nessuno è straniero. Insegnare e apprendere nella scuola
multiculturale, Firenze, Giunti.
LEGHISSA G.
2005
Il gioco dell’identità: differenza, alterità, rappresentazione, Milano,
Mimesis.
LIEGEOIS.
2007
Roms en Europe, Strasburgo, Editions du Conseil de l’Europe.
KARLI P.
1990
L’uomo aggressivo, Milano, Jaca Book.
M ARTIN M.C.
2010
La scuola: un cantiere per l’intercultura. Lo “straniero” nell’immaginario dei
bambini, Vimodrone (MI), IMOC.
M ODESTI M.
2011
“I figli dei migranti e i diritti umani”, in Antropologia e diritti umani nel
mondo contemporaneo, a cura di V. Maher, Torino, Rosenberg & Sellier,
pp 149-162.
M ELIS A.
1995
La terza metà del cielo, Cagliari, Gia Editrice.
102
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Mura V., La produzione dell’altro e l’educazione al confronto.
M EMMI A.,
1999
Il razzismo. Paura dell’altro e diritti della differenza, Ancona-Milano,
Costa & Nolan.
PASQUALOTTO G.
2003
East & West. Identità e dialogo interculturale, Venezia, Marsilio.
PIASERE L.
1991
Popoli delle discariche: saggi di antropologia zingara, Roma, CISU.
2011 La stirpe di Cus, Roma, CISU.
PUGLIESE E.
2006
L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, Il
Mulino.
S IGNORELLI A.
2006
Migrazioni e incontri etnografici, Palermo, Sellerio.
S PINELLI S. A.
2012
Rom, genti libere, Milano, Dalai Editore.
TODESCO D.
2004
“Le maschere dei pregiudizi. L’innocenza perduta dei pregiudizi positivi.
Una categoria esemplare: gli zingari”, in Quaderno di Servizio Migranti,.
47.
VITALE T. (a cura di)
2009
Politiche possibili - Abitare le città con i rom e i sinti, Roma, Carocci.
WIEVIORKA M.
2000
Il razzismo, Roma-Bari, Laterza.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
103
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
Emiliano Branca
Charivari. Condanna e repressione.
Abstract
In this article I will analyze the reasons and methods of punishment of the practice of
social derision known as Charivari. The Church first, and then the civil authorities,
have undertaken since the fifteenth century, work of condemnation and repression of
the charivari and other forms of popular culture, following the new climate of the
Counter which has changed deeply religious piety.
Key words
Charivari, cultura popolare, storia sociale, Chiesa, Controriforma.
Le repressioni ecclesiastiche nei testi sinodali (XIV – XV secolo)
A differenza delle autorità civili, la Chiesa per prima si è
mobilitata nel condannare le pratiche di charivari.1 Attraverso le
testimonianze dei testi sinodali, è possibile ripercorrere le
evoluzioni delle denunce e delle repressioni, attuate dalle
autorità ecclesiastiche, ai danni di un rituale che doveva
rappresentare l'espressione più diretta del controllo e del
mantenimento dell'ordine sociale.
François Lebrun, in un suo studio (1977) afferma che lo
1
Rituale caratterizzato da frastuoni, urla e baccano che si svolgeva in tutta Europa,
solitamente, in occasione di matrimoni male assortiti o non accettati dalla comunità. Il
rito veniva sempre accompagnato da una musica assordante, provocata da strumenti
quali pentole, piatti, campane, carabattole. Il rumore provocato da tali utensili doveva
rappresentare una sorta di "serenata alla rovescia". Lo charivari, infatti, deve essere
letto sotto un'ottica carnevalesca, come un momento di extra – ordinarietà, in cui il
caos e il disordine sovrastano il cosmos e l'ordine.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
105
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
charivari, in Francia, ha conosciuto due forti ondate di
repressione, diverse tra loro per motivi e contesto storico. La
prima ondata avviene intorno alla prima metà del XIV secolo e la
metà del XV secolo, la seconda dal XVII al XVIII secolo. L’autore
elenca alcuni testi sinodali in cui è presente la condanna di
questo rituale: Lione (1321-1326), Reims (1328-1330), Avignone
(1337).
Il primo problema che si incontra riguarda proprio
l’apparizione del termine charivari; attraverso lo studio di questi
documenti è necessario domandarsi se l’apparizione del termine
possa coincidere con quella del rituale in sé.
Lebrun avanza una tesi piuttosto cauta su questo tema. I testi
sinodali appartenenti alla ‘prima ondata di repressione’ si
differenziano inoltre per la denominazione della pratica vietata.
Aux XIV e XV siècles, les termes latins et français varient quelque peu:
charavaria (Lyon, 1321-1326); chalvaricum et charivarit (Avignon, 1337);
charivari (Meaux, 1365); charavallium (Bourges, 1368); charivari et
chelevalet (Tréguier, 1365); charwary (Troyes, 1399); charivari (Langres,
1404); chalvaritum (Avignon 1437) […] Par contre, les statuts synodaux
du XVII siècle emploient tous, sans exception, le mot charivari (Ivi: 222).
Tuttavia le denunce che appaiono nei testi del XIV secolo non
condannano lo charivari in quanto tale, ma la sua carica troppo
gioiosa e vitale, che troppo spesso sfocia in atti vandalici e
degenera in violenze.
Attraverso la lettura di alcuni testi della fine del Medioevo è
possibile scorgere il motivo di queste repressioni: nello statuto di
Troyes del 1399, lo charivari viene considerato un “ludus turpis et
noxius”, mentre in quello di Tréguier del 1365 vengono elencate
le conseguenze che comporta il rituale, “ex quibus frequenter
proveniunt rancores et odia, interdum quoque vulnerationes et
homicidia eveniunt”, e continua con lo statuto di Tours del 1431,
106
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
“mutilationes et homicidia sunt secuta”.
È necessario ricordare che nei testi sinodali della fine del
Medio Evo lo charivari appare legato solamente alle celebrazioni
delle seconde nozze; nonostante questo rituale venisse
condannato nello stesso paragrafo in cui erano presenti altri
abusi – canzoni oscene in chiesa, rumori assordanti, disordini o la
celebrazione del rito del ‘vino degli sposi’ 2 – lo charivari non
veniva confuso con essi, ma anzi, conservava uno suo stretto
significato.
Differentemente, nei testi sinodali del XVII secolo, la sua
valenza semantica si estende ricoprendo anche tutti gli altri abusi
precedentemente elencati. Jean-Baptiste Thièrs, nel suo “Traité
des joux” considera lo charivari in questa maniera:
La canaille et le gens de nulle importance se font quelquefois un grand
divertissement de ce qu'ils appellent charevaris, charivaris ou charibaris,
afin de tirer quelque somme d'argent des nouveaux mariés ou de les
charger de confusion. Il y a des lieux où cela ne se fait guère qu'à de
secondes noces disproportionnées en effet ou en apparence. Mais il y en
a d'autres où il se fait presque à toutes les noces (Burguière 1977: 187).
L'atteggiamento che porta i testi sinodali ad assimilare in un
unico contesto alcuni rituali, solo perché caratterizzati da rumori
e frastuoni, è finalizzato al coronamento di un'opera di
designificazione «che dovrebbe privare il rito dei suoi elementi di
aggressività e della sua funzione di destabilizzazione» (Avanzi
2000: 178). Una preziosa testimonianza di tale concezione è
offerta dai sinodi di Reggio Emilia del 1665 e del 1697 (Ibidem:
176-177).
Le vin du mariage era un rito propiziatorio celebrato durante i matrimoni. La
gioventù della comunità in cambio di un pagamento da parte degli sposi
interrompeva lo charivari.
2
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
107
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
Nel XV secolo la sopravvivenza del rituale veniva garantita
dal contesto socio-culturale delle città episcopali, le quali “avec
leur nombreuse population de clercs migrants ont servi de
creuset au XV siècle à la culture carnevalesque et joyeuse” (Ivi:
180); in un simile ambiente in cui vigeva una sorta di sub-cultura
giovanile, le manifestazioni di ribellione sia culturale che
simbolica avevano una determinata funzione: le varie feste che
vedevano come protagonisti i giovani servivano per allentare e
regolare le tensioni in un ambiente come quello delle città
episcopali, popolato da baccellieri e da chierici vaganti, molto
spesso giovani provenienti da altre città, per poi integrarli nella
vita sociale.
Ma se da una parte queste festività venivano accettate,
dall’altra si vietavano
les cérémonies qui avaient le plus de chances de dégénérer en violences
ou qui insultaient les sacrements. La première vague de répression
contre le charivari découle de cette politique de tolérance sélective face à
l'activisme frondeur des jeunes et aux pratiques carnevalesques (Ivi:
181-182).
Le repressioni ecclesiastiche nell'ambito della Controriforma
Come si è detto precedentemente, François Lebrun data la
seconda ondata di repressione tra il XVII e il XVIII secolo. André
Burguière precisa la datazione indicando gli anni esatti l'uscita
degli statuti sinodali:
Dix statuts synodaux ou mandements épiscopaux le condamnent entre
1640 et 1699: il s’agit de ceux de Saint-Omer en 1640, Beauvais 1646,
Châlons-sur-Marne 1657, Mâcon 1659, Amiens 1662, Beauvais 1669,
Noyon 1673, Troyes 1680, Amiens 1696, Beauvais 1699 (Ivi: 180).
108
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
Non a caso questa nuova ondata di denunce e di condanne nei
confronti dello charivari si innesta nel clima socio-culturale e
politico post-tridentino e della Controriforma.
Le ‘nuove’ condanne si differenziano da quelle ‘vecchie’ per
un mutamento di significato dello stesso rituale. Lo charivari, dal
XVI secolo, non viene più condannato esclusivamente per il suo
carattere indecente, ma perché viene considerato eretico.
Questo cambiamento di percezione del rituale cammina di
pari passo con una rivalutazione totale dei divertimenti e degli
svaghi popolari. Sono due gli elementi, entrambi figli del regime
culturale post-tridentino, che hanno contribuito alla nascita di
una nuova repressione nei confronti dello charivari: “une
nouvelle conception de la piété, retenue, sérieuse, austère”
(Ibidem) e la riaffermazione da parte della Chiesa della validità
delle seconde nozze, argomento di cui parleremo
successivamente.
Per quanto riguarda il primo elemento, la Chiesa, attraverso
l’impresa della Riforma, ha voluto imporre un nuovo tipo di
pietà austera e pudica, che garantisse la sottomissione del fedele
al magistero ecclesiastico. Si scorge una rottura tra la vecchia
devozione medievale – una devozione in cui convivevano sacro e
profano, gioia e pianto, elementi pre-cristiani e retaggi del
paganesimo – e la nuova devozione post-tridentina, purificata da
tutti gli eccessi e regolata secondo i dettami del nuovo ordine
vigente. Lo charivari, trattandosi di un rituale strettamente legato
a delle pratiche sia di svago che di controllo popolari e
carnevalesche, venne inevitabilmente preso di mira. Una
testimonianza relativa al clima di repressione generalizzata viene
offerta da un'ingiunzione di Monsignor de Clermont, vescovo di
Laon, piccolo centro della Piccardia, nel 1696
Nous voulons qu’il soit épuré dans notre diocèse de cette pompe et de
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
109
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
cet appareil profane que les payens avaient coutûme d’y employer: et à
cet effet, nous défendons de conduire les futurs époux au son des
violons à l’Église, soit pour les fiançailles, soit pour le mariage, même
de sonner aux fiançailles, comme aussi tout ce qui s'appelle bienvenues, bouquets et autres semblables appareils qui ressentent l'esprit
du paganisme (Ivi: 189).
Nei testi sinodali appartenenti alla ‘seconda ondata’ di
repressione è sempre presente l’intento di bandire e di eliminare
tutti i comportamenti gioiosi della devozione popolare. Il divieto
non si fermava solamente alla musica in chiesa o al rumore
assordante tipico dello charivari, ma si estendeva addirittura a
“les déguisements et actions indécentes contraires à l'honneur
des temples et à la sainteté de ce sacrament» (Soissons, 1673); «les
chansons déshonnêtes, danses dissolues” (Chalons-sur-Marne,
1657) (Ibid.).
Peter Burke, a proposito di questo periodo parla di una
“riforma della cultura popolare” (Burke 1980: 204), caratterizzata
da un rigido controllo sistematico dei comportamenti collettivi
ed individuali. Non è un caso, tuttavia, che tra i secoli XVI – XVII
vennero pubblicati i catechismi, i galatei, i trattati di buona
creanza (Elias:1980) L'élite culturale, rappresentata dalla Chiesa,
operava una pressione culturale ed educativa finalizzata a
‘migliorare’ gli atteggiamenti, i valori, le dimostrazioni di fede
della popolazione. Affinché ciò potesse avvenire era necessario
mettere fuori legge alcuni comportamenti giudicati sovversivi e
pericolosi per il mantenimento e per la conservazione del nuovo
sistema; infatti “una lista completa raggiungerebbe davvero
proporzioni enormi, ma anche un elenco riassuntivo dovrebbe
comprendere: attori, ballate, burattini, carte da gioco, charivari
[...]” (Ivi:204).
Perché la cultura popolare faceva così tanto paura ai
riformatori? Qual era il motivo di tutta questa repressione? Sia i
110
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
cattolici che i protestanti avanzavano due tipi di condanne, una
sul piano teologico, l’altra sul piano morale.
Su un piano prevalentemente teologico, Erasmo da Rotterdam
considerava il carnevale non-cristiano “perché contiene «tracce
dell'antico paganesimo» (veteris paganismi vestigia); [e inoltre]
perché in tale occasione «il popolo indulge eccessivamente alla
licenza» (populus... nimium indulget licentiae)” (Ivi: 205),
L’arcivescovo di Milano, San Carlo Borromeo paragonava il
carnevale ai Bacchanalia, e gli spettacoli teatrali a delle pratiche
sataniche. Addirittura, i protestanti tacciarono alcune pratiche
cattoliche come retaggi pagani e pre-cristiani, “paragonando il
culto della Madonna a quello di Venere e facendo dei Santi i
successori degli dei e eroi pagani” (Ibidem).
Da un punto di vista prettamente morale, le feste
incoraggiavano il ‘mondo al rovescio’, il libertinaggio, la
fornicazione, i piaceri della carne, l'ebbrezza, l'ingordigia. Le
danze e i canti avevano una simbologia legata all’atto sessuale, i
pali di maggio3 e gli alberi della cuccagna erano visti come un
simbolo fallico.
Gli aspetti legati al controllo della sfera sessuale avevano una
notevole importanza nelle condanne degli charivaris. Come
riporta Fincardi:
Poco prima della Rivoluzione Francese, secondo l'erudito rettore di una
minuscola parrocchia rurale posta tra Lucca e Pisa, Bartolomeo Napoli,
proprio questo incentivo che le scampanate offrono al popolo a
elaborare narrazioni sboccate della vita privata delle persone,
costituirebbe il loro aspetto più diseducativo, riprovevole per inciviltà.
In occitano ramade, palo infiorato posto dai ragazzi del paese la notte del 30
aprile davanti alle finestre delle "ragazze da marito"; ogni albero veniva
addobbato in maniera differente, il codice vegetale rendeva pubblica la
condotta di ogni ragazza.
3
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
111
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
Rimasta propria di culture marginali, tale creatività risulta deviante dai
principi etici a cui si attingono ormai le moderne istituzioni civili e
religiose del XVIII secolo (Fincardi 2008: 140).
L'aspra critica che don Bartolomeo Napoli muove nei
confronti del rituale definito da egli «una musicaccia concertata
di campanacci, bigongi, nicchi […] e in uno di voci sgraziate, e di
schiamazzi» (Ivi: 141) denuncia i pericolosi effetti che i versi
lascivi, con espliciti riferimenti sessuali, possono sortire nelle
giovani donne e nei giovani uomini non ancora in età da marito:
Pensate poi che sarà di que' giovanetti, che già hanno mutato
temperamento di flemmatico in sanguigno, e sieno pure informati di
tali cose, ma non ancora tocchi dal fuoco! O dal fumo della lascivia; o
per un'indole più felice, che abbian sortito dalla nascita, o per una
educazione e cura più attenta, che abbian ricevuto dai genitori! Gran
pericolo vi ha da temersi, che eglino là correndo fra tanti tizzoni accesi,
e sfavillanti di impurissima fiamma non se gli attacchi in mal punto
l'ardore pruriginoso e l'ancor chiusa concupiscenza non allarghi il seno
e attragga la vampa (Ivi: 144).
Le condanne legate allo charivari sono una conseguenza di
questo clima repressivo. Se i protestanti, attraverso la nuova etica
nascente basata sull'autocontrollo, la sobrietà, il lavoro e la
parsimonia – ‘ascesi intramondana’ (innerweltliche Askese),
secondo un termine di Max Weber (1965) – cercavano di educare
i loro fedeli, contrastando la Chiesa di Roma, i cattolici cercavano
di non essere da meno, facendo fronte alle eresie regolamentando
i comportamenti religiosi e non, al fine di reprimere qualsiasi
tipo di condotta che non rispondesse ai codici della nuova pietà.
Negli atti del Concilio di Trento si parla proprio del divieto di
entrare in chiesa ubriachi in occasione delle feste dei santi:
Né la celebrazione dei Santi [né] la visita alle reliquie [deve] essere
112
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
degradata dalla gente a baldorie e ubriachezza, come se le feste in onore
dei Santi dovessero venire celebrate con bagordi e senza il benché
minimo senso della decenza (Burke 1980: 215).
Le seconde nozze
Un ulteriore elemento che costituisce la ‘seconda ondata’ di
repressioni nei confronti dello charivari è il nuovo atteggiamento
che la Chiesa ha verso le seconde nozze. Il remariage era una delle
cause maggiormente scatenanti uno charivari.
Sin dal Concilio di Compiègne, nel 1329, le autorità
ecclesiastiche hanno riconosciuto la stessa solennità delle prime
nozze ai vedovi che si risposano; un comportamento insolito se si
pensa che
La Chiesa ha per lungo tempo privato di qualsiasi solennità le seconde
nozze. Innanzitutto poiché l’imparentamento per via di matrimonio
sopravvive alla vedovanza, un insieme di rapporti pratici e senz’altro
banali – fino alla quarta generazione canonica – finivano
nell'immoralità. In seguito, il personaggio della vedova ha assunto negli
scritti dei moralisti, connotati sospetti, che la rendono subito ambigua e
scarsamente frequentabile (Fabre 1993: 445).
Nel XVI secolo le seconde nozze diventano totalmente
legittime. Negli statuti sinodali del 1577, l'arcivescovo di Lione,
Monsignor Depinac, dichiara la piena libertà, sia per gli uomini
che per le donne di risposarsi nel nome di Dio:
Jaçoit que de l’avis de l’Apôtre et par disposition du Droit et
constitutions canoniques, déclare Monseigneur Depinac, archevêque de
Lyon dans les statuts synodaux de 1577, il soit loisible à la femme, après
la mort de son mari, se marier au nom de Dieu, et reciproquement à
l’homme après la mort de sa femme (Burguière 1977: 187-188).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
113
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
Tuttavia l’‘apertura’ della Chiesa nei confronti di un secondo
matrimonio non deve essere letta come una sorta di
liberalizzazione. Continuava ad esistere, sia nel diritto canonico
che in quello civile, una certa ostilità nei confronti della figura
della vedova, la quale era obbligata a mantenere un
comportamento rigidamente controllato intra tempus luctus.
Ma l'opinione che prevalse, sia nell'ultima metà del sec. XV, sia ancora
nei secoli susseguenti, presso i commentatori così del diritto canonico
che del diritto civile di ogni paese […] fu quella che dovessero
intendersi corrette dal diritto canonico, e per ogni caso, tutte le pene
legali per la vedova che passasse a seconde nozze entro l'anno del lutto,
perché introdotte in favore dei figli, e di regola, neppure quelle stabilite
contro la donna che avesse entro l'anno del lutto menato vita lussuriosa
(Fadda 1906: 141-143).
A questo punto è necessario domandarsi i motivi che hanno
spinto la Chiesa a modificare il loro atteggiamento verso le
seconde nozze. In primo luogo i testi sinodali del periodo della
Controriforma erano finalizzati non solo a censurare e a
condannare determinati comportamenti e rituali, ma anche a
regolamentare la vita religiosa e i sacramenti. Il matrimonio
doveva essere salvaguardato sia sul piano religioso che su quello
sociale. Rendendo valido il remariage, la Chiesa cercava di
arginare possibili motivi di disordini popolari: “il matrimonio
era un modo per prevenire una nascita illegittima o per porre
fine a un grave disordine pubblico come nel caso del
concubinato” (Fauve-Chamoux 2002: 326). Le seconde nozze di
un vedovo, o di una vedova erano, infatti, mal accettati dai
‘vicini’ nella misura in cui perturbavano l'equilibrio
matrimoniale della comunità e potevano suscitare diverse
tensioni.
Il rifiuto di accordare la benedizione alle seconde nozze
114
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
svalutava la cerimonia e la sua sacralità e, agli occhi dei profani
rendeva incerta l’indissolubilità del rito. In questa maniera, la
Chiesa non possedeva più il comando sul sacramento, divenuto
oramai di dominio popolare, per cui:
L’assouplissement de la position de l’Église sur ce problème de la
bénédiction des remariages est dû pour une grande part à la persistance
des désordres que les autorités ecclésiastiques voulaient supprimer. En
refusant la bénediction nuptiale aux remariages, l’Église donnait malgré
elle une forme de légitimité à la méfiance populaire... et au charivari
(Burguière 1977: 191).
In tale contesto, lo charivari svolge, dunque, un ruolo
estremamente importante: laddove il rituale ecclesiastico non
garantiva una consacrazione completa, l’accompagnamento
popolare – con il suo rumore dissonante, i suoi mascheramenti, i
balli dissoluti, le disarmonie gestuali e sonore, le simbologie –
donava al matrimonio un sostegno magico. Secondo
l’interpretazione di Lévi-Strauss (1966), il rumore rituale – lo
stesso che si usava celebrare durante le eclissi di sole – serviva ad
esorcizzare una rottura pericolosa e conflittuale del normale
equilibrio della comunità. Tuttavia, questa interpretazione di
Lévi-Strauss non è esente da critiche, uno dei suoi limiti è quello
di compiere: “un’analisi formale, da cui deduce la funzione,
definita una volta per tutte dello charivari” (Ginzburg 1982: 164).
A tal proposito E.P. Thompson muove una serie di critiche nei
suoi confronti. Lo storico inglese dà importanza non tanto alla
forma quanto alla funzione del rituale, determinate dal contesto
sociale:
Se lo charivari cacciava dal villaggio le persone contro cui era rivolto, se
la sua semplice minaccia era sufficiente ad impedire certi
comportamenti, e affermava in maniera manifesta un sistema di valori,
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
115
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
non abbiamo bisogno di andare oltre alla ricerca di un significato.
Saremo più fedeli ai significati che gli stessi partecipanti attribuivano
coscientemente ai loro atti; spingersi oltre, alla ricerca di un significato
più profondo, finisce per diminuire la razionalità e la statura morale dei
protagonisti , per sottovalutare la consapevolezza e la determinazione
delle persone illetterate (Thompson 1981: 157).
Lo charivari, attraverso la denuncia e la sanzione del
comportamento svolgeva l’ambivalente funzione di punire il
matrimonio ma anche di legittimarlo. A tal proposito, si cita un
testo sinodale in cui si menziona
Le paiement d'une somme d'argent dont devaient s'acquitter les
victimes d'un charivari. Les statuts d'Odet de Châtillon, comte-évêque
de Beauvais (1554) ordonnent «ut ab eis abstineant, ab eisdem conjugibus (il
s'agit des mariés qui sont victimes de charivaris) pecunias aut aliud
quovis modo extorqueant (Ivi: 380).4
La pratica di estorcere denaro alle vittime di uno charivari era
conosciuta in Francia come le vin de mariage. I vedovi che si
risposavano dovevano pagare una ‘multa’ per risarcire il corpo
sociale leso, attraverso il pagamento avveniva il ‘ristabilimento’
dell'ordine e la ‘normalizzazione’ della coppia. Ma ormai il clima
controriformistico ha provocato una frattura irreversibile nello
stesso charivari: la pressanti denunce, le sanzioni, le condanne e le
sistematiche repressioni attuate dalla Chiesa, hanno mutato la
natura stessa del rito, avendo, quest’ultimo perso la sua funzione
pseudo-sacramentale e acquisito un significato di censura e di
Lévi-Strauss (1966) ha avanzato una tesi nella quale ritiene che lo charivari
era rivolto solo ed esclusivamente nei confronti dei matrimoni non accettati
dalla comunità, e connetteva il rumore rituale del rito al rumore – altrettanto
rituale – che molte società compivano quando si manifestava un'eclissi. Per la
critica a Lévi-Strauss cfr. E. P. Thompson, Rough music: lo charivari inglese.
4
116
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
denuncia.
Le contexte même de la répression qui devient avec la réforme
catholique de plus en plus globale et normative, l’incitait à devenir
contestataire et rebelle comme tous les autres rites populaires associés
au mariage avec lesquels on le confond et auxquels il communique ses
moyens d’expression. Parallèlement, il tendait à rationaliser son
discours et à s’enfermer dans une conduite justicière. Comme l’ont fort
bien montré Natalie Z. Davis et Jacques Rossiaud, les groupes de
jeunes, les institutions de classe d’âge, promoteurs en milieu urbain à la
fin du XV siècle et au début du XVI siècle d’une activité carnavelesque
qui canalise les tensions et freine la marginalisation des nouveaux
adultes... ou des nouveaux venus, ont contribué à charger le charivari
d’une agressivité dénonciatrice (Ibid.).
In questa maniera lo charivari allarga il suo campo, prima
delimitato quasi del tutto alle questioni matrimoniali, per
estendersi alle questioni morali, sociali e politiche.
Lo stato contro lo charivari
Come afferma Yves Marie Bercé (1985) nel suo libro Fête et
revolte le autorità civili affrontarono la questione dello charivari e
degli altri rituali di derisione in un secondo momento rispetto
alla Chiesa. Gli interventi statali si verificavano solo in occasione
di episodi sanguinosi, di risse e di omicidi.5
A Reggio Emilia nel 1502 vengono redatti gli statuti della
comunità i quali vietavano le celebrazioni notturne delle
matutinatae. Se le autorità ecclesiastiche condannavano certi usi
sia di giorno che di notte, quelle civili ponevano maggiore
attenzione alle pratiche notturne poiché potevano costituire un
Torino è stata la prima città in Italia ad adottare misure contro lo charivari.
L'ordinanza del governo è del 1343.
5
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
117
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
attento all'ordine pubblico maggiore. Il testo dello statuto spiega
le pene da infliggere ai trasgressori:
Prohibemus per aliquem decaetero noctis tempore, fieri matutinatam,
cum aliquo sono, sive instrumento cuiuscumque generis, vel cum voce,
aut aliter, ante dominum, velfores alicuius: sub poena librarum quinque
Communi Regii applicanda, pro quolibet ed qualibet vice: et in totidem,
ei, qui hanc iniuriam sibi factam esse fuerit conquestus: cuius
conquerentis sacramento credi omnino volumus, de personis in dicta
matutinata existentibus, qui cas viderit et cognoverit. Et liceeat Militi et
familiac Domini Potestatis, vel Capitaneo plateae, eas invenientibus,
auferre eis delinquentibus omnia instrumenta sonatoria, ipsorum lucro
cessura. Et haec etiam locum habeant in illis matutinatis, quae senibus
nubentibus et viduis fieri consuevere: cum poena librarum decem,
Communi Regii applicando pro quolibet, et qualibet vice, contra quos
contrafacientes Dominus Potestas Regii possit procedere, etiam ex
officio et prout sibi videbitur (Avanzi 2000: 184).
Risentendo sempre del clima controriformistico, alcune città
della Francia, a partire dal XVI secolo, iniziano ad enunciare
esplicitamente i divieti del rito; nel 1538 è la volta del parlamento
di Tolosa, ma nel corso del XVII secolo i divieti divengono
abituali in altri grossi centri: “i parlamenti di Borgogna nel 1606,
di Bordeaux nel 1639, di Aix-en-Provence nel 1640, e così via,
richiamano la norma, che ha vigore in tutto il regno” (Fabre 2001:
446).
Le condanne effettuate dalle autorità civili nei confronti dei
rituali di derisione, tuttavia avevano un intento differente da
quello della Chiesa; lo charivari non veniva perseguito perché
eretico o blasfemo, bensì perché disturbatore della ‘quiete
pubblica’. Troviamo, però, un insolito silenzio nei confronti della
‘corsa all'asino’; questo rituale non solo veniva tollerato ma, anzi,
utilizzato come pena da scontare per determinati rituali.
Martine Boiteux spiega che l’asouade è presente nella Roma
118
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
medievale: “Cette promenade est mentionnée en trois
circostances: en relation avec la fête de la Cornomania, avec des
mascarades carnavalesques et avec des condamnations
judiciares” (Boiteaux 1977: 238).
Tralasciando gli aspetti folklorici legati alle feste e al carnevale
e concentrandoci maggiormente sugli aspetti giudiziari,
noteremo che la condanna della corsa all’asino veniva inflitta a
chi si ribellava o combatteva il potere pontificio. L’autrice riporta
un testo del XII secolo di Falcone di Benevento, citato da Antonio
Ludovico Muratori negli Annali d'Italia, in cui si parla di un
castigo fatto ai danni di un antipapa:
Tunc praeparato sibi camelo pro albo caballo, et pilosa pelle vevecum
pro clamyde rubea, positus est in transverso super ipsum camelum, et
in manibus ejus pro freno posita est cauda ipsius cameli: Talibus ergo
indumentis ornatus in comitatu Pontificis praecedebat, revertens ad
Urbem cum tanto dedecore, quatenus et ipse in sua confunderentur
erbescentia, et aliis exemplum praeberet, ne similia ulterius attentare
praesumant (Ivi:245).
Anche nell’Inghilterra dei Tudor e dei degli Stuart, alcuni
tribunali imponevano come pena la cavalcata sull'asino
accompagnata dalla rough music.
Ma tra il XVII e il XVIII avviene il capovolgimento della prassi.
Nel 1655 a Bayonne “i giurati emettono un mandato contro
privati che confessano di far correre l'animale che chiamano
asino o asina” (Fabre 2001: 447).
Un nuovo clima di religiosità e un intervento sempre crescente
dei sovrani nella vita urbana investivano l’Europa. «È mutata
l'ottica con cui il potere si afferma e il rapporto
autorità/comunità ha assunto una dimensione molto più
complessa in un sistema in cui si affina e diventa sottilmente
ambigua la strategia di controllo sulle forme di vita comunitaria»
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
119
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
(Avanzi 2000: 185). Nelle città della Francia settentrionale questa
situazione si presentava in maniera più marcata rispetto al Sud,
in quanto «les souverains – alors espagnols – de la région
dévèloppèrent dès le XVI siècle une Contre-Réforme
conquérante, qui s’installa plus tardivement dans le royaume de
France proprement dit” (Muchembled 1977: 239). A poco a poco
le autorità, sia ecclesiastiche che civili, affermano che le feste
popolari sono inutili e dannose; tuttavia riconoscono la funzione
terapeutica che esercitano sul corpo sociale e più che proibirle
cercano di inquadrarle nei quadri dell’ortodossia cristiana. Le
feste private, le feste pubbliche, les ducasses,6 i matrimoni
venivano sempre di più regolamentati. Il cattolico Filippo II
promulgò un'ordinanza, nel 1560, in cui vietava di
Chanter, ou jouer, faire divulguer, chanter, ou jouer publicquement, en
compaignie, ou en secret, aulcunes farces, ballades, chansons, comédies,
refrains, ou aultres semblables escriptz, de quelque matière ou en
quelque langaige que ce soit, tant vieulx que nouveaulx, esquelz soyent
meslées aulcunes questions, propositions ou faitz concernant nostre
relligion, ou les personnes ecclésiasticques […] et, pour aultant que par
cy-devant n'estant le mond si corrompu, ne les erreurs si grans qu’ilz
sont présentement, l’on n’a prins de si près regard à yceulx jeux, farces,
chansons, refrains, ballades et dictiers, comme le convient au temps
présent, ouquel les mauvaises et damnables sectes, de jour en jour
pullulent et s'accroissent davantaige (Muchembled 1977: 230).7
I divieti e le regolamentazioni non si fermano solamente alle
festività, ma si espandono fino a sorvegliare e controllare
rigidamente il loisir di tutti gli abitanti. Il nuovo regime inquadra
i comportamenti e muta i rapporti sociali: “commence en effet un
Feste tradizionali del Belgio e della Francia settentrionale.
Su tale argomento cfr. Castan (1977) e la novella in lingua occitana dell'Abate
Fabre Jean l'an prés in (Le Roy Ladurie:1983).
6
7
120
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
mouvement de contrainte des corps et de soumission des âmes
qui ira s’accélérant au siècle de la Raison et à l’époque des
Lumières” (Ivi: 231).
Il declino della vecchia concezione dell’uomo “a sonné au
cadran des horloges tridentines, absolutistes et patriciennes” (Ivi:
232); si crea, così, una nuova idea di uomo, sottomessa e cattolica.
La legislazione repressiva del XVI secolo trasformò le festività
in spettacoli per il popolo e restrinse sensibilmente le libertà delle
Abbazie della Gioventù o come li definiscono:
Very often by organizations which literary historians have called
“sociétés joyeuses” or “fool-societes” or “play-acting societes”, but
which I will call Abbeys, since that name comes closest to what they
usually called themselves – the Abbeys of Misrule (Zemon Davis 1971:
43),
le quali venivano sempre più inquadrate dai ricchi borghesi.
Il nuovo ceto emergente, infatti, tutelato dalle nuove norme,
diventa nemico diretto della Gioventù8 e dei suoi rituali derisori;
tra il XVII e il XVIII secolo si presenta in Europa una sorta di
‘rivolta delle vittime dello charivari’, le quali chiedono alla Legge
di essere difese da chi vuole intromettersi nella loro intimità e
nella loro vita privata. Il rituale non viene più condannato perché
“contro il sacramento del matrimonio” o in quanto disturbatore
de “l'ordine pubblico”, ma, come condannano i parlamentari di
Navarra nel 1769, in quanto attentano “alla libertà all'interno
delle famiglie”. In seguito alla Rivoluzione Francese la serietà e la
rispettabilità della nuova classe borghese si scontra con i
tradizionali costumi “villani” e nel mentre cerca di conquistare
Solitamente negli ambienti a forte sociabilità locale, come nel caso di alcune
zone rurali, la popolazione utilizzava i propri mezzi per contrastare la censura
ecclesiastica e per affermare un proprio potere di contestazione.
8
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
121
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
uno status sociale presenta e propone «la famille comme norme
et modèle de la vie sociale, come sources de vertus et origine des
“valeurs”, comme ensemble de conduites régulières et
régulatrices». (Bonnain-Moerdyk, Moerdyk 1982: 392).
Conclusioni
Con molta difficoltà possiamo stabilire quando sia iniziata la
decadenza dello charivari.9 Possiamo soltanto chiamare in causa
alcuni eventi che hanno caratterizzato l’Era Moderna: la
Controriforma e il nuovo Stato assolutista.
Ormai anche nelle piccole comunità locali, le quali prima si
reggevano su contratti interpersonali e su regole non scritte,
devono fare i conti con uno Stato che si intromette sempre di più
sui rapporti sociali. Un controllo sempre più serrato sui
comportamenti, una nuova idea di pietà cristiana, un nuovo
rigore religioso e una sempre maggiore censura sui
comportamenti considerati eretici, chiudono per sempre un’era
caratterizzata dalla sociabilità anonima (Chartier: 2001), da un
tipo di società in cui il privato e il pubblico convivevano assieme
senza negarsi l’uno con l'altro.
L’uomo dell'Era Moderna, il cui comportamento è sempre
stato osservato e giudicato, sviluppa un nuovo bisogno di
intimità e di solitudine – non più quella solitudine anacoretica la
quale secondo la concezione medievale veniva considerata come
una punizione – ma un piacevole isolamento in cui coltivare i
Piuttosto che di decadenza sarebbe più opportuno parlare di trasformazione
delle pratiche di charivari; vi è una continuità nella funzione derisoria e
sanzionatoria e nell'utilizzo di strumenti rumorosi tra i rituali dell'Ancien
Régime e le manifestazioni dei movimenti sindacali del Sessantotto, dei
movimenti studenteschi del Settantasette, dei cazelorasos in America Latina e
dei movimenti No Global negli anni 2000 (cfr. Fincardi, 2005).
9
122
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
propri affetti e le proprie passioni.
Anche nella sfera relazionale si intravedono i primi
cambiamenti. La scelta del coniuge diventa progressivamente un
problema di scelta individuale e non più legata alla famiglia o al
contesto ecologico; il matrimonio, sempre di più, perde la
valenza legata all’aspetto economico o di lignaggio per diventare
un unione affettiva. La famiglia diventa il rifugio dell’intimità.
Nel XVIII secolo, inizia ad intravedersi un lungo processo che
porterà all’aumento dell’individualismo e della mobilità sociale,
il cui protagonista sarà l’emergente ceto borghese. In una simile
prospettiva, lo charivari perde la sua funzione di garante
dell’ordine sociale e diventa sempre più un’intromissione nella
vita privata degli individui e delle famiglie.
Una simile riflessione, tuttavia, non deve essere estesa a tutte
le realtà europee. Si presentavano, nel Vecchio Continente, realtà
differenti, per questioni economiche, sociali, culturali e politiche.
All’interno di uno stesso paese vi erano forti differenze, dovute
spesso al contesto ambientale, come il divario tra centro urbano e
centro rurale.10
Un rituale di giustizia popolare come lo charivari sopravvive
laddove il contesto sociale lo permette; in cui l'ambiente vincola
l’agire individuale di ogni persona e questi vincoli acquisiscono
valore quasi giuridico; come nel caso di una novella di Giovanni
Procacci intitolata proprio “La scampanata”,11 la quale racconta
di uno charivari in Toscana intorno alla metà del XIX secolo:
È una chiassata – rispose il notaio. - È la scampanata per quei due
Sulla dissonanza tra la Gioventù come istituzione municipale e la Gioventù
come complesso di pratiche cfr. Agulhon (1968).
11
Il termine “scampanata” era diffuso nell'Italia centrale e settentrionale. Il
nome rimanda al suono della campana utilizzato per creare rumore. Detta
anche “chiassata”, “campanate”o “far campanate”.
10
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
123
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
vedovi là che discorrono insieme e saranno sposi tra pochi giorni. È una
consuetudine del paese, e ciò che si fonda sulla consuetudine non è
un’ingiuria, è un quasi diritto, diremmo noi. Ingiuria è quod non iure fit
(Procacci 1961: 354-355).
Bibliografia
AGULHON A.
1968 Pénitents et Francs-Maçons de l'ancienne Provence, Paris, Fayard.
AVANZI, R.
2004
“Sonitus, fragores, clamores dissoni, strepitus, rumores matutinatae”, in
Charivari, mascherate di vivi e di morti, atti del convegno internazionale di
Rocca Grimalda, 7-8 ottobre 2000, a cura di Franco Castelli, Alessandria,
Edizioni dell'Orso, pp. 175-187.
BOITEAUX B.
1977
“Dérision et déviance: à propos de quelques coutumes romaines”, in Le
Charivari. Actes de la table ronde organisée à Paris (25-27 avril 1977), a
cura di J. Le Goff, Schmitt, J-C, Paris-La Haye, Mouton, pp. 237-249.
BONNAIN MOERDYK R. - MOERDYK D.
1977
“A propos du charivari: discours bourgeois et coutumes populaires”, in
Annales ESC, 2.
BURGUIÈRE A.
1977
“Pratique du charivari et répression religieuse dans la France d'Ancien
Régime”, in Le Charivari. Actes de la table ronde organisée à Paris (25-27
avril 1977), a cura di J. Le Goff, J-C. Schmitt, Paris-La Haye, Mouton,
pp. 179-195.
BURKE P.
1980
Cultura popolare nell'Europa moderna, Milano, Mondadori. (ed. or. 1978,
Popular culture in Early Modern Europe, London, Temple Smith).
CASTAN N.
1977
“Contentieux social et utilisation variable du charivari à la fin de l'Ancien
Régime en Languedoc”, in Le Charivari. Actes de la table ronde organisée à
Paris (25-27 avril 1977), a cura di J. Le Goff, J-C. Schmitt, Paris-La
Haye, Mouton, pp. 197-205.
CHARTIER R.
2001
“La comunità, lo Stato e la famiglia. Introduzione”, in La vita privata dal
124
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
Rinascimento all'Illuminismo, P. Ariès, G. Duby, Bari, Laterza, pp. 323326. (ed. or., 1986, La communauté, l'État et la famille. Introduction, in
Histoire de la vie privée. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil.
FABRE D.
2001
“Famiglie. Il privato contro la consuetudine”, in La vita privata dal
Rinascimento all'Illuminismo, P. Ariès, G. Duby, Bari, Laterza, pp. 426457. (ed. or. 1986, Le privé contre le coutume, in Histoire de la vie privée.
De la reinassance aux Lumières, Paris, Seuil.
FADDA C.
1906
Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel 25. anno del suo insegnamento,
vol. III, Napoli, L. Pierro, tip. Editore.
FAUVE-CHAMOUX A.
2002
“Matrimonio, vedovanza e divorzio”, in Storia della famiglia in Europa dal
Cinquecento alla Rivoluzione Francese, a cura di M. Barbagli, D.I.
Kertzer, Bari, Laterza, pp. 307-351.
FINCARDI M.
2005 Derisioni notturne. Racconti di serenate alla rovescia, Santa Maria
Capua di Vetere, Spartaco.
2008
“I rimatori satirici per le scampanate” in La ricerca folklorica, 56, pp. 133146.
GINZBURG C.
1982
“Charivari, associazioni giovanili, caccia selvaggia”, in Quaderni Storici, 49,
pp. 164-177.
LE ROY LADURIE E.
1983
Il denaro, l'amore, la morte in Occitania, Milano, Rizzoli. (ed. or. 1980,
L’Argent, l'amour et la mort en pays d'Oc, Paris, Le Seuil).
LEBRUN F.
1977
“Le charivari à travers les condamnations des autorités ecclésiastiques en
France du XIV au XVIII siècle”, in Le Charivari. Actes de la table ronde
organisée à Paris (25-27 avril 1977), a cura di J. Le Goff, J-C. Schmitt,
Paris-Le Haye, Mouton, pp. 221-228.
LÉVI-STRAUSS C.
1966
Il crudo e il cotto, Milano, Il Saggiatore. (ed. or. 1964, Le Cru et le Cuit,
Paris, Plon).
MUCHEMBLED R.
1977
“Des conduites de bruit au spectacle des processions. Mutation mentales et
déclin des fêtes populaires dans le Nord de la France (XV et– XVI siècle)”, in
Le Charivari. Actes de la table ronde organisée à Paris (25-27 avril 1977), a
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
125
Branca E., Charivari. Condanna e repressione.
cura di J. Le Goff, J-C. Schmitt, Paris-Le Haye, Mouton, pp. 229-236.
PROCACCI G.
1961
“La scampanata”, in Narratori dell'Ottocento e del Primo Novecento, a cura
di A. Borlenghi, Milano – Napoli, Ricciardi Editore.
THOMPSON E.P.
1981
“Rough music: lo Charivari inglese”, in Società patrizia, cultura plebea,
Torino, Einaudi.
WEBER M.
1965
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Firenze, Sansoni. (ed. or.
1904-1905, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus,
Tubinga).
ZEMON DAVIS N.
1971
“The reason of Misrule: Youth groups and Charivaris in Sexteenth –
Century France”, in Past and Present, 50, pp. 41-75.
126
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Stefano Pau
Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto
Abstract
Comics are often seen as a sub-genre of literature, instead of being judged as a genre
itself, and it's very common now-a-days to ear the definition of “graphic novel”.
Although this definition, a great part of the so called “graphic novels” are not fiction
at all. In this article I try to underline the importance of saving the memory of terrible
historical events through the medium of the comic, focusing my analysis on three
Peruvian works published in Lima in recent years. The three of them deal with
historical and social events happened in the last part of the XX century; they use
images and words in order to preserve the memory, make the audience know more
about their country and rise a democratic consciousness.
Key words
Fumetto, Perù, Sendero Luminoso, graphic novel.
All'interno del vasto panorama culturale di Lima, capitale
ricca di contraddizioni e animata da realtà diversissime fra loro,
sta prendendo piede da ormai qualche anno un'interessantissima
produzione fumettistica realizzata da autori giovani e impegnati
che trovano in questo supporto comunicativo il mezzo
appropriato a veicolare ansie, ideologie, visioni del mondo e
della storia recente.
Sono opere che si liberano dalla definizione alla moda di
graphic novel, troppo vaga e ambigua e che sta decisamente stretta
a una produzione che cammina su binari paralleli a quelli della
pura fiction. Del resto non sono gli unici, in quanto “a number of
the most acclaimed and commercially successful 'graphic novels'
of recent years have not been novels at all, but non-fiction
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
127
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
memoirs in comics form” (Hathaway 2011: 250).
La graphic novel, o novela gráfica nei paesi ispanofoni, in realtà
non è altro che una definizione con la quale si cerca di nobilitare
un mezzo che di per sé non avrebbe nulla da invidiare alla
narrativa scritta: il fumetto non ha bisogno di essere assimilato al
romanzo per essere un prodotto culturale degno di nota; come i
romanzi, o come qualsiasi altro genere letterario, può essere di
basso livello o di ottimo livello, e ciò dovrebbe bastare a
classificarlo, analizzarlo e, a seconda dei casi, apprezzarlo.
Riprendendo le riflessioni di Edward Said nell'introduzione di
un capolavoro quale Palestina dello statunitense Joe Sacco:
I fumetti sono un fenomeno presente ovunque, di solito associato
all'adolescenza. Sembrano esistere in tutte le lingue e culture, da est a
ovest. Le loro storie possono spaziare dal visionario e il fantastico fino
al sentimentale e il buffo. […] Ritengo che alla maggior parte degli
adulti […] appaiano frivoli ed effimeri, e c'è la convinzione che appena
si cresce debbano essere messi da parte per occupazioni più serie, se
non in casi molto rari (per esempio per Maus di Art Spiegelman) in cui
un argomento scomodo e scabroso è affrontato da un vero e proprio
maestro del fumetto (Said 2011: 9).
Tuttavia l'etichetta di graphic novel sempre più spesso viene
data a tutti quei comics che esulano dalla serialità; a quelli che
trattano temi che vanno al di là della pura avventura di un
protagonista a cui il pubblico lettore si affeziona settimana dopo
settimana, mese dopo mese; a quelli che magari vengono
pubblicati con una copertina rigida anziché una brossura.
Nella capitale peruviana negli ultimi anni sono state
pubblicate delle opere che già dai loro sottotitoli sottolineano
quanto per loro sia inappropriata una simile etichetta: la prima è
Rupay: historias gráficas de la violencia en el Perú 1980-1984; la
seconda è Barbarie: comics sobre violencia política en el Perú, 1985128
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
1990. Lo status di fumetto viene dunque riconosciuto e
valorizzato, e allo stesso modo viene esplicitato l'argomento
trattato nelle due opere: la violenza politica che sconvolse il Perù
negli anni '80 (e nella decade successiva).1 È dunque questo uno
dei rari casi a cui si riferisce Said nel brano citato poc'anzi: un
argomento scomodo trattato attraverso tale medium, che rende
più accessibili temi aridi, duri, di cui la gente spesso preferisce
non sentir parlare. In questo modo il fumetto diventa un mezzo
perfetto per parlare di sentimenti, di emozioni.
Carlo Lucarelli, giornalista e scrittore, nell'introduzione a La
strage di Bologna, un comic italiano che ha come tema questo
terribile fatto di cronaca, scrive: “Le emozioni. La memoria è fatta
di dati, di eventi, di nozioni anche, ma sopratutto di emozioni.
Il conflitto armato interno sviluppatosi nelle ultime due decadi del XX secolo
portò alla spaventosa cifra di circa 70.000 vittime. I principali responsabili di
questa carneficina furono due movimenti eversivi, il Partido Comunista del
Perú-Sendero Luminoso (SL) e il Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA), e le Forze Armate nazionali. Il primo periodo del conflitto vide lo
svilupparsi di una guerra non convenzionale; tuttavia la gravità delle azioni
dei senderisti andò aumentando progressivamente, fino a quando divenne
palese che gli assassinii sistematici e gli attentati stavano diventando un
problema di carattere nazionale: Ayacucho per prima, e in seguito diverse
altre provincie vennero dichiarate in “stato di emergenza” e lasciate nelle
mani delle Forze Armate. Gli attentati dei senderisti si fecero più violenti, ma i
metodi repressivi dei militari non differivano granché da quelli dei terroristi.
Le truppe inviate nelle zone di emergenza operarono una repressione
indiscriminata verso terroristi e presunti tali, arrivando alla violenta
distruzione di intere comunità sospettate di essere complici di SL. Nel 1992,
dopo anni di indagini, i servizi segreti riuscirono a mettere le mani sul leader
di SL Abimael Guzmán, ma il processo di pacificazione nazionale si sviluppò
lentamente, in quanto le zone d'emergenza continuarono a restare tali e le
Forze Armate a esservi stanziate, forti anche della Legge di amnistia che nel
giugno del 1995 rimise in libertà tutti i condannati per violazione dei diritti
umani durante il conflitto.
1
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
129
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Per tutto quello che ci succede attorno e per come siamo fatti noi
in quanto esseri umani, le emozioni si raffreddano in fretta”
(Lucarelli 2006: 5). Le emozioni si raffreddano, e lasciano il posto
all'oblio e al silenzio. Le uniche due cose che i narratori possono
fare, dice Lucarelli, è far rivivere le emozioni e mettere in fila i
fatti che le hanno suscitate.
Rupay e Barbarie operano in questo senso. Scavano nella
memoria per far sì che gli errori del passato non vengano
commessi nuovamente, e per dare almeno la dignità del ricordo
alle 70.000 vittime del conflitto armato interno che vide
contrapposte le Forze Armate dello Stato peruviano e i
movimenti eversivi di Sendero Luminoso2 e del Movimento
Revolucionario Tupac Amaru.
Sendero Luminoso sorse negli anni '70 nella regione di Ayacucho in un'epoca
caratterizzata dal forte disequilibrio di carattere economico e sociale esistente
fra la Capitale e le provincie, le fratture causate dalla sproporzionata
distribuzione della ricchezza e del potere, nonché una forte discriminazione
etnico-culturale. Se a ciò si somma l'acuirsi della crisi economica durante gli
anni '70, gli scioperi degli operai, i vuoti di potere venutisi a creare in molte
zone rurali dopo il fallimento della riforma agraria (con immensi spazi che
divennero spesso dominio dei narcotrafficanti), e soprattutto la diffusa
diffidenza nei confronti dei partiti politici, atrofizzati da anni di governi
militari, si può iniziare a comprendere come un movimento rivoluzionario
come SL (e in seguito il MRTA) potesse porsi come alternativa percorribile.
Sendero Luminoso riteneva fosse necessario minare alla base il nuovo sistema
democratico che stava per nascere con le elezioni del maggio 1980 e diede
dunque inizio alla Lotta Armata, che mirava alla distruzione dell'ordine
costituito e alla creazione di una República Popular de Nueva Democracia.
Caratterizzato da una forte gerarchizzazione interna e dal culto del leader
Abimael Guzmán, portò avanti la sua azione di proselitismo fra i lavoratori,
gli studenti e le masse, la cui adesione non era però sempre consensuale: non
era raro, infatti, il ricorso alla violenza e alla coercizione. (Degregori 1990;
Gorriti 1991).
2
130
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Rupay: historias gráficas de la violencia en el Perú 1980-1984
Rupay è un'opera collettiva realizzata da tre giovani limeños:
Luis Rossell, Alfredo Villar e Jesús Cossio e pubblicata nel 2008; è
un fumetto-documentario, e, come si legge nell'introduzione
degli autori (Cossio-Rossel-Villar 2008: 3), non è un libro di
Storia, bensì di 'alcune delle storie' accadute in Perù fra il 1980 e
il 1984, primi anni della violenza politica che colpì
principalmente i più poveri ed emarginati fra i cittadini
peruviani: gli strati inferiori, i subalterni, i 'senza voce'. Nella
presentazione dell'opera si sottolinea il fatto che il conflitto abbia
avuto le maggiori ripercussioni sugli strati più deboli della
società: ciò sta a indicare il carattere razzista e classista di
quest'ultima, nonché la profonda indifferenza e disprezzo delle
élite nei riguardi di ciò che avveniva lontano dalla capitale.
Politici, mass-media, gli alti comandi militari preferiscono
dimenticare il conflitto, ben sapendo di essere corresponsabili del
livello di barbarie a cui si arrivò nelle ultime due decadi del XX
secolo (v. Fig. 1).
Sul blog (non più aggiornato) del poeta e critico letterario
Paolo de Lima,3 già membro del gruppo poetico Neón, si trova un
interessante intervista a uno degli autori, Alfredo Villar, in cui
viene descritto il processo che ha portato alla creazione di Rupay
(che in quechua significa 'bruciare, incendiare'). Il progetto,
durato in totale circa tre anni a causa della complessità
dell'argomento trattato, si è sviluppato inizialmente con una
intensa fase di documentazione, imprescindibile per un tema di
importanza capitale qual è il conflitto armato interno. Questa
Consultato il 31/05/2012 su
http://zonadenoticias.blogspot.it/2008/08/busco-memoria.html.
3
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
131
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Fig. 1 – Copertina di Rupay.
132
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
prima fase, a carico principalmente dello stesso Villar, scrittore e
critico di professione, consisteva nella scelta dei temi da trattare
attraverso la lettura soprattutto dell'Informe della Comisión de la
Verdad y Reconciliación,4 fonte principale ma non esclusiva del
soggetto. Villar, infatti, ha incluso nella sua raccolta di dati anche
la stampa dell'epoca: riviste, quotidiani e periodici di varia
natura, nonché saggi e libri sull'argomento (Díaz Martínez 1985,
Vargas Llosa 1990, Degregori 1990, Gorriti 1991) . Oltre a questa
documentazione sui testi, la ricerca ha assunto le tinte di una
vera e propria ricerca etnografica sul campo nella regione di
Ayacucho, con lo scopo di raccogliere testimonianze dai
protagonisti e dalle vittime del conflitto (è il caso ad esempio di
Mamá
Angélica
Mendoza,
fondatrice
dell'ANFASEP,
l'Associazione dei familiari degli scomparsi durante il conflitto).
Il soggetto con i temi e gli episodi da trattare preparato da
Villar, è stato in seguito elaborato da Jesús Cossio che ne ha
estratto una sceneggiatura vivida e dal forte impatto, con
inquadrature che proiettano il lettore all'interno della scena e
l'inserimento di fotografie e illustrazioni che rendono ancora più
emotivamente impressionante la lettura. Lo stesso Cossio è
l'autore delle matite dell'opera, mentre a Luis Rossell è spettato
un ulteriore lavoro di supervisione e la realizzazione
dell'inchiostrazione. Un lavoro lungo e molto complesso che ha
creato, come la definisce Villar, “una narrativa gráfica que es a la
vez un documento y una ficción, un testimonio histórico y una creación
literaria y artística”.5
L'intero Informe è disponibile sul sito
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php consultato il 31/05/2012.
5 Ancora dal blog di Paolo de Lima,
http://zonadenoticias.blogspot.it/2008/08/busco-memoria.html consultato il
31/05/2012.
4
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
133
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Il contributo che quest'opera apporta al processo di recupero
della memoria storica, avviene attraverso la rappresentazione di
alcuni eventi simbolici che caratterizzarono i primi anni del
conflitto armato interno, quelli fra il 1980 e il 1984. Eventi violenti
che scossero profondamente l'opinione pubblica e soprattutto
colpirono gli abitanti della sierra del sud del Paese.
La prima parte del cómic-documental narra la cruda realtà di
eventi come la prima azione senderista, l'incendio delle urne
elettorali nel paesino di Chuschi, per poi passare all'assalto
dell'avamposto della polizia di Tambo e allo 'spettacolare' attacco
al carcere di Huamanga, con la liberazione di diversi militanti
prigionieri. Viene di seguito narrata anche la rappresaglia che
seguì l'assalto al carcere, con l'uccisione di alcuni presunti
terroristi ricoverati in un ospedale. La crudeltà che si scatenò sia
dal fronte istituzionale che da quello sovversivo in questi anni è
ritratta con dovizia di particolari e con un tratto realistico ma di
facile assimilazione, espressivo a tal punto da riuscire a far
rivivere la drammaticità di eventi come l'assalto alla caserma di
Vilcashuamán o il terribile eccidio di Uchuraccay. 6 Questo
episodio è forse uno dei più dolorosamente angoscianti fra quelli
immortalati nelle pagine del fumetto, forse anche per
l'abbondanza di immagini fotografiche che catapultano il lettore
dentro l'ambiente in cui si consumò il delitto. La critica all'Informe
redatto dalla commissione presieduta da Mario Vargas Llosa si fa
evidente nei disegni e nelle stesse fotografie, che smentiscono le
teorie della commissione investigativa (v. Fig. 2).7
Per i vari episodi citati si rimanda in particolare all'Informe della CVR; per i
fatti di Uchuraccay vedi anche Vargas Llosa 1990, Vich 2002, Ubilluz 2009.
7 Nel gennaio del 1983 nei pressi della comunità andina di Uchuraccay
vennero brutalmente assassinati 8 giornalisti e una guida. Per investigare
sull'accaduto venne istituita una commissione composta da tre illustri
6
134
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
La seconda parte dell'opera narra episodi altrettanto violenti e
sconvolgenti, come le lotte fratricide fra gli eserciti popolari
reclutati da Sendero Luminoso e i Comitati di Difesa Civile
organizzati dalle Forze Armate. In particolare vengono descritti
gli eventi che sconvolsero la zona di Chungui/Oreja de Perro,
dove le violenze furono tali da far sparire intere comunità. In
questa sezione il forte impatto emotivo è dato dall'inserzione di
alcune delle testimonianze degli abitanti della zona raccolte in un
libro intitolato “Chungui, violencia y trazos de memoria” (Jiménez
2005): i personaggi parlano in prima persona della propria
esperienza del conflitto e ognuna delle sei testimonianze grafiche
è accompagnata da un disegno del compilatore del libro,
l'antropologo e illustratore ayacuchano Edilberto Jiménez. Fra i
più significativi, ci sono quello che rappresenta l'uccisione di
decine di bambini da parte di militanti senderisti o quello in cui
intellettuali: il giornalista Mario Castro Arena, l'avvocato Abraham Guzmán e
lo scrittore Mario Vargas Llosa, che la presiedeva.
Il documento che presentarono dopo circa un mese di indagini individuava i
responsabili degli omicidi nella popolazione della comunità nel suo insieme.
A tal proposito, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pur
confermando che i colpevoli materiali furono effettivamente gli abitanti di
Uchuraccay, denuncia la superficialità e la manipolazione della realtà
effettuata dalla commissione di Vergas Llosa in merito alle cause che
portarono al tragico episodio. Essa indicava come causa fondamentale (oltre ai
problemi causati dalle colonne senderiste che operavano nella zona) la
presunta violenza atavica delle popolazioni andine, una ferocia quasi belluina
insita nella natura dei comuneros. Una stereotipizzazione superficiale che
alterò la percezione dei fatti accaduti.
La lacuna presente nella versione dei fatti fornita dalla commissione di Vargas
Llosa consiste inoltre nella sottovalutazione di una questione fondamentale: il
ruolo delle Forze Armate e del Governo, colpevoli di aver istigato gli abitanti
di Uchuraccay al delitto, alla vendetta e alla giustizia sommaria, non più di
qualche giorno prima del massacro.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
135
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Fig. 2 – Pagina di Rupay.
136
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
sono rappresentati dei sinchis, dei militari dei corpi speciali
antisovversivi, che dopo aver ucciso i propri nemici, asportano
mani o orecchie dei cadaveri con lo scopo di consegnarli ai propri
superiori in modo da guadagnarsi una promozione. Il tratto
semplice e crudo delle illustrazioni, così diverse dai disegni di
Cossio e Rossell, ha un effetto particolare sul lettore: lo veicola
direttamente nel tremendo orrore vissuto dalle popolazioni della
sierra peruviana, senza neanche il sottile filtro a cui ci si era
abituati nelle pagine precedenti.
In seguito, ad essere rappresentate sono due vicende quasi
speculari: il massacro di Lucanamarca da parte dei militanti di
Sendero Luminoso e l'uccisione di trentanove comuneros8 (fra cui
anche sette bambini) a Soccos da parte dei militari dell'esercito,
eccidio che ispirerà anche l'episodio culmine del film di Francisco
Lombardi La boca del lobo (1988). La violenza dei metodi
repressivi militari è palesata anche negli ultimi due episodi
presenti nell'opera, che trattano delle torture perpetrate nello
stadio di Huanta e nella base militare de Los Cabitos, veri e propri
'mattatoi' di uomini, in cui vennero seviziate un numero
incalcolabile di persone, i cui resti venivano poi fatti sparire in
delle fosse comuni o fatti a pezzi con le bombe. Le fosse comuni
sono uno degli spaventosi segni che quel periodo di violenza ha
lasciato. Si è parlato dell'esistenza di circa 4000 botaderos9 di
cadaveri, fra cui si contano le sei rinvenute nella località di Putis.
Proprio con la foto di una di queste fosse, si conclude l'opera di
recupero della memoria operata da Villar, Cossio e Rossell.
Le immagini che hanno trasmesso ai lettori, con il loro
I comuneros sono gli abitanti dei villaggi delle Ande peruviane, che vivono
secondo il principio dell'ayni termine quechua che si riferisce alla reciprocità,
alla solidarietà comunitaria e al mutuo soccorso.
9 Letteralmente “discariche”: si tratta delle fosse comuni.
8
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
137
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
caratteristico bianco e nero, hanno la funzione di smuovere le
coscienze e di invitare a non dimenticare. Non sorprende che
l'unico colore presente nelle pagine di Rupay sia il rosso. Rosse
sono le bandiere delle fazioni in lotta: quella rossa e bianca dello
stato peruviano, e quella rossa con la falce e il martello dei
militanti senderisti, ma soprattutto rosso è il colore del sangue,
versato così spesso negli anni del conflitto.
Il proposito degli autori, espresso da Villar nell'intervista di
Paolo de Lima, è quello di divulgare la conoscenza di un
argomento che, come suggerisce il titolo del fumetto, continua ad
'ardere', in quanto, nonostante i tentativi di 'pacificazione', molte
domande rimangono ancora senza risposta e molte vittime
attendono giustizia.
Barbarie: comics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990
Lo stesso spirito di inchiesta e di preservazione della memoria
ha spinto uno degli autori di Rupay, Jesús Cossio, a iniziare a
lavorare, nell'agosto del 2009, a un secondo volume, Barbarie, che
tuttavia presenta alcune differenze sostanziali rispetto al lavoro
precedente (v. Fig. 3).
Se nel primo lavoro gli autori si concentravano in particolar
modo sulla spiegazione del contesto in cui avvennero
determinati fatti e abbondavano le didascalie recanti
informazioni fondamentali alla comprensione, in Barbarie,
pubblicato a ottobre del 2010, l'autore ha optato per una scelta
stilistica diversa: partendo da una ricca bibliografia (ancora una
volta di fondamentale importanza risulta l'Informe de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación e diverso materiale saggistico: Uceda
2004; Cristóbal 1987) e da un certosino lavoro di ricerca (anche
138
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Fig. 3 – Copertina di Barbarie.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
139
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
sul campo), Jesús Cossio ha deciso di elaborare questa materia
prima per la creazione di situazioni e dialoghi verosimili che
potessero esprimere ciò che documenti storici, giornali e
fotografie non riuscivano a comunicare direttamente.
Questo processo di ficcionalización si basa però su registri del
parlato presi dalla vita reale, ricavati ad esempio dalle
testimonianze di vittime e carnefici ai processi. Ciò che risulta da
questo esperimento è un fumetto crudo, in cui i dialoghi
sottolineano gli abusi che vennero commessi dai vari
schieramenti in campo. Un esempio nitido di questa strategia di
narrazione è una sequenza relativa all'episodio della strage di
Accomarca: vi sono rappresentati degli ufficiali dell'esercito che
pianificano un'operazione volta a sgominare una presunta cellula
terrorista; un sottufficiale formula una domanda terribile “Una
domanda, signore: se, durante l'operazione, qualche abitante
dovesse comparire nella valle, dobbiamo considerarlo come un
terrorista?”;10 segue una vignetta muta in cui appaiono i due
ufficiali in primo piano che fissano l'interlocutore, e
conseguentemente anche il lettore, con aria impassibile, a cui
segue una terza vignetta in cui campeggia il primissimo piano di
uno dei due e la risposta secca: “Si” (v. Fig. 4).
Barbarie, nonostante le differenze sostanziali, segue per vie
diverse una sorta di filo conduttore ideale iniziato con Rupay,
perlomeno dal punto di vista della cronologia, in quanto
vengono ficcionalizados alcuni fra i più tremendi episodi del
quinquennio tra il 1985 e il 1990, epoca del primo mandato del
presidente della repubblica Alan García Pérez, verso il quale non
mancarono le critiche per le decisioni prese riguardo al conflitto.
E Alan García oltre ad essere il personaggio che apre il fumetto (è
10
La traduzione all'italiano è mia.
140
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Fig. 4 – Pagina di Barbarie.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
141
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
infatti presente nella prima vignetta) è in modo più o meno
esplicito il destinatario principale dell'opera. Lo stesso autore,
nell'introduzione, sottolinea come abbia lavorato a ritmi
sostenuti per riuscire a dare alla stampa il fumetto prima del
termine secondo mandato del presidente García, conclusosi nel
luglio del 2011. La ragione è molto chiara: Alan García e il suo
governo acquiescente furono, nella seconda metà degli anni '80,
tra i maggiori responsabili dello sproporzionato aumento della
violenza nelle regioni del sud del Paese. Ciò avvenne soprattutto
per la mancata supervisione dell'operato delle Forze Armate in
quelle che ormai da anni erano diventate 'zone d'emergenza', in
cui lo Stato di diritto non esisteva e i diritti umani venivano
quotidianamente calpestati.
Ancora una volta lo spirito con il quale l'opera prende vita è
legata alla memoria, al bisogno di riportare alla luce le storie
tremende di una terribile epoca di violenza. Ne vengono narrate
cinque, e la crudezza delle immagini esplicita senza mezzi
termini i livelli di vera e propria barbarie raggiunti in quegli
anni. Nonostante siano sparite, rispetto a Rupay, le fotografie, le
copertine di riviste, le illustrazioni e quel colore rosso che
sottolineava la tragicità dei fatti narrati, le sequenze assumono in
questo lavoro i ritmi serrati della realtà, le vignette aumentano le
proprie dimensioni fino a occupare pagine intere, come ad
esempio quella in cui appare una fossa comune colma dei
cadaveri degli abitanti della zona di Pucayacu, assassinati e
occultati dopo essere stati torturati per giorni dalle Forze
Armate. È questo il primo degli episodi narrati, cui segue un
ulteriore abuso perpetrato dai militari, la strage di Accomarca.
Alla fine di ognuno di questi due episodi, l'autore sottolinea
come questi delitti siano rimasti fondamentalmente impuniti:
prove evidenti di quanto possa essere lenta e lacunosa la
142
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
giustizia.
I due episodi che vengono rappresentati successivamente
presentano due carneficine perpetrate dall'altro grande
schieramento in lotta: i militanti del Partido Comunista del PerúSendero Luminoso. In particolare vengono narrate le vicende che
portarono al massacro degli abitanti di due comunità, quella di
Aranhuay (avvenuta nell'aprile del 1988) e quella di Paccha
(dicembre 1989). Entrambi i villaggi soffrirono una sorta di
'castigo esemplare' per mano dei senderisti, in quanto gli abitanti
vennero accusati di collaborare con le Forze Armate e di aver
abbandonato la rivoluzione che avrebbe migliorato le loro
condizioni di vita. Gli episodi rappresentati suscitano tanto più
sdegno in quanto sono inframezzate da scampoli dell'intervista
concessa al giornale El diario il 31 luglio del 1988 dal capo
supremo di Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso,
conosciuto come Presidente Gonzalo.11 Le immagini di
umiliazioni pubbliche, mutilazioni, omicidi e distruzioni di vario
tipo vengono affiancate alla freddezza delle parole di Guzmán,
che con distacco descrive come sia necessario pagare un tributo
di sangue per raggiungere gli obiettivi: rovesciare lo status quo e
instaurare una repubblica comunista rivoluzionaria. Infine,
l'ultimo avvenimento narrato è quello della cosiddetta 'strage
delle carceri', avvenuta tra il 18 e il 19 giugno del 1986, quando
l'esercito soffocò nel sangue delle rivolte scoppiate in tre carceri
di Lima: il caso più grave fu quello del carcere di Lurigancho,
dove vennero brutalmente giustiziati dei prigionieri che già si
erano arresi.
Riprendendo le considerazioni che Rosemary V. Hathaway
formula su Maus di Art Spiegelman, potremmo dire che lavori
L'
intervista
completa
è
disponibile
presso
http://www.solrojo.org/pcp_doc/pcp_0688.htm consultato il 02/06/2012.
11
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
143
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
come Rupay e Barbarie costituiscono in parte dei lavori di
etnografia alternativa, perché “like ethnography, the texts are
concerned with depicting the complex relationships among
personal histories and larger 'official' histories.” (Hathaway 2011:
249). Citando Charles Hatfield, la studiosa definisce Maus come
un lungo saggio sul tentativo di descrivere l'indescrivibile: e
descrivere l'indescrivibile, ossia l'orrore della realtà storica
attraverso un linguaggio che unisca l'immediatezza delle
immagini alla parola scritta, è in certa misura ciò che viene
compiuto anche dai due fumetti peruviani di cui si è trattato.
Fare ciò attraverso l'utilizzo e la ficcionalización di testimonianze
dirette tuttavia potrebbe suscitare dei dubbi riguardo l'obiettività
del punto di vista, ma questo è del resto il dilemma intorno al
quale ruota qualsiasi ricerca di carattere etnografico: come si può
riuscire a dipingere oggettivamente e accuratamente un quadro
storico-sociale partendo da casi singoli? Ci si trova sempre di
fronte a verità parziali? Avendo fra le fonti principali un
documento importante e ricco di informazioni come l'Informe de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación potremmo dire che si
evita questo rischio, anche se nella realtà la brutalità del conflitto
armato interno viene ancora molto spesso messa in discussione,
perfino dalle sentenze e dagli esiti dei processi a cui vengono
sottoposti i responsabili dei delitti.
Inoltre, riprendendo ancora la Hathaway e le riflessioni
dell'autore di Maus che essa cita:
What makes an ethnographic text speak to readers is, paradoxically, the
very ways in which it 'narrativizes' its source material—the ways in
which it translates and mediates raw data into a complex <<fiction>>
that <<usefully steer[s] you back directly to reality>>, as Spiegelman
describes the process. Without that kind of 'streamlining' and 'shaping'
(to borrow Spiegelman’s words again), all you have is source material—
and source material that has already been shaped both by the person
144
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
who amassed it and by his or her collaborators: the interviewer and
interviewee, the photographer and the photographic subject. All
ethnography is inherently biased; in its very bias, however, it also
carries the capacity to “reveal beyond what one knows one is revealing”
(Hathaway 2011: 263-64).12
Sta dunque alla sensibilità del lettore interpretare nella
maniera corretta ciò che l'autore plasma a partire dai dati
raccolti. Nella lettura di Rupay e di Barbarie è palese la condanna
che gli autori formulano nei riguardi della violenza degli ultimi
anni del XX secolo, ma soprattutto della politica dell'oblio che
tende a sotterrare le realtà scomode.
Novísima Corónica y mal gobierno
Un simile atteggiamento di denuncia è espresso anche da un
terzo lavoro di stampo fumettistico, per quanto non
convenzionale,13 prodotto ancora una volta a Lima dal
disegnatore Miguel Det: la sua Novísima Corónica y mal gobierno
pubblicata a luglio del 2011. Il titolo riporta subito alla Nueva
Corónica y buen gobierno, opera del primo cronista autoctono
“Ciò che permette a un testo etnografico di comunicare al lettore è,
paradossalmente, proprio il modo in cui esso 'narrativizza' il proprio
materiale originale – il modo in cui traduce e interpreta i dati puri in una
complessa 'fiction' che 'ti riporta direttamente alla realtà', come Spiegelman
descrive il processo. Senza questo 'dare forma' e 'modellare' (usando ancora le
parole di Spiegelman), ciò che si possiede è solo il materiale originale – e
materiale originale che è già stato plasmato sia dalla persona che l'ha raccolto
sia dai suoi collaboratori: l'intervistatore e l'intervistato, il fotografo e il
soggetto fotografato. Tutta l'etnografia è intrinsecamente di parte: tuttavia,
nonostante i limiti e i pregiudizi, è anche capace di 'comunicare più di ciò che
una persona sa che si sta comunicando' ”. La traduzione all'italiano è mia.
13 Non è infatti il classico fumetto composto da vignette e nuvolette con i
dialoghi.
12
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
145
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
peruviano, il primo esempio della resistenza indigena in ambito
letterario, Felipe Guaman Poma de Ayala. Essa è appunto la
cronaca della conquista del Perù da parte degli spagnoli e dei
primi anni della colonia. Quest'opera, concepita nella prima parte
del 1600, era accompagnata dalle illustrazioni dello stesso
Guaman Poma, nelle quali venivano riaffermati i codici culturali
autoctoni in maniera molto maggiore rispetto alla parte testuale.
Miguel Det abbandona il testo discorsivo per riprendere invece il
formato e lo stile delle immagini di Guaman Poma, le quillcas, e
crea delle illustrazioni ricche di particolari, a volte persino
confuse, in cui personaggi e scritte ricche di sarcasmo si
intrecciano a rappresentare le bellezze e le brutture del Perù.
Nell'opera di Guaman Poma, l'immagine risulta essere un
mezzo di comunicazione più potente del linguaggio scritto
(Adorno 1991: 110); tuttavia la cronaca in questione era un'opera
indirizzata direttamente al re Filippo III di Spagna e la vena
polemica dell'autore risulta chiara solo quando viene sottoposta
a un'attenta analisi, è una polémica disimulada (ivi: 13): infatti, la
combinazione di “dibujos idealizantes y prosa acusatoria, le permiten
criticar sin ofender, protestar sin manifestar falta de respeto por el rey,
y persuadir a éste con una indignación que no amenaza” (ivi: 118).
Nel lavoro di Miguel Det la critica è invece esplicita, la realtà
in tutta la sua crudezza viene sbattuta in faccia al lettore, che si
trova fra le mani una piccola antologia della società e della storia
peruviana attuale e passata. Dopo le prime sezioni dedicate alle
origini del Paese, alla sua geografia, alla sua gente, alle risorse
naturali, all'arte e alle feste, si giunge alle sezioni intitolate Los
poderes fácticos y sus crímenes e Miseria y sociedad, senz'altro le più
interessanti e ricche di spunti polemici. Vi vengono
rappresentate le scomode realtà della corruzione in tutti gli strati
della società, della lenta burocrazia, degli abusi polizieschi e
146
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
soprattutto degli scandali legati alla politica. La terribile fase
della guerra interna viene narrata attraverso la rappresentazione
di episodi simbolo e di realtà a cui la popolazione tristemente
fece l'abitudine: l'inizio della lotta armata, gli abusi dei militari,
gli attentati, la scoperta di fosse comuni, fino al regime di Alberto
Fujimori degli anni '90 e la cattura di Abimael Guzmán.
L'impegno politico dell'autore contro il regime Fujimorista si fa
esplicito nelle immagini in cui rappresenta le nefandezze
compiute dall'ex presidente e dal suo uomo di fiducia Vladimiro
Montesinos, e quelle in cui invece presenta le plebiscitarie
manifestazioni di protesta che puntualmente venivano soffocate
dalle forze di polizia. La storia politica recente non riserva
nessuna sorpresa positiva e le immagini di Miguel Det lo
testimoniano senza pietà. La satira grottesca del disegnatore
limeño colpisce il presidente Alejandro Toledo (2001-2006) e
ancora di più il suo successore Alan García (al suo secondo
mandato dopo quello della seconda metà degli anni '80, 20062011). L'autore non usa mezzi termini per sottolineare come
durante il secondo 'Alanismo' sia cresciuto l'abisso che separa i
ricchi dai poveri, come siano stati favoriti gli investimenti
stranieri a scapito delle popolazioni e delle terre amazzoniche e
come, ancora una volta, le proteste siano state soffocate nel
sangue.
Il linguaggio utilizzato da Miguel Det è schierato, non lascia
spazio ai fraintendimenti, spesso è condito da insulti verso una
classe dirigente colpevole di aver dissanguato il Paese, ma allo
stesso tempo lascia trasparire un forte senso di disillusione che
tuttavia non genera immobilismo e passività. Tutt'altro: la
resistenza popolare diventa capace, per citare le stesse parole
dell'autore, di esprimersi in forme culturali e artistiche ricche di
un'allegria dirompente e di ineguagliabile bellezza (Det 2011: 4).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
147
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
In conclusione, sembra necessario sottolineare come sia
fondamentale proporre un dibattito su questioni storico-sociali
che spesso vengono insabbiate o nascoste. I messaggi veicolati
dagli autori di Rupay, Barbarie e la Novísima Corónica y mal
gobierno tendono alla preservazione della memoria e al
raggiungimento di una coscienza democratica e partecipativa.
Queste opere rappresentano la dura vita del Paese, una realtà
che spacca in due la popolazione, fra chi soffre e chi, indifferente,
cerca di coprirsi gli occhi; tendono inoltre a far sì che anche
coloro che preferiscono dimenticare la tragedia possano
prenderne coscienza, perché la conoscenza rappresenta il primo
passo verso la democrazia. E il fumetto risulta essere un mezzo
adatto a tale scopo: con un linguaggio che unisce le immagini alla
discorsività, le opere esaminate contribuiscono a rendere fruibili
al maggior numero di persone le conoscenze necessarie a
confrontarsi con l'attualità, spesso suscitando polemiche e
critiche, ma con l'obbiettivo ben chiaro di partecipare alla
formazione di una società più consapevole e giusta; citando
ancora una volta le parole di Edward Said potremmo dire che:
Nel mondo in cui viviamo, saturato dai mezzi di comunicazione e
controllato da poche persone che, dalle loro postazioni di Londra o
New York, diffondono l'informazione e le immagini a esse legate, le
parole e i disegni dei fumetti, con la loro assertività enfatica e a volte
grottesca, in perfetta sintonia con le situazioni straordinarie che
descrivono, possono essere considerate un antidoto di notevole efficacia
(Said 2011: 12).
148
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Bibliografia
ADORNO R.
1991
Guaman Poma: literatura de resistencia en el Perú colonial, México D.F.,
Siglo XXI
editores (de. or. 1986, Guaman Poma, writing and
resistance in colonial Peru, Austin,
University of Texas Press).
CHUTE H.
2006
“The Shadow of a past Time: History and Graphic Representation in Maus”,
in Twentieth
Century Literature, Vol. 52, N.2, pp. 199-230.
COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN
2002
Informe
Final,
consultato
su
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php il 10/09/2012.
COSSIO J. - ROSSEL L. - VILLAR A.
2008
Rupay: historias gráficas de la violencia en el Perú 1980-1984, Lima,
Contracultura.
COSSIO J.
2010
Barbarie: comics sobre violencia política en el Perú, 1985-1990, Lima,
Contracultura.
CRISTÓBAL J.
1987
¿Todos murieron? Recopilación de artículos sobre la masacre de los Penales,
Lima, Contracultura.
DEGREGORI C.I.
1990
Ayacucho 1969-1979: el surgimiento de Sendero Luminoso, Lima, Instituto
de Estudios
Peruanos.
DET M.
2011
Novísima corónica y mal gobierno, Lima, Contracultura.
DÍAZ MARTÍNEZ A.
1985
Ayacucho. Hambre y esperanza, Lima, Mosca Azul editores.
GORRITI G.
1991
Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú, Lima, Editorial Apoyo.
GUAMAN POMA DE AYALA F.
1980
Nueva corónica y buen gobierno, a cura di John V. Murra, Rolena Adorno
e Jorge L., Urioste, México D.F., Siglo XXI editores.
HATAWAY R.V.
2011
“Reading Art Spiegelman's Maus as Postmodern Ethnography”, in Journal
of Folklore
Research, Vol. 48, N. 3, pagine 249-267.
HIBBET A.- UBILLUZ J.C.- VICH V.
2009
Contra el sueño de los justos: la literatura peruana ante la violencia política,
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
149
Pau S., Perù. Società e storia recente attraverso la lente del fumetto.
Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
JIMÉNEZ E.
2005
Chungui: violencia y trazos de memoria, Lima, COMISEDH.
LUCARELLI C.
2006
Affreschi di storia italiana, in La strage di Bologna, di Boschetti A. Ciammiti A., Treviso, BeccoGiallo, pagine 9-15.
SACCO J.
2011
Palestina, Milano, Mondadori (de. or. 2002, Palestine, Seattle,
Fantagraphics Books Ink.).
SAID E. W.
2011
“Omaggio a Joe Sacco” in Palestina, una nazione occupata, di Joe Sacco,
Milano, Mondadori, pagine 9-15.
SPIEGELMAN A.
2006
Maus, Roma, Gruppo editoriale L'Espresso/Coconino Press.
UCEDA R.
2004
Muerte en el Pentagonito, Bogotá, Editorial Planeta.
VARGAS LLOSA M.
1990
“Historia de una matanza”, in Contra viento y marea, III, Barcelona, Seix
Barral.
VICH V.
2002
El canibal es el otro, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
Fonti delle immagini
Fig. 1 – http://www.nocreoqueseasreal.pe/?p=2856
Fig. 2 – http://www.perufoto.org/2009/02/uchuraccay-visto-por-rupay.html
Fig. 3 – http://www.nocreoqueseasreal.pe/?p=2856
Fig. 4 – http://publicacioneslibres.blogspot.com/
150
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
LAVORO
ს
ა
მ
უშა
ო
δουλε
ι
ά
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
Davide Stocchero
Riflessioni sull’antropologia culturale
in versione ‘applicata e professionale’
Abstract
The article briefly addresses some central questions about applied and professional
anthropology in the Italian contest. Starting from the relationship between the
identity of the anthropologist and the different academic training available in the
Italian university, it then tries to point out some common dilemmas felt by Italian
young anthropologist about the social relevance of the discipline, some features of the
labour market and the challenge of facing other professional social scientists with
different background. After these social and psychological insights, the author tries to
open a reflexive path analyzing one of the first article about professional anthropology
in Italy, published in 1991. Using the informations emerged, the author suggests some
ideas about what professional anthropology would need to flourish in the Italian
contest, such as a strong commitment on life long learning and training and a clear
analysis and deep evaluation of the labour niches that show good potentials for
anthropological engagement in private sector, NGOs, communication, research,
health, education. The Italian anthropologists don’t have a basic professional habitus
and the formal university training doesn’t help them out to set it in a pragmatic
manner. This article is a little move toward a more open and structured debate about
professional anthropology in Italy.
Key words
Antropologia applicata, antropologia professionale, formazione continua.
Mi è stato chiesto di preparare un documento che riprendesse
e ampliasse le discussioni attorno all’applicazione pratica
dell’antropologia culturale al di fuori dall’accademia. Queste
discussioni, nate nel blog di ‘Intrecci’ e nel forum di ‘Anthropos’,
si sono poi sviluppate in diversi luoghi virtuali arrivando a
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
153
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
toccare molti punti importanti della questione del potenziale
lavoro antropologico professionale. È con un po’ di apprensione
che affronto tali tematiche. Pare un po’ velleitario farlo di questi
tempi: un mondo del lavoro e delle professioni autonome sotto
scacco tra precarizzazione e restringimento continuo delle
opportunità; un’accademia che vede i corsi di laurea in
antropologia culturale eliminati o a rischio eliminazione in
diverse prestigiose realtà; i mass media che perpetuano un
continuo disinteresse o banalizzazione delle scienze sociali in
tutta la sfera pubblica nonostante i repentini cambiamenti in atto
a livello nazionale, europeo e internazionale sia dal punto di
vista economico e socioculturale richiedano oggi più che mai tale
tipo di lettura della realtà. C’è bisogno di parlare di conoscenze e
di competenze antropologiche, di percorsi reali per costruirsi una
capacità di intervento che sia riconosciuta e pertanto spendibile e
retribuibile, di individuare opportunità, di esplorare delle nicchie
sapendole poi abitare e far crescere, di continuare a formarsi e
specializzarsi dopo la laurea, essendo questa l’inizio e non il
termine del proprio percorso di apprendimento. Insomma, anche
per i laureati in antropologia culturale arriva il momento di
confrontarsi con il mercato del lavoro: cosa si può
ragionevolmente fare se non si opta per la roulette accademica,
per l’emigrazione o per l’abbandono precoce dell’amata
antropologia? Sarà anche velleitario come approccio, ma vale la
pena di essere tentato.
Quali identità per l’antropologo?
Le lauree triennali e magistrali in antropologia culturale sono
di recentissima istituzione nel nostro ordinamento accademico, le
ultime arrivate, a distanza di decenni, rispetto a quelle nelle altre
154
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
scienze umane e sociali. È utile ricordare che prima della nascita
di lauree specifiche era possibile laurearsi in antropologia
culturale sostenendo la tesi con il docente dell’omonima
disciplina all’interno dei corsi di laurea in lettere, filosofia,
lingue, sociologia o psicologia. Questo portava lo studente a
costruirsi una doppia identità formativa che conduceva ad
autodescrizioni del tipo ‘sociologo laureato in antropologia
culturale’ oppure ‘dottoressa in lettere con indirizzo
antropologico’. C’era quindi un corso formativo di un certo tipo,
socialmente più riconosciuto, con un’iniezione specifica di
antropologia acquisita durante una tesi di laurea che poteva
comprendere o meno un periodo di ricerca sul campo.
Attualmente questi due percorsi coesistono, nel senso che è
possibile sia diventare dottori in antropologia culturale che
dottori in qualche altro corso di laurea con un percorso che
comprenda al proprio interno ‘dosi’ variabili di antropologia
culturale. Questa premessa può essere importante per capire
quanto l’identità dell’antropologo culturale nella realtà italiana
sia molteplice fin dal percorso accademico. Scopo di questo
contributo è fornire degli stimoli per riflettere su cosa si possa
utilmente fare con una laurea in antropologia culturale in tasca,
sia essa pura (triennale o quinquennale) o spuria (percorso di tesi
innestato su altro corso di laurea). I due percorsi sono
ovviamente diversi e peculiari, oltre ad avere una diversa serie di
punti di forza e di debolezza quando, una volta conclusi, ci si
avvicini al mondo del lavoro. In poche parole, perché la loro
analisi richiederebbe un articolo dedicato, il percorso puro
permette di acquisire una conoscenza dell’antropologia molto
ampia e approfondita, mentre lo spurio è spesso settoriale e
disomogeneo. Inoltre, il percorso puro spesso permette
esperienze concrete di ricerca etnografica, mentre quello spurio
prende spesso forma in termini di analisi concettuale o
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
155
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
bibliografica, restando povero dal punto di vista metodologico e
esperienziale. D’altro canto, la prima opzione rischia di creare
maggior disorientamento perché l’antropologia culturale non è
ancora una disciplina ‘da mercato del lavoro’, mentre il percorso
spurio, grazie all’interazione tra la formazione di base e quella
antropologica, può favore l’emergere di un profilo professionale
più spendibile (penso soprattutto a lingue e antropologia, o
psicologia e antropologia). In realtà, esisterebbe una altro
possibile percorso, quello della triennale diversa è la specialistica
in antropologia, soluzione a mio parere veramente interessante
che potenzia alcune caratteristiche della laurea spuria senza
perdere i vantaggi di quella pura. Resta il fatto che riflettere a
fondo su quale sia stato il proprio percorso di studio, e imparare
a costruire una traiettoria ottimale per i propri interessi e idealità
lavorative è uno dei passaggi più delicati e fondamentali da cui
discendono conseguenze per gran pare della carriera lavorativa.
Partire con il piede giusto, in questo come i molti altri ambiti, è
fondamentale per ottimizzare l’investimento in istruzione.
Un altro aspetto al centro del dibattito è quanta enfasi valga la
pena di mettere sulla parola ‘antropologia’ una volta che si
decida di operare mercato del lavoro. Una parte degli
antropologi propone comunque di contraddistinguersi con
questo termine, visto che è la disciplina propria all’interno della
quale ci si muove, mentre altri tendono a smorzare l’impatto di
questo termine decisamente impegnativo, vago e sconosciuto
limitandosi a spiegare che si offrono servizi di ricerca, analisi o
consulenza provenendo da una formazione ‘antropologica’,
magari integrandola con altre conoscenze in ottica
interdisplinare. Ognuno gestisce la propria identità come meglio
crede, ma penso che gli appartenenti alla seconda categoria
abbiano qualche argomento in più per validare la propria tesi
156
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
rispetto ai primi.
I dilemmi del laureato in antropologia culturale.
Quanto verrà qui abbozzato scaturisce da ormai un decennio
di discussioni nella comunità di Anthropos, gestita dal network
di Antrocom, e dal confronto con un buon numero di laureati in
antropologia culturale che si affacciavano al mondo del lavoro
una volta laureati, accantonate definitivamente le opzioni che più
facilmente vengono alla mente, ossia il proseguire gli studi
tentando di iniziare un dottorato o emigrare in cerca di miglior
antropologia e miglior fortuna. Accantonate queste prospettive,
non resta che fare seriamente i conti con cosa si possa fare con
una laurea in antropologia in Italia.
Una delle frustrazioni principali è quella che emerge dal
contrasto tra la passione che si è profusa negli studi e la completa
assenza di posizioni lavorative pensate ad hoc per gli antropologi.
A cosa è servita, e a cosa serve, la mia genuina passione per
questa disciplina se nessuno è in grado di riconoscerla e
valorizzarla? Non esistono posizioni aperte per ‘antropologi
culturali’ in Italia. Il mercato del lavoro non conosce la categoria,
un po’ come l’anagrafe italiano non contempla alcune professioni
da inserire nel campo ‘professione’ nel documento di identità. È
con notevole sgomento che si apprende, l’indomani della laurea
per alcuni, ma già durante gli studi per molti altri, che in quanto
antropologi non si sarà mai cercati da nessuno. Non è una
formazione socialmente rilevata perché non è, al momento,
percepita come socialmente rilevante. Il termine stesso circola
pochissimo sui media, non è una parola semanticamente
presente per il pubblico e per la società civile, nemmeno per
quella istruita. Ciò è un dato. La divulgazione mira a modificare
questo stato di cose, con beneficio di tutti, ma i tempi sono
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
157
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
lunghi.
Un'altra enorme frustrazione nasce dal confronto tra ciò che
l’antropologo culturale potrebbe portare per favorire la
comprensione e valorizzazione delle persone nelle nostre società
(immigrazioni, globalizzazione, politiche pubbliche, mediazione,
conflitti, contatti fra culture, ecc.) e la realtà delle proprie attività
concrete. D’altro canto, l’ampiezza e la dispersività del sapere
antropologico è spesso visto come un ostacolo alla focalizzazione
verso opzioni professionali che conducano verso una expertise
spendibile sul mercato del lavoro. La forma di conoscenza
macroscopica e olistica propria dell’antropologia culturale è
fortemente distonica rispetto a un mercato del lavoro
parcellizzato, iperspecializzato e decisamente asfittico, con un
grave ritardo nello sviluppo del settore terziario e quaternario.
Un’ulteriore frustrazione emerge dal vedere come laureati in
altre discipline, o personale nemmeno adeguatamente formato,
lavorino in contesti dove l’antropologo porterebbe un grande
valore aggiunto e potrebbe muoversi in maniera appropriata e
professionale. L’ambito delle scienze umane e sociali è molto
variegato e non è facile definire in maniera chiara chi sia
adeguatamente abilitato a fare cosa. Ancora, mancano dispositivi
formativi che aiutino a costruirsi un profilo professionale che
incoraggi all’applicazione dell’antropologia nel mondo reale. I
corsi essenzialmente teorici impartiti all’università aiutano a
formarsi una mentalità antropologica che dà il meglio di sé nel
assimilare contenuti attraverso lo studio di testi e renderli
nuovamente sotto forma orale agli esami. Al mondo del lavoro
queste abilità, seppur importanti, interessano solo in parte perché
non aiutano di per sé a creare valore aggiunto a ciò che si può
offrire al mondo. Mancano, ad esempio, tirocini istituzionali
dedicati, momenti potenzialmente preziosi per mediare tra
158
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
accademia e attività lavorativa Visto questo stato di cose, sarebbe
opportuno attivarsi affinché gli studenti e i laureati in
antropologia potessero beneficiare di un percorso di
orientamento scolastico e professionale che integri un momento
informativo (corsi disponibili, percorsi formativi peculiari,
spendibilità dei titoli, condizioni del mercato del lavoro e
previsioni, profili professionali realistici) ad un momento di
autoformazione e autovalutazione attraverso gli strumenti del
colloquio d’orientamento e del bilancio di competenze. Dovrebbe
essere un compito delle istituzioni ma non è colto nella sua
importanza. Può essere un’opportunità per dei servizi del terzo
settore che vogliano sostenere l’inserimento lavorativo dei
laureati in discipline culturali.
Archeologia delle fonti scritte: cosa è successo nel 1991?
Nell’aprile 1991 la rivista La Ricerca Folklorica ha pubblicato un
numero monografico intitolato “Professione antropologo”e che
riporta al proprio interno un contributo intitolato “La domanda
sociale di competenze antropologiche nei settori pubblico e privato”. Si
tratta di una sessione di lavoro con relazioni e interventi
provenienti dalle due metà del cielo: da un lato i rappresentanti
del mondo imprenditoriale e socioculturale (CONFAPI –
Confederazione nazionale piccole e media industrie,
Confindustria, Confederazione italiana coltivatori, Museo
nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, Ufficio cultura del
Mondo Popolare della Regione Lombardia, Cooperativa
antropologi di Napoli, e altri ) e dall’altro il mondo accademico
(tra gli altri Maria Laura Bonin di Trento, Vanessa Maher di
Torino, e altri). Cercherò di analizzare alcune parti che trovo
salienti, consigliandone poi la lettura integrale a chiunque sia
interessato alla storia del dibattito dell’antropologia applicata e
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
159
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
professionale in Italia. Farò una sorta di esegesi, sperando di non
risultare noioso né banale, perché trovo questo documento
veramente rivelatore di ciò che costituisce la base, il nucleo
profondo, della condizione dell’antropologia applicata in Italia.
Già il titolo contiene informazioni molto utili per le nostre
riflessioni. Innanzitutto, si parla di “domanda sociale”. Questo
vuol dire che si fa propria la logica di un sistema di mercato,
ossia di ‘domanda’ e ‘offerta’. Senza qualcuno a cui interessi ciò
che abbiamo da offrire in quanto antropologi non esiste
possibilità di entrare nel circuito sociale. Per domanda si intende
quindi l’azione di una o più persone che attivamente richiedono
una risposta per placare un bisogno, una necessità, risolvere un
problema. Penso che affrontare la questione della ‘domanda di
antropologia culturale’ sia centrale perché ciò ha ricadute enormi
sulla struttura della professione stessa. Questione legittima e
urgente, quindi, anche se la sede dell’elaborazione delle risposte
difficilmente sarà l’accademia. Lo sarà forse il web, questo e altri
giornali, associazioni e reti di colleghi che attraverso l’operatività
quotidiana creano le condizioni per far nascere qualcosa di
nuovo dal versante professionale.
Il titolo prosegue con “competenze antropologiche”. Si
presume che questo termine si riferisca a ciò che viene trasferito
all’interno di un corso di laurea in antropologia. Uno studente si
iscrive al rispettivo corso perché vuole diventare competente in
quella disciplina, e sarà questa competenza che gli garantirà quel
capitale cognitivo e creativo per svolgere attività e prestazioni
remunerate dalla società perché utili a soddisfare certi bisogni.
Ma di che competenze antropologiche parliamo? Spesso le
competenze, ciò che so fare e realizzare concretamente, vengono
schiacciate dalle cosiddette “conoscenze antropologiche”, ossia
informazioni organizzate inerenti diversi ambiti del reale. Le
160
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
conoscenze si acquisiscono, si immagazzinano e si restituiscono
principalmente per via linguistica, orale e scritta. Ciò produce
oratori e scrittori, che è ciò che l’accademia richiede per
perpetuare se stessa: persone che trasmettano la disciplina e
contribuiscano alla conoscenza pura realizzando ricerche e
scrivendo saggi e articoli. Questi sono i bisogni dell’accademia, e
chi segue quel percorso formativo diventerà un produttore e
trasmettitore di conoscenza antropologica. Riflettere a fondo sul
rapporto fra conoscenze e competenze antropologiche è urgente
perché è il cuore della costruzione di una identità professionale
solida. Su quali competenze professionali può contare un
laureato in antropologia? Se la professione è ancora in gran parte
da inventare, codificare e testare sul campo, è difficile che le
competenze siano già disponibili, codificate e pronte. Saranno
presumibilmente incerte, abbozzate, in fase di test e di confronto
con altre. Servirà un lavoro a ritroso: a partire dalla domanda
della società, che va fatta emergere, occorre comprendere le
risorse dell’antropologia culturale scavando nella sua storia e
nella sua attualità fino ad acquisire le competenze tali per
rispondere ai bisogni stessi. È un percorso riflessivo e operativo
che richiede tempo, e che in gran parte sarà simile a quanto fatto
da altre professioni imperniate sulle scienze umane e sociali.
Il titolo conclude con “settori pubblico e privato”. La loro
unione rappresenta la totalità della platea che può chiedere agli
antropologi di soddisfare i propri bisogni tramite l’utilizzo di
competenze antropologiche. Le logiche organizzative, politiche e
economiche del pubblico e del privato differiscono, almeno ai
miei occhi, in maniera radicale. Ciò che è più importante è che le
prestazioni verso il pubblico sono remunerate con risorse
provenienti dalla fiscalità generale nazionale, e quindi devono
essere potenzialmente di interesse ampio, pubblico, di
orientamento generale, ‘antropologico’ per definizione, diciamo.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
161
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
D’altro canto, lo spazio privato apre diverse possibilità di
intervento in quando è potenzialmente infinito il grado di
creatività e di particolarità sia della domanda che dell’offerta
perché essa si basa su contrattazione privata tra le parti, senza
necessità di interventi burocratici, valutazioni politiche e di
opportunità elettorali. L’antropologia culturale è una sapere
profondamente contestuale e credo che il contesto ‘pubblico’ e
quello ‘privato’ differiscano a tal punto da portare alla
costituzione di due antropologie applicate diverse e spesso
scarsamente correlabili. Ciò non toglie che sia stimolante
misurarsi con entrambi i contesti, avendo ben chiare in mente le
loro peculiarità. Il percorso che traccerò all’interno del
documento è ovviamente personale e dettato da ciò che colpisce
me oggi, tenendo conto delle mie esperienze passate e presenti.
Invito nuovamente tutti gli interessati a procurarsi il documento
e realizzare la propria personale lettura e conseguenti riflessioni.
Presenterò prima un breve riassunto dell’intervento e in seguito
alcune brevi riflessioni spontanee.
Lanfranco di Mario, di CONFAPI, ritiene che le piccole e
medie industrie siano direttamente coinvolte nella discussione
della professionalità dell’antropologo. Lamenta la carenza di una
funzione pubblica che non supporta le PMI nello stare al passo
con l’evoluzione velocissima dei processi produttivi, con le
dinamiche della globalizzazione e con la necessità di stare sul
mercato in maniera competitiva. La piccola impresa spesso non
ha capacità culturale per comprendere l’evoluzione del mercato e
quindi le competenze dell’antropologo potrebbero essere utili.
Lamenta le carenze dell’istruzione pubblica e della formazione
aziendale e conclude dicendo che le valutazioni sulla
professionalità dell’antropologo non si risolveranno parlandone,
ma solo vedendo i risultati concreti degli antropologi all’opera.
162
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
Di Mario porta l’attenzione sulle piccole e medie imprese
italiane,
l’ossatura
del
nostro
sistema
produttivo.
L’internazionalizzazione delle PMI è sicuramente uno scenario
che vede potenzialmente l’antropologia culturale come sapere
strategico che possa mediare nei processi economici tra il tessuto
economico italiano e quello di altri paesi e intere aree in rapido
sviluppo (Est Europa, India, Cina e numerose realtà africane).
D’altro canto, credo che in Italia, nel 1991, non esistesse nessun
antropologo qui formatosi in grado di predisporre un piano di
consulenza aziendale per PMI. L’intervento è piuttosto vago ma
evocativo, prospettando una collaborazione possibile tra aziende,
imprenditori e antropologi culturali.
Aldo Giuliano, di Confindustria, si rifà subito alla business
anthropology americana, e in particolare alle ricerche di business
ethnography svolti al PARC della Xerox, che volevano capire
‘come si lavora negli uffici’. L’antropologia può dare un
contributo nei processi di cambiamento culturale o di
trasferimento o unificazione di culture diverse e preesistenti.
Ritiene che al centro del mondo economico stiano la conoscenza
e le nuove tecnologie della comunicazione e che il ruolo
dell’innovazione tecnologica sia il motore dell’evoluzione sociale.
Servono persone che sappiano governare il cambiamento e la
tecnologia con l’obiettivo di migliorare la vita di tutti. Ritiene che
l’antropologo non abbia minori competenze di altri professionisti
che lavorano nella pubblicità, nell’analisi dei comportamenti di
consumo, nella comunicazione e nella sponsorizzazione
culturale. Anche se l’antropologo si forma nella società
‘primitive’, esso acquisisce strumenti che possono essere ben
utilizzate nell’impresa. In particolare, i problemi dell’impresa che
l’antropologo potrebbe affrontare sono quelli legati alla cultura
aziendale, ai modelli di comunicazione e alla resistenza
all’innovazione. La ragione dell’antropologo in azienda è quello
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
163
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
di capire la cultura aziendale, capacità che non hanno né gli
imprenditori né i consulenti. Cita Olivetti, Apple, IBM.
L’antropologo potrebbe essere al fianco della aziende con le
proprie analisi per favorire processi di cambiamento, di fusione,
di delocalizzazione, di privatizzazione o statalizzazione. Ma
allora, se esiste tutto questo potenziale di incontro proficuo,
perché le aziende non chiamano gli antropologi? Giuliano
risponde “A mio avviso, non è l’azienda che ignora
l’antropologo, ma è questi che ignora l’azienda, ignorandone i
problemi, la realtà”.
L’intervento di Giuliano è spesso preso a modello, tra i
partecipanti, per la capacità di stimolare in maniera appropriata
il dibattito fornendo buoni spunti. Lo stile e la competenza è
decisamente da Ufficio Studi, così come l’aggiornamento sulle
pratiche
di
ricerca
internazionali
in
ambito
antropologico/manageriale. Il concetto di ‘cultura aziendale’ è
stato un punto di svolta per gli studi sull’impresa in ambito
anglosassone, ma pare che in Italia questo concetto non sia mai
stato preso sul serio. Non lo era allora come non lo è oggi.
L’antropologia culturale italiana non ha mai visto nemmeno
lontanamente come proprio oggetto di studio il mondo
dell’impresa. Come conclude Giuliano, le imprese sentono di
aver potenzialmente bisogno di antropologia ma non chiamano
gli antropologi perché per prime sanno che gli antropologi, di
impresa, non sanno nulla, e quindi non potranno mai rispondere
ai loro bisogni. Come si cambia tale stato di cose, secondo
Giuliano? Aprendo la mente degli antropologi stessi, inserendo
tesi di laurea aziendali, tenendo corsi adeguati, facendo
orientamento verso temi di ricerca innovativi e agganciati
all’antropologia culturale internazionale.
Maria Laura Bonin, antropologa a Trento, ritiene che esista
164
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
uno spazio per gli antropologi nelle aziende, lavorando lei stessa
nel mondo della moda. Dice
[…] penso che il giorno in cui nascerà una generazione di studiosi
disposta ad occupare questo spazio ne sarò contenta, perché non sarò
più sola a portare avanti questo tipo di collaborazione considerata
peccaminosa.
Sostiene che gli antropologi, occupandosi di miti, potrebbero
indagare quelli aziendali e del mondo della produzione e del
consumo di oggetti, cercando di scoprire come le persone
attribuiscono loro un significato. Attività questa sicuramente
molto lontana dalla ricerca teorica che si svolge tradizionalmente
in accademia.
Intervento tanto breve quando denso da parte di una delle
poche antropologhe che aveva il coraggio di lavorare con le
aziende, una ‘peccatrice’ secondo molti colleghi ben più puri e
ortodossi. Il mondo della moda, eccellenza italiana, è una
possibilità di grande interesse per l’antropologia applicata perché
intreccia questioni di gusto, di design, di rapporto tra cultura e
stile, di collezioni etniche, di globalizzazione e codici
comunicativi.
Marisa Iori interviene in qualità di operatore museale a Roma.
Lamenta il misconoscimento della professionalità tecnica
dell’antropologo e i limiti della formazione antropologica
universitaria rispetto al lavoro pubblico:
gli strumenti conoscitivi elaborati nella nostra area di studi non
producono infatti competenze immediatamente impiegabili sul mercato
del lavoro pubblico, la cui complessità è data proprio dalla necessaria e
non sempre risolta integrazione dialettica dell’aspetto teorico-scientifico
con quello amministrativo-istituzionale.
È strettissimo il rapporto tra riconoscimento della professione
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
165
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
e qualità della formazione. È impossibile al giorno d’oggi
proporsi come professionisti sul mercato senza una formazione
solida e approfondita a livello universitario unita a una
formazione applicata che continui lungo tutta la vita attiva.
Ritroviamo poi il rapporto tra strumenti conoscitivi e
competenze impiegabili, altra chiave di volta da sviluppare e
chiarire prima di poter pensare a qualsiasi strutturazione
professionale dell’antropologia culturale.
Bruno Pianta, operatore culturale della regione Lombardia,
spiega che nel territorio in cui opera non si parla mai di
antropologia anche se c’è una notevole richiesta di psicologi,
esperti di gruppi, fotografi, esperti di audiovisivi, ecc. C’è
pertanto una concorrenza notevole nel settore culturale tra gli
antropologi e altre figure ben più abituate a muoversi nel
mercato del lavoro. Gli antropologi rischiano di trovarsi
disarmati. Sottolinea che negli interventi di Giuliano e Bonin
bastava cambiare qualche termine e i loro discorsi potevano
valere per psicologi, sociologi, grafici, artisti…gli antropologi
dovranno lottare “con il coltello” contro altre competenze ben
più agguerrite. Non esiste nessun Eldorado. Dice che in
Lombardia manca una tradizione antropologica accademica e i
funzionari pubblici ignorano del tutto cosa essa sia. Non
esistevano corsi di antropologia, nemmeno clandestini. Non è un
discorso di scarsa credibilità dell’antropologo, in Lombardia
l’antropologo non esiste proprio. Accennando alla struttura della
macchina pubblica, rileva il fatto che è il politico a decidere se
approvare un progetto o meno, e che il funzionario può
solamente spingere e incoraggiare. A decidere è sempre
l’apparato amministrativo-legislativo, non quello funzionale.
Intervento denso e opportuno, tocca temi centrali per la
professione. L’antropologia è talmente ampia che moltissime
166
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
operazioni che legittimamente potrebbero rientrare nel suo
dominio sono svolte da persone con altre formazioni, spesso in
maniera più efficace e strutturata perché già preparati, fin
dall’università, ad applicare le proprie conoscenze. È il caso degli
psicologi sociali e culturali, degli educatori e dei formatori, dei
sociologi spesso ottimi etnografi e metodologicamente ben
attrezzati, esperti di turismo, progettisti sociali, di consulenti di
varia estrazione che, da autodidatti, giungono a offrire servizi
culturalmente sensibili senza aver mai frequentato un corso di
antropologia. Tutte queste persone non sono antropologi, ma
intercettano ampie fette di bisogno d’antropologia e lo
soddisfano. È molto difficile individuare degli ‘atti tipici’ della
professione antropologica, e forse non è nemmeno così utile in
questa fase preliminare di analisi. Inevitabile però che l’identità e
la riconoscibilità sociale sia assente. Il fattore competizione con
altri e della competitività della propria preparazione è quindi
centrale.
Duccio Canestrini, redattore di Airone, porta il discorso
dell’antropologia sul piano della divulgazione e del giornalismo.
Lamenta la presenza di luoghi comuni e di approssimazione nel
settore delle tradizioni popolari e dell’etnologia nelle riviste di
viaggi e di culture. Consiglia di formarsi in maniera
approfondita e poi dedicarsi ad esempio alla cronaca estera,
come antropologi-reporter, producendo materiali di vario genere
dai luoghi più diversi del mondo. Altra prospettiva quella di
dedicarsi al giornalismo d’inchiesta rivolto a tematiche
antropologiche, al cambiamento sociale, alle minoranze etniche,
al mondo dell’arte e dello spettacolo. Secondo Canestrini è
compito dell’antropologo rimanere equilibrato tra le diverse
forze che da un lato spingono verso l’esotismo, che tutto
appiattisce, e dall’altro verso il ‘bingobonghismo’, che tratta tutti
gli altri come primitivi.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
167
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
Canestrini autorevolmente muove dal proprio settore di
attività portando dei consigli pratici a chi, provvisto di una
formazione antropologica, voglia intraprendere la via del
giornalismo e della divulgazione di alto livello. Conoscenza
approfondita di ciò di cui si parla, capacità di critica e sguardo
sveglio sulla realtà sono gli ingredienti base per contribuire ad
alzare il livello medio della pubblicistica etnologica e di viaggio.
L’antropologia culturale applicata e professionale vent’anni dopo. Cosa
è cambiato?
Rispetto al periodo di pubblicazione dell’articolo appena
analizzato sono cambiate molte cose sia nell’antropologia italiana
che nel mondo, mentre altre sembrano rimaste inalterate. Nel
primo ambito inserirei sicuramente la nascita di corsi di laurea
dedicati interamente all’antropologia culturale, che garantiscono
una preparazione più ampia, approfondita e solida. Metterei la
rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, che impattano radicalmente sugli stili di vita,
sulle possibilità formative e informative, sulle dinamiche
sociopolitiche e economiche. Oggigiorno l’antropologia culturale
non può prescindere dall’evoluzione di internet e delle reti
comunicative globali che creano spinte di trasformazione
culturale straordinarie. Tra queste, emerge con sempre maggior
forza l’uso delle tecnologie per la produzione e la diffusione
dell’antropologia stessa, che vede forum, blog, social network e
riviste open access come vettori principali per far uscire il sapere
antropologico dalle torre d’avorio accademica, permettendogli
contaminazioni, collaborazioni e confronti decisamente vitali in
un contesto altrimenti piuttosto tradizionalista e asfittico.
Tra le cose inalterate rispetto agli interventi direi sicuramente
168
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
il profondo disinteresse, nemmeno dissimulato, dell’accademia
per qualsiasi prospettiva applicativa concreta dell’antropologia
culturale. Tra le righe del documento analizzato emerge una
chiara incomunicabilità tra il mondo produttivo e sociale e i
rappresentanti della disciplina. Trapela l’imbarazzo reciproco, il
non detto soverchia chiaramente il detto, in una danza statica che
mirava probabilmente a far terminare il prima possibile
quell’incontro tra persone che, di fatto, non hanno nulla da dirsi
salvo frasi di circostanza per salvare la faccia senza
compromettersi nel rispettivo ambiente di attività. Il mondo del
lavoro, la realtà dell’impresa, le possibilità consulenziali, la
dinamica domanda-offerta applicata alla conoscenza e alle
competenze nelle scienze umane semplicemente non sono
conosciute né comprese all’interno della logica dell’accademia
così come è concepita in Italia. Non solo gli antropologi italiani,
nella gran maggioranza, ignorano il versante applicato della loro
disciplina, ne ignorano gli sviluppi internazionali e la storia
creata dai practitioner statunitensi, ne ignorano le potenzialità ma,
soprattutto, non ritengono sia di loro competenza. Chiedendo
informazioni riguardo alle applicazioni pratiche del sapere
antropologico agli antropologi italiani si ottiene, e parlo per
esperienze personali, una espressione del viso che comunica
chiaramente il seguente pensiero: ‘perché chiede a me queste
cose?’. Non mi sembrava che ci stessero pensando ma non
trovassero risposte, non è che ignorassero e lo ammettessero (non
ci sarebbe nulla di male, non si può sapere tutto); pareva che la
loro coscienza intellettuale non possedesse la categoria, non
disponesse della possibilità, non com-prendesse la domanda.
Potrei sbagliarmi, ma la sensazione è stata chiara. L’unica
prospettiva antropologica applicata che esiste in Italia è quel
poco nato attorno all’antropologia dello sviluppo nei paesi del
cosiddetto Terzo Mondo, che conta qualche cultore che ha
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
169
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
concretizzato
collaborazioni
con
qualche
organismo
internazionale come la FAO, la Banca Mondiale o qualche
importante ONG soprattutto in temi di sviluppo agricolo e
rurale. Il resto, e parlo di un mondo intero di conoscenze,
pratiche, decenni di sperimentazioni internazionali nelle
dinamiche culturali aziendali, di progettazione sociale, culturale
e urbana innovativa, di gestione di risorse ambientali, turistiche,
di ricerche applicati in settori militari, spaziali, di intelligence,
nelle nuove tecnologie, nel counseling, nell’antropologia medica,
nella formazione, nel management interculturale, non c’è
praticamente traccia. Mentre l’antropologia applicata e
professionale mondiale provava, certo con fatica, ad evolvere, in
Italia tutti si fissavano l’ombelico ben soddisfatti della loro
produzione intellettuale, evitando accuratamente di sporcarsi le
mani, e di macchiarsi la carriera, con progetti nel settore
applicato.
Formazione continua, unica soluzione.
Le attività applicate e professionali in generale necessitano di
una certa specializzazione settoriale. È molto improbabile
riuscire a operare come antropologi limitandosi alle conoscenze e
alle competenze acquisite durante il corso di laurea. Questo non
succede ormai per nessuna disciplina professionalizzante, dove
la life long learning è diventata la regola per riuscire prima ad
entrare, e poi rimanere, nel mercato del lavoro. Se a questo
uniamo il fatto che all’iter formativo in antropologia culturale
mancano alcune conoscenze e competenze di base per poter
cominciare a operare professionalmente, si capisce come la
laurea sia solo il primo passo di una lunga camminata per
aspirare a diventare dei professionisti dell’antropologia che
170
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
possano garantire servizi di qualità. Come per altre formazioni,
occorre effettuare una svolta pratica. Sapere che per fare ricerca
occorre scrivere un progetto non significa saperlo fare. Sapere le
fasi di una ricerca etnografica non significa saperla realizzare. Ed
è questa la differenza fra il sapere e il saper fare. Finché gli esami
di profitto accademici (cioè di livello delle conoscenze) saranno a
crocette o domande aperte si sforneranno molti laureati
capacissimi di compilarli, con l’unico inconveniente che nessuno
nel mondo del lavoro ti darà un incarico retribuito che consista
nel rispondere a domande aperte. È per questo motivo che la
formazione applicata viene spesso demandata alla fase postlauream, dove sulla base delle conoscenze già acquisite si
cominciano ad innestare e sviluppare competenze specialistiche
legate al fare concreto attraverso la propria disciplina. Si
cominciano a fare sessioni di etnografia, a scrivere progetti
realistici con metodi realmente adottati nel mondo del lavoro, si
opera in gruppo, si scrivono report come un ipotetico
committente li vorrebbe probabilmente vedere, visto che la tesi
di laurea come la commissione la vuol vedere si è già scritta una
o due volte. Si acquisiscono nuovi linguaggi, si accede ad altra
bibliografia, ci si confronta con problemi che emergono dalla
realtà sociale aperta e non da qualche dipartimento universitario.
In pratica, si comincia ad esplorare l’altra metà del cielo, quello
dove ai problemi occorre portare una evoluzione concreta, non
una disquisizione teorica. L’idea è che unendo le due metà del
cielo, la teorica in una prima fase, la pratica in una seconda, si
ottenga poi un professionista a tutto tondo capace di muoversi in
autonomia e con competenza in diversi scenari professionali. Per
iniziare questo percorso, lungo e non facile, esistono una serie di
corsi di perfezionamento, master, scuole private e ambienti di
vario tipo che vanno scelti in base ai propri interessi e
competenze da acquisire e che sono un passo ormai obbligato per
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
171
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
costruirsi un profilo antropologico più spendibile sul mercato del
lavoro non tanto in quanto tale (alla fine domanda di
antropologia ce n’è pochissima) ma in quando capace, questo
corso, di mettere nelle condizioni di produrre qualcosa che il
mercato veda come utile, e quindi degno di essere retribuito.
Sarà banale da ripetere, ma il mercato del lavoro cerca sempre
meno titoli e sempre più capacità e abilità, spesso trasversali ai
corsi di studi. Sarà sempre meno importante il portafoglio titoli e
sempre più rilevanti il portafoglio competenze, il valore aggiunto
che si saprà portare per far crescere il settore dove si opera.
Questo appena tratteggiato è un percorso di natura formale
che si impernia sull’università e su altri corsi erogati da altre
scuole o centri formativi. Esiste però un altro tipo di traiettoria, a
mio parere in molte condizioni è da privilegiare per diversi
motivi, che definirei di tipo autodidattico. Con questo termine si
intenda l’attivazione delle risorse personali per costruirsi un
capitale di esperienze pratiche, competenze e conoscenze in
modo peculiare a seconda delle variabili tempo, impegno,
interesse, occasione e obiettivi. In altre parole, è il formarsi in
autonomia e in relazione ai vari contesti di apprendimento in
vista di un obiettivo che evolve con il tempo. È un metodo di
formazione molto adatto se si vogliono affrontare ambiti nuovi e
quindi incerti e in rapido cambiamento, oppure se si punta ad
avvicinarsi a settori di nicchia per i quali non sono previsti
percorsi istituzionali o, ancora e soprattutto, se mal si tollera, per
questioni caratteriali o economiche, la prolungata permanenza
all’interno del sistema formativo istituzionale.
Sostanzialmente, una volta acquisita una preparazione teorica
di base, triennale o quinquennale, si comincia a muoversi con
iniziativa personale appoggiandosi a risorse diverse dalle
agenzie formative. L’antropologia culturale, come altre arti,
172
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
pratiche creative, discipline di confine e mondi professionali è
probabilmente uno dei campi d’elezione per l’autodidattica. In
alcuni ambiti è addirittura necessario essere autodidatti, perché
l’antropologia culturale italiana contempla ad oggi un numero
molto ristretto di ‘interessi disciplinari’ rispetto al resto del
mondo. Semplicemente, in interi ambiti di esperienza
l’antropologia culturale non è ancora arrivata con le sue analisi e
riflessioni. Ciò non toglie che siano campi di grande interesse, e
spesso i più innovativi e lavorativamente promettenti.
Fondamentale per attivare un processo autodidattico è la
capacità di movimento personale, la curiosità, la voglia di
esplorare e di connettere esperienze diverse per formare un
bagaglio di conoscenze e competenze ampio, strutturato e
originale. In un mondo dove i titoli di studio sono sempre più
rapidamente obsoleti e le richieste del mercato del lavoro sempre
più varie, schizofreniche e peculiari, aver intrapreso questa
strada, sicuramente faticosa e incerta, può riservare delle
sorprese positive in termini di impiegabilità e richiesta
professionale. Inutile dire che il percorso autoformativo non si
può imporre, in quando emerge dallo studente che si trasforma
in studioso autonomo intento a costruirsi le possibilità stesse del
proprio apprendere. È tipico di chi decide per questo scenario
formativo la capacità di far interagire l’antropologia culturale con
altre discipline anche lontane, l’aver fatto esperienze pratiche
consistenti, ad esempio, nel terzo settore, in imprese di vario
tipo, l’aver sviluppato un ‘curriculum nascosto’ in occasioni di
attività extrascolastiche, in viaggi di vario tipo, sfruttando
condizioni educative particolari, ecc. Spesso il percorso passa
dalla pratica alla teoria, cioè mira a ricostruire le basi teoriche e
metodologiche a posteriori rispetto a quanto appreso sul campo
in un primo momento.
Per un percorso professionale in antropologia culturale può
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
173
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
essere quindi importante più il proprio curriculum vitae
(l’esperienza globale di vita) piuttosto che quello studiorum, che
invece è vincolante per molte altre professioni più
standardizzate. Le competenze richieste ad un antropologo
culturale, in qualsiasi ambito lavori, sono tanto di natura
cognitiva che di natura relazionale (soft skills), in quanto egli è
spesso impiegato in contesti umani ad alta complessità e in
condizioni di disagio o trasformazione. L’università non forma in
alcun modo le risorse empatiche, relazionali e umane, che vanno
pertanto forgiate in contesti opportuni e possono rivelarsi una
ingrediente necessario per mettere in campo un agire
professionale di qualità.
Antropologia culturale applicata e professionale: quali possibilità?
Come abbiamo già visto, grande è l’eterogeneità sotto il cielo
antropologico. C’è chi comincia a fare esperienza sul campo da
volontario fin dalla triennale, che acquisisce competenze
trasversali in contesti extra-accademici, come lavorare in
associazioni, fare assistenza ai disabili, attività di animatore,
lavori serali e nei fine settimana per mantenersi agli studi e
vedere da dentro il mondo del lavoro, riesce a prendere parte
come uditore alle situazioni più diverse – ONG, gruppi di autoaiuto, consigli comunali. La capacità di movimento degli studenti
di antropologia è veramente notevole, stando alle storie che mi è
capitato di sentire e alle persone incontrate, sia realmente che
virtualmente. Inutile dire che chi fa queste scelte ha poi una
marcia in più una volta finito il corso di studi rispetto a chi ha,
legittimamente, scelto di dedicarsi esclusivamente alla
preparazione teorica.
L’esperienza diretta sul campo, in qualsiasi attività, purché
174
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
fatta da apprendista antropologo ha dei risvolti formativi
eccezionali: innanzitutto addestra precocemente a confrontare la
teoria con la realtà, il funzionamento sociale e culturale descritto
nei libri con il fluire della vita sociale reale. Quanto ci si rende
conto che il proprio oggetto di studio e di lavoro sarà la seconda
di queste, una ‘folgorazione preoccupata’ è ciò che si prova.
Ancora, si impara a gestire la propria inadeguatezza nello
spiegare perché si è lì, cosa si studia e la connessione tra le due
cose: chiunque l’abbia fatto, sa che non è immediato. E nella
professione di antropologo applicato capiterà sempre: saper
presentarsi e spiegare in poche parole comprensibili ciò che si
vuol fare credo sia il cinquanta per cento della professionalità.
Farlo, è l’altro cinquanta. Poi, entrando in un settore particolare
si verifica se si ha reale interesse per quell’ambito di attività, per
quello spaccato di realtà: ecologia? Comunicazione? Formazione?
Salute? Immigrazione? Aziende? Musei? Se non ho mai
sperimentato nessuna situazione, non posso sapere cosa mi
piace, posso solo supporlo. Infatti molto laureati in antropologia
culturale non sanno dire quali siano i loro reali interessi, cosa
vogliano approfondire. Finché tutto resta nel vago, nel
potenziale, il proprio movimento personale risulta debole e
discontinuo, scarsamente efficace. Ancora, si ha modo di
conoscere persone, iniziare qualche scambio, scrivere qualcosa,
costruire comunioni di intenti che possono tornare utili una volta
completati gli studi, quando si hanno più conoscenze e più
tempo per concretizzarle. Altra cosa importante, si apprende la
lingua dei nativi. Se l’obiettivo è lavorare con le aziende,
dobbiamo conoscere la loro lingua meglio di chi ci lavora dentro,
così come ci preoccupiamo di apprendere quella delle
popolazioni nei quattro angoli del pianeta dove gli antropologi
fanno ricerca. Lo stesso vale per le ONG, per le istituzioni
burocratiche, per le logiche del mercato. Spesso gli studenti
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
175
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
sottovalutano questa criticità tipica dell’antropologia fatta ‘a casa
propria’: essendo nativi, credono di avere tutte le competenze
per muoversi nel ‘loro’ ambiente. Niente di più sbagliato: spesso
l’essere nativo, se non viene analizzato in profondità con una
buona dose di riflessività e di autocritica, porta a posizionarsi sul
campo in maniera problematica, pieno di stereotipi e stereotipie
che offuscano gran parte della realtà. Muovendo da questi
presupposti, e da altri che ognuno scoprirà in autonomia per
prove ed errori, è possibile inquadrare velocemente alcuni ambiti
dove gli antropologi culturale possono provare a muoversi una
volta acquisita la giusta formazione. Ne indicherò brevemente
alcuni che derivano dalla mia esperienza e da quella di
antropologi culturali con cui ho maggior scambio di
informazioni.
Terzo settore/privato sociale no profit
Con una opportuna formazione metodologica di etnografia,
interviste, questionari si riesce a operare in associazioni,
cooperative, ONG, centri di ricerca privati come analisti e
progettisti sociali, addetti alla ricerche preliminari di fattibilità,
conduttori di gruppi e responsabili di laboratori di vario tipo.
Cominciano a emergere anche antropologi in ruoli di
responsabilità amministrative e formative, dove una formazione
sociale di base deve unirsi a doti manageriali e gestionali
adeguate alla complessità del terzo settore. Si può intervenire
nella fase di start up come consulenti, sondare il territorio per far
emergere risorse e necessità latenti, supportare nella stesura di
mission, vision e organizzazione societaria. Dal punto di vista
dell’innovazione sociale gli antropologi culturali potrebbero
concentrarsi sui servizi alla popolazione immigrata non solo da
176
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
integrare ma anche da supportare nei processi evolutivi: penso
all’imprenditoria immigrata, all’orientamento scolastico e
professionale di seconde generazioni, di supporto alla
comunicazione tra gruppi di immigrati, all’empowerment di
comunità. Interessanti anche le tematiche dell’invecchiamento,
del benessere sociale dell’anziano e dell’attivazione di reti di
supporto territoriale. Peculiare l’ambito della comunicazione
sociale e della promozione del cambiamento culturale in vari
ambiti quali disabilità, omosessualità, emarginazione sociale,
infanzia, valorizzazione della diversità. I profili concorrenti in
questo ambito sono soprattutto psicologi sociali e di comunità,
pedagogisti, cooperanti allo sviluppo non antropologi, sociologi.
Aziende e servizi for profit
Le aziende richiedono supporto formativo e consulenziale per
l’internazionalizzazione e lo sviluppo di una cultura
dell’innovazione. Sono questi i due ambiti dove l’antropologia
culturale può dare un contributo immediato al mondo
dell’imprenditoria nostrana. Conoscenza delle lingue, del
management e dei paesi esteri di riferimento sono condizioni
imprescindibili per questo settore. Occorre sviluppare metodi di
indagine seri per reperire informazioni utili a ridurre il rischio
d’impresa e monitorare i processi di cambiamento aziendali. Gli
strumenti etnografici, la prospettiva comparata, una forte
conoscenza dei mercati sviluppata operando all’interno
dell’azienda permette di costruirsi un profilo adeguato, meglio se
incardinato su studi formali di business management. In diversi
contesti le formazioni antropologiche e interculturali stanno
dimostrando una netta superiorità rispetto alle formazioni
manageriali più tradizionali. Settori quali il security management,
il diversity management e le risorse umane sono ormai sempre più
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
177
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
‘antropologizzati’. Spesso l’ingresso in azienda avviene
ricoprendo altre mansioni, e sviluppando in seguito una
traiettoria di carriera verso un ruolo dove la propria formazione
antropologica sia uno strumento operativo quotidiano. I profili
concorrenti sono dottori in economia aziendale, psicologi del
lavoro, dottori in lingue, diplomati MBA, sociologi.
Antropologia medica e della salute
L’antropologo culturale interessato alle prospettive curative,
del benessere e della crescita personale può integrare le proprie
conoscenze con corsi strutturati di naturopatia, discipline
olistiche, counseling di vario tipo, tradizioni occidentali e orientali
volte alla crescita personale. Esistono scuole ben strutturate e con
formatori di grande esperienza anche in Italia in tutte le
discipline più conosciute. Accanto alla pratica professionale si
possono innestare momenti di ricerca personali in collaborazione
con associazioni e gruppi di ricerca legati o meno all’accademia
sulle tradizioni spirituali più diverse, sulle meditazioni,
sull’empowerment personale. Questo settore del ‘benessere non
terapeutico’ è in grande crescita nel nostro e in molti altri paesi
occidentali. Servono formazioni approfondite e attenzione alle
normative di riferimento nazionale per non incorrere nell’accusa
di abuso della professione medica o psicologica.
Formazione e istruzione
In qualità di antropologi culturali si può essere formatori per
diversi enti privati. È opportuno un percorso ad hoc che permetta
di acquisire i principali modelli formativi e strumenti operativi.
Orientarsi nella formazione di persone immigrate, o seconde
178
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
generazioni, privilegiando aspetti linguistici e comunicativi,
senza omettere di considerare ambiti formativi nuovi tarati su
precise esigenze della popolazione immigrata. Interessanti i
servizi di supporto all’istruzione, come doposcuola pomeridiani
e centri di supporto per studenti in difficoltà, che spesso vedono
la compresenza di ragazzi e ragazzi dalle provenienze più
diverse. L’interazione tra antropologia culturale e pedagogia
interculturale può dare buoni frutti in questi contesti. I profili
concorrenti sono formatori, pedagogisti, educatori, psicologi
dell’età evolutiva, sociologi.
Ricerca e divulgazione
Esistono delle possibilità nel fare ricerca sociale e culturale
fuori dall’accademia presso enti privati, associazioni di categoria,
o come ricercatori indipendenti. Gli antropologi culturali
dovrebbero consolidare le loro capacità metodologiche
soprattutto in termini quantitativi perché spesso è necessario fare
ricerche con metodologia mista. L’etnografia è efficace in
determinate condizioni e per determinati obiettivi, a volte
costruire, somministrare e analizzare un buon questionario, o
utilizzare dei test strutturati, dà risultati migliori in minor tempo.
Spesso di tratta di fare ricerche su opinioni, atteggiamenti,
preferenze, bisogni di una determinata popolazione, oppure
riguardo a degli esiti di progetti, o ancora analisi preliminari che
possano chiarire l’orizzonte operativo da intraprendere. Gli
antropologi culturali potrebbero sforzarsi di mettere a punto
degli strumenti di rilevamento ad hoc per indagare scenari di loro
competenza. Interessanti a questo riguardo gli ambiti di ricerca
più innovativi come le nuove tecnologie comunicative, il web e le
sue applicazioni, i nuovi stili di vita, l’innovazione sociale, gli
scenari della globalizzazione, le emergenze sociali, i gruppi di
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
179
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
pressione planetari, il cosmopolitismo. I profili concorrenti sono
sociologi, psicologi sociali, tutti i laureati interessati all’analisi
della contemporaneità e alla comunicazione.
Eventi, arte, spettacolo
Un settore in rapido sviluppo è quello della creazione e
gestione di eventi culturali e artistici. Utile una formazione postlauream dedicata e peculiari abilità organizzative e manageriali. Il
mondo dell’antropologia si intreccia con i beni culturali e la
promozione/marketing di eventi sociali che trovano
nell’esperienza offerta al fruitore la loro ragion d’essere. Una
formazione ulteriori garantisce la capacità di gestire la
complessità dell’event management dal punto di vista
organizzativo, contenutistico e economico. Interessante anche la
prospettiva consulenziale in qualità di antropologi culturali
specializzati in particolari settori (museale, artistico visuale,
artistico musicale ecc.).
Conclusioni
In questo contributo ho messo sul piatto alcune questioni che
la comunità degli antropologi, così come si esprime sul web in
diversi siti collegati, ritiene importanti per riflettere sul proprio
sviluppo professionale. Ho accennato alle questioni di identità, ai
percorsi formativi, alle conoscenze e alle competenze, alle
frustrazione dello scoprirsi dottori in antropologia e non sapere
cosa fare, al dibattito sull’antropologia applicata e professionale,
ad alcuni atteggiamenti utili per non appendere subito
l’antropologia al chiodo e un breve excursus su alcuni possibili
posizionamenti operativi in diversi ambiti. Molto resta ancora da
180
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Stocchero D., Riflessioni sull’antropologia culturale in versione ‘applicata e professionale’
analizzare, strutturare e dibattere: inquadramenti normativi e
burocrazia
professionale,
deontologia
professionale,
approfondimenti sulle competenze, metodologie applicate,
buone pratiche internazionali, standard formativi, associazioni di
categoria, bibliografie applicate e professionali, corsi utili e meno
utili per formarsi, utilizzo dei social network, marketing e
collaborazione con altre figure professionali….avremo modo di
affrontare anche questi temi in modalità social web. Chiudo il
contributo consigliando un volume che credo possa essere molto
utile al lettore italiano anche se prodotto negli USA: Anthropology
in practice. Building a career outside the academy di Riall W. Nolan –
Boulder London (2003).
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
181
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
Moreno Tiziani, Lucia Galasso
La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale:
l'attività di Antrocom onlus
Abstract
The debate between the different anthropologies often focuses on methods and
definitions, while the possibility of application is sidelined. We have to connect to this
aspect, however, the question more often asked by graduates in these disciplines: is
there job for anthropologists? The answer is not simple, considering the different
variables that make up the problem. We must first identify the underlying issues, not
always obvious, that concern the relationship between the anthropological disciplines
and the areas in which it could be applied. We need to understand what is the role of
the anthropologist in contemporary society and what may be its contribution, both in
social, cultural, and economic terms. Antrocom, a non-profit organization, is an
association of research and dissemination of anthropology. It has, among its
institutional purposes, the enhancement of the anthropologist as a professional figure,
able to respond to the real needs of society, through the realization of studies and
initiatives that arise from the demands of citizens and their territory.
Introduzione
L'antropologia culturale ha visto negli anni una proliferazione
subdisciplinare evidente; anche l'antropologia biologica è stata
oggetto dello stesso processo, anche se in modo più circoscritto.
Questa tendenza si spiega attraverso l'analisi di diversi fattori:
uno di questi è di tipo linguistico: il fatto di definire la disciplina
attraverso il significato più generico del termine, cioè 'studio
dell'uomo', la rende vulnerabile a interpretazioni alquanto
fuorvianti, tali da equiparare la figura dell'antropologo a quella
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
183
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
di un tuttologo. E la proliferazione subdisciplinare, dunque, non
fa che amplificare questa equivalenza semantica.
Nel contempo, la divisione tra antropologia culturale e
antropologia biologica che si registra in diversi paesi europei ed
extraeuropei, laddove è stata mutuata l'organizzazione del
sistema formativo vigente in Europa, non permette di
riconoscere i campi di ricerca che sono veri e propri ponti tra
l'interpretazione culturale e l'interpretazione biologica dell'essere
umano. Ad esempio, sia l'ecoantropologia sia l'ecologia umana
studiano il rapporto tra una popolazione umana e l'ambiente in
cui vive. Avendo approcci differenti al medesimo problema, le
due discipline non sono sovrapponibili, ma fanno sicuramente
parte di un'unica prospettiva sullo stesso orizzonte di ricerca.
Una prospettiva che viene ignorata e che non ha permesso
l'affermarsi di un approccio bioculturale sistematico allo 'studio
dell'uomo'.1
Dobbiamo allora riscontrare un problema conoscitivo che
riguarda l'antropologia, che si riflette all'esterno della disciplina
stessa, allorquando l'antropologia viene considerata tuttologia, e
al suo interno, nel momento in cui gli stessi antropologi non
riconoscono le affinità che riguardano i loro stessi colleghi. E
dunque se molti sanno dell'esistenza della figura
dell'antropologo, pochi conoscono veramente di cosa si occupa.
1
A tal proposito è utile precisare che non si tratta di ricreare l'olismo che
regnava nella disciplina nella seconda metà del XIX secolo, ma di riconoscere
quel substrato comune sia all'antropologia biologica che all'antropologia
culturale. Per spiegare questo approccio, facciamo spesso riferimento alla
formazione dei medici e dei naturalisti: dopo un percorso formativo comune,
sia i primi che i secondi si specializzano in una sottodisciplina particolare, ma
sono comunque in grado di interfacciarsi con i loro colleghi.
184
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
Antrocom onlus: scopi, storia e organizzazione
Nella primavera del 2002 queste problematiche divennero lo
sfondo di un progetto che cercava di farvi fronte, ripensando
l'antropologia come uno strumento applicativo per rispondere a
problemi concreti. Inizialmente si partì da una constatazione:
mancava un punto di incontro in rete per gli antropologi. I pochi
gruppi usenet e le mailing list erano poco frequentate, anche per
via della loro scarsa diffusione. Nacque così Anthropos,
nell'aprile 2003, l'unico portale verticale in lingua italiana a
riunire antropologi fisici e culturali, una comunità online pensata
per favorire quell'incontro di cui si sentiva la necessità. A mano a
mano che la comunità cresceva e si andava creando un gruppo
affiatato di coordinatori, si sentì l'esigenza di dare struttura a
questa esperienza. Nel marzo 2005 nacque Antrocom, rivista
online liberamente consultabile che ospita saggi e articoli di
antropologia biologica e antropologia culturale. Col tempo la
rivista, già pensata per ospitare contributi di antropologi di
diverse nazionalità, crebbe sia in termini di apprezzamenti che di
contributi sino a trovare, nel 2011, un editore negli Stati Uniti e
una distribuzione in tutto il mondo.
La rivista fu il primo passo verso la formalizzazione di un
progetto che si era avviato in puro spirito di volontariato e che
voleva continuare su questa strada. Nel giugno 2006 nacque
quindi l'associazione Antrocom, riconosciuta onlus l'anno
successivo. Il nome fu scelto per richiamare gli scopi del
progetto, già contenuti nel nome del dominio della comunità.
Antrocom come antropologia e comunità, appunto, ma anche
come antropologia e comunicazione. Uno spazio di incontro e
confronto tra antropologi e tra antropologi e pubblico, un luogo
in cui parlare di antropologia in termini semplici e dove si
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
185
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
potesse realizzare un'azione mirata a far conoscere l'antropologia
e ad applicarla a casi concreti.2
Esisteva infatti, ed esiste tuttora, una domanda di
antropologia che non è espressa in modo esplicito, ma è
formulata in altri termini proprio perché il lavoro
dell'antropologo non è conosciuto e non sono conosciuti gli
ambiti applicativi dell'antropologia.
Per riuscire nell'intento, l'associazione si approcciò al
problema pensando al 'mercato' in cui questa domanda veniva
espressa, alle azioni di 'marketing' da intraprendere e al 'target'
da soddisfare.
Il 'mercato' dell'antropologia e Antrocom onlus
Pensare all'antropologia in termini di 'mercato' e di
'marketing' non è usuale, almeno nel contesto italiano. Per
ragioni storiche e sociali, il lavoro dell'antropologo è di solito
confinato alla ricerca pura. In tal senso, l'antropologia è un fine.
Farla divenire un mezzo significa rivolgersi a un pubblico più
ampio rispetto ai soli specialisti e a 'volgarizzarla' nel senso
etimologico del termine. Un approccio che sia di ricerca pura non
è in contrasto con quest'ultima visione dell'antropologia, bensì è
in sinergia con essa. Senza la prima difficilmente esisterebbe la
seconda.
Non a caso, all'interno di Antrocom vi sono antropologi dediti
alla ricerca così come antropologi che si spendono nella
divulgazione e nella realizzazione di iniziative. E a volte i ruoli
sono scambiabili. Chi viene a far parte dell'associazione può
2
Per maggiori dettagli sulla storia dell'associazione, si veda l'articolo di
Galasso e Tiziani citato in bibliografia.
186
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
applicarsi nel campo che gli è più congeniale, e ciò si riflette
nell'organizzazione stessa di Antrocom.
Questa direttiva è uno dei motivi che ha spinto l'associazione,
a partire dal 2008, a creare gruppi e sezioni regionali che sono
parte integrante della struttura associativa. Le sezioni assolvono
a un altro concetto fondamentale che muove il progetto
Antrocom: essere presenti nelle realtà locali, dove è
effettivamente più facile applicare i metodi antropologici alla vita
quotidiana.
Ognuna delle cinque sezioni che attualmente rappresentano
Antrocom a livello regionale (Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Campania e Sicilia) ha una sua specificità che è anche
ricchezza per l'associazione stessa: antropologia applicata,
antropologia sociale, valorizzazione delle tradizioni popolari e
antropologia visuale sono alcuni degli ambiti in cui gli
antropologi dell'associazione operano.3
La constatazione da cui parte l'azione di Antrocom è che esiste
sì il mercato e una domanda tangibile, ma non c'è la corrispettiva
offerta di professionisti dell'antropologia.
La professione di antropologo, infatti, è in sostanza ancora da
costruire. Da un lato ciò significa un 'mercato' non sfruttato, dove
è possibile inserirsi cogliendo le opportunità a cui il singolo
antropologo è più portato; dall'altro implica un maggior
dispendio di energie per realizzarsi in un percorso in cui non vi
sono strade già tracciate né strumenti già creati allo scopo.
Da questo punto di vista, Antrocom onlus è una sorta di
3
L'associazione è aperta sia ad antropologi fisici che culturali. Per ragioni di
carattere statistico e di possibilità applicative, attualmente gli antropologi
culturali sono i più rappresentati, per quanto siano in fase di studio dei
progetti finalizzati a dare più spazio all'antropologia biologica, che nel nostro
paese sembra non riuscire a esprimersi al di fuori dell'ambito universitario.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
187
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
incubatore della figura dell'antropologo, che vuole valorizzare
proprio come professionista. L'antropologo che lavora in
Antrocom è stimolato a ideare e realizzare in autonomia i
proprio progetti, con l'assistenza del caso da parte
dell'associazione. Lo scopo, infatti, è di formare una figura
professionale in grado di affrontare eventuali committenze in
autonomia e di introdurlo in una rete di occasioni lavorative in
cui già opera l'associazione, in modo da fornire una prima base
di relazioni e contatti sfruttabili autonomamente per altri
incarichi.4
Antrocom, Giornale Online di Antropologia, è uno strumento
che coadiuva l'associazione in questa attività. Si tratta di un
canale su cui il neoprofessionista può pubblicare, costituirsi un
primo nucleo di pubblicazioni e farsi conoscere, anche all'estero,
soprattutto da quando la rivista è editata anche in forma
cartacea.
La linea di azione appena descritta trova applicazione sia in
progetti di tipo formativo sia di tipo esperienziale. Si tratta di
due tipologie a stretto contatto tra loro e vicendevolmente
influenzabili. Non può esserci infatti applicazione senza
formazione e, nel contempo, la formazione deve fornire gli
strumenti adatti all'applicazione. La formazione universitaria di
un antropologo non contempla nozioni utili a interpretare la
situazione lavorativa di cui stiamo discutendo in questo articolo
e, relativamente al quadro attuale, sembra compito di organismi
4
Per spiegare questo concetto, spesso paragoniamo l'associazione a un
ombrello: gli antropologi lavorano in autonomia, mentre Antrocom onlus si
preoccupa di fornire l'assistenza, le relazioni e la logistica necessaria,
'riparandoli' dai problemi legati alla loro implementazione. A mano a mano
che l'antropologo diviene più esperto, l'ombrello viene chiuso gradualmente.
188
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
terzi colmare questa lacuna.
Alcuni esempi applicativi
Dei progetti compiuti o in via di compimento da parte di
Antrocom onlus, ne vengono qui descritti alcuni nelle loro linee
generali. Sono particolarmente interessanti rispetto allo scopo di
questo
articolo,
ovvero
discutere
la
valorizzazione
dell'antropologo come figura professionale. Come tale,
l'antropologo si deve confrontare con le richieste della società
civile e ponderarne le necessità. Ponderare, in questo contesto,
significa trovare il giusto equilibrio tra ricerca antropologica e
soddisfacimento del bisogno in tempi accettabili, per quanto ciò
risulti difficile soprattutto in contesti in cui le problematiche che
fanno sorgere la necessità sono complesse e poco informative.
Antrocom onlus Lombardia sta conducendo uno studio con
l'obiettivo di comprendere e raccontare le esperienze e i progetti
di vita degli ex detenuti in una fase storica di aumento del
controllo sociale e di diminuzione delle risorse per la
riabilitazione sociale.5 L'uscita dal carcere è di per sé
un'esperienza che produce alienazione nel momento in cui il
soggetto cerca di misurarsi con le dinamiche quotidiane del
mondo esterno. Il meccanismo di reinserimento sociale agisce in
modi spesso imprevisti nel divario tra aspettative dell'ex
detenuto, modello di routine acquisito in carcere fino al
momento del rilascio e potere 'modellante' dell'istituzione
carceraria stessa. Da qui la ricerca, che esplora tre ambiti definiti:
5
L'argomento, di per sé vario e particolarmente interessante, è affrontato in
diversi volumi. Qui si conigliano gli scritti di De Giorgi e Melossi, citati in
bibliografia.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
189
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
l'esperienza soggettiva del reinserimento, l'analisi dei progetti già
avviati allo scopo e il monitoraggio delle modalità di intervento
degli operatori. Si tratta dunque di seguire da vicino sia gli ex
carcerati sia gli operatori stessi, anche al fine di comprendere le
procedure, individuare le carenze e ottimizzare il processo di
reinserimento.
Antrocom onlus Veneto ha focalizzato la sua attenzione sul
dialogo tra archeologia e antropologia e sulla divulgazione del
patrimonio storico e artistico del Triveneto, in collaborazione con
società e associazioni che operano già in questo contesto. Gli
antropologi sono chiamati a considerare il rapporto tra vestigia
antiche, memoria e percezione del passato da parte di diverse
componenti della società. Non si tratta dunque di semplice
valorizzazione finalizzata a incrementare il turismo, ma di
considerare il passato come base storica di una determinata
società e integrazione del suo divenire sociale e culturale.6 Il
progetto ha due scopi principali: fornire agli archeologi
strumenti di interpretazione del passato di tipo antropologico, al
fine di trovare nuovi spunti di ricerca; interpretare il paesaggio
6
A questo proposito, Antrocom onlus Veneto cita David Lowenthal (si veda
in bibliografia), secondo cui il passato è ovunque, che sia celebrato o respinto,
atteso o ignorato, il passato è onnipresente. La distruzione dei Buddha di
Baghram non cancella il passato, al contrario, il vuoto talvolta può essere
anche più significativo dell'oggetto, l'assenza a volte è più visibile della
presenza. Un tempo confinato solo nei musei, il passato si esibisce nei vari
paesi per puntellare regimi, celebrare antiche glorie, creare nuove nazioni.
Partiti politici si combattono brandendo spezzoni diversi del passato di un
paese, traggono dubbi paragoni e favoriscono audaci ricostruzioni
nell'industria dell'heritage. Chi ha pochi monumenti antichi li ricrea nei parchi
storici, che ne ha troppi a volte li ignora e li lascia andare in rovina.
190
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
antico e il paesaggio della memoria del Triveneto,
considerandone gli aspetti meno conosciuti in termini di
processo di studio, catalogazione e fruizione nel corso del tempo.
Si tratta di una ricerca che vede ampie opportunità di
applicazione anche in altri ambiti regionali e che tende ad
armonizzare le richieste della contemporaneità con le esigenze di
conservazione del patrimonio storico e archeologico.
La Burattinaria Fest è stata la conclusione di un percorso di
studio e ricerca sul campo condotto da Antrocom onlus
Campania in Basilicata, per riscoprire le leggende e le tradizioni
locali relazionandole al sentimento popolare odierno. La
cittadina di Rapone, luogo dello studio, è stata al centro di questa
riscoperta divenendo essa stessa protagonista. Le sue vie e i suoi
cittadini sono stati testimoni di un evento distribuito su tre giorni
e basato sul lavoro degli antropologi. La ricerca sul campo ha
prodotto inoltre delle proposte operative per il riassetto
urbanistico di Rapone e per una nuova lettura del territorio alla
luce della riscoperta della memoria e dell'identità dei luoghi.
Il progetto presentato alla X Biennale di Architettura di
Venezia da Antrocom onlus, al seguito del gruppo di architetti
Mass Studio, mirava a descrivere le relazioni tra struttura
urbana, gruppi sociali e territorio in modo che le informazioni
raccolte fossero impiegabili in campo architettonico. La
progettazione di nuovi edifici, al di là delle difficoltà tecniche,
impone l'analisi dell'impatto sull'ambiente e su eventuali
insediamenti già presenti, alla luce di dinamiche culturali ed
ecologiche già presenti. I dati raccolti dagli antropologi possono
coadiuvare il lavoro di architetti e ingegneri nella
programmazione di nuove opere, e le amministrazioni nella fase
di razionalizzazione del territorio.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
191
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
A Santa Maria La Fossa, in provincia di Caserta, Antrocom
onlus Campania è stata chiamata a realizzare uno spot
audiovisivo per promuovere le politiche ambientali e territoriali
del comune. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di
UncoSo Factory e della Scuola di Cinema di Napoli. L'idea di
fondo è rivalutare i luoghi di Santa Maria La Fossa per una
nuova visione dell’immaginario collettivo e la restituzione di
processi identitari, coinvolgendo gli abitanti del luogo, che in
questo modo sono stati – e si sono sentiti – responsabilizzati
verso la propria comunità e il proprio territorio. Nella
costruzione di questo nuovo immaginario collettivo si è dato
ampio spazio alle scuole.
L'associazione è sempre stata molto attenta alla formazione,
specialmente verso i più piccoli, consci del fatto che saranno le
generazioni future a dover sopperire alle mancanze delle
generazioni attuali. Partire dai bambini significa lavorare su un
terreno pressoché scevro da condizionamenti e coltivare semi che
avranno il tempo e le modalità per svilupparsi in maniera
robusta.
Una nuova opportunità per Antrocom si è palesata con la
nomina a direttore scientifico del Museo della Civiltà Contadina
e dell'Ulivo di Lucia Galasso, già Segretaria Nazionale di
Antrocom onlus. In questo modo l'associazione può non solo
confrontarsi con l'ambito della museografia e del ricco universo
di ambiti di ricerca e attività che ruotano intorno all'universo dei
musei etnografici, ma anche utilizzare il museo stesso come
valido supporto sul quale iniziare tutta una serie di iniziative di
più ampio respiro.
Prendendo come linea guida la definizione di museo fornita
192
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
dall'ICOM (International Council of Museums),7 secondo cui
Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio
della società e del suo sviluppo; è aperto al pubblico e compie ricerche
che riguardano le testimonianze materiali dell’umanità e del suo
ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le
espone a fini di studio, educazione e diletto.
Si sta cercando di risvegliare un museo per troppo tempo
lasciato nel torpore rimettendolo in comunicazione non solo con
il suo territorio ma anche con gli interessi di coloro che vengono
anche fuori dalla Ciociaria per visitarlo. Questo si sta attuando
tramite iniziative che rivitalizzano la sua memoria materiale ma
soprattutto che si concretizzano attraverso il 'fare' nuovamente la
sua memoria immateriale.
Il museo, infatti, deve essere un'istituzione culturale dinamica
che rappresenti l'identità di un territorio e della comunità che lo
abita. Non deve solo conservare la memoria di luoghi e persone,
ma interagire con la gente e con le attività che essi svolgono
quotidianamente.
Le parole chiave utilizzate sono infatti 'fare' e 'comunicare',
chiavi di volta per evitare che il museo rimanga un'istituzione
passiva alla sguardo del visitatore. Così il 'fare' si sta
concretizzando in tutta una serie di laboratori che riprendono le
fila dei vecchi lavori artigianali (intreccio del vimini, filatura del
7
La definizione è tratta dal 'Codice Etico dell'ICOM per i Musei'. Il Codice
etico professionale dell’ICOM è stato adottato all’unanimità dalla 15^
Assemblea Generale dell’ICOM a Buenos Aires (Argentina) il 4 novembre
1986. È stato modificato dalla 20^ Assemblea Generale a Barcellona (Spagna) il
6 luglio 2001, che lo ha rinominato Codice etico dell’ICOM per i Musei, ed
infine revisionato dalla 21^ Assemblea Generale a Seoul (Repubblica di Corea)
l’8 ottobre 2004. Il documento è citato in bibliografia.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
193
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
lino, panificazione...) che consentono al museo di far rivivere
nuovamente gli oggetti che custodisce, tenendo i corsi al suo
interno, animando così le sue sale con i ritmici gesti del lavoro
manuale. Lavoro aperto ai ragazzi di Pastena così come agli
appassionati che vengono fin da lontano per re-imparare una
vecchia arte. Si cerca così di offrire qualcosa di realmente
funzionante, di utile e appagante sotto il profilo di quello che
Richard Sennett (2008) definisce “uomo artigiano” e nel
contempo non si lascia morire la memoria di un tempo
quotidiano fatto di fatica e di lavoro e troppo spesso oggetto di
una retorica buonista che fa della vita contadina un paradiso
perduto.
Il tentativo di valorizzare tutto questo patrimonio non tanto
materiale quanto immateriale è invece deputato alla
comunicazione di cui il museo è oggetto di studio. Si è partiti da
un sito web all'avanguardia nella grafica e ancorato alle
piattaforme dei social network più importanti (Twitter, Facebook
e Youtube) e si sta continuando attraverso la pianificazione di
giornate di studio che diano profondità ai laboratori artigianali
progettati.
Il museo di Pastena è un laboratorio a cielo aperto per
Antrocom, ma è anche una grande opportunità per tutti gli
antropologi interessati a collaborare; uno strumento per chi ha
voglia di fare anche se non strutturato accademicamente, una
fucina per giovani menti e talenti. Ci piace immaginarlo come il
primo museo demoantropologico concepito come un FABlab.8
8
FABlab è l'acronimo di fabrication laboratory. Nati come un progetto pilota
presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), i FABlab si sono diffusi
in diverse nazioni, con lo scopo di offrire strumenti utili a soddisfare i bisogni
progettuali delle persone comuni, che arrivano in questi laboratori con l'idea e
la voglia di crearsi in proprio gli oggetti che possono essergli utili. Per un
194
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
Non a caso è allo studio la possibilità di aprire il catalogo del
museo, recentemente finanziato dalla Provincia di Frosinone, a
contributi di antropologi specializzati nelle tematiche del museo
stesso.
Gli esempi sopra riportati9 hanno cercato di mostrare gli ampi
interessi e le attività di Antrocom onlus. Nel corso degli anni le
iniziative portate a termine hanno contribuito a rendere più
solide le premesse su cui è stata fondata l'associazione, ma anche
a costruire un'immagine concettualmente concreta presso gli
utilizzatori finali dei servizi implementati dall'associazione. Si
tratta di un aspetto particolarmente interessante, alla luce del
fatto che l'apparato che, all'interno di Antrocom onlus, si occupa
della promozione e, in sostanza, della pubblicità, è di dimensioni
relativamente ridotte.
La presenza sul territorio e il dialogo diretto con gli
utilizzatori finali, che spesso si identificano con gli stessi
finanziatori dei progetti, sono risultati essere molto più efficaci e
proficui.
Ciò non toglie che, dalla nascita dell'associazione, i ricercatori
impiegati nella realizzazione dei progetti abbiano dovuto
formarsi continuamente sia dal punto di vista antropologico sia
dal punto di vista burocratico e lavorativo.
È vero infatti che l'associazione provvede all'espletamento
delle pratiche necessarie all'avvio e al mantenimento di un
progetto, ma si preoccupa nel contempo di formare i suoi Soci,
specialmente se interessati dalla meccanica di realizzazione di
approfondimento, si veda il libro di Neil Gershenfeld citato in bibliografia.
9
Per ulteriori esempi si può visitare il sito di Antrocom onlus all'indirizzo
www.antrocom.org.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
195
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
uno studio sul campo, in modo che conoscano i passi da
compiere e le istituzioni da interpellare nel caso vogliano
cimentarsi nella libera professione.
In ciò, le singole competenze dei Soci sono state importanti per
avviare un processo di formazione interno. Da sole, esse non
avrebbero potuto essere di tale utilità, ma l'averle messe in
comune ha contribuito a limitare i costi e a velocizzare i tempi di
apprendimento.
Una proposta alle associazioni antropologiche
In tal senso, la possibilità di prestare le competenze acquisite
anche al di fuori dell'associazione sarebbe uno sbocco del tutto
naturale sia per quanto riguarda gli scopi statutari, sia per le
attività e le iniziative organizzate. Da qualche tempo, all'interno
di Antrocom onlus, si sta pensando a una rete di associazioni
antropologiche che possano dialogare tra loro, avanzare proposte
concrete su obiettivi comuni e scambiarsi reciprocamente le
competenze acquisite. Per quanto gli ambiti di operatività e le
strutture organizzative delle singole associazioni siano diversi
(non fosse altro che la loro nascita si deve, molto spesso, a
bisogni diversi tra loro), è possibile immaginare un piano di
lavoro comune e di interscambio che trovi concretezza in una
organizzazione di carattere più ampio. Una sorta di 'federazione',
dunque, che permetta l'apertura e il mantenimento di canali di
collaborazione fattiva tra le associazioni stesse.
Non si tratta sicuramente di un progetto semplice da
realizzare. È necessario un confronto diretto e sincero tra le parti,
nonché la lungimiranza di guardare a obiettivi che possono
essere collocati anche in un futuro lontano. Tuttavia,
196
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
considerando il quadro attuale dell'antropologia italiana e le
considerazioni esposte in questo articolo, i vantaggi di una tale
operazione sono di gran lunga superiori alle difficoltà che si
potrebbero incontrare.
Di esempi federativi ce ne sono diversi. Probabilmente il più
noto è costituito dall'American Anthropological Association, con
sede negli Stati Uniti; in Italia si potrebbe guardare a realtà come
la Federazione Italiana Scienze della Vita.
Da notare che la prospettiva federale andrebbe a supplire le
problematiche connesse con l'istituzione di un ordine
professionale, ovvero la burocratizzazione, la mancanza di
concorrenza e la carenza di regolamenti applicabili. Fermo
restando che
Direttiva D36/2005/CE emanata dall'Unione
Europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
sconsiglia la creazione di ordini professionali.10
Conclusioni
L'antropologia è uno strumento efficace e flessibile per
comprendere le complessità che viviamo ogni giorno, siano esse
di carattere sociale, culturale o biologico. Dare risposte articolate
in tempi abbastanza brevi è divenuto un fattore determinante,
soprattutto per garantire flessibilità operativa e capacità di
risoluzione delle problematiche che si presentano di volta in
volta. Ovvero, l'antropologia è capace di favorire adattamenti di
diversa natura allorquando sia necessario seguire un
cambiamento. Ma lo scarso riconoscimento che la figura
10
A tal proposito, uno degli Autori del presente articolo ha affrontato
l'argomento in modo più dettagliato sul blog 'Professione Antropologo', citato
in bibliografia.
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
197
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
dell'antropologo ottiene non consente di operare attivamente su
questi cambiamenti, nonostante si sia visto che le condizioni di
mercato esistano. Soprattutto ora, che i mutamenti di quegli
assetti economici che sembravano monolitici impone una seria
riflessione e un ripensamento di un intero sistema culturale.
L'antropologo deve, innanzitutto, saper riconoscere questi
nuovi campi di intervento e deve saper utilizzare anche
strumenti che, a prima vista, non fanno parte del suo bagaglio
formativo. Deve, in poche parole, saper osare. Solo così, uscendo
da un non-ruolo in cui la sua figura è stata confinata, potrà
esprimere la sua professionalità.
In questo, le associazioni di antropologi sono un aiuto e nel
contempo uno stimolo, a patto di sapersi confrontare e trovare
momenti di dialogo costruttivo sia al loro interno che all'esterno,
conservando comunque le proprie specificità, essendo state
plasmate dai bisogni e dalle necessità che hanno portato proprio
alla loro nascita.
Antrocom onlus, il cui progetto di base ha toccato nel 2012 i
dieci anni di esistenza, è una delle associazioni che hanno
iniziato a creare le condizioni per questo dialogo e per il
riconoscimento della professione dell'antropologo. È però
necessario andare oltre e visualizzare una nuova visione che
spinga l'antropologia oltre i limiti autoimposti per far emergere
quelle componenti di innovazione che sono proprie della
disciplina. A partire dalla formazione, procedendo per piani e
progetti concreti, bisogna ripensare l'intero percorso di
costruzione dell'identità dell'antropologo. Costruzione che, in
realtà, si muove su due piani distinti quanto compenetrati: ricostruzione verso l'interno, nel senso che il singolo antropologo
deve prendere coscienza del proprio ruolo e della propria
identità professionale; costruzione verso l'esterno, dove la
198
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
formazione dell'immagine pubblica deve passare per il contatto
diretto con le istituzioni e soprattutto con i cittadini.
L'antropologo deve dunque prendere possesso del ruolo che
gli appartiene, utilizzando gli strumenti che ha a disposizione e il
filtro conoscitivo della realtà che gli è proprio. L'associazionismo
antropologico sembra aver riconosciuto il problema e aver
indicato le possibili soluzioni. In alcuni casi ha proposto anche
interventi concreti, che tuttavia vanno ampliati e ridiscussi alla
luce degli ultimi cambiamenti socio-economici.
Solo un approccio partecipativo riuscirà a proporre soluzioni
durature nel tempo. Solo la persecuzione di un obiettivo comune
porterà a quella condivisione e a quella sinergia necessarie per
far emergere la figura professionale dell'antropologo senza
passare attraverso uno sterile corporativismo.
Bibliografia
DE GIORGI, A.
2002
Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo, Roma,
DeriveApprodi.
GALASSO, L. - TIZIANI, M.
2007
“Antrocom, an opportunity for Anthropology”, in Journal of
Anthropological Sciences, 85, pp. 195-203, consultato il 15/06/2012 su
http://www.isitaorg.com/jass/Contents/2007%20vol85/Articoli/Tiziani.pdf
GERSHENFELD, N.
2008
Fab - Dal personal computer al personal fabricator, Torino, Codice
Edizioni (ed. or. 2008, FAB: The Coming Revolution on Your Desktop-From Personal Computers to Personal Fabrication, New York, Basic
Books)
ICOM (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS),
2004
Codice etico dell’ICOM per i musei, consultato il 15/06/2012 su
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/italy.pdf
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
199
Tiziani M., Galasso L., La valorizzazione dell'antropologo come figura professionale.
MELOSSI, D.
2002
Stato, controllo sociale, devianza, Milano, Bruno Mondadori.
LOWENTHAL, D.
1985
The Past is a Foreign Country, Cambridge, Cambridge University Press.
TIZIANI, M.
2011
Un ordine professionale per gli antropologi?, consultato il 15/06/2012 su
http://www.professioneantropologo.it/2011/06/02/un-ordineprofessionale-per-gli-antropologi/
200
Intrecci. Quaderni di antropologia culturale, Anno I, n°1
Gli autori
Domenico Branca è dottorando in Antropologia Sociale e Culturale all'Universitat Autònoma de
Barcelona dove lavora ad un progetto sull’etnonazionalismo fra gli Aymara del sud peruviano. Ha
condotto ricerche sul campo a Derry (Irlanda del Nord) e in Sardegna.
Emiliano Branca, studente magistrale di Servizio Sociale e Politiche Sociali all'Università di Sassari,
si occupa dello studio della devianza e della marginalità minorile, della storia della famiglia e del
controllo sociale letto attraverso una prospettiva storico-sociale.
Manuela Casu, dottoranda in Studi filologici e letterari presso l’Università di Cagliari con un
progetto incentrato sull’analisi del patrimonio culturale indigeno all’interno dei curricula
scolastici di EIB (educación intercultural bilingüe) elaborati da Formabiap, ha partecipato al
progetto di ricerca Amazonía: mitos occidentales y pensamiento indígena contemporaneo. Ha svolto
ricerca sul campo ad Iquitos (Perù) e ha realizzato un laboratorio di scrittura creativa presso la
scuola di Formabiap.
Lucia Galasso, laureata in Antropologia culturale, è segretario nazionale di Antrocom Onlus,
associazione di ricerca e di divulgazione antropologica, e Direttore scientifico del Museo della
Civiltà Contadina e dell’Ulivo di Pastena (FR). Specializzata nello studio dell’evoluzione culturale,
dell’antropologia alimentare e della storia delle religioni.
Valentina Mura, laureata in antropologia culturale presso l'università di Sassari, si occupa di
studi sulle comunità rom e di dialogo interculturale
Stefano Pau, dottorando in Studi Filologici e Letterari con specializzazione in Letteratura
Ispanoamericana, si occupa della raccolta e dell’analisi di opere di letteratura scritta e orale
peruviana e dell conflitto armato interno peruviano dell'ultimo quarto del XX secolo.
Alessandro Pisano, laureato in antropologia culturale a Sassari, ha condotto ricerche nel campo
dell’antropologia delle migrazioni e dei processi di costruzione identitaria in Sardegna.
Davide Stocchero, laureato in psicologia sperimentale e perfezionato in antropologia culturale a
Padova, ha fatto ricerca sul campo in Guinea Bissau. Socio di Antrocom Onlus, si interessa di
antropologia applicata e di innovazione culturale e sociale.
Moreno Tiziani, presidente dell’associazione di ricerca e divulgazione antropologica Antrocom
Onlus, si occupa di divulgazione dell'antropologia e delle sue potenzialità per le aziende e le
istituzioni tramite articoli e consulenze.
203