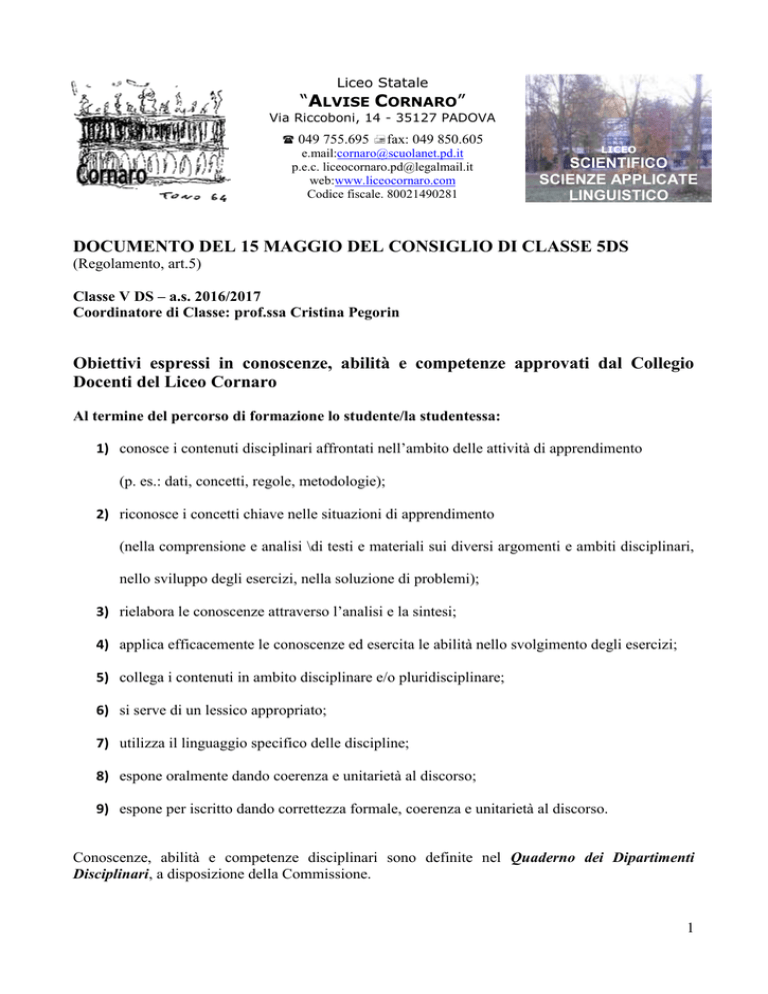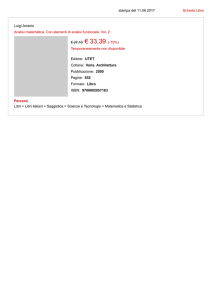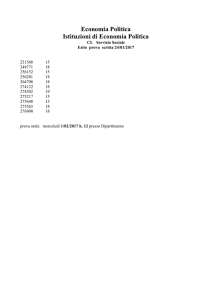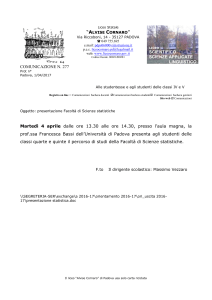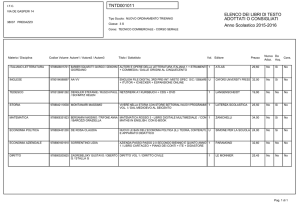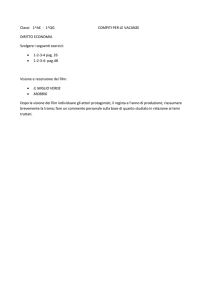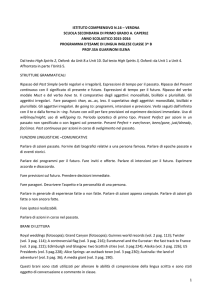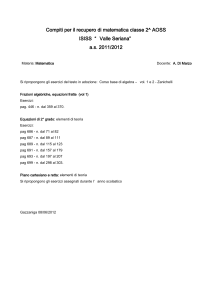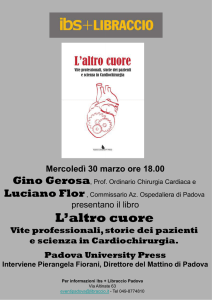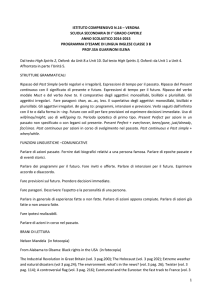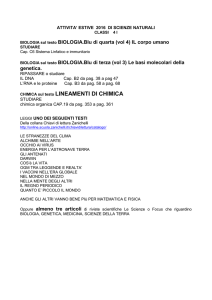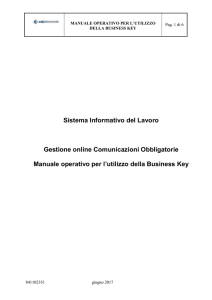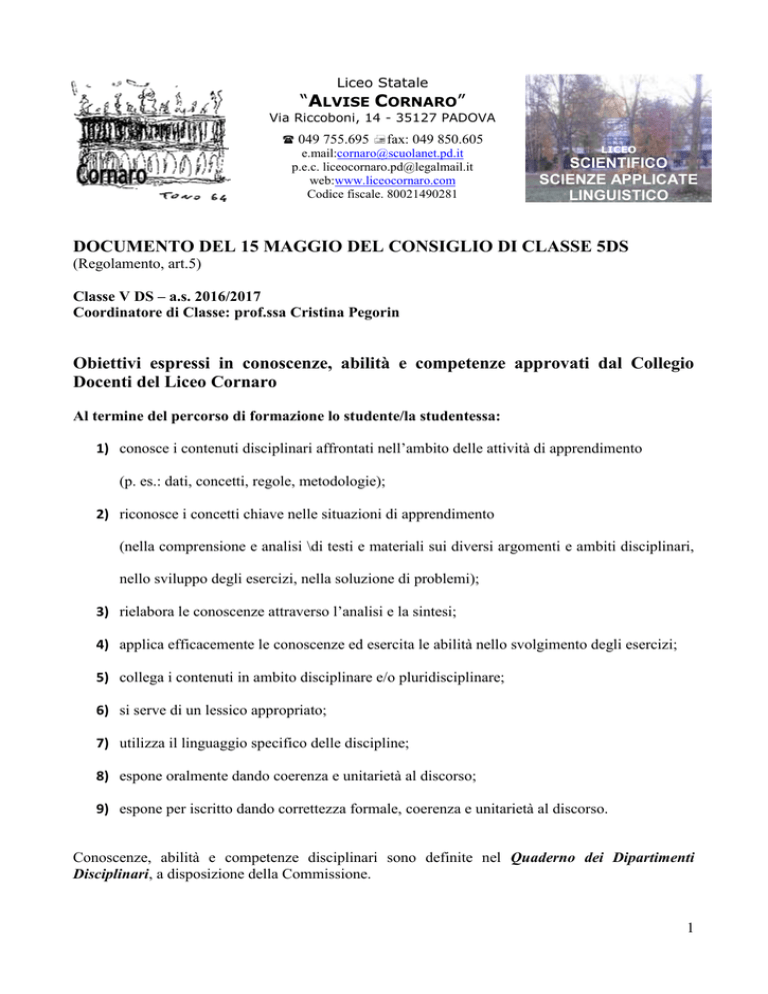
Liceo Statale
“ALVISE CORNARO”
Via Riccoboni, 14 - 35127 PADOVA
049 755.695 fax: 049 850.605
e.mail:[email protected]
p.e.c. [email protected]
web:www.liceocornaro.com
Codice fiscale. 80021490281
LICEO
SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
LINGUISTICO
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5DS
(Regolamento, art.5)
Classe V DS – a.s. 2016/2017
Coordinatore di Classe: prof.ssa Cristina Pegorin
Obiettivi espressi in conoscenze, abilità e competenze approvati dal Collegio
Docenti del Liceo Cornaro
Al termine del percorso di formazione lo studente/la studentessa:
1) conosce i contenuti disciplinari affrontati nell’ambito delle attività di apprendimento
(p. es.: dati, concetti, regole, metodologie);
2) riconosce i concetti chiave nelle situazioni di apprendimento
(nella comprensione e analisi \di testi e materiali sui diversi argomenti e ambiti disciplinari,
nello sviluppo degli esercizi, nella soluzione di problemi);
3) rielabora le conoscenze attraverso l’analisi e la sintesi;
4) applica efficacemente le conoscenze ed esercita le abilità nello svolgimento degli esercizi;
5) collega i contenuti in ambito disciplinare e/o pluridisciplinare;
6) si serve di un lessico appropriato;
7) utilizza il linguaggio specifico delle discipline;
8) espone oralmente dando coerenza e unitarietà al discorso;
9) espone per iscritto dando correttezza formale, coerenza e unitarietà al discorso.
Conoscenze, abilità e competenze disciplinari sono definite nel Quaderno dei Dipartimenti
Disciplinari, a disposizione della Commissione.
1
1. Presentazione sintetica della classe:
1.1 Storia del triennio della classe
CLASSE
TERZA
QUARTA
QUINTA
ISCRITTI ALLA
STESSA CLASSE
ISCRITTI DA
ALTRA CLASSE
28
28
27
1
1
-
PROMOSSI A
GIUGNO
NON AMMESSI
ALLA CLASSE
SUCCESSIVA O RITIRATI
16
17
-
1
-
1.2 Continuità didattica nel triennio
DISCIPLINE
Religione
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Disegno e Storia dell’arte
Educazione Fisica
DOCENTI 2014/2015
DOCENTI 2015/2016
DOCENTI 2016/2017
Lanfranco Gianesin
Paola Rubinato
Paola Rubinato
Vincenzo Pasquarella
Anna Chitarin
Francesca Palazzo
Anna Collauto
Renzo Bortelli
Claudia Sagrillo
Marco Anacleto Ronga
Giampaolo Monaco
Davide Penello
Laura Lippi
Laura Lippi
Roberto Rigoni
Loretta Barison
Loretta Barison
Cristina Pegorin
Adriana Giusto
Claudia Sagrillo
Marco Anacleto Ronga
Giampaolo Monaco
Davide Penello
Laura Lippi
Laura Lippi
Roberto Rigoni
Loretta Barison
Loretta Barison
Cristina Pegorin
Cristina Pegorin
Claudia Sagrillo
Marco AnacletoRonga
Giampaolo Monaco
1.3 Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi raggiunti
La classe 5DS è composta da 27 studenti, 12 maschi e 15 femmine. Nel corso del triennio il gruppo
classe non ha subito grandi trasformazioni, in particolare tra il quarto e il quinto anno il gruppo è
rimasto invariato.
Durante il terzo anno, nel passaggio dal biennio al triennio, sono emerse fragilità e difficoltà diffuse
dovute alla necessità di uno studio più approfondito e articolato in varie materie. La classe ha
attraversato un periodo complesso che ha determinato, in molti studenti, un livello di ansia elevato e
difficile da gestire sia nelle relazioni con i compagni, che con insegnanti e genitori.
L’atteggiamento collaborativo di tutti ha successivamente permesso una distensione generale dei
rapporti e un approccio più sereno dei ragazzi alle normali attività didattiche anche se il livello di
ansia rimane una componente non trascurabile per molti.
Il consiglio di classe è rimasto sostanzialmente il medesimo nel corso degli ultimi due anni, ma c’è
da segnalare una discontinuità, non senza ripercussioni, per quanto riguarda l’insegnamento della
fisica, in quanto nel quinquennio si sono avvicendati cinque diversi docenti.
Nel corso dell’ultimo anno la classe è risultata abbastanza omogenea e unita, l’atteggiamento
generale è stato propositivo, il comportamento educato e corretto. In generale il livello di
maturazione e responsabilità raggiunto risulta abbastanza adeguato.
Il gruppo classe ha dimostrato un interesse vivo e un impegno nello studio personale e nello
svolgimento dei compiti assegnati regolare e continuo.
Nella classe si possono riconoscere tre fasce di merito.
La prima, dal profitto molto buono in tutte le discipline (con punte di eccellenza in alcune materie),
è composta da studenti molto attivi, curiosi e capaci, che hanno acquisito un metodo di studio
efficace e del tutto autonomo, conoscenze approfondite in diversi ambiti, abilità di analisi critica e
sintesi dei contenuti. Questi studenti sono in grado di effettuare collegamenti trasversali e di
esprimersi in modo adeguato e con lessico specifico.
2
La seconda, composta da una decina di studenti, presenta ragazzi che hanno mantenuto un impegno
abbastanza regolare nello studio, manifestando tuttavia difficoltà nel gestire contemporaneamente e
in modo continuo diverse materie. Il profitto di questi è positivo con valutazioni più elevate
nell’ambito umanistico e qualche carenza in alcune discipline.
È presente un gruppo di studenti (5-6) che per motivi diversi (abilità cognitive, difficoltà personali,
malattia, lacune pregresse) presenta un profilo più disarmonico con alcune difficoltà in matematica,
fisica ed inglese, spesso determinate da un percorso di studi irregolare.
2. Contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione
Nell’ambito delle singole discipline: si rinvia alle schede per ogni disciplina: All. A
Nell’ambito delle Aree disciplinari o comunque in ambito pluridisciplinare: si rinvia alle schede
concernenti le attività pluridisciplinari: All. B
3. Attività di potenziamento e integrazione del curricolo
Nell’ambito dei progetti di potenziamento e integrazione del curricolo, la classe ha partecipato o
parteciperà alle seguenti attività:
- 23 Novembre visita guidata alla mostra “Storie dell’Impressionismo” a Treviso presso il
museo di S.Caterina;
- 25 gennaio conferenza con i detenuti con il Progetto Carcere;
- 24 aprile spettacolo teatrale “La sfinge” su E.Fermi al cinema Rex;
- 3 giugno visita guidata alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.
Nell’ambito degli approfondimenti di carattere storico:
- 25 marzo conferenza con il prof. M.Mistri sui trattati di Roma e sul processo di integrazione
europea;
- 04 aprile visita alla Sinagoga di Padova e Museo Ebraico;
- 06 aprile visita alla mostra fotografica sul genocidio Armeno.
Nell’ambito dei progetti sulla sicurezza e sull’educazione alla salute:
- 17 marzo conferenza sul doping;
- 06 marzo con il prof. Conte conferenza su “Stili di vita e cancro”;
- 10 maggio lezione teorica e pratica di primo soccorso.
Attività sportive:
- 30 novembre gara d’Istituto di Bowling;
- 7 giugno attività di tiro a segno.
La classe ha partecipato o parteciperà alle seguenti attività in lingua inglese:
- 26 gennaio spettacolo “Pygmalion” al Multisala Pio X;
- 19 maggio conferenza del prof. J. Quinn sul romanzo “1984” di George Orwell;
- aprile-maggio attività CLIL: approfondimento su Dalì in inglese mediante trasmissione della
BBC “Salvador Dalì: a Master of the Modern Era - Mikos Arts” prof. Rigoni e Prof. Ronga.
Nei giorni 08 marzo - 11marzo 2017 la classe è stata in viaggio di istruzione a Praga e Mauthausen.
3
4. Simulazioni di Terza Prova effettuate e criteri di valutazione adottati
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova
Prima simulazione: Data28 Novembre 2016
Tipologia: B - Tempo a disposizione: 3 ore
Materie coinvolte: Storia (2 domande), Inglese (3 domande), Fisica (3 domande-10 righe), Latino (2
domande)
STORIA
1. Illustra l’organizzazione dell’India sotto il dominio inglese, mettendo in rilievo gli aspetti
politici ed economici.
2. Esponi quale fu la posizione della Chiesa nella disputa tra liberalismo e marxismo, in
relazione alla questione operaia.
INGLESE
1. Why is it negative for poetry to be “moral” according to Percy B. Shelley?
2. Explain John Keats's distinction between the Man of Genius and the Man of Power.
3. What does the subtitle “The Modern Prometheus” allude to in “Frankenstein”?
FISICA
1.
a) Descrivi l’effetto Joule.
b) Con riferimento al circuito in figura sapendo
che gli estremi A e B sono collegati ad un
generatore da 12V, calcola la potenza dissipata
dalle 3 resistenze giustificando i calcoli
eseguiti.
2.
a) Definisci le grandezze fisiche campo elettrico e potenziale spiegando la relazione tra i
due eventualmente aiutandoti con un esempio.
b) Se un elettrone viene liberato da fermo in un campo elettrico uniforme orizzontale di 2 ∙
106 𝑁/𝐶 diretto nel verso positivo dell’asse x che velocità raggiunge dopo aver viaggiato
per 10cm? In quale direzione si è mosso? Spiega.
Un elettrone si muove con velocità v dalla costa orientale a quella occidentale degli Stati
Uniti, mentre un elettrone si muove con la medesima velocità dal sud degli Stati Uniti al
Canada.
a) Stabilisci se le due cariche risentono di una forza magnetica descrivendone le
caratteristiche (direzione e verso) e giustificando la tua risposta.
b) Calcola il valore di tale forza nel caso in cui v sia un quarto della velocità della luce.
c) Una carica di 2𝜇𝐶 viaggia con la stessa velocità in direzione Est-30°Nord, quanto vale la
forza magnetica?
3.
LATINO
1. L'arte allusiva nelle Odi di Orazio (con riferimenti ai testi)
2. L'amore in Tibullo, Properzio e Ovidio elegiaco con riferimento ai testi.
4
Seconda simulazione:Data 20 Marzo 2017
Tipologia: B - Tempo a disposizione : 3 ore
Materie coinvolte: Fisica (3 domande- 10 righe), Scienze (3 domande- 8 righe), Inglese(3 domande- 10
righe), Filosofia ( 2 domande-10 righe)
FISICA
1.
a) Descrivi brevemente la legge di Ampere-Maxwell.
b) Un dielettrico di costante 𝜀 = 𝜀𝑟 𝜀0 = 3,5 ∙ 10−11 𝐶 2 /𝑁𝑚2 riempie completamente il volume
fra le armature di un condensatore. Il flusso del campo elettrico varia secondo la legge
Φ(𝐸) = 𝑎𝑡 3 𝑐𝑜𝑛𝑎 = 8,0 ∙ 103 𝑉𝑚/𝑠 3 , in quale istante la corrente di spostamento vale 21𝜇𝐴?
2.
Dopo aver definito la grandezza flusso di campo elettrico enuncia il teorema di Gauss per
il campo Elettrico e utilizzalo per ricavare l’espressione del campo elettrico generato da
una distribuzione piana infinita di cariche.
Una barra conduttrice di massa m=30g è a contatto con due rotaie conduttrici poste
verticalmente e separate da una distanza L=40cm, l’intero sistema è immerso in un
campo magnetico di intensità B=0,5T diretto come in figura. Sapendo che la barra scende
senza attrito e che 𝑅 = 40Ω:
a) descrivi il moto della barretta quando viene lasciata libera
b) stabilisci se si genera corrente specificandone il verso e giustificando in modo esauriente
la tua affermazione
c) calcola la velocità della barra molto tempo dopo che ha iniziato a cadere.
3.
SCIENZE
1. Che relazione esiste tra struttura delle proteine e DNA? (massimo 7-8 righe).
2. Spiega come la glicemia sia un parametro ematochimico molto importante regolato da
ormoni specifici (massimo 7-8 righe).
3. Come viene prodotto un anticorpo monoclonale e come viene utilizzato? (massimo 7-8
righe)
INGLESE
1. Which features of the sacrifice scene in John Keats's “Ode on a Grecian Urn” sadden the
poet? Why?
2. How does Rochester account for his marriage proposal to Jane after she finds out that he
is already married?
3. What does the Duke's reference to a bronze statue underline in Robert Browning's “My
Last Duchess”?
FILOSOFIA
1. Analizza il concetto di alienazione in Marx .
2. Analizza il significato del termine rappresentazione secondo Schopenhauer e sviluppa
opportuni possibili riferimenti.
5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA
GIUDIZIO
Gravemente insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
buono/ottimo
INDICATORI
CONOSCENZE
Correttezza e
pertinenza dei
contenuti
ABILITÀ
Applicazione di
concetti e procedure;
capacità espositiva e
padronanza dei
linguaggi specifici
1/2
3
3,5
4
Conosce i contenuti
in modo lacunoso e
non corretto
Conosce i
contenuti in
modo parziale e
incerto
Conosce in modo
semplice e
schematico i
contenuti in alcuni
ambiti disciplinari
Conosce i
contenuti in modo
corretto e
abbastanza ampio
nella maggior
parte degli ambiti
disciplinari
1/2
3
3,5
4
5
Applica i concetti in
modo confuso ed
espone i contenuti
in modo
frammentario,
senza utilizzare
linguaggi specifici
Applica i concetti
in modo
approssimato ed
espone i
contenuti in
modo confuso,
utilizzando
termini
inappropriati
Applica i concetti
in modo ordinato
ed espone i
contenuti in modo
abbastanza
corretto,
utilizzando
parzialmente i
linguaggi specifici
Applica i concetti
in modo chiaro ed
espone i contenuti
con ordine,
utilizzando in
modo corretto i
linguaggi settoriali
Applica i concetti in
modo efficace ed
espone i contenuti in
modo coerente,
utilizzando con
proprietà i linguaggi
settoriali
1
COMPETENZE
Capacità di sintesi:
individuazione e
collegamento dei
concetti
5
Conosce i contenuti
in modo preciso ed
ampio in tutti gli
ambiti disciplinari
Non individua i
principali concetti
chiave o propone
collegamenti
incoerenti o
inconcludenti
2
Individua in
maniera parziale
o approssimativa
concetti e
collegamenti
delle questioni
proposte
3
Individua i
concetti chiave
essenziali, e
propone alcuni
collegamenti
fondamentali
4
Collega in un
percorso unitario
e coerente
concetti chiave
chiaramente
definiti
5
Propone una sintesi
precisa, dettagliata e
articolata
Le prove svolte dagli studenti sono a disposizione presso la segreteria.
6
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
All. A
Relazione finale del docente: Laura Lippi
Disciplina Lingua e Letteratura Italiana
Classe VDS
A.S. 2016-2017
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali
raggiunti.
La classe, nel suo complesso, ha dimostrato un crescente impegno e interesse per la disciplina,
aumentando, rispetto all’inizio del triennio, le competenze di analisi del testo e migliorando il
metodo di studio. La maggior parte degli alunni è in grado di esprimersi nella produzione orale
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e rielaborando anche autonomamente le
conoscenze. Nella produzione scritta tutti gli studenti riescono ad esprimersi in modo corretto, una
buona parte della classe riesce ad elaborare con originalità gli svolgimenti proposti, con punte di
eccellenza.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Il Romanticismo Europeo e Italiano
Periodo
dell’anno
settembre
N. di ore
impiegato
3 ore
Settembre
/Ottobre
9 ore
1. Caratteristiche generali del Romanticismo Europeo; (vol. 4 pp.)
2. Il Romanticismo italiano: caratteristiche generali(vol. 4 pp.65-76);
3. La poesia dialettale in Italia (vol. 4 pp.439-440):
Giuseppe Gioacchino Belli: “I sonetti escatologici: Er giorno
dergiudizzio, La morte co la code” (vol. 4 pp.444-445)
Giuseppe Gioacchino Belli: "Er caffettierefisolofo" (on-line);
4. Il Melodramma in Italia(on-line).
Alessandro Manzoni
1. La vita e le opere; (vol. 4, pp.211-214))
2. La poetica di Manzoni :
La Lettre a M. Chauvet (vol. 4, pp.240-242);
La lettera sul Romanticismo (vol. 4, pp.243-244).
3. Le tragedie (vol. 4, pp.230-232):
Coro dell’atto terzo da Adelchi (vol.4 pp.402-406)
4. Il romanzo
7
L’episodio di Azzeccagarbugli (vol.4 pp.286-289);
L’episodio della conversione dell’Innominato(vol. 4 pp.278282);
La storia della Monaca di Monza (vol. 4 pp. 291-296);
Il Conte Zio e il Padre Provinciale (vol. 4 pp.297-301);
La folla durante i tumulti di San Martino (vol. 4 pp. 302307);
5. Critica su “I Promessi Sposi”
Lettura tratta da “Il romanzo dei rapporti di forza”di I.
Calvino; (on-line)
Giacomo Leopardi (Volume Leopardi: il primo dei moderni di “La
letteratura e noi)
1. La vita (pp.7-9);
2. La poetica e l’ideologia: le fasi del pessimismo leopardiano
(pp.10-13);
3. Le operette morali (pp. 18-21)
4. I Canti (pp.48-50);
5. Testi analizzati dell’autore:
“L’infinito” dai Canti (pp.117-119);
“La sera del dì di festa” dai Canti (pp.121-123);
“A Silvia” dai Canti (pp.56-60);
“La quiete dopo la tempesta” dai Canti (pp.85-86);
“Il sabato del villaggio” dai Canti (pp.124-127)
“Canto notturno di un pastore errante per l’Asia” dai Canti
(pp. 88-93);
“A se stesso” dai Canti (pp.128-129);
“La Ginestra o Fiore del deserto” dai Canti (pp. 94-108)
“Dialogo della Natura e di un Islandese” da Le Operette
morali (pp. 21-27);
“Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”
(pp.28-32).
OttobreNovembre
16 ore
Dicembre
3 ore
Il Positivismo, il Naturalismo Francese e la Scapigliatura
(vol. 5 Il Secondo Ottocento La letteratura e noi)
1. Dal Positivismo alla rottura epistemologica di fine secolo (pp.6061)
2. Un anno chiave: il 1857 (pp.64-65);
3. Naturalismo e Simbolismo: due modi opposti di vedere il mondo
(pp.67-70)
4. La Scapigliatura in Italia (pp. 70-73);
Letture:
Emile Zola: L’Assemoir: un romanzo operaio pp.30-36;
Gustave Flaubert: “ L’inquietudine di Emma Bovary” da
8
“Madame Bovary” pp. 549-553;
“L’albatro” da “I fiori del male” di C. Baudelaire (pp.12-14);
Il Verismo Italiano e Verga
1. Vita e opere (pp.149-151);
Dicembre-
2. I romanzi preveristi (pp.151-152);
gennaio
7 ore
3. La poetica del verismo (pp. 156-158);
4. La novellistica: da Nedda a Vita dei campi (pp.160-161)
5. Il ciclo dei vinti e i Malavoglia (pp.200-212)
6. Testi analizzati dell’autore:
“Nedda” (on-line);
“Rosso Malpelo”, da “Vita dei Campi” (pp.168-182);
“La roba”, da Novelle rusticane, (pp. 190-194);
“La prefazione ai Malavoglia”, (pp.216-218)
“L’incipit”, da “I Malavoglia”, cap. I (pp.203-207);
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e
interesse economico”, da “I Malavoglia, cap. IV”(pp.245250);
“Mena e Alfio”, da“I Malavoglia” (pp. 223-224);
“Una narrazione a più voci” da “I Malavglia” (pp. 226-229)
“Il capitolo finale”, da “I Malavoglia” cap. XV (pp.232-233);
“Mastro don Gesualdo” cap I (on-line);
Il Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli
1. Giovanni Pascoli: vita e opere (pp.269-270); La poetica del
fanciullino (pp.270-271); La struttura e i contenuti di Myricae
Febbraio-
10 ore
marzo
(pp.281-282)
2. Testi analizzati di Pascoli:
“Gloria” da Myricae (pp.277-280);
“Lavandare” da Myricae(pp.285-286);
“Novembre” da Myricae (pp.287-288);
“Il Lampo” da Myricae (pp. 289-290);
“Il Nido” da Myricae (pp. 295-296);
“X agosto” da Myricae (pp.298-299);
“L’assiuolo” da “Myricae” (pp.301-303);
“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio (pp.304306);
3. Gabriele d’Annunzio: vita (pp.315-317); L’ideologia e la politica
(pp.317-319); Il piacere (pp. 452-454 ) e i romanzi del superuomo
(pp. 323-324); Le laudi (pp.324-325).
4. Testi analizzati di D’Annunzio:
“Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” da Il piacere, libro I,
9
cap II (pp. 454-456);
“Il verso è tutto” da Il piacere, libro II, cap. I (pp.456-458);
“ Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” da Notturno (pp.327330);
“La pioggia nel pineto” da Alcyone (pp.352-355);
“La sera fiesolana” da Alcyone (pp.348-351);
Luigi Pirandello (vol. 6 Dal Novecento ad oggi La letteratura e noi)
1. La vita (pp. 99-103);
Aprile
4 ore
1. La vita (pp.193-196);
Aprile
4 ore
2. La cultura di Svevo (pp.196-198);
Maggio
2. La cultura e l’ideologia (pp.103-104);
3. La poetica dell’umorismo (pp.104-105);
4. I romanzi (pp.108-110);
5. Il Fu Mattia Pascal (pp.517-520)
6. Il teatro (pp.116-120);
7. Le novelle per un anno (pp.141-142)
8. Testi analizzati dell’autore:
“Che cos’è l’umorismo” da L’umorismo (pp. 106-107);
“La vita in una macchina da presa” da I quaderni di Serafino
Gubbio Operatore, (pp. 110-112);
“Il finale di Uno, nessuno e centomila” (pp.113-115);
“L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico” da Sei
personaggi in cerca d’autore (pp.121-128)
“Enrico getta la maschera” da Enrico IV (pp.129-132);
“La carriola” da Novelle per un anno (pp.144-149);
“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno (pp.159-164)
Italo Svevo
3. I romanzi e le novelle (pp.199-202);
4. La coscienza di Zeno (pp.214-216);
5. Testi analizzati dell’autore:
“La prefazione del dottor S.” da La coscienza di Zeno
(pp.211-213);
“Preambolo” da La coscienza di Zeno (on-line);
“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno (pp.219-221)
“Storia di un’associazione commerciale” da La coscienza di
Zeno (pp.223-225);
“Il funerale mancato” da La coscienza di Zeno (pp.227-228;
“Il finale del romanzo: la vita è una malattia” da La
coscienza di Zeno (pp.229-232)
“Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo” da La coscienza di
Zeno (pp.238-241);
10
Divina Commedia: Paradiso (tramite presentazioni in power point
curate dagli studenti e lettura e commenti dei versi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Canto I;
Canto III;
Canto VI;
Canto XI;
Canto XVII;
Canto XXXIII ;
Settembre
12 ore
-gennaio
La Prima Prova dell’esame di stato
1. La tipologia B (ripasso e approfondimento);
Tutto
2. Compiti in classe ed esercitazioni domestiche su tutte le tipologie
l'anno
10 ore
della prima prova dell’esame di stato.
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio1
Ungaretti;
Saba;
Montale;
Il romanzo nel dopoguerra.
Firma degli studenti rappresentanti di classe
3. Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi a casa e in classe, uso della televisione per la
visione di filmati di critici letterari sui vari autori. Ricerche di approfondimento degli alunni su
argomenti e/o analisi testuali.
4.Materiali e strumenti didattici impiegati
Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione: Luperini, Cataldi, Baldini, Gibertini,
Castellana, Marchiani "La letteratura e noi" vol. 4-5-Leopardi-6, Palumbo.
A integrazione del testo sono utilizzati altri materiali messi a disposizione degli studenti tramite il
registro elettronico (didattica).
1 Se effettivamente svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in un documento, firmato dal/dalla docente e dagli
studenti, che verrà depositato in segreteria.
11
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Si sono svolte per il primo periodo quattro prove scritte (due secondo le tipologie previste per la
prima prova d’esame e due con domande aperte su porzioni del programma di letteratura) e almeno
una prova per l’orale (interrogazioni di tipo tradizionale) più alcune valutazioni orali
sull’esposizione di ricerche e approfondimenti. Per il secondo periodo si sono svolte fino a questa
data 3 prove scritte (due secondo le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato e una
con domande aperte su porzioni di programma) e almeno una prova orale. È programmata una
simulazione di prima prova scritta per il giorno 15 maggio (comune a tutte le classi quinte) ed
eventualmente un’ulteriore prova scritta con domande sugli ultimi argomenti di letteratura italiana.
Le griglie di valutazione per la prima prova d’esame sono quelle adottate dal dipartimento di
lettere di questo istituto.
Le prove effettuate sono a disposizione della Commissione presso la segreteria
Padova 15/05/2017
Firma della docente
12
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “ALVISE CORNARO”
All. A
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Laura Lippi
Disciplina: Lingua e Cultura Latina
Classe VDS
A.S. 2016-2017
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti dal
Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali
raggiunti.
La classe, nel suo complesso, ha dimostrato un crescente impegno e interesse per la disciplina, aumentando,
rispetto all’inizio dell'anno, le competenze di analisi del testo e migliorando il metodo di studio. Durante
quest'anno scolastico lo studio della letteratura latina è stato affrontato, per lo più, tramite la lettura di testi in
italiano affiancati dal testo originale in latino. Si è così potuto di volta in volta porre il focus sul lessico
utilizzato dai vari autori e approfondire le tematiche da questi trattate. La maggior parte degli alunni è in
grado di esprimersi nella produzione orale utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e rielaborando
anche autonomamente le conoscenze.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
Periodo
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
dell’anno
Testo di riferimento Diotti-Dossi-Signoracci, Res et Fabula Vol. 2-L'età
augustea, Sei editore.
SettembreOttobre
N. di ore
impiegato
14 ore
Quinto Orazio Flacco
1. La vita (pp.162-163);
2. Le opere (pp. 164-167);
3. Le odi (pp.172-179);
4. Testi analizzati dell'autore
"Maecenasatavis edite regibus "(carmina I,1) (pp.202-204)
(latino e italiano);
“La fonte Bandusia” (carmina III, 13) (pp.206-207)
(latino e italiano)
"Exegimonumentum aere perennius" (carmina III, 30)
(pp.209-210) (latino e italiano);
"Solvituracrishiems" (carmina I, 4) (pp.218-220) (latino e
italiano);
"Un'allegoria dello stato" (carmina I, 14) (pp.221-222)
(latino e italiano);
"Vides ut alta stetnivecandidum" (carmina I, 9) (pp. 223225) (latino e italiano);
"Nunc est bibendum" (carmina I, 37) (pp.227-228) (latino e
13
italiano);
"Tu ne quaesieris" (carmina I,11) (pp.234-234) (latino e
italiano);
La poesia elegiaca a Roma
1. I caratteri dell'elegia (pp.254-257);
Novembre
9 ore
DicembreGennaio
10 ore
GennaioFebbraio
6 ore
2. AlbioTibullo (pp.259-262);
3. Sesto Properzio (pp.263-267);
4. Testi analizzati degli autori:
AlbioTibullo "Amore e vita agreste: il sogno esistenziale di
Tibullo" (corpus Tibullianum I, 1) (pp.270-277 italiano);
Sesto Properzio "Elegia I, 3" (on-line);
Sesto Properzio "Elegia I,1" (latino/italiano)(pp.292-294);
5. Approfondimenti: Nos odimus arma: l'antimilitarismo nell'elegia
latina di "Nicola Cadoni" on-line;
Publio Ovidio Nasone
1. L'autore (pp. 312-313);
2. Ovidio "elegiaco" (pp.314-317);
3. Le Metamorfosi (pp.321-324);
4. Lo stile (pp.328-329);
5. Testi analizzati dell'autore:
"Il ritratto del poeta d'amore", Amores I, 3 (pp.333334)(latino e italiano);
"Militatomnisamans", Amores I, 9 (on-line , italiano);
"La milizia d'amore", Amores II, 12, 1-16 (pp. 334-335)
(latino e italiano);
"Apollo e Dafne" ,Metamorphoseonliber I, 525-566 (pp.347350) (latino e italiano);
"Piramo e Tisbe", Metamorphoseonliber IV, 55-166 (pp.352354) (italiano);
"Dedalo e Icaro" Metamorphoseonliber VIII, 183-235
(pp.355-358) (italiano);
"Eco e Narciso" Metamorphoseonliber III, 344-350 (pp.360363) (italiano);
"Orfeo ed Euridice" Metamorphoseonliber X,1-77 (pp. 363365) (italiano).
Tito Livio
1. Uno storico-letterato (pp. 388-389);
2. Ab Urbe condita libri: la struttura dell'opera (pp.391-393);
3. La Praefatioe la visione della storia (pp.394-397);
4. Il rapporto con il principato e la funzione degli exempla (pp.397398);
5. La tecnica narrativa e lo stile (pp.400-402);
14
6. Testi analizzati dell'autore:
"Enea in Italia" Ab Urbe condita liber I,1 (pp.407-409) (latino
e italiano);
"Lucrezia e le virtù femminili” Ab Urbe condita liber I, 57, 411 (pp.413-414) (italiano);
"La virtus: Camillo e i Galli" Ab Urbe condita liber V, 49, 1-5
(p.415) (italiano);
"La fides: Camillo e il maestro di Faleri" Ab Urbe condita
liber V, 27 (pp.415-417) (italiano);
“Il conservatorismo di Livio”:
“La secessione della plebe” Ab Urbe Condita II, 32; 33, 1-2
(pp. 419-421) (italiano);
“Il conservatorismo religioso: la repressione dei Baccanali”
Ab Urbe condita XXXIX, 8-18, (pp.422-425) (italiano).
“La prefazione e il giuramento di Annibale” Ab Urbe condita
XXI, 1 (p. 429) (italiano);
“Il ritratto di Annibale” Ab Urbe condita XXI, 4 (pp.432-433)
(latino e italiano)
Testo di riferimento Diotti-Dossi-Signoracci, Res et Fabula Vol. 3Dall'età di Tiberio alla letteratura cristiana, Sei editore.
Publio Cornelio Tacito
Marzo
8 ore
Aprile
8 ore
1. L'autore (pp.334-335);
2. L'opera: L'Agricola, la Germania, le Historiae e gli Annales (pp.340353);
3. Alle radici del potere imperiale (pp.354-355);
4. La storiografia "tragica" di Tacito (pp.356-357);
5. Lo stile (p.359);
6. Testi analizzati dell'autore:
"Il discorso di Calgaco" Agricola cap.30 1-4 (p.341)
(italiano);
"Il proemio delle Historiae"Historiae I, 1-3 (pp.387-389)
(italiano);
"Il discorso di Galba: la scelta del successore"Historiae I, 16
(pp.389-390) (italiano);
"L'excursus sugli Ebrei"Historiae, I, 3-5 (pp.392-394)
(italiano);
"L'incendio di Roma" Annales XV, 38-44 (pp.417-422) (latino
e italiano);
"La morte di Seneca" Annales XV, (on-line);
7. Approfondimento Tacito e Tiberio (on-line).
Lucio Anneo Seneca
1. L'autore (pp.36-37);
2. La filosofia dell'interiorità (pp.38-40);
3. Le opere in prosa (pp.40-50);
4. Le Tragedie (pp.52-53);
15
5. L'Apokolokyntosis (pp.55-56);
6. Lo stile (pp.57-59);
7. Testi analizzati dell'autore:
"La vita interiore sotto il principato" (letture antologiche
tratte da Consolatio ad Helviammatrem, De ira, De vita
beata, De tranquillitate animi") (pp.66-69) (italiano);
"Il senso del tempo" (letture antologiche tratte da
Epistulaemorales ad Lucilium 1, De brevitate vitae;) (pp.7488) (italiano);
"Il filosofo e il principe" (letture antologiche tratte da De
clementia e De otio) (pp. 197-110) (italiano);
"Il singolo e la folla" Epistulaemorales ad Lucilium 7 1-5 (online) (latino e italiano);
"Il prossimo è anche lo schiavo" Epistulaemorales ad
Lucilium 47, 1-21 (pp.99-105) (latino e italiano).
Petronio
1. L'autore e la testimonianza di Tacito (pp.168-170);
Maggio
2. L'opera e la vicenda narrata (pp.171-173);
4 ore
3. Tempo lento e spazio labirintico (pp.175-177);
4. Il realismo di Petronio (pp.177-181);
5. Lo stile (pp.182-183);
6. La fortuna (pp.183-185)
7. Letture analizzate dell'autore:
La matrona di Efeso Satyricon ,111 1-13 (pp. 216-221)
(italiano);
La cena di TrimalchioneSatyricon, 32-34; 40, 75-76 (pp. 197202) (italiano);
L'incombere della morte sul mondo di Petronio Satyricon
114, 8-13; 115, 6-20; 141 (pp.212-216)
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio2
1. Apuleio
Firma degli studenti rappresentanti di classe
2 Se effettivamente svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in un documento, firmato dal/dalla docente e dagli
studenti, che verrà depositato in segreteria.
16
3. Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi a casa e in classe. Ricerche di
approfondimento degli alunni.
4.Materiali e strumenti didattici impiegati
Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione: Diotti, Dossi, SignoracciRes et Fabula,
vol.2 (l'età augustea) e vol.3 (dall'età di Tiberio alla letteratura cristiana), Sei editore.
A integrazione del testo sono stati utilizzati altri materiali messi a disposizione degli studenti
tramite il registro elettronico (didattica).
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Si sono svolte per il primo quadrimestre due prove scritte (una prova strutturata di analisi
contrastiva con domande aperte e una simulazione di terza prova tipologia B) e tre per il secondo
(due prove strutturate tipologia B e un'analisi del testo/saggio breve su argomenti di letteratura
latina) e almeno una prove per l’orale per quadrimestre (interrogazioni di tipo tradizionale).
Le prove effettuate sono a disposizione della Commissione presso la segreteria
Padova 15/05/2017
Firma della docente
17
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
All. A
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Cristina Pegorin
Disciplina: MATEMATICA
Classe: VDS
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti dal
Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali
raggiunti.
La classe all’inizio del quarto anno presentava una preparazione sufficiente e un metodo di studio abbastanza
efficace ed organizzato. Fin da subito si è evidenziato un approccio ansioso e timoroso nei confronti della
disciplina. Il percorso di maturazione è stato apprezzabile. La classe ha, in generale, preso consapevolezza
delle proprie abilità e ha acquisito il giusto grado di autostima e coraggio.
L’atteggiamento è stato collaborativo, e un gruppo di studenti è sempre stato molto attivo nel lavoro in classe
e impegnato nel lavoro personale.
La preparazione globale è adeguata. Qualche studente si distingue per impegno e senso responsabilità
lodevoli e per aver acquisito conoscenze articolate, abilità metodologiche specifiche sicure e una precisione
adeguata nell’applicazione di procedure e nella risoluzione di problemi.
Una parte della classe ha raggiunto una preparazione appena sufficiente, determinata da difficoltà individuali
specifiche e da un’applicazione non sempre adeguata allo studio, 4-5 studenti non hanno raggiunto un livello
di preparazione accettabile.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
QUADRIMESTRE
I
Settembre –
Ottobre
30
I
Novembre dicembre –
gennaio
40
II
Febbraio-Marzo
CONTENUTI
Limiti
Derivate e studio
di funzione
Integrali
CONOSCENZE
I teoremi sui limiti
Le forme indeterminate
I limiti notevoli
La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo
I punti di discontinuità di una funzione
Gli asintoti
La derivata di una funzione in un punto
L’interpretazione geometrica della derivata in un punto
Le derivate delle funzioni potenza, logaritmo, esponenziale e delle
funzioni goniometriche
La funzione derivata e le derivate successive
La continuità e la derivabilità
Il differenziale di una funzione
I teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy e la regola di De l’Hospital
I punti stazionari, a tangente verticale, angolosi
I massimi e i minimi relativi e assoluti
La concavità e i punti di flesso
Gli asintoti
La primitiva di una funzione
L’integrale indefinito e le sue proprietà
18
QUADRIMESTRE
30
CONTENUTI
II
Aprile
15
Le equazioni
differenziali
II
Maggio
10
Dati e previsioni
II
Maggio
8
Geometria
CONOSCENZE
L’integrale definito e le sue proprietà
Il teorema fondamentale del calcolo integrale
Gli integrali impropri
Equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti o che si
risolvono mediante integrazioni elementari
Equazioni differenziali a variabili separabili
Equazioni differenziali del secondo ordine
Calcolo combinatorio:
Le disposizioni
Le permutazioni
Le combinazioni
La funzione n! - I coefficienti binomiali
Probabilità:
Teoremi di calcolo di probabilità
Teorema di Bayes
Distribuzioni discrete e continue di probabilità:
- Distribuzione binomiale
- Distribuzione normale
Coordinate cartesiane nello spazio
Equazioni delle rette, dei piani e di alcune superfici notevoli
Firma degli studenti rappresentanti di classe
______________________________
______________________________
3. METODOLOGIA DIDATTICA E MATERIALI USATI
L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso lezioni frontali, arricchite dallo svolgimento di
esercizi alla lavagna o tramite gruppi di lavoro. Al termine di ogni lezione è stato assegnato del lavoro da
svolgere a casa, basato sullo studio dell’argomento spiegato in classe e sulla risoluzione di alcuni esercizi,
graduati nella difficoltà. Il lavoro di correzione dei compiti è stato sistematico e puntuale e ha permesso la
verifica quotidiana del lavoro personale svolto dagli studenti. Il libro di testo(Manuale blu 2.0 di matematica
“Bergamini-Trifone-Barozzi) è stato integratoda esercizidi approfondimento, quesiti e problemi assegnati
agli esami di maturità degli anni precedenti.
4. VERIFICHE e CRITERI di VALUTAZIONE
Le verifiche, strettamente correlate con il complesso delle attività svolte durante il processo di insegnamentoapprendimento,hanno coinvolto tutte le tematiche affrontate, tenendo conto degli obiettivi previsti. Le prove
scritte somministrate sono state di diverso tipo (monotematiche, strutturate, sommative) composte sempre di
esercizi e/o problemi e/o quesiti teorici.
Verrà eseguita una simulazione di seconda prova d’esame il 16 maggio.
Padova, 15 maggio 2017
Firma della docente
_____________________________
19
Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“ALVISE CORNARO”
All. A
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Cristina Pegorin
Disciplina:FISICA
Classe: VDS
A.S.2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti dal
Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali
raggiunti.
L’insegnamento della fisica in questa classe ha visto l’avvicendarsi di 5 diversi insegnanti nel corso del
quinquennio. Il livello di preparazione all’inizio di quest’anno scolastico è risultato sufficiente, le
conoscenze pregresse poco consolidate e scollegate, assente anche una visione organica e globale della
disciplina. La conoscenza degli strumenti di base necessari per lo studio e l’analisi dei fenomeni risultava
non del tutto adeguata.
L’atteggiamento iniziale è stato di timore e sfiducia, tuttavia con impegno e responsabilità molti studenti
sono riusciti a continuare il percorso di recupero iniziato durante il quarto anno e a costruirsi un metodo di
studio specifico abbastanza efficace ottenendo anche risultati confortanti.
Nel complesso la maggior parte della classe dimostra di possedere una sufficiente conoscenza degli
argomenti trattati, qualcuno ha acquisito una conoscenza molto buona e riesce anche ad eseguire
collegamenti ed ad analizzare in modo corretto le situazioni problematiche posposte.
Una parte degli alunni ha continuato a manifestare difficoltà, per questi le lacune pregresse e le difficoltà
personali nello studio della disciplina sono stati determinanti per il mancato raggiungimento di una
preparazione del tutto sufficiente, tuttavia per alcuni è da segnalare che l’impegno non è mancato.
Un gruppo composto da 3-4 studenti si è dedicato allo studio della disciplina con impegno scarso e
discontinuo, questi alunni hanno raggiunto livelli di preparazione differenti, ma non adeguati, dimostrando
difficoltà nel risolvere correttamente semplici esercizi, nell’individuare le regole e le leggi da applicare,
nell’esporre in modo esauriente aspetti teorici essenziali.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
QUADRIMESTRE
I
Settembre/Ottobre
15 ore
CONTENUTI
Cariche elettriche e
campi elettrici
CONOSCENZE
Fenomeni elementari di elettrostatica - Convenzione sui segni delle
cariche - Conduttori e isolanti - La legge di conservazione della carica
L’elettroscopio
Unità di misura della carica elettrica nel SI - La carica elementare
La legge di Coulomb
Il principio di sovrapposizione - La costante dielettrica relativa e assoluta La forza elettrica nella materia
Elettrizzazione per induzione
Polarizzazione degli isolanti
Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico prodotto da una carica
puntiforme e la più cariche - Rappresentazione del campo elettrico
attraverso le linee di campo - Le proprietà delle linee di campo
20
QUADRIMESTRE
CONTENUTI
I
Novembre
15 ore
Il potenziale elettrico
I
Dicembre
10 ore
Circuiti in corrente
continua
I
Dicembre Gennaio
4 ore
II
Gennaio - Febbraio
15 ore
La corrente elettrica
nella materia
II
Febbraio - Marzo
15 ore
Il campo magnetico
L’induzione
elettromagnetica
CONOSCENZE
Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
La densità superficiale e lineare di carica
Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica, da
una distribuzione lineare infinita di carica, all’esterno di una distribuzione
sferica di carica e all’interno di una sfera omogenea di carica
L’energia potenziale elettrica - L’andamento dell’energia potenziale in
funzione della distanza tra due cariche
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura - La differenza di potenziale
- Le superfici equipotenziali
La relazione tra le linee di campo e le superfici equipotenziali - Relazioni
tra campo elettrico e potenziale elettrico
Circuitazione del campo elettrico
La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della carica nei
conduttori - Campo elettrico e potenziale in un conduttore carico
La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI
Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata
Il condensatore - Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce
piane e parallele - Concetto di capacità equivalente
Collegamento di condensatori in serie e in parallelo
L’energia immagazzinata in un condensatore
Intensità e verso della corrente continua
L’unità di misura della corrente nel SI
I generatori di tensione
Elementi fondamentali di un circuito elettrico
Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico
Le leggi di Ohm
I resistori
Collegamento in serie e in parallelo di resistori
La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule
Unità di misura per i consumi di energia elettrica
La forza elettromotrice e il generatore reale di tensione
Le leggi di Kirchhoff
L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei conduttori
La velocità di deriva
I processi di carica e di scarica di un condensatore
Fenomeni di magnetismo naturale - Attrazione e repulsione tra poli
magnetici
Caratteristiche del campo magnetico
Le interazioni tra magneti e correnti
Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel SI
La forza di Lorentz
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Forza magnetica su un fili percorso da corrente
Legge di Biot-Savart
Le forze tra fili percorsi da corrente
Momento torcente di una spira e di una bobina
Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère
Le proprietà magnetiche della materia
La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica
La legge di Faraday-Neumann
La forza elettromotrice indotta media e istantanea
La legge di Lenz sul verso della corrente indotta
21
QUADRIMESTRE
II
Marzo-Aprile
12 ore
CONTENUTI
Le equazioni di
Maxwell e le onde
elettromagnetiche
II
Maggio
8 ore
La relatività ristretta
II
Maggio
4 ore
Meccanica quantistica
CONOSCENZE
Campi elettrici indotti
La circuitazione del campo elettrico indotto
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione
Lo spettro elettromagnetico
L’invarianza della velocità della luce
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
Il concetto di simultaneità e la sua relatività
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
Quantità di moto relativistica
Energia relativistica
La composizione delle velocità
Gli spettri atomici
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck
L’effetto fotoelettrico
L’effetto Compton
Firma degli studenti rappresentanti di classe
______________________________
______________________________
3. Materiali e strumenti didattici
Libro di testo (Romeni - FISICA E REALTA’ Campo elettrico – FISICA E REALTA’ Campo magnetico,
Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti - Zanichelli), appunti dalle lezioni, materiali e
strumenti di laboratorio, fotocopie integrative con esercizi supplementari e approfondimenti.
Dal libro di testo:(elenco dei capitoli e delle pagine relativi agli argomenti svolti)
Cap 18. Cariche elettriche e campi elettrici da pag. 796 a pag. 828
Cap 19. Il potenziale elettrico da pag. 844 a pag. 846, da pag. 848 a pag. 877
Cap 20. Circuiti in corrente continua da pag. 892 a pag. 916
Cap 21. La corrente elettrica nella materia da pag. 942 a pag. 950 - Carica e scarica di un condensatore
svolte come applicazione delle equazioni differenziali.
Cap 22. Campo magnetico da pag.984 a pag. 1018
Cap 23. L’induzione elettromagnetica da pag. 1034 a pag. 1056 e pag. 1066-1067
Cap 24 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche da pag.1088 a pag. 1103, da pag. 1106 a pag.
1109, da pag. 1113 a pag. 1118.
Cap 25 La relatività ristretta da pag. 1130 a pag. 1138 efotocopie tratte da “I problemi della fisica” –
Cutnell, Johnson vol3 cap.21
Cap 26 Oltre la fisica classica da pag. 1176 a pag. 1196
4. Metodologia didattica
L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti:
1) esposizioneteorica
2) applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi
22
3) realizzazione di esperimenti di laboratorio: analisi di fenomeni di induzione magnetica.
5. Tipologia delle prove di verifica
Sono state svolte verifiche scritte in forma mista (quesiti a risposta breve, soluzione di problemi) e verifiche
orali. Sono state effettuate due simulazioni di terza prova nel mese di novembre e marzo.
Padova, 15 maggio 2017
Firma della docente
____________________________
23
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
All. A
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Roberto Rigoni
Disciplina Lingua e Civiltà Inglese
Classe 5Ds
A.S. 2016 - 2017
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali
raggiunti, anche in riferimento ad impegno, interesse e partecipazione al dialogo
educativo; percentuale di studenti della classe che ha raggiunto gli obiettivi minimi
secondo la programmazione iniziale.
La classe ha compiuto insieme a me un percorso biennale di studio della lingua inglese applicato a
svariati contesti. In particolare, il secondo periodo del quarto anno e la quasi totalità del quinto sono
stati impiegati in lavori di analisi e discussione di testi letterari, sia in autonomia che alla luce del
contesto storico, sociale e culturale in cui gli stessi erano stati prodotti. L'idea era soprattutto quella
di usare questi testi come palestra in cui esercitare la propria capacità di utilizzare la lingua straniera
come strumento di lavoro nella redazione di note, nell' espressione ed applicazione di riflessioni
personali, nel confronto con altri compagni e nella comunicazione dei risultati al gruppo classe. Il
fine non è stato tanto l'acquisizione di specifiche conoscenze culturali, quanto l'affinamento della
capacità di utilizzare quanto appreso in contesti diversi da quelli in cui i dati erano stati inizialmente
acquisiti evitando, per quanto possibile, di indurre gli studenti a memorizzare testi di cui non
avevano reale consapevolezza. Questo ci ha portato ad avvalerci solo occasionalmente degli esercizi
presenti nei libri di testo e ha talvolta condotto ad esiti interpretativi anche significativamente
diversi da quelli suggeriti dagli autori delgli stessi.
Dal punto di vista del contesto storico, sociale e culturale, le informazioni rilevanti sono state
fornite dal docente, che si è basato su scelte personali. Ad esempio, gli accenni ad avvenimenti
relativi alla biografia degli autori sono stati scelti più per stimolare la curiosità dei discenti e per
favorire la comprensione del rapporto tra l'artista ed il contesto storico e sociale in cui si è trovato a
vivere che non per indurre un'acquisizione di conoscenze sostanzialmente inutili, come giorno e
mese di nascita e morte, o numero di fratelli e sorelle. Gli studenti sono stati, pertanto, abituati a
confrontarsi e ad esprimersi sui contenuti dei testi studiati e a dimostrare di conoscere solo quegli
aspetti teorici o critici che erano rilevanti per la comprensione dei testi stessi, piuttosto che
dell'intera carriera dell'artista. Così, ad esempio, mentre sono state fornite informazioni relative alle
“epiphanies” nell'opera di James Joyce insieme a qualche nozione sullo stream of consciousness,
che parevano essere di una certa rilevanza per la comprensione dell'unica short story analizzata,
“Eveline”, non si è detto niente sui “moments of being”, che nulla avevano a che vedere col saggio
di Virginia Woolf che stavamo analizzando.
La classe ha affrontato il quinto anno con un atteggiamento sufficientemente positivo sul piano
comportamentale, seguendo le lezioni con interesse e manifestando una costante disponibilità
all'interazione e al lavoro, che ci ha permesso di analizzare porzioni di testi molto maggiori di
24
quanto non sia normalmente possibile fare utilizzando soltanto il materiale antologizzato. Questo ci
ha anche consentito di fare analisi più approfondite delle opere letterarie, e di puntualizzarne la
collocazione nei moduli esplicitati nel programma fissato ad inizio anno anche sulla base di scelte
effettuate dagli studenti.
Dal punto di vista del profitto, anche se alcuni studenti tendono a ripetere errori formali
caratteristici di cui stentano a liberarsi, il progresso è stato evidente e, anche se nessuno raggiunge
la perfezione, quasi tutti sono in grado di fornire prestazioni almeno decorose sia allo scritto che
all'orale. Si sono comunque evidenziati sei studenti capaci di prestazioni buone / eccellenti, quattro
studenti capaci di prestazioni discrete / buone, tre studenti capaci di prestazioni più che sufficienti /
discrete, dieci studenti capaci di prestazioni sufficienti, quattro studenti che non sempre riescono a
raggiungere la sufficienza. Il giudizio buono / eccellente designa prestazioni in prove scritte o orali
caratterizzate da buona, anche se non necessariamente impeccabile, correttezza formale, da
scioltezza e facilità nella gestione dell'argomentazione e dell'interazione con l'interlocutore, e da
sicurezza nella gestione delle informazioni basata su conoscenze ben fondate e ponderate. Il
giudizio sufficiente / accettabile, invece, designa prestazioni caratterizzate da argomentazioni che
possono anche essere piuttosto scolastiche, superficiali o schematiche, ma comunque non
contraddittorie, che sono basate su conoscenze pertinenti, non errate ed espresse in forme
comprensibili, anche se possono contenere errori formali di livello talvolta elementare.
Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Periodo
dell’anno
N. di ore
impiegato
First-generation romantic poets and relevant essays (ripasso):
Burke, Wordsworth, Coleridge
13 / 09
20 / 09
2016
4
Second-generation romantic poets and relevant essays : Shelley,
Keats
21 / 09
10 / 11
2016
19
Romantic fiction: Mary Shelley, Wilde
15 /11
2016 24
/ 01
2017
13
Woman in English Literature: Austen, C. Brontë, Browning, Wilde,
Shaw, Joyce, Woolf
24 / 11
2016 06
/04 2017
31
The Dystopian Novel and War: Wells, Huxley, Orwell, Frayn
06 / 04
17 / 05
2017
13
Firma degli studenti rappresentanti di classe
25
Metodologiedidattiche
lezione frontale;
analisi autonoma o guidata, individuale e/o di gruppo, di testi di autori noti;
group work con relazione finale da parte di uno speaker designato;
discussione aperta a tutta la classe.
Materiali e strumenti didattici impiegati
D. Ellis, Literature for Life 2A, edLoescher.
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Culture &Literature 3, ed Zanichelli.
Opere e frammenti di opere non presenti nei libri di testo
Compendio scritto dei risultati del lavoro di analisi e discussione effettuato
Criteri e strumenti di valutazione adottati
Prove Scritte:
breve analisi testuale;
quesiti a risposta chiusa;
Prove Orali:
relazione, in qualità di speaker, sui risultati delle attività di gruppo;
colloqui individuali col docente su tematiche specifiche;
analisi e commento dei testi trattati nel corso, con effettuazione di eventuali collegamenti.
VALUTAZIONE
La valutazione delle prove è stata condotta sulla base dei seguenti elementi:
Prove Scritte:
conoscenza, pertinenza e correttezza delle conoscenze e dei contenuti;
padronanza dei linguaggi specifici.
Capacità di analisi, sintesi e collegamento
Prove Orali:
capacità di comprendere l’interlocutore;
comprensibilità globale e accettabilità formale;
fluidità e velocità;
pronuncia ed intonazione;
ricchezza e proprietà nell’uso del lessico;
conoscenza dei contenuti;
capacità di gestire i contenuti in modo adeguato alle richieste.
26
GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER LE PROVE DI PRODUZIONE SCRITTA
IN GIALLO LA PARTE AGGIUNTA CHE PER LA LINGUA STRANIERA SOSTITUISCE IL
SEGMENTO GENERICO ABILITA’
GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA
GIUDIZIO
gravementeinsuf
f.
insufficiente
Sufficiente
discreto
buono/ottimo
INDICATORI
CONOSCENZE
Correttezza e
pertinenza dei
contenuti
ABILITÀ
Applicazione di
concetti e procedure;
capacità espositiva e
padronanza dei
linguaggi specifici
ABILITA
CAPACITÀ ESPOSITIVA
E PADRONANZA DELLA
LINGUASTRANIERA
1-2
3
3,5
4
Conosce i
contenuti in modo
lacunoso e non
corretto
Conosce i contenuti
in modo parziale e
incerto
Conosce in modo
semplice e
schematico i
contenuti in alcuni
ambiti disciplinari
Conosce i
contenuti in modo
corretto e
abbastanza ampio
nella maggior
parte degli ambiti
disciplinari
1-2
3
3,5
4
Applica i concetti
in modo confuso
ed espone i
contenuti in modo
frammentario,
senza utilizzare
linguaggi
specifici
Applica i concetti
in modo
approssimato ed
espone i contenuti
in modo confuso,
utilizzando termini
inappropriati
Applica i concetti
in modo ordinato
ed espone i
contenuti in modo
abbastanza
corretto,
utilizzando
parzialmente i
linguaggi specifici
Applica i concetti
in modo chiaro ed
espone i contenuti
con ordine,
utilizzando in
modo corretto i
linguaggi settoriali
Capacità di sintesi:
individuazione e
collegamento dei
concetti
5
Applica i concetti in
modo efficace ed
espone i contenuti in
modo coerente,
utilizzando con
proprietà i linguaggi
settoriali
1-2
3
3,5
4
5
Usa strutture
scorrette che
impediscono la
comprensione. Si
esprime con
numerosi errori
morfosintattici
che rendono il
messaggio poco
chiaro
Si esprime con
errori
morfosintattici che
pregiudicano
parzialmente la
comprensione. Il
lessico non è molto
vario
Si esprime in
modo per lo più
adeguato seppure
con qualche
errore. Lessico e
strutture sono
semplici
Si esprime in
modo chiaro
seppure con
qualche errore.
Lessico e strutture
sono abbastanze
varie.
Si esprime
correttamente
utilizzando anche
strutture di una certa
complessità e ben
collegate tra di loro. Il
lessico è vario e
appropriato
1
COMPETENZE
5
Conosce i contenuti
in modo preciso ed
ampio in tutti gli
ambiti disciplinari
Non individua i
principali concetti
chiave o propone
collegamenti
incoerenti o
inconcludenti
2
Individua in
maniera parziale o
approssimativa
concetti e
collegamenti delle
questioni proposte
3
Individua i
concetti chiave
essenziali, e
propone alcuni
collegamenti
fondamentali
4
Collega in un
percorso unitario e
coerente concetti
chiave
chiaramente
definiti
5
Propone una sintesi
precisa, dettagliata e
articolata
Le prove scritte sono state a volte valutate anche in base a griglie diverse da quella suindicata, che è
comunque quella adottata dal Coordinamento di lingue del nostro Istituto.
NB: anche se gli studenti sono stati invitati a servirsene il meno possibile, nell’ effettuazione
delle prove scritte è stato sempre loro concesso di servirsi di dizionari monolingue e bilingue.
Padova, 15 maggio 2017
Firma del docente
27
All. A
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Claudia Sagrillo
Disciplina
Classe
A.S.
Scienze naturali
VDS
2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali
raggiunti, anche in riferimento ad impegno, interesse e partecipazione al dialogo
educativo; percentuale di studenti della classe che ha raggiunto gli obiettivi minimi
secondo la programmazione iniziale.
La classe si presenta piuttosto eterogenea per impegno e profitto con un comportamento
caratterizzato da una certa vivacità ma sempre corretto e collaborativo. Il grado di autonomia
raggiunto nello studio è senz’altro positivo e maturato notevolmente nel corso del triennio.
Per quanto riguarda l’impegno e il profitto, si possono distinguere tre gruppi diversi:
- un discreto numero di studenti, grazie a buone capacità di studio, ha saputo mantenere un livello di
applicazione costante realizzando profitti molto buoni durante tutto l'anno;
- un gruppo, circa metà degli alunni, si è impegnato raggiungendo risultati più che discreti;
- un terzo gruppo, esiguo, che, per motivazioni diverse, spesso non ha raggiunto livelli di impegno
e/o di profitto soddisfacente.
Lo svolgimento del programma, molto vasto, ha imposto delle scelte che sono state dettate in parte
dall’interesse dei ragazzi e in parte dalla logica continuazione di tematiche affrontate negli anni
precedenti e che hanno trovato nel quinto anno un adeguato approfondimento.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Chimica organica
Dal carbonio agli idrocarburi
L’ibridazione del carbonio, la formazione di legami σ e π, il loro orientamento
nello spazio
Alcani e cicloalcani
I composti organici e le loro rappresentazioni
L’isomeria: isomeri di struttura (di catena e di posizione) e stereoisomeri
L’isomeria ottica, chiralità, la stereoisomeria nei farmaci (talidomide)
Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi
Periodo N. di
dell’ann ore
o
impieg
ato
1Q
27
28
Reattività degli idrocarburi saturi: alogenazione per sostituzione radicalica
Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi insaturi: alcheni
e alchini
Isomeria geometrica degli alcheni
Addizione elettrofila di alcheni e alchini
Gli idrocarburi aromatici
La sostituzione elettrofila aromatica (no meccanismo di reazione)
Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 1 p. 4- 35
Dai gruppi funzionali ai polimeri
I gruppi funzionali
Gli alogenogerivati (no meccanismi di reazione p. 45 - 46)
Nomenclatura (regole generali) e caratteristiche fisiche di alcoli, fenoli e eteri
(no effetto induttivo di vari gruppi su acidità p. 51)
Acidità di alcoli e fenoli
Le reazioni di alcol e fenoli : sostituzione nucleofila, disidratazione,
ossidazione
Nomenclatura di aldeidi e chetoni (regole generali) e la reazione di addizione
nucleofila (no meccanismo nei dettagli p. 57)
Nomenclatura (regola generale) e proprietà fisiche e chimiche degli acidi
carbossilici
Esteri (no nomenclatura) e saponi
Composti azotati: ammine, ammidi e composti eterociclici (in generale, senza
nomenclatura)
I polimeri di sintesi: polimeri di addizione (polietilene) e di condensazione
(PET) (in generale, senza dettagli sulle reazioni)
Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 2 pp. 42-72, escluse le
cose citate e le schede di approfondimento.
Biochimica
Le biomolecole
Carboidrati: classificazione e generalità
Monosaccaridi e disaccaridi: gruppi funzionali, aldosi e chetosi, enantiomeri
D ed L
Forma aperta e forma ciclica dei monosaccaridi con formazione di anomeri α
eβ
Polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno
Lipidi saponificabili e non: caratteristiche strutturali e funzionali di trigliceridi,
fosfolipidi, steroidi e terpeni.
Amminoacidi: struttura, enantiomeri L e D, caratteristiche dei gruppi
funzionali
Classificazione degli amminoacidi a seconda delle caratteristiche del gruppo
R e reazione di condensazione tra due aminoacidi
Proteine: legame peptidico, strutture primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria ed interazioni che le stabilizzano
Struttura proteica e attività biologica
Le biomolecole nell’alimentazione (scheda p. 98 99)
Gli enzimi
Struttura dei nucleotidi e degli acidi nucleici, concetto di complementarietà
delle basi azotate
Tipi di RNA e loro ruolo
Duplicazione del DNA
Codice genetico e sintesi proteica
Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 3 pp. 82 - 104
1Q
8
Biochimica
Il metabolismo
Anabolismo e catabolismo
Le vie metaboliche
L’ATP
Il ruolo dei coenzimi NAD, FAD e NADP
La regolazione del metabolismo
1Q
10
29
Il metabolismo dei carboidrati
Le due fasi della glicolisi (non viene richiesta reazione per reazione, ma
bilancio generale, resa energetica e ruolo della fosfofruttochinasi)
La fermentazione lattica e alcolica
La gluconeogenesi, la glicogenosintesi e la glicogenolisi (significato generale
dei processi, senza reazioni)
Il metabolismo dei lipidi: digestione, assorbimento, trasporto
β-ossidazione (in generale, senza reazioni)
Il metabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione
ossidativa, il ciclo dell’urea (in generale, senza reazioni)
Il metabolismo terminale
La decarbossilazione ossidativa del piruvato e la formazione dell’acetil-CoA
Il ciclo di Krebs (bilancio generale e passaggi significativi, non viene richiesto
reazione per reazione)
La catena di trasporto degli elettroni e la produzione di ATP per chemiosmosi
La resa energetica della respirazione cellulare
Il controllo della glicemia (no meccanismi intra cellulari p. 154 p. 155)
Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” Cap. 4 pp. 112-155 (escluse le
cose citate, le schede di approfondimento e le pp. 125 132 134 148 149 150)
Biotecnologie
La regolazione genica in virus e batteri
La regolazione genica in eucarioti (cenni, da appunti di lezione)
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie
Colture cellulari
Le cellule staminali
Gli enzimi di restrizione e la loro azione
L’elettroforesi,
Il riconoscimento di sequenze mediante sonde marcate.
La PCR
Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger
Il clonaggio del DNA
La clonazione
Le biblioteche a DNA
L’analisi delle proteine (Western blotting)
L’ingegneria genetica e gli OGM
Le applicazioni biotecnologiche
Biotecnologie per la medicina
Biotecnologie agrarie
Biotecnologia ambientali (cenni)
Sadava et altri Biologia Vol. B cap. 5 pp 246-258 escluse letture di
approfondimento
Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” cap. 5 pp 164-173, 176-186,
188.193
Valitutti et altri “Dal carbonio agli OGM PLUS” cap. 6 pp 202-216, 220, 222.
Modelli della tettonica globale
L’interno della Terra: discontinuità sismiche, modello a gusci, crosta
oceanica e continentale, litosfera astenosfera, flusso di calore, correnti
convettive del mantello, campo magnetico, isostasia.
Crippa Fiorani “Sistema Terra” vol. C D p. 148 – 161 esclusa scheda 2 p 158
2Q
26
2Q
14
La dinamica della litosfera: teorie fissiste e mobiliste, deriva dei continenti,
espansione dei fondali oceanici, paleomagnetismo morfologia dei fondali
oceanici, struttura delle dorsali
La teoria della tettonica a placche: margini delle placche, caratteristiche
generali, margini continentali, apertura degli oceani, sistemi arco-fossa, punti
caldi, il meccanismo che muove le placche, orogenesi, struttura dei
continenti
Crippa Fiorani “Sistema Terra “ vol. EFG: unità 1 p. 2-15 (esclusa scheda p
12), unità 2 p 21-39
30
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio3
L’atmosfera: composizione struttura e dinamica
Composizione e struttura a strati dell’atmosfera, buco nell’ozonosfera,
bilancio radiativo e energetico, effetto serra e riscaldamento globale,
temperatura, pressione, venti, modello della circolazione atmosferica
generale.
Crippa Fiorani “Sistema Terra “ vol. EFG: unità 4 p.80-101 (esclusa scheda p
85)
2Q
5
Firma degli studenti rappresentanti di classe
______________________________________
______________________________________
3. Metodologiedidattiche
Per perseguire gli obiettivi si operato in tal modo:
ogni argomento è stato proposto e spiegato attraverso lezioni frontali con l'ausilio di
presentazioni al computer e lasciando adeguato spazio alle domande degli studenti;
l’apprendimento è stato rafforzato tramite la proposta di esercizi, schemi, mappe, filmati;
sono stati favoriti, ove possibile, l’interdisciplinarietà e l’approfondimento di alcune
tematiche più vicine agli interessi degli studenti.
Gli studenti hanno assistito alla conferenza “Cancro e stili di vita” del prof. Pier Carlo Conte
nell’ambito delle attività della “Fiera della scienza” promossa dall’istituto.
4. Materiali e strumenti didattici impiegati
Libri di testo adottati per la classe quinta:
Sadava et al. Dal carbonio agli OGM PLUS ed. Zanichelli
Crippa Fiorani SISTEMA TERRA EFG ed. Mondadori scuola
Libri di testo degli anni precedenti:
Sadava et al. L’ereditaretà e l’evoluzione (vol. B) ed. Zanichelli in possesso dalla classe terza
Crippa Fiorani SISTEMA TERRA CD ed. Mondadori scuola in possesso dalla classe quarta
Per le parti di biochimica e biotecnologie sono state messe a disposizione degli studenti le
presentazioni in powerpoint utilizzate in classe per condurre le lezioni.
Reagenti, strumenti e vetreria del laboratorio di Chimica
Collegamenti internet per visione di filmati e ricerca di materiale utile.
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
In accordo con gli altri docenti di Scienze del Liceo sono stati usati i seguenti criteri di valutazione:
conoscenze generali e specifiche
comprensione degli argomenti
rielaborazione e capacità di sintesi
capacità espressive e linguaggio appropriato e scientifico
abilità nell’applicazione del metodo scientifico sperimentale
Durante il percorso didattico la comprensione dei concetti e la capacità di rielaborazione personale è
stata accertata con domande a risposte brevi o articolate.
3
Soltanto nel caso in cui avrà subito delle variazioni e/o non sarà stata svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in
un documento a parte, firmato dal/dalla docente e dagli studenti, che verrà depositato in segreteria e pubblicato nel sito.
31
Per il controllo del profitto scolastico sono stati utilizzati diversi strumenti:
interrogazioni orali
verifiche scritte
simulazione di terza prova
Padova, 15 maggio 2017
Firma del/della docente
32
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Barison Loretta
Disciplina
FILOSOFIA
Classe 5DS
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti.
La classe ha dimostrato di seguire con molto interesse i vari contenuti proposti, evidenziando
discrete capacità di analisi anche in relazione a tematiche particolarmente complesse come
l’Idealismo.
Relativamente più facile è stato l’approccio deglistudenti con gli autori che hanno maturato il
proprio pensiero in antitesi a Hegel (es. Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, ecc.) Il confronto
costante con l’insegnante e il dialogo tra gli allievi e docente sui singoli temi è stata la nota
dominante di tutto il biennio di corso. Il lavoro di analisi del testo, pur difficoltoso in relazione
soprattutto agli autori romantici, credo abbia maturato nei ragazzi una discreta capacità critica
personale. Alcuni alunni hanno poi dimostrato eccellenti capacità di analisi e di riflessione.
Nel complesso si possono ritenere acquisiti gli obiettivi della programmazione didattica. La
maggior parte della classe ha evidenziato un costante progresso nell’acquisizione dei contenuti e
delle abilità e competenze, attestandosi su livelli medio- alti. Solamente pochi alunni si attestano su
un livello appena sufficiente.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
•
Periodo dell’anno
N. di ore
impiegato
Settembre
Kant e la svolta critica del pensiero occidentale.
La Dialettica trascendentale
.Le Idee trascendentali
Valore costitutivo e regolativo delle Idee
* la "Critica della Ragione Pratica” Significato e problemi.
Ragione pratica e ragione pura-pratica.
La morale autonoma e le morali eteronome.
10
Ottobre
33
Azione morale e azione legale
Il Rispetto.
I postulati della Ragione pratica.
* la "Critica del Giudizio".
I giudizi riflettenti e determinanti.
L’idea di finalità.
Le nozioni di Bello e Sublime (percorso pluridisciplinare)
• dibattiti sulle aporie del Kantismo e i preludi all'idealismo
(Jacobi,Reinhold, Schulze, Maimon, Beck).
• La fondazione dell'Idealismo: Fichte. L’io puro e i principi
dell’Idealismo. L’attività etica e conoscitiva. Schelling (concetto di
assoluto).La filosofia della Natura. L’arte come espressione
dell’assoluto
•
Hegel e l'Idealismo assoluto
Novembre
* vita, opere e genesi del pensiero di Hegel.
I capisaldi del pensiero hegeliano: la realtà è spirito, la vita dello
spirito è dialettica,
* la Fenomenologia dello Spirito: le figure della
<fenomenologia, la dialettica servo-padrone
* la Logica: differenze con Aristotele. Struttura
* la filosofia della Natura: aspetti problematici di questa parte
del sistema hegeliano
* la filosofia dello Spirito (particolarmente lo Spirito oggettivo
e Assoluto: diritto, moralità ed eticità ;arte,religione e filosofia)
10
Dicembre
Gennaio
10
Febbraio
5
1. Cenni sulla Destra Hegeliana e le sue problematiche
1. La Sinistra Hegeliana
1. M. Stirner: l’unico e la sua proprietà
2. L. Feuerbach:la teologia come antropologia. Il nuovo umanesimo
7
1. K. Marx: critiche a Feuerbach.Hegel e Marx. Materialismo Storico.
Il Manifesto. Il concetto di alienazione economica e religiosa. Struttura
34
e sovrastruttura. Il concetto di plusvalore ed il capitale.
1. I grandi contestatori del sistema Hegeliano
* A. Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e il
mondo come volontà.La vita come dolore e noia.Le vie della
liberazione: arte e ascesi. La noluntas.
* S. Kierkegaard: lo stadio estetico,etico e religioso.L’esistenza
come possibilità.L’angoscia e la disperazione.La storia e il possibile.
Marzo
12
Aprile
• Il Positivismo: Comte.La legge dei tre stadi.La dottrina della
scienza.Sociologia e sociocrazia.
• Nietzsche e la trasmutazione dei valori.La morte di Dio.’La nascita
della tragedia’.Amor fati ed eterno ritorno.Genealogia della morale. La
cattiva coscienza.La nozione di superuomo.La volontà di potenza.
4
8
4
Maggio
• Lo Spiritualismo: Bergson.Il concetto di durata.L’evoluzione
creatrice.
• La psicanalisi di Freud.Prima e seconda topica.Il ‘recupero’
dell’inconscio.
Maggio/giugno 4
La guerra secondo Freud.
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio
•
L’esistenzialismo di Heidegger.
•
H. Arendt. L'origine del Totalitarismo.
Testi analizzati
FOTOCOPIE
•
“Il rispetto della legge morale e il supremo significato etico del
dovere”
•
“Comparazione del bello col piacevole e col buono mediante
l’osservazione precedente”
•
“Il signore e il servo. - La signoria”/ “L’Assoluto come
soggetto e come risultato. Il vero, in quanto divenire di se stesso, è il
tutto”
35
•
“Prefazione Il divenire del sapere”
•
“La logica e la totalità delle sue categorie”
•
“L’Esteriorità come determinazione fondamentale della
Natura” / “Sul carattere divino della Natura” / “Esteriorità naturale ed
estrinsecazione spirituale” / “Equivoci relativi a una presunta
superiorità dell’elemento naturale su quello spirituale” / “La Natura
come sistema di stadi necessari” / “Lo scopo finale della Natura è lo
Spirito”
•
“Stirner: l’ateismo religioso di Feuerbach”
•
VOLUME 2 “FILOSOFIA CULTURA CITTADINANZA”
“Le idee della ragione” (pg.646)
•
“Virtù e felicità” (pg. 650)
•
“Bello e sublime” (pg.653)
•
“Che cos’è l’illuminismo” (pg.657)
•
“L’Io assoluto” (pg.717)
•
“La deduzione dello spirito finito come essenzialmente pratico”
(pg.720)
•
“La libertà e la scelta tra realismo e idealismo” (pg.721)
•
“La superiorità dell’arte” (pg.727)
•
“La logica del divenire: «togliere», «conservare», «superare»”
(pg.826)
•
“Il reale e il razionale” (pg.830)
•
“L’eticità: la famiglia, la società civile, lo Stato” (pg.832)
•
“Arte simbolica, arte classica, arte romantica” (pg.839)
•
“Divinità e razionalità nella storia universale” (pg.844)
•
“L’uomo è l’artefice e il contenuto della religione” (pg.863)
•
VOLUME 3 “FILOSOFIA CULTURA CITTADINANZA”
“Il mondo è rappresentazione” (pg.26)
•
“Il mondo è volontà” (pg.28)
•
“La redenzione attraverso l’arte” (pg.30)
•
“La redenzione attraverso la virtù” (pg.32)
•
“Hegel e Abramo, ovvero la filosofia e la fede” (pg.55)
•
“L’angoscia” (pg.57)
36
•
“La disperazione” (pg.57)
•
“Il coraggio di scegliere se stessi” (pg.62)
•
“Lavoro e alienazione” (pg.129)
•
“La produzione materiale e storica delle idee” (pg.131)
•
“Struttura e sovrastruttura” (pg.133)
•
“Idee dominanti e classi dominanti” (pg.135)
•
“La rivoluzione della borghesia” (pg.137)
•
“La concezione materialistica della storia” (pg.140)
•
“La legge dei tre stadi come legge fondamentale dello sviluppo
storico” (pg.177)
•
“La filosofia positiva” (pg.179)
•
“La fisica sociale” (pg.180)
•
“Cattiva coscienza e senso di colpa” (pg.282)
•
“Morale dei signori e morale degli schiavi” (pg.284)
•
“La morte di Dio” (pg.288)
•
“Le tre metamorfosi” (pg.289)
•
“L’eterno ritorno” (pg.290)
•
“La volontà di potenza” (pg.291)
•
“La durata reale” (pg.403)
Firma degli studenti rappresentanti di classe
3. Metodologiedidattiche
Lezione frontale. Spiegazione dei contenuti più significativi del pensiero dell’autore. Lettura e
analisi dei testi degli autori.
Metodo di spiegazione: Metodo storico/teoretico per affrontare le analisi dei testi:
Descrizione del contenuto
37
Interpretazione e commento per affinare lo spirito critico
Visione di DVD del “Caffè filosofico” relativi a Marx, Nietzsche e Freud
4. Materiali e strumenti didattici impiegati
Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione.
La Vergata, Trabattoni. Filosofia,cultura,cittadinanza. La Nuova Italia. Vol.3
A integrazione del testo sono state proposte molteplici fotocopie di documenti storici.
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Verifiche orali; prove strutturate (simulazione di terze prove)
Criteri: acquisizione ordinata dei contenuti; esposizione corretta nell’uso della terminologia
specifica;pertinenza delle considerazioni personali avanzate, anche a partire dai testi esaminati.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle Verifiche
orali; prove strutturate (simulazione terza prova).
Verifiche effettuate secondo le seguenti tipologie:Tipologia B
Padova, 15 maggio 2017
Loretta Barison
38
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Barison Loretta
Disciplina
STORIA
Classe 5DS
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e trasversali
raggiunti.
La Classe 5DS nel corso dell’ultimo biennio ha dimostrato correttezza, spirito collaborativo ed
interesse per il lavoro scolastico.
Ciò ha consentito a ciascun studente di sviluppare, secondo le proprie capacità, la conoscenza dei
contenuti, le abilità e le competenze caratteristiche della disciplina, specialmente attraverso l’analisi
e lo studio dei documenti storici, ai quali è stata riservata particolare attenzione sia nell’attività
didattica sia nello studio individuale.
Tale lavoro ha rappresentato la nota costatante di tutto il biennio e credo abbia favorito lo sviluppo
di un discreto spirito critico nella maggior parte degli studenti ed un metodo adeguato in
riferimento allo studio della storia.
Nel complesso la quasi totalità degli alunni ha conseguito gli obiettivi prefissati in relazione a
conoscenze, abilità e competenze. In alcuni casi i risultati conseguiti si sono evidenziati buoni o
addirittura eccellenti. Sono rari i casi di studenti che hanno conseguito obbiettivi minimi e ciò a
motivo di un impegno incostante nello studio individuale.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati
Periodo
dell’anno
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Difficile decollo del nuovo Stato Unitario.Problemi dell’Italia dopo
l’Unità (politici, sociali ed economici)
I governi della Destra storica.La Questione romana
Ottobre
N. di ore
impiegato
3
La seconda rivoluzione industriale: cause e caratteri
Le conseguenze sociali della seconda rivoluzione industriale ed il
39
movimento operaio.Ilsocialismo.Il Partito Socialdemocratico
tedesco e Russo.
La Seconda Internazionale
Il Colonialismo e l’Imperialismo
La Cina ed i "trattati ineguali"
La crisi del Giappone feudale e la rivoluzione
La Conferenza di Berlino per gli Affari Africani
L’Imperialismo statunitense
La Sinistra storica al potere.Programmi
La politica economica della Sinistra
La politica estera.La triplice Alleanza.
Il regime parlamentare in pericolo
* Crispi:
* l'espansionismo coloniale
* le leggi eccezionali ed il ristabilimento delle legalità
costituzionali
L’età giolittiana:sistema delle riforme,politicafinanziaria,rapporto
con i socialisti e con i cattolici,la guerra di Libia.
Gli Stati Europei alla fine dell'800.
* la Terza Repubblica in Francia:riforme e limiti
* l'Impero Tedesco. dalla politica bismarckiana al ‘Nuovo
corso’ di Guglielmo II
*La Russia di Nicola II (la rivoluzione del 1905 e la riforma
di Stolypin)
Ottobre
3
Novembre
3
Novembre/dic.
3
Dicembre
Dicembre
3
Gennaio
2
Gennaio
2
Febbraio
La costituzione della Triplice Intesa
Situazione dell’Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale: la
crisi marocchina e la crisi balcanica. Conflitti tra Stati
4
5
Marzo
La Prima guerra mondiale nei suoi aspetti più salienti:loscoppio,la
situazione dell’Italia tra interventismo e neutralismo,
la Rivoluzione Russa e la difficile situazione nel 1917,l’entrata
degli Stati Uniti e la disfatta di Caporetto. La conclusione del
conflitto.La Conferenza di Pace di Parigi (particolarmente i Trattati
di Versailles e S.Germain)
4
Il dopoguerra in Europa:la Russia di Lenin dal comunismo di
guerra alla N.E.P.
* la dura età di Stalin
La Repubblica di Weimar e i difficili problemi della ripresa
economica.Hitler e il ‘MeinKampf’.Da Weimar al Terzo Reich
Inghilterra, Francia(cenni)e Stati Uniti nel dopoguerra
Il problema irlandese
Europa ed America tra le due guerre mondiali.
* l'isolazionismo degli U.S.A.
3
aprile
3
40
* il crollo della Borsa
* il New Deal
Il genocidio armeno
Il fascismo in Italia
La vittoria mutilata
L’occupazione delle terre e la fase degli scioperi
La crisi dei governi dal 1919 al 1922
La costituzione del movimento fascista
La marcia su Roma
La fase della dittatura e la sua organizzazione
maggio/giugno
6
La guerra di Spagna.
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio
giugno
La seconda guerra mondiale e la partecipazione dell’Italia
Il crollo del fascismo e la Resistenza
Il secondo dopoguerra nel mondo:
La “guerra fredda”e le sue ripercussioni sullo scenario soprattutto
europeo.
I principali avvenimenti del secondo dopoguerra.
3
Stati Uniti e URSS a confronto
4
Il costituirsi delle due Germanie
Il processo d’integrazione europea.
DOCUMENTI
FOTOCOPIE
•
Fotocopia: “Gli effetti dell’emancipazione dei servi della
gleba”
•
Fotocopia: “Il programma imperialistico degli Stati Uniti”
•
Fotocopia: “Le leggi antisocialiste di Bismarck”
•
Fotocopia: “Bernstein: i presupposti del socialismo e i
compiti della socialdemocrazia”
•
Fotocopia: “Le leggi sociali tedesche al tempo di Bismarck”
•
Fotocopia: “Sillabo”
•
Fotocopia: “Legge delle Guarentigie”
•
Fotocopia: “La <missione di civiltà> della nazione tedesca”
•
Fotocopia: “J’Accuse…”
41
•
Fotocopia: “Per una Germania più grande”
•
Fotocopia: “Tesi di Aprile di Lenin”
•
Fotocopia: “La dichiarazione di Balfour”
•
Fotocopia: “Protocolli dei Savi di Sion”
VOLUME DI TESTO:Castronovo, MILLE DUEMILA.vol 2
•
P. 383 “La civiltà contadina in Russia: obscina, la comune
rurale”
•
P. 385 “La nascita della nazione americana”
•
P. 421 “L’Italia senza italiani”
•
P. 422 “Una esplorazione socio-antropologica dell’Italia
meridionale”
•
P. 513 “Il trattato di Nanchino fra Gran Bretagna e Cina”
•
P. 567 “Il programma del Partito socialista italiano”
•
P. 599 “Il successo del Giappone tra progresso e tradizione”
•
P. 627 “I compiti della socialdemocrazia”
•
P. 627 “Rerum Novarum”
•
P. 631 “La selezione naturale delle nazioni”
VOLUME DI TESTO: Castronovo, MILLE DUEMILA vol.3
•
P. 90 “L’azione pacificatrice del governo”
•
P. 92 “Luci e ombre dell’opera di Giolitti”
•
P. 130 “Lettere dal fronte”
•
P. 133 “L’<inutile strage>”
•
P. 134 “I <14 punti> per un nuovo sistema di relazioni
internazionali”
•
P. 145 “Amiamo la guerra”
•
P. 147 “La guerra distrugge il patrimonio comune
dell’umanità”
•
P. 149 “La guerra non cambia nulla”
•
P. 226 “Il programma dei democratici per uscire dalla crisi”
•
P. 270 “Il Manifesto dei fasci italiani di combattimento”
•
P. 271 “Discorso del bivacco”
42
•
P. 306 “Le accuse di Hitler agli ebrei”
•
P. 307 “Le leggi di Norimberga”
•
P. 308 “I successi e le difficoltà dei bolscevichi”
•
P. 310 “Osservazioni sul compendio del manuale di <Storia
moderna>”
•
P. 315 “La costituzione di Weimar”
•
P. 316 “Il decreto del Presidente del Reich per la tutela del
popolo e dello Stato”
•
P. 433 “La definizione di genocidio”
Altri documenti verranno analizzati fino alla fine dell’anno
scolastico.
Firma degli studenti rappresentanti di classe
3. Metodologiedidattiche
Lezione frontale; lettura e analisi dei documenti o testi storiografici.
Metodo di spiegazione:
Analisi della successione cronologica degli avvenimenti di un periodo
Rilevazione e riconoscimento della cause motrici originarie degli avvenimenti oggetto di studio
Lettura e analisi di documenti storici.
La classe ha partecipato:
Visione della mostra fotografica sul genocidio armeno,allestita nell’atrio del Liceo. “Armin
T. Wegner e gli Armeni in Anatolia,1915”
ad una conferenza tenuta dal prof Mistri sul processo d’integrazione europea.
ad una visita guidata alla sinagoga e al museo della Comunità ebraica di Padova.
Conferenza con il prof. Tonello sulla Costituzione degli stati Uniti
Visita alla mostra fotografica sul Vajont allestica preso l'Aula magna del Liceo.
Incontro con alcuni detenuti del carcere "Due Palazzi" di Padova relativamente al "Progetto
carcere".
4. Materiali e strumenti didattici impiegati
43
Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione.
V.Castronovo. Milleduemila. Un mondo al plurale. La Nuova Italia. Vol.3
A integrazione del testo sono state proposte molteplici fotocopie di documenti storici.
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Verifiche orali; prove strutturate (simulazione di terze prove)
Criteri:
Acquisizione ordinata dei contenuti
Esposizione corretta nell’uso della terminologia specifica
Pertinenza delle considerazioni personali avanzate, anche a
partire dai documenti
proposti.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche
effettuate secondo le seguenti tipologie:Tipologia B
Padova, 15 maggio 2017
Loretta Barison
44
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Marco Anacleto Ronga
Disciplina: Disegno e Storia dell'Arte
Classe 5^ DS
A.S.2016/2017
6. In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi
definiti dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della
commissione.
La classe (27 studenti di cui 15 f. e 12 m.) eterogenea per motivazione e attitudini, ha avuto una
continuità didattica di 4 anni dimostrandosi partecipe e responsabile. Una parte degli studenti ha
consolidato il metodo di lettura dell'opera d'arte adottato dalle prime lezioni, riuscendo a esplicitare
i contenuti significativi oltre a cogliere diversi collegamenti interdisciplinari con ottime capacità di
sintesi e padronanza del lessico specifico. Per altri l'approccio all'opera rimane agevole
limitatamente ad alcune delle principali opere già affrontate nel percorso scolastico, ma gli obiettivi
minimi sono stati raggiunti da tutti gli studenti che hanno complessivamente ampliato le
competenze disciplinari grazie anche a interesse crescente, spirito collaborativo nel gruppo classe e
clima didattico sereno.
7. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Il Romanticismo. Riepilogo dei caratteri generali trattati l'anno precedente. Il tema
della Natura (madre o matrigna) John Constable, Caspar David Friedrich, William
Turner, ThéodoreGéricault, EugéneDelacroix (la Libertà).
Francesco Hayez (la Storia e il Sentimento): la vita, "la congiura dei Lampugnani", “I
profughi di Parga”, "Il bacio"
Il Realismo, premesse storiche e contesto culturale. Gustave Courbet: vita, "il
funerale di Ornans"(opera non presente nel testo), "gli spaccapietre", "l'Atelier
dell'artista", "Fanciulle sulle rive della Senna".
Daumier: "Scompartimento di terza classe" (opera non presente sul testo), le litografie
di satira politica come antenate della grafica satirica contemporanea (Charlie
Hebdo) - distribuito breve testo/dispensa su Daumier e mostrata carrellata di
litografie e vignette satiriche in argomento.
Periodo
dell’anno
13.09.16
N. di ore
impiegato
1h
17.09.16
1h
Dal 20.09.16
2h
al 24.09.16
La Scuola di Barbison
I Macchiaioli. Paragrafo 25.6. Giovanni Fattori: la vita e la formazione, "Campo di
battaglia a Magenta", "La Rotonda di Palmieri". Paragrafo 25.6.1
27.09.16
1h
L'architettura del ferro: nuovi materiali e tecnologie con la seconda rivoluzione
industriale, l'Eclettismo storicistico. Paragrafo 25.8
01.10.16
1h
45
04.10.16
1h
Dal 08.10.16
al 25.10.16
6h
Dal 29.10.16
al 19.11.16
5h
Dal 21.11.16
5h
Restauro nell'800: stilistico (Viollet Le Duc) e romantico (John Ruskin). Paragrafo
25.9.
l'Impressionismo. Cap.26. Introduzione.
Eduard Manet: la vita e "Colazione sull'erba". Manet, "l'Olympia" e "il bar delle Folies
Bergère".
Claude Monet. Par.26.4.
Edgar Degas. La vita, studi grafici, "La lezione di danza, "L'assenzio", "Quattro ballerine
dietro le quinte". Paragrafo 26.5.
Pierre-Auguste Renoir. La vita, confronto fra le due versioni della "Grenoullière" di
Monet e di Renoir, "Moulin de la Galette", "Colazione dei canottieri" "le bagnanti".
Paragrafo 26.6
Altri impressionisti: Pissarro, Sisley, Bazille, Callebotte, Morisot, Casset. Paragrafo
26.7.
23.11.2017 Visita guidata alla mostra “Storie dell'Impressionismo” presso Museo
di S.Caterina a Treviso
Il Postimpressionismo. Introduzione.
Paul Cézanne, "La casa dell'impiccato", "I bagnanti", "I giocatori di carte", "la montagna
di Sainte-Victoire vista da Lauves". Paragrafi 27.1 e 27.2
Georges Seurat. "Une baignade à Asnières", "Un dimancheaprès-midi à l'Ile de la
Grande Jatte", "il Circo". Paragrafo 27.3
Paul Gauguin. Paragrafo 27.4
Vincent Van Gogh. Tutto il paragrafo 27.5.
Van Gogh nel cinema (come cambia un'artista nell'immaginario collettivo):
visione di clips e trailers da film sull'artista dal 1956 ad oggi ("lust for life" di
Minnelli 1956, "dreams" di Kurosawa 1990, "Exhibition on screen: Vincent Van Gogh a
new way of seeing" 2015, "Loving Vincent" di Kobiela 2016, "Mica Van Gogh" videoclip
musicale di Caparezza).
Art Nouveau. Introduzione. Paragrafi 28.1 (dalla Belle epoque alla Prima guerra
mondiale) 28.2 (William Morris e le Art and CraftsExhibition Society) 28.3 (il nuovo
gusto borghese).
al 17.12.16
Esempi di Art Nouveau nelle versioni nazionali (Henry Van de Velde, Victor Horta,
Mackintosh), La Secessione Viennese (par.28.5), Gustav Klimt (28.4).
Antoni Gaudi', Casa Mila' (la Pedrera), la Sagrada Familia (cenni), Casa Batlo' nella
Manzana della discordia, la formazione e il contesto culturale (il Modernismo e gli
influssi culturali nelle tradizioni catalane) le sperimentazioni (la catenaria come matrice
degli archi parabolici) il fitomorfismo e la componente onirica delle architetture di Gaudi'
(argomento non trattato dal testo ma è stata fornita breve dispensa a corredo della
lezione con le immagini proiettate).
Approfondimento: Documentario della BBC in italiano “tre città un secolo: Vienna
1908” sul clima culturale durante la Secessione, Freud, Klimt, Schiele, Loos,
Schonberg.
46
Le avanguardie storiche del Novecento
Dal
17.12.16 al
23.01.17
6h
Dal 28.01.17
al 04.02.17
3h
Dal 11.02.17
al 20.02.17
4h
Dadaismo. MarcelDuchamp, Man Ray.
Dal 25.02.17
al 4.3.17
2h
Surrealismo. Introduzione, l'arte dell'inconscio. Marx Ernst.
Dal 06.03.17
al 6.05.17
7h
L'Espressionismo. Confronto tra i Fauves e il gruppo Die Brucke. Alcune premesse
alle avanguardie storiche: Van Gogh, Gauguin, l'arte africana, la letteratura scandinava,
Nietzsche, la filosofia Esistenzialista. Munch, “la fanciulla malata”, “sera nel corso Karl
Johann”, “il grido”, “pubertà”.
L'Espressionismo in architettura e nel cinema. Esempi di architettura espressionista:
“Padiglione di vetro” per il Werkbund a Colonia 1914 di Bruno Taut, “Grande Teatro” a
Berlino 1918-19 di Hans Poelzing, “Torre Einstein” a Potsdam 1919-24 di Erich
Mendelsohn, “Chilehaus” ad Amburgo 1923-24 di Fritz Hoger. Cenni sul cinema della
A.U.F. nel primo dopoguerra con “Metropolis” di Fritz Lange del 1927.
Pablo Picasso, la vita e alcune opere significative, il Cubismo e le caratteristiche delle
tre fasi. Par.29.2
Lettura dell'opera Guernica, il soggetto e i temi, gli aspetti innovativi del linguaggio e
della tecnica, le fonti classiche e barocche rielaborate (le decorazioni dei frontoni greci
classici e "le conseguenze della guerra" di Rubens)
Futurismo. Introduzione. Par.30.1 e 30.2. Boccioni, “la città che sale”, “stati d'animo”,”
forme uniche della continuità nello spazio”.Par.30.3
Balla: dinamismo di un cane al guinzaglio, velocità astratta. Paragrafo 30.5.1
Sant'Elia (architetture impossibili), Giacomo Balla, Fortunato Depero (Ricostruzione
futurista dell'universo) – Paragrafi 30.4 , 30.5 e 30.6.
Breve video di animazione sulle architetture di S.Elia.
Salvador Dali'. “Costruzione molle con fave bollite”, “apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia”, “sogno causato dal volo di un'ape”, “melancolia”. Paragrafo
31.2.4
E' stata svolto approfondimento su Dalì con visione in lingua inglese di
documentario su Salvador Dalì della BBC "Dalì. A Master of the Modern Era.
MIKOS ARTS - A documentary for educational purposesonly" con la collaborazione
del prof. Roberto Rigoni che ha analizzato il lessico specifico con gli studenti oltre a
collaborare nella valutazione del test conclusivo in inglese in forma di terza prova.
Dalì e il cinema. Visione dell'episodio del sogno in "Io ti salvero' (Spellbound)" di
Hitchcock e "Il cane andaluso" di Bunuel.
Astrattismo lirico e geometrico Kandinsky, Klee, Mondrian
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio4
06.05.17
Temi
programmat
i, da
svolgere
dopo il 15
maggio5
Temi
programm
ati, da
svolgere
dopo il 15
maggio6
4
Se effettivamente svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in un documento, firmato dal/dalla docente e
dagli studenti, che verrà depositato in segreteria.
47
Il Movimento Moderno. Premesse. Bauhaus, LeCorbusier e F.L .Wright
3h
Arte Informale. Pollock e Burri
1h
Pop Art. Andy Warhol
1h
Visita guidata alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia
03.06.17
Firma degli studenti rappresentanti di classe
8. Metodologiedidattiche
Lezioni frontali e interattive, lettura delle opere col metodo proposto e acquisito nel triennio,
visione di filmati e documentari sugli autori e i movimenti analizzati . Il 23.11.2016 è stata
effettuata una visita guidata alla mostra “Storie dell'Impressionismo” presso il Museo di S.Caterina
a Treviso. Alcuni contenuti didattici sono stati proposti in lingua inglese (documentario della BBC
per esempio su Dalì). A conclusione del percorso didattico sull'arte del '900 è stata programmata
visita guidata alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.
9. Materiali e strumenti didattici impiegati
Per l'attività didattica si è fatto uso del libro di testo in adozione (Cricco Di Teodoro “Il Cricco Di
Teodoro - Itinerario nell'arte” Dall'Art Nouveau ai giorni nostri” terza edizione Versione arancione)
filmati e documentari, presentazioni in powerpoint, dispense/fotocopie da altri libri di testo.
10. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Conformemente alle indicazioni del Dipartimento di Disegno e Storia dell'arte sono state
considerate almeno tre valutazioni per quadrimestre, interrogazioni e prove scritte nella tipologia
della terza prova.
Padova, 15.05.2017
Firma del/della docente
48
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: prof. MONACO Giampaolo
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe:5DS
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti dal
Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1.
Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti: la totalità degli studenti ha raggiunto gli obiettivi minimi. Nel
complesso la classe ha mostrato un interesse partecipe ed un impegno costante. Alcuni di loro
hanno evidenziato particolari attitudini nei confronti della disciplina conseguendo risultati
eccellenti.
Obiettivi disciplinari
Possedere nozioni di teoria dell’allenamento, in particolare “la forza e le sue diverse
espressioni”;
Saper eseguire correttamente gli esercizi per lo sviluppo e la valutazione delle qualità fisiche;
Conoscere i regolamenti tecnici delle principali attività sportive praticate;
Saper applicare le regole del gioco;
Partecipare in modo attivo nell’attività ludico-sportiva secondo le proprie possibilità;
Saper valutare l’efficacia e la correttezza esecutiva di un gesto motorio;
Saper assumere ruoli diversi, nel gioco e nell’organizzazione (coordina, arbitra, ...);
Possedere nozioni di primo soccorso e traumatologia;
Saper riconoscere situazioni di pericolo per sé e per gli altri nel vita di tutti i giorni e saper
adottare un comportamento corretto nel soccorrere un infortunato;
Saper assumere comportamenti igienico sanitari di prevenzione e di tutela della salute propria
(autoprotezione) e altrui (soccorso ad un infortunato) in situazione di emergenza.
Conoscere i comportamenti che costituiscono doping, contrari ai principi di lealtà e correttezza
alla base dello sport.
Conoscere le sostanze e metodi vietati dalla legge e comprendere i loro danni sulla salute
Stimolare una coscienza sportiva che basi il raggiungimento dei risultati sul corretto
allenamento e sull’alimentazione piuttosto che sull’uso del doping.
49
2.
Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Parte pratica:
MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA' CONDIZIONALI:
- Resistenza generale o endurance: corsa continua
anche in ambiente naturale. Test di Cooper per
misurare la potenza aerobica.
- Mobilità articolare e allungamento muscolare
(stretching).
- Forza generale: esercitazione di circuit-training. Test
per verificare le diverse espressioni di forza.
Periodo
dell’anno
N. di ore
impiegato
I Q/II Q
8/10
I Q/II Q
12
EDUCAZIONE STRADALE: ATTIVITÀ CON IL SIMULATORE DI GUIDA
DEL MOTOCICLO E DELL’AUTOMOBILE.
IQ
2
BOWLING NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BOWLING A SCUOLA”
II Q
2
ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO CON L’USO DI PISTOLA E
CARABINA AD ARIA COMPRESSA PRESSO IL TSN DI PADOVA.
II Q
3
IQ
6
II Q
6
II Q
4
GIOCHI PRESPORTIVIE SPORTIVI: GIOCO DEI 10 PASSAGGI,
PALLAVOLO, PALLAMANO.
Parte teorica:
LE CAPACITÀ FISICHE: definizione e classificazione della
forza muscolare; i regimi di contrazione; nozioni di
anatomia e fisiologia alla base delle diverse espressioni di
forza e test e strumenti da campo per la loro misurazione.
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO: il primo soccorso; attivazione
del servizio di emergenza; omissione di soccorso,
autoprotezione; esame dell’infortunato; B.L.S; posizione
laterale di sicurezza; manovra di HEIMLICH; le ferite;
fratture; ustioni;emorragie;shock; malori.
DOPING:conferenza e lezione sul fenomeno del doping e
sull’uso corretto degli integratori alimentari.
Firma degli studenti rappresentanti di classe :
_____________________________________________________________________________
50
3.
Metodologie didattiche
Metodo di tipo misto analitico e globale alternato. Ampio spazio è stato lasciato al gioco sportivo
in quanto strumento educativo privilegiato perché inteso anche come contesto operativo e
comunicativo in cui il soggetto esprime le proprie capacità ed abilità anche nel confronto
competitivo con se stesso e con gli altri. La classe ha, inoltre, seguito un corso teorico/pratico di
1° soccorso tenuto da medici dell'IRC (ItalianResuscitationCouncil). Inoltre ha partecipato ad
una conferenza sul Doping e sull’uso scorretto degli integratori.
4.
Materiali e strumenti didattici impiegati.
Per la parte pratica: laboratorio palestra e gli spazi attrezzati esterni (campo da calcio, da basket,
pallavolo).
Per la parte teorica: dispensa di 1° soccorso della C.R.I.; registro elettronico e piattaforma
Moodle per approfondimento e apprendimento on-line.
5.
Criteri e strumenti di valutazione adottati
Nella verifica dell’apprendimento delle abilità motorie, la prima forma di accertamento è stata
quella di misurare la prestazione finale. Una seconda forma di verifica è consistita
nell'individuare la competenza esecutiva mediante l'osservazione di elementi che sono stati
definiti preventivamente come sicuri indici del possesso di quell'abilità motoria. Per la parte
teorica si è optato per la verifica mediante somministrazione di questionari a risposta multipla
compilati on-line (Piattaforma Moodle).
Padova, 04 maggio ’17
51
Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
Allegato A
Relazione finale del docente: Davide Penello
Disciplina: Religione Cattolica
Classe VDS
A.S. 2016-17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1.
Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e gli obiettivi
disciplinari e trasversali raggiunti, anche in riferimento ad impegno,
interesse e partecipazione al dialogo educativo.
Gli alunni che si avvalgono dell’Irc sono 16. Tutti hanno compiuto un percorso di apprendimento e
riflessione critica sugli ambiti disciplinari trattati. L’impegno e l’interesse dimostrato per gli
argomenti trattati ha consentito ad ognuno di migliorare le condizioni di partenza e di raggiungere
gli obiettivi didattici proposti nella programmazione
2.
Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Questioni di etica della vita familiare.
La questione dell’immigrazione.
Periodo
dell’anno
Settembre
Dicembre
N. di
ore
12
Gennaio
Marzo
Aprile
8
Etica ed economia. La Finanza solidale.
Maggio
Giugno
6
4
Etica della responsabilità: le persone che hanno
caratterizzato la storia della Chiesa nel XX secolo.
Etica ed Ambiente.
Firma degli studenti rappresentanti di classe :
52
1. Metodologiedidattiche
Dal 8 al 11 marzo 2017 ho accompagnato la classe al viaggio d’istruzione a Praga. È stata una
occasione per approfondire conoscenza storica e religiosa della città e della popolazione dell’est
Europa. In modo particolare è stata approfondita la figura del riformatore protestante Giovanni Hus
e la visita del quartiere ebraico con approfondimenti legati alla storia e tradizione della religione
stessa. La classe ha visitato la mostra sugli armeni organizzata dal Dipartimento di religione.
2. Materiali e strumenti didattici impiegati
L’attività didattica è stata articolata in lezioni frontali nelle quali è prevalsa la partecipazione degli
allievi con dibattiti e confronti in merito alle problematiche emerse e con alcuni lavori di gruppo ed
elaborazione personale dei contenuti. Le lezioni si sono svolte utilizzando libri e dispense e in
alcuni casi si sono stati proposti dei video e documentari per allargare la comprensione delle
tematiche stesse.
3. Criteri e strumenti di valutazione adottati
La valutazione tiene conto della partecipazione e del coinvolgimento dei singoli e del gruppo classe
durante l’attività didattica. In modo particolare l’impegno in alcuni approfondimenti assegnati come
lavoro personale.
Padova, 04 maggio 2017
Firma docente
Davide Penello
53
All. B
3. Allegato B
Relazione sulle attività pluridisciplinari
I nuclei pluridisciplinari, fondamentali per la strutturazione delle prove a carattere pluridisciplinare:
terza prova e colloquio (artt. 4-5 D.P.R. 323/98), sono stati articolati nell’azione didattica come
risulta dalle schede seguenti, relative, distintamente, ai nodi affrontati nelle terze prove effettuate,
già illustrate nel documento al punto 3, oppure agli argomenti funzionali al colloquio.
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI CLASSE VDS ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Nuclei
pluridisciplinari
Discipline
Contenuti
La guerra
Italiano, Storia,
Filosofia, Fisica,
Storia dell'Arte,
Inglese
Si rimanda agli allegati A delle singole discipline.
Il Romanticismo
Italiano, Filosofia,
Inglese, Storia
dell'Arte
Si rimanda agli allegati A delle singole discipline.
La crisi del soggetto
Italiano, Filosofia,
Storia dell'Arte
Si rimanda agli allegati A delle singole discipline.
Il rapporto tra
Intellettuali e Potere
Italiano, Latino, Storia Si rimanda agli allegati A delle singole discipline.
dell'Arte, Fisica,
Inglese
54
4. Griglia di valutazione del colloquio orale (proposta)
Argomento scelto dal/dalla candidato/a
Conoscenze
Correttezza e
pertinenza
dei contenuti
Abilità
Applicazione
delle
conoscenze,
capacità
espositiva e
proprietà
Competenze
Sviluppo,
collegamento,
discussione e
approfondimento
delle conoscenze
Conoscenze
Discussione prove scritte
Argomenti proposti dalla commissione
Correttezza e
pertinenza
dei contenuti
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
1
Dimostra di non conoscere
neppure per sommi capi
l’argomento proposto
1
Non sa utilizzare
le conoscenze in relazione
allo sviluppo
dell’argomento. Espone in
modo disarticolato e molto
confuso. Non ha nessuna
padronanza del lessico
specifico
1
La sua analisi è del tutto
superficiale, manca di una
qualsiasi visione sintetica
d’assieme dell’argomento
1,5
Propone l’argomento in
modo scorretto e
lacunoso
1,5
Utilizza impropriamente
le conoscenze nella
trattazione
dell’argomento.
Espone in modo poco
coerente, servendosi di
un linguaggio generico e
approssimativo
1,5
È incerto nell’analisi,
poco lineare nella
sintesi; propone
collegamenti arbitrari
Grav. insuff.
Insufficiente
1/2
Conosce gli
argomenti in modo
scorretto e
lacunoso
3
Conosce gli
argomenti in modo
incerto e parziale
Abilità
1/2
Applica i concetti
in modo confuso
ed espone i
contenuti in modo
frammentari o
senza utilizzare
linguaggi specifici
3/4
Applica i concetti in
modo
approssimato
ed espone i contenuti
in modo confuso,
utilizzando un
linguaggio non
appropriato.
Competenze
1/2
È frammentario
nell’analisi,
dispersivo nella
sintesi e propone
collegamenti non
motivati
2,5
È incerto nell’analisi,
poco lineare nella
sintesi e propone
collegamenti non
motivati
Applicazione di
concetti e
procedure;
capacità
espositive e
padronanza dei
linguaggi specifici
Sviluppo,
collegamento,
discussione e
approfondimento
delle conoscenze
Competenze
Autocorrezione,
revisione
critica e
discussione
Sufficiente
Buono
2
Propone l’argomento in modo
semplice ma pertinente
3
Propone l’argomento
in modo ampio ed approfondito
2
Utilizza correttamente le
conoscenze nella trattazione
dell’argomento.
Espone in modo ordinato,
servendosi parzialmente dei
linguaggi specifici
3
Utilizza proficuamente le
conoscenze nella trattazione
dell’argomento.
Espone in modo chiaro e
ordinato, servendosi dei
linguaggi specifici in modo
appropriato
2
Sviluppa l’analisi in modo
semplice, è abbastanza lineare
nella sintesi e propone
collegamenti motivati
3
Sviluppa efficacemente
l’analisi, è coerente nella
sintesi e propone collegamenti
originali e criticamente fondati
Sufficiente
Discreto/Buono
Ottimo
4
Conosce gli
argomenti in modo
semplice e
schematico oppure in
modo preciso e
ampio ma solo in
alcuni ambiti
disciplinari
5
Applica i concetti in
modo ordinato ed
espone i contenuti in
modo abbastanza
corretto, utilizzando
parzialmente i
linguaggi specifici
4,5
Conosce gli
argomenti in modo
preciso ed ampio
nella maggior parte
degli ambiti
disciplinari
5
Conosce gli argomenti in
modo completo e
approfondito in tutti gli
ambiti disciplinari
6/7
Applica i concetti in
modo chiaro ed
espone i contenuti
con ordine,
utilizzando
correttamente i
linguaggi settoriali
8
Applica i concetti in modo
efficace ed espone i
contenuti in modo coerente,
utilizzando con proprietà i
linguaggi settoriali
3
Sviluppa l’analisi in
modo semplice, è
abbastanza lineare
nella sintesi e
propone collegamenti
motivati
4
Sviluppa l’analisi in
modo semplice, è
abbastanza lineare
nella sintesi e
propone collegamenti
motivati
5
Sviluppa efficacemente
l’analisi; è coerente nella
sintesi e propone
collegamenti motivati e
rilevanti
Insufficiente
Sufficiente
Buono
1
Si orienta parzialmente nella
riproposizione delle affermazioni e
nella correzione di errori e/o
imprecisioni per la maggior parte delle
prove
2
Ripropone le affermazioni e corregge gli
errori e/o imprecisioni di ciascuna prova,
se guidato
3
Esplicita e giustifica le
affermazioni e le
approfondisce; corregge
autonomamente
eventuali errori e/o
imprecisioni di ciascuna
prova
55
Firma dei Docenti del Consiglio di Classe
Loretta Barison
Laura Lippi
Giampaolo Monaco
Cristina Pegorin
Davide Penello
Roberto Rigoni
Marco Anacleto Ronga
Claudia Sagrillo
Padova, 15 maggio 2017
Firma del Coordinatore
Timbro della scuola
Firma del Dirigente
Scolastico
56