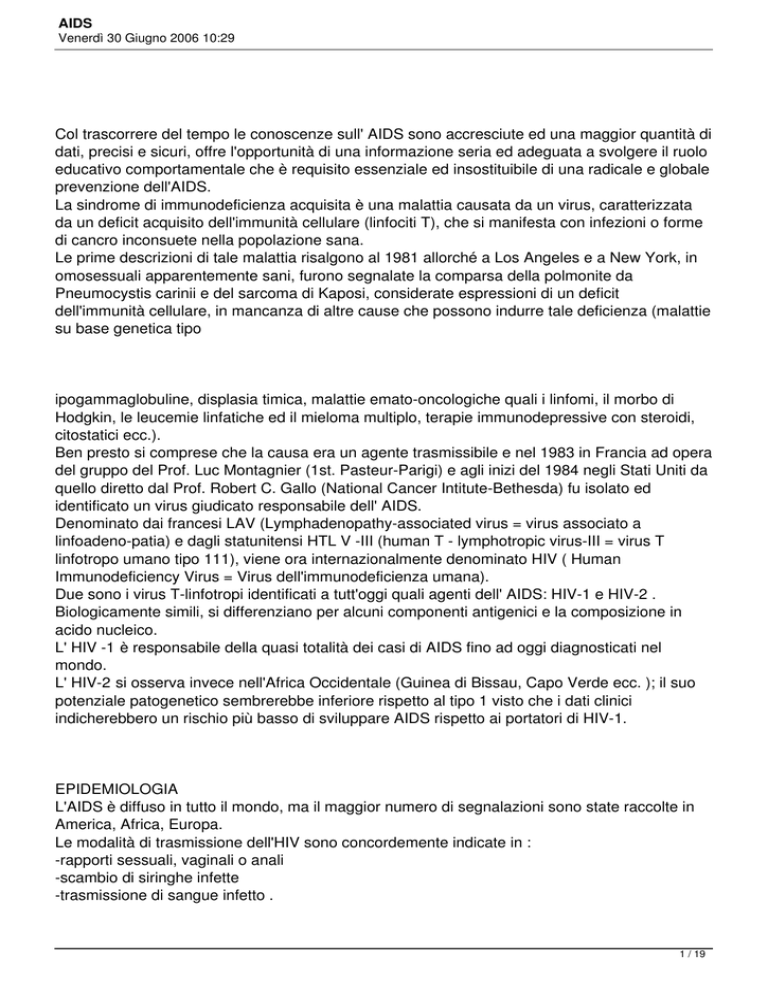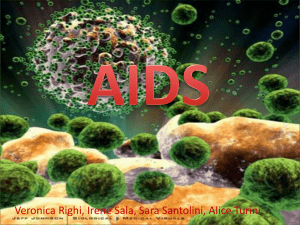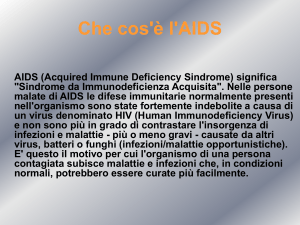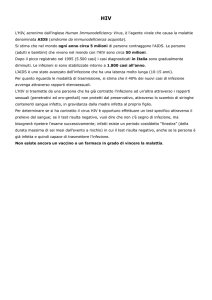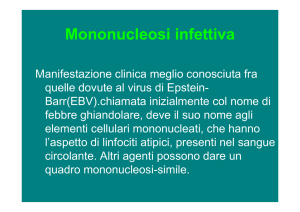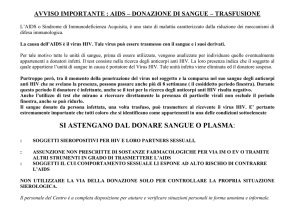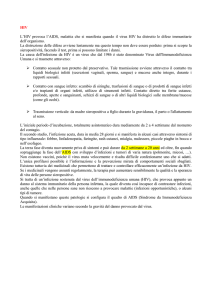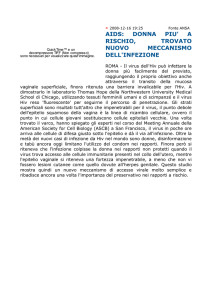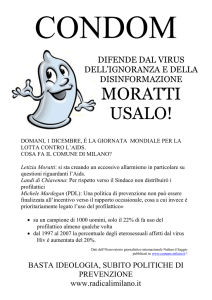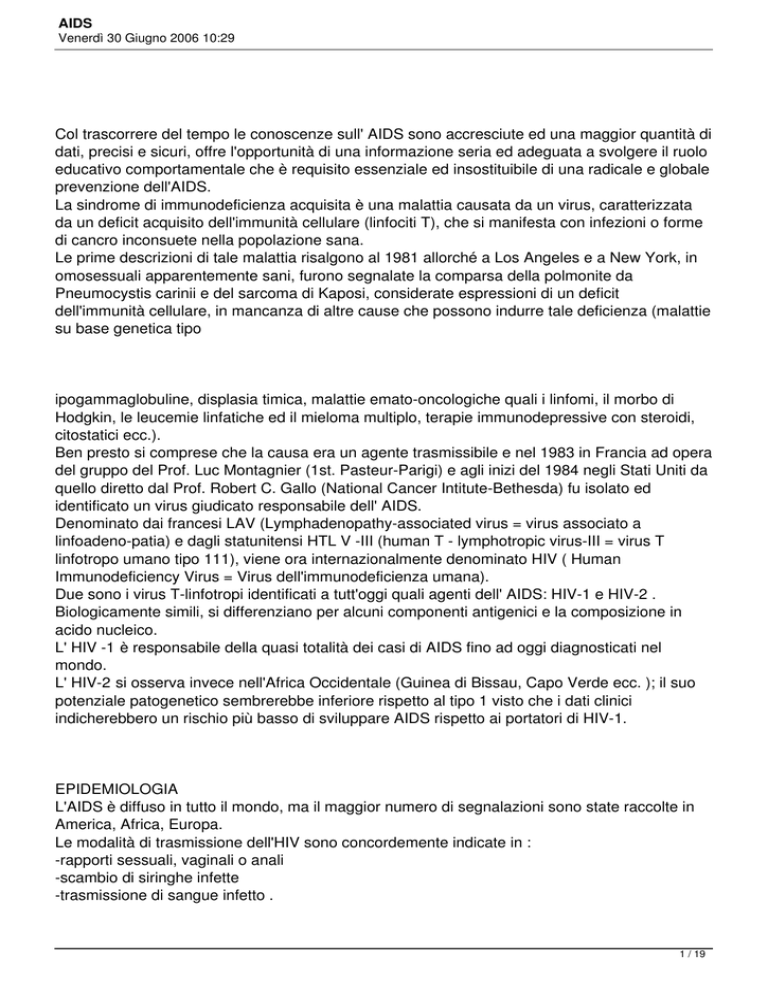
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
Col trascorrere del tempo le conoscenze sull' AIDS sono accresciute ed una maggior quantità di
dati, precisi e sicuri, offre l'opportunità di una informazione seria ed adeguata a svolgere il ruolo
educativo comportamentale che è requisito essenziale ed insostituibile di una radicale e globale
prevenzione dell'AIDS.
La sindrome di immunodeficienza acquisita è una malattia causata da un virus, caratterizzata
da un deficit acquisito dell'immunità cellulare (linfociti T), che si manifesta con infezioni o forme
di cancro inconsuete nella popolazione sana.
Le prime descrizioni di tale malattia risalgono al 1981 allorché a Los Angeles e a New York, in
omosessuali apparentemente sani, furono segnalate la comparsa della polmonite da
Pneumocystis carinii e del sarcoma di Kaposi, considerate espressioni di un deficit
dell'immunità cellulare, in mancanza di altre cause che possono indurre tale deficienza (malattie
su base genetica tipo
ipogammaglobuline, displasia timica, malattie emato-oncologiche quali i linfomi, il morbo di
Hodgkin, le leucemie linfatiche ed il mieloma multiplo, terapie immunodepressive con steroidi,
citostatici ecc.).
Ben presto si comprese che la causa era un agente trasmissibile e nel 1983 in Francia ad opera
del gruppo del Prof. Luc Montagnier (1st. Pasteur-Parigi) e agli inizi del 1984 negli Stati Uniti da
quello diretto dal Prof. Robert C. Gallo (National Cancer Intitute-Bethesda) fu isolato ed
identificato un virus giudicato responsabile dell' AIDS.
Denominato dai francesi LAV (Lymphadenopathy-associated virus = virus associato a
linfoadeno­patia) e dagli statunitensi HTL V -III (human T - lymphotropic virus-III = virus T
linfotropo umano tipo 111), viene ora internazionalmente denominato HIV ( Human
Immunodeficiency Virus = Virus dell'immunodeficienza umana).
Due sono i virus T-linfotropi identificati a tutt'oggi quali agenti dell' AIDS: HIV-1 e HIV-2 .
Biologicamente simili, si differenziano per alcuni componenti antigenici e la composizione in
acido nucleico.
L' HIV -1 è responsabile della quasi totalità dei casi di AIDS fino ad oggi diagnosticati nel
mondo.
L' HIV-2 si osserva invece nell'Africa Occidentale (Guinea di Bissau, Capo Verde ecc. ); il suo
potenziale patogenetico sembrerebbe inferiore rispetto al tipo 1 visto che i dati clinici
indicherebbero un rischio più basso di sviluppare AIDS rispetto ai portatori di HIV-1.
EPIDEMIOLOGIA
L'AIDS è diffuso in tutto il mondo, ma il maggior numero di segnalazioni sono state raccolte in
America, Africa, Europa.
Le modalità di trasmissione dell'HIV sono concordemente indicate in :
-rapporti sessuali, vaginali o anali
-scambio di siringhe infette
-trasmissione di sangue infetto .
1 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
-dalla madre infetta al neonato
L'età prevalente è tra i 20 ed i 49 anni ed i gruppi a rischio (in ordine decrescente di
importanza):
-omosessuali e bisessuali
-tossicodipendenti (droghe per via endovena)
-emofilici
Il rapporto sessuale rappresenta la forma di trasmissione prevalente (il virus è presente nello
sperma e nelle secrezioni cervico-vaginali).
La prevalenza degli omosessuali si spiega con la intensa vascolarizzazione della mucosa anale
e la promiscuità dei rapporti (più frequente nel passato).
Nei tossicodipendenti, come negli emofilici, è la trasmissione ematica la fonte del virus: per i
primi per il frequente scambio di siringhe ed aghi infetti, per i secondi a seguito della trasfusione
di derivati del sangue (fattore VIII), quando ancora non era in atto l'attuale diagnostica di
laboratorio.
Altra forma di trasmissione (cosiddetta "verticale") è quella da madre infetta al figlio
durante la gravidanza, col parto e talora dopo il parto coll'allattamento.
Non bisogna dimenticare che anche l'inseminazione artificiale ed il trapianto d'organo sono
modalità accertate di trasmissione.
La possibilità di contagio con cibo e acqua, uso comune di stoviglie, di abiti, puntura di insetto,
starnuti, colpi di tosse, ecc. non è provato e pertanto non deve essere tenuto in alcun conto, ad
evitare che alcune voci distorcano dati di fatto ed impediscano la corretta attuazioni di efficaci
misure di controllo.
Sulla base delle segnalazioni giunte dai vari continenti l'andamento dell' AIDS è stato suddiviso
in tre gruppi.
L'Andamento I è proprio dei paesi industrializzati (Stati Uniti, Canada, Europa Occidentale,
Australia, Nuova Zelanda, America Meridionale ; alcune zone dell' Africa, pur non essendo
industrializzate, hanno questo andamento): l'infezione predomina tra gli omosessuali maschi ed
i tossicodipendenti che usano droga per via endovenosa. I rigorosi accertamenti di laboratorio
hanno praticamente annullato la possibilità di trasmissione a seguito di trasfusioni di sangue ed
emoderivati; la ridotta percentuale di donne infette (il rapporto maschi infetti-donne infette è di
10-15 a uno) spiega la ridotta incidenza di neonati contagiati.
L'andamento II è tipico dell' Africa Centrale, orientale e meridionale (generalmente nelle grandi
città) di alcune zone dell'America Latina e dei Caraibi. In tali zone il rapporto maschi-­donne
infetti è uno a uno e quindi la via di contagio predominante è quella eterosessuale (maschiofemmina, femmina- maschio); scarsa o nulla è l'incidenza dell'omosessualità e della
tossicodipendenza per via endovenosa mentre alta è la trasmissione madre-neonato
(trasmissione perinatale) per l'alto numero di donne portatrici del virus.
L'Andamento III si esprime in zone dell'Europa orientale, Africa settentrionale, Asia, Medio
Oriente, Oceania; poche sono le segnalazioni di infezione da HIV, a carico di individui che si
erano recati in zone ad andamento I, II e avevano avuto rapporti con abitanti di quei Paesi. In
alcune zone si è avuta forte incidenza in soggetti trasfusi, mentre bassa è la percentuale di casi
registrati in omosessuali maschi, eterosessuali, tossicodipendenti.
ETIOPATOGENESI
2 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
Come abbiamo visto nell' introduzione la causa dell' AIDS è un virus.
Che cosa è un virus? E' un microrganismo che non è in grado di replicarsi (ossia moltiplicarsi)
se non si impadronisce, sfruttandolo per sè, dell'apparato di sintesi di una cellula.
I virus vengono suddivisi, in base al loro patrimonio genetico di acidi nucleici, in virus a DNA
(acido desossiribonucleico) e virus a RNA (acido ribonucleico).
Normalmente l'informazione genetica necessaria alla replicazione segue una via di
trasformazione che dal DNA va all' RNA ed alle proteine (che sono la componente strutturale e
funzionale della cellula).
I virus a DNA seguono tale flusso. Invece in quelli a RNA il materiale genetico è contenuto nell'
RNA dal quale, con diversi meccanismi, si ottiene senza traduzione in DNA la sintesi proteica.
Invece il virus dell' AIDS, pur essendo un virus a RNA, si comporta diversamente; infatti esso
appartiene alla famiglia dei "retrovirus", i quali possiedono un enzima, la
transcriptasi inversa, il quale trasforma il codice RNA in codice DNA, permettendo così la
trascrizione e la traduzione dei geni virali in proteine secondo la normale sequenza.
Prima di procedere alla definizione eziologica della malattia è opportuno aprire una parentesi
per chiarire che cosa è la risposta immunitaria (ossia difensiva, di protezione) del soggetto.
La risposta immune contempla meccanismi ASPECIFICI e SPECIFICI.
I primi agiscono in maniera generica trattandosi di un sistema di difesa naturale rappresentato
da fattori tissutali di barriera (cute e mucose), fattori cellulari ( PMN, monociti, macrofagi) e
fattori umorali (lisozima, complemento, properdina, interferone).
L'immunità specifica invece è acquisita e presuppone meccanismi complessi.
Il nostro organismo sviluppa durante il periodo fetale la capacità di riconoscere ciò che è proprio
(cosiddetto "self') da ciò che è estraneo (cosiddetto "non self'). Questo è il
presupposto che permette ad ogni individuo di affrontare efficacemente le svariate sostanze
estranee (cosiddetti "antigeni") che sono presenti nell'ambiente che ci circonda e
con i quali esso può venire a contatto.
Il fine ultimo di questo sistema è mantenere l'integrità fisica del soggetto di fronte
all'aggressione di virus, funghi, batteri, parassiti ecc. eliminando con precisione l'elemento
estraneo ed impedendo che l'infezione da essi indotta possa nuocere al soggetto.
Gli elementi cellulari che compongono il sistema immunitario sono vari; essi originano da una
cellula indifferenziata presente nel midollo osseo -cellula staminale (stem cell)- in grado di dare
origine a diverse linee cellulari: cellule linfoidi, fagociti, cellule mediatrici.
La definizione dei primi due gruppi ci permette di comprendere il perché delle manifestazioni
cliniche dell' AIDS.
Le cellule linfoidi danno origine a due tipi di linfociti (oltre a particolari cellule denominate natural
Killers -N K): i linfociti T e B.(i Linfociti fanno parte dei globuli bianchi di cui costituiscono il 20-25
% del totale; sono così definiti perché non hanno pigmento e sono quindi "incolori",
al contrario dei globuli rossi).
I linfociti T acquisiscono la loro maturazione differenziativa nel timo, mentre i linfociti B hanno
come organi maturativi la milza ed i tessuti detti "bursa equivalenti" quali le placche
di Peyer dell'ileo ed i noduli linfatici dell'appendice.
I linfociti T svolgono la loro azione contro virus, funghi, protozoi, taluni batteri e sono
responsabili della reazione del rigetto dei trapianti (poiché trattasi di tessuti estranei) e di unà
3 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
azione antitumorale (si tratta di tessuti mutati dell'organismo); la risposta immunitaria da loro
svolta viene definita immunità cellulare o immunità cellulo-mediata ed avviene allorché linfociti
"sensibilizzati" nei confronti delle molecole estranee, iniziano a riprodursi e
differenziarsi, rilasciando delle molecole, linfochine, alcune delle quali regolano l'attività degli
altri componenti della risposta immune mentre altre partecipano direttamente all'eliminazione
delle cellule estranee.
I linfociti B invece esplicano la loro azione nella risposta immunitaria nei confronti delle infezioni
batteriche. Presiedono la cosiddetta immunità umorale che comporta la produzione e
liberazione di particolari proteine denominate anticorpi (sono immunoglobuline IgM, IgG, IgA,
IgD, IgE) specifici per l'antigene che ha provocato la risposta immune (questa produzione
avviene dopo che il linfocita B si è trasformato, a livello dei linfonodi, in plasmacellula).
I meccanismi svolti dai linfociti T e B non sono certamente separati gli uni dagli altri ma vi è una
costante cooperazione per rendere efficace ed altamente specifica la difesa dell'organismo.
Scendendo più in dettaglio, allorché l'antigene (come già detto agente estraneo all' organismo
del soggetto)
penetra all'interno dell' organismo,
viene ingerito da cellule denominate macrofag
i (originano dai monociti, fanno parte dei fagociti, ed il loro nome significa "macro = grande
e fago = divoratore) i quali sono presenti praticamente in tutti i tessuti, ed in particolare in quelli
in cui più facile è la probabilità di entrare in contatto con sostanze estranee. Si distinguono
macrofagi fissi presenti su alcuni vasi sanguigni e linfatici con il compito di eliminare dal sangue
e dalla linfa batteri e particelle estranee e macrofagi mobili, capaci di muoversi nei tessuti e
nelle cavità, es. macrofagi degli alveoli polmonari ecc ...
Queste cellule svolgono un ruolo fondamentale nella risposta immunitaria in quanto
rappresentano la risposta più precoce all'invasione di molecole estranee sia in maniera non
specifica agendo come "cellule spazzino" che inglobano cellule infettate e particelle
estranee, sia riconoscendo specificamente l'antigene come non-self e presentando poi
l'informazione ai linfociti T. A loro volta i linfociti T si differenziano in linfociti T memoria, in grado
di rispondere efficacemente e soprattutto rapidamente nel caso di successivo attacco da parte
dello stesso antigene, in
linfociti T helpers
(detti anche linfociti T4 oppure OKT4),
linfociti T suppressors
(linfociti T8 oppure OKT8),
linfociti effettori
e
linfociti killers
.
A questo punto iniziano a scoprirsi le interazioni tra linfociti T e B. Infatti i linfociti T4 facilitano la
produzione di anticorpi da parte dei linfociti B, mentre i linfociti T8 ne controllano, limitano e
quindi regolano la stessa produzione. Inoltre i linfociti effettori, come già detto, producono le
linfochine (piccole ma potenti proteine) le quali, tra i molti altri ed importanti effetti, stimolano la
proliferazione delle plasmacellule e dei linfociti T effettori.
Da tutto ciò si comprende, pur nella notevole complessità dell'argomento, come la limitazione di
un solo elemento della straordinaria edificazione che è il sistema immune, si traduca in un
fallimento di questo meccanismo esponendo l'organismo all'azione negativa di elementi
estranei quali tossine, batteri, virus ecc. , col risultato di danni importanti per l'organismo fino
4 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
alla morte del soggetto.
Essendo l'immunità cellulo-mediata baluardo difensivo capace di opporsi ed eliminare virus,
funghi, parassiti, e certi batteri quali i micobatteri (a questo gruppo appartiene la tubercolosi), il
declino dei linfociti T4 (mediatori dell'immunità cellulare), permetterà l'insorgenza di quadri
clinici correlati agli agenti patogeni suesposti, altrimenti ben controllati da una organizzata ed
efficiente risposta cellulo-mediata.
La caratteristica del virus HIV è quella di infettare i linfociti ed i macrofagi. Il perché è legato alla
elevata affinità del virus dell' AIDS per una molecola presente sulla superficie delle cellule
suindicate, denominata CD4 (questo è il marcatore dei linfociti T4, del 40% dei monociti ed in
numero minore di alcuni macrofagi e di cellule microgliali presenti nel cervello e midollo osseo).
In particolare il legame avviene tra il CD4 ed una proteina dell'involucro del virus, la gp120
(glicoproteina, ossia proteina contenente zuccheri complessi, con peso molecolare di 120
chilodalton), che sporge all'esterno della membrana virale.
La popolazione linfociti T-helper (T4) oltre a consentire la duplicazione del virus e ad andare
incontro a morte liberando il virus, può essere soggetta ad un processo di fusione per cui
moltissimi linfociti T4 non infettati si legano, fondendosi, ad un'unica cellula infetta (la cellula
infetta presenta sulla sua superficie la gp120 che funge così da legame per altri linfociti T) a
formare un grosso aggregato di cellule (fino a 500 - cosiddetti sincizi) incapaci di sopravvivere.
Così la morte di una sola cellula infettata è accompagnata nella stessa sorte da decine o
centinaia di cellule T4 non infettate.
Inoltre il virus HIV è molto fragile e perciò spesso dall'involucro esterno si stacca la gp120 la
quale legandosi al recettore CD4 di cellule non infettate, le rende "non-self' e come tali
soggette ad essere attaccate e distrutte dal sistema immunitario.
I ricercatori hanno inoltre evidenziato due fenomeni paradossi:
il primo per cui la replicazione del virus e la morte delle cellule è aumentata quando i linfociti T4
sono "attivati" e cioè quando essi stanno partecipando "attivamente" alla
difesa immunitaria. In questo caso il processo che dovrebbe portare all'eliminazione dell' HIV, si
traduce al contrario in una incrementata proliferazione del virus;
il secondo è legato all'osservazione, in soggetti infettati, della replicazione del virus solo in una
piccola percentuale di linfociti T 4, numericamente non sufficiente a giustificare
l'immunodeficienza. E' stata la scoperta in vitro (ossia in laboratorio, ma si presume che ciò
avvenga anche nell'uomo) della formazione di sincizi (vedi) e dell'azione del frammento virale
libero gpl20 (vedi) a suggerire come la grande deficienza immunitaria non sia dovuta
unicamente alla replicazione virale.
In termini pratici osserveremo una riduzione numerica ed una perdita delle funzione dei linfociti
T-helper (vedi) e parzialmente dei macrofagi (vedi) con declino generalizzato nel funzionamento
delle difese immunitarie ( immunodeficienza ) e quindi estrema sensibilità ad agenti patogeni
banali.
Poiché quindi la diminuzione progressiva dei linfociti T 4 (helper) condiziona negativamente la
funzionalità del sistema immunitario e conseguentemente l'espresione clinica dell'infezione da
HIV, presso il "Walter Reed Army MedicaI Center" di Washington D.C. (U.S.A.) è
stato adottato un sistema di classificazione che valuta il decorso della malattia dall'esposizione
al virus sino all' AIDS
conclamato, basandolo su vari indicatori del danno
immunitario, primo tra tutti il numero e la funzionalità dei linfociti T4, definiti i "registi"
del sistema immunitario per le loro svariate funzioni che li rendono essenziali
nell'interdipendenza del sistema immunitario.
5 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
Nel soggetto normale il numero di linfociti T4 è di 800 cellule per millimetro cubo. Nella
classificazione del Walter Reed (WR) vengono considerate valore di riferimento le 400
cell./mm3: la caduta persistente al di sotto di tale soglia è segno di declino del potere
immunitario del soggetto.
Oltre all'aspetto cellulare tale classificazione tiene conto dell'ingrossamento dei linfonodi (
linfoadenopatia cronica che deve permanere per almeno tre mesi per assumere valore di prova
dell'infezione), della risposta ai tests cutanei (tubercolina, tricofitina, candidina, PPD ) che sono
espressione dell'immunità cellulo-mediata. Queste proteine specifiche vengono iniettate
sottocute e la positività della risposta, che si sviluppa con la comparsa dopo 24-48· ore, in sede
di iniezione, di arrossamento, edema, induramento, esprime l'efficienza della risposta cellulare
(la parziale o completa mancanza di risposta deve permanere tale per tre mesi prima di essere
indicata come criterio valido di classificazione), dello sviluppo di candidosi, dell' insorgere di
infezioni opportunistiche (sono così definite le infezioni dovute a microrganismi che
normalmente non provocano malattie nell'uomo, che si manifestano soltanto a seguito
dell'inefficace, perché depressa, risposta immunitaria).
Si parte con lo stadio WR O che esprime il periodo che va dal momento dell'esposizione al
virus (contagio) al momento in cui si positivizzano i tests sierologici per l' HIV (vedi) (tempo
variabile tra sei settimane ed un anno). E' il periodo denominato "finestra
immunologica" poichè in tale tempo non è ancora avvenuta la sieroconversione, cioè la
comparsa degli anticorpi contro il virus la cui presenza è espressa dalla positività dei tests. Il
soggetto infetto perciò pur essendo siero negativo può trasmettere l'infezione; in questo stadio
si tende ad includere i soggetti siero negativi appartenenti a categorie a rischio.
Con la siero conversione si ha il passaggio allo stadio WR 1. Solitamente i soggetti a questo
punto non presentano alcun disturbo, eccetto alcuni i quali lamentano astenia, febbre,
ingrossamento delle linfoghiandole, con un quadro simile alla mononucleosi. In poche settimane
tutto regredisce. In questo frattempo però il virus continua a replicarsi ed a distruggere,
lentamente, i linfociti T 4.
Uno dei primi segni che chiaramente orientano verso una progressione di malattia è il
rigonfiamento persistente dei linfonodi (linfoadenopatia cronica) espressione dello stadio WR2 c
he corrisponde al LAS- gruppo III della classificazione CDC.
Anche in questo stadio (variabile da 3 a 5 anni) il paziente gode di buone condizioni fisiche,
dopodiché appare, a livello subclinico (con tale termine indichiamo una anomalia che non si
esprime con una sintomatologia evidente), un segno persistente che inesorabilmente segnala il
declino dell'attività immunitaria: la caduta del numero di linfociti T4 al di sotto dei 400/mm 3 (stad
io WR3 ).
Dopo circa 18 mesi compaiono, pur sempre nell'asintomaticità della malattia, anomalie nella
risposta ai test cutanei (l'iniezione di tre dei quattro tests classici non evoca alcun segno reattivo
della cute).
Lo stadio WR 5 viene raggiunto quando tutti i tests sono negativi (anergia) oppure si sviluppa
una candidosi orale (micosi che determina la formazione di chiazze biancastre). Il numero dei
3 . Oltre
linfociti T4 è sceso a questo punto al di sotto delle 200-100 cellule/mm
alla candidosi possono essere presenti, con carattere persistene e grave, infezioni da herpes
simplex attorno alla bocca ed in sede perianale (erosioni, ulcerazioni -quindi lesioni
approfondite della cute- in opposizione alle classiche vescicole dei soggetti non
immunodepressi). e la cosiddetta "Leucoplachia orale pelosa" caratterizzata da
chiazze di colore biancastro (e perciò simile alla candidosi) ma di aspetto villoso, lanuginoso.
6 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
Tutte queste manifestazioni sono spesso presagio della comparsa di infezioni opportunistiche e
quindi, nel giro di uno o due anni, del passaggio allo stadio
WR 6, ossia all' AIDS vero e proprio.
TABELLA
STADIO
anticorpi anti.HIV e/o virus
Linfoadenopatia cronica
Cellule T Helper/mm3
Ipersensibilità ritardata
Candidosi
Infezioni opportunistiche
WR0
-
7 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
-
> 400
Normale
-
-
WR1
+
-
> 400
Normale
-
8 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
-
WR2
+
+
> 400
Normale
-
-
WR3
+
+/-
9 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
< 400
Normale
-
-
WR4
+
+/-
<400
P
-
-
10 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
WR5
+
+/-
<400
C e/o Candidosi
-
-
WR6
+
+/-
< 400
11 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
+/-
-
Abbiamo già chiarito cosa significhi infezione opportunistica. Esse sono presenti in tutti i
pazienti allo stadio WR 6 poichè un sistema immunitario in cui la risposta cellulare è deficitaria
(pertanto incapace di eliminare ogni agente patogeno), espone il soggetto ad infezioni
sconosciute alla popolazione sana.
INFEZIONE
QUADRO CLINICO
PARASSITI
(Protozoi ed elmiti)
Pneumocystis carinii
Polmonite
Toxoplasma gondii
Polmonite, lesione del sistema nervoso centrale (encefa
Strongyloides stercoralis
Polmonite, lesione del sistema nervoso centrale, infezio
Cryptosporidium
Gastroenterite (diarrea refrattaria alla terapia della durat
Isapora belli
Gastroenterite (diarrea persistente per più di un mese)
FUNGHI
Candida albicans
Orofaringite, vaginite, esofagie, infezione bronchiale o p
Cryptococcus neoformas
Lesione del sistema nervoso centrale (meningite), polm
Histoplasma capsulatum
Infezione disseminata
Aspergillus fumigatus
Infezione disseminata o lesione del sistema nervoso cen
Nocardia asteroides
Lesione del sistema nervoso centrale, polmonite
BATTERI
Mycobacterium tubercolosis
Infezione disseminata
Micobatteri atipici (avium intracellulare,
Infezione
Kanrasii)
disseminata
Salmomella
Batterimia
Legionella pneumophile
Polmonite
Streptococcus pneumoniae
Polmonite
Staphylococcus aureus
Batterimia (sepsi) infezioni cutanee, polmonite
Hemophilius influenzae
Polmonite, batteriemia (sepsi), cellulite (infezione tessut
VIRUS
Cytomegalovirus
Lesione del sistema nervoso centrale, polmonare, gastr
Herpes simplex
Lesioni mucocutanne (con ulcere persistenti per oltre un
Varicella/zoster herpes virus
Infezione grave e localizzata (zoster) o disseminata
12 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
Papovavirus
Epstein-Barr virus
TUMORI
Sarcoma di Kaposi
Linfomi
Leucoencefalopatia progressiva multifocale
Linfoadenopatia, leocoplachia orale villosa, infezione dis
Lesioni cutanne (placche purpuriche e noduli) infiltrati po
Linfoadenopatia stenomegalia epatomegalia
Oltre alla classificazione del &quot;Walter Reed&quot; (la più frequentemente usata), ne esiste
un'altra proposta dal &quot;Center of Disease Control&quot; (C D C) di Atlanta (USA) ; essa si
basa sull'ampio spettro dei quadri clinici e propone criteri esclusivamente clinici con suddivisioni
in gruppi nei quali è racchiusa l'ampia varietà di espressione e gravità della malattia (vedi
tabella).
TABELLA Classificazione dell'infezione da HIV -1 secondo CDC
GRUPPO I infezione acuta sindrome simil-mononucleosica (febbre, brividi, artralgie, mialgie,
orticaria, rash maculo-papulosi, crampi addominali, diarree con risoluzione spontanea in 2-3
settimane)
GRUPPO II infezione asintomatica
GRUPPO III linfoadenopatia generalizzata persistente (LAS = linfoadenopatia sistemica) .
L'ingrossamento dei linfonodi (detti anche linfoghiandole) deve superare 1 cm di diametro,
interessare 2 o più distretti ghiandolari del corpo umano (nuca, collo, ascella ecc.), durare da
almeno tre mesi senza che vi siano malattie o siano stati somministrati farmaci in grado di
causare effetti sui linfonodi.
GRUPPO IV
Sottogruppo A malattia costituzionale (ARC = complesso correlato all' AIDS). Rientrano in
questo sottogruppo pazienti che presentano da almeno tre mesi 2 o più dei seguenti sintomi:
perdita di peso superiore al 10%
,
sudorazioni notturne profuse
,
stanchezza (astenia) profonda
,
febbre,
diarrea
,
ingrossamento dei linfonodi
(linfoadenopatia) in numerosi distretti.
Sottogruppo B malattia neurologica: demenza, mielopatia, neuropatia periferica, meningite
acuta e cronica;
Sottogruppo C malattie infettive secondarie:
categoria C1 infezioni opportunistiche che rientrano nella definizione di AIDS secondo CDC
protozoi o elminti (pneumocistys carinii, cryptosporidium, isospora, toxoplasma, stongyloides)
miceti (candida, cryptococcus, histoplasma)
batteri (complesso mycobacterium avium, m. kansasii) virus (citomegalovirus, herpes simplex,
pàpovavirus)
13 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
categoria C2 malattie infettive secondarie:
leucoplachia orale, herpes zoster, sepsi ricorrente da salmonellosi, nocardiosi, tubercolosi,
candidosi
orale).
Sottogruppo D tumori secondari: sarcoma di Kaposi.
Lesione del sistema nervoso centrale, polmonare, gastrointestinale
Lesioni mucocutanee (con ulcere persistenti per oltre un mese), infezioni polmonari,
gastrointestinali o disseminate.
DECORSO
Il decorso della malattia dal contagio all' AIDS conclamato è piuttosto lento.
La teoria più accreditata ipotizza che ruolo fondamentale sia svolto dal sistema immunitario.
Per un certo periodo infatti l'organismo riesce ad opporre un'efficace risposta immunitaria nei
confronti dell' HIV, sia neutralizzandolo, sia impedendo legami con altre cellule, sia eliminando
le cellule infette. Nonostante questa attenta sorveglianza, la proliferazione virale, pur essendo
contenuta nei suoi aspetti citotossici, si mantiene sempre attiva e lentamente raggiunge uno
stadio in cui, complice la caduta.numerica dei linfociti T4 (stadi WR 3 - WR 5), viene meno la
capacità di controllo del sistema immunitario e la replicazione virale, libera da ogni freno
inibitorio, avviene in maniera incontrollata ed il virus, presente in quantità numericamente
sempre maggiore, distrugge i residui linfociti T4.
Questa ipotesi non rappresenta solo un esercizio accademico volto a dare una attendibile
spiegazione sull'evoluzione della malattia ma propone precise riflessioni sul grado di infettività
dei soggetti venuti a contatto con l' HIV . Infatti si presume (vedi tabella) che momenti di alta
infettività siano legati:
1) alle prime fasi del contagio
2) alla progressiva riduzione dei linfociti T4
Infatti
1) corrisponde al periodo di tempo necessario perché l'organismo produca un'efficace risposta
immunitaria (fase pre-sierologica ossia prima che i tests risultino positivi)
2) procedendo dallo stadio WR 3 allo stadio WR 6, al sempre più marcato declino dei linfociti T4
si accompagna, con una curva di andamento opposto, un aumento della carica virale sempre
più spiccato.
Quindi riteniamo validi gli assiomi per cui a maggior quantità di virus nel sangue si accompagna
maggiore capacità infettante del soggetto e quanto più lungo è il tempo trascorso dal momento
infettante, maggiore è la capacità infettante stessa.
Da ciò si comprende come attenta debba essere la sorveglianza sanitaria e parimenti valida la
collaborazione e la coscienza dei cittadini nell'osservazione di precise norme di vita,
quotidianamente sollecitate.
PREVENZIONE
Per la popolazione in generale
-non fare uso di droghe;
-evitare rapporti sessuali occasionali o con partners sospetti o almeno usare sempre il
profilattico;
14 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
-usare soltanto siringhe a perdere ed evitarne assolutamente lo scambio o la riutilizzazione;
-in caso di trasfusione fare uso di sangue proveniente esclusivamente da Centri Trasfusionali
autorizzati
Per i soggetti appartenenti a categorie a rischio
-sottoporsi ad esami clinici e di laboratorio per accertare il proprio stato rispetto all'infezione;
-evitare rapporti sessuali occasionali;
-ridurre il numero dei partners sessuali;
-usare regolarmente il profilattico;
-le coppie di soggetti a rischio, desiderose di figli, devono sottoporsi ad esami preliminari;
-evitare l'uso comune di spazzolini da denti, rasoi ed altri oggetti da toilette;
-astenersi dalle donazioni di sangue, plasma, organi,
Per i soggetti sieropositivi (infetti)
-evitare i rapporti sessuali o almeno usare regolarmente il profilattico fin dall'inizio del rapporto
sessuale;
-informare il partner della propria condizione di sieropositività anche a scanso di eventuali
responsabilità giuridiche;
-evitare lo scambio di articoli personali da toilette, specialmente di oggetti aguzzi o taglienti;
-usare soltanto siringhe a perdere ed evitarne assolutamente lo scambio o il riutilizzo;
-evitare donazione di sangue, plasma, tessuti, organi, sperma;
-informare i sanitari curanti (medico, dentista, chirurgo, ginecologo, analista ecc.) del proprio
stato di sieropositività;
-è controindicata la gravidanza nelle donne sieropositive in età fertile
-le donne sieropositive gravide devono rivolgersi ai Centri indicati dalla Regione, dato l'elevato
rischio della trasmissione dell'infezione dalla madre al feto
-sottoporsi a regolari controlli clino-diagnostici;
DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DEI MATERIALI CONTAMINATI
15 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
DISINFETTANTE
TEMPO DI ESPOSIZIONE
INDICAZION
IPOCLORITO DI SODIO
(diluizione 1:10 - 1:100
(varechuna o candeggina)
5 -10 minuti
ACE 100 ml
in 900 mo di acqua
piastrelle, superfici, banconi, pavimenti, vasche da bagno,, lav
ANTISAPRIL 200 ml in 800 ml di acqua
AMUCHINA 500 ml in 500 ml di acqua
ALCOOL ETILICO
30 minuti
termometri, forbici, pet
GLUTARALDEIDE
5 minuti
strumentario ( endosco
CALORE (56 °C)
30minuti
materilai organici
(100 °C)
5 minuti
strumentario
BOLLITURA
5 minuti
indumenti e biancheria
CIDEX (2%)
intero o diluito 1/5
DIBA (20%)
diluito 1:10 - 1:20
5 minuti
16 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
L'antigene (Ag) ossia il virus sarebbe svelabile nel siero 2-3 settimane dopo l'infezione e
scompare nel giro 3-5 mesi. I primi a comparire sono gli anticorpi (Ag) anti
&quot;envelope&quot; (gp-41) presenti anche in caso di antigenemia; più tardiva la comparsa
degli anticorpi (Ac) anti &quot;core&quot; (p-24).
DIAGNOSI DI LABORATORIO
Come abbiamo visto da quadri classificativi dell' AIDS (WR o CDC), la maggior parte delle
persone affette da HIV non presenta, per alcuni mesi dall'evento contagiante, alcun sintomo di
malattia.
In assenza totale di ogni riferimento clinico (per gli stadi iniziali si può avere patologia
similmononucleosica- vedi WR lo gruppo 1 CDC - , o gonfiore persistente dei linfonodi- vedi WR
2 o gruppo 2 CDC-) il criterio necessario sufficiente per confermare l'avvenuta infezione da HIV
(o la malattia nel caso in cui siano già presenti i sopra esposti dati patologici) è basato
unicamente su indagini di laboratorio.
Le diagnosi di laboratorio di infezioni da HIV si basa
sia 1) sull'isolamento del virus
sia 2) su prove sierologiche che ricercano anticorpi specifici o antigeni virali nel siero del
soggetto.
1) ISOLAMENTO DEL VIRUS
La procedura che porta ad individuare il virus dal sangue o da diversi materiali biologici è
estremamente indaginosa ed eseguibile solo presso laboratori estremamente attrezzati. Essa si
basa sulla inoculazione dei suddetti materiali in colture cellulari e nella dimostrazione della
replicazione del virus secondo vari monitoraggi (attività della transcriptasi inversa, ricerca del
virus e degli antigeni virali mediante tecniche di immunofluorescenza, microscopia elettronica
ecc.)
2) PROVE SIEROLOGICHE
Più semplice ed alla portata di tutti i laboratori è la ricerca degli anticorpi specifici per l'agente
etiologico della malattia, dimostrazione indiretta del contagio da HIV.
Comunemente vengono utilizzati tests immunoenzimatici (ELISA = Enzime-Linked
Immuno-Sorbent Assay)
L'introduzione di questi saggi fu dettata dalla necessità di evitare che sangue HIV infetto fosse
trasfuso ad individui non infetti. Pertanto a tali metodiche si richiese una altissima sensibilità:
occorreva infatti che gli anticorpi HIV specifici venissero riconosciuti ogni volta che fossero
presenti nel campione di sangue anche in quantità minima, per evitare di indicare come
negative (e quindi non infette) sacche di sangue infetto (cosiddetti falsi negativi).
Infatti bisogna tener conto che esiste un lasso di tempo (da 2-3 settimane a 3-6 mesi)
17 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
immediatamente successivo all'infezione (cosiddetta &quot;finestra&quot;) nella quale la
produzione di anticorpi HIV-specifici è del tipo IgM e non IgG. I kits in commercio comunemente
usati riconoscono solo le IgG e non le IgM lasciando quindi un buco.
A questo concetto di sensibilità si sacrificò volutamente un altro importante concetto, quello
della specificità, ossia la capacità del test di riconoscere solo gli anticorpi HIV-specifici e non
anche anticorpi simili a quelli specifici ma non diretti contro i virus (e quindi senza significato
nello screening dell'AIDS). Ecco perché alla positività del test ELISA si cerca conferma con
metodiche meno sensibili ma molto specifiche che ci permettono di confermare o escludere con
certezza la sua positività (Western-Blot)
Il significato di questi due livelli di indagine è ovvio. Col primo metodo (altissima sensibilità)
dobbiamo evitare che ci sfuggano soggetti infetti mentre con la seconda metodica (alta
specificità) si cercheranno eventuali positività, specialmente se il soggetto non appartiene alle
categorie a rischio. Infatti nella globalità dell'indagine bisogna tener conto che il fattore di rischio
(ossia l'appartenenza alle categorie già citate) è compendio fondamentale all’indagine di
laboratorio.
VACCINO
La vaccinazione rappresenta la migliore forma di prevenzione come dimostrano la scomparsa di
alcune malattie (vaiolo, poliomielite) o la ridotta incidenza di altre (morbillo, rosolia, ecc.).
Le proprietà terapeutiche della vaccinazione (si tratta di introdurre nell'organismo l'antigene nei casi suddetti i virus- in forma innocua 'immunoantigene',ossia in forma tale da non produrre
la malattia ma in grado di creare una memoria immunologica verso l'antigene introdotto) si
basano sull'assunto che essa crea nel soggetto condizioni tali per cui se egli viene a contatto
con il virus per il quale è stato vaccinato, l'organismo è pronto ad affrontare e a sconfiggere in
maniera rapida ed efficacie l'agente infettivo senza possibilità di contrarre la malattia.
Anche nel caso dell' AIDS le ricerche per lo sviluppo di un vaccino hanno assunto carattere di
priorità dal momento in cui è stato isolato l' HIV.
L' HIV appartiene ad una classe di virus, i retrovirus, scoperti in un recente passato (meno di
dieci anni) e verso i quali la ricerca di un vaccino non era mai stata sollecitata poiché essi
infettavano solo gli animali. Ora che invece anche l'uomo è entrato nella spirale dell'infezione
retrovirale ci si rende conto di quanto sia difficile da percorrere tale strada. Infatti le difficoltà
nell' allestimento di un vaccino per l'AIDS sono legate:
1) alla particolarità del ciclo vitale del virus HIV (può nascondersi nelle cellule -comportamento
definito con il termine &quot;cavallo di Troia&quot;- ; può subire mutazioni, cambiando la
composizione del proprio rivestimento proteico; può inserire i propri geni tra quelli della cellula
ospite senza che vi sia replicazione virale stabilendo una infezione permanente; infetta alcune
delle stesse cellule che il vaccino deve attivare; manca un modello animale per la malattia)
2) alla difficoltà di sperimentare vaccini su esseri umani (problemi etici, legali, carenza di
volontari).
Quindi anche se notevoli sono le difficoltà e poco incoraggianti i risultati allo stato attuale, la
testimonianza dell'impegno e dello sforzo collettivo di numerosissimi ricercatori in tutto il mondo
impone non rassegnati atteggiamenti di fronte ai fallimenti ma, concreta e fattiva speranza di
poter controllare una malattia altrimenti esplosiva nei suoi impatti futuri sull'intero sistema
mondiale.
18 / 19
AIDS
Venerdì 30 Giugno 2006 10:29
TERAPIA
Attualmente non esistono risposte definitive a questo angoscioso problema.
La difficoltà di creare molecole antivirali nasce dal fatto che i virus non potendo replicarsi da soli
devono infettare cellule di un altro organismo per sfruttare l'apparato genetico ai propri fini.
Questo stretto coinvolgimento della cellula ospite nella fase di replicazione attiva crea difficoltà
nell'inibizione selettiva dell'attività virale, nell'intento di non danneggiare o per lo meno
danneggiare il meno possibile l'ospite.
Alcuni agenti terapeutici contro l'AIDS sono tuttavia in vari stadi di sperimentazione, per alcuni
ancora in laboratorio per altri in fase di applicazione clinica.
Di tutti questi solo uno è stato approvato come farmaco per gravi infezioni da HIV nel marzo
1987 dalla Food and Drug Administration ( USA): l'AZT (zidovudina o azidotimidina).
Questo composto interviene sulla fase di sintesi del DNA virale da parte dell'enzima
transcriptasi inversa.
Infatti la sua costituzione chimica, simile ad uno dei costituenti del DNA (timidintrifosfato), fa sì
che esso venga incorporato in una catena di DNA virale al posto del timidintrifosfato,
impedendo la prosecuzione della sintesi virale poiché l' AZT (trifosfato) non può formare legami
con altri costituenti. Si stabilisce perciò una &quot;inibizione competitiva&quot;.
Il farmaco si è dimostrato utile nel rallentare l'evoluzione della malattia (prolungando perciò la
sopravvivenza) oltre che diminuire il numero e la gravità delle infezioni opportunistiche (in ciò
alleviandone i sintomi).
Purtroppo però esso possiede anche effetti di tossicità midollare con anemia e, in alcuni casi,
riduzione dei valori dei globuli bianchi e piastrine.
Ciò limita la quantità di AZT che può essere somministrata specie in soggetti con malattia
conclamata.
Certamente l' AZT, pur con i benefici dimostrati, non rappresenta una cura definitiva ma una
prima risposta a dubbi e timori sulla possibilità di sintetizzare un farmaco capace di attaccare
direttamente il virus.
Sicuramente in seguito, con la sintesi di farmaci capaci di aggredire l' HIV in diverse parti del
ciclo vitale, verranno utilizzate strategie terapeutiche che forniranno risultati migliori rispetto a
quelle ottenibili con ciascun farmaco singolarmente ( associazione di più farmaci, farmaci
diversi in rapporto alla fase della malattia, anche in relazione al dosaggi ed alla posologia, ecc.).
LUCIANO SCHIAZZA
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Specialista in Leprologia e Dermatologia tropicale
Genova Tel 010/ 590270
pubblicazione del 1990
19 / 19