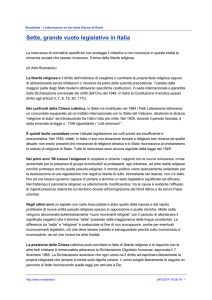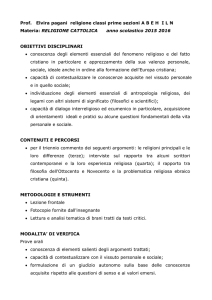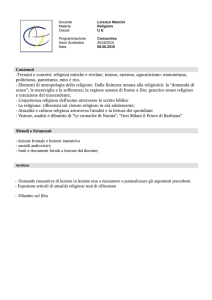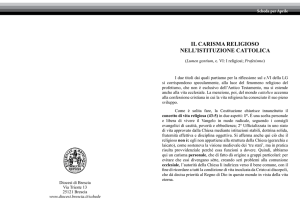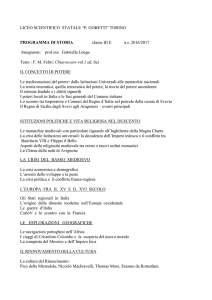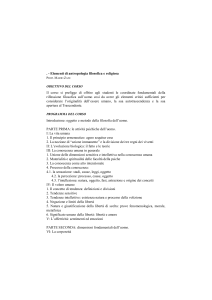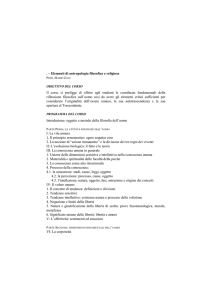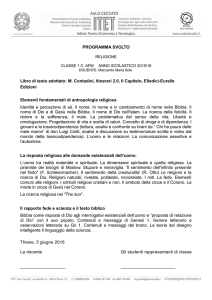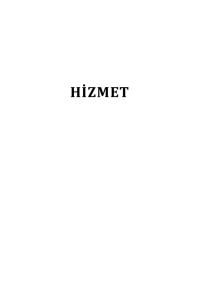Politica
TURCHIA
p
aternalismo e cambiamento
Dopo dieci anni, in crisi la leadership di Erdogan
Q
uando, nel mese di agosto, la rivista della compagnia di bandiera Turkish Airlines, Skylife, ha
pubblicato un ridondante
articolo sull’attuale museo di Santa Sofia a Istanbul, intitolandolo «La moschea dei sultani», non si
trattava della gaffe, sfuggita alla redazione, di uno studentello svogliato e molto ignorante in storia, ma di una tappa
ulteriore della strategica manipolazione
della storia (nella fattispecie, una «piccola dimenticanza» di 800 anni di vita del
più grande tempio della cristianità fino
alla costruzione della basilica di San Pietro a Roma).
Questa manipolazione si perpetua
nella «Turchia repubblicana» fin dai
tempi della sua fondazione. Agli inizi si
trattava della propaganda kemalista che
doveva dare un’identità a un paese nato
sulle ceneri di un grande Impero, quello ottomano; oggi si tratta della propaganda di un governo che, pur smantellando formalmente l’ideologia kemalista
in modo sistematico, in realtà ne perpetua la stessa logica sotto mentite spoglie.
Quelle che possono cambiare sono le ragioni di una tale manipolazione: si va dal
più nobile intento di creare un’identità
nazionale dal nulla (dopo l’implosione di
un’impero multinazionale e multiculturale, conseguenza del dissolversi della dinastia che l’aveva creato, allargato a dismisura e tenuto insieme nella sua diversità), al molto meno nobile intento di perennizzare un potere diventato, probabilmente, la strada più breve per arricchire sé stessi e un gruppo ristretto di
amici compiacenti.
16
Il Regno -
16-18_art_monge.indd 16
attualItà
Strano destino quello del Partito per
la giustizia e lo sviluppo (AKP), al governo in modo incontrastato da oltre
dieci anni, che puntellò la sua folgorante ascesa proprio a partire dal significato evocativo dalle iniziali del suo nome, «AK», che in lingua turca significa
«bianco» ma anche «puro». Queste due
lettere erano la sintesi di un programma politico che puntava prima di tutto a porre fine alla devastante corruzione che aveva portato alla deriva una sinistra ancora al potere alla fine degli anni Novanta. Molti, dieci anni fa, erano
pronti a scommettere su un partito che
si presentava come post-islamista, liberale, democratico e riformista. Il quadro
oggi è radicalmente cambiato, anche se
è troppo presto per tirare delle conclusioni sulle possibili conseguenze politiche dell’inchiesta su corruzione e riciclaggio di denaro sporco in corso, che
coinvolge direttamente e indirettamente una grossa fetta dell’establishment del
governo turco.
Si possono fare, tuttavia, alcune considerazioni più generali, non semplicemente suscitate dall’attualità e relative a un’evoluzione in corso in Turchia
già da alcuni anni che, in parte, è motivo di inquietudine ma anche il segno
di un cammino forse necessario per arrivare a una forma più matura di democrazia. Un’apparente invincibilità elettorale (quello del 2011 è stato il terzo clamoroso successo elettorale consecutivo
dell’AKP) ha fatto dimenticare all’ attuale primo ministro Tayyip Erdogan che
il gioco democratico prevede non solo
un’alternanza al governo ma, più semplicemente, un sano dibattito e la neces-
sità di dare delle buone ragioni alle proprie scelte politiche, evitando coinvolgimenti troppo personali e l’accanimento
in certi progetti difesi contro tutto e tutti
… Ma la metamorfosi del potere dell’ex
sindaco di Istanbul non è solo l’espressione di un «delirio di onnipotenza personale»; è l’epifenomeno di una cultura
storica dove «l’autoritarismo paternalista» sembra essere una fatalità e questo,
evidentemente, non solo nei paesi arabi
dove vige ancora in gran parte una struttura dinastico-tribale del potere.
La tentazione, anche guardando
all’attuale situazione turca di crescente
scontro sociale a forte connotazione religiosa, è allora quella di riaffermare una
presunta incompatibilità tra islam tout
court (in tutte le sue molteplici espressioni) e democrazia. Questa spiegazione, tuttavia, non ci convince, né in termini generali (da un punto di vista della storia delle idee già l’islam medievale conosce più modelli politici di riferimento) né, tanto meno, se pensiamo al
contesto turco. Certo, nel mondo islamico l’impatto con la modernità ha generato immediatamente una risposta autoritaria, mentre in Occidente, con la modernità inizia la contestazione radicale
dell’autoritarismo. Ma là dove c’è una
concezione autoritaria del potere non significa necessariamente che ci si opponga al cambiamento: si spera solamente
di gestirlo esercitando un controllo politico ostile alla partecipazione politica.
Qui si innesta una visione paternalistica
della relazione sociale, caratterizzata da
un rapporto verticale e clientelare, dove
si punta a una lealtà incondizionata in
cambio di alcuni beni o favori. In questo
2/2014
22/01/14 19.13
sistema, «legale» e «illegale» si combinano quasi naturalmente, così come «coercizione» e «solidarietà».
Alleanze fragili
Ma i rapporti sono inevitabilmente
molto fragili e a rischio: gli amici di ieri diventano spesso e volentieri i nemici di oggi, con capovolgimenti di fronte repentini e spesso farseschi. Ecco che
la polizia, difesa strenuamente dal primo ministro turco dei giorni della repressione violenta di Gezi Park, diventa, pochi mesi dopo, un covo di cospiratori da epurare al momento dell’inizio delle inchieste sugli scandali finanziari; l’esercito, smantellato nei suoi vertici da un processo mediatico e con non
poche ombre, detto Ergenekon (che in
realtà ha coinvolto anche giornalisti, intellettuali e politici d’opposizione), viene
a sorpresa in parte riabilitato, quando la
forte influenza sull’attività delle procure
inizia a ritorcersi contro coloro che l’anno troppo sfruttata: al momento dell’inizio dell’inchiesta anti-corruzione appunto…
Sembrerebbe un teatrino dell’assurdo, ma la stessa opinione pubblica turca sta iniziando a percepire che le cose
inizieranno davvero a cambiare in Turchia quando la gente comune sarà disposta a pagare di tasca propria il prezzo di un cambiamento che non riguarda semplicemente chi è di turno al potere, ma l’interpretazione stessa del potere. È una convinzione che traduce un’idea molto semplice: se il potere paternalistico autoritario ha potuto perpetuarsi e sopravvivere fino a oggi in Turchia (ma la riflessione potrebbe, ancora
una volta, essere estesa a tutta l’area mediorientale e oltre), è perché ha trovato un terreno fertile nel tacito consenso
di un’opinione pubblica che ha sempre
preferito delegare la fatica di pensare e
gestire il cambiamento, in cambio solamente di un minimo di sicurezza materiale personale.
Le ormai prossime elezioni municipali potrebbero offrire il primo segnale
politico chiaro di una radicale inversione di tendenza: il messaggio di chi non si
accontenta più solo di sanzionare attraverso le urne un cartello politico in favore di un altro, ma che fa del voto il
punto di partenza di un nuovo (più che
rinnovato) senso civico e di partecipazione alla cosa pubblica. È dal maggio
dello scorso anno, con l’inizio dell’ondata di sit-in pacifici suscitata dal movimento Occupy Gezi, che s’intravvedono dei segnali nuovi in questo senso (posto che questo movimento di mobilitazione cittadina continui a isolare quelle
frange minoritarie della piazza che sono
meno democratiche ancora di chi è oggetto di contestazione). La posta in palio
del turno elettorale del 31 marzo è dunque molto alta e riguarda non solo l’amministrazione delle grandi città del paese, prime fra tutte le megalopoli Istanbul
e Ankara (fino ad ora vero volano dell’azione del partito di governo), ma idealmente anche il ripristino della dignità
della politica, da tempo abolita in una
sorta di «stato privatizzato».
La «guerra intra-islamica» che opporrebbe attualmente, in una sorta di
scontro finale, il partito del primo ministro e il suo vecchio alleato, il movimento Hizmet (Servizio), espressione della neo-confraternita che fa riferimento
all’imam Fethullah Gülen, è un fattore
che ingarbuglia non poco un quadro già
di per sé complesso. La rottura sarebbe (i
dubbi sono leciti) clamorosa, visto che si
parla di partner di lunga data che hanno
sempre attinto consenso presso la stessa base sociale (ovvero la classe media
anatolica, moralmente conservatrice ma
economicamente ultra-liberale), e che si
sono mutualmente rafforzati grazie allo
smantellamento progressivo delle prerogative politiche dell’esercito e dell’apparato burocratico kemalista, dominatori
incontrastati dei primi ottant’anni di vita repubblicana. Ora, se di Tayyip Erdogan e del suo partito si conoscono ormai virtù e debolezze, del movimento
Hizmet si sa ben poco, perché si è sempre caratterizzato fin qui per un profilo
non politicamente organizzato ma semplicemente di sostegno di quelle forze
politiche favorevoli a un secolarismo rispettoso della libertà di religione in nome della democrazia.
Le minoranze al bivio
L’impressione è che le divergenze
crescenti, più che tra Hizmet e l’AKP,
siano tra il movimento islamico e il modo autoritario di interpretare il potere
da parte del primo ministro (a che pro
smantellare l’autoritarismo kemalista
rimpiazzandolo con un’altra versione
autoritaria del potere?), poco apprezzato anche in riferimento ad alcune recenti
scelte di politica estera che hanno accentuato l’isolamento della Turchia a livello internazionale. Questo isolamento è
particolarmente pesante per un paese al
cuore di una regione drammaticamente inquieta e potrebbe avere riflessi poco positivi anche su quella diversità interna che si esprime in molteplici minoranze etniche e religiose che hanno fatto
per secoli la ricchezza del sistema turcoottomano.
Del resto, anche queste minoranze,
soprattutto quelle cristiane, si trovano a
un vero e proprio bivio della loro storia:
si tratta di decidere se si vuole perpetuare un anacronistico «comunitarismo etnico» prima che confessionale, rischiando di implodere ripensando nostalgicamente a un passato più o meno glorioso e, certamente, molto mitizzato, oppure se si vuole vivere di un Vangelo che è
per natura «cattolico», nel senso di universale, senza per questo mortificare la
ricchezza della diversità di tradizioni e
liturgie spesso antichissime. Quest’ultime, per brillare, non possono continuare a essere messe semplicemente in vetrina ma devono potersi declinare nella
pratica di una fede ispirata da una Parola viva che porta all’incontro e combatte la fatale tentazione dell’auto ghettizzazione.
Insomma, se gli avvenimenti che caratterizzano quotidianamente la situazione in Medio Oriente portano spesso a
focalizzare l’attenzione su questa o quella comunità particolare, in realtà è la
condizione generale delle minoranze religiose che non cessa di porre dei problemi, in Oriente. È innegabile che negli ultimi decenni il peso sociale e politico dei
cristiani (soprattutto nell’Oriente arabo)
sia decisamente scemato a causa di una
demografia sfavorevole e di un’inesorabile migrazione. Ma dietro la crisi delle «Chiese nazionali», eredità dell’Impero ottomano (oltre che fattore di accelerazione della sua fine), c’è la crisi stessa della strumentalizzazione delle fedi a
servizio dell’affermazione identitaria di
un gruppo che sente la sua esistenza minacciata. Si tratta di un atteggiamento
in generale di difesa identitaria reazionaria. A torto o a ragione, si trasforma
cioè l’immutabilità stessa della tradizione religiosa in un operatore identitario.
Ecco perché le credenze si sclerotizzano,
si radicalizzano e talvolta si inaspriscono pure: atteggiamento che, oltre a rap-
Il Regno -
16-18_art_monge.indd 17
attualità
2/2014
17
22/01/14 19.13
presentare un fattore di allontanamento
delle nuove generazioni dalla pratica religiosa, offre il fianco a un’ulteriore strumentalizzazione politica della religione.
Una delle conseguenze più negative
delle attuali tensioni politiche in Turchia,
è l’apparente arenarsi del primo vero
tentativo parlamentare di riforma di una
Costituzione che risale ancora agli inizi
della Repubblica, salvo pochi emendamenti imposti dall’alto per via militare e
non frutto di un consenso politico. Questa riforma costituzionale avrebbe dovuto, tra l’altro, ripensare lo statuto giuridico delle minoranze religiose e cristiane in particolare: soprattutto il diritto di
proprietà indispensabile alla loro sopravvivenza e alla professione della fede individuale e comunitaria dei loro membri.
Ma le Chiese orientali hanno a più riprese dimostrato, nella lunga e ancora poco
produttiva fase di negoziato con il governo, di non sapere in genere disinnescare le implicazioni politiche e identitarie
insite nella legittima domanda di riconoscimento della loro personalità giuridica.
Comunità chiuse che si trovano sempre
più solo per contarsi e che hanno sempre
più difficoltà anche a mantenere i rapporti con la loro diaspora, disseminata ai
quattro angoli della terra.
Intanto la crisi del pensiero laico, la
difficoltà, già evidenziata, di strutturare
delle proposte politiche davvero democratiche, così come l’indiscutibile crescendo di certe correnti fondamentalistiche, soprattutto islamiche, sono fattori che rendono sempre più complessa e
difficile una vera partecipazione alla costruzione del futuro di paesi che tutelino l’uguaglianza dei diritti e della dignità di tutti i loro cittadini, indipendentemente dalle appartenenze etniche e religiose. Non c’è futuro, infatti, né per i cristiani di Turchia né per quelli del resto
del Medio Oriente, là dove si continuerà
a pensare che la sacrosanta rivendicazione dei propri diritti può essere limitata a
una battaglia confessionale, e non essere piuttosto integrata alla lotta di milioni
di uomini e donne in cerca di speranza.
Come ricorda spesso papa Francesco, il
Vangelo, linfa vitale del cristianesimo, si
declina là dove si creano le condizioni di
una convivenza basata sul rispetto e non
sul sospetto, la paura e la mutua esclusione!
Claudio Monge
18
Il Regno -
16-18_art_monge.indd 18
attualità
Indonesia
Libertà religiosa
I
Credo
e cittadinanza
l 5 gennaio oltre 130.000 persone hanno
sfilato per le strade della capitale
dell’Indonesia Giacarta per ribadire il
desiderio di tolleranza religiosa e rispetto
dei diritti umani. Il corteo ha celebrato la
prima Giornata per l’armonia religiosa, organizzata dal Ministero federale degli affari religiosi. Negli ultimi mesi, nel paese con
la più numerosa popolazione musulmana
del mondo (l’80% di fedeli musulmani su
oltre 240 milioni di abitanti, e circa l’11% di
cristiani) il dibattito sulla convivenza religiosa si è riacceso a seguito di una crescita
della violenza su base religiosa e di una
proposta politica mirante a eliminare la
menzione dell’appartenenza religiosa dalla carta d’identità.
L’intolleranza e la violenza su base religiosa sono sempre più diffuse: nel 2013 si
sono verificati 222 episodi di violenza, che
hanno avuto luogo in 20 province, 7 in più
rispetto alle 13 province interessate nel
2012. Lo afferma il Setara Institute, centro
studi con sede a Giacarta, che nel suo rapporto La diversità è possibile nota come,
pur essendo diminuiti del 16% nel complesso, i casi di violenza per motivi religiosi siano più diffusi sul territorio.
Le discriminazioni e le persecuzioni ai
danni delle minoranze religiose sono anche legate, secondo molti osservatori, a un
provvedimento legislativo varato nel 2004,
in base al quale sono limitate a sei le appartenenze religiose riconosciute dallo stato:
islam, protestantesimo, cattolicesimo, induismo, buddismo e confucianesimo, e
vanno indicate sulla carta d’identità. Nonostante molte voci si fossero levate perché
questa menzione venisse tolta, in quanto
fonte di discriminazioni per le minoranze
religiose non rientranti tra le sei opzioni
maggiori e anche per chi sceglie nel documento d’identità l’opzione «altro» – perdendo il diritto ad alcuni importanti servizi
come l’assistenza sanitaria e l’educazione
–, il 26 novembre la Camera dei rappresentanti ha confermato la misura.
A sostenere con forza la necessità di
rimuovere dalla carta d’identità l’indicazione del credo religioso è Basuki Tjahaja
Purnama, vice governatore del distretto
della capitale Giacarta e primo cristiano a
ricoprire questo ruolo. L’obbligo di scelta
fra le sei religioni riconosciute ha indotto
moltissimi cittadini indonesiani a definirsi
ufficialmente «musulmani», mentre, di fatto, seguono e praticano culti tradizionali,
indigeni o ancestrali. Eliminare l’obbligatorietà contribuirebbe dunque a ridefinire il
volto religioso della nazione indonesiana
oggi, ed è anche per questo motivo che
la proposta è stata vivamente avversata
soprattutto dai movimenti islamisti.
Tjahaja Purnama, nativo di Sud Sumatra, è già stato contestato negli scorsi mesi
da frange islamiste che rifiutavano di essere sottoposte a un funzionario di religione
cristiana. Il governatore di Giacarta Joko
Widodo ha chiuso ogni polemica affermando di aver «scelto in base ai meriti» e
avocando a sé deleghe e competenze per
gli affari religiosi islamici. «Se la tolleranza è
la chiave della libertà religiosa – ha spiegato Tjahaja Purnama – per la crescita futura
dell’Indonesia occorre avere il coraggio di
modificare una norma ormai desueta». Rimuovendola, infatti, si vuole garantire l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni
che spesso subiscono i cittadini non musulmani, anche nelle scuole e nei posti di
lavoro pubblici.
Il 4 dicembre così ha scritto sul Jakarta Post il caporedattore Endy Bayuni:
«Aspettatevi che le discriminazioni e le
persecuzioni attuate verso le minoranze
religiose in Indonesia aumentino. (…) La
discussione parlamentare sulla revisione
di questa legge del 2004 sull’amministrazione civile era una buona occasione per
correggere ciò che costituisce una delle
più gigantesche anomalie nella vita della
nazione dalla sua fondazione, cioè l’assenza di libertà di religione, pure scritta nero
su bianco nell’art. 28 della Costituzione
del 1945».
D. S.
2/2014
22/01/14 19.13