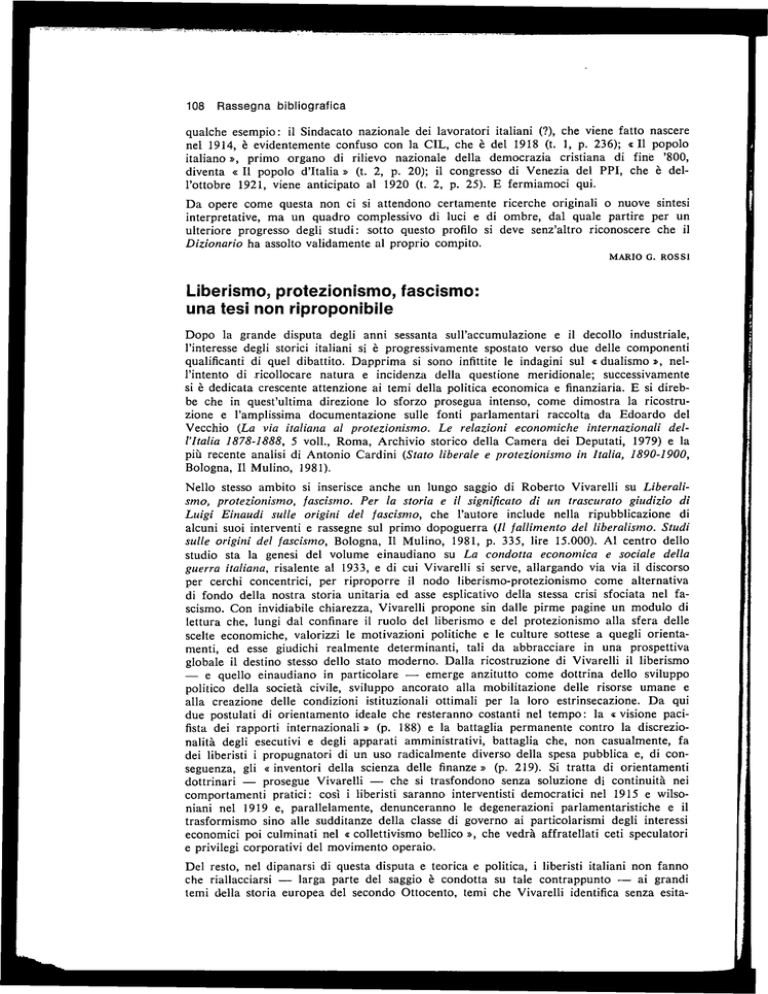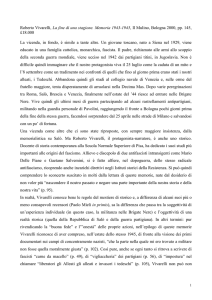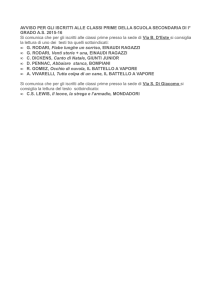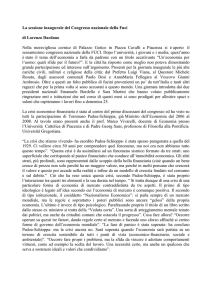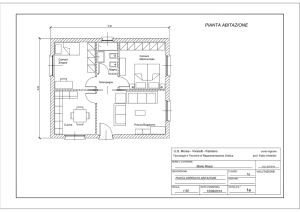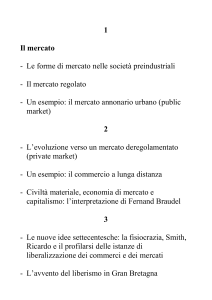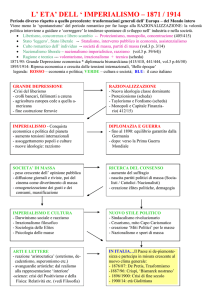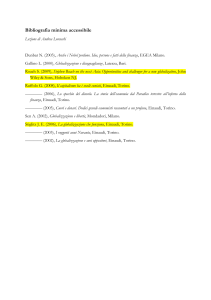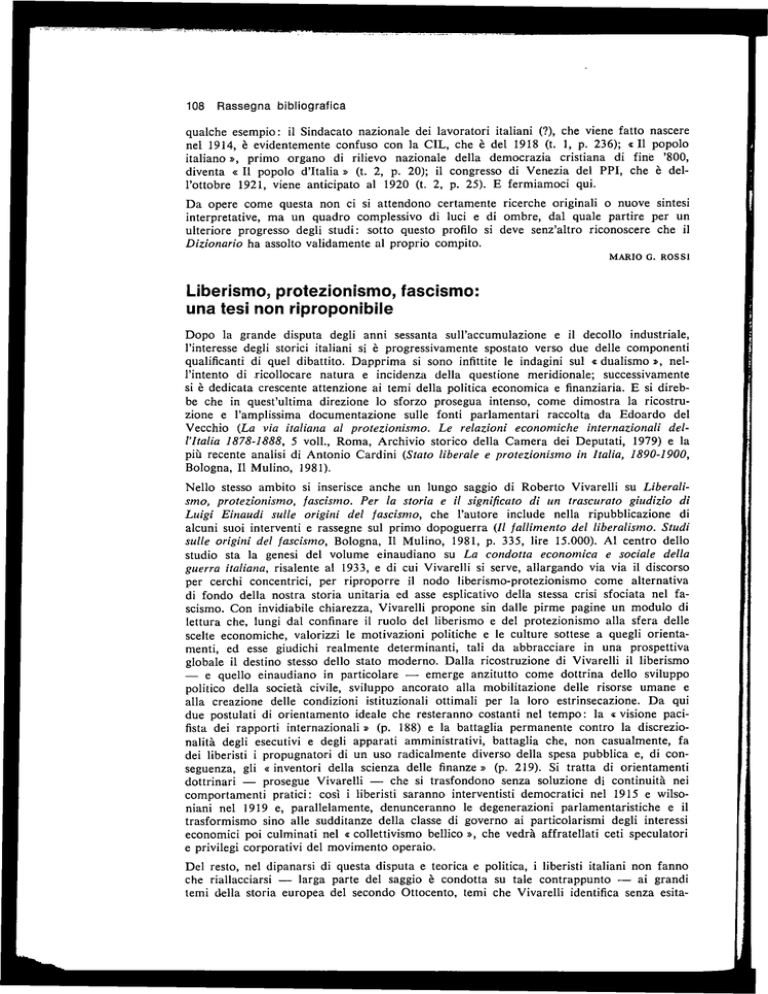
108 Rassegna bibliografica
qualche esempio: il Sindacato nazionale dei lavoratori italiani (?), che viene fatto nascere
nel 1914, è evidentemente confuso con la CIL, che è del 1918 (t. 1, p. 236); «Il popolo
italiano », primo organo di rilievo nazionale della democrazia cristiana di fine ’800,
diventa « Il popolo d’Italia » (t. 2, p. 20); il congresso di Venezia del PPI, che è del­
l’ottobre 1921, viene anticipato al 1920 (t. 2, p. 25). E fermiamoci qui.
Da opere come questa non ci si attendono certamente ricerche originali o nuove sintesi
interpretative, ma un quadro complessivo di luci e di ombre, dal quale partire per un
ulteriore progresso degli studi: sotto questo profilo si deve senz’altro riconoscere che il
Dizionario ha assolto validamente al proprio compito.
M A R IO
G .
R O S S I
Liberismo, protezionismo, fascismo:
una tesi non riproponibile
Dopo la grande disputa degli anni sessanta sull’accumulazione e il decollo industriale,
l’interesse degli storici italiani si è progressivamente spostato verso due delle componenti
qualificanti di quel dibattito. Dapprima si sono infittite le indagini sul « dualismo », nel­
l’intento di ricollocare natura e incidenza della questione meridionale; successivamente
si è dedicata crescente attenzione ai temi della politica economica e finanziaria. E si direb­
be che in quest’ultima direzione lo sforzo prosegua intenso, come dimostra la ricostru­
zione e l’amplissima documentazione sulle fonti parlamentari raccolta da Edoardo del
Vecchio (La via italiana al protezionismo. Le relazioni economiche internazionali del­
l’Italia 1878-1888, 5 voli., Roma, Archivio storico della Camera dei Deputati, 1979) e la
più recente analisi di Antonio Cardini (Stato liberale e protezionismo in Italia, 1890-1900,
Bologna, Il Mulino, 1981).
Nello stesso ambito si inserisce anche un lungo saggio di Roberto Vivarelli su Liberali­
smo, protezionismo, fascismo. Per la storia e il significato di un trascurato giudizio di
Luigi Einaudi sulle origini del fascismo, che l’autore include nella ripubblicazione di
alcuni suoi interventi e rassegne sul primo dopoguerra (Il fallimento del liberalismo. Studi
sulle origini del fascismo, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 335, lire 15.000). Al centro dello
studio sta la genesi del volume einaudiano su La condotta economica e sociale della
guerra italiana, risalente al 1933, e di cui Vivarelli si serve, allargando via via il discorso
per cerchi concentrici, per riproporre il nodo liberismo-protezionismo come alternativa
di fondo della nostra storia unitaria ed asse esplicativo della stessa crisi sfociata nel fa­
scismo. Con invidiabile chiarezza, Vivarelli propone sin dalle pirme pagine un modulo di
lettura che, lungi dal confinare il ruolo del liberismo e del protezionismo alla sfera delle
scelte economiche, valorizzi le motivazioni politiche e le culture sottese a quegli orienta­
menti, ed esse giudichi realmente determinanti, tali da abbracciare in una prospettiva
globale il destino stesso dello stato moderno. Dalla ricostruzione di Vivarelli il liberismo
— e quello einaudiano in particolare — emerge anzitutto come dottrina dello sviluppo
politico della società civile, sviluppo ancorato alla mobilitazione delle risorse umane e
alla creazione delle condizioni istituzionali ottimali per la loro estrinsecazione. Da qui
due postulati di orientamento ideale che resteranno costanti nel tempo : la « visione paci­
fista dei rapporti internazionali» (p. 188) e la battaglia permanente contro la discrezio­
nalità degli esecutivi e degli apparati amministrativi, battaglia che, non casualmente, fa
dei liberisti i propugnatori di un uso radicalmente diverso della spesa pubblica e, di con­
seguenza, gli «inventori della scienza delle finanze» (p. 219). Si tratta di orientamenti
dottrinari — prosegue Vivarelli — che si trasfondono senza soluzione di continuità nei
comportamenti pratici: così i liberisti saranno interventisti democratici nel 1915 e wilsoniani nel 1919 e, parallelamente, denunceranno le degenerazioni parlamentaristiche e il
trasformismo sino alle sudditanze della classe di governo ai particolarismi degli interessi
economici poi culminati nel « collettivismo bellico », che vedrà affratellati ceti speculatori
e privilegi corporativi del movimento operaio.
Del resto, nel dipanarsi di questa disputa e teorica e politica, i liberisti italiani non fanno
che riallacciarsi — larga parte del saggio è condotta su tale contrappunto — ai grandi
temi della storia europea del secondo Ottocento, temi che Vivarelli identifica senza esita­
Rassegna bibliografica
109
zioni nel modello tedesco (« bismarckiano ») e nel modello inglese (« smithiano »). « An­
che se la svolta protezionista — si legge — trovò la sua occasionale origine nella crisi
economica apertasi nel 1873, non era affatto scritto fatalmente nelle cose che ad essa
non si potesse dare risposta diversa da quella che fu allora decisa. Fu ancora una volta
la politica di Bismarck, introducendo il protezionismo in Germania, ad imporre in Eu­
ropa la sua scelta ». Il protezionismo, dunque, come momento rivelatore delle vocazioni
autoritarie, come strumento insostituibile degli stati e dei regimi che si adoperano per la
permanenza delle « strutture sociali tradizionali » (p. 202) : ancora una volta la Germania
e l’Inghilterra come incarnazione di destini irrimediabilmente contrapposti. Sulla stessa
falsa riga, sembra a Vivarelli evidente che la conversione italiana al protezionismo rispon­
da non già ad esigenze di sviluppo economico — «la tariffa doganale del 1887 sembra
aver prodotto risultati di assai dubbia convenienza » (p. 2) — bensì di conservazione
sociale. E l’esemplificazione più persuasiva verrebbe da Alessandro Rossi. Attraverso il
protezionismo l’Italia « sbarrava la strada allo sviluppo della società civile, ribadendo una
concezione paternalistica dello stato e garantendo, insieme alla conservazione del tradi­
zionale assetto sociale e dei tradizionali privilegi, la sopravvivenza delle più mortificanti
condizioni di arretratezza civile » (p. 235). Sulla scelta protezionista s’innesta perciò la
vera dicotomia della nostra storia unitaria, si rende « insanabile la frattura tra paese
legale e paese reale » (p. 236). La crisi del primo dopoguerra rappresenterà il punto più
basso della parabola allora aperta. Le illusioni accese dal primo fascismo sulle capacità
rigeneratrici del movimento mussoliniano soprattutto sul terreno della destrutturazione
dello « Stato economico » non potevano non suggestionare Einaudi e gli altri liberisti.
La ragione economica induce Einaudi — ma non esso soltanto: il richiamo alla parallela
evoluzione di Luigi Albertini è in Vivarelli puntuale — a minimizzare la violenza squa­
drista e ad accettare la marcia su Roma. Solo la sconfitta della linea economica e finan­
ziaria di De Stefani sospinge l’economista piemontese all’opposizione.
L’analisi delle posizioni di Einaudi nel 1919-1922, che occupa una parte cospicua del
saggio (pp. 295-344), è condotta da Vivarelli con grande ricchezza di dettagli, quasi con
accanimento, per dar forza all’esortazione secondo cui l’apprezzamento dell’iniziale filo­
fascismo di Einaudi va « riportato e inteso » sul « terreno del giudizio politico », senza
sovrapporvi quella « questione morale » che non può investire i contemporanei, i quali
« potranno arrivare a riconoscere la natura del fascismo solo attraverso la loro vissuta
esperienza, cioè attraverso quel processo durante il quale la nebulosa fascista assunse
validi e definiti contorni » (p. 296). Precisazione ineccepibile e, forse, superflua; essa
rischia tuttavia di oscurare il tema centrale del saggio proprio quando l’asserita funzione
propulsiva del liberismo nel saldare scelte economiche e passaggio dal regime liberale al
sistema democratico offre il banco di prova più significativo. È proprio seguendo l’argo­
mentazione preliminare di Vivarelli sulla consapevolezza e finalità anzitutto politiche del
liberismo che l’appoggio assicurato da Einaudi al fascismo sino alla fine del 1923 risulta
inspiegabile. Ed infatti la contraddizione è troppo palese perché lo stesso Vivarelli non
la colga pienamente, ad esempio quando osserva : « ciò che in Einaudi al momento della
marcia su Roma appare tipico è il contrasto tra il già avvenuto riconoscimento nel movi­
mento fascista di tratti inconciliabili con le proprie idealità politiche, e il consenso con
cui pur si accoglie la salita al potere di Mussolini e se ne accompagna l’inizio dell’espe­
rimento di governo » (p. 309). Dove il « si accoglie » e il « si accompagna », o è riferito
ai soli aspetti economici e rivela quindi uno stato di divorzio tra politica ed economia
che smentirebbe integralmente la caratteristica essenziale attribuita al liberismo, oppure è
frutto di una insufficiente percezione, da parte di Einaudi, della realtà di quegli anni che
va spiegata, non semplicemente descritta. In effetti, la risposta non può venire restando
all’interno del periodo considerato, ma allargando il discorso alla impostazione comples­
siva del saggio per chiedersi se non sia appunto l’interpretazione proposta ad ostacolare
l’intelligenza dei singoli momenti e comportamenti.
Un primo aspetto da sottolineare è la convinzione che « per comprendere il liberismo
italiano e valutarne il significato esso andrà visto non sul piano dei fatti compiuti, in
cui non riuscì a tradursi, bensì su quello delle idee e della critica », facendo riferimento
al quadro generale e alla « capacità di previsione » di tali orientamenti critici. Se ne
dovrebbe allora dedurre — al di là della rigida dicotomia tra elaborazioni e realizza­
110
Rassegna bibliografica
zioni — che la politica economica italiana nasce, letteralmente, nel 1887, e che la linea
seguita dalla Destra storica — ovvero di quel governo che Einaudi considera il punto
più alto dell’età liberale — non va letta anche come sperimentazione attiva del liberismo
e come maturazione delle ragioni che ne determinarono il successivo abbandono? Né
dovrebbe sembrare improprio — giacché lo stesso Vivarelli chiude il saggio ribadendo la
« insospettata attualità della critica liberista, cioè la sua capacità di applicarsi alla realtà
dell’Italia contemporanea » (p. 344) — coinvolgere nell’esame anche l’esperienza « libe­
rista » del secondo dopoguerra (esperienza che ebbe appunto in Einaudi una delle sue
guide più lucide e più autorevoli) e il rapporto in cui essa si pone con l’evoluzione del
nostro sistema politico e sociale, con la prospettiva, per usare ancora una volta le parole
di Vivarelli, di « fare dell’Italia un paese libero e moderno » (p. 344). In definitiva, l’in­
vito a restringere l’analisi del liberismo al campo della pura dottrina e delle formula­
zioni propositive non comporta forse la ricezione di un modulo interpretativo che i libe­
risti per primi si sforzarono polemicamente di imporre, ma che oggi va assunto soprattutto
come manifestazione della temperie culturale e politica entro la quale quelle dispute si
svilupparono? E, in ogni caso, anche assumendo come esclusivo il livello della progetta­
zione, le indicazioni che emergono dal saggio sfiorano solo alcuni aspetti decisivi. In due
direzioni soprattutto: della cultura industrialista e della esemplarità riassuntiva dei mo­
delli tedesco e inglese. Per Vivarelli la propensione dei liberisti all’industrializzazione è
un postulato fuori discussione. Eppure sono frequenti i passi in cui lo stesso Einaudi
solleva dubbi e riserve, manifestando sino a qual punto non di acquisizioni si tratta, ma
di tormentate incertezze. Così, qando osserva, proprio nella Condotta economica e sociale
della guerra italiana, che il conflitto « disperse ed indebolì quello che restava delle antiche
classi indipendenti », ripropone in tutta evidenza una immagine dei ceti produttori che
rimette in questione non solo i modi del processo di industrializzazione, ma la sua stessa
« legittimità ». Ne discende che la pregiudiziale di scelte economico-produttive compatibili
con programmi di conservazione sociale -— che Vivarelli, l’abbiamo ricordato, denuncia
come ossessione dominante dello schieramento protezionista — è fattore per nulla estraneo
alle dottrine liberiste (ad una radicalizzazione di tale tesi invitano, ad esempio, Adriana
Lay e Maria Luisa Pesante, Produttori senza democrazia. Lotte operaie, ideologie corpo­
rative e sviluppo economico da Giolitti al fascismo, Bologna, Il Mulino, 1981, parte II,
cap. VI).
Non meno rilevante diventa allora valutare nella stessa prospettiva l’inasprirsi dei conno­
tati antisocialisti e privatisti del liberismo, il suo rapido procedere, nel trapasso dall’Otto
al Novecento, dall’iniziale radicalismo verso posizioni sempre più spiccatamente conser­
vateci. Si intende che il problema va visto nella più ampia cornice della presenza/
assenza di una cultura industrialista (su cui si può ora vedere il saggio di V. Castronovo,
Cultura e sviluppo industriale in Storia d’Italia, Annali 4. Intellettuali e potere, Torino,
Einaudi, 1981, pp. 1259, 1296).
Qualcosa di analogo avviene a proposito della esemplarità dei casi tedesco e inglese. Deli­
neare il profilo dell’Europa del secondo Ottocento come ossificato entro le equivalenze
liberismo-democrazia e protezionismo-autoritarismo comporta la liquidazione preventiva
di tutti i più vivi fermenti della letteratura sulla rivoluzione industriale. Tant’è che Viva­
relli è costretto a indicare nella Germania bismarkiana, e proprio nel momento in cui
essa assume dimensioni di potenza industriale tali da intaccare la supremazia inglese, la
patria per eccellenza dei « rapporti gerarchici e [dei] valori di una società tradizionale »
(p. 200). Dove, va da sé, non sono in discussione la gerarchia e il tradizionalismo, bensì
il meccanico determinismo della loro ascendenza protezionistica. Dovremmo allora misu­
rare sullo stesso metro il protezionismo della Francia contadina della Terza Repubblica
o il protezionismo dei « nordisti » americani prima e dopo la guerra di Secessione?
Il saggio di Vivarelli ha il merito indiscutibile di alimentare il dibattito su un tema di
enorme rilievo, e del quale in questa nota si sono potuti richiamare solo alcuni aspetti.
Ma le proposte interpretative avanzate appaiono troppo adesive alla fonte da cui l’analisi
prende spunto e c’è davvero da dubitare dell’utilità di riproporre, puramente e sempli­
cemente, l’ottica di uno degli agenti del dibattito che si ricostruisce senza restare vinco­
lati a opzioni ideologiche che prevaricano ogni possibilità di comprensione storica.
MASSIMO LEGNANI