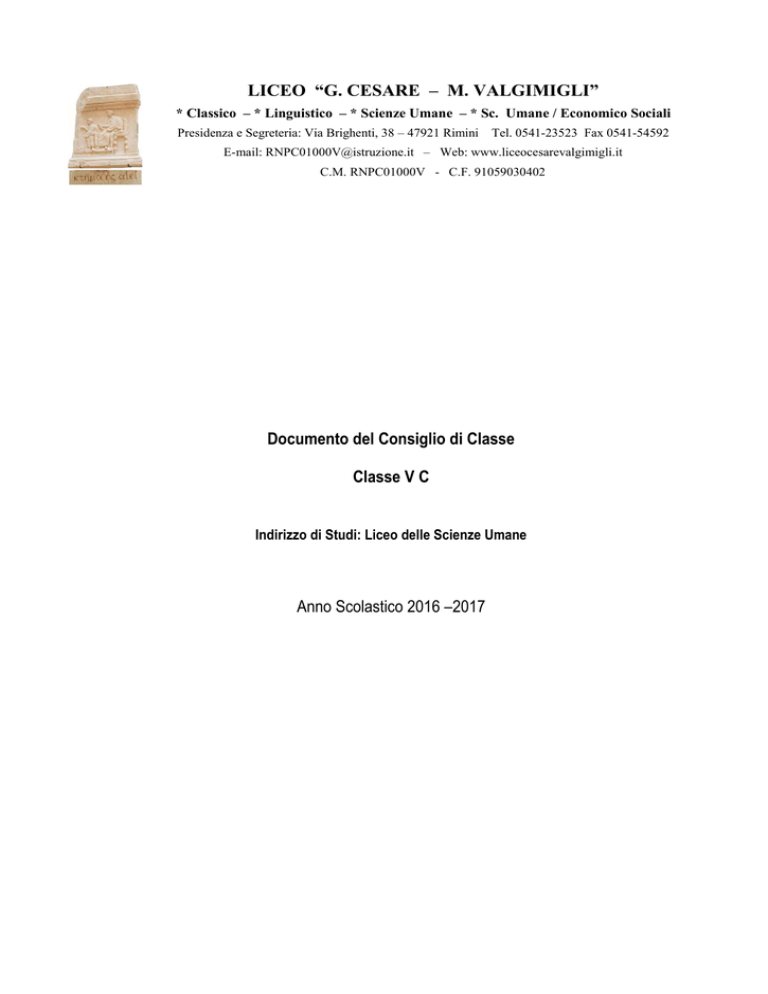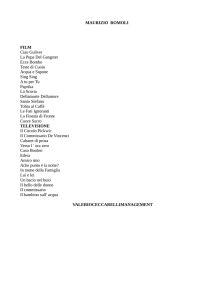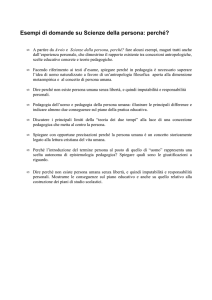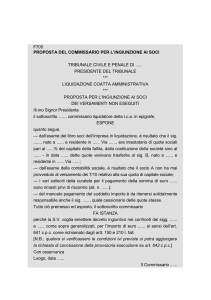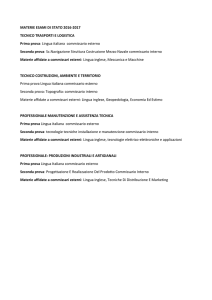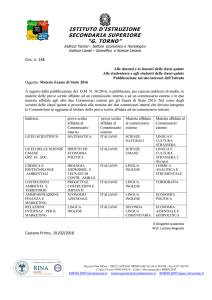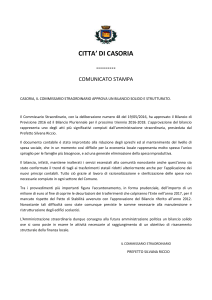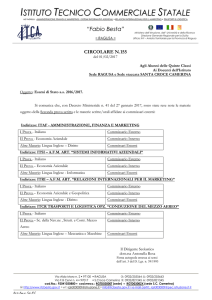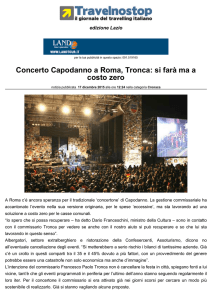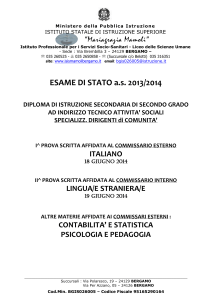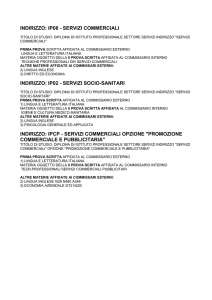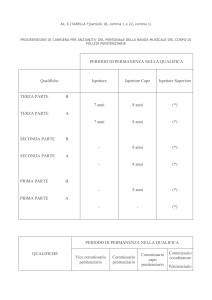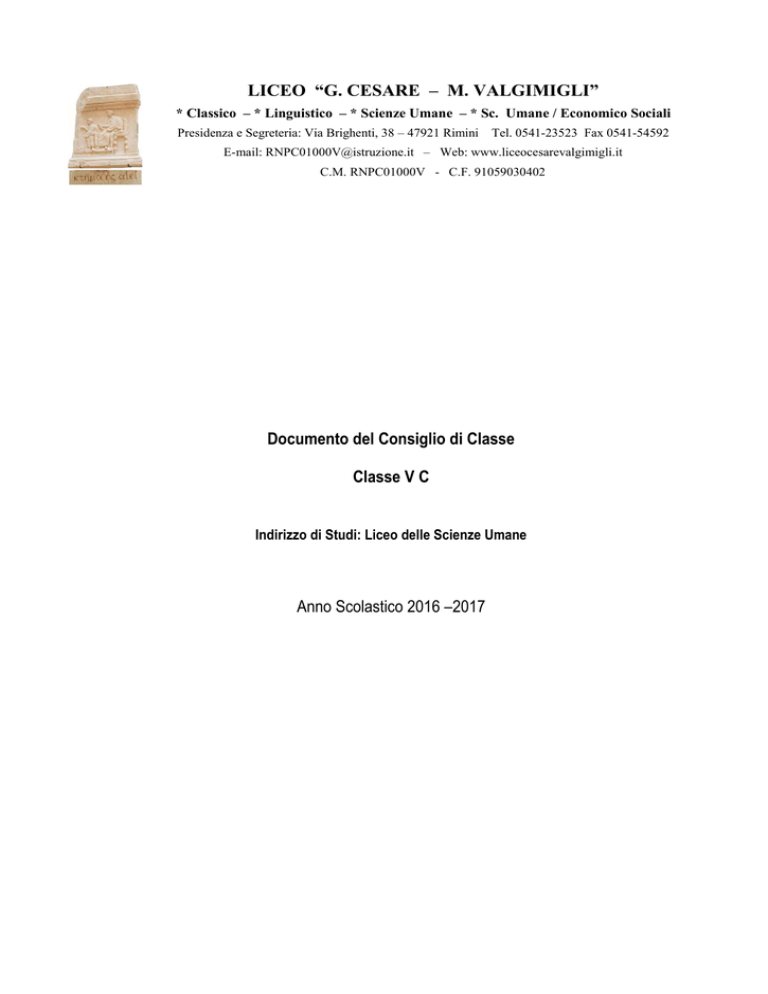
LICEO “G. CESARE – M. VALGIMIGLI”
* Classico – * Linguistico – * Scienze Umane – * Sc. Umane / Economico Sociali
Presidenza e Segreteria: Via Brighenti, 38 – 47921 Rimini
Tel. 0541-23523 Fax 0541-54592
E-mail: [email protected] – Web: www.liceocesarevalgimigli.it
C.M. RNPC01000V - C.F. 91059030402
Documento del Consiglio di Classe
Classe V C
Indirizzo di Studi: Liceo delle Scienze Umane
Anno Scolastico 2016 –2017
Indice
Finalità generali del corso di studi e quadro orario
Membri del Consiglio di classe
Profilo della classe
Storia della classe
Uscite didattiche, viaggi d’istruzione ed altre attività didattiche
Simulazioni di terza prova
Obiettivi didattici trasversali perseguiti e raggiunti
Strumenti e criteri di valutazione
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 7-8
Pag. 7
Pag. 9
Pag.10
Pag. 30
Allegati:
1. Copia delle simulazioni di terza prova assegnate durante l’anno scolastico, pag. 12
2. Copia delle griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni, pag. 29
3. Programmi svolti, pag. 46
2
Finalità dell’indirizzo di studio e quadro orario
In continuità con gli studi specifici del liceo socio-psico-pedagogico, il nostro Liceo favorisce un percorso di studi che
approfondisca le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle scienze umane.
Fornisce allo studente importanti strumenti per orientarsi nella dimensione interiore della mente e del suo sviluppo.
Approfondisce e sviluppa le conoscenze e le competenze necessarie per cogliere la specificità dei processi formativi,
nonché per comprendere la complessità dei comportamenti umani e sociali.
Permette di riconoscere e interpretare i differenti modelli teorici di educazione permettendo di applicarli nei diversi
campi relazionali e comunicativi della società.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane, volte alla
conoscenza dei problemi della persona e della società.
Garantisce una solida base culturale ed una formazione completa in ogni ambito, tali da consentire il proseguimento
degli studi in qualsiasi facoltà.
QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Materie
1°anno
2°anno
3°anno
4°anno
5°anno
Religione/attività alternative
1
1
1
1
1
Italiano
4
4
4
4
4
Latino
3
3
2
2
2
Lingua e cultura straniera
3
3
3
3
3
Diritto ed economia
2
2
-
-
-
Scienze umane *
4
4
5
5
5
Storia
-
-
2
2
2
Storia e geografia
3
3
-
-
-
Filosofia
-
-
3
3
3
Matematica **
3
3
2
2
2
Fisica
-
-
2
2
2
Scienze naturali ***
2
2
2
2
2
Storia dell’arte
-
-
2
2
2
Scienze motorie
2
2
2
2
2
Totale unità didattiche
27
27
30
30
30
*Antropologia., Psicologia,Pedagogia e Sociologia
**Con informatica nel primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
3
Membri del Consiglio di Classe
La composizione del Consiglio di classe della V C per l’anno scolastico 2016-2017 è riportata nella tabella
sottostante.
Disciplina
Italiano
Latino
Storia
Filosofia
Scienze umane
Scienze naturali
Inglese
Matematica
Fisica
Storia dell’Arte
Scienze motorie
Religione
Orario annuo
132
66
66
99
165
66
99
66
66
66
66
33
Docente
Pizzi Marinella
Pizzi Marinella
Guagliano Fiona
Colangelo M. Antonella
Colangelo M.Antonella
Vasconi Cristina
Pioppo Mariachiara
Perotti Maria Rita
Lucchi Chiara
Barone Sonia
Bernardi Fabio
Colonna Massimo
Nel corso del triennio si sono registrati alcuni avvicendamenti, in quarta la prof.ssa Guagliano succede al prof. Carlini
(storia) e la prof.ssa Barone succede alla prof.ssa Tanfani (storia dell’arte), mentre i docenti che hanno mantenuto la
continuità didattica anche nel triennio sono: italiano e latino (prof.ssa Pizzi), inglese (prof.ssa Pioppo), Scienze
umane (prof.ssa Colangelo) e matematica (prof.ssa Perotti).
I
4
Profilo della classe
5
La classe è composta dai seguenti alunni:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Cognome
Andruccioli
Bernardini
Borghi
Bonzetti
Capeti
Cesarini
Darderi
Fiorini
Gentilini
Giovagnoli
Giuliani
Guiducci
Miserocchi
Morigi
Morolli
Mussoni
Nestorovic
Padiglioni
Pesaresi
Prete
Pulvirenti
Ronchi
Sarti
Volpini
Nome
Valentina
Giulia
Cesare
Lucia
Chiara
Elisa
Martina
Serena
Elisa
Giorgia
Martina
Elena
Claudia
Riccardo
Isotta
Martina
Julia
Simona
Federica
Maria Chiara
Alessandro
Martino
Anna
Giulia
6
Storia della classe
La tabella riporta i dati numerici relativi agli iscritti e all’esito finale dei cinque anni di studi.
Anno scolastico
1° anno
2012/2013
2° anno
2013/2014
3° anno
2014/2015
4° anno
2015/2016
5° anno
2016./2017
Iscritti
32
Ritirati o trasferiti
8
Respinti
4
Promossi *
15
26
4
1
16
25
1
17
24
0
18
24
* indicare eventuali sospensioni del giudizio
Sospensione del giudizio:
I anno n. 9 alunni
II anno n. 12 alunni
III anno n. 7 alunni
IV anno n. 6 alunni
Uscite didattiche, viaggi d’istruzione ed altre attività didattiche
Viaggi di istruzione
Primo anno:
Secondo anno:
Terzo anno:
Quarto anno:
Quinto anno:
Modena (Terramare)- Ravenna (Planetario).
Caserta-Pompei-Paestum.
Ville Venete.
Milano (Expo)- Monaco di Baviera - Innsbruck.
Barcellona.
Nel corso del quinquennio la classe è stata coinvolta nelle seguenti iniziative:
Primo anno:
Secondo anno:
- Concorso letterario “Una pagina del mio diario” , prof.ssa Pizzi,
- Progetto accoglienza Biblioteca, prof.ssa Pizzi e prof.ssa Colangelo,
- Progetto “Il mare tra i banchi” prof.ssa Vasconi.
-
Progetto “Lettura” prof.ssa Pizzi,
Progetto “Quotidiano in classe” prof.ssa Pizzi,
Progetto “Conoscere il territorio: Rimini, la campagna” prof.ssa Vasconi,
Uscita didattica a Firenze, “Museo della matematica”, prof.ssa Perotti,
Progetto “Pace”, prof.ssa Colangelo.
7
Terzo anno:
-
Quarto anno:
Quinto anno:
- “ Marcia della Pace” (Assisi- 19 ottobre 2014) prof.ssa Colangelo e prof.ssa Perotti,
- “Cultura e tradizione, dal mito al logos”: incontro con la cucina greca , prof.ssa Colangelo,
- Progetto “La biblioteca va a scuola” prof. Carlini (con uscita didattica Biblioteca di Cesena).
- Teatro : “Plauto” Prof.ssa Pizzi,
- Teatro “Pitagora” prof.ssa Perotti e prof.ssa Colangelo,
- Laboratorio interculturale:”Zingaro chi sei?” prof.ssa Colangelo,
- Progetto “Stili di vita tra uso ed abuso”, prof.sse Colangelo ,Vasconi
- Uscita didattica presso la comunità di recupero “San Patrignano” prof.sse Colangelo ,Vasconi.
- Progetto pronto intervento CRI, prof. Bernardi,
- Uscita didattica a Firenze, “Mostra di Picasso prof.sse Tanfani e Perotti.
- Uscita didattica a Chiaravalle, visita fondazione Maria Montessori, prof.ssa Colangelo,
- Incontro con l’autore sul tema dell’autismo, Gina Codovilli, prof.ssa Colangelo,
- Uscita didattica presso il convento delle Clarisse, Rimini, prof. Vari,
- Progetto pronto intervento CRI, prof. Bernardi,
- Progetto “Finger Printing”, prof.ssa Vasconi,
- Teatro : Verga, “Rosso malpelo”, prof.ssa Pizzi,
- Uscita didattica ad Urbino, prof.ssa Barone,
- Progetto “Crescere informati”, prof.ssa Colangelo,
- Potenziamento della Lingua Inglese, prof.ssa Pioppo,
- Progetto “Ecosostenibilità”, prof.ssa Vasconi,
- Uscita didattica “Mostra fotografica: Rimini nella Prima Guerra Mondiale” prof.ssa Guagliano,
- Incontro sul tema “Giovani costruttori di pace: il coraggio della responsabilità” F. Cavalli,
prof.ssa Colangelo.
-
Progetto “Avis” prof.ssa Vasconi,
Progetto “Ecosostenibilità”, prof.ssa Vasconi,
Progetto “Non solo palestra”, prof. Bernardi,
Uscita didattica a Modena, “Festival della Filosofia”, prof.ssa Colangelo, prof:ssa Perotti,
Uscita didattica a Milano, Museo del Novecento, prof.ssa Barone,
Uscita didattica a Milano, mostra del pittore Escher, prof.ssa Perotti e prof.ssa Colangelo,
Uscita presso il “Centro per le famiglie”, prof.ssa Colangelo,
Laboratorio “La pedagogia tra i banchi di scuola” presso la scuola primaria “A.Brandi”
Riccione, prof.ssa Colangelo,
Staffetta di orientamento:”Lezione sui disturbi dell’apprendimento” presso Università di
Rimini,
Lezione di diritto “I cambiamenti nella Costituzione e il referendum” prof. Marini,
Lezione di psicologia “Disturbi mentali: la schizofrenia” prof.ssa Marcucci,
Lezione: “La diversabilità e i percorsi “su misura” “ prof.ssa E. Urbinati,(docente coordinatore
del sostegno).
CLIL, modulo di Filosofia si J. Dewey, prof.ssa Maurizia Manzi.
8
Simulazioni Terza prova
Il Consiglio di classe, nella seduta del 16 novembre 2016 e del 20 marzo 2017 ha deliberato di utilizzare nelle
simulazioni di terza prova scritta, la tipologia composta da tre domande a risposta aperta, indicata come tipologia B.
Sono state eseguite 2 simulazioni:
- La prima, in data 1 dicembre 2016 , relativa alle seguenti discipline : Storia dell’Arte, Filosofia, Fisica e
Inglese.
- La seconda, in data 3 maggio 2017, relativa alle seguenti discipline : Matematica, Inglese, Fisica e Storia
dell’Arte.
In allegato vengono riportati i testi delle simulazioni assegnate agli alunni e i criteri di valutazione utilizzati.
Per lo svolgimento delle prove è stato assegnato un tempo di tre (3) ore.
Sono state inoltre svolte una simulazione relativa alla prima prova scritta d’esame in data 22 aprile 2017 ed una
relativa alla seconda prova in data 27 aprile 2017. Anche per le rispettive griglie di valutazione si rimanda agli
allegati.
9
Obiettivi cognitivi e educativi trasversali
Strumenti e criteri di valutazione
Obiettivi comportamentali
Consolidare – acquisire corrette capacità relazionali
nei rapporti con i docenti, con i compagni, con i soggetti
esterni eventualmente coinvolti nelle attività didattiche
curriculari ed extracurriculari;
Rafforzare la consapevolezza delle proprie
responsabilità ed impegni;
Consolidare - ampliare gli interessi culturali;
Consolidare la motivazione sottesa alla scelta del
corso di studi anche in vista di future scelte di studio o
di lavoro;
Arrivare ad una prima consapevolezza della
complessità del reale;
Educare alla tolleranza e all’accettazione della
diversità.
Strumenti/metodi
Attività disciplinari e multidisciplinari
Lavori di gruppo
Dibattiti
Visite guidate e viaggio di istruzione;
Promozione della lettura;
Promozione della partecipazione ad attività culturali
Obiettivi/competenze
Modalità di verfica
Modalità di verifica
Partecipazione e interesse rispetto alle attività svolte
in
classe;
Discussione e dibattiti;
Partecipazione alle assemblee di classe;
Assiduità e motivazione nella
partecipazione alle attività svolte
Indicatori di livello
Valutazione
Conoscenza: capacità di rievocare
Colloqui
Elementi specifici
Relazioni
Scarsa
2-4
Modi e mezzi per usarli
Analisi testuali
Limitata
4-5
Dati universali
Prove strutturate e/o semistrutturate
Sufficiente
6
Produzioni di varia tipologia
Ampia
7-8
Esauriente
9-10
utilizzando codici diversi
Comprensione:
capacità
di afferrare
il
senso
di una
Colloqui
comunicazione
Relazioni
Approssimativa
2-4
Trasformare
Analisi testuali
Superficiale
4-5
Interpretare
Prove strutturate e/o semistrutturate.
Corretta
6
Estrapolare
Costruzioni di mappe concettuali.
Consapevole
7-8
Risoluzione di problemi
Completa
9-10
Applicazione:
Relazioni orali e scritte
capacità di utilizzare dati o procedimenti conosciuti riuscendo a
Analisi testuali
Errata
2-4
Collegare
Risoluzione di problemi
Incerta
4-5
Organizzare
Costruzioni di mappe
Accettabile
6
Generalizzare
Costruzioni di tabelle
Sicura
7-8
Autonoma
9-10
Produzioni
di
varia
tipologia
utilizzando codici diversi
Analisi:capacità di separare gli elementi costitutivi di una
Analisi testuali
confusa
2-4
comunicazione per evidenziare
Risoluzione di problemi
superficiale
4-5
elementi
Costruzioni di mappe
essenziale
6
relazioni
Costruzioni di tabelle
. articolata
7-8
principi organizzativi
profonda
9-10
Sintesi: capacità di riunire elementi al fine di formare, in modo
Relazioni orali e scritte
confusa
2-4
coerente, comunicazioni uniche, piani di azione, insiemi di
Relazioni orali e scritte
frammentaria
4-5
relazioni astratte
Risoluzione di problemi
coerente
6
efficace
7-8
personale
9-10
Espressione: capacità di esprimere/comunicare il proprio pensiero
Colloqui
in modo
Relazioni orali e scritte
Aderente
Produzioni
Coerente
Fluido
di
varia
utilizzando codici diversi
tipologia
Scorretta/confusa
2-4
Incerta
4-5
Corretta
6
Chiara
7-8
Disinvolta
9-10
10
Programmi effettivamente svolti
Le pagine che seguono in allegato riportano le simulazioni di terza prova, le griglie di correzione e, per ciascuna
disciplina, gli argomenti effettivamente svolti.
Rimini 15 Maggio 2017
Il segretario verbalizzante e coordinatore della classe
Prof. ssa Perotti Maria Rita
11
ALLEGATO 1: le simulazioni di terza prova
12
FISICA,
PRIMA SIMULAZIONE ,
1 DICEMBRE 2016
ALUNNO_______________________________________________
1) DESCRIVI LO SPETTRO DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE, SOFFERMANDOTI POI SULLA
DESCRIZIONE DI UNA TIPOLOGIA DI ONDE ELETTROMAGNETICHE DI CUI PREFERISCI SCRIVERE,
SPECIFICANDONE GLI UTILIZZI, I PERICOLI ECC…
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2) SE STROFINO UNA BACCHETTA DI VETRO SU UN PANNO DI LANA E POI TOCCO CON LA
BACCHETTA UN ELETTROSCOPIO, COSA SUCCEDE ALLE FOGLIOLINE D’ORO
DELL’ELETTROSCOPIO? SE POI ALLONTANO LA BACCHETTA, COSA SUCCEDE ALLE FOGLIOLINE?
SPIEGA QUALI FENOMENI FISICI SONO COINVOLTI IN QUESTO ESPERIMENTO E COSA SUCCEDE A
LIVELLO MICROSCOPICO PER GIUSTIFICARE LA COSA.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3) DESCRIVI LA FORZA ELETTRICA CON CUI SI ATTIRANO O RESPINGONO DUE CARICHE
ELETTRICHE. SCRIVINE LA FORMULAZIONE DATA DA COULOMB SPECIFICANDO NOME E UNITAQ’
DI MISURA DI OGNI GRANDEZZA CHE COMPARE NELLA FORMULA. SPIEGA POI QUALE SEGNO
PUO’ ASSUMERE TALE FORZA E COSA SIGNIFICA.
13
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
14
STORIA DELL’ARTE,
PRIMA SIMULAZIONE,
1 DICEMBRE 2016
Cognome e Nome____________________________________ Classe VC S.U.
1. Ne La morte di Marat sono presenti molte delle caratteristiche della cultura neoclassica. Elencale, indica chi ha
dipinto questa tela e individua una collocazione cronologica (max 10 righe).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Francisco Goya presenta nelle sue opere elementi del pensiero illuminista e sensibilità romantiche, sia nei temi
trattati che nello stile utilizzato. Quali opere che conosci possono confermare quest’affermazione e perché? (max 10
righe).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15
3. La Libertà guida il popolo di E.Delacroix: contestualizza l'opera nel movimento artistico di riferimento, individua
l'evento storico narrato ed elenca le caratteristiche essenziali del movimento di appartenenza (max 10 righe).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
16
INGLESE,
PRIMA SIMULAZIONE,
1 DICEMBRE 2016
Nome e cognome dell'alunno: ________________________________________________
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS
1. Why is Romantic poetry considered the appearance of modern poetry? (max 8 lines)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. How does Wordsworth's idea of Nature differ from Coleridge's idea of Nature? (max 10 lines)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
17
3. Why was Nature considered a shelter by many Romantic poets? (max 5 lines)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
18
INGLESE,
PRIMA SIMULAZIONE - DARDERI MARTINA,
1 DICEMBRE 2016
Nome e cognome dell'alunno: MARTINA DARDERI
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS
1. Why is Romantic poetry considered the appearance of modern poetry? (max 8 lines)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. How does Wordsworth's idea of Nature differ from Coleridge's idea of Nature? (max 10 lines)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
19
FILOSOFIA,
PRIMA SIMULAZIONE,
1 DICEMBRE 2016
STUDENTE:_________________________________________________________________
CLASSE VC
TIPOLOGIA B- 3 QUESITI A RISPOSTA APERTA , 10 RIGHE
1 – LE FORME A PRIORI PURE DELLA SENSIBILITA’ ESPRESSE DA KANT NELL’ESTETICA
TRASCENDENTALE.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2 – L’ ASSOLUTEZZA DELLA LEGGE MORALE IN KANT.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3 – FINITO E INFINITO NEL PENSIERO OTTOCENTESCO.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
20
FISICA,
SECONDA SIMULAZIONE ,
3 MAGGIO 2017
ALUNNO_______________________________________________
1)
SCRIVI E SPIEGA LA SECONDA LEGGE DI OHM, SPECIFICANDO NOME E UNITA’ DI MISURA DI OGNI
GRANDEZZA CHE COMPARE NELLA SUA FORMULAZIONE, SOFFERMANDOTI POI SULLA RESISTIVITA’,
SPECIFICANDO DA COSA DIPENDE E COME VIENE UTILIZZATA PER CLASSIFICARE I MATERIALI.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2)
DESCRIVI L’ESPERIMENTO DI AMPERE DELLA FORZA FRA CORRENTI ELETTRICHE, DESCRIVENDO
TALE FORZA, DI CHE TIPO DI FORZA SI TRATTA, DA QUALI GRANDEZZE DIPENDE E COME ENTRA IN
GIOCO NELLA DEFINIZIONE DELL’AMPERE COME UNITA’ DI MISURA DELLA CORRENTE ELETTRICA.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
21
3)
DESCRIVI IL CAMPO MAGNETICO FORMATO DA UN SOLENOIDE PERCORSO DA CORRENTE
ELETTRICA. DA QUALI GRANDEZZE FISICHE DIPENDE, COME SI CALCOLA, SOFFERMANDOTI POI SUL SUO
UTILIZZO PER FORMARE UN ELETTROMAGNETE.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
22
STORIA DELL’ARTE,
SECONDA SIMULAZIONE,
3 MAGGIO 2017
Cognome e Nome_______________________________________________________________ Classe VC S.U.
Fra i pittori impressionisti, quello più anomalo è Edgar Degas, che d’altronde si è sempre definito più realista che
impressionista. Il candidato motivi questa affermazione facendo riferimento ad un’opera dell’artista (max 10 righe).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Il candidato spieghi le novità tecniche dell’opera “Autoritratto con cappello di feltro grigio” di V. Van Gogh rispetto a “I
mangiatori di patate” evidenziando i motivi dell’evoluzione del suo stile (max 10 righe).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
23
Dopo aver collegato le principali declinazioni dell’espressione Art Nouveau alle varie nazioni europee in cui si diffuse,
spiega quali furono i caratteri comuni a questa tendenza artistica, precisando anche il contesto storico in cui si
collocò (max 10 righe).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
24
INGLESE,
SECONDA SIMULAZIONE,
3 MAGGIO 2017
Nome e cognome dell'alunno: ________________________________________________
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS
1. How does R.L.Stevenson use the theme of the double to criticize the hypocrisy of Victorian
society? (10 lines)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. The Woman Question, which grew in importance in the XIX century, strikes its first important goal
with universal suffrage in England. Give a definition of "Woman question", say when and how universal
suffrage was obtained in England and mention C. Bronte and her heroine Jane Eyre as an example of a
woman fighting for her rights. (10 lines)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
25
3. Describe Tennyson's Ulysses: point out the strengths and weaknesses of this character (8 lines)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
26
INGLESE,
SECONDA SIMULAZIONE - DARDERI MARTINA,
3 MAGGIO 2017
Nome e cognome dell'alunno: MARTINA DARDERI
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS
1. How does R.L.Stevenson use the theme of the double to criticize the hypocrisy of Victorian society? (10
lines)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. The Woman Question, which grew in importance in the XIX century, strikes its first important goal with universal
suffrage in England. Give a definition of "Woman question", say when and how universal suffrage was obtained in
England and mention C. Bronte and her heroine Jane Eyre as an example of a woman fighting for her rights. (10
lines)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
27
MATEMATICA,
SECONDA SIMULAZIONE,
3 MAGGIO 2017
Cognome e Nome_______________________________________________________________ Classe VC S.U.
Data la funzione :
studiare:
1° Quesito : a. Dominio
b. Simmetrie
c. Intersezioni con gli assi cartesiani
d. Segno
2° Quesito: a. asintoti:
b. crescenza e decrescenza
c. massimi e minimi relativi
3° Quesito:
In base ai risultati ottenuti, rappresentare il grafico della funzione.
28
ALLEGATO 2: griglie di valutazione
29
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO: SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE
Candidato ___________________________________________________________
5-4
Conoscenz
e
3
Espone
informazion
Espone
i essenziali
conoscenz
o
e corrette e
comunque
complete/
utili
allo
utilizza in
svolgiment
modo
o /utilizza
appropriato
parzialment
i dati forniti
e i dati
forniti
Capacità:
corretto
utilizzo
della
tipologia
testuale
4 - corretta,
con
Si esprime
sintassi e
in forma
lessico
adeguati
nel
complesso
corretta e
con lessico
abbastanza
appropriato
Sa
proporre
una
Interpretazi interpretazi
one
ed one
elaborazion adeguatam
e critica
ente
esemplifica
ta/
approfondit
Esprime
giudizi, ma
non
sempre
debitament
e motivati/
chiarament
e
riconoscibili
/
2
1
0
Espone
informazion
i generiche/
imprecise/
utilizza in
modo poco
efficace i
dati forniti
Riconosce
gli elementi
più
significativi
solo
in
modo
frammentar
io
Espone
informazion
i scorrette/
non utilizza
i dati forniti
Comprend
e
le
indicazioni
di
svolgiment
o/ adotta
un
tipo
testuale
chiaro e ne
rispetta le
caratteristic
he
sostanzial
mente
chiara, ma
con
qualche
ripetizione/
errore
d’ortografia
/connettivi/
sintassi/
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
Comprend
e in modo
parziale/
adotta un
tipo
testuale
chiaro, ma
ne rispetta
solo
in
parte
le
caratteristic
he
Non
individua le
indicazioni
di
svolgiment
o/
non
rispetta le
caratteristic ___
he
della
tipologia
testuale
richiesta
scorretta in
più punti /
confusa
con errori
di
ripetizione/
ortografia/c
onnettivi/
sintassi/
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
gravement
e scorretta/
confusa
con errori
di
ripetizione/
ortografia/c
onnettivi/
sintassi/
___
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
Interpreta
in
modo
semplicistic
o
le
tematiche
proposte
Interpreta
in
modo
superficiale
le
tematiche
proposte
Esprime
valutazioni
incongrue/
non
esprime
valutazioni
___
___
30
a/
con
eventuali
contributi
personali
approfondit
i/
esemplifica
ti
Voto
complessiv
o
___
/15
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
31
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO: TEMA STORICO E DI ATTUALITA’
Candidato ___________________________________________________________
4
Conoscenz
e
3
2
Propone
informazion
Propone
i essenziali,
informazion
comunque
i corrette e
utili
allo
significative
svolgiment
o
Comprend
e la traccia
e
il
problema
proposto
Comprensi
one della
traccia
Organizza
il testo in
modo
logico
e
conseguen
ziale
Organizza
il testo in
Organizzazi
modo
one
del
semplice
testo
ma
coerente
sostanzial
mente
chiara, ma
con
nel
qualche
corretta,
complesso ripetizione/
con
Si esprime
corretta e errore
sintassi e
in forma
lessico
d’ortografia
lessico
abbastanza /connettivi/
adeguati
appropriato sintassi/
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
Sa
proporre
una
interpretazi Propone
one
un’interpret
Interpretazi
adeguatam azione non
one
ed
ente
sempre
elaborazion
esemplifica debitament
e critica
ta/
e
/approfondi approfondit
ta
con a
eventuali
contributi
personali
1
0
Propone
Propone
informazion
informazion
i scorrette/
i generiche/
non
___
imprecise
pertinenti
Individua il
problema
proposto in
modo
parziale/
generico
Non
individua il
problema
proposto
___
Espone i
contenuti in
modo non
sempre
organico
Espone i
contenuti in
modo
disorganico ___
/ non coeso
scorretta in
più punti /
confusa/
con errori
di
ripetizione/
ortografia/c
onnettivi/
sintassi/
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
gravement
e scorretta/
confusa/
con errori
di
ripetizione/
ortografia/c
onnettivi/
sintassi/
___
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
Tratta
superficial
mente le
tematiche
proposte
Esprime
valutazioni
incongrue/
non
esprime
valutazioni
___
32
Voto
complessi
vo
___
/15
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
33
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO
Candidato ___________________________________________________________
4
nella
totalità del
significato /
sa
parafrasare
/
sa
riassumere
Comprende
il testo
Riconosce
3
correttame
nte e in
modo
completo la
struttura
formale, la
poetica
dell’autore,
il contesto
storicoletterario
Il
riconoscim
ento
è
parziale,
ma corretto
2
negli
elementi
essenziali
del
significato /
parafrasi o
riassunto
talora
incerti
Il
riconoscim
ento
è
molto
limitato
sostanzial
mente
chiara, ma
con
nel
qualche
corretta,
complesso ripetizione/
con
Si esprime
corretta e errore
sintassi e
in forma
abbastanza d’ortografia
lessico
appropriata /connettivi/
adeguati
nel lessico sintassi/
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
Sa
approfondir
e
ed
Esprime
elaborare
Interpreta
giudizi
Interpretazi in
modo
in
modo
personali,
one
ed personale
semplicistic
ma
non
elaborazion e coerente
o
le
sempre
e critica
i contenuti,
tematiche
debitament
argomenta
proposte
e motivati
ndo
con
coerenza
ed
1
0
fraintende il
in
modo testo/ non
frammentar ne coglie
io
gli aspetti ___
essenziali
Riconosce
in
modo
molto
frammentar
io
gli
elementipiù
significativi
Non
riconosce
gli elementi
più
___
significativi
scorretta in
più punti /
confusa /
con errori
di
ripetizione/
ortografia/c
onnettivi/
sintassi/
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
gravement
e scorretta/
confusa /
con errori
di
ripetizione/
ortografia/c
onnettivi/
sintassi/
___
lessico/pun
teggiatura/
paragrafazi
one
Interpreta
in
modo
superficiale
le
tematiche
proposte
Esprime
valutazioni
incongrue/
non
esprime
valutazioni
___
34
esemplifica
zioni
adeguate
Voto
complessi
vo
___
/15
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
35
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: SCIENZE UMANE
Candidato ___________________________________________________________
CRITERI
INDICATORI
a. Aderenza alla
traccia
Completa
Adeguata
ESSENZIALE
Parziale
Lacunosa/fuori tema
Precise, esaurienti, ampie
Precise e soddisfacenti
Adeguate
ESSENZIALI
Limitate e/o imprecise
Assenti e/o errate
Articolata
Efficace e agile
LINEARE
Sommaria
Frammentaria
Accurata, con buona proprietà lessicale
Chiara e corretta
SUFFICIENTEMENTE chiara e corretta
Confusa e/o con errori morfosintattici e
improprietà
Scorretta
b. Pertinenza della
risposta
Conoscenze specifiche
e/o riferimenti agli
autori.
Grado di organicità/
elaborazione dei
contenuti
Esposizione
punti
Punteggio
tema
Punteggio
quesiti
(X 0,7)
(X 0,3)
4
3,5
3
2
1
5
4,5
4
3
2
1
3
2,5
2
1,5
1
3
2,5
2
1,5
1
TOTALE PUNTI
Punteggio pesato
VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA
PROVA
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
36
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: INGLESE
Candidato_________________________________________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE della Simulazione di Terza Prova
INDICATORI
DOMANDA N° 1
LIVELLO RILEVATO
Scarso
/
Insufficiente
1
Sufficiente
1,5
1
1,5
2
Scarso
/
Insufficiente
1
Sufficiente
1,5
1
1,5
2
Scarso
Insufficiente
1
Sufficiente
1,5
PUNTI
Discret Buono
o
/
2
(max 15)
0-5
Realizzazione linguistica
Correttezza ortografica,
morfosintattica e sintattica.
Adeguatezza e proprietà lessicale.
2,5
3
Controllo dei contenuti
Padronanza e uso adeguato dei
contenuti. Comprensione del
quesito proposto. Coerente
esposizione delle conoscenze in
proprio possesso in rapporto al
quesito posto.
valutazione domanda n° 1
DOMANDA N° 2
Realizzazione linguistica
Correttezza ortografica,
morfosintattica e sintattica.
Adeguatezza e proprietà lessicale.
Discret Buono
o
/
2
2,5
0-5
3
Controllo dei contenuti
Padronanza e uso adeguato dei
contenuti. Comprensione del
quesito proposto. Coerente
esposizione delle conoscenze in
proprio possesso in rapporto al
quesito posto.
valutazione domanda n° 2
DOMANDA N° 3
Realizzazione linguistica
Correttezza ortografica,
morfosintattica e sintattica.
Adeguatezza e proprietà
lessicale.
/
Discret Buono
o
/
2
0-5
37
Controllo dei contenuti
1
1,5
2
2,5
3
Padronanza e uso adeguato dei
contenuti. Comprensione del
quesito proposto. Coerente
esposizione delle conoscenze in
proprio possesso in rapporto al
quesito posto.
valutazione domanda n° 3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Totale Punti___________________________/15
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
38
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: FILOSOFIA
Candidato ___________________________________________________________
Indicatori
Punteggio massimo
Padronanza del codice
linguistico specifico e
correttezza formale
Conoscenze e
competenze riferite agli
argomenti richiesti
Capacità di sintesi, di
collegamento e di
integrazione delle
conoscenze e
competenze
4 punti
6 punti
5 punti
Livelli di valutazione
Gravemente insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo
Gravemente insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo
Gravemente insuff.
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo
Punteggio per livelli
1
2
2,5
3
4
1
2
2,5
3
4
1
2
2,5
3
4
1
3
4,5
5
6
1
2
3
4
5
1
3
4,5
5
6
1
2
3
4
5
1
3
4,5
5
6
1
2
3
4
5
Totale Punti___________________________/15
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
39
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: FISICA
Candidato ___________________________________________________________
Descrittori
Conoscenza degli
argomenti
Maxpunti 7
Linguaggio specifico
e correttezza
specifica
Maxpunti 5
Livelli
Punti
Conoscenza completa e approfondita
Conoscenza ampia
Conoscenza soddisfacente
Conoscenza sufficiente
Conoscenza non del tutto sufficiente
Conoscenza sommaria
Conoscenza inesistente
Elaborazione fluida e pertinente
Elaborazione corretta
Elaborazione con qualche imprecisione
Elaborazione confusa e con lessico
inadeguato
Nessuna elaborazione
quesito
N. 1
quesito
N. 2
quesito
N. 3
7
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Capacità di sintesi
Maxpunti 3
Organizzazione dei dati e delle
informazioni attraverso analisi e sintesi
appropriate ed efficaci
Organizzazione dei dati e delle
informazioni attraverso analisi e sintesi
sufficienti
Organizzazione dei dati e delle
informazioni attraverso analisi e sintesi
parziali
3
2
1
TOTALE parziale
TOTALE DELLA PROVA
/15
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
40
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: STORIA DELL’ARTE
Candidato ___________________________________________________________
INDICATORI
Conoscenza
degli
argomenti
(aderenza
alla traccia,
completezza
dei
contenuti:
informazioni,
riferimento
pertinente
alle opere e
ai periodi
storicoartistici
studiati)
Capacità di
organizzare
le
informazioni
(analisi –
sintesi –
capacità
critica
personale –
terminologia
specifica )
Correttezza,
chiarezza
espositiva e
proprietà
linguistica
PUNTEGGIO LIVELLI DI
MASSIMO VALUTAZIONE
Ottimo/Distinto
Buono/Discreto
Sufficiente
max: 7 punti
Insufficiente
Gravemente
insuff.
PUNTEGGIO
Quesito Quesito Quesito
CORRISPONDENTE
n.1
n.2
n.3
7
6
5
3/4
2
0/1
Nessuno
Ottimo/Distinto
5
Buono/Discreto
4
Sufficiente
3
Insufficiente
2
Gravemente
insuff.
/Nessuno
0/1
max: 5 punti
Ottimo/Buono
3
max: 3 punti
Sufficiente
2
Insuff/Gravemente
insuff
0/1
Totale Totale Totale
parziale parziale parziale
Tot max:15
punti
/15
/15
Totale
/15
/15
41
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
42
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: MATEMATICA
Candidato ___________________________________________________________
Indicatori
Punteggio massimo
attribuito all’indicatore
Padronanza del codice
linguistico specifico
4 punti
Conoscenze e competenze
riferite agli argomenti
proposti
7 punti
Capacità di sintesi e/o di
collegamento e
articolazione delle
conoscenze e competenze
4 punti
Livello di valore
Scarso
mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
ottimo
scarso
mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
scarso
mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Punteggio
corrispondente ai diversi
livelli
1
1,5
2,5
2,5
3
4
1/2
3/4
5
5,5
6
7
0,5
1,5
2,5
3
3,5
4
Totale Punteggio _______________________________/15
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
43
GRIGLIA DI VALUTAZIONE : COLLOQUIO
Candidato ___________________________________________________________
Punti
(/30)
Voto
(/10)
Punti
(/15)
1-3
4-5
1
2
1
2
6-7
2,5
3
8-9
3
4
Conoscenze frammentarie
e gravemente lacunose
10-11
3,5
5
12-13
4
6
14-15
4,5
7
Conoscenze
frammentarie, con errori o
lacune
Conoscenze carenti,
con errori ed
espressione impropria
Conoscenze carenti,
espressione
difficoltosa
16-17
5
8
Conoscenze superficiali,
improprietà di linguaggio
18-19
5,5
9
Conoscenze complete con
imperfezioni, esposizione
a volte imprecisa
20
6
10
Conoscenze complete ma
non approfondite,
esposizione semplice ma
corretta
6,5
11
Conoscenze complete,
poco approfondite,
esposizione corretta
21-23
24-26
27-28
29-30
CONOSCENZE
Nessuna
Gravemente errate,
espressione
sconnessa
Grosse lacune ed errori
7-7,5 12-13 Conoscenze complete,
quando guidato sa
approfondire,
esposizione corretta con
proprietà linguistica
8-8,5
14 Conoscenze complete,
qualche
approfondimento
autonomo
9-10
15 Conoscenze complete,
approfondite e ampliate,
esposizione fluida con
utilizzo di un lessico ricco
e appropriato
COMPETENZE
CAPACITA’
Nessuna
Non sa cosa fare
Nessuna
Non si orienta
Non riesce ad applicare le
minime conoscenze, anche
se guidato
Applica le conoscenze
minime solo se guidato,
ma con gravi errori
Applica le conoscenze
minime solo se guidato,
ma con errori
Applica le conoscenze
minime solo se
guidato
Applica le conoscenze
minime anche
autonomamente, ma
con gravi errori
Applica autonomamente
le minime conoscenze,
con qualche errore
Applica autonomamente
le minime conoscenze,
con imperfezioni
Non riesce ad
analizzare, non
comprende
Compie analisi errate,
non sintetizza, commette
errori
Compie analisi lacunose.
Sintesi incoerenti,
commette errori
Analisi parziali, sintesi
scorrette, qualche
errore
Analisi e sintesi parziali,
qualche errore
Applica autonomamente le
conoscenze, anche a
problemi complessi, in modo
corretto
Applica in modo autonomo
e corretto le conoscenze
anche a problemi
complessi, trova da solo
soluzioni adeguate
Coglie le implicazioni,
compie analisi complete
e coerenti, rielabora
correttamente
Coglie le implicazioni,
compie correlazioni
esatte e analisi
approfondite, rielabora in
modo corretto, completo
e autonomo
Analisi parziali, sintesi
imprecise
Analisi corrette, difficoltà
nel gestire semplici
situazioni nuove,
imprecisioni
Applica autonomamente e Significato compreso,
correttamente le
esatta interpretazione di
conoscenze minime
informazioni semplici,
analisi corrette, gestione
di situazioni semplici
Applica autonomamente le nuove
Interpreta esattamente il
conoscenze anche a
testo, sa ridefinire un
problemi complessi, ma con concetto, gestisce
errori
autonomamente
situazioni nuove
Applica autonomamente le Coglie le implicazioni,
conoscenze anche a
compie correlazioni con
problemi complessi, ma con qualche imprecisione
imperfezioni
44
Rimni,
Presidente
__________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
______________________________________
Commissario
___________________________________
Commissario
____________________________________
Commissario
____________________________________
45
ALLEGATO 3: Programmi svolti
46
ITALIANO,
DOCENTE:
Pizzi Marinella
RELAZIONE FINALE
Il programma del quinto anno è stato svolto in conformità ai programmi ministeriali , partendo dal recupero di alcuni
argomenti non interamente affrontati nell’anno precedente. Sono stati presi in esame sia movimenti che autori
Dell’Ottocento e del Novecento, soprattutto italiani , ma inseriti nel panorama europeo , per offrire una visione più
aperta delle varie problematiche e dei reciproci scambi e combinazioni fra le diverse culture. Gli alunni hanno
preparato anche approfondimenti personali, su autori minori, che hanno studiato ed esposto in classe ai compagni,
collegandoli agli autori studiati, per dare maggior rilievo al panorama contemporaneo. Sono stati operati opportuni
collegamenti con le letterature straniere, soprattutto con quella britannica , studiata in parallelo in lingua inglese,
senza trascurare le coordinate storiche, sociali e antropologiche, con riferimenti alle discipline specifiche e ai grandi
mutamenti epocali, di cui sentiamo ancora oggi gli effetti.
PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione:
Baldi, Giusso,Razetti, Zaccaria"Il Piacere dei testi,vol. 4-5-6,ed. Pearson.
Dante Alighieri "La Divina Commedia", edizione integrale, a scelta.
AUTORI ED OPERE.
L’OTTOCENTO
Ritratto d’autore: GIACOMO LEOPARDI.
La vita e le opere, ideologia e poetica.
Evoluzione del pensiero Leopardiano riguardo ai concetti di natura, società e ragione.
Il pessimismo e la teoria del piacere.
La poetica del "Vago e indefinito"
Leopardi e il Romanticismo.
Lo”Zibaldone” come diario e autobiografia dell’autore
Dalle opere giovanili ai Canti
Gli Idilli: L’Infinito, Alla Luna.
I canti Pisano- Recanatesi: A Silvia, il sabato del villaggio
L’ultimo Leopardi: la Ginestra o fiore del deserto (significato del messaggio)
Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese ,
.
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.
NATURALISMO, DECADENTISMO E SIMBOLISMO(1861/1903)
Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi e gli autori:
La figura dell’artista, la perdita dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale in Italia.
Il dandy e il poeta vate: il ruolo del poeta nella società europea e italiana di fine Ottocento.
IL REALISMO IN EUROPA : (accenni)
IL REALISMO IN RUSSIA: (accenni.)
IL NATURALISMO FRANCESE:
Gustave Flaubert ed Emile Zola (accenni)
IL VERISMO ITALIANO :
poetiche e contenuti
Percorso di approfondimento:
La condizione femminile nell'Età borghese
La rappresentazione di M:me Bovary in Gustave Flaubert;
"La presa di coscienza di una donna"da "Casa di bambola",atto III di Henrik Ibsen;
"Il rifiuto del ruolo tradizionale", da "Una donna",capp.XII,XIII, di Sibilla Aleramo.
47
Ritratto d’autore:GIOVANNI VERGA
vita, opere e formazione giovanile . L’evoluzione della poetica del Verismo.
Fantasticheria e l’ideale dell’ostrica .
“Impersonalità e regressione": prefazione all'amante di Gramigna:
la poetica del documento umano.
Rosso Malpelo e le altre novelle di “Vita dei campi”.
Letture delle novelle: Rosso Malpelo.
4
Il ciclo de “I vinti”: la prefazione a “I Malavoglia”
Ritratto di un’opera: I Malavoglia. (lettura dell’opera intera o di alcuni brani scelti.)
Lettura della novella“La Roba”, tratto da “Novelle Rusticane”.
L’altro grande romanzo del ciclo de “I Vinti”: Mastro don Gesualdo.
Lettura:"La morte di Mastro don Gesualdo"
La Scapigliatura in Italia:lo sperimentalismo e le caratteristiche generali.
Il movimento francese dei “Décadents “e il Decadentismo Europeo.
DECADENTISMO E SIMBOLISMO IN FRANCIA:
Charles Baudelaire e "I fiori del male";
lettura de:"L'Albatro"( da "I fiori del male");
"Perdita d'aureola" da "Lo spleen di Parigi"
I poeti simbolisti: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè: simbolo e allegoria
L’ESTETISMO di D'Annunzio e O. Wilde:
confronto fra i rispettivi romanzi:
"Il Piacere" e "Il ritratto di Dorian Gray"
IL DECADENTISMO ITALIANO E I SUOI RAPPRESENTANTI PIU’ SIGNIFICATIVI : PASCOLI E D’ANNUNZIO.
Ritratto d’autore: GIOVANNI PASCOLI:
La vita tra il “nido” e la poesia.
La poetica del”Fanciullino” ( lettura di alcuni passi de”il Fanciullino”)
Myricae e Canti di Castelvecchio. Il simbolismo naturale e il mito della famiglia
letture scelte:
I puffini dell’Adriatico, Lavandare, X Agosto, Temporale,Il lampo, Novembre (da Myricae);
Il Gelsomino notturno (da”I Canti di Castelvecchio” )
.
Ritratto d’autore: GABRIELE D’ANNUNZIO:
la vita inimitabile di un mito di massa.
Le poesie: i tre libri delle Laudi del cielo, del mare,della terra, degli eroi
il Panismo estetizzante del Superuomo.
I romanzi: dal Piacere al Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto
Letture tratte da :Alcyone: La pioggia nel pineto , La sera fiesolana.
“Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti( da “Il Piacere,libro III, cap.II)
Dal “Notturno”: la" prosa notturna "
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: Le Avanguardie.
L’Avanguardia Futurista: il Manifesto del Futurismo,di F. T. Marinetti.
"Il Palombaro",di C. Govoni, da "Rarefazione e parole in libertà" ;
il Surrealismo, il Dadaismo.
I Crepuscolari, i Vociani e i poeti del “Frammento”
Poetica e poesia dei “Crepuscolari”.
SVEVO E LA NASCITA DEL ROMANZO IN ITALIA
48
Caratteri dei romanzi Sveviani:l’inettitudine a vivere
"Una vita" e "Senilità": due insuccessi letterari
Analisi del romanzo capolavoro:
La “Coscienza di Zeno “
IL POSTO DI PIRANDELLO NELL’IMMAGINARIO NOVECENTESCO E NELLA LETTERATURA EUROPEA.
Pirandello e la poetica dell’umorismo: “persona” e “personaggio”, la “forma” e la “vita”. “Un'arte che scompone il
reale"(da "L'umorismo" )
I romanzi umoristici:da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno, centomila.
(Lettura dell’intero romanzo: Il fu Mattia Pascal o di alcune letture antologizzate)
Le novelle per un anno:
Lettura di”Il treno ha fischiato”,”Ciaula scopre la luna”
Il teatro di Pirandello:
Sei personaggi in cerca d’autore e il”teatro nel teatro “
Enrico IV e la follia.
**UNO SGUARDO ALLA POESIA DEL NOVECENTO
“VITA DI UN UOMO”: Giuseppe Ungaretti e la religione della parola
Le sue raccolte:“Allegria”, il“sentimento del tempo”,”Il dolore”.
Lettura e analisi delle liriche: ”Soldati “,”S. Martino del Carso ,”Mattina”, “Veglia” (dalla raccolta “Allegria”) .
DANTE E LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO
canto I: l’ascesa al cielo di Dante e Beatrice (vv.1-142);
canto III: incontro con Piccarda Donati (vv.I-130);
canto XI : san Francesco (vv.I-129),
canto XVII :L'incontro con Cacciaguida e la profezia dell'esilio (vv.1-142);
canto XXXIII : La preghiera di San Bernardo alla Vergine (vv.I-145)
L'ultimo argomento di letteratura, contrassegnato dal doppio asterisco, sarà svolto dopo il 15 Maggio, per
collegarlo alla contemporanea guerra mondiale
e concludere il percorso letterario con uno sguardo al '900.
Rimini 15/05/2017
Il docente, prof.ssa Pizzi Marinella
____________________________
Gli studenti
_________________________
__________________________
49
LATINO,
DOCENTE:
Pizzi Marinella
RELAZIONE FINALE
Poiché il latino, nel triennio del Liceo della Formazione, è diventato una materia prevalentemente orale, il programma
svolto riguarda esclusivamente la trattazione della Letteratura Latina, di cui sono stati presi in esame i principali
autori, collocati nel periodo storico e culturale in cui vissero.
Il disegno storico della Letteratura Latina è stato svolto dall’Età Imperiale fino a quella pre-cristiana, analizzando le
opere dei principali autori, collocati nell’ambito storico e letterario in cui vissero.
Di ciascuno di essi sono stati letti molti passi in traduzione per comprendere il loro pensiero e la loro importanza nella
continuità della nostra cultura e tradizione.
Alcuni passi significativi, tratti soprattutto da Seneca e Quintiliano , con riflessioni filosofiche e pedagogiche,
utilizzabili anche negli approfondimenti personali e confrontati con le discipline di Scienze Umane, sono stati letti
nei testi originali e confrontati con le traduzioni in italiano e analizzati dal punto di vista dello stile e del contenuto.
Il programma iniziale è stato corredato da uno sguardo d’insieme sugli ultimi argomenti del programma del IV anno,
che sono stati ripresi e approfonditi.
Sono poi stati individuati i nuclei fondamentali del programma del V anno, da svolgere nel rispetto delle normative
ministeriali e in consonanza le altre materie , con cui sono stati effettuati tutti i possibili confronti e collegamenti
interdisciplinari, durante lo svolgimento del programma.
Quintiliano,pur essendo stato collocato con asterisco, da svolgere cioè dopo il 15 Maggio, verrà spiegato per l'
importanza che riveste nella nostra scuola, come primo pedagogista e insegnante nella scuola pubblica, sotto
l'imperatore Vespasiano.
PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione: GARBARINO PASQUARIELLO - VELUTI FLOS VOL 2 – PARAVIA
Argomenti e Autori
L’età di Augusto.
ORAZIO:cenni biografici.
I SERMONES E I CARMINA:caratteri, contenuti e messaggio.
Letture in traduzione :
Lettura integrale della satira 1,9”Il seccatore”
Il topo di campagna e il topo di città (Sermones 2,vv.79-117.)
Una scelta di vita”(Carmina 1,1)
Il Congedo ( Carmina 3,30)
Carpe diem (Carmina I;11).
I POETI ELEGIACI
OVIDIO :cenni biografici.
Le opere erotico-didascaliche:
Amores,Heroides, Ars Amatoria,I Fasti (caratteri generali)
Le Metamorfosi.
Letture in traduzione:
Apollo e Dafne (Metamorfosi,I, vv.452-567.).
Piramo e Tisbe (Metamorfosi (IV,vv.55-166)
Narciso (Metamorfosi,III,vv.407-510)
LIVIO E LA SUA OPERA STORIOGRAFICA
Cenni biografici
Struttura e contenuti
50
La sua opera storiografica:”Ab urbe condita libri”
Lettura in traduzione:
“L’Apologo di Menenio Agrippa”(Ab Urbe condita ,II,,32,5-12)
.”Lucrezia”(op.cit.vv :1,57,4-11;58)
Panorama storico- culturale: gli imperatori della dinastia Giulio- Claudia e i mutamenti istituzionali e culturali
nell’impero.
SENECA E IL SUO TEMPOLa vita e i suoi rapporti con l'Imperatore Nerone.
Le opere: I “Dialogi”,-I trattati,-Le tragedie,-L’”Apokolôkyntosis,”
Le “Lettere a Lucilio”.
Lo stile della prosa senecana
Letture in traduzione:
Il valore del tempo:
“Riappropriarsi di sè e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium,1 , 1-5): lettura integrale del par.1 e traduzione.
“Il valore del passato” (dal “De brevitate vitae”,10,2-5)
“La galleria degli occupati”( dal “De brevitate vitae,12,1-7;13,1-3)
L’ira (dal " DE IRA",1,1,1-4.))
“La lotta contro l’ira”( op. cit.3,13,1-3)lettura integrale e traduzione
LA FAVOLA: FEDRO.
Il modello Esopico e il genere della “favola”
Il “Prologo”, l'apologo animalesco e la “Morale”
La scelta della poesia e le finalità educative
Lettura delle favole più celebri:”Il lupo e l'agnello”,
“La volpe e l'uva”, “La vedova e il soldato”.
PETRONIO:
elegantiae arbiter (ritratto di Petronio in Tacito.)
“Il Satyricon” : opera complessa.
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano
Letture in traduzione del Satyricon:
“L’ingresso di Trimalchione”(Satyricon,32-33.)
Presentazione dei padroni di casa”(Satyricon,37,1-38,5)
La novella: "La matrona d’Efeso” (111-112)
L’Età dei Flavi: avvenimenti storici e panorama letterario.(in sintesi)
* QUINTILIANO
Quintiliano e l’oratoria del suo tempo
Quintiliano e i suoi rapporti con l’imperatore:
Istituzione dell’insegnamento finanziato dallo stato
L’ “Institutio oratoria”
La formazione dell’oratore
La decadenza dell’oratoria
Letture in traduzione :
Dall’Institutio Oratoria:
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore(Proemium,9-12)
“I vantaggi dell’insegnamento collettivo” (1,2, 18-22.)
L’asterisco segnala l' ultimo argomento , che sarà svolto dopo il 15 Maggio.
51
Rimini15/05/2017
Il Docente, prof.ssa Pizzi Marinella
_______________________________
Gli studenti
__________________________
__________________________
52
RELIGIONE CATTOLICA,
DOCENTE:
Colonna Massimo
RELAZIONE FINALE
L'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore
della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al
patrimonio storico, culturale e civile del nostro Paese. L'IRC promuove, insieme alle altre discipline scolastiche, il
pieno sviluppo della personalità degli studenti con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza.
Questa disciplina possiede contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storicoartistico-culturale; viene
incontro ad esigenze di verità e di ricerca di senso; contribuisce alla formazione della coscienza morale; offre
elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. L’IRc, favorisce l'incontro tra le altre
religioni ed è in grado di offrire il proprio contributo allo sviluppo del dialogo inter-culturale, creando un clima di stima
e di collaborazione reciproca nell’ impegno a favore del bene comune e della promozione degli autentici valori umani,
culturali e religiosi, promuovendo tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando
all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.
PROGRAMMA SVOLTO
1. La questine antropologica:
Visione dell'uomo nel mondo greco e confronto con la novità ebraico/cristiana: lettura ed esegesi di Gen 1 e
2 la creazione;
Introduzione all'antropologia cristiana: L'uomo trinitario nei Padri della Chiesa.
L'uomo in rapporto con l'infinito domande di senso: definizione e confronto tra la dimensione religiosa e
dimensione spirituale.
Visione film 7 Km da Gerusalemme.
Il ruolo della donna nella Bibbia: confronto con l'Antico e il Nuovo Testamento: lettura ed esegesi di alcuni
brani del vangelo.
2. Il progetto di Dio sull'uomo:
L'uomo di fronte alle scelte della vita: la via del male e la via del bene (riferimenti alla Didachè);
visione filmato tratto dal programma televisivo Le invasioni barbariche: intervista sul tema delle scelte
giovanili: confronto tra Fabri Fibra e il filosofo Galimberti;
visione del film Se Dio vuole dibattito sulla questione cosa voglio fare da grande e su cosa voglio essere da
grande;
Le scelte di Abramo raccontate da Giovanotti: percorso biblico attraverso la musica.
3. La visione dell'uomo in Occidente e in Oriente:
Il concetto di persona nelle religioni induista e buddhista: lettura di alcuni canoni induisti;
La figura del saggio nella cultura cinese: confucianesimo e taoismo
4. Questioni dogmatiche:
La Chiesa e i Sacramenti come segni efficaci della Grazia di Dio: visione filmato di padre Rupnik, percorso
d'arte attraverso il mosaico.
L'escatologia: riflessione e confronto sul concetto di Inferno e Paradiso: lettura di alcuni brani biblici;
5. La Chiesa e il mondo:
La questione dell'aborto visione confronto e riferimento al documento, Catechismo della Chiesa Cattolica;
L'eutanasia un problema attuale: visione del film Io prima di te.
53
Che cos'è la famiglia: lettura di alcuni passi dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, riflessione e
confronto.
L'amore in tutte le sue forme: dal Simposio di Platone all'amore cristiano (carità).
Visione del film Risvegli: quanto è importante l'empatia e l'amicizia (amore) nell'approcciarsi con la
diversabiltà?
Rimini15/05/2017
Il Docente, prof. Calonna Massimo
_______________________________
Gli studenti
__________________________
___________________________
54
INGLESE,
DOCENTE:
PIOPPO MARIACHIARA
RELAZIONE FINALE
Nello studio della lingua è stato privilegiato un approccio comunicativo nel tentativo di rafforzare l’uso della lingua
straniera come strumento di comunicazione. Si è cercato di disincentivare una acquisizione piattamente mnemonica
e di favorire piuttosto una libera interpretazione personale dei contenuti. Si è preferito dare valore prioritario alla
“fluency” del discorso (con ciò intendendosi la velocità e/o la scorrevolezza della produzione linguistica e la capacità
di fare interagire lingua e contenuto) rispetto all’accuratezza formale fine a se stessa dell’espressione linguistica.
Pertanto l’esposizione orale dell’alunno non è mai stata interrotta per sottolineare imperfezioni e/o errori sintattici,
morfologici o grammaticali fintanto che l’alunno si mostrava capace di interloquire col docente e di rispondere in
modo contenutisticamente corretto.
Nello studio degli autori non si è data importanza alla biografia degli autori o alla trama dei romanzi quanto piuttosto
all’analisi delle opere e dei testi. Il contesto storico è stato delineato al fine di meglio comprendere gli autori e di
suggerire ulteriori chiavi di lettura senza, tuttavia, soffermarsi in dettaglio su fatti e date.
PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione:De Flavis, Muzzarelli, Quinn, Heading Out, vol. 1 e 2, Signorelli scuola
Il romanticismo
Historical Context: The age of Revolutions; the industrial revolution;
The Romantic revolutions: the features of English Romantic Poetry;
William Wordsworth: “ “Daffodils”, "She Dwelt among the Untrodden Ways", “The Solitary Reaper”, "My Heart Leaps
up".
Samuel Taylor Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner”, part I;
John Keats: “Ode on a Grecian Urn” (p. 99), “La Belle Dame Sans Merci”;
L’epoca Vittoriana
Historical Context: Queen Victoria, the Victorian Compromise and the importance of Respectability. The Reform Bills
of 1832,1867, 1884-5, The Chartist Movement; Urban slums and The Poor Law. Charles Darwin and Victorian
society. The Woman Question;
Early Victorian Fiction (p. 168-70). Charles Dickens: , Hard Times: “Coketown”, "A Classroom Definition of a Horse";
Oliver Twist: "Oliver is taken to the workhouse"; David Copperfield: opening paragraph (fotocopy); Comparison
between C. Dickens "David Copperfield" (opening paragraph) and J.D.Salinger "The Catcher in the Rye" (opening
paragraph); "School began in earnest next day";
Charlotte Bronte: Jane Eyre: chapter 17, chapter 26
Later Victorian Fiction: Robert L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: "Story of the Door" “Dr
Jekyll’s Full Statement of the Case”.
Alfred Tennyson: "Ulysses"
L’epoca moderna
Historical Context: the Edwardian Era (p.151), The Beginning of the XX Century: a brief introduction;
*Modernism, T.S.Eliot: The Waste Land: “The Burial of the Dead” (fotocopy), “The Fire Sermon”;
*Modernism and the “stream-of-consciousness” technique (p. 80-1), James Joyce: Ulysses: excerpts
Gli argomenti contrassegnati da * saranno svolti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2017 e la fine dell’anno
scolastico
55
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.ssa Pioppo Mariachiara
_______________________________
Gli studenti
__________________________
___________________________
56
SCIENZE UMANE,
DOCENTE:
Colangelo Maria Antonella
RELAZIONE FINALE
La classe ha seguito con attenzione ed interesse le tante esperienze, proposte, attività e argomenti che sono stati
affrontati. Per molti di questi sono stati protagonisti gli studenti stessi, proponendosi di sperimentare in autonomia lo
studio e la presentazione alla classe di alcuni argomenti e autori che risultavano interessanti a prima vista. Così
anche per i libri letti durante l’anno. Riguardo ai saggi hanno mostrato intuito e capacità organizzativa e di pensiero.
La trasversalità è stata sempre sostenuta, pur rimanendo una difficoltà, anche perché molti sono gli autori e le teorie,
per ogni argomentazione, da ricordare. Certamente la sociologia si è rivelata la più interessante fra le discipline di
quest’anno; anche la ricerca effettuata ha coinvolto tutti, mostrando che hanno colto come muoversi in questo
campo, così complesso. Le lezioni tenute da alcuni colleghi hanno evidenziato che oltre all’interesse, c’è capacità di
ascolto, di scambio comunicativo corretto anche se vivace e diversificato. L’esperienza nella scuola primaria ha,
invece, stimolato la comprensione delle tematiche pedagogiche, sempre articolate, attuali e confrontabili con il loro
breve passato. Sottolineo che la maggior parte degli studenti ha realizzato un percorso personale preciso, organico e
fortemente motivato.
PROGRAMMA SVOLTO
Testi in adozione:
PEDAGOGIA: U. Avalle – M. Maranzana “ La prospettiva pedagogica - Dal Novecento ai nostri giorni “
V anno – Paravia
SOCIOLOGIA : E. Clemente – R. Danieli “ Sociologia- contesti e problemi del mondo socio – politico” II
biennio e V anno del Liceo delle scienze umane – Paravia
ANTROPOLOGIA : A. Bianchi- P. Di Giovanni -“ La dimensione antropologica” per il Liceo delle
scienze umane e l’opzione economico –sociale - Paravia
PEDAGOGIA
RIPASSO SISTEMATICO DAL 1200 AL 1800, uso della linea del tempo, parole chiave, testi, autori, con particolare
attenzione a Michel de Montaigne, Comenio, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Froebel; confronto con il presente.
Riflessioni, discussioni, considerazioni. ( testo secondo biennio)
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: scenario storico ( approfondimento del docente)
Unità 1 . L’esperienza delle “Scuole nuove”
- L’ esordio del movimento in Inghilterra
. Cosa sono le “Scuole nuove”
. Abbotsholme : la prima scuola nuova
. Baden-Powell e lo scoutismo
- La diffusione delle scuole nuove in Francia : sguardo globale
- La diffusione delle scuole nuove in Germania: sguardo globale
- La diffusione delle scuole nuove in Italia
. Le sorelle Agazzi e la scuola materna
. Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata ”
Letture: T1 – All’origine del movimento scout- Baden Powel
T2 – All’origine del museo didattico- Rosa Agazzi
T3 – La scuola rinnovata – Giuseppina Pizzigoni
57
Unità 2. Dewey e l’attivismo statunitense
- Dewey : educare mediante l’esperienza
- Kilpatrick e l’eredità di Dewey
Letture: L’ideale democratico e l’educazione, da R. Tassi “ Itinerari pedagogici” – proposta del docente
T1 – Educazione, individuo e società- J. Dewey
- Riflessioni sul concetto di “democrazia” a scuola – tra passato e presente.
- Il saggio di pedagogia- requisiti per svolgerlo- esercitazione su brano di Dewey e la democrazia
Unità 3. L’attivismo scientifico europeo
- Decroly e la scuola dei “centri d’interesse”
- Montessori e le “Case dei bambini”
- Claparède e l’educazione funzionale
- Binet e la psicologia
Lettura del testo” La scoperta del bambino” di M. Montessori – attività individuale di riflessione sul testo e lavoro
di gruppo legato all’esperienza dello scorso anno: visita alla casa di M. Montessori e alla scuola d’infanzia e
primaria montessoriani a Chiaravalle ( An)- vedi raccoglitore di classe
- La pedagogia narrata: Montessori e Gandhi: uno scambio epistolare tra due pacifisti; coll con filosofia: Kant –
“La pace perpetua”
- Saggio: “ Migrazioni e educazione alla cittadinanza in prospettiva interculturale”
( coll. con sociologia)
Unità 4. Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo
- Cousinet e l’apprendimento “in gruppo”
- Freinet : un’educazione attiva , sociale e cooperativa
- Boschetti Alberti e la “scuola serena ”
- Dottrens e l’educazione emancipatrice
- Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill
Unità 5. L’attivismo tra filosofia e pratica
- L’attivismo cattolico (globale)
- Maritain e “l’umanesimo integrale”
- L’attivismo marxista : - Makarenko e il “collettivo”
- L’attivismo idealistico : - Gentile e l’attualismo pedagogico
- Lombardo-Radice e la “didattica viva”
IL NOVECENTO: scenario storico
Unità 6. E parte della 7. eseguite in autonomia con trasversalità psicologica: autori già affrontati in psicologia in
classe quarta
Unità 6. La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti
- Freud e la psicoanalisi
- Oltre il freudismo: Adler
- Anna Freud e la psicoanalisi infantile
- La psicoanalisi negli Stati Uniti: Erikson e lo sviluppo psicosociale
- La psicologia della forma in Germania : Wertheimer e il pensiero produttivo
- Piaget e l’epistemologia genetica
- Vygotskji e la psicologia in Russia
Unità 7. Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti
- Il comportamentismo: Watson e la programmazione dell’apprendimento
58
-
Skinner e il condizionamento operante – termine lavoro autonomo.
- Bettelheim: psicoanalisi ed educazione
- Bruner : dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura
Lettura: T2 – L’apprendimento basato sulla scoperta – J. Bruner
Unità 8. L’esigenza di una pedagogia rinnovata
- Rogers e la pedagogia non direttiva
- L’educazione “alternativa” in Italia : Don Milani e l’esperienza di Barbiana
Letture: La pedagogia narrata- Don Milani e la gioia di educare
T5 – Una scuola discriminante – Don Milani- “Lettera ad una prof”
FILM: “Il romanzo di un maestro”,di Vittorio De Seta, tratto dal libro
“ Un anno a Pietralata”di Albino Bernardini
ESPERIENZA: “ La pedagogia tra i banchi di scuola” – Uscita presso la Scuola primaria A. BrandiApprofondimento “ Il metodo Bortolato”
TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA
La pedagogia a confronto con la realtà individuale e sociale
-
L’epistemologia pedagogica
La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica
L’epistemologia della complessità : MORIN e la riforma dell’insegnamento
Le scienze dell’educazione
-
Unità 9. La pedagogia come scienza ( sguardo generale)
Unità 10. La ricerca educativa e i suoi metodi ( sguardo generale)
La natura e gli ambiti della ricerca educativa
I principali metodi della ricerca educativa
Misurazione e programmazione
Unità 11. I contesti formali e non formali dell’educazione
-
La scuola e il sistema scolastico in prospettiva internazionale ( globale)
L’educazione permanente
Il compito educativo del territorio
Laboratorio di cittadinanza attiva: l’affido
Il tempo libero ( collegam con Sociologia)
-
Lettura: T2 “Le affinità di tutti gli educatori”
Unità 12 . Educazione e mass-media
- Le caratteristiche dell’educazione di massa
- La fruizione della tv nell’età evolutiva
- L’educazione ai mass- media
- La didattica multimediale
Letture: T1 ” Educazione, sviluppo, bambini e televisione”
59
-
Unità 13. Educazione, diritti e cittadinanza
L’educazione ai diritti umani
Laboratorio di cittadinanza attiva: Gli obblighi nei confronti dei bambini
L’educazione civica
Lettura: T1 “ Il bambino solo”
Unità 14. Educazione, uguaglianza, accoglienza
-
Il disadattamento
Lo svantaggio educativo
L’educazione interculturale
La diversa abilità
I bisogni educativi speciali
-
Lezione: “La diversabilità e i percorsi “su misura”- Prof Emanuela Urbinati
del sostegno)
-
Letture: T2 “ La diversità come valore- Educare alla convivenza”
( docente coordinatore
Saggio: “ Migrazioni e educazione alla cittadinanza in prospettiva interculturale”
( coll sociologia e antropologia)
PSICOLOGIA
ARGOMENTI RIPASSATI sul testo in adozione fino allo scorso anno e collegamento con PEDAGOGIA unità 6 e 7
Unità 1: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
Che cos'è la psicologia - La psicologia nella società - La psicologia come scienza Unità 2: IL COMPORTAMENTO UMANO
Il comportamentismo : Pavlov e l'apprendimento condizionato;
Skinner e il condizionamento operante ; Strategie educative comportamentali
Unità 3: MENTE E APPRENDIMENTO
Il cognitivismo: Piaget e Vygotskij
La psicologia della Gestalt
L'apprendimento sociale , Bruner : cognizione e cultura (collegamento con pedagogia T3: "La deprivazione
culturale e Head Start"
Bandura ( concetti chiave)
Unità 4: IL MONDO INTERNO
Freud ; Jung ; Adler ; Anna Freud (con cenni ai "Meccanismi di difesa": rimozione e regressione); Erikson
con sintesi degli stadi di sviluppo; Bowlby con particolare attenzione alla "Teoria dell'attaccamento"
Unità 5: DALL'INDIVIDUO ALLE RELAZIONI
La psicologia della personalità ; Allport
60
Scheda "Emozioni" ripassata attraverso la visione di due video:
" Le cinque emozioni di base secondo Inside Out" -"L'invito della follia"
La psicologia sociale : Lewin
Lezione in classe di psicologia:” I disturbi mentali: la schizofrenia” Prof. Annalisa Marcucci
SOCIOLOGIA
Ripasso dall’Unità 1 alla 5: Dal senso comune alla sociologia come scienza; i padri fondatori ; le istituzioni ; la
conflittualità sociale; il sociologo al lavoro.
Film: “ Un borghese piccolo piccolo” di M. Monicelli, tratto dall’omonimo romanzo
di V.Cerami
: Scenari della società industriale
Le seguenti unità sono state affrontate mediante un lavoro di ricerca a piccoli gruppi
Unità 6
LA VITA URBANA
La città moderna e la sua storia
I sociologi di fronte alla città
La vita urbana oggi
La crescita urbana nei paesi in via di sviluppo
Unità 7
LA SOCIETA’ DEL TEMPO LIBERO ( coll. Pedagogia – Unità 11 – cap.5)
La natura sociale del tempo
La storia del tempo libero
Il tempo libero oggi
T2 Bartezzaghi: “I doveri del week-end” – Saggio
Unità 8
IL CITTADINO E LA POLITICA ( colleg. pedagogia Unità 13 Educazione, diritti e cittadinanza)
Nel cuore della politica: il potere
Lo stato moderno e la sua evoluzione
Avventure del Novecento: Stato totalitario - Stato sociale
Film: Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta- dibattito
La partecipazione politica
Lezione in classe di diritto: “ I cambiamenti nella Costituzione Italiana e il referendum” – Prof Marini Elio
Unità 9
L’INDUSTRIA CULTURALE
La nascita dell’industria culturale
L’industria culturale nella società di massa
L’intellettuale di fronte alla cultura di massa
(Colleg. con pedagogia: Unità 12. Educazione e mass – media)
Unità 10
RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE ( collegamento con ANTROPOLOGIA)
La religione come fatto sociale
61
Prospettive sociologiche sulla religione
La religione nella società contemporanea
Scenari della società di oggi
Unità 11
DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE
La globalizzazione: di cosa parliamo?
I diversi volti della globalizzazione
Vivere in un mondo globale: problemi e risorse
Unità 12
SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’( collegamento con pedagogia: Unità 14 Educazione, uguaglianza,
accoglienza ) La salute come fatto sociale
La malattia mentale
La diversabilità
NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE ( colleg. Unità 11 di pedagogia, cap 1 e 2)
La scuola moderna
Trasformazioni della scuola nel XX secolo
Oltre la scuola
RICERCA SOCIOLOGICA: DIPENDENZA DAI SOCIAL NETWORK NEGLI ADULTI
Perché abbiamo scelto questo tema? ( La parola agli studenti)
Dopo esserci interrogati su quale potesse essere l’argomentazione più adatta su cui improntare la ricerca
sociologica, siamo giunti alla conclusione di prendere in considerazione l’ambito tecnologico, dal momento che
permea ogni momento della nostra vita quotidiana. Pertanto, in seguito ad un percorso di studi che ha dimostrato la
crescita esponenziale dell’utilizzo dei mass-media da parte dell’uomo, ci siamo focalizzati sulla dipendenza dai social
network negli adulti.
FASE IDEATIVA E ATTIVITA’ PRATICA:
•
•
•
•
•
•
Scelta del problema
Oggetto d’indagine: dipendenze social network negli adulti
Formulazione delle ipotesi
Elaborazione di un questionario con domande aperte e chiuse
Raccolta dei dati e loro interpretazione.
Produzione di un power – point con grafici e risultati
ANTROPOLOGIA
Ripasso dei contenuti affrontati negli anni precedenti:
La cultura e lo sguardo antropologico
Consapevolezza antropologica, superare l’etnocentrismo
62
Tollerare le diversità ,teorie e metodi dell’antropologia culturale : la storia dell’antropologia e la ricerca
antropologica
Le società umane: Società di caccia e raccolta;società pastorali; società orticole; società statali
La vita di relazione: la parentela, il matrimonio, l’amicizia, le emozioni
L’arte e folklore
MODULO 3 : la produzione simbolica
Collegamento antropologia e sociologia nel contesto della religione
Punto di vista antropologico
Come definire la religione?
Un’ esperienza presente in tutte le società umane
La variabilità delle forme religiose
Si può fare a meno della religione?
Le religioni nei rapporti tra i popoli
Panorama di religioni nel mondo
Approfondiamo: Islam
LABORATORIO DI LETTURA: ( x ripassare e/o approfondire tematiche)
PSICOPEDAGOGIA
“ L’interpretazione dei sogni” di S. Freud ( colleg con Psicologia x ripasso)
“ Coca e cocaina” S. Freud ( coll con le dipendenze in psico)
“ Cattiva maestra televisione” di Karl Popper ( coll con mass-media)
“ Gioco e realtà” di Donald W. Winnicott ( colleg con Psicologia età evolutiva)
“ Il mistero dell’innamoramento” di F. Alberoni ( coll con Psicologia: adolescenza)
“ La prima ferita” di Willy Maurer ( coll psico: Bowlby, Lorenz, Imprinting, attaccamento)
“ Il complesso di Telemaco” di Massimo Recalcati ( coll tema famiglia dal passato a oggi)
“Tv per un figlio” di Anna Oliverio Ferraris ( coll. mass-media)
“ Il linguaggio segreto del volto” di Anna Guglielmi ( la fisiognomica, coll. psicologia)
“ Puoi fidarti di me” di Raffaele Morelli ( coll. psicologia: le tecniche psicologiche)
“ Diario di una schizofrenica” di Sechehaye (approf. psicologia e le malattie mentali)
“ Il mondo incantato” di B. Bettelheim ( coll con psicologia : realtà e fantasia, la fiaba)
SOCIOANTROPOLOGIA
“Il suicidio” di E. Durkheim ( collegamento con Sociologia)
“Vita liquida” di Z. Bauman ( collegamento con Sociologia
“ Modernità liquida” di Z. Bauman ( coll con la sociologia e la psicologia)
“L’ arte della vita” di Z. Bauman , con tutoraggio in classe quarta
“ Viaggi e avventure della serendepity” di b. Merton e E. Bacher( approf socio)
“Il contratto sociale” di J. J. Rousseau, con tutoraggio in classe quarta
“ I sogni belli non si ricordano” di C. Verdelli ( psico- antropologico- sociologico)
“1984”di G.Orwell ( coll sociologia e psicologia)
Rimini , 15 maggio 2015
Il docente, prof.ssa Colangelo Maria Antonella
_______________________________
Gli studenti
__________________________
___________________________
63
FILOSOFIA,
DOCENTE:
Colangelo Maria Antonella
RELAZIONE FINALE
La classe ha svolto con attenzione il suddetto programma, riscontrando qualche difficoltà soprattutto negli autori
affrontati nella prima parte dell’anno. Si è preferito controllare il ritmo di presentazione degli stessi, per permettere
agli studenti di prendere coscienza dei contenuti ed affinare l’esposizione e la critica.
In classe si è dato spazio alla visione delle opere più importanti relative ai filosofi presentati, di leggerne parti in
libertà di scelta. Anche sul libro di testo si sono cimentati in approfondimenti personali, leggendo le proposte
antologizzate, sia autonomamente che in gruppo.
Compatibilmente con il tempo a disposizione, si sono svolte esperienze di dibattito a seguito delle letture dei testi,
anche con riflessioni scritte e successiva condivisione e scambio di idee.
Alcuni autori sono stati presentati con
power - point o visionando DVD della collana “ Il caffè filosofico” raccontati da filosofi contemporanei. Quando
possibile, si sono cercati collegamenti con altre discipline, in particolare le Scienze Umane. Sono risultate
interessanti le due esperienze svolte: quella ad inizio anno con la giornata, sia pure piovosa, immersa nella filosofia
del festival di Modena, che l’approccio alla metodologia CLIL, svolto dalla collega prof Manzi Maurizia, che ha
sviluppato il pensiero di Dewey che i ragazzi hanno affrontato in pedagogia e per il momento di valutazione finale
hanno prodotto brevi video che li ha divertiti, coinvolgendoli in una forma espositiva nuova per tale disciplina.
64
PROGRAMMA SVOLTO
Dal testo della programmazione didattica condivisa per la classe quinta:
Competenze
Abilità / Capacità
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche Saper concettualizzare le tematiche e gli autori
della disciplina.
fondamentali della storia del pensiero occidentale.
Individuare i nessi tra la filosofia e le altre Saper collocare gli autori e le tematiche trattate nel
forme del sapere, in particolare le Scienze contesto storico- culturale di riferimento.
Umane.
Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche
Sviluppare la riflessione personale, il della disciplina.
giudizio critico, l’attitudine alla discussione
razionale, la capacità di argomentare una Saper analizzare e sintetizzare gli argomenti trattati.
tesi, anche in forma scritta.
Saper argomentare una tesi, anche in forma scritta.
Saper cogliere le radici concettuali e filosofiche della
cultura occidentale, individuando i nessi tra la
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare le
scienze umane.
TESTO : “La Filosofia”dall’Illuminismo a Hegel - Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero; ed. Paravia Volume
2B
I.Kant:
- Vita dell’autore e la dissertazione del 1770
- Scritti del periodo precritico e quelli del criticismo kantiano
- La Critica della ragion pura:
Il problema generale e la partizione della critica
I giudizi sintetici a priori
La rivoluzione copernicana (globale)
Estetica trascendentale e la teoria dello spazio e del tempo
Analitica trascendentale e le categorie,l’io penso,fenomeno e noumeno
Dialettica trascendentale: la metafisica e le sue tre idee; il nuovo concetto di
metafisica in Kant
Letture sul testo tratte dalla Critica della ragion pura :dall’analitica trascendentale
T6 “ I concetti puri dell’intelletto” e T8 “ L’Io penso”.
-
La Critica della ragion pratica: I suoi compiti e il suo primato
La realtà e l’assolutezza della legge morale
La categoricità dell’imperativo morale
Dal dovere alla libertà
65
La critica del Giudizio: Giudizi determinanti e giudizi riflettenti, cenni giudizio estetico e teologico
L’analisi del bello e del sublime
Letture sul testo tratte dalla Critica del giudizio:
T3” I caratteri del bello” e T5 “ Il sublime, differenze con il bello”.
-
Sguardo globale:
Kant e la fede razionale
Kant e la storia
Kant e la pace
Kant nel pensiero moderno e contemporaneo.
“ Per la pace perpetua”: presentazione del testo in collegamento
con pedagogia: Ed. alla pace
Il sublime e l’arte” Il viandante sul mare di nebbia”
L’Ottocento tra Romanticismo e Idealismo:
Punti salienti del:
Il Romanticismo come problema critico e storiografico
La nascita dell’idealismo romantico e il senso dell’infinito
(su sintesi del docente)
G.W.F. Hegel:
- La vita e gli scritti
- Il giovane Hegel
- Le tesi di fondo del sistema hegeliano: finito – infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia
- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
- La dialettica
- La critica alle filosofie precedenti
- La Fenomenologia dello spirito: collocazione nel sistema
- Coscienza, Autocoscienza e Ragione e le figure:
servo e padrone; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice
Lo spirito e il sapere assoluto
Letture dal testo sulla Fenomenologia: T1 – “ La certezza sensibile”;
T2 “ La coscienza infelice”
- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:
- La logica dell’essere, dell’essenza e del concetto
- La filosofia della natura ( sguardo generale)
- La filosofia dello spirito
- Lo spirito soggettivo e oggettivo
- Eticità
- La filosofia della storia ( globale)
- Lo spirito assoluto (globale)
VOLUME 3 A – La filosofia da Schopenhauer a Freud
Caratteri essenziali della critica e rottura del sistema hegeliano
A. Schopenhauer:
- Vita e radici culturali del suo sistema
- Il velo di Maya e le caratteristiche della volontà
- Il pessimismo
- Le vie della liberazione dal dolore
Letture dal testo: T1” : ” Il mondo come rappresentazione”; T2 “ Il mondo come volontà”;
T3 “ Il pessimismo cosmico”; T4 “ La vita umana tra dolore e noia”; T6 “ L’ascesi”.
La sinistra hegeliana : sguardo generale
66
L. Feuerbach:
- Vita
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
- La critica alla religione
- “L’uomo è ciò che mangia” : l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach e la sua importanza storica
K. Marx:
- Vita e opere
- Il carattere globale dell’analisi marxista
- La critica al misticismo di Hegel, allo Stato moderno,al liberalismo e all’economia borghese; l’alienazione
- L’interpretazione della religione in chiave sociale
- La concezione materialistica della storia: ideologia ; struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia
- Il Manifesto del partito comunista : borghesia, proletariato e lotta di classe; i falsi socialismi
- Il Capitale : economia e dialettica ; merce, lavoro e plusvalore
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato
- La futura società comunista
Letture dal testo : T5 “L’alienazione”; T6 “ Struttura e sovrastruttura”,
T7 “Classi e lotta tra classi”; T11 “ Il crollo del capitalismo”
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
- Positivismo, Illuminismo e Romanticismo
A. Comte
- collegamento con Sociologia : vita e opere
- Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze
- La sociologia
- La dottrina della scienza
- Empirismo e razionalismo in Comte ( sguardo generale)
- La divinizzazione della storia dell’uomo
Tra Ottocento e Novecento : le reazioni al positivismo e la crisi delle scienz
- La reazione anti – positivista
- Caratteri generali dello spiritualismo
H.Bergson
- Vita e scritti
- Tempo e durata e l’origine di tali concetti
- La polemica con Einstein ( video You- tube)
- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo
- Lo slancio vitale
- Istinto, intelligenza e intuizione,Società, morale e religione
Letture dal testo: T1 “ La libertà come espressione dell’io”
T2 “ Lo slancio vitale”
F.W.Nietzsche:
- la vita e gli scritti
- filosofia e malattia
- nazificazione e denazificazione
- le caratteristiche del pensiero e della scrittura
- le fasi del filosofare nietzscheano: il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco; rapporto con
Schopenhauer e Wagner: la storia
il periodo illuministico e la “ morte di Dio”
il periodo di Zarathustra – il superuomo, l’eterno ritorno,
67
il periodo finale: la morale, la volontà di potenza, il nichilismo; il prospettivismo.
Letture dal testo: T1 “ Apollineo e dionisiaco”; T1 “Il superuomo e la fedeltà
alla terra”; T2 “ La morale dei signori e quella degli schiavi”.
* Dopo il 15 maggio, compatibilmente con il tempo a disposizione, si effettuerà il ripasso.
Esperienze
16 /9 / 2016
FESTIVAL DELLA FILOSOFIA – MODENA – TEMA : AGONISMO
LEZIONI MAGISTRALI SEGUITE E POI COMMENTATE IN CLASSE
LEVIATANO di Hobbes, docente G. Marramao, prof Filosofia teoretica , Roma
COSTRUIRE LA PACE, docente A.Riccardi, prof . Storia contemporanea, Roma
Marzo - Aprile 2017 : J. Dewey: CLIL module – Prof Manzi Maurizia
Criticism of the tradizional notion of true, theory of instrumentalism, how we think: analysis of a complete act of
thought
TEXTS
- “Finding one's way, an allustration of reflection”, J. Dewey, How we think, pag 10-11
- “The three cases from a series, logical consideration”, J. Dewey, How we think, pag 68-71
https://www.youtube.com/watch?v=wMh1LYuZ3B4 A.G.Rud, Washington State University teacher, introduces J.
Dewey, philosopher of democracy and his importance to education
Resources and materials:
adapted materials, handout, power point presentation, internet
Activity types:
-reading: match paragraphs with title, order paragraphs, fill in a grid, fill in the gaps
- listening: open ended questions, true/false, rearrange information, fill in the gaps
- speaking: question loops, word guessing game, our CLIL dictionary, presentations
- writing: fill in the gaps using the words in the box, sum up text by writing headlines for each paragraph, linking
sentences, word scramble
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.ssa Colangelo Maria Antonella
____________________________________
Gli studenti
_______________________
_______________________
68
STORIA,
DOCENTE:
Guagliano Fiona
RELAZIONE FINALE
OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE
Rielaborare oralmente il contenuto della storia mettendo in evidenza le cause dei vari avvenimenti;
Cogliere i nessi tra la realtà contemporanea e i vari fatti storici;
Sviluppare una certa competenza nella rielaborazione schematica dei contenuti;
Educare al rispetto della libertà dell’altro e delle regole della convivenza civile;
Educare alla partecipazione attiva e responsabile alle attività didattiche;
Favorire l’autonomia dei singoli nell’organizzazione del lavoro personale e di gruppo;
Far comprendere agli alunni il valore delle conoscenze storiche indispensabili per la formazione dell’uomo e del suo
senso civico;
Far capire che la conoscenza del passato è indispensabile per comprendere i molteplici aspetti della realtà attuale e
per avere con questa un approccio più consapevole e critica.
Obiettivi cognitivi:
• Conoscere la sequenza degli avvenimenti dall'Unità d'Italia fino al secondo dopoguerra;
Saper leggere uno schema storico;
Orientarsi con chiarezza nello spazio e nel tempo;
Continuare a instaurare relazioni esatte tra dati, concetti e fenomeni;
Trovare analogie e differenze, elementi di rottura e continuità tra i vari fenomeni storici;
Riuscire ad effettuare collegamenti in termini diacronici con le conoscenze acquisite attraverso lo studio di altre
materie.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Area Cognitiva: la maggior parte degli alunni ha compreso nel complesso gli eventi storici affrontati durante l’anno,
nonché le cause che li hanno determinati e le conseguenze che hanno avuto nel determinarne altri o nell’impatto
sociale. Non tutti sono però autonomamente critici nei confronti degli argomenti studiati.
Sapere: la maggior parte degli alunni si orienta nello spazio e nel tempo, ricorda gli avvenimenti principali e i loro
protagonisti.
Saper fare: la maggior parte della classe riesce a operare confronti e collegamenti anche con le altre materie,
nell’ambito dello stesso periodo storico. Tuttavia, spesso, tali collegamenti vanno sollecitati dall’insegnante.
Competenze: Gli alunni sono stati in grado di cogliere le differenze tra le epoche storiche, cominciando ad operare
confronti con l’attualità e hanno sviluppato attraverso lo studio del passato maggiore consapevolezza civica .
Area Socio-affettiva: la classe risulta nel complesso omogenea e le relazioni tra gli alunni sono abbastanza solidali
CONSIDERAZIONI
Gli obiettivi iniziali sono stati quasi del tutto conseguiti, in quanto gli alunni hanno raggiunto generalmente un'ottima
comprensione degli eventi storici. Qualche alunno ha avuto difficoltà a comprendere alcune dinamiche storiche, ma
nel complesso le conoscenze essenziali risultano ben assimilate. E’ stato tuttavia difficile stimolare una discussione
critica e consapevole, che portasse a confronti diacronici, salvo in quegli alunni interessati alla materia e dotati di
forte spirito critico.
Nello studio della materia l'attenzione non si è concentrata sulle singole nozioni, ma sulle dinamiche generali, con
particolare attenzione all'aspetto umano e sociale dello sviluppo storico, operato attraverso riflessioni critiche.
69
SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
Il programma risulta in linea con le altre quinte. Impossibile completare le linee guida ministeriali, avendo la materia
subito una decurtazione del monte ore a fronte di un aumento degli argomenti.
VERIFICHE
Le verifiche sono state minimo due per quadrimestre, con voti orali e verifiche scritte, nella tipologia di test o
domande aperte.
Ai fini della valutazione, tuttavia, la docente ha tenuto conto anche della partecipazione attiva al dibattito storico.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono stati quelli indicati dal PTOF.
PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione: La torre e il pedone. F.M. Feltri, M.M.Bertazzoni, F. Neri- La torre e il pedone ” S.E.I. vol.3°.
_________________________________________
I problemi del nuovo Stato in Italia (1861-1890)
I primi quindici anni: il governo della Destra storica
Gli anni della Sinistra storica al governo
Documenti: le condizioni di vita degli operai nella seconda metà dell'Ottocento
La guerra al brigantaggio
Gli anni Novanta in Italia
Il governo Crispi tra tensioni e tumulti sociali
Colonialismo e crisi di fine secolo
Approfondimento: Educare i nuovi italiani- "Cuore" e "Pinocchio"
Rai storia: video sul brigantaggio
L'Italia nell'età giolittiana
La strategia politica di Giolitti
Lo sviluppo industriale in Italia
La guerra di Libia
La riforma elettorale e il Patto Gentiloni
Le origini del conflitto
Guerre e alleanze a fine Ottocento
L'Europa verso la guerra ( tranne la polveriera balcanica)
L'inizio delle ostilità: le azioni politiche
La prima fase dello scontro
Guerra di logoramento e guerra totale
La guerra di trincea.
Le grandi battaglie del 1916
La prosecuzione della guerra
Intervento americano e sconfitta tedesca
L’intervento americano
La fine del conflitto.
L’Italia nella grande guerra
La scelta della neutralità
I sostenitori dell’intervento
70
Un nuovo stile politico
Il Patto di Londra
Il fronte italiano
Da Caporetto alla vittoria
Rai storia: Wilson e i 14 punti
Sussidio audiovisivo: "La grande guerra" - Piero e Alberto Angela
Il comunismo in Russia
Le due rivoluzioni del 1917
La Russia, un Paese arretrato
La rivoluzione di febbraio ( tranne l'ordine n.1)
La questione del potere ( tranne "Un'epoca adatta per la rivoluzione")
Lenin e le tesi di aprile
Il pensiero politico di Lenin
Le prime fasi della rivoluzione d’ottobre
Comunismo di guerra e Nuova politica economica
La guerra civile
Il comunismo di guerra e l’internazionale comunista
Malcontento diffuso e Nuova politica economica ( escluso la lotta a ogni dissenso)
Sussidio audiovisivo: dvd la Rivoluzione russa - Focus storia
Stalin al potere
La lotta per la successione e le prime misure economiche di Stalin
La violenza staliniana
Documento: "Dimensioni e caratteri della violenza staliniana"
L’Italia dopo la prima guerra mondiale
Le delusioni della vittoria
La tensione politica del dopoguerra
Il movimento fascista
Benito Mussolini e i primi passi del fascismo
Il fascismo da movimento a partito (tranne Giolitti e la speranza di addomesticare il fascismo)
Il fascismo al potere
Lo Stato fascista
La distruzione dello Stato liberale
La costruzione dello Stato totalitario
Il fascismo e la questione della razza
La Repubblica di Weimar
La Germania dopo la guerra
Le difficoltà del nuovo Stato tedesco
Adolf Hitler
Il razzismo di Hitler e il Mein Kampf
Hitler al potere
Hitler diventa cancelliere
Da Stato democratico a regime totalitario
Il regime nazista
Verso la guerra
71
La situazione politica internazionale negli anni Venti e Trenta ( tranne "I confini orientali e il trattato di Locarno ")
La politica estera tedesca negli anni 1937-38
I successi tedeschi ( 1939- 1942)
Lo scoppio della guerra
Anno di guerra 1940
L’invasione tedesca dell’URSS
La guerra globale ( 1942-1945)
L’entrata in guerra degli Stati Uniti
Le difficoltà della Germania
Le conferenze di Casablanca e di Teheran
La sconfitta della Germania
La sconfitta del Giappone
L’Italia nella seconda guerra mondiale
La scelta di entrare in guerra_ Approfittare della vittoria tedesca
La guerra in Africa e in Russia
Il fronte interno
Lo sbarco alleato e la caduta del fascismo
La fine del Ventennio
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione
La Repubblica sociale italiana ( tranne l’atteggiamento dei partiti italiani)
Il movimento della Resistenza
Approfondimento: "Diagnosi dei dittatori"( Jung parla- interviste e incontri- Adelphi 1995)
L’ordine bipolare
1945: accordi tra le nazioni vincitrici
La nascita dei blocchi
Il blocco americano
Il blocco sovietico ( tranne l'acuirsi de i contrasti)
Gli USA e la presidenza di Kennedy
La rivoluzione di Cuba
La fine della guerra fredda
La nascita della repubblica
Dalla liberazione al referendum
Approfondimenti svolti singolarmente dagli alunni e presentati alla classe:
"Cinema e teatro e caccia alle streghe"
"La guerra civile spagnola"
" La Sardegna nella Grande Guerra"
" la persecuzione degli Ebrei"
"Shoà e identità di genere "
" Il ghetto di Terezin"
"L'America latina"
"i processi contro i criminali nazisti"
" Uomini e donne nel movimento fascista"
" Le deportazioni in Italia"
" Il movimento giovanile tedesco"
" La lotta per i diritti civili"
" Le origini dell'ideologia fascista"
72
" La prima guerra mondiale nel Basso Lazio"
" Eliminare il nemico- le dinamiche della violenza"
" Dio dopo Auschwitz"
" Il genocidio degli Armeni"
" La bomba atomica"
" Individuo e società"
" Guerra e identità di genere in Italia"
" La violenza fascista in Etiopia"
" La battaglia di Stalingrado"
" Guerra e identità di genere"
" Il secolo dell'immagine"
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.ssa Guagliano Fiona
____________________________________
Gli studenti
_______________________
_______________________
73
MATEMATICA,
DOCENTE:
Perotti Martia Rita
RELAZIONE FINALE
La classe ha partecipato al lavoro con grande serietà e impegno collaborando con l’insegnante anche laddove gli
argomenti si dimostravano più ostici e complessi.
Permangono ancora alcune difficoltà da parte di un piccolo gruppo della classe dovute al difficile rapporto nei
confronti dell’ambito scientifico
Gli obiettivi posti dal corso di studi sono i seguenti:
(1) conoscenza di massima del programma di analisi matematica,
(2) acquisizione delle tecniche di calcolo,
(3) applicazione delle regole e capacità di analizzare in maniera critica i procedimenti seguiti ed i risultati ottenuti,
(4) ottenimento di una visione di insieme del percorso fatto nell’intero corso di studi.
Per quanto riguarda la metodologia, invece, si è stabilito di procedere in modo induttivo: dopo una introduzione di
tipo intuitivo dell’argomento, arricchita di numerosi esempi, si è passati alla formulazione rigorosa:
I teoremi sono stati solo enunciati tralasciando la corrispondente dimostrazione, per ottenere una esposizione più
agile e scorrevole.
PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione: Bergamini M.-Trifone A.-Barozzi G. “Matematica.Azzurro” Vol.5 Zanichelli
Argomenti effettivamente svolti e Autori:
RIPASSO DI GONIOMETRIA
INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI
Definizione di intervallo
Definizione di intorno
Definizione di funzione reale di una variabile reale
Definizione di dominio e di codominio
Definizione di grafico di una funzione
Definizione di funzione pari e funzione dispari
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo
Classificazione di una funzione
Determinazione del dominio di funzioni algebriche e trascendenti
Determinazione dei punti di intersezione di una funzione algebrica con gli assi cartesiani
Studio del segno di funzioni algebriche
LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito
Limite infinito per x che tende all’infinito
Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato)
Teorema della permanenza del segno (solo enunciato)
Teorema del confronto (solo enunciato)
Teoremi sul calcolo dei limiti (solo enunciati)
Limiti notevoli:
e
.
Forme indeterminate e loro semplici risoluzioni
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
Definizione di punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
Teorema degli zeri (solo enunciato)
Teorema di Weierstrass (solo enunciato)
74
Teorema dei valori intermedi (solo enunciato)
Ricerca degli asintoti di una curva
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Il problema della tangente ad una curva come problema che conduce al calcolo della derivata
Rapporto incrementale
Definizione di derivata di una funzione in un punto e in un intervallo.
Significato geometrico di derivata, determinazione della tangente in un punto.
Derivate fondamentali.
Regole di derivazione.
Derivabilità.
Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale).
Crescenza e decrescenza di una curva.
Teorema di Lagrange (solo enunciato)
Teorema di Rolle (solo enunciato)
Teorema di Cauchy (solo enunciato)
Teorema De L’Hospital (solo enunciato)
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti,
Punti di flesso e concavità..
Studio del grafico di funzioni, soprattutto razionali fratte.
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.ssa Perotti Maria Rita
____________________________________
Gli studenti
_______________________
_______________________
75
STORIA DELL’ARTE,
DOCENTE:
Barone Sonia
RELAZIONE FINALE
L’insegnamento di “Storia dell’arte” è triennale e la mia attività didattica con la classe 5^C S.U. è stata svolta a partire
dalla classe Quarta. Il dialogo educativo e l’impianto didattico hanno seguito un iter “regolare”, caratterizzato dalle
consuete fasi di avvio e consolidamento del rapporto discente/docente (conoscenza reciproca, precisazione e
perfezionamento dei metodi di studio).
Un aspetto problematico è correlato al programma in quanto sarebbe stato auspicabile iniziare dal Neoclassicismo,
in realtà, considerando la vastità dello stesso programma distribuito in soli tre anni e in due ore settimanali, le lezioni
a settembre sono iniziate dalla pittura veneta del Cinquecento, pertanto è stata operata una selezione per poter
raggiungere le Avanguardie del Novecento.
Il viaggio d’istruzione di novembre, che ha avuto tra le principali tappe Barcellona e Figueres, ha richiesto di
anticipare alcuni argomenti, quali la “Sagrada Familia” di Antoni Gaudí (non presente nel libro di testo), cenni a
Picasso e al Surrealismo di Salvator Dalí.
L’esperienza di un’uscita didattica nel mese di marzo a Milano per visitare il Museo del Novecento è stata utile per
affrontare le Avanguardie storiche, poiché il rapporto diretto con le opere ha suscitato interesse e ha permesso di
riprendere gli argomenti fidando su una maggiore consapevolezza degli studenti.
Il metodo di lavoro ha utilizzato la lezione frontale, sempre accompagnata dalla videoproiezione delle opere, per far
esercitare gli allievi ad effettuare le analisi attraverso l’osservazione attenta e la comparazione.
L’attività didattica ha insistito sul conseguimento di diversi obiettivi, in particolare una decodificazione non
superficiale e ovvia delle immagini, l’adeguata conoscenza del lessico tecnico e critico, l’individuazione delle
caratteristiche dell’opera d’arte in rapporto al contesto storico-culturale, la capacità di utilizzare la conoscenza dei
diversi stili per effettuare correlazioni e confronti, l’acquisizione della consapevolezza del valore del patrimonio
artistico nella società.
Parte della classe, in possesso di un metodo di studio autonomo, ha dimostrato un atteggiamento collaborativo e ha
raggiunto tali obiettivi in modo sicuro, alcune studentesse anche con esiti eccellenti. Altri hanno lavorato inizialmente
affidandosi soprattutto a quanto appreso durante le lezioni e, dopo essere stati indirizzati verso un metodo più
strutturato e approfondito, hanno raggiunto gli obiettivi elencati con una padronanza soddisfacente. Un piccolo
gruppo nella prima parte dell’anno scolastico ha evidenziato un’applicazione discontinua e qualche studentessa ha
manifestato difficoltà nel seguire le indicazioni di metodo ma in seguito hanno lavorato con maggiore
consapevolezza.
PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione verde, vol. II e vol. III, Zanichelli.
IL RINASCIMENTO. L’ESPERIENZA VENEZIANA (Vol. 2°)
TIZIANO (in continuità al programma interrotto nell’a.s. 2015-2016)
Analisi di: Paolo III Farnese con i nipoti; La Pietà.
IL MANIERISMO
Caratteri generali (pp. 640-641).
GIAMBOLOGNA: Il ratto della Sabina (p. 655).
IL SEICENTO E L’ETÀ BAROCCA
I caratteri del BAROCCO.
CARAVAGGIO: formazione, caratteristiche stilistiche.
Analisi di: Canestra di frutta; Vocazione di San Matteo; Crocifissione di San Pietro; Morte della
Vergine.
GIAN LORENZO BERNINI: formazione, caratteristiche stilistiche.
Analisi di: Apollo e Dafne; Cappella Cornaro ed Estasi di Santa Teresa.
F. BORROMINI: formazione, caratteristiche stilistiche.
Analisi di: Chiostro e Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma.
76
VERSO IL SECOLO DEI LUMI
IL ROCOCÒ: caratteristiche (p. 471).
G. B. TIEPOLO: formazione, caratteristiche stilistiche; il quadraturismo.
Analisi: Banchetto di Antonio e Cleopatra.
Il vedutismo: A. CANALETTO, Il Canal Grande verso Est.
NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO (Vol. 3°)
I caratteri del Neoclassicismo (pp.780-785).
A. CANOVA: formazione, caratteristiche stilistiche, la tecnica scultorea.
Analisi di: Amore e Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.
J. L. DAVID: formazione.
Analisi di: Giuramento degli Orazi; La morte di Marat.
F. GOYA: Il sonno della ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio sulla montagna del Principe
Pio.
I caratteri del Romanticismo. Il sublime (pp. 838-842).
T. GÉRICAULT: formazione.
Analisi di: La zattera della Medusa.
E. DELACROIX: formazione.
Analisi di La Libertà che guida il popolo.
REALISMO
LA SCUOLA DI BARBIZON: caratteri generali (p. 872).
Analisi di: Tramonto nella foresta di P.E.T. Rousseau.
G. COURBET: formazione, caratteristiche stilistiche.
Analisi di: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore.
IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI: storia, protagonisti, soggetti, peculiarità stilistiche.
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA
La Torre Eiffel.
LA FOTOGRAFIA (pp. 907-911)
Cenni (breve storia; i fotogrammi e il movimento; le pose; il taglio fotografico; rapporti con la pittura)
E. MANET: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère.
IMPRESSIONISMO
La ville lumière, Il Cafè Guerbois, il colore locale e la tecnica, la luce, le nuove frontiere, le stampe
giapponesi, la prima mostra (pp. 899-905).
C. MONET: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: Impressione, sole nascente; La serie di La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle
ninfee; La Grenouillère.
P. A. RENOIR: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri.
E. DEGAS: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: La lezione di danza; L’assenzio.
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE: caratteri generali (pp. 941-942).
P. CÉZANNE: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire vista dai
Lauves.
G. SEURAT e il Pointillisme: l’artista (formazione, peculiarità tecniche e stilistiche).
Analisi delle opere: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte; Il circo.
P. GAUGUIN: formazione, peculiarità stilistiche. Cloisonnisme e Sintetismo.
Analisi delle opere: L’onda; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.
V. VAN GOGH: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Veduta di Arles con
iris in primo piano; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi.
IL DIVISIONISMO ITALIANO: cenni.
77
G. PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato.
L’ART NOUVEAU NELLE SUE DECLINAZIONI (pp. 978-980)
G. KLIMT: formazione.
Analisi delle opere: Giuditta I; Giuditta II; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Danae; La culla.
A. GAUDÌ: La Sagrada Família.
E. MUNCH: formazione, peculiarità stilistiche (pp. 1002-1003).
Analisi: Il grido.
L’ESPRESSIONISMO
ESPRESSIONISMO FRANCESE (Fauves): storia e caratteristiche.
H. MATISSE: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: Lusso, calma e voluttà; La stanza rossa; La danza.
ESPRESSIONISMO TEDESCO (Die Brücke): storia e caratteristiche.
E. L. KIRCHNER: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: Due donne per strada; Cinque donne per la strada; Autoritratto in divisa.
CUBISMO
Caratteri generali; “Cubismo analitico” e “Cubismo sintetico”. Tecniche.
P. PICASSO: formazione, peculiarità stilistiche. Periodo blu e periodo rosa.
Analisi delle opere: Les demoiselles d’Avignon (cubismo primitivo); Ritratto di Ambroise Vollard
(cubismo analitico); Natura morta con sedia impagliata (cubismo sintetico); Guernica.
LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO
Storia, obiettivi e principi (pp. 1045-1047)
U. BOCCIONI: formazione, peculiarità stilistiche.
Analisi delle opere: La città che sale; Stati d’animo: Gli addii (I versione); Gli addii (II versione); Forme
uniche della continuità nello spazio.
METAFISICA: caratteristiche generali e principi filosofici.
G. DE CHIRICO: l’artista (formazione e peculiarità).
Analisi delle opere: L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti.
Si ipotizza di svolgere, dopo il 15 maggio, i seguenti argomenti, almeno nelle linee essenziali:
Dadaismo
Surrealismo.
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.ssa Barone Sonia
____________________________________
Gli studenti
_______________________
_______________________
78
FISICA,
DOCENTE:
Lucchi Chiara
PROGRAMMA SVOLTO
TESTO IN ADOZIONE: Amaldi – Le traiettorie della fisica azzurro – Zanichelli
La luce: teoria ondulatoria e corpuscolare.
La propagazione della luce. La velocità della luce nel vuoto e nei mezzi. Indice di rifrazione
Riflessione della luce. Le leggi della riflessione. Specchi piani.
Diffusione della luce
La riflessione negli specchi curvi
La rifrazione della luce. La legge di Snell
La dispersione della luce
Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde,infrarossi, luce, ultravioletti, raggi x e raggi gamma
Carica elettrica.
Elettrizzazione per strofinio e per contatto.
Isolanti e conduttori
L'elettroscopio. La carica elettrica.
La legge di Coulomb
Elettrizzazione per induzione e polarizzazione
Campo elettrico. Vettore campo elettrico. Linee di campo.
Il campo elettrico di una carica puntiforme
Campo elettrico generato da due cariche e rappresentazione delle linee di campo.
Determinare la forza elettrica conoscendo il campo elettrico.
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana. Teorema di Gauss per il campo elettrico.
Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico.
Potenziale di terra e di massa.
Capacità di un condensatore piano.
Corrente elettrica. Definizione di intensità di corrente elettrica. Verso della corrente continua.
I circuiti elettrici. I generatori di tensione.
Le leggi di OHM. La resistenza, i resistori e la resistività.
Amperometro e voltmetro. La forza elettromotrice.
Magneti e campo magnetico.
L’esperimento di Oersted e di Faraday.
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
Forza di Ampere. Definizione di Ampere e definizione di Coulomb. Sostanze ferromagnetiche.
79
Forza di interazione fra corrente e campo magnetico.
Forza di Lorenz e aurore boreali.
Elettromagnete e magneti permanenti.
Il motore elettrico.
Corrente indotta. Forza elettromoptrice indotta.
Legge di Faraday-Newmann. Legge di Lentz.
Funzionamento dell'alternatore.
Le centrali elettriche.
Il trasformatore
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.ssa Lucchi Chiara
____________________________________
Gli studenti
_______________________
________________________
80
SCIENZE MOTORIE,
DOCENTE:
Bernardi Fabio
RELAZIONE FINALE
La scelta delle situazioni motorie è stata effettuata in modo da favorire l’acquisizione del senso di responsabilità
attraverso l’alternarsi di strategie di apprendimento più o meno strutturate. Per quanto riguarda la metodologia, le
varie attività sono state illustrate e motivate nelle loro finalità. E’ stato adottato sia il metodo globale che analitico a
seconda delle circostanze, delle situazioni e delle caratteristiche delle varie attività. Tutte le attività proposte ed i
gesti motori sono stati strutturati in modo da partire da esecuzioni semplici per divenire sempre più complesse.
STRUMENTI DI LAVORO
Tutte le attrezzature presenti nelle varie palestre; piccoli e grandi attrezzi,palloni,campo esterno,pista di atletica.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche si sono svolgeranno attraverso l’osservazione in itinere delle principali unità didattiche. Le valutazioni
terranno conto del livello di partenza, del miglioramento delle capacità motorie ed in particolare dell’impegno e della
partecipazione attiva alle lezioni pratiche. Si effettueranno verifiche orali durante le attività in palestra per valutare la
capacità di ascolto, l’interiorizzazione degli argomenti proposti e l’apprendimento della teoria e delle regole dei
principali giochi di squadra.
PROGRAMMA SVOLTO
Esercizi di tonificazione a carattere generale (corpo libero e con piccoli attrezzi)
Esercizi di tonificazione specifici per la muscolatura posturale (corpo libero e con piccoli attrezzi)
Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale, coxo-femorale e del rachide nelle sue varie porzioni
Esercizi di allungamento muscolare (con spiegazione dei principi fisiologici)
Esercizi eseguiti in corsa ed in marcia
Esercizi con piccoli attrezzi e di riporto( pesi kg1-funicelle-elastici)
GIOCHI SPORTIVI
Pallavolo: propedeutici – tecnica – semplici schemi di gioco – le regole principali
Pallacanestro: propedeutici – tecnica – semplici schemi di gioco – le regole principali
Gioco del volano: propedeutici – tecnica – le regole principali
Badminton: propedeutici introduttivi– tecnica – le regole principali
Baseball:propedeutici introduttivi– tecnica – le regole principali
Note: Tutte le attività proposte sono seguite da spiegazioni sull’intervento muscolare e sulle finalità fisiologiche.
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.Bernardi Fabio
____________________________________
Gli studenti
_______________________
_______________________
81
SCIENZE NATURALI,
DOCENTE:
Vasconi Cristina
PROGRAMMA SVOLTO
Testo utilizzato: Biologia La scienza della vita (autore Sadava. Ed Zanichelli )
IL CORPO UMANO
Capitolo 1
L’organizzazione del corpo umano
COMPETENZE
•
•
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da sistemi autonomi ma strettamente correlati
Saper mettere in relazione il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento di condizioni fisiologiche costanti
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 Il corpo umano presenta
un’organizzazione gerarchica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’organizzazione dei tessuti
La funzione degli epiteli
I principali tipi di tessuti epiteliali
La funzione del tessuto muscolare
Il tessuto muscolare liscio e striato
Le funzioni del tessuto connettivo
I connettivi propriamente detti
I connettivi specializzati
Il tessuto nervoso
•
•
•
•
•
2 Organi, sistemi
e apparati:
uno sguardo d’insieme
•
•
•
•
Gli organi e i sistemi che formano il
corpo umano
I sistemi di coordinamento del corpo
umano: nervoso ed endocrino
Le membrane interne
La cute
•
•
•
Descrivere l’organizzazione strutturale del corpo umano
Elencare i diversi tipi di sistemi che compongono l’organismo
umano indicandone le funzioni
Indicare le diverse modalità con cui il sistema nervoso e
quello endocrino garantiscono l’equilibrio interno e
l’adattamento alle condizioni ambientali
Illustrare le funzioni delle membrane interne distinguendo le
sierose da quelle mucose
Descrivere la struttura e le funzioni svolte dalla cute
Le modalità di comunicazione tra
cellule
Recettori e molecole segnale
La trasduzione del segnale
Le giunzioni serrate
•
•
•
Illustrare come si svolge la comunicazione tra cellule
Spiegare la trasduzione del segnale
Descrivere le giunzioni serrate
La capacità di rigenerazione dei
tessuti
Le cellule staminali
Le cellule tumorali
Le sostanze cancerogene
•
•
•
•
•
Distinguere i tessuti in base alla loro capacità rigenerativa
Illustrare le caratteristiche delle cellule tumorali
Distinguere i tumori benigni da quelli maligni
Spiegare che cosa s’intende per metastasi
Spiegare come agiscono le sostanze cancerogene
•
•
3 La comunicazione
tra le cellule
e la regolazione dell’attività
cellulare
•
4 Nel corpo umano
la rigenerazione
dei tessuti
è controllata
•
•
•
•
•
•
•
Descrivere l’organizzazione strutturale dei tessuti
Elencare i tipi e le rispettive funzioni dei tessuti presenti nel
corpo umano
Distinguere gli epiteli di rivestimento da quelli ghiandolari e
sensoriali
Distinguere le ghiandole esocrine da quelle endocrine
Descrivere e distinguere i tre tipi di tessuto muscolare
Classificare i tessuti connettivi in base alla loro funzione e alla
composizione della matrice
Descrivere il tessuto nervoso distinguendo i neuroni dalle
cellule gliali
82
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
5 L’omeostasi: come
mantenere costante l’ambiente
interno
•
•
•
•
Le condizioni da mantenere costanti
I meccanismi dell’omeostasi
La regolazione della temperatura
corporea
•
•
•
Capitolo 2
Elencare le variabili da mantenere costanti nel nostro
organismo
Illustrare come lavora il sistema di controllo delle variabili
Distinguere i sistemi a feedback negativo da quelli a feedback
positivo
Descrivere la regolazione a feedback negativo della
temperatura corporea
L’apparato cardiovascolare e il sangue
COMPETENZE
•
•
Comprendere il ruolo fondamentale svolto dal cuore nel sistema cardiovascolare e l’importanza di una perfetta coordinazione dei meccanismi
che lo azionano e lo regolano
Mettere in relazione l’efficienza della circolazione con il proprio stato di salute
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 L’organizzazione
dell’apparato cardiovascolare
•
•
•
•
•
Descrivere la circolazione doppia e completa
Descrivere la struttura del cuore
Distinguere le arterie dalle vene
Spiegare il percorso del sangue nel corpo umano
•
Un sistema chiuso con una doppia
circolazione
L’anatomia
dell’apparato
cardiovascolare
I movimenti del sangue
•
•
•
L’anatomia del cuore
Il ciclo cardiaco
Il battito cardiaco
•
•
Descrivere i tre strati che formano la parete del cuore
Descrivere gli eventi del ciclo cardiaco distinguendo la sistole
dalla diastole
Indicare la funzione delle valvole cardiache e i problemi
derivanti da loro malfunzionamento
Spiegare come insorge e si propaga il battito cardiaco
•
2 Il cuore è il motore
dell’apparato cardiovascolare
•
•
3 I vasi sanguigni
e il movimento
del sangue
•
•
•
Struttura e funzione delle arterie
I capillari
Struttura e funzione delle vene
•
•
•
Descrivere la struttura delle arterie e delle vene in relazione
alle loro rispettive funzioni
Descrivere la rete capillare correlandola con gli scambi
effettuati tra il sangue in essa contenuto e le cellule
Evidenziare i meccanismi che consentono al sangue di
ritornare al cuore
4 I meccanismi
di scambio
e la regolazione
del flusso sanguigno
•
•
•
Gli scambi nei capillari
La funzione delle arteriole
Il controllo del flusso sanguigno
•
Indicare le sostanze che attraversano liberamente la parete
dei capillari
5 La composizione
e le funzioni
del sangue
•
•
•
•
Gli elementi figurati e il plasma
Gli eritrociti
I leucociti
Le piastrine
•
•
•
•
•
Elencare gli elementi figurati e le loro rispettive funzioni
Descrivere la composizione del plasma e le sue funzioni
Descrivere gli eritrociti e il trasporto dei gas respiratori
Distinguere i diversi tipi di leucociti e le rispettive funzioni
Spiegare il processo di coagulazione del sangue
Capitolo 3
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi
COMPETENZE
•
Comprendere le relazioni tra le strutture e le funzioni delle diverse parti dell’apparato respiratorio
83
•
Saper mettere in relazione le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato cardiovascolare comprendendo la stretta
interdipendenza di questi due apparati
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 L’organizzazione e la
funzione dell’apparato
respiratorio
•
•
•
•
•
Distinguere l’inspirazione dall’espirazione
Spiegare gli scambi gassosi a livello polmonare e dei tessuti
Descrivere i diversi tratti dell’apparato respiratorio
Spiegare le relazioni anatomiche e funzionali tra la cavità
toracica, la cavità pleurica e i polmoni
•
Spiegare come varia la pressione nella ventilazione
polmonare
Spiegare come il sistema nervoso centrale controlla il normale
alternarsi di inspirazioni ed espirazioni
Evidenziare la stretta relazione tra sistema nervoso, recettori,
apparato cardiovascolare e respiratorio per garantire un
adeguato apporto di ossigeno ai tessuti
•
•
2 La meccanica della
respirazione: la ventilazione
polmonare
•
•
•
I due processi della respirazione
polmonare
L’anatomia dell’apparato respiratorio
umano
Le relazioni tra polmoni e cavità
toracica
Inspirazione ed espirazione
Le secrezioni del tratto respiratorio
Il controllo della ventilazione
•
•
3 Il sangue
e gli scambi
dei gas respiratori
•
•
•
•
•
•
Scambi gassosi per diffusione
Lo scambio polmonare dei gas
Lo scambio sistemico dei gas
Il trasporto dell’ossigeno
Il trasporto del diossido di carbonio
La mioglobina
•
•
•
•
•
4 la respirazione cellullare
Capitolo 4
Descrivere come i gas respiratori passano dall’aria al sangue
e viceversa
Descrivere gli scambi gassosi a livello dei tessuti
Spiegare come viene trasportato l’ossigeno nel sangue
Spiegare come viene trasportato il diossido di carbonio nel
sangue
Illustrare il ruolo della mioglobina nei muscoli
Glicolisi
Ciclo di krebs
Catena degli elettroni
Descrivere la relazione tra respirazione interna ed
esterna
L’apparato digerente e l’alimentazione
COMPETENZE
•
•
Comprendere che il processo digestivo ha la funzioni elaborare gli alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule
Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato digerente con le rispettive funzioni
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 L’organizzazione e la
funzione dell’apparato
digerente
•
•
•
•
•
•
Le fasi della trasformazione del cibo
Lo scopo della digestione
I nutrienti essenziali
I macronutrienti e i micronutrienti
Le vitamine
L’organizzazione
dell’apparato
digerente
L’anatomia dell’apparato digerente
•
•
•
La digestione in bocca
La digestione nello stomaco
Il passaggio del chimo nell’intestino
tenue
•
•
•
2 Dalla bocca
allo stomaco:
le prime fasi
della digestione
•
•
•
•
•
•
•
Descrivere le diverse fasi della trasformazione del cibo
Spiegare a che cosa serve la digestione
Individuare tra le sostanze presenti nel cibo quelle
indispensabili per il corpo umano
Distinguere il ruolo svolto da minerali e vitamine da quello di
carboidrati, proteine e lipidi
Descrivere la struttura della parete del canale alimentare e i
diversi tratti dell’apparato digerente
Descrivere le fasi della digestione che si svolgono in bocca
Descrivere la struttura dello stomaco elencando i secreti
prodotti dalle fossette gastriche
Spiegare le funzioni dell’acido cloridrico, della pepsina e del
muco
Descrivere il passaggio del chimo dallo stomaco all’intestino
tenue
84
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
3 L’intestino lavora
in sinergia
con il pancreas
e il fegato
•
•
•
•
•
•
•
La digestione nell’intestino tenue
Struttura e funzione digestiva del
fegato
Le altre funzioni del fegato
Il pancreas ghiandola esocrina ed
endocrina
L’assorbimento all’interno dell’intestino
tenue
Struttura e funzioni dell’intestino
crasso
•
•
•
•
•
•
4 Il controllo
della digestione
e il metabolismo
Capitolo 5
•
Il controllo della digestione da parte
del sistema nervoso e di ormoni
Il controllo della glicemia
•
•
•
Illustrare i processi digestivi che si svolgono nell’intestino
tenue
Descrivere la struttura e funzioni del fegato e le funzioni della
bile
Distinguere le LDL dalle HDL evidenziando il loro ruolo nella
regolazione del colesterolo
Descrivere il pancreas e la funzione delle sostanze che
produce
Distinguere tra le diverse modalità di assorbimento delle
sostanze nutritive
Descrivere la struttura dell’intestino crasso e le funzioni della
flora batterica intestinale
Spiegare come il sistema nervoso intrinseco coordina le
attività del tratto digestivo
Spiegare come agiscono secretina, colecistochinina e gastrina
Spiegare come la parte endocrina del pancreas regola la
glicemia
L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino
COMPETENZE
•
•
Comprendere la complessità e l’importanza per la salute dei meccanismi messi in atto dai reni per mantenere l’equilibrio idrosalino e per
eliminare i rifiuti metabolici azotati
Saper mettere in relazione i diversi tratti del nefrone con le rispettive funzioni
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 L’organizzazione
e le funzioni dell’apparato
urinario
•
Gli organi che formano l’apparato
urinario
Le funzioni dei reni
L’equilibrio idrico e salino
L’eliminazione delle sostanze azotate
•
•
•
•
•
•
•
•
La struttura del rene
Il glomerulo e la capsula di Bowman
Il tubulo renale
I capillari peritubolari
Le tre tappe della formazione
dell’urina
•
•
•
La regolazione della concentrazione
dei liquidi corporei
La moltiplicazione controcorrente
Lo scambio controcorrente
Il mantenimento dell’equilibrio acidobase nel sangue
•
2 Il nefrone
è l’unità funzionale
del rene
3 I nefroni modulano la loro
attività in relazione alle
esigenze dell’organismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 I meccanismi
che regolano
le funzioni dei reni
•
•
•
I fattori che influenzano la filtrazione
glomerulare
Gli effetti di angiotensina e
aldosterone
L’ormone antidiuretico
•
•
•
Descrivere la struttura dell’apparato urinario
Elencare i processi che portano alla formazione dell’urina
Spiegare perché il controllo dell’equilibrio idrico è legato al
controllo della concentrazione salina
Individuare nell’urea il catabolita azotato eliminato dai reni
umani
Descrivere la struttura del rene
Mettere in relazione le diverse parti del nefrone con le
rispettive funzioni
Descrivere i processi che dal filtrato glomerulare portano alla
formazione dell’urina
Spiegare cosa si intende per osmolarità e come viene
regolata
Spiegare il meccanismo della moltiplicazione controcorrente
Elencare i vantaggi della moltiplicazione controcorrente
Mettere in relazione lo scambio controcorrente con il gradiente
osmotico verticale
Spiegare in che modo i reni controllano il pH del sangue
Elencare i fattori che influenzano la velocità di filtrazione
glomerulare
Spiegare come agiscono gli ormoni angiotensina e
aldosterone
Spiegare come l’ADH regola la pressione sanguigna e
85
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
l’osmolarità del sangue
Capitolo 6
Il sistema linfatico e l’immunità
COMPETENZE
•
•
Acquisire le informazioni essenziali per comprendere l’importanza della tutela della propria salute, nonché la complessità dei meccanismi messi
in atto dal nostro corpo per combattere le malattie
Comprendere l’importanza per il corpo umano di mettere in atto meccanismi in grado di operare una precisa distinzione tra self e non self
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 Il sistema linfatico e gli
organi linfatici sono importanti
per la difesa
immunitaria
•
L’immunità innata e l’immunità
adattativa
I vasi linfatici e i linfonodi
Gli organi linfatici primari e secondari
•
•
2 L’immunità innata:
la prima linea
di difesa dell’organismo
•
•
Le barriere superficiali
Le difese aspecifiche cellulari e
chimiche
L’infiammazione
•
Il processo di riconoscimento degli
antigeni
I recettori antigenici
La selezione clonale
I linfociti T e i linfociti B
•
•
•
•
•
•
3 I linfociti: responsabili
dell’immunità adattativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 La risposta immunitaria
umorale
•
•
La risposta immunitaria primaria
Gli anticorpi
•
•
•
5 La risposta immunitaria
cellulare
•
•
Distinguere il self dal non-self
Spiegare come l’organismo riconosce gli antigeni
Mettere in relazione la varietà dei determinanti antigenici con
la variabilità genetica
Spiegare come si formano i linfociti per selezione clonale
distinguendo le cellule effettrici dalle cellule della memoria
Distinguere l’immunità umorale dall’immunità cellulare
Spiegare la sequenza di passaggi che dà luogo alla risposta
primaria
Descrivere la struttura degli anticorpi
Spiegare come gli anticorpi neutralizzano gli antigeni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La risposta immunitaria secondaria
L’immunità acquisita
I vaccini
Le vaccinazioni
L’immunità passiva
•
•
•
•
Spiegare come si acquisisce la memoria immunologica
Spiegare perché la risposta secondaria è più rapida di quella
primaria
Distinguere tra immunità attiva e passiva
Spiegare come agiscono i vaccini
•
Le allergie
•
Definire gli allergeni
•
7 Che cosa succede quando
Descrivere i sistemi di difesa costituiti dalla cute, dalle
membrane e dai loro secreti
Elencare le difese aspecifiche di natura chimica e cellulare
Descrivere il processo infiammatorio evidenziando il ruolo
della febbre e dell’istamina
I linfociti T helper e citotossici
Le proteine MHC di classe I e di
classe II
Il ruolo delle proteine MHC II e dei
linfociti T helper nella risposta
umorale
Il ruolo delle proteine MHC I e dei
linfociti T citotossici nella risposta
cellulare
La tolleranza nei confronti del self
•
6 La memoria immunologica
Distinguere l’immunità innata da quella adattativa
Descrivere il sistema linfatico distinguendo i vasi linfatici dai
linfonodi
Differenziare gli organi linfatici in primari e secondari
•
•
•
Distinguere i linfociti T helper dai citotossici
Distinguere le proteine MHC di classe I da quelle di classe II
Individuare nelle proteine MHC le strutture in grado di
presentare gli antigeni
Spiegare come i linfociti T helper intervengono nell’attuazione
dell’immunità umorale
Spiegare come i linfociti T citotossici riconoscono e
contribuiscono ad eliminare le cellule infettate da virus e le
cellule tumorali
Spiegare i rapporti tra proteine MHC e trapianti di organi
86
PARAGRAFI
CONOSCENZE
l’immunità non funziona?
•
Immunodeficienze
autoimmuni
ABILITÀ
e
malattie
•
•
•
Capitolo 7
Distinguere tra ipersensibilità immediata e ritardata
Descrivere le immunodeficienze primarie distinguendole dalle
malattie autoimmuni
Elencare le più comuni malattie autoimmuni
Il sistema endocrino
COMPETENZE
•
Comprendere l’importanza degli ormoni per controllare, modulare e integrare le funzioni del corpo umano in risposta alle variazioni
dell’ambiente interno ed esterno
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 L’organizzazione
e la funzione
del sistema endocrino
•
•
•
•
•
•
•
•
Gli ormoni come messaggeri chimici
La natura chimica dei diversi ormoni
Ormoni idrosolubili e liposolubili
Ghiandole e cellule secretrici
Il controllo a feedback della
secrezione ormonale
•
•
•
•
2 L’integrazione
tra funzioni nervose
ed endocrine avviene
a livello dell’ipofisi
e dell’ipotalamo
•
Descrivere le caratteristiche di un ormone
Distinguere le cellule endocrine dalle cellule bersaglio
Distinguere tra ormoni peptidici, ormoni steroidei e ormoni
derivati da amminoacidi
Spiegare il meccanismo d’azione degli ormoni idrosolubili e di
quelli liposolubili
Descrivere le ghiandole endocrine
Elencare le ghiandole endocrine del corpo umano
associandole alle rispettive funzioni
Spiegare come viene regolata la secrezione ormonale
distinguendo la regolazione a feedback negativo da quella a
feedback positivo
•
•
•
•
Il rilascio di ADH e ossitocina da
parte della neuroipofisi
Gli ormoni prodotti dall’adenoipofisi
Gli ormoni ipotalamici
3 Tiroide
e paratiroidi regolano
il metabolismo
e l’omeostasi
•
•
•
•
La struttura della tiroide
L’ormone tiroideo
Calcitonina e paratormone
La vitamina D
•
4 Il pancreas endocrino
e il controllo
della glicemia
•
•
La struttura del pancreas
L’insulina e il glucagone
•
•
Descrivere la struttura del pancreas endocrino
Spiegare come avviene, per opera di insulina e glucagone, la
regolazione della glicemia
5 Il surrene
è costituito
da due ghiandole endocrine
distinte
•
•
•
Le ghiandole surrenali
Adrenalina e noradrenalina
Glucocorticoidi,
mineralcorticoidi,
steroidi sessuali
•
Descrivere le ghiandole surrenali, distinguendo tra regione
midollare e corticale
Spiegare gli effetti differenti dell’adrenalina su diverse cellule
bersaglio
Descrivere le azioni delle tre classi di ormoni steroidei prodotti
dalla corticale surrenale
6 Le gonadi producono
ormoni sessuali
•
•
•
•
•
•
La determinazione dei caratteri
sessuali primari e secondari
•
•
Descrivere le azioni dell’ADH e dell’ossitocina
Elencare gli ormoni secreti dall’adenoipofisi distinguendo le
tropine dagli ormoni ad azione diretta
Spiegare le relazioni tra ipotalamo e ipofisi
Descrivere la tiroide, gli ormoni da essa secreti e le relazioni
con ipotalamo e ipofisi
Spiegare come l’ormone tiroideo regola il metabolismo
Spiegare come calcitonina e paratormone interagiscono per
regolare la concentrazione del calcio nel sangue assieme alla
vitamina D
Elencare gli ormoni prodotti dalle gonadi maschili e femminili
Distinguere i caratteri sessuali primari da quelli secondari,
87
PARAGRAFI
CONOSCENZE
•
•
•
7 Come funzionano l’apparato
riproduttore maschile
e femminile?
•
•
•
•
•
Capitolo 9
Ormoni
sessuali
e
sviluppo
embrionale
Ormoni sessuali e cambiamenti
puberali
Gli ormoni prodotti dall’epifisi e dal
timo
Il controllo ormonale dell’attività
sessuale
Il controllo ormonale nel maschio
Il ciclo ovarico e il ciclo uterino
Il controllo ormonale del ciclo
femminile
L’età fertile femminile
ABILITÀ
•
•
•
•
•
•
associandoli agli ormoni che li determinano
Spiegare come gli androgeni inducono il differenziamento
embrionale in senso maschile
Mettere in relazione l’azione degli ormoni ipofisari con lo
sviluppo in età puberale
Descrivere gli effetti della melatonina nella regolazione dei
ritmi biologici
Individuare gli ormoni ipofisari e ipotalamici che controllano la
produzione sia degli ormoni femminili sia di quelli maschili
Descrivere gli effetti del testosterone a partire dalla pubertà
Spiegare il significato del termine menopausa
Il sistema nervoso
COMPETENZE
•
•
•
Comprendere come il sistema nervoso controlla, modula e integra le funzioni del corpo umano in risposta alle variazioni dell’ambiente interno
ed esterno
Saper riconoscere nell’encefalo e, in particolare, nella corteccia cerebrale una struttura sofisticata, sede delle capacità mentali come la memoria
e il ragionamento
Comprendere che anche piccole alterazioni nel funzionamento dell’encefalo possono provocare notevoli anomalie sia fisiche sia
comportamentali
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
1 L’organizzazione
e la funzione
del sistema nervoso
•
•
•
•
•
•
•
Come opera il sistema nervoso
Il sistema nervoso degli animali
vertebrati
Le unità funzionali del sistema
nervoso
Le cellule gliali
Il controllo a feed-back della
secrezione ormonale
•
•
•
•
2 I neuroni generano
e conducono segnali elettrici
•
•
•
•
•
•
Il potenziale di membrana dei neuroni
Il potenziale di riposo
Il potenziale d’azione
La propagazione del potenziale
d’azione
I fattori che condizionano la velocità
della propagazione dell’impulso
nervoso
Intensità dei potenziali d’azio-ne
•
•
•
•
•
•
•
Elencare le tre fasi secondo cui opera il sistema nervoso
Distinguere le funzioni del sistema nervoso centrale da quelle
del sistema nervoso periferico nei vertebrati
Descrivere il neurone evidenziando le funzioni delle diverse
parti
Definire le sinapsi
Distinguere i neuroni sensoriali dai neuroni efferenti e dagli
interneuroni
Spiegare le funzioni delle cellule gliali e della guaina mielinica
Spiegare da che cosa dipende l’eccitabilità dei neuroni
Spiegare come viene mantenuto il potenziale di riposo
evidenziando il ruolo delle proteine di membrana
Descrivere come vengono regolati i canali ionici
Analizzare gli eventi che susseguendosi rapidamente
determinano il potenziale d’azione
Spiegare come si propaga l’impulso nervoso distinguendo tra
propagazione continua e saltatoria
Evidenziare l’importanza della guaina mielinica e del diametro
degli assoni per determinare la velocità di propagazione
dell’impulso nervoso
Spiegare perché i potenziali d’azione sono sempre uguali
indipendentemente dall’intensità dello stimolo che li ha
prodotti
88
PARAGRAFI
CONOSCENZE
ABILITÀ
3 Le sinapsi trasmettono
lo stimolo nervoso
da una cellula all’altra
•
•
•
•
•
•
4 sistema nervoso centrale
,midollo spinale,sistema
nervoso periferico
La giunzione neuromuscolare
La trasmissione sinaptica
Le sinapsi tra neuroni
I neurotrasmettitori
Le sinapsi elettriche
Organizzazione anatomica
Spiegare come funziona una sinapsi chimica utilizzando come
esempio la giunzione neuromuscolare
• Distinguere una sinapsi eccitatoria da una inibitoria
• Spiegare come il neurone postsinaptico integra le informazioni
• Elencare i principali neurotrasmettitori
• Spiegare come funziona una sinapsi elettrica
Spiegare le complesse relazioni fra le varie parti del
sistema nervoso
Rimini, 15 maggio 2017
Il docente, prof.ssa Vasconi Cristina
____________________________________
Gli studenti
_______________________
_______________________
89