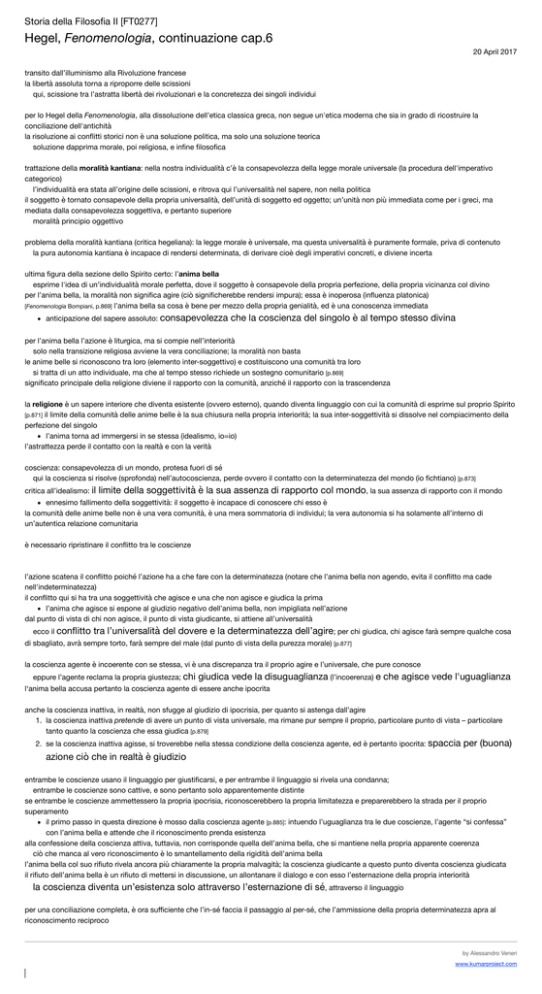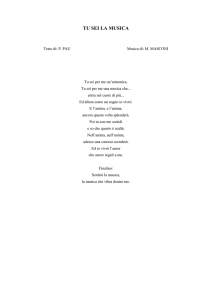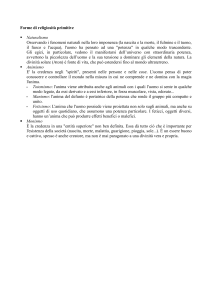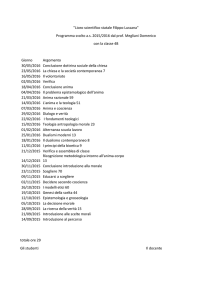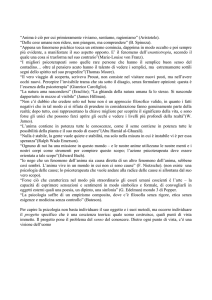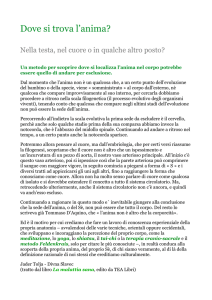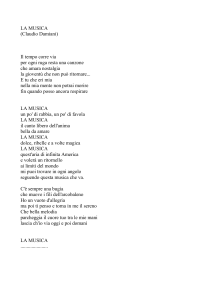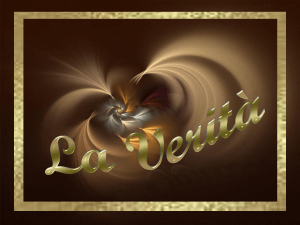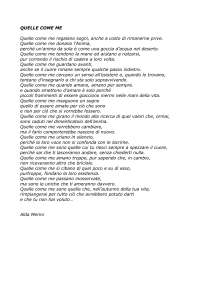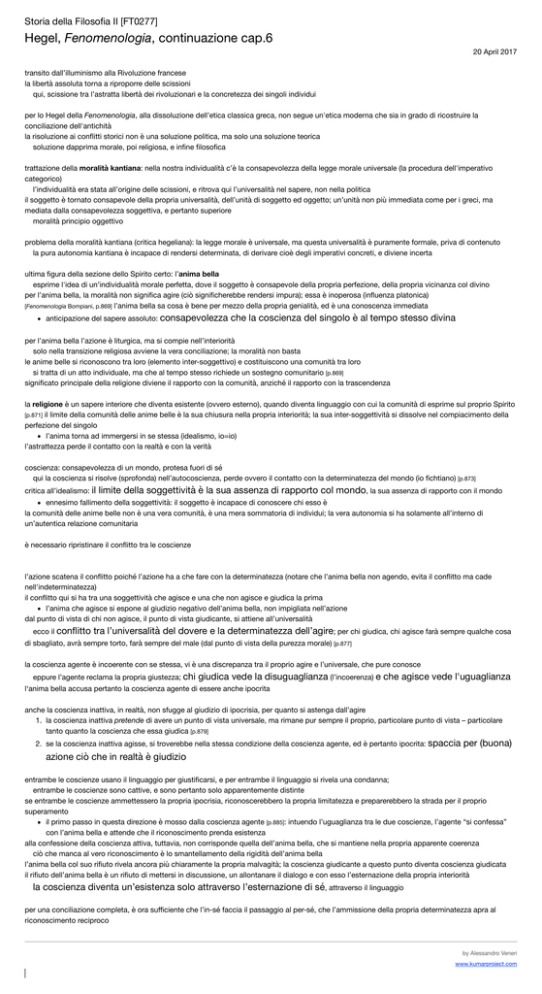
Storia della Filosofia II [FT0277]
Hegel, Fenomenologia, continuazione cap.6
20 April 2017
transito dall’illuminismo alla Rivoluzione francese
la libertà assoluta torna a riproporre delle scissioni
qui, scissione tra l’astratta libertà dei rivoluzionari e la concretezza dei singoli individui
per lo Hegel della Fenomenologia, alla dissoluzione dell’etica classica greca, non segue un'etica moderna che sia in grado di ricostruire la
conciliazione dell'antichità
la risoluzione ai conflitti storici non è una soluzione politica, ma solo una soluzione teorica
soluzione dapprima morale, poi religiosa, e infine filosofica
trattazione della moralità kantiana: nella nostra individualità c’è la consapevolezza della legge morale universale (la procedura dell'imperativo
categorico)
l’individualità era stata all’origine delle scissioni, e ritrova qui l’universalità nel sapere, non nella politica
il soggetto è tornato consapevole della propria universalità, dell’unità di soggetto ed oggetto; un’unità non più immediata come per i greci, ma
mediata dalla consapevolezza soggettiva, e pertanto superiore
moralità principio oggettivo
problema della moralità kantiana (critica hegeliana): la legge morale è universale, ma questa universalità è puramente formale, priva di contenuto
la pura autonomia kantiana è incapace di rendersi determinata, di derivare cioè degli imperativi concreti, e diviene incerta
ultima figura della sezione dello Spirito certo: l’anima bella
esprime l'idea di un’individualità morale perfetta, dove il soggetto è consapevole della propria perfezione, della propria vicinanza col divino
per l’anima bella, la moralità non significa agire (ciò significherebbe rendersi impura); essa è inoperosa (influenza platonica)
[Fenomenologia Bompiani, p.869] l’anima bella sa cosa è bene per mezzo della propria genialità, ed è una conoscenza immediata
anticipazione del sapere assoluto: consapevolezza
che la coscienza del singolo è al tempo stesso divina
per l’anima bella l’azione è liturgica, ma si compie nell’interiorità
solo nella transizione religiosa avviene la vera conciliazione; la moralità non basta
le anime belle si riconoscono tra loro (elemento inter-soggettivo) e costituiscono una comunità tra loro
si tratta di un atto individuale, ma che al tempo stesso richiede un sostegno comunitario [p.869]
significato principale della religione diviene il rapporto con la comunità, anziché il rapporto con la trascendenza
la religione è un sapere interiore che diventa esistente (ovvero esterno), quando diventa linguaggio con cui la comunità di esprime sul proprio Spirito
[p.871] il limite della comunità delle anime belle è la sua chiusura nella propria interiorità; la sua inter-soggettività si dissolve nel compiacimento della
perfezione del singolo
l’anima torna ad immergersi in se stessa (idealismo, io=io)
l’astrattezza perde il contatto con la realtà e con la verità
coscienza: consapevolezza di un mondo, protesa fuori di sé
qui la coscienza si risolve (sprofonda) nell’autocoscienza, perde ovvero il contatto con la determinatezza del mondo (io fichtiano) [p.873]
critica all’idealismo: il
limite della soggettività è la sua assenza di rapporto col mondo, la sua assenza di rapporto con il mondo
ennesimo fallimento della soggettività: il soggetto è incapace di conoscere chi esso è
la comunità delle anime belle non è una vera comunità, è una mera sommatoria di individui; la vera autonomia si ha solamente all’interno di
un’autentica relazione comunitaria
è necessario ripristinare il conflitto tra le coscienze
l’azione scatena il conflitto poiché l’azione ha a che fare con la determinatezza (notare che l’anima bella non agendo, evita il conflitto ma cade
nell'indeterminatezza)
il conflitto qui si ha tra una soggettività che agisce e una che non agisce e giudica la prima
l’anima che agisce si espone al giudizio negativo dell’anima bella, non impigliata nell’azione
dal punto di vista di chi non agisce, il punto di vista giudicante, si attiene all’universalità
ecco il conflitto
tra l’universalità del dovere e la determinatezza dell’agire; per chi giudica, chi agisce farà sempre qualche cosa
di sbagliato, avrà sempre torto, farà sempre del male (dal punto di vista della purezza morale) [p.877]
la coscienza agente è incoerente con se stessa, vi è una discrepanza tra il proprio agire e l’universale, che pure conosce
eppure l’agente reclama la propria giustezza; chi
giudica vede la disuguaglianza (l’incoerenza) e che agisce vede l'uguaglianza
l‘anima bella accusa pertanto la coscienza agente di essere anche ipocrita
anche la coscienza inattiva, in realtà, non sfugge al giudizio di ipocrisia, per quanto si astenga dall’agire
1. la coscienza inattiva pretende di avere un punto di vista universale, ma rimane pur sempre il proprio, particolare punto di vista – particolare
tanto quanto la coscienza che essa giudica [p.879]
2. se la coscienza inattiva agisse, si troverebbe nella stessa condizione della coscienza agente, ed è pertanto ipocrita: spaccia
per (buona)
azione ciò che in realtà è giudizio
entrambe le coscienze usano il linguaggio per giustificarsi, e per entrambe il linguaggio si rivela una condanna;
entrambe le coscienze sono cattive, e sono pertanto solo apparentemente distinte
se entrambe le coscienze ammettessero la propria ipocrisia, riconoscerebbero la propria limitatezza e preparerebbero la strada per il proprio
superamento
il primo passo in questa direzione è mosso dalla coscienza agente [p.885]: intuendo l’uguaglianza tra le due coscienze, l’agente “si confessa”
con l’anima bella e attende che il riconoscimento prenda esistenza
alla confessione della coscienza attiva, tuttavia, non corrisponde quella dell’anima bella, che si mantiene nella propria apparente coerenza
ciò che manca al vero riconoscimento è lo smantellamento della rigidità dell’anima bella
l’anima bella col suo rifiuto rivela ancora più chiaramente la propria malvagità; la coscienza giudicante a questo punto diventa coscienza giudicata
il rifiuto dell’anima bella è un rifiuto di mettersi in discussione, un allontanare il dialogo e con esso l’esternazione della propria interiorità
la coscienza diventa un’esistenza solo attraverso l’esternazione di sé, attraverso il linguaggio
per una conciliazione completa, è ora sufficiente che l’in-sé faccia il passaggio al per-sé, che l’ammissione della propria determinatezza apra al
riconoscimento reciproco
by Alessandro Veneri
www.kumarproject.com