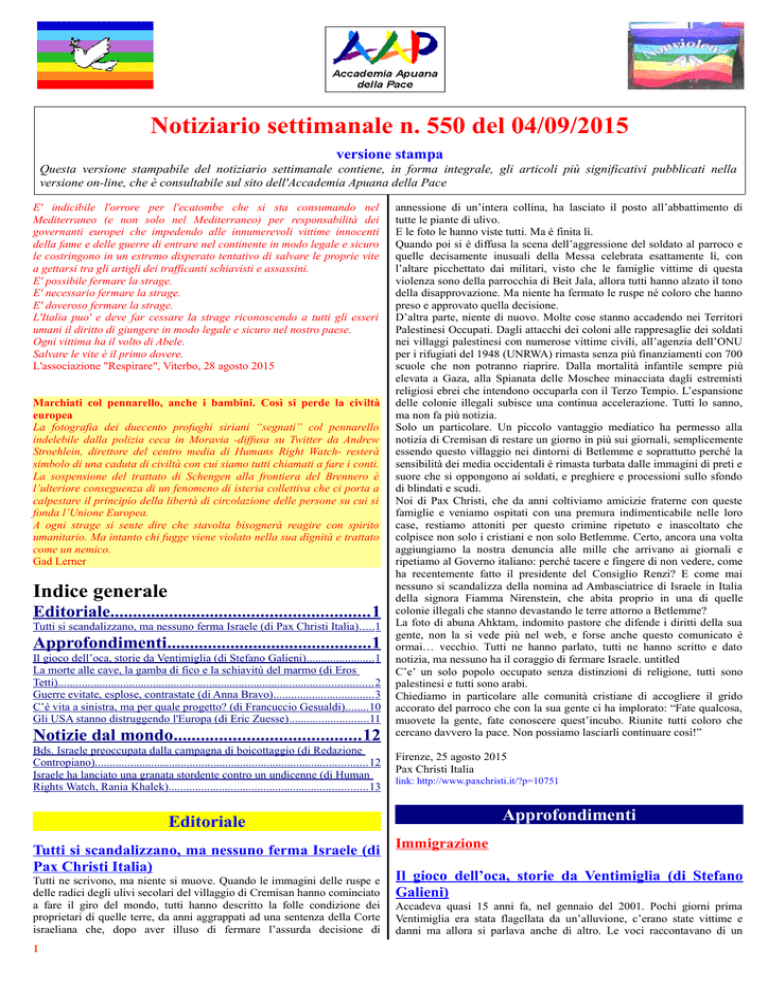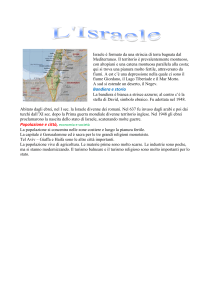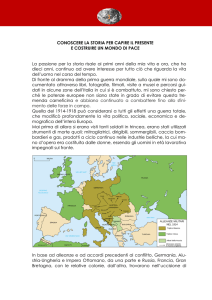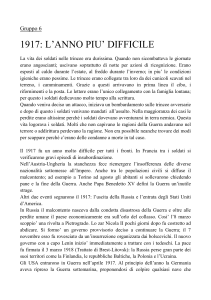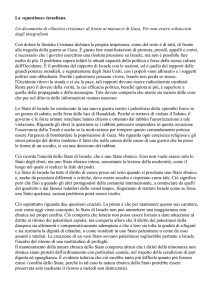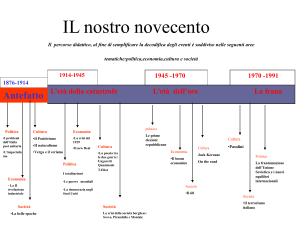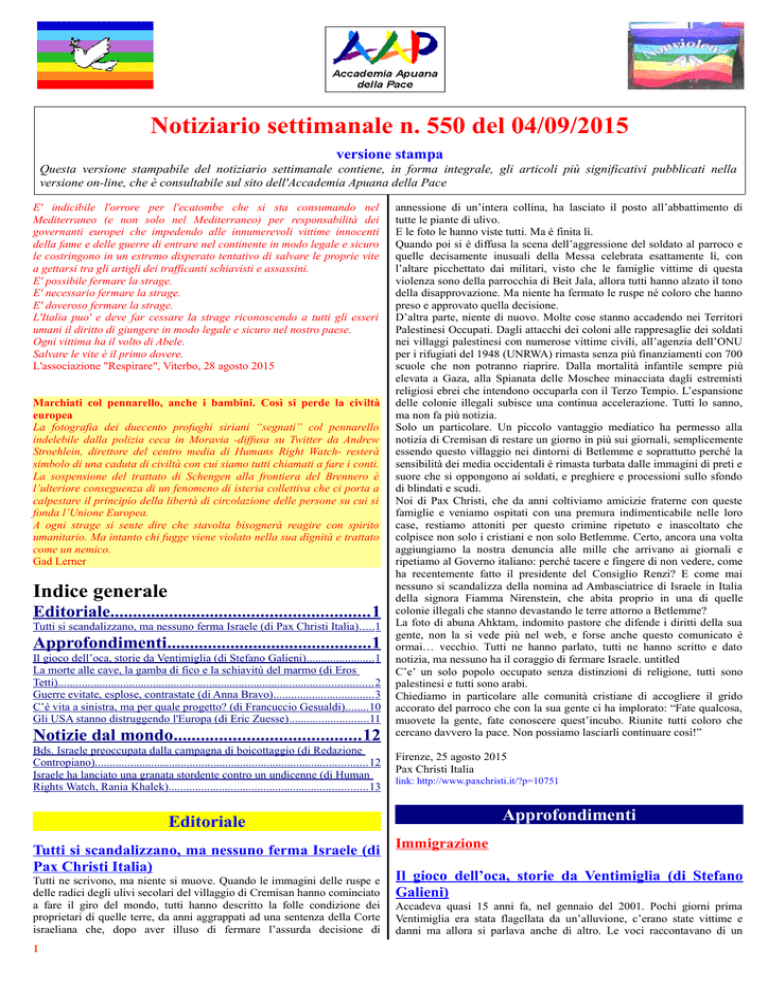
Notiziario settimanale n. 550 del 04/09/2015
versione stampa
Questa versione stampabile del notiziario settimanale contiene, in forma integrale, gli articoli più significativi pubblicati nella
versione on-line, che è consultabile sul sito dell'Accademia Apuana della Pace
E' indicibile l'orrore per l'ecatombe che si sta consumando nel
Mediterraneo (e non solo nel Mediterraneo) per responsabilità dei
governanti europei che impedendo alle innumerevoli vittime innocenti
della fame e delle guerre di entrare nel continente in modo legale e sicuro
le costringono in un estremo disperato tentativo di salvare le proprie vite
a gettarsi tra gli artigli dei trafficanti schiavisti e assassini.
E' possibile fermare la strage.
E' necessario fermare la strage.
E' doveroso fermare la strage.
L'Italia puo' e deve far cessare la strage riconoscendo a tutti gli esseri
umani il diritto di giungere in modo legale e sicuro nel nostro paese.
Ogni vittima ha il volto di Abele.
Salvare le vite è il primo dovere.
L'associazione "Respirare", Viterbo, 28 agosto 2015
Marchiati col pennarello, anche i bambini. Così si perde la civiltà
europea
La fotografia dei duecento profughi siriani “segnati” col pennarello
indelebile dalla polizia ceca in Moravia -diffusa su Twitter da Andrew
Stroehlein, direttore del centro media di Humans Right Watch- resterà
simbolo di una caduta di civiltà con cui siamo tutti chiamati a fare i conti.
La sospensione del trattato di Schengen alla frontiera del Brennero è
l’ulteriore conseguenza di un fenomeno di isteria collettiva che ci porta a
calpestare il principio della libertà di circolazione delle persone su cui si
fonda l’Unione Europea.
A ogni strage si sente dire che stavolta bisognerà reagire con spirito
umanitario. Ma intanto chi fugge viene violato nella sua dignità e trattato
come un nemico.
Gad Lerner
Indice generale
Editoriale......................................................... 1
Tutti si scandalizzano, ma nessuno ferma Israele (di Pax Christi Italia) .....1
Approfondimenti.............................................1
Il gioco dell’oca, storie da Ventimiglia (di Stefano Galieni).......................1
La morte alle cave, la gamba di fico e la schiavitù del marmo (di Eros
Tetti).......................................................................................................... 2
Guerre evitate, esplose, contrastate (di Anna Bravo).................................. 3
C’è vita a sinistra, ma per quale progetto? (di Francuccio Gesualdi) ........10
Gli USA stanno distruggendo l'Europa (di Eric Zuesse)...........................11
Notizie dal mondo......................................... 12
Bds. Israele preoccupata dalla campagna di boicottaggio (di Redazione
Contropiano)............................................................................................ 12
Israele ha lanciato una granata stordente contro un undicenne (di Human
Rights Watch, Rania Khalek)................................................................... 13
Editoriale
annessione di un’intera collina, ha lasciato il posto all’abbattimento di
tutte le piante di ulivo.
E le foto le hanno viste tutti. Ma è finita lì.
Quando poi si è diffusa la scena dell’aggressione del soldato al parroco e
quelle decisamente inusuali della Messa celebrata esattamente lì, con
l’altare picchettato dai militari, visto che le famiglie vittime di questa
violenza sono della parrocchia di Beit Jala, allora tutti hanno alzato il tono
della disapprovazione. Ma niente ha fermato le ruspe né coloro che hanno
preso e approvato quella decisione.
D’altra parte, niente di nuovo. Molte cose stanno accadendo nei Territori
Palestinesi Occupati. Dagli attacchi dei coloni alle rappresaglie dei soldati
nei villaggi palestinesi con numerose vittime civili, all’agenzia dell’ONU
per i rifugiati del 1948 (UNRWA) rimasta senza più finanziamenti con 700
scuole che non potranno riaprire. Dalla mortalità infantile sempre più
elevata a Gaza, alla Spianata delle Moschee minacciata dagli estremisti
religiosi ebrei che intendono occuparla con il Terzo Tempio. L’espansione
delle colonie illegali subisce una continua accelerazione. Tutti lo sanno,
ma non fa più notizia.
Solo un particolare. Un piccolo vantaggio mediatico ha permesso alla
notizia di Cremisan di restare un giorno in più sui giornali, semplicemente
essendo questo villaggio nei dintorni di Betlemme e soprattutto perché la
sensibilità dei media occidentali è rimasta turbata dalle immagini di preti e
suore che si oppongono ai soldati, e preghiere e processioni sullo sfondo
di blindati e scudi.
Noi di Pax Christi, che da anni coltiviamo amicizie fraterne con queste
famiglie e veniamo ospitati con una premura indimenticabile nelle loro
case, restiamo attoniti per questo crimine ripetuto e inascoltato che
colpisce non solo i cristiani e non solo Betlemme. Certo, ancora una volta
aggiungiamo la nostra denuncia alle mille che arrivano ai giornali e
ripetiamo al Governo italiano: perché tacere e fingere di non vedere, come
ha recentemente fatto il presidente del Consiglio Renzi? E come mai
nessuno si scandalizza della nomina ad Ambasciatrice di Israele in Italia
della signora Fiamma Nirenstein, che abita proprio in una di quelle
colonie illegali che stanno devastando le terre attorno a Betlemme?
La foto di abuna Ahktam, indomito pastore che difende i diritti della sua
gente, non la si vede più nel web, e forse anche questo comunicato è
ormai… vecchio. Tutti ne hanno parlato, tutti ne hanno scritto e dato
notizia, ma nessuno ha il coraggio di fermare Israele. untitled
C’e’ un solo popolo occupato senza distinzioni di religione, tutti sono
palestinesi e tutti sono arabi.
Chiediamo in particolare alle comunità cristiane di accogliere il grido
accorato del parroco che con la sua gente ci ha implorato: “Fate qualcosa,
muovete la gente, fate conoscere quest’incubo. Riunite tutti coloro che
cercano davvero la pace. Non possiamo lasciarli continuare così!”
Firenze, 25 agosto 2015
Pax Christi Italia
link: http://www.paxchristi.it/?p=10751
Approfondimenti
Tutti si scandalizzano, ma nessuno ferma Israele (di Immigrazione
Pax Christi Italia)
Tutti ne scrivono, ma niente si muove. Quando le immagini delle ruspe e Il gioco dell’oca, storie da Ventimiglia (di Stefano
delle radici degli ulivi secolari del villaggio di Cremisan hanno cominciato Galieni)
a fare il giro del mondo, tutti hanno descritto la folle condizione dei
proprietari di quelle terre, da anni aggrappati ad una sentenza della Corte
israeliana che, dopo aver illuso di fermare l’assurda decisione di
1
Accadeva quasi 15 anni fa, nel gennaio del 2001. Pochi giorni prima
Ventimiglia era stata flagellata da un’alluvione, c’erano state vittime e
danni ma allora si parlava anche di altro. Le voci raccontavano di un
mondo sommerso, dei centinaia di kurdi, soprattutto turchi e iracheni, che
tentavano di attraversare la frontiera per poi arrivare in Germania, dove la
comunità è sempre stata molto forte e compatta. Arrivavano dagli sbarchi
in Puglia, raggiungevano in treno l’ultimo avamposto italiano e si
fermavano per alcuni giorni: i più poveri nei giardini della stazione, chi
aveva qualche lira in più (non c’erano ancora gli euro) in alberghetti o in
stanze prese in affitto. Il tempo di rifocillarsi, di prendere contatto con
qualche passeur e poi via, verso la vera libertà che già allora non era in
Italia.
Con una collega e amica, Antonella Patete, partimmo per andare a vedere
di persona, con tanta inesperienza e poche certezze, ma soprattutto la
voglia di scoprire e di capire. Restammo quasi una settimana: parlammo
con tutti, kurdi e autoctoni, passeur e taxisti, agenti di polizia italiani e
francesi, albergatori e negozianti. Ne venne fuori un reportage che quasi
due anni dopo, insieme ad altri simili realizzati nei luoghi di arrivo o di
fuga dei migranti, prese la forma di un libro, Frontiera Italia (Città Aperta
Edizioni), ormai fuori commercio.
A rileggerlo oggi il presente si mescola col passato. Sono mutati i contesti
internazionali, è peggiorata la fase economica, si sono imbarbariti i
rapporti sociali, ma quel luogo di frontiera resta un pezzo di storia ancora
capace di evocare antichi fantasmi, non solo per i tragici eventi del
presente ma per il carico di passato che porta con sé. Il Regno d’Italia
nasce, infatti, con il plebiscito attraverso cui i cittadini di Nizza e di
Mentone (a soli 6 km da Ventimiglia) decidono di essere annesse alla
Francia: diventeranno Nice e Menton e resteranno città di frontiera.
L’Italia è allora un Paese povero e dai valichi rivieraschi e di montagna
nasce la fama dei passeur, descritti in maniera romantica dallo scrittore
Francesco Biamonti, ma in realtà contrabbandieri di persone e di merci. In
un secolo da quel confine passò di tutto: soldi, armi, sale, ragazze da
mandare a prostituirsi nei bordelli francesi e mendicanti figli di famiglie
troppo povere, rei in fuga, anarchici, sobillatori, socialisti e poi
antifascisti, fino alla seconda guerra mondiale e alla momentanea
riannessione all’Italia mussoliniana. Durò poco e il traffico riprese
imperterrito. Passare via terra era difficile, si veniva facilmente individuati
e respinti. Si provava per la via degli scogli, i cosiddetti Balzi rossi, ma il
rischio di venire intercettati o, peggio, di finire in mare era alto. Oppure si
provavano i passi di montagna. Uno dei più famosi, passando per un
albergo chiamato Le Calandre, divenne il famigerato Passo della Morte.
Salendo da Ventimiglia, ovviamente di notte, ci si inerpicava per sentieri
sempre più ripidi, sempre più insicuri. Ma si arrivava ad un punto, pochi
metri di strada, in cui le luci dall’Italia non si vedevano più mentre quelle
della cittadina francese illuminavano la roccia. C’era (c’è ancora) uno
spazio ristretto in cui, grazie a questo gioco di luci, diviene impossibile
vedere il sentiero. In tanti sono precipitati fra le rocce e tanti altri non sono
mai stati recuperati. Morti poco importanti da piangere. Accadeva con gli
italiani e accadeva, all’inizio degli anni 2000, con i kurdi e i migranti in
generale.
Quando andammo su quel confine erano cinque le strade battute: quella
del confine di San Luigi, da attraversare a piedi, col rischio di essere
intercettati dalle polizie dei due stati se si aveva la pelle più scura o l’aria
di chi ha dormito di notte all’addiaccio. Oppure si poteva andare con i
passeur, gli scafisti leggeri, che portavano persone in taxi, in furgone, con
un’automobile privata. Se al confine il mezzo veniva fermato e perquisito
scattava il sequestro, la condanna del guidatore, il respingimento dei
passeggeri. Si pagavano 50 mila lire a persona circa, per 6 km. Se si
voleva tentare di raggiungere Nizza, città cosmopolita in cui più era facile
mimetizzarsi, i chilometri diventavano 60. I rischi di essere fermati
aumentavano e, ovviamente, i costi anche.
Un’altra strada possibile era la via ferroviaria, anche questa con due
alternative. La prima consisteva nell’eludere i controlli della polizia a
Ventimiglia, salire facendo il biglietto e sperare nella scarsità dei controlli
lungo il percorso. Se si veniva trovati si perdevano solo i soldi del
biglietto, si tornava a Ventimiglia, si dormiva in stazione e poi si
riprovava. Si tiravano i dadi, come nel gioco dell’oca. Poi c’era anche chi i
dadi li tirava da più in alto, mettendo a rischio la propria vita: erano quelli
che provavano l’antica rotta dei Balzi rossi, sugli scogli, dopo aver
raggiunto il mare alla foce del fiume Roia. Quelli che si incamminavano
2
lungo la ferrovia, passando nelle gallerie e sperando di non essere investiti
da un treno merci (tutti conoscevano gli orari dei convogli con passeggeri)
e quelli che ancora provavano il Passo della Morte, con gli stessi rischi dei
decenni passati. A Mentone, poi, i controlli erano certosini. La bella e
luminosa cittadina ha sempre avuto amministrazioni che non tolleravano
l’arrivo degli stranieri, italiani o kurdi che fossero, così la caccia all’uomo
era frequente. E se venivi preso tornavi indietro, per poi rilanciare i dadi.
È andata avanti così per molti anni ma il numero dei fuggitivi diminuiva,
si cercavano altre rotte e anche i passeur avevano perso lavoro.
Una nuova impennata che riportò alla ribalta la cittadina ligure, si è avuta
nei primi mesi del 2011. Quelle che allora venivano chiamate “Primavere
Arabe” affollarono dapprima Lampedusa, poi i centri di raccolta e di
“detenzione camuffata” in buona parte del Paese, da Trapani a Manduria,
da Santa Maria Capua Vetere a Palazzo San Gervasio, fino a Crotone,
Civitavecchia, Elmas. Caserme e strutture improvvisate, concentrate in
alcune regioni, fino a quando l’allora Ministro dell’Interno Roberto
Maroni diede due disposizioni: la ripartizione dei fuggitivi in ogni regione
e l’erogazione di permessi di protezione umanitaria temporanea che,
secondo il Ministro, avrebbero dovuto permettere alle persone di recarsi
nei Paesi europei in cui ognuno aveva già legami. La Protezione Civile in
quel periodo si attivò per facilitare il transito e centinaia, forse migliaia di
biglietti ferroviari, vennero offerti a chi voleva andare via.
Roma, Stazione Termini, binario 21. I volontari prendevano i nomi,
davano la lista ai funzionari del Comune o della Prefettura e in breve
arrivavano i preziosi titoli di viaggio per un treno che avrebbe portato
ognuno verso il confine francese. All’inizio non ci furono problemi, poi il
numero delle persone che giungevano in Francia superò una certa soglia di
guardia e iniziarono i primi respingimenti. Alcuni di coloro che intanto
erano arrivati già a Parigi – soprattutto giovani tunisini – vennero
rimandati in Italia senza tanti complimenti, in base al Regolamento di
Dublino e a una interpretazione secondo cui i permessi rilasciati in Italia
avevano valore solo in tale Paese. Ci fu un lungo braccio di ferro
diplomatico, amplificato mediaticamente per fare in modo che, intanto,
iniziassero rimpatri verso la Tunisia e che si evitassero concentrazioni di
persone tali da imbarazzare entrambi i governi.
Con la fine delle Primavere Ventimiglia tornò nel dimenticatoio. Ma da
almeno un anno non è più così. È tornata ad essere una frontiera ambita,
verso la Francia vissuta come Paese di transito. Sono tornati a lavorare i
passeur, con tariffe anche ridotte rispetto al passato. Poi c’è stato un
crescendo su cui hanno influito, come al solito, le scadenze elettorali. La
Francia ha ricominciato a fermare, identificare e respingere persone,
soprattutto dall’Africa Sub-Sahariana. Il mese scorso si è trattato di
almeno un migliaio di uomini e donne: verso i minori c’era maggiore
attenzione ma ora non si risparmia nessuno. Oggi, come da ormai oltre
150 anni, quello sprazzo di terra compreso fra montagna e mare torna a
essere luogo di silenzioso conflitto moderno, fra chi ha diritto a muoversi
e chi è condannato a essere fermato.
Stefano Galieni
(fonte: Corriere delle migrazioni)
link:
http://www.corrieredellemigrazioni.it/2015/08/10/gioco-delloca-storieventimiglia/
Lavoro ed occupazione
La morte alle cave, la gamba di fico e la schiavitù
del marmo (di Eros Tetti)
Una riflessione a caldo dopo l’ennesimo incidente alle cave, uno sfogo
dettato dalla frustrazione di vedere l’ennesima famiglia violentata da
questa economia barbara con sempre maggior convinzione dobbiamo
uscire da questo “cul de sac”.
La prima volta che vidi la gamba di fico al museo del marmo di
Fantiscritti rimasi letteralmente scioccato, provai con enorme sforzo ad
immaginarmi come potesse esser possibile che un essere umano dopo aver
perso la sua gamba sotto un blocco di marmo, potesse sostituirla con una
gamba di legno di fico per poter poi tornare a lavorare in quell’inferno
bianco. Tutta la settimana successiva non potei far altro che pensare a
questa cosa e a quanto attorno ai 0 cavatori si sia cercato di dipingere un
superuomo che andava oltre ogni umana aspettativa.
Uomini in grado di camminare per ore per arrivare su un luogo di lavoro
che non era certo riposante, a chi andava meglio se ne stava tutto il giorno
seduto a sbozzare a mano con un pesante martello un blocco di marmo,
altri tagliavano la montagna mentre altri ancora facevano scendere i
ciclopici blocchi per vie di lizza dalle pendenze improponibili
trascinandoli su tronchi insaponati al ritmo di canti singhiozzanti che
sincronizzavano il laborioso gruppo. Nel secolo scorso su queste
montagne abbiamo visto dei lavori forzati che hanno forse avuto eguali
solo nella costruzione delle faraoniche piramidi egiziane, lavori che hanno
massacrato a mio avviso buona parte della nostra cultura che era
primariamente legata al bosco, ai campi e ai pascoli. Un’
industrializzazione della montagna che ci ha regalato quella devastazione
visibile anche da decine di km nello spazio..
Tutto questo tribolare ha nel tempo arricchito solamente poche famiglie
che si sono fatte sempre più potenti ed influenti e di fatto, a noi che
viviamo e vivremo qui, ha lasciato solo danni di ogni tipo dalla corruzione
fino alla non indifferente devastazione ambientale che oltre a distruggere
il paesaggio, protetto dal nostro amato articolo 9 della costituzione, ha
avvelenato le falde acquifere bene primario che ci ha permesso di vivere
su questo territorio per millenni.
Oggi questo mio popolo dannato ha perso un altro dei suoi figli, lo ha
perso tragicamente nel lavoro alle cave cadendo da oltre 10 metri e a
quanto riporta qualche quotidiano pare che stesse lavorando senza alcuna
protezione. Su la Nazione del 30/08/2015 si riporta inoltre che negli
ultimi dieci anni ci sono stati circa 1258 infortuni alle cave di cui 8
mortali, si avete capito bene, un numero disarmante se pensiamo che
sicuramente molti saranno stati anche incidenti gravissimi. Una strage
silenziosa, una tortura accettata da troppi con troppo silenzio.
Perdonate questo mio sfogo, ho 38 anni e sono veramente deluso di come
ci è stato consegnato questo territorio dalle generazioni che ci hanno
preceduto, soprattutto le generazioni che hanno governato gli ultimi
decenni, le stesse che ancora oggi vorrebbero rifare un’immagine a questo
lavoro che non ha mai avuto nulla di umano, un lavoro che ha trascinato
questo paradiso in un inferno fatto di sofferenza, morte, mafia, marmo e
marmettola. Qualche politico “presuntuoso” ha pure avuto il coraggio di
stravolgere il piano paesaggistico per mettere riferimenti su una presunta
identità legata all’escavazione. Bene a questi esseri disdicevoli oggi dico
solamente che questa è solo l’identità a cui volete condannarci, l’identità
di un popolo schiavo che per due briciole si lascia distruggere un ambiente
che non ha eguali al mondo, un ambiente prezioso ma soprattutto la nostra
casa.
E’ da qui che il nostro popolo deve ripartire dicendo no a questa
dannazione che ci mangia il futuro, dicendo no al tormento che i nostri avi
hanno subito alle cave, dicendo no a tutto questo raccapricciante teatrino
che si sta imbastendo per rifare l’immagine ad un’economia fatta di morte,
sfruttamento e devastazione.
In ultimo chiudo parlando direttamente ai sindacati che tanto si sbracciano
per difendere l’attività di cava ma forse troppo poco fanno per difendere il
nostro popolo. Dopo aver visto il teatrino imbastito dal sindacalista delle
Fillea CGIL Venturini, che ha attaccato la Sindaca di Fosdinovo Camilla
Bianchi, che difende il suo territoio dal devastante passaggio dei camion
delle cave. Una Sindaca che sta scommettendo su un futuro diverso fatto
di economie durevoli e basato sulla nostra vera identità quella agricola,
dell’ospitalità, dell’artigianato di qualità e dell’enogastronomia.
I sindacati oggi, soprattutto in questo territorio, se veramente difendono i
lavoratori ed il lavoro dovrebbero innanzitutto cominciare a pretendere
una riconversione economica del territorio perchè non vogliamo più essere
schiavi del marmo, non vogliamo più condannare questi luoghi
meravigliosi alla devastazione, non vogliamo essere impoveriti e
sottomessi ad una monocultura sfrutta da pochi e da multinazionali, ma
soprattutto non vogliamo più aver bisogno gambe di fico per avanzare in
questo incerto mondo.
(fonte: Pressenza: international press agency)
3
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2334
Nonviolenza
Guerre evitate, esplose, contrastate (di Anna Bravo)
Dal libro di Anna Bravo, "La conta dei salvati. Dalla Grande Guerra al
Tibet: storie di sangue risparmiato", Laterza, Roma-Bari 2013, riportiamo
il capitolo secondo "Guerre evitate, esplose, contrastate" (pp. 18-52),
pubblicato nella newsletter del Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo.
Un prima e un dopo
L'interpretazione di una guerra - la più complicata delle operazioni
storiografiche, la più influente sulla riscrittura del passato e sulla
prefigurazione del futuro - è di diretto interesse per la nonviolenza. Non si
tratta solo di denunciare lo spargimento di sangue, le sofferenze di militari
e civili, ma di capire come quel conflitto è scoppiato, proseguito,
terminato, come si sarebbe potuto evitarlo o contenerne la carica
devastante.
Vale in particolare per la grande guerra, la prima guerra totale, "moderna",
di massa, in cui convergono caratteri e elementi che fino allora non si
erano mai presentati congiuntamente e in forma così radicale: un sistema
economico che indirizza le sue immense risorse allo sforzo militare; un
uso quasi illimitato di scienza e tecnica a fini bellici (1); l'esplosione
demografica degli ultimi decenni del XIX secolo che rende disponibile
una quantità impensabile di uomini; i sistemi di coscrizione universale che
ingigantiscono gli eserciti come mai era avvenuto. È il debutto della
società di massa nelle sue linee di tendenza principali, incluso l'accesso
alla sfera pubblica di settori ampi di popolo - all'insegna della distruttività.
Con i suoi 60 milioni di combattenti e 9,7 milioni di morti, con una nuova
carta d'Europa, questa guerra segna uno spartiacque che divide la storia e
la memoria moderna in un prima - fiducia nella migliorabilità del mondo e
nella sua razionalità - e un dopo - realtà come "scherzo del destino",
rivincita di forme di pensiero e di comportamento mitico-magiche (2).
Eppure è anche l'occasione in cui una parte, sia pure minoritaria, di quelle
moltitudini riesce a fare storia in vari modi. Fra i quali c'è sì l'esplosione
rivoluzionaria, ma nello stesso tempo lo sforzo di risparmiare il sangue.
Inevitabile
Sulla grande guerra la storiografia offre molto. Attraverso milioni di
documenti scritti, orali, sonori, visivi, ufficiali e non, da quasi un secolo si
studiano i contesti, le tappe, i soggetti, le forze in gioco. E soprattutto le
origini, su cui si è accumulata una mole di giudizi divergenti, quando non
opposti. Il groviglio di questioni era (è) tale che secondo uno storico
britannico interessato alla didattica, Robert Pearce, chiedere a uno
studente "quali sono le cause della prima guerra mondiale" è un atto di
sadismo (3). Sarcasmo giustificato. "Il dibattito fra esperti è insieme
voluminoso e incompleto. Spiegare esattamente come l'Europa arriva alla
guerra è più un punto di confusione che di contrapposizione, specialmente
perché dalla nostra prospettiva nessun obiettivo di una guerra sembra
commensurabile ai costi per ottenerlo" (4). Nel 1969, un altro storico
aveva scelto la boutade: "things happen because they happen" (5).
Già nei primi anni Trenta, l'affievolirsi delle passioni politiche e il
desiderio di maggiore unità di fronte alla grande depressione avevano
indebolito le interpretazioni "patriottiche", che facevano rimbalzare
l'accusa di aver provocato la catastrofe da uno schieramento all'altro,
infestando l'opinione pubblica e la scuola (6). Alla vigilia della seconda
guerra mondiale, un buon numero di studiosi concordava in linea di
massima su alcuni punti. Il primo: la responsabilità andava divisa fra tutte
le potenze. Il secondo: il conflitto non era stata pianificato a freddo da
singole istituzioni, Stati, uomini politici, il cui torto era piuttosto non aver
saputo impedire la degenerazione della crisi. Il terzo: di fronte ai principali
cambiamenti di fine Ottocento-inizi Novecento - l'acuirsi della
competizione coloniale, la creazione di due blocchi di Stati contrapposti il sistema internazionale aveva rivelato i suoi limiti strutturali e i suoi
punti ciechi, confermando le critiche del presidente americano Wilson:
diplomazia segreta, diffidenza verso l'istituto dell'arbitrato, corsa agli
armamenti, permeabilità alle retoriche nazionaliste. Fattore chiave, la
rigidezza delle alleanze, che come in un gioco del domino avrebbe
trasformato una crisi bilaterale in scontro generale. Sulla scorta di Lenin,
gli studiosi marxisti mettevano invece sotto accusa il modello capitalistico
in se stesso, lo sfruttamento interno, la lotta per il dominio del mondo lo
rendevano incompatibile con la pace. In tutti e due i casi, si evocavano
grandi forze sovrapersonali, innescate dall'uomo ma ormai fuori dal suo
controllo, che avrebbero reso il conflitto probabile, probabilissimo,
inevitabile - lo scriveva già Tucidide per le guerre del Peloponneso.
Sebbene nei decenni successivi nuove ricerche mettessero in discussione
anche radicalmente i primi due punti (7), il terzo sostanzialmente reggeva.
La guerra poteva essere stata "la più stupida e la meno necessaria" (8), "il
più grande errore della storia moderna" (9), ma il fatto che non si fosse
riusciti a scongiurarla finiva per confermare la sua aura di fatalità. E si
riverberava sul passato. Le ricostruzioni storiche privilegiavano i momenti
di irrigidimento rispetto ai momenti di moderazione, le crisi alle soluzioni,
le scelte avventate rispetto a quelle tendenti al compromesso, il fallimento
finale ai risultati raggiunti in precedenza (10): l'intera storia delle relazioni
internazionali fra il 1870 e il 1914 veniva così ridotta a preludio del
conflitto, l'attentato di Sarajevo a puro pretesto per iniziarlo. Grosso modo
fino agli anni Ottanta, uno studente si abituava a pensare a quella guerra
come allo sbocco logico di tensioni che non potevano non esplodere prima
o poi. Se non nel 1914, "in qualche altro momento del primo Novecento"
(11).
Il paradosso è che quello fra il 1871 e il 1914 è uno dei più lunghi periodi
di pace - beninteso una pace europea, ottenuta a costi spaventosi per le
popolazioni africane e asiatiche. Ma quei quarantaquattro anni restano uno
strano antefatto: o le crisi non erano state così gravi da degenerare, oppure
le relazioni fra Stati contemplavano meccanismi che erano in grado di
riassorbirle, e che avrebbero potuto agire anche nel 1914.
"Nessuna guerra è inevitabile finché non scoppia" (12)
Alla fine degli anni Novanta qualche storico sensibile alla contraddizione
rovescia il punto di vista. Non solo quella guerra non era inscritta nel
destino dell'umanità, ma all'epoca alcuni la ritenevano improbabile o
addirittura impossibile. Le tensioni non si erano forse risolte senza
spargimento di sangue? Piuttosto che sulle origini del conflitto, scriveva
già nel 1972 Paul Schroeder, si sarebbe dovuto studiare il modo in cui era
stata mantenuta la pace (13) - ottimo contrappeso all'effetto "buco nero"
tipico delle guerre.
Argomentata in termini convincenti, la tesi dello scontro evitabile ha
ricevuto più critiche che consensi e resta minoritaria. Peccato, in primo
luogo per la scuola. È vero (ed è importante) che nei libri di testo si parla
sempre più di origini, sempre meno di cause, che il cliché della
ineluttabilità vacilla, ma rimane un abisso fra lo spazio dedicato alla
grande guerra e le poche righe con cui si trattano le crisi risolte e i conflitti
limitati. Che del resto occupano sì e no l'1% della ricerca sul periodo, di
contro al 99% riservato al conflitto.
Percentuali non indolori. È la gerarchia dei temi di ricerca che dà una
veste parascientifica alla visione del mondo secondo cui la guerra sarebbe
una componente normale della storia, e i popoli si dedicherebbero a
massacrarsi in un crescendo di barbarie esasperato dalla modernità e
postmodernità. Per estensione, la violenza può apparire il tratto prevalente
della specie umana, e nello stesso tempo un oggetto di per sè degno di
interesse, mentre la normalità avrebbe ben poco da dire.
Dietro l'assuefazione al sangue e al vilipendio dei corpi, di cui si getta la
responsabilità su internet, sui fumetti, sul cinema, sulla tv, c'è, anche,
questo filo nero che corre dal passato al presente. Per quanto esistano
controspinte potenti, siamo già piuttosto avanti sulla strada verso la
normalizzazione dei conflitti - a patto che si tengano lontani da casa
nostra.
Il detto di Gandhi: "Se la storia dell'universo fosse cominciata con le
guerre, non un solo uomo sarebbe vivo oggi" andrebbe affisso in tutte le
scuole. Perché la sua visione del mondo insegna un benefico scetticismo
verso le ideologie catastrofiche, e una benefica curiosità per i tentativi di
conservare la pace, per l'impegno a risparmiare il sangue anche nel pieno
di un conflitto.
Churchill: guerre ritardate, guerre evitate
Non so se fra quanti sostengono la tesi della guerra evitabile qualcuno sia
amico della nonviolenza, nè penso che i molti convinti della sua fatalità
subiscano il fascino del sangue. Semplicemente, i primi non sembrano
4
disponibili a etichettare un intero ciclo storico sulla base di un evento
successivo, quasi che di per sè non avesse alcun significato. A chi come
me è arrivato al tema attraverso l'interesse per la nonviolenza, autori come
questi offrono una chiave di lettura preziosa (14), che dà valore ai modi in
cui si sono affrontate crisi a alto rischio di guerra intereuropea (15).
Decenni prima Churchill, certamente non imputabile di filopacifismo,
aveva difeso la diplomazia pre-1914 con queste parole: "Non bisogna
scordare che una guerra ritardata significa spesso una guerra evitata per la
rapidità con cui le situazioni vengono a mutare, con cui si formano nuovi
aggruppamenti e con cui nuovi interessi sopraffanno gli antichi" (16).
Già gli ultimi due decenni dell'Ottocento avevano visto frizioni
gravissime: per esempio tra Francia e Gran Bretagna per l'Egitto (17), fra
britannici e russi sulla Cina e in seguito sui Dardanelli. Tre guerre che
potevano scoppiare, e vengono scongiurate. Il nuovo secolo inizia con una
crisi russo-tedesca in Cina, ma i focolai di tensione si trovano
principalmente nel Nordafrica e nei Balcani, dove si sta consumando
l'agonia dell'impero ottomano, "il grande malato d'Europa".
Nel 1905 divampa la prima crisi marocchina. La Francia, potenza
dominante, chiede al sultano nuove prerogative commerciali e militari. La
Germania risponde con lo sbarco a Tangeri del Kaiser Guglielmo II, una
mossa vistosissima a favore dell'indipendenza marocchina e contro la
politica francese. Il risentimento tedesco è ricambiato a Londra e Parigi,
che dal 1904 sono unite nell'Entente cordiale. In una situazione tesissima,
il ministro degli Esteri britannico Grey sperimenta la sua diplomazia delle
intese: prova a distogliere la Germania dall'attaccare, ventilando un aiuto
del Regno Unito alla Francia, contemporaneamente invita la Francia a un
compromesso alludendo a un mancato aiuto se avesse provocato una
guerra.
Il metodo funziona, e non solo perché i tedeschi non sono disposti ad
aprire le ostilità per la questione marocchina, ma perché alla conferenza di
Algeciras organizzata per sciogliere la crisi, la sola Austria-Ungheria
sostiene la Germania, e tiepidamente: gli Asburgo non hanno intenzione di
essere coinvolti in un conflitto "per i supposti interessi dei loro alleati in
Nordafrica" (18) - la dissuasione funziona anche nello schieramento della
Triplice Alleanza. Un'altra guerra evitata (19), e un precedente cruciale per
le relazioni intereuropee.
Il Marocco torna in primo piano nell'11, quando l'Italia, "piccola grande"
potenza preoccupata di essere esclusa dall'intero Nordafrica, porta la
guerra in Cirenaica e Tripolitania, mentre la Francia preme per ottenere il
protettorato sul Marocco. La Germania reagisce platealmente mandando
una cannoniera nel porto di Agadir. Ma nel momento in cui questa
seconda crisi marocchina minaccia di precipitare, Lloyd George pronuncia
un duro discorso alla Mansion House in cui manifesta il suo pieno
appoggio alla Francia, mentre l'Austria-Ungheria si mostra ancora una
volta indisponibile a sostenere fino in fondo la posizione tedesca. La
Germania deve ripiegare, i negoziati ricominciano e si concludono il 4
novembre 1911: Parigi ottiene il riconoscimento del protettorato, Berlino
alcuni territori appartenenti al Congo francese.
La guerra in Europa
Terreno elettivo di scontro intereuropeo, i Balcani erano una regione
sussultoria, dove l'impero ottomano stentava a mantenere il controllo sui
suoi - ormai teorici - possedimenti, e i nazionalismi locali incalzavano. Fra
Otto e Novecento si erano susseguiti colpi di Stato e di mano, rivolte,
guerre commerciali, e ogni crisi aveva minacciato di portare a uno scontro
fra Russia e Austria-Ungheria, le due potenze più influenti nella penisola
sia direttamente sia attraverso i loro Stati-clienti.
Nel luglio del 1908 un gruppo di ufficiali turchi si ribella al sultano,
chiedendo il ripristino della Costituzione e riforme modernizzanti. Si apre
una fase burrascosa, che incoraggia l'Austria-Ungheria ad annettersi la
Bosnia-Erzegovina, che il Congresso di Berlino del 1878 le aveva dato in
amministrazione, ma lasciandola formalmente sotto l'autorità turca.
Mentre a Belgrado, in Montenegro, a Praga si manifesta contro la mossa
austriaca, la Serbia mobilita 100.000 soldati, il principato autonomo della
Bulgaria, nominalmente ancora dipendente dalla Turchia, dichiara la piena
indipendenza, e l'Italia chiede una compensazione territoriale.
Le potenze hanno interessi diversi in questa occasione. Tendono a
sostenere la sopravvivenza dell'impero ottomano i paesi che non
avrebbero grandi vantaggi dalla sua frantumazione, la Francia, la Gran
Bretagna e inizialmente la Germania. Russia e Austria-Ungheria vedono
invece la possibilità di guadagnare territori e prestigio; in più, la prima
spera di ottenere, in cambio del consenso all'annessione, un aggiustamento
dell'accordo sugli Stretti, che negava il passaggio alle sue navi da guerra
attraverso i Dardanelli; la seconda teme che le ambizioni nazionaliste
destabilizzino lo stesso impero asburgico. Tutte e due fanno una politica di
forza, con preparativi militari e mobilitazioni parziali. La guerra sembra
una prospettiva concreta.
Ma la diplomazia di entrambe le parti sa che la Russia non è preparata a
uno scontro. Proprio su questo conta la Germania quando, per vendicare il
fallimento di Algeciras e rompere l'asse franco-anglo-russo, manda un
ultimatum a San Pietroburgo perché accetti l'annessione; la Gran Bretagna
e la Francia, che ha spiegato chiaramente di non volere supportare le
richieste russe nei Balcani, invitano alla moderazione sia la Russia, loro
alleata dal 1907, sia la Serbia, spingendole a un compromesso. Come
avverrà.
Solo che nel frattempo, invocando affinità etnico-religiose, Serbia,
Bulgaria, Montenegro e Grecia ribadiscono le loro pretese su Macedonia,
Rumelia orientale e Tracia; e nel 1912, dopo lunghi negoziati, si uniscono
nella Lega balcanica. Stavolta Russia e Austria cooperano al di là dei
blocchi per prevenire un conflitto nella regione. Fallendo. Secondo il
leader greco Venizelos, le grandi potenze ormai non sarebbero che
"venerabili vecchie donne" (20) occupate a rimuginare "viete formule"
(21). La Lega non è interessata a rafforzare l'uno o l'altro schieramento,
vuole innanzitutto scacciare gli ottomani.
La guerra inizia a ottobre, è rapida e, a dispetto delle previsioni, rovinosa
per la Turchia; viene interrotta da un armistizio a dicembre; a gennaio
1913 ha una nuova fiammata; si conclude con il Trattato di Londra,
firmato dagli ambasciatori delle grandi potenze, che fanno rivivere il
Concerto europeo rivendicando il diritto a decidere sulle questioni in
sospeso. La Russia lascia cadere le aspirazioni serbe a un porto
sull'Adriatico, e accetta il nuovo principato albanese come Stato
cuscinetto, venendo incontro alle richieste di Austria-Ungheria e Italia.
Che a loro volta acconsentono all'ingrandimento della Serbia. Anche se
non intendono prostrarsi alle vecchie signore, di fronte alla perdurante
tenuta del loro sistema di potere, gli Stati balcanici sono costretti a cedere.
Ma le tensioni continuano. La lotta per l'assegnazione di alcuni territori
ex-ottomani sbocca a giugno 1913 nella seconda guerra balcanica, fra la
Bulgaria e tutti gli altri riuniti in coalizione. Accerchiata, la Bulgaria viene
disfatta nel giro di un mese, e il trattato di Bucarest del 1913 la penalizza
duramente, senza peraltro accontentare del tutto Serbia e Grecia.
Dietro questo arco di vicende, ci sono dinamiche intricate, in cui si
mischiano problemi strategici, politica interna, interessi economici,
idiosincrasie ed errori personali, fraintendimenti - e il caso. Ne esistono
analisi in dettaglio e in profondità (22). Per chi è amico della nonviolenza,
l'aspetto più importante è il rifiuto della grandi potenze a lasciarsi
coinvolgere nella guerra.
Uomini
Guardando a quei quarantaquattro anni dal punto di vista della pace
mantenuta, molte cose cambiano aspetto. A cominciare dall'immagine di
alcuni politici, militari, sovrani. Anziché malefici guerrafondai, come
vuole un potente luogo comune, appaiono, spesso, negoziatori, più o meno
efficaci, a volte incapaci. Sono anche adepti della pace?Per qualcuno
sembra di sì. Quando nel '12, alla vigilia della conferenza degli
ambasciatori, Grey propone insieme ai delegati francesi che le potenze
diffondano una dichiarazione di disinteresse per i problemi britannici,
l'ambasciatore tedesco a Londra, principe Lichnowsky, lo appoggia
nonostante il rifiuto della Germania, e critica la propria diplomazia, che
"ogni qualvolta i francesi cominciano a dimenticarsi della revanche, glielo
[ricorda] sempre con gli stivali dei militari" (23); nel '14 si impegnerà allo
stremo per la pace; al suo ritorno in patria sarà accusato di essersi fatto
manipolare da Grey.
Per moltissimi, dipende dalle circostanze. Nel '14-'15, Giolitti lotta contro
l'intervento italiano, e lo paga con una violentissima campagna di odio da
parte dei nazionalisti, "manifestazione terziaria della sifilide dannunziana"
(24); ma nell'11 aveva avallato la guerra in Nordafrica. Guglielmo II, che
"trovava la vita impossibile se la Prussia non l'applaudiva una volta al
giorno, la Germania una alla settimana, e l'Europa ogni due settimane"
5
(25), fino alla grande guerra non usurpa il soprannome di Kaiser della
pace, ma si produce in impennate pericolosissime. Lloyd George, pur non
essendo affatto un militarista, nell'11 aveva corso il massimo azzardo
ventilando la guerra contro la Germania.
Che i politici abbiano un'idea di pace piuttosto selettiva è evidente nei
Balcani. Di quei popoli, Guglielmo II aveva scritto sprezzantemente:
"Lasciate che se la sbrighino da soli. Si prenderanno una bella batosta o
altrimenti la daranno, e sarà quello il momento di mettersi a discutere [...].
Lasciateli proseguire indisturbati nella loro guerra. Gli Stati balcanici
mostreranno allora ciò che sanno fare [...] le grandi potenze devono
stendere un cordone intorno al campo di battaglia in cui avrà luogo questo
conflitto e dentro il quale deve essere delimitato" (26). Il sangue balcanico
era evidentemente meno pregiato di quello delle grandi potenze, se anche
Kiderlen, ministro degli Esteri tedesco, non vedeva l'ora che "i bravi turchi
dessero finalmente una buona lezione ai predoni del basso Danubio" (27);
e se, come ricorda Poincarè, presidente della Repubblica francese allo
scoppio della guerra, la preoccupazione di tutte le potenze era evitare un
conflitto paneuropeo - i Balcani sono Europa, ma evidentemente un pò
meno Europa del resto del continente. Lo stesso vale oggi per la Cecenia:
"dopo due guerre e un genocidio, gli europei stentano ad ammettere che
Grozny è in Europa" (28).
In generale, scrive Mulligan, "i governi ebbero molte meno esitazioni a
fare ricorso alla violenza al di fuori della loro cerchia, e la violenza non
fece distinzioni tra uomini bianchi e altre razze, come scoprirono a loro
spese i boeri e gli spagnoli" (29).
Ma il compito principale della storia non è guardare come le persone sono
fatte dentro, o, per usare le parole dello storico tedesco Gustav Droysen,
scrutare nel sacrario della coscienza. È descrivere il campo di possibilità
in cui si muovono, ed è qui che le interpretazioni attente alla pace
scoprono quel che i fautori della guerra inevitabile non potevano vedere:
che il sistema internazionale non necessariamente produce conflitti, al
contrario ha un potenziale stabilizzante.
Sistemi
La deprecata divisione dell'Europa in due sistemi di alleanze non è in
realtà così rigida: sia pure con più o meno forti difficoltà, Stati fra i quali
esiste un contenzioso, come Austria-Ungheria e Italia, sono uniti nella
stesso schieramento; paesi collocati in versanti opposti possono stringere
intese bilaterali o collaborare su punti secondari, ma utili ad allentare le
tensioni; o possono trovarsi dalla stessa parte in una controversia - gli
interessi geopolitici non sempre corrispondono ai blocchi.
Le alleanze non impediscono fasi di apertura reciproca, come la
distensione anglo-tedesca del '12-'13, nè la cooperazione economica e
finanziaria. Nel '14, per esempio, la Gran Bretagna era il miglior partner
commerciale della Germania, che riceveva anche il 44% delle esportazioni
russe e mandava in Russia il 47% delle proprie. Le trattative anglotedesche sulla ferrovia di Bagdad si erano concluse con un accordo appena
prima della crisi di luglio. Fattori diplomatici minori, come le
commissioni internazionali sui confini e lo statuto di neutralità di alcune
vie d'acqua e di terra, disegnavano una fitta rete di accordi fra le grandi
potenze; le compensazioni coloniali erano usate per controbilanciare
battute di arresto e perdite territoriali.
La dissuasione e il contenimento, le reti di relazioni trasversali - e la
violenza contro Stati asiatici e africani - non sono episodici. È attraverso
questi strumenti e pratiche che le alleanze riescono a non innescare
reazioni a catena, possono anzi bloccarle. Nate principalmente per offrire
sicurezza e mutuo sostegno militare, spingono i paesi che non vogliono
essere trascinati in una guerra estranea alle loro strategie a distogliere i
loro partner da scelte irreparabili (30) - come avviene lungo questi
decenni. Il ricorrere delle crisi nelle stesse aree, Balcani, Nordafrica,
Estremo Oriente, suggerisce che le soluzioni si basavano su compromessi,
destinati a evitare una divisione netta fra vincitori e vinti e a contenere i
rancori degli Stati meno favoriti (31).
Alla vigilia dell'attentato di Sarajevo, le dispute coloniali e commerciali
che avevano contribuito a infiammare l'Europa erano risolte o in via di
soluzione. Anche se le ambizioni imperiali entravano in collisione nel
mondo, gli interessi vitali in contrasto erano relativamente pochi, e - punto
cruciale - la guerra era considerata una scelta estrema.
Da pace a guerra
Eppure nel '14, le condizioni che avevano mantenuto la pace non fermano
la guerra. Alcuni elementi del sistema delle alleanze erano di per sè
problematici: il confine tra la dissuasione efficace e la forzatura era
incerto, e ambigui i concetti di equilibrio dei poteri e di interessi vitali di
una nazione, diversi da fase e fase e altamente manipolabili.
Non solo. La serie di crisi e guerre circoscritte iniziata nel 1911 aveva
rivelato i limiti del controllo delle potenze sui fatti europei, la rivalità
austro-russa nei Balcani aveva svuotato il Concerto delle nazioni, nella
seconda metà del 1913 il ruolo di mediazione delle alleanze vacillava.
Temendo di perdere il loro status di grande potenza, Austria, Russia e
Germania avevano ormai optato per una politica più intransigente. La
distensione anglo-tedesca, uno dei principali fattori di stabilizzazione, era
stata indebolita nella primavera del 1914 da una convenzione navale
anglo-russa - per Grey un aggiustamento minore, ma un colpo per la
Germania. Che decide di affidare la propria sicurezza alla sola alleanza
con l'Austria, mentre la Russia non intende più essere limitata da Francia e
Gran Bretagna. I blocchi diventano così più rigidi, e insieme meno
efficaci.
L'ultimatum austriaco alla Serbia fa schierare la Russia con il suo primo
alleato nei Balcani, la pressione di Grey per affidare la soluzione al
Concerto della nazioni viene respinta dalla Germania e dall'Austria, che
mobilita l'esercito, seguita dalla Russia il 30 luglio, e immediatamente
dopo dalla Germania, che inizia l'invasione del neutrale Belgio. È per
questo, ufficialmente, che il 4 agosto la Gran Bretagna dichiara guerra alla
Germania. Vero, ma almeno altrettanto conta la volontà di preservare gli
equilibri di potere.
Nonostante le mobilitazioni, la guerra si sarebbe potuta ancora evitare, o
circoscrivere a Serbia e Austria-Ungheria, come fa capire il clima
"disperato, frenetico, isterico, convulso" di fine luglio, quando nelle
capitali si cerca una via d'uscita in extremis. "Il contagio mondiale è il
risultato di un accavallarsi di decisioni ognuna delle quali, presa
singolarmente, non era pensata per provocare un conflitto, ma che
interagirono una con l'altra" (32), in una bancarotta delle norme
diplomatiche e politiche del passato. Il che non vuol dire che la guerra
fosse inevitabile, ma che si erano affievoliti - si era permesso che si
affievolissero - i vincoli alla pace. In primo luogo la riluttanza a iniziare
una guerra fra grandi potenze per controversie coloniali, pubblici affronti,
o per l'acquisizione di un territorio, inclusa l'Alsazia-Lorena o il Trentino.
Nessuno dei maggiori Stati voleva un conflitto generale nel 1914; ma tutti
erano disposti a rischiarne uno - il che segna la differenza rispetto alle crisi
precedenti, dove al massimo uno Stato o un blocco avevano scelto di
rischiare.
Una guerra indesiderata
La prima tragedia di questa guerra è che in nessuno dei paesi coinvolti
esistono pressioni insostenibili in suo favore. La sinistra internazionalista
è dovunque più forte della destra e dell'estrema destra, cui alcuni politici
conservatori guardavano con disprezzo - "con questi idioti", aveva detto il
cancelliere tedesco Bethmann-Hollweg, "non si può condurre una politica
estera" (33). In Gran Bretagna il partito liberale vince tre elezioni
consecutive contro un'opposizione conservatrice manifestamente più
bellicosa. In Germania l'Spd, il partito socialdemocratico, ottiene il suo
maggiore successo elettorale nel 1912, facendo una campagna contro "il
rincaro del pane a causa del militarismo"; e conta nelle sue file grandi
teorici internazionalisti come Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. In
Francia alle elezioni dell'aprile 1914 torna una maggioranza di sinistra. In
Russia più di un milione di lavoratori, circa il 60% degli operai
dell'industria, sono coinvolti negli scioperi del 1914. In Belgio il partito
cattolico fa opposizione ai progetti di aumento delle spese per la difesa.
È vero che il "pacifismo" dichiarato aveva poco peso politico in quegli
anni, anche perché era diviso fra socialisti, contrari a mischiarsi con i
pacifisti della borghesia e dell'aristocrazia, e quanti pensavano invece che
"persino i re" avrebbero dovuto dare un contributo. Ma, come scrive
Churchill nelle sue memorie, in Gran Bretagna, e non solo, "l'idea della
pace era entrata ormai nella mente di ognuno" (34). Dunque il militarismo
non era affatto la forza dominante della politica europea alla vigilia della
grande guerra. Al contrario, era in declino, in buona parte come diretta
conseguenza della democratizzazione politica.
Neppure il nazionalismo aveva un seguito di massa. La "comunità
6
d'agosto", l'ondata di entusiasmo innescata dalla prospettiva della guerra,
era giovanile, cittadina, di classe media, maschile, e assolutamente
minoritaria. In Germania, secondo alcuni studiosi, "l'euforia per la guerra
è in larga parte un mito postbellico creato da politici e propagandisti di
destra nel periodo di Weimar per contrabbandare un'immagine di unanime
passione nazionale, poi distrutta dall'attivismo antimilitarista dei
socialisti" (35).Tranne che in Italia e Russia, i nazionalisti erano più
fragorosi che influenti. Del resto prima del 1914 il principio di nazionalità
era contraddetto da vecchi e nuovi Stati plurietnici e plurilingue, e da
minoranze che non aspiravano alla sovranità - i cechi, gli slovacchi, gli
scozzesi, gli ebrei.
I militari di rado riuscivano a manovrare i governi, anche se in Russia e
Germania sono decisivi nell'ultima fase della crisi - il capo di stato
maggiore russo Nikolaj Januskevic addirittura "stacca il telefono" per
impedire a chiunque (per esempio allo zar) di dargli contrordini che
avrebbero bloccato la mobilitazione (36).
Fra i banchieri, gli industriali e gli uomini d'affari molti erano terrorizzati
dalla prospettiva di una guerra che avrebbe sconvolto il sistema
tendenzialmente globalizzato da cui avevano tratto profitti enormi (37).
L'antipatia popolare fra tedeschi e inglesi era scemata, mentre rimanevano
stretti i rapporti fra socialdemocratici e fabiani - quando scoppia la guerra,
Sidney e Beatrice Webb erano sul punto di partire per la Germania, dove
avrebbero studiato i sindacati, la cooperazione e le forme dell'intervento
statale. Fra i diplomatici e i politici, la soluzione delle crisi fra l'11 e il '13
aveva favorito una certa fiducia nel fatto che la precipitazione si potesse
evitare.
Per quali strade passa allora la guerra?La corsa agli
armamentiPraticamente tutti gli storici indicano alle radici della guerra le
rivalità economiche e la controversia anglo-tedesca per la supremazia
navale, la volontà dei militari, le campagne di stampa violente, le tensioni
innescate dai nazionalismi radicali, tanto nemici e tanto simili: il critico
teatrale George Jean Nathan aveva scoperto che una piece di gran
successo a Broadway, scritta da un "osservatore neutrale" e costruita sulla
dicotomia classica buoni-cattivi, era rappresentata identica, a ruoli
capovolti, nei teatri del nemico (38).
Per alcuni, su tutti i fattori in gioco spicca la corsa agli armamenti,
accelerata dopo la crisi marocchina dell'11 (39). Non si trattava solo di
quantità, anche se l'organico di tutti gli eserciti viene enormemente
gonfiato. È competizione tecnologica. Le corazzate veloci messe a punto
in Gran Bretagna accentuano la rincorsa tedesca. La Francia ha sviluppato
un cannone da 75 millimetri a tiro rapido. Nel 1913 la Russia sta
continuando il suo piano di riarmo complessivo, con l'aumento dei pezzi
di artiglieria e nuove linee ferroviarie per il trasporto di truppe. Dalla fine
del 1911 in Germania e Austria-Ungheria c'è un boom delle spese militari,
che crescono anche in Italia e ancora di più negli Stati balcanici.
Alle origini del fenomeno non c'è un progetto di guerra, c'è una logica di
tutela degli "interessi vitali" e di autodifesa - il leitmotiv della deterrenza
non nasce nel secondo dopoguerra. Concepito come mezzo per creare una
superiorità capace di strappare concessioni agli altri paesi o di consentire il
rifiuto di richieste sgradite, il potenziamento militare è il fulcro di una
strategia del rischio calcolato, che dovrebbe raggiungere i suoi obiettivi
senza neppure aprire le ostilità.
Ma se interesse vitale è un'espressione ambigua, lo è ancora di più il
concetto di autodifesa. Nel luglio 1914 tutte le grandi potenze sostengono
di essere sul punto di iniziare una guerra difensiva, il tema dell'unione
sacra contro la barbarie crea un clima da crociata. È frutto, anche, di
questa pressione il crollo della II Internazionale, che riporta i partiti
socialisti (eccetto il russo e il serbo e in parte l'italiano) negli alvei
nazionali, mentre i governi si premurano di tacitare o perseguire la
componente che si oppone alla linea "patriottica".
L'autonomia della violenza
Il punto è che la corsa agli armamenti funziona come un piano inclinato:
l'aumento degli arsenali bellici in un paese provoca un aumento in altri, il
che spinge il primo a rafforzarsi ulteriormente. I politici che avevano
gestito con successo l'uso o il potenziale uso della forza militare ormai
sono dominati dalla paura di restare permanentemente indietro.
Questo inseguimento non è un effetto perverso: è la conseguenza
prevedibile del principio "si vis pacem para bellum", che Bertha von
Suttner, esponente del pacifismo giuridico e premio Nobel per la pace nel
1905, definiva "un residuato antico-romano", e che al luminoso buon
senso del deputato britannico Wilfred Lawson sembrava ridicolo come
dire a un ubriaco "se vuoi essere sobrio, vivi in un pub". Nella proposta di
accordo internazionale per limitare gli armamenti, il ministro degli Esteri
russo Murav'ev aveva scritto che "più aumentano gli armamenti di una
grande potenza, sempre meno viene soddisfatto lo scopo che il governo si
era proposto con quell'aumento" (40).
Eppure la rincorsa continua, anche se, contrariamente a un luogo comune
diffuso, non tutti i politici e i militari ritenevano che la guerra si sarebbe
risolta in una rapida serie di battaglie; anche se alcuni osservatori già a
fine Ottocento avevano previsto la sua infinita portata distruttiva (41).
Mentre alla conferenza sugli armamenti si ottiene un accordo soltanto
sulla richiesta di rallentarne il ritmo di produzione, l'uso di termini come
pace armata e deterrenza si intensifica, la diplomazia ad alto rischio
sostenuta dalla forza militare sembra un'opzione più accettabile; si apre lo
spazio per il concetto di "finestra di opportunità", o, per usare le parole di
diversi generali, del "prima è, meglio è" - per la Germania, vuol dire prima
che la Russia completi la preparazione alla guerra. Come per un singolo
possedere un'arma è una tentazione, così la disponibilità di arsenali enormi
lo era per gli Stati: "C'è un limite - scriverà Charles Seymour a proposito
delle tensioni balcaniche - alla capacità dei governi di resistere alla
tentazione di una guerra" (42).
Le scelte politiche sono decisive, ma non da sole. Nel 1914 il piano
inclinato della rincorsa agli armamenti e la tecnologia della violenza
avevano sviluppato una dinamica propria, trasformandosi da questione
politica a problema sistemico - in altre parole, l'Europa era ormai avvolta
in una rete militarizzata che i leader non erano in grado di controllare. "Fu
così - scriverà Lloyd George nelle sue memorie - che i grandi armamenti
provocarono la guerra" (43). In altre parole, è così che si creano le
premesse per l'eterogenesi dei fini.
In gran parte è vero. Ma neppure la corsa agli armamenti può essere vista
come la causa della guerra. Fra il '45 e l'89, la competizione nucleare fra
Usa e Urss non è sfociata in un uno scontro diretto, e secondo alcuni a
impedirlo ha concorso la consapevolezza che avrebbe innescato
meccanismi incontrollabili. La responsabilità dei governanti nello scoppio
della grande guerra sta appunto nella presunzione di padroneggiare quella
dinamica - quasi che la violenza sia semplicemente un mezzo da usare se
necessario, anziché una potenza capace di cambiare chi la subisce e chi la
pratica. Nel 1918, nessuno ammetterà questo reato di superbia.
Strano che la tesi della guerra evitabile sia ritenuta consolatoria, mentre
mostra che si finisce in guerra anche senza volerlo, basta smettere di
cercare la pace. Strano che sia a volte etichettata (44) come un futile
esempio di storia fatta con i "se": descrivere gli errori e i passi falsi che si
potevano evitare per evitare una catastrofe è un lavoro fra i più interessanti
(45) - almeno finché le guerre rimangono un fulcro delle interpretazioni
storiografiche.
Due villaggi dei Balcani
Nella grande guerra, in quelle balcaniche (e non solo), si incontrano
esempi di fraternità, senso dell'onore, autonomia di pensiero - taciuti per
decenni e messi in luce a partire dagli anni Sessanta - che alcuni autori
considerano sopravvalutati, semileggende cui solo gli ingenui danno
ancora credito.
Molto dipende dalle domande che ci si pone. Chiedere ai comportamenti
dei soldati della grande guerra nientemeno che di metterle fine, come fa
Niall Ferguson, è un criterio estremista, e stupisce in un sostenitore del
conflitto evitabile: se si valorizzano gli elementi anche minori che
contribuiscono a sventarlo, perché non fare lo stesso per quelli che aiutano
a limitare la distruttività dopo che è scoppiato?Secondo tutti i resoconti, le
guerre balcaniche sono un precipizio di spietatezza reciproca, in cui la
norma era irrompere nei villaggi del "nemico", saccheggiarli e incendiarli,
stuprare donne e bambine, torturare, uccidere.
I delegati della commissione internazionale creata dalla Carnegie
Endowment for International Peace (46) lavorano per mesi, raccogliendo
una casistica impressionante di crimini su militari, civili, prigionieri di
guerra (47), perpetrati sia dagli eserciti e da bande armate, sia dalle
comunità etniche le une contro le altre.
Nessuno è esente. Non gli uomini della Lega balcanica, che lasciano
7
dietro di sè cadaveri, rovine, e in qualche caso battesimi forzati a opera di
preti ortodossi chiamati appositamente. Non gli ottomani, che, salvo le
conversioni, fanno lo stesso. L'alternarsi degli eserciti sul territorio dà
spazio alle peggiori ritorsioni, in una pratica di "pulizia etnica" che
spingerà molti a emigrare.
Ma ci sono due villaggi bulgari, uno a maggioranza cristiana, DervicheTepe, l'altro a maggioranza turco-musulmana, Khodjatli, dove le cose
vanno diversamente. Durante la prima guerra, mentre l'esercito bulgaro
avanza, sessanta turchi chiedono protezione ai loro vicini cristiani. La
ottengono, e al passaggio delle truppe restano indisturbati. Fra loro, un
mercante di caffè che racconta ai delegati il seguito: "quando sono tornati i
turchi, avevano l'ordine di non toccare il villaggio: ai contadini hanno
detto: 'Non abbiate paura, voi che avete salvato la nostra gente, abbiamo
una lettera da Costantinopoli dove è scritto di lasciarvi in pacè" (48).
Evidentemente quei contadini turchi avevano fatto arrivare la notizia alla
capitale.
Non si sa se ci siano stati altri fatti simili: la commissione indaga sui
crimini compiuti, non su quelli evitati. Non si sa granché neppure
dell'episodio, che compare in poche righe nel Rapporto conclusivo. Forse
la propaganda di odio etno-religioso non era arrivata a Derviche-Tepe,
forse gli abitanti avevano deciso che i loro vicini erano esseri umani come
loro, con lo stesso diritto di vivere nei luoghi dove erano nati. Certo
dovevano sapere che dagli altri villaggi poteva partire una delazione con
l'accusa, gravissima, di connivenza con il nemico; lo stesso rischio che
corrono i turchi quando sono loro a farsi protettori. Vecchio meccanismo
destinato a ripetersi: in Ruanda, gli hutu che nascondevano tutsi dovevano
agire in segreto (49), come in tutte le guerre civili, dove i moderati e i
dialoganti sono le prime vittime degli estremisti del loro gruppo di
appartenenza.
La storia di Derviche-Tepe e di Khodjatli non compare in nessun libro
sulle guerre balcaniche, nè nei grandi archivi on line, che rimandano
invariabilmente all'Inchiesta Carnegie. Peccato. Ma oggi azioni come
queste hanno un nome: comportamenti di pace in tempo di guerra, o
diplomazia di base - a conferma che i principi della nonviolenza hanno
raggiunto una parte almeno degli osservatori.
Perché si combatte?
Il fronte occidentale è il simbolo della guerra di trincea, la tripla serie di
cunicoli distribuiti su una linea che va dal Mare del Nord fino alle Alpi, e
che tra il '15 e il '18 non si sposterà mai di più di 15 chilometri.
Nel chiuso delle trincee i soldati fanno una vita da topi o da talpe, ne
escono per essere buttati all'attacco e di notte per tagliare reticolati nemici,
riparare i propri, trasportare materiali; muoiono per caso, "senza aver visto
e capito niente" (50). Ma non sempre e non ininterrottamente.
Sull'esperienza della guerra sul fronte occidentale esistono opere
splendide, fondate su atti di processi, resoconti ufficiali, lettere conservate
negli archivi della censura militare, documentari, letteratura dell'epoca. E
su scritti dei combattenti, una "emorragia di espressione" (51) che per la
prima volta in Occidente coinvolge contadini e operai, facendo giustizia di
molta retorica eroicista. Se fra gli ufficiali e i corpi di elite può vigere una
concezione paracavalleresca dell'onore e del valore, per molti proletari la
guerra è un nuovo insieme di mansioni sfiancanti, sporche e mortalmente
pericolose comandate da un caposquadra in divisa (52). La differenza di
classe si sente e scava un abisso fra il militare di leva e il volontario, che al
primo sembra un giocatore d'azzardo, un irresponsabile, un vizioso da
deridere e perseguitare (53). Ma dopo qualche mese di trincea anche per
molti giovani di classe media l'immagine della patria tracolla.
Perché allora si continua a combattere? Secondo l'epigono di Freud Niall
Ferguson, gli uomini lo fanno perché lo vogliono, perché hanno scoperto
che uccidere è facile, liberatorio, inebriante (54): è la vecchia tesi della
guerra come liberazione dai "lacci" della civiltà o come apprendistato per
"veri uomini", che stranamente sorvola sul primato della tecnologia e sul
nuovo, rigido sistema di vincoli in cui i soldati si trovano immersi.
È vero che solo nel '17-'18 si arriva alle diserzioni e rese di massa (milioni
di russi e austro-ungarici, 340.000 tedeschi, 300.000 italiani (55)) grazie
alle quali i combattimenti evaporano per mancanza di combattenti. Ma
fino a quell'anno, neppure nel cosiddetto fronte interno si arriva a vere e
proprie sollevazioni e a critiche esplicite di figure eminenti. Sono del '17
la rivoluzione di febbraio e quella di ottobre, che fanno sperare
nell'avvento di un'era di giustizia; la nota di Benedetto XV in cui si
definisce la guerra una inutile strage; l'intervento americano, che rende
familiari le proposte di Wilson per un mondo pacificabile in virtù di un
nuovo assetto internazionale. Vuol dire che fino al 1917 la guerra era
popolare? Inferire dall'assenza di rese di massa la volontà di combattere
equivale ad attribuire alle donne maltrattate che esitano a denunciare il
marito la volontà di continuare a farsi maltrattare.
Se la voluttà del sangue può contagiare, se il gigantismo della macchina
bellica può generare una stupefatta complicità, secondo moltissime
testimonianze si combatte per altri motivi: amore per il proprio paese,
fiducia in un comandante, senso del dovere, spirito di vendetta, fatalismo.
Ma innanzitutto per costrizione e per mancanza di alternative. La fuga, la
diserzione, la ribellione individuale agli ordini, l'ammutinamento - per lo
più contro la prospettiva di tornare in prima linea o di andare all'assalto
(56) - portano alla corte marziale. Le fucilazioni sul posto per
disobbedienza o "codardia" non sono fatti isolati, i tribunali militari
lavorano su vasta scala. Può succedere che gendarmi e ufficiali sparino sui
propri soldati per costringerli a uscire dalle trincee. Darsi prigionieri è
doppiamente pericoloso: si può essere uccisi dai catturatori, per vendicare
un compagno, a volte soltanto per non dividere con i nuovi venuti le
razioni già insufficienti (57); si può, se si è soldati semplici (58), dover
lavorare duramente con viveri ridotti al minimo. Si può morire di fame e
malattie da fame (59).
Ma nei comportamenti gioca anche una spinta morale che per un'infinità
di combattenti non guarda alla politica, a un dio, a un sovrano, alla patria fra le lettere censurate, si trovano espressioni come "state pur certi che io
non muoio per questa schifa di Italia" (60), o "Fa venire il voltastomaco
essere francesi. [...] I veri criminali non sono qui, sotto tiro. [...] La legge
li difende" (61).
L'impegno morale ha per destinatari i compagni: si continua a combattere
anche quando ne diventa lampante l'insensatezza, cioè spesso, per fedeltà
ai più vicini, per non lasciarli soli, se possibile per salvarli. Non solo in
questa guerra: delle otto medaglie ottenute da un reparto di marines nel
1944, sei riguardavano uomini che si erano buttati a coprire le granate con
il proprio corpo per fare scudo agli altri (62).
Piuttosto che da solidarietà precedenti o da sentimenti umanitari, il legame
nasce dal mondo stesso delle trincee, dove si soffre e si rischia insieme, e
nella vita in comune uomini molto diversi finiscono per assomigliarsi.
E sperimentano qualcosa di importante: per un singolare paradosso, è il
soldato, non l'uomo di pace, a imparare per primo a farsi carico del suo
simile, sostituendo alla "virtù eroica" del combattimento quella che
Todorov definisce virtù quotidiana della cura (63). Significa misurarsi con
l'arte di ascoltare e di parlare, di palesare uno stato d'animo o di
nasconderlo se si sa che può ferire o scoraggiare - "medicine del cuore
somministrate in dosi premurose" (64). Significa badare al corpo dell'altro
- non più il corpo in boccio il cui fascino omoerotico affiora in tanta
letteratura (65), ma lo scempio che spesso ne resta - da pulire, medicare,
tenere vicino negli ultimi istanti, superando paura o disgusto: in trincea si
vive e si muore fra sangue, escrementi, pus, stracci luridi (66) - e magari
accanto a una pentola bucata (67). La guerra è forse l'unica occasione in
cui giovani maschi praticano - fra pari - un lavoro di cura simile a quello
riservato a figure professionali come medici, infermieri, educatori,
psicologi (68). E, da sempre, assegnato alle donne. Un soldato francese
aveva detto di aver vissuto in trincea i suoi momenti più teneri (69) - e per
questo potenzialmente forieri di smisurato rancore verso chi minaccia o
falcidia il gruppo.
Interpretare questa "manutenzione della vita" in chiave di cameratismo o
spirito di corpo (che pure esistono e contano) rischia di nascondere il loro
potenziale antibellicista (70). Che diventa indiscutibile quando si comincia
a riconoscere come simile il nemico, "uomini e soldati come noi, fatti
come noi, in uniforme come noi" (71).
Prove di nonviolenza
Se hanno scoperto il piacere della violenza, i soldati hanno scoperto anche
quanto sia mortifera la teoria degli stati maggiori, secondo cui la vittoria
premierà chi sarà riuscito a eliminare il maggior numero di nemici al
minor costo per le finanze statali (72). La verità del fronte è un'altra: se
non si vuole morire, è consigliabile non uccidere - il che implica
combattere il meno possibile, e se si è costretti, inventare un modo, vari
8
modi di contenere la distruttività. In guerra il dilemma del prigioniero si
configura così: se io sparo e lui no, lui muore; se lui spara e io no, morirò
io; se spariamo tutti e due, tutti e due moriremo; se nessuno spara, tutti e
due vivremo.
L'esempio più noto della quarta alternativa è la tregua del primo Natale di
guerra. Nel 1914 la proposta di un cessate il fuoco generale avanzata dal
papa e da gruppi di suffragiste viene respinta da vari paesi. Ma in alcuni
settori del fronte occidentale quel giorno vede una calma assoluta; è il
frutto di una serie di tregue decise da soldati inglesi e tedeschi, iniziate
con gli scambi di auguri da una trincea all'altra, culminate nell'incontro
sulla terra di nessuno per scambiarsi sigarette e piccoli doni, e proseguite
in qualche caso fino all'anno nuovo. Grande momento di fraternità, la
tregua di Natale commuove e strappa ammirazione; non è strano che sia
diventata una leggenda, arricchita di elementi a volte più suggestivi che
comprovati (73).
Non ci saranno più eventi di questa portata, sia per le reazioni dei comandi
britannico e tedesco, sia perché i massacri del '15-'16 possono riattivare
l'ostilità reciproca - con il tempo, altri soldati guarderanno alle tregue di
Natale con una certa sprezzante ironia (74).
Ma prima e dopo quella tregua non c'è il vuoto, c'è un tessuto a macchia di
leopardo di accordi taciti, diversi per durata e obiettivi, all'insegna del
principio: "vivi e lascia vivere" declinato in tutte le lingue, e dello
"scambiarsi la pace" anziché la guerra. Prove di nonviolenza, si
potrebbero definire, figlie del pragmatismo, e della paura e del coraggio,
che anticipano e calano nella realtà uno slogan pacifista dei nostri anni: tra
uccidere e morire c'è un'altra scelta, vivere.
Ci sono tregue ad hoc, circoscritte ad alcuni momenti della giornata, come
quelle per il cibo. Racconta un sottufficiale inglese che quando un gruppo
della prima linea usciva per andare a prendere il rancio, dalla parte
opposta nessuno sparava, e lo stesso succedeva quando a uscire erano i
tedeschi. È una delle forme più durature del vivere e lasciar vivere. "Dopo
tutto, se impedisci al nemico di prendere le sue razioni, il suo rimedio è
semplice: ti impedir" di prendere le tue".
Ci sono le tregue del cattivo tempo. Se grandi piogge si abbattono sulle
trincee, i soldati ne escono restando in piena vista gli uni degli altri.
Nessuno ha voglia di sparare. In un caso almeno, vanno a prendere dallo
stesso mucchio la paglia per ripararsi e tenersi caldi.
Ci sono le tregue umanitarie, a volte improvvisate, come quando un
battaglione britannico della XVI divisione è invitato dai tedeschi a
raccogliere i feriti rimasti nella terra di nessuno, e prima che gli ufficiali
delle due parti riescano a intervenire, l'accordo è fatto, e si estende
velocemente agli altri reparti del settore (75).
C'è la ritualizzazione della violenza, un modo per risparmiare il sangue
persino durante i combattimenti, quando il compito è uccidere prima di
essere uccisi. A Verdun, in un settore poco esposto, un volontario tedesco
riferisce che i francesi avevano l'ordine di bersagliarli con bombe a mano
anche di notte, e di fatto le lanciavano, ma, come da accordi presi con
compagni tedeschi, solo sulla destra e sulla sinistra della trincea (76).
Infine c'è l'inerzia, che gli alti comandi definiscono "l'insidiosa tendenza a
scivolare in un'attitudine passiva e letargica" (77).
Ipnotizzati dalla fraternizzazione, gli stati maggiori la perseguono
sistematicamente, e facilmente. Le tregue tacite sono invece sfuggenti. Da
un lato, sebbene tutti pretendano un'attività costante, nel '14-'15 nessuno
ha una strategia definitiva per la guerra di trincea, dunque l'inerzia non è
una violazione di ordini specifici nè un reato da corte marziale. D'altro
lato, è difficile capire chi ha adottato quel comportamento, quali ufficiali
l'hanno tollerato, e prima ancora se c'è stato davvero un accordo.
Ma a volte può bastare il sospetto o un episodio minore per deferire alla
corte marziale. Quando un ufficiale tedesco e forse venti uomini erano
usciti dalle trincee gridando "Good morning, Tommies, avete delle
gallette?" e nessun inglese aveva sparato contro di loro, i due ufficiali
presenti sono arrestati, e poco dopo trasferiti con l'intero reparto nella
fabbrica di cadaveri che è il fronte della Somme (78).
Vicini di casa
Le tregue informali sono fragili, per farle saltare basta che arrivi in trincea
la polizia militare a controllare la situazione, o che qualcuno cominci
inopinatamente a sparare mentre gli avversari sono occupati in una delle
attività "protette". Sono rischiose: il nemico può tendere una trappola, un
compagno zelante può trasformarsi in delatore, un compagno solidale può
essere un infiltrato dei Comandi. Le zone davvero "quiete" sono rare,
come lo sono le zone superbelligeranti; per lo più, aggressività e inerzia si
mischiano in modo imprevedibile, e la scelta di passare all'attacco è
possibile anche in condizioni estreme. Eppure tanti continuano a cercare
lo scambio della pace. Conta la religiosità, contano ideali anarchici e
antimilitaristi, o un cuore buono senza marchio di origine. Il fattore più
importante è il conflitto stesso.
Insieme a una enorme capacità distruttiva, la guerra di trincea ha una
potenzialità opposta. Spesso i soldati sono relativamente vicini, possono
origliare e scrutare, poi guardarsi e sentirsi, quanto basta a capire che le
sofferenze e la paura sono le stesse, simile la voglia di farla finita con il
sangue. È la prima condizione perché possano nascere l'empatia e la
compassione reciproca. E infatti i più coinvolti sono i reparti di fanteria, il
corpo che resta nelle trincee per tutta la guerra, il corpo per eccellenza dei
contadini, distolti dal lavoro dei campi per essere sbattuti in mezzo a una
natura devastata che - ci si chiede - chissà quando tornerà fertile. Ma fra
l'empatia e lo scambio di pace c'è il serissimo problema della
comunicazione.
Quando si può, ci si parla; oppure ci si scambiano messaggi arrotolati
dentro bombe disinnescate o intorno a una pietra. In uno c'era scritto:
"Stiamo per bombardarvi. Dobbiamo, ma non vogliamo. Sarà per
stamattina, fischieremo due volte per avvertirvi" (79). Sul fronte austroitaliano, alcuni soldati avevano addestrato un cane a portare biglietti da
una trincea a quella opposta - con la globalizzazione e l'emigrazione, è
facile che qualcuno conosca la lingua del nemico. Uno dei biglietti diceva:
"Cari fratelli, vi facciamo consapevoli che siamo stanchi di questa guerra,
e se i nostri diplomatici non la vogliono terminare noi italiani verremo
tutti da voi, prima che venga l'inverno. Fate il piacere di non tirare. Potete
mandarci nuovamente questo cane con un bigliettino. State bene
arrivederci. Sarebbe ora di terminare questa misera guerra, addio" (80). È
il sogno di una pace senza vincitori nè vinti, che coincide con la famosa
frase di Wilson sulla necessità di una pace senza vittoria (81).
Se si era troppo lontani, si ricorreva a comportamenti simbolo. La
fraternizzazione non è uno slancio spontaneo, è il frutto di un
avvicinamento graduale - una mano che saluta, una testa che fa capolino,
qualcuno che scavalca il parapetto, pronto a ributtarsi indietro. Oppure il
canto di un motivo popolare - Stille Nacht o la versione inglese Silent
Night, ma anche Tipperary e Wacht am Rhein. Mentre l'inerzia, oltre che
per scambiarsi la pace, funziona benissimo per far capire le proprie
intenzioni.
Si era creato così, per tentativi, un sistema di comunicazione non verbale,
un codice comprensibile dai combattenti delle trincee, non da estranei, che
poteva smentire le rappresentazioni ufficiali dello spazio bellico, secondo
cui più i combattenti sono vicini più aumenta il rischio (82). A volte era
vero il contrario - vedere i feriti nemici che giacevano indifesi nella terra
di nessuno poteva favorire una tregua umanitaria, o uno scatto individuale:
"Ho visto gente che è uscita a raccogliere anche il nemico, andar fuori in
mezzo alla sparatoria a portare il compagno ferito [...] perché lì in trincea
succedevano delle cose curiose" (83).
Grazie a questo codice, soldati che spesso non potevano vedersi nè
parlarsi riuscivano a palesare la loro volontà di pace - e il proprio senso
dell'onore. Quando i reparti stavano per essere avvicendati, cercavano di
informare i "nemici", perché non si esponessero contando sui vecchi
accordi. Oltre che sulla differenza fra i combattenti e tutti gli altri in
uniforme e sui modi di sfidare con intelligenza l'autorità degli inetti (84),
le reclute venivano iniziate "all'arte della guerra come all'arte della pace",
e spesso in termini espliciti. Durante la visita a una postazione avanzata,
un ufficiale chiede al nuovo venuto se gioca a cricket. "Un pò", e se
saprebbe tirare la palla fino alla trincea opposta. "Penso di sì". "Allora
potresti farlo con una granata... ma comunque non ne avrai voglia. Non
svegliare il can che dorme. Se gli tiriamo una bomba, puoi scommettere
che ce la restituiranno, e Mr Digby e Mr 'Arris [i soldati che tenevano la
postazione] sono uomini sposati. Non è il cricket, sai?" (85).
Qui il nemico non è il fratello, come a volte è accaduto e come ci
piacerebbe che fosse. Ma è quantomeno un vicino di casa con cui è giusto
tenere un comportamento corretto e rispettare la parola data.
Peccato che tregue e fraternizzazione, sebbene citate in molti testi, non
9
compaiano come oggetto storico autonomo, inserito in una genealogia
diversa da quella delle guerre.
Ma l'esempio non si è del tutto perso. Ottanta anni dopo, nella Sarajevo
assediata, un reparto serbo che aveva fatto una periodica "tregua del
calcio" con alcuni combattenti bosniaci, li avverte: "Noi domattina
andiamo a casa e arriverà un altro gruppo. Loro sicuramente spareranno.
Se non state attenti, se quelli vi ammazzano, con chi giocheremo noi?"
(86).
La cosa giusta
Che queste prove di nonviolenza nascano, come la fedeltà ai propri
compagni, dall'esperienza diretta, mostra che alle armi può contrapporsi la
critica delle armi. In uno scontro in cui su tutti i combattenti incombe la
strapotenza della guerra tecnologica, identificarsi con il nemico e con la
sua volontà di sopravvivere è logico, addirittura necessario: se ogni colpo
di mortaio, ogni raffica di mitragliatrice, ogni sparo di cecchino vengono
ricambiati, un atteggiamento "offensivo" sarebbe suicida (87).
Questa consapevolezza non può da sola impedire i massacri: una morte
dilazionata non è automaticamente una morte evitata, e una delle tragedie
di questa guerra è che uomini che si erano salvati scambiandosi la pace, si
trovano a uccidersi l'un l'altro nella macelleria di Verdun, della Somme, di
Ypres.
Ma tregue e fraternizzazione restano uno dei tentativi più forti di
riprendere in mano un pò della propria vita, dando al nemico la possibilità
di fare lo stesso.
Sul fronte austro-italiano un militare austriaco e il soldato di vedetta G. C.,
messinese, carrettiere, analfabeta, vedovo con figli, si parlano così:
"Italiano, italiano, ti metti paura a parlare?", e G. C.: "Non ho paura a
parlare", e l'Austriaco: "Come stai?", e la vedetta: "Come stai tu piuttosto
che ieri ti lamentavi e come te l'hai passata la notte?", e l'Austriaco: "L'ho
passata male, avevo un pò appetito, hai da buttarmi una pagnotta? e per
fumare come la passate?", e G. C.: "Bene, ho avuto la mia razione di 13
sigarette e 14 sigari" (88). Leggendo che G. C. è stato condannato a cinque
anni con l'accusa di "agevolazione al nemico", è difficile non essere
unilaterali.
Quella dei soldati di trincea non è una controstoria dal punto di vista delle
vittime, come avviene in un grande filone storiografico, letterario,
memoriale (89). È una testimonianza di coraggio, inventiva,
discernimento, che insegna alcune belle verità.
La propaganda non era onnipotente: per una parte almeno dei soldati,
lungo la guerra il nemico aveva cambiato faccia: non più il mostro che
tagliava le mani ai bambini belgi (e la testa ai prigionieri tedeschi), ma la
fame, la stanchezza, l'inverno, la paura - e chi "per odio, ambizione, o
desiderio di decorazioni" imponeva "il gioco immorale e frivolo" (90)
dell'ostilità gratuita. L'inerzia non aveva niente di "letargico", era attiva e
densa di significati come il gesto contrario dell'aggressione. I soldati
erano, anche, soggetti che in condizioni di spossessamento estremo
mettevano alla prova nuove strategie di sopravvivenza, concepibili solo a
patto di discostarsi dalla legge dell'onore militare, della maschilità
bellicosa, dal formulario perenne della violenza autogiustificante - il
"mors tua vita mea", la difesa preventiva, il diritto-dovere della ritorsione.
Non sono modelli per monumenti celebrativi, e forse non li avrebbero
voluti. Erano uomini che tentavano di risparmiare il sangue nel loro
ristretto campo di azione e con i pochi mezzi disponibili, senza sentirsi
eroi o agenti del bene; si accontentavano di fare una cosa giusta.
Note
1. In realtà c'è un uso simultaneo di ritrovati modernissimi (in parte già
impiegati nelle guerre balcaniche) e di armi non molto diverse dagli
attrezzi dell'agricoltura e della caccia: filo spinato come quello per
recintare i campi, le cesoie per tagliare i reticolati, coltelli variamente
adattati.
2. È una delle tesi clou di Paul Fussell, La grande guerra e la memoria
moderna, trad. it., il Mulino, Bologna 1984. Per Arno J. Mayer (Il potere
dell'Ancien Regime fino alla prima guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari
1999) solo con la guerra scompaiono i residui aristocratici, premoderni,
persino "feudali" della società europea.
3. Robert Pearce, The Origins of the First World War, in "History
Review", 27, March 1997.
4. Michael S. Neiberg (a cura di), The World War I Reader. Primary and
Secondary Sources, New York University Press, New York 2007, p. 8.
5. A.J.P. Taylor, War by Time-Table: How the First World War Began,
Macdonald & Co., London 1969, cit. in Pearce, The Origins of the First
World War cit.
6. Gli argomenti erano simili a quelli usati nella crisi di luglio, quando le
potenze avevano pubblicato immediatamente i "libri colorati", in cui si
denunciavano i germi bellicosi della politica degli avversari - il
revanchismo francese, il materialismo mercantile della Gran Bretagna, il
militarismo della Germania, l'ostinazione dell'Austria-Ungheria, il
panslavismo russo.
7. Nel 1961, Fritz Fischer (Assalto al potere mondiale, trad. it., Einaudi,
Torino 1965) sostiene che nel 1914 i leader tedeschi avevano perseguito
deliberatamente una politica estera aggressiva. In precedenza una tesi
simile si trovava, fra gli altri, in Luigi Albertini, Le origini della guerra del
1914, Fratelli Bocca, Milano 1942, e in parte in Taylor, The Struggle For
Mastery cit. Secondo Niall Ferguson, invece (La verità taciuta. La Prima
guerra mondiale: il più grande errore della storia moderna [1999], trad. it.,
Corbaccio, Milano 2002), la politica britannica prima del 1914 aveva
accettato la virtuale certezza di una guerra con la Germania.
8. È il giudizio del banchiere Albert Ballin, cit. in Albertini, Le origini
della guerra cit., vol. I, p. 342.
9. Cfr. sopra il sottotitolo di Ferguson, La verità taciuta cit.
10. William Mulligan, Le origini della prima guerra mondiale, trad. it.,
Salerno, Roma 2012, p. 301.
11. James J. Sheehan, L'età post-eroica. Guerra e pace nell'Europa
contemporanea, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2009, p. 67. Sulla e per la
scuola ha lavorato molto un maestro della nonviolenza, Johan Galtung:
vedi, per esempio, Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, trad.
it., Plus - Pisa University Press, Pisa 2008.
12. A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918, Oxford
University Press, New York 1954, p. 518.
13. Paul Schroeder, World War I as Galloping Gertie, in "The Journal of
Modern History", 44, 3, September 1972, pp. 319-345, cit. in Mulligan, Le
origini cit., p. 26.
14. Il testo di gran lunga più pertinente e suggestivo è quello sopra citato
di Mulligan, da cui riprendo varie riflessioni.
15. Anche se Giappone e soprattutto Stati Uniti sono fra le potenze
mondiali, è in Europa che tutto inizia, e molto finisce.
16. Winston Churchill, Crisi mondiale e Grande Guerra 1911-1922, trad.
it., il Saggiatore, Milano 1968, p. 51. Nelle memorie dei leader politici lo
scarto fra vita vissuta e vita raccontata può essere accentuato dal desiderio
di sostenere le ragioni proprie, del proprio paese, partito, clan, e di
ridefinire se stessi alla luce della sopravvenuta esecrazione della guerra.
Ma, come ha sottolineato un dibattito ampio, lo scarto è connaturato alle
fonti personali, che, da qualsiasi soggetto provengano, sono
interpretazioni, non specchi del passato.
17. Occupando militarmente l'Egitto nel 1882, la Gran Bretagna aveva
innescato una controversia diplomatica di lungo periodo, che la costrinse
"fra il 1882 e il 1922 a promettere non meno di 66 volte il ritiro", cfr.
Ferguson, La verità taciuta cit., p. 86, e l'intero paragrafo Guerre evitate,
pp. 86-92.
18. Mulligan, Le origini cit., pp. 81 e 87.
19. La Francia riesce a proteggere i suoi progetti in Marocco, mentre la
Germania vede garantiti i propri interessi economici da una politica di
libertà del traffico.
20. Charles Seymour, The Diplomatic Background of the War, 1870-1914,
Yale University Press, New Haven 1916, p. 238.
21. Alessandro De Bosdari, Delle guerre balcaniche, della grande guerra e
di alcuni fatti precedenti ad esse (appunti diplomatici), Mondadori, Milano
1928, p. 58. Il testo descrive i retroscena, abboccamenti, bluff,
impuntature della diplomazia europea nel 1911-13.
22. Richard C. Hall, The Balkan Wars, 1912-1913: Prelude to the First
World War, Routledge, London-New York 2000, dove si esamina il
contenzioso fra gli Stati balcanici e con l'impero ottomano.
23. La battuta è di un diplomatico austriaco, citata da Karl Max von
Lichnowsky, My Mission to London 1912-14 (1916), online in WW1
Document Archive (http://wwi.lib.byu.edu), trad. it., La mia missione a
Londra, 1912-14, Treves, Milano 1918.
10
24. Secondo la definizione di Croce (cfr. Benedetto Croce e Giuseppe
Prezzolini, Le lettere di Croce a Prezzolini, a cura di Giovanni Spadolini,
Archivio Storico Ticinese, Bellinzona 1981, p. 139). Sull'ingresso in
guerra, Gian Enrico Rusconi, L'azzardo del 1915. Come l'Italia decide la
sua guerra, il Mulino, Bologna 2009.
25. L'espressione è del cancelliere tedesco Bethmann-Hollweg, citato in
Michael Balfour, Guglielmo II e i suoi tempi, trad. it., il Saggiatore,
Milano 1968, p. 399.
26. Ivi, pp. 437-438.
27. L'espressione è riferita dall'ex cancelliere tedesco Bernhard von
Buelow, Memorie 1849-1920, trad. it., Mondadori, Milano 1930-31, vol.
III: Guerra mondiale e catastrofe: 1909-1920, p. 113, dove denuncia anche
che ai turchi fu lasciato credere che non si sarebbe in nessun caso toccato
lo status quo, e che anzi li si incoraggiò alla lotta.
28. Adriano Sofri, Chi è il mio prossimo, Sellerio, Palermo 2007, p. 325.
29. Mulligan, Le origini cit., p. 305.
30. Una certa duttilità si deve anche alla posizione della Gran Bretagna,
che ha perso il ruolo di controllo e di mediazione svolto a partire dal
congresso di Vienna, ma resta la potenza più solida e autorevole.
31. Norman Angell (in Peace Theories and the Balkan War, Marshall &
Son, London 1912, p. 58) invitava i
(fonte: Centro di Ricerca per la Pace di Viterbo)
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2332
Politica e democrazia
C’è vita a sinistra, ma per quale progetto? (di
Francuccio Gesualdi)
Ci sono due modi di fare politica a sinistra: facendo cambiare le cose con
l’obiettivo di fare avanzare un progetto alternativo o cercando di
correggere solo gli aspetti più odiosi, accettando il sistema com’è. Nel 900
il partito comunista faceva la politica del primo tipo, giusto o sbagliato
che fosse il progetto. Poi è caduto il muro di Berlino e facendosi più
realista del re ha deciso di imboccare la strada del pragmatismo fino a
diventare il più strenuo sostenitore del liberismo. La fine fatta dal PD è
sotto gli occhi di tutti.
A sinistra molti criticano il PD solo per avere perso totalmente l’anima
sociale, ma ne condividono l’impostazione di fondo: il sistema è questo,
non solo non si può cambiare, ma va bene così: bisogna solo porgli
qualche regola affinché non si incagli nelle sue contraddizioni e bisogna
rafforzare i paracaduti sociali per soccorrere le vittime che inevitabilmente
produce. Non a caso la nuova parola d’ordine è diventata “sinistra di
governo”, che meglio di ogni altra espressione ne racchiude il concetto.
In controtendenza, io penso che oggi più che mai la sinistra ha bisogno di
un progetto alternativo perché questo sistema ci è nemico
nell’impostazione di fondo. Cercare di correggere gli aspetti più odiosi è
una regola di sopravvivenza, ma farlo senza intervenire sul senso di
marcia è come preoccuparsi della tappezzeria in un treno che va verso il
baratro.
Tradizionalmente il tema forte della sinistra è la distribuzione, le correnti
più moderate accontentandosi di spostare quote crescenti di reddito a
vantaggio dei salari e della collettività; le correnti più radicali pretendendo
di destinare tutto a salari e collettività non riconoscendo diritto di
cittadinanza al profitto. Da cui i sistemi socialisti, ormai tramontati per
varie cause che nessuno ha ancora studiato in tutti gli aspetti. Ma questa
impostazione, per così dire distributivista, ha portato la sinistra a
condividere la stessa matrice capitalista di adulazione della ricchezza. Per
entrambi, la ricchezza è un valore. Il capitalismo vuole produrne sempre di
più per garantire alle imprese merci crescenti finalizzate al profitto; la
sinistra vuole produrne sempre di più per creare nuove opportunità di
lavoro e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e delle loro
famiglie. Del resto c’è un detto classico nella sinistra: “Non si può
distribuire la miseria: prima si produce la ricchezza, poi la si distribuisce”.
Ed è così che anche a sinistra c’è una forte febbre produttivista: laddove
più si riesce ad estrarre, più si riesce ad asfaltare e cementificare, più si
riesce a manipolare la natura, più si riesce ad accrescere la tecnologia, in
una parola più si riesce ad innalzare il Pil, meglio si sta. Una concezione
un po’ antiquata che configura il benessere solo con la quantità di cose che
siamo capaci di buttare nel carrello della spesa, dimenticando che prima di
tutto abbiamo bisogno di una buona aria e che oltre alle esigenze del corpo
abbiamo anche quelle psichiche, affettive, spirituali, sociali.
La questione della qualità della vita e la questione ambientale, hanno l’aria
di essere temi ancora estranei alla sinistra, tant’è che né l’uno né l’altro
fanno parte del decalogo di Norma Rangieri. Ma se nell’ottocento
potevano essere ignorati perché altre erano le priorità ed altro era il
contesto ambientale, oggi la distruzione della casa comune rappresenta il
tema che condiziona ogni altro aspetto sanitario, sociale, economico. Il
concetto che più di ogni altro siamo costretti a rimettere in discussione è
quello di crescita e benché sappiamo che varie attività consentono spazi di
crescita senza maggior consumo di risorse e senza maggior produzione di
rifiuti, il problema è il paradigma. Sappiamo che trattando in maniera più
intelligente i rifiuti, ricorrendo di più all’agricoltura biologica,
potenziando i servizi alla persona, si può creare Pil e occupazione
sostenibile, ma per fare pace con la natura dovremmo annientare, o giù di
lì, l’industria dell’automobile, dovremmo cambiare totalmente il sistema
distributivo per ridurre al minimo gli imballaggi, dovremmo smetterla di
creare nuovi bisogni. In definitiva dovremmo chiudere per sempre con un
sistema che ha fatto dell’aumento delle vendite il suo cuore pulsante. E se
razionalmente sentiamo che questa è la strada da battere, dall’altra siamo
bloccati per la disoccupazione che ne può derivare. Preoccupazione più
che legittima in un sistema che ci offre l’acquisto come unica via per
soddisfare i nostri bisogni e ci offre il lavoro salariato come unica via per
accedere al denaro utile agli acquisti. Per questo il lavoro è diventato una
questione di vita o di morte e in suo nome siamo tutti diventati partigiani
della crescita. L’unico modo per uscirne è smettere di concentrarci sul
lavoro e concentrarci sulle sicurezze. La domanda giusta da porci non è
come creare lavoro, ma come garantire a tutti la possibilità di vivere
dignitosamente utilizzando meno risorse possibile, producendo meno
rifiuti possibile e lavorando il meno possibile. Cambiando prospettiva ci
renderemo conto che il mercato non è l’unico modo per soddisfare i nostri
bisogni, né il lavoro salariato l’unico modo per produrre ciò che ci serve. I
due grandi canali, se non alternativi, sicuramente complementari, sono il
fai da te e l’economia comunitaria che hanno il vantaggio della gratuità e
della piena inclusione lavorativa senza bisogno della crescita dei consumi.
La costruzione di una società che finalmente sappia mettere la persona al
centro della sua attenzione e sappia porsi come obiettivo, non già l’offerta
di lavoro, ma la garanzia a tutti, donne e uomini, giovani e vecchi, abili e
inabili, di una vita sicura dalla culla alla tomba, nella piena soddisfazione
di tutte le dimensioni umane e nel rispetto dei limiti del pianeta, dovrebbe
essere il vero progetto politico della sinistra perché tiene insieme tutti i
valori che la contraddistinguono: equità, rispetto, sostenibilità, solidarietà,
autonomia. Un progetto che, certo, ci costringe a ripensare tutto, dal senso
e la funzione del lavoro ai tempi di vita, dal modo di produrre ciò che ci
serve all’uso e il governo del denaro, dal ruolo del mercato al ruolo
dell’economia collettiva, dal modo di concepire la tecnologia al modo di
partecipare all’economia collettiva. Ma è ciò di cui abbiamo bisogno in un
momento che il sistema di mercato sta mettendo in evidenza tutto il suo
fallimento umano, sociale, ambientale, financo economico.
Con un progetto di società, non solo potremmo riaccendere la passione per
la politica nei milioni di cittadini che oggi vivono ai margini perché
stanchi e delusi, ma potremmo tornare al ruolo di forza con un’agenda da
perseguire, non più costretta a giocare perennemente in difesa. Finalmente
smetteremmo di correre dietro alle falle che crea il sistema e metteremmo
a punto il nostro piano strategico di trasformazione della società, con
proposte per tutti i livelli: da quello personale a quello comunale, da
quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale.
Perché un’altra certezza è che la costruzione di un’altra società esige non
solo una nuova visione dell’economia e della società, ma anche una nuova
concezione del modo di fare politica.
11
* Articolo originariamente scritto come contributo al dibattito promosso
dal Manifesto
(fonte: Pressenza: international press agency)
link: http://www.pressenza.com/it/2015/08/ce-vita-a-sinistra-ma-per-quale-progetto/
Politica internazionale
Gli USA stanno distruggendo l'Europa (di Eric
Zuesse)
In Libia, Siria, Ucraina e in altri paesi della periferia come ai confini dell'
Europa, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha perseguito una
politica di destabilizzazione, caratterizzata da attentati e altre forme di
assistenza militare, che spingono milioni di profughi fuori di quelle aree
periferiche verso l' Europa, versando altra “benzina sul fuoco” sul rifiuto
anti-immigrati caratteristico della destra politica, e la conseguente
destabilizzazione politica, in tutta Europa, non solo alla sua periferia, ma
anche nel più lontano nord Europa.
Shamus Cooke, nella notizia sul Off-Guardian del 3 agosto 2015 intitolata
“Obama’s ‘Safe Zone’ in Syria Intended to Turn It into New Libya” (la
“Zona di Sicurezza” di Obama in Siria è prevista diverrà una nuova
Libia"), riferisce che Obama ha approvato il supporto aereo da parte degli
Stati Uniti per la precedentemente senza rinforzi “no-fly zone” della
Turchia orientata verso la Siria. Gli Stati Uniti ora abbatteranno tutti gli
aerei del presidente siriano Bashar al-Assad che stanno prendendo di mira
i gruppi estremisti musulmani, tra cui l' ISIS, che hanno conquistato un
enorme area del territorio siriano.
Cooke riferisce:
“Questa no-fly zone è stata richiesta da parte di Obama alla Turchia fin da
quando è iniziata la guerra siriana. Se ne è discusso durante tutto il
conflitto e anche nei mesi recenti, anche se l' obiettivo è sempre stato il
governo siriano. E improvvisamente accade la no-fly zone - proprio dove
la Turchia ha sempre voluto- ma etichettata come zona di sicurezza “anti
ISIS”, anzichè chiamarla col suo vero nome: zona di sicurezza “Anti
governo curdo e anti-siriano".
Il il 27 luglio il New York Times riferiva, che "il piano richiede l'
insurrezione di siriani relativamente moderate al fine di prendere il
territorio, con l' ausilio del supporto aereo americano e forse anche quello
turco". Comunque, il Times, segnalando in modo stenografico (come al
solito) da e per le loro fonti del governo americano (quindi facendo
propaganda per il governo degli Stati Uniti), fallisce nel definire
l'accezione di "relativamente moderato", ma tutti i gruppi "relativamente
moderati" ribelli in Siria cooperano con l' ISIS e li aiutano a trovare e
decapitare, o, talvolta,
per chiedere riscatti, agli eventuali non-musulmani. Sotto Assad, la Siria è
stata uno stato non-clericale, e ha goduto della libertà di religione, ma tutta
l'opposizione siriana ad Assad è estranea a questo. Gli Stati Uniti sono ora,
anche più chiaramente di prima, anti-Assad, pro-islamista.
Seymour Hersh ha riferito sulla London Review of Books, il 17 aprile
2014, che la campagna di bombardamenti in Libia dell' amministrazione
Obama nel 2011 è stato parte di un programma più ampio per portare il
gas sarin dalla Libia al
fronte di al-Nusra in Siria, al fine di aiutare a produrre un gas per un
attacco contro i civili, per il quale l' amministrazione USA potrebbe quindi
incolpare Assad, diventando una scusa per bombardare laggiù proprio
come Obama aveva già fatto con successo in Libia. Entrambi i dittatori,
Gheddafi e Assad, erano alleati con la Russia, e specialmente Assad è stato
importante per la Russia, come rotta di transito per le forniture di gas della
Russia stessa, e non per le forniture di gas del Qatar – essendo il Qatar la
principale potenziale minaccia per lo status della Russia di maggior
fornitore di gas in
Europa.
Obiettivo principale di Obama nelle relazioni internazionali, e attraverso
tutta la sua politica militare, è stata quella di sconfiggere la Russia, forzare
un cambio di regime che renderà la Russia parte dell' impero Americano,
non più la grande nazione che resiste al controllo da parte di Washington.
Prima i bombardamenti americani della Libia nel 2011, la Libia era in
pace e fiorente. Il PIL pro-capite (ricavi) nel 2010 secondo il FMI è stato
di $ 12,357.80, ma immerso per soli $ 5,839.70 nel 2011 - l'anno che
abbiamo bombardato e distrutto il paese. (Hillary Clinton notoriamente si
vantava: "Siamo venuti, abbiamo visto, egli [Gheddafi] è morto!") (E, a
differenza di alleato degli Stati Uniti in Arabia Saudita, dove il PIL procapite fù notevolmente uniformemente distribuito, e l' istruzione e l'
assistenza sanitaria socializzati e disponibile a tutti, anche ai poveri). Più
di recente,
il 15 febbraio 2015, la giornalista Leila Fadel di NPR sbandierava "con i
campi di olio sotto attacco, il futuro economico della Libia sembra tetro".
Annunciava: "L'uomo in carica guarda verso la produzione e sa che il
futuro è
desolante. “Non possiamo produrre. Stiamo perdendo l'80 per cento della
nostra produzione”, dice Mustapha Sanallah, il presidente della Libia
National Oil Corporation". Seguendo le istruzioni di Washington, il FMI
non è stato
affidabile nel riportare i dati sul PIL della Libia dopo il 2011, ma mostr
invece che le cose ci sono state subito riportate alla normalità (anche
meglio rispetto al normale: $ 13,580.55 PIL pro-capite) nel 2012, ma tutti
sanno che è
falso; anche NPR sta, in effetti, riportando che non è vero. La CIA stima
che il PIL della Libia pro-capite è stato un ridicolo $ 23.900 nel 2012 (non
esistono dati relativi agli anni precedenti), e dice che il PIL pro capite
della Libia è diminuito solo leggermente da allora in poi. Nessuna delle
stime ufficiali sono affidabili, anche se il Consiglio Atlantico ha compiuto
almeno uno sforzo per spiegare le cose onestamente, portandone
informazione nel loro ultimo sistematico rapporto sull' economia della
Libia, il 23 gennaio 2014, "La Libia: Di fronte al crollo economico nel
2014."
La Libia è diventata il grande problema dell'Europa. Milioni di libici
stanno fuggendo dal caos laggiù. Alcuni di loro sono in fuga attraverso il
Mediterraneo e finendo nei campi profughi nel Sud Italia; e alcuni
scappano a altrove in Europa.
E la Siria è ora ancora un' altra nazione che sta venendo distrutta allo
scopo di permettere la conquista della Russia. Anche l' affidabilmente
propagandistico New York Times sta riconoscendo, nelle sue “notizie” di
segnalazione, che "entrambi, i turchi e gli insorti siriani, vedono la
sconfitta del presidente Bashar al-Assad come la loro priorità". Quindi: i
bombardieri US rinforzeranno una no-fly-zone sulle zone della Siria, al
fine di abbattere l' alleato della Russia Bashar al-Assad e sostituire il suo
governo laico da un governo islamico – e la cosa dell' “anti-ISIS” è solo
per puro spettacolo: è propaganda. Il pubblico si preoccupa molto di più
della sconfitta dell' ISIS piuttosto che la sconfitta della Russia, ma non è
questo il modo con cui l' aristocrazia Americana vede le cose. Il loro
obiettivo è estendere l' impero americano - estendere il loro impero.
Allo stesso modo, Obama ha rovesciato il governo neutralista di Viktor
Yanukovych in Ucraina nel febbraio 2014, il quale però era sotto la finta
copertura di manifestazione di “democrazia”, anzichè sotto la copertura
della falsa “opposizione al terrorismo islamico” o qualunque delle altre
frasi che il governo americano utilizza per ingannare i fessi circa
l'installazione americana di, e il supporto per, un rabbiosamente prossimo
governo razzista-fascista o nazista anti-Russia e sempre più nei pressi alla
Russia, in Ucraina. Proprio come la Libia era in pace prima che gli Stati
Uniti la invadessero e la distruggessero, e proprio come la Siria era in pace
prima che gli Stati Uniti e la Turchia la invadessero e distruggessero,
anche l' Ucraina era in pace prima che gli Stati Uniti perpetrassero il loro
colpo di stato lì e installassero
nazisti e una campagna di pulizia etnica distruggessero anche l'Ucraina.
12
Come con la Libia prima del rovesciamento di Gheddafi, o la Siria prima
che l'attuale sforzo di rovesciarvi Assad, o il più recente rovesciamento in
Ucraina del democraticamente eletto presidente Viktor Yanukovich, tutto è
rivolto a sconfiggere la Russia.
Il fatto che tutta l' Europa stia condividendo con Obama e gli altri
conservatori americani – imperialisti, anche - la devastazione che essi
impongono, è di poco o nessun interesse per i poteri in carica a
Washington DC, ma, se c' è qualcosa di importante per tutti loro, forse è
un altro interessante aspetto di questa più ampia operazione: con
l'indebolimento delle nazioni europee, e non solo le nazioni del Medio
Oriente, la guerra di Obama contro la Russia sta ulteriormente stabilendo l'
America come “l'ultimo uomo in piedi" alla fine del caos e della
distruzione che l' America sta causando.
Di conseguenza, per esempio, in termini di strategia internazionale degli
Stati Uniti, il fatto che le sanzioni economiche contro la Russia stanno
enormemente danneggiando le economie delle nazioni europee è un bene,
non un male.
Ci sono due modi per vincere, in ogni gioco: uno è migliorando la propria
performance. L' altro è indebolendo le prestazioni di ognuno degli altri
concorrenti. Gli Stati Uniti stanno ora facendo affidamento quasi
esclusivamente su quest'ultimo tipo di strategia.
Eric Zuesse
Fonte: www.strategic-culture.org
Link: http://www.strategic-culture.org/news/2015/08/07/us-is-destroyingeurope.html
7.08.2015
Traduzione per www.comedonchisciotte,org a cura di GIULIANO
MONTELEONE
(fonte: Come Don Chisciotte)
link:
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?
name=News&file=article&sid=15471
Notizie dal mondo
Palestina e Israele
Bds. Israele preoccupata dalla campagna
boicottaggio (di Redazione Contropiano)
di
“Prima ti ignorano, poi ti deridono, infine ti combattono”. Lo schema di
Gandhi sembra attanagliarsi perfettamente alle reazioni messe in campo
dalle autorità israeliane e dai loro sostenitori a livello internazionale. La
campagna Bds (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) contro Israele è
stata avviata nel 2005, tre anni dopo la sanguinosa repressione della
seconda Intifada palestinese.
Ignorata nella prima fase, derisa nella seconda, da un anno a questa parte
la campagna Bds viene combattuta a tutti i livelli dalle autorità israeliane,
sia introducendo una legge che prevede sanzioni giudiziarie per chi la
sostiene, sia mobilitando i loro apparati ideologici (scrittori, giornalisti
etc.) in Europa e negli Stati Uniti per demonizzare chi sostiene e pratica la
campagna di boicottaggio.
Il 19 giugno è stato lo scrittore Abraham Yoshua su La Stampa a
mescolare “parole di buonsenso” contro gli eccessi di Israele con
l’urgenza di depotenziare una campagna di boicottaggio. “Israele, in un
primo tempo, non ha preso sul serio questi segnali di boicottaggio. Dopo
tutto già negli Anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, prima della
guerra dei Sei Giorni, quando il giovane Stato ebraico era
economicamente e politicamente debole, i Paesi arabi si coalizzarono per
un suo boicottaggio, in particolare in campo economico. Tale tentativo
però fallì, soprattutto a causa del mancato appoggio del mondo
occidentale. La memoria della Shoah era ancora viva nella coscienza
generale e Israele era giustamente considerato una democrazia che lottava
per la propria sopravvivenza contro dittature arabe il cui potere economico
non trovava riscontro nel livello di vita dei loro abitanti” scrive Yoshua “
Ma il boicottaggio che sta prendendo piede ora è di carattere
completamente diverso ed è diretto a un Israele diverso. Sì, Israele è
ancora «l’unica democrazia del Medio Oriente» ma la storia del XX
secolo ci insegna che anche Paesi democratici possono conquistare
territori e commettere gravi soprusi contro altre nazioni, come la Francia
in Algeria o gli Stati Uniti in Vietnam e, più di recente, in Iraq. Il regime
democratico di Israele non lo rende immune dal commettere ingiustizie
nei confronti dei palestinesi o dal mantenerli per anni sotto occupazione
militare e civile. Per questo nella comunità internazionale si va
diffondendo l’attuale boicottaggio (un’iniziativa, per certi versi, simile a
quella attuata a suo tempo contro il Sud Africa) con l’intenzione di
costringere Israele a cambiare linea politica, ma soprattutto (ed è questa la
cosa importante) a fermare l’espansione degli insediamenti nei territori
destinati al futuro Stato palestinese” sottolinea lo scrittore israeliano.
Il 20 giugno invece è toccato a un panzer del sionismo europeo, il filosofo
Bernard Henry Levy, l’uomo inseguito dalle torte in faccia in mezza
Europa, a fare il suo lavoro di supporter a Tel Aviv. E non poteva che
trovare ospitalità sul Corriere della Sera. Ma le argomentazioni del
filosofo di tutte le guerre occidentali si sono spente in quanto a efficacia.
Non riesce ad andare oltre all’invocazione di “perché non boicottate il
Qatar?”. Invocare un doppio standard da chi – come Israele – ne ha
usufruito ininterrottamente dal 1948 a oggi appare argomento ormai
spuntato e francamente irricevibile.
Infine non poteva mancare Fiamma Nirenstein che oggi dalle colonne del
giornale amico “Il Giornale” si strappa i capelli perché la campagna Bds si
sta affermando ben oltre di quanto le autorità israeliane e i loro supporter
avessero mai pensato. Anche la Nirestein però non brilla per originalità e
ricorre ad argomenti da disco incantato: “Il Bds è antisemita, è un nuovo
tipo di guerra molto astuto perchè legalizza una vera persecuzione
antisraeliana, coprendola della menzogna di essere a favore del benessere
dei palestinesi, per la pace, contro l’occupazione: ma non è vero”.
Sono passati dieci anni dal lancio della campagna internazionale Bds e la
realtà ne sta dimostrando l’efficacia. Israele, con la brutale repressione
della seconda Intifada nel 2002, con i massacri su Gaza del 2009 e del
2014, pensava di aver posto fine alle aspirazioni del popolo palestinese nel
raggiungimento dei suoi obiettivi. Le sconfitte sul campo, l’altissimo
numero di vittime e prigionieri, le divisioni tra Hamas e Al Fatah, gli
opportunismi di alcuni dirigenti palestinesi, la destabilizzazione totale in
Medio Oriente provocata dagli interventi e ingerenze imperialiste
statunitense ed europee, il gioco sporco delle ambizioni dell’Arabia
Saudita e del polo islamico, hanno indubbiamente indebolito la lotta per
l’autodeterminazione del popolo palestinese. A questo punto solo
l’intervento di una potenza esterna poteva riaprire il gioco e mettere in
difficoltà la politica coloniale israeliana. Ovviamente questa potenza non
potevano essere gli Usa né l’Unione Europea (vedi la miserrima vicenda
di Tony Blair come presidente del “quartetto” sul Medio Oriente) rivelatisi
sistematicamente complici dell’occupazione coloniale israeliana. Questa
potenza si è manifestata e declinata con l’iniziativa di base di una
campagna internazionale come il Bds che, goccia a goccia, ha combattuto
su ogni aspetto della rete di complicità tra potenze occidentali e Israele:
dagli accordi economici allo sport, dai concerti musicali agli eventi
culturali. E gli effetti, dopo dieci anni, stanno preoccupando seriamente
l’avversario da battere. Le reazioni isteriche delle autorità israeliane e dei
loro apparati ideologici di stato (come gli articoli sui giornali italiani che
abbiamo visto) confermano che – con grande “scuorno” per le anime belle
che continuano a cianciare di Israele come “unica democrazia del Medio
Oriente” – questa strada si sta rivelando efficace per poter cambiare le
cose per i palestinesi. Anche per il Sudafrica dell’apartheid la partita
sembrava chiusa dopo la grande repressione del 1985/86 contro i
movimenti e le proteste dei neri. Ma solo quattro anni dopo, nel 1990 il
regime dell’apartheid, boicottato a livello internazionale, venne costretto a
13
trattare, e nel 1994 Nelson Mandela divenne il primo presidente nero del
Sudafrica. Le cose cambiano ma hanno bisogno di lotta, tenacia e
perseveranza.
http://contropiano.org/articoli/item/31482
(fonte: Bocche Scucite - segnalato da: Massimo Pretazzini)
link:
http://www.bocchescucite.org/bds-israele-preoccupata-dalla-campagna-diboicottaggio/
Israele ha lanciato una granata stordente contro un
undicenne (di Human Rights Watch, Rania Khalek)
Un soldato israeliano ha lanciato una granata stordente contro alcuni
palestinesi.
Un nuovo rapporto di Human Rights Watch (HRW) accusa le forze
israeliane di sottomettere bambini palestinesi arrestati a prese al collo,
percosse, perquisizioni corporali e confessioni forzate.
Il rapporto giunge a seguito di una nuova legge approvata dal parlamento
israeliano, la Knesset, che prevede pene più severe per il lancio di pietre.
Le accuse di aver lanciato pietre sono usualmente utilizzate dalle forze
israeliane come pretesto per arresti, torture, imprigionamento e persino la
morte di palestinesi, senza alcuna conseguenza.
Utilizzando l'imputazione di aver lanciato pietre, le forze israeliane
"hanno preso per il collo bambini, lanciato contro di loro granate stordenti,
li hanno picchiati mentre erano in stato di fermo, li hanno minacciati e
interrogati senza la presenza di familiari o avvocati e non hanno informato
i genitori su dove si trovassero," secondo HRW.
HRW ha documentato e confermato le esperienze di quattro ragazzini di
Gerusalemme est, di 11, 12 e 15 anni, e anche di una ragazzina di 14 anni
e di un quindicenne di altre zone della Cisgiordania occupata.
Obbligati
Nel novembre scorso la polizia di frontiera ha lanciato una granata
stordente contro l'undicenne Rashid S. a Silwan, un quartiere di
Gerusalemme est. Poi lo hanno preso per il collo, gli hanno strappato la
maglietta e il cappotto e lo hanno arrestato con l'accusa di aver lanciato
pietre.
"Sono corso verso la moschea, ma mi hanno lanciato una bomba
assordante che mi ha colpito alle gambe sulla scalinata, così sono caduto
giù dalle scale e mi hanno afferrato per la maglietta. Mi hanno preso per il
collo e sbattuto per terra a faccia in giù," ha raccontato Rashid a HRW.
Mentre lo trascinavano all'interrogatorio con un cappuccio nero in testa,
gli israeliani hanno colpito il ragazzo agli stinchi, minacciando di
picchiarlo, e lo hanno lasciato fuori al freddo senza maglietta per un'ora.
Questo trattamento ricorda i tempi in cui Israele ha tenuto chiusi bambini
palestinesi arrestati in gabbie di ferro all'aperto durante una violenta
tempesta invernale nel 2013.
Una costante in tutti i casi documentati da HRW è il fatto che le forze
israeliane non abbiano informato i genitori che i loro figli erano stati
arrestati e che l'interrogatorio dei ragazzini [si sia svolto] senza
permettere loro di parlare prima con un avvocato o con un familiare. Molti
ragazzini sono stati obbligati a firmare confessioni in ebraico, lingua che
non parlano. In alcuni casi, alcuni ragazzini sono stati tenuti lontano dai
loro genitori per mesi.
Nessun luogo è sicuro per questi ragazzini, neppure vicino a scuola.
Ahmad Abu Sbitan, 11 anni, è stato preso per il collo dalla polizia di
frontiera israeliana durante l' arresto davanti alla sua scuola a
Gerusalemme est. Anche un uomo di 22 anni di nome Muhammad, che
cercava di rendere più tranquilla la situazione, è stato arrestato e più tardi
perquisito e picchiato dagli israeliani davanti a Ahmad.
Mentre stava aspettando l'autobus dopo la scuola nella Città Vecchia di
Gerusalemme, un dodicenne di nome Mohammed Khatib è stato arrestato
in modo violento. Un ufficiale israeliano "mi ha preso da dietro per la
giacca e mi ha sollevato da terra, stavo soffocando," Mohammed ha
raccontato a HRW.
Mentre interrogavano Mohammed, si sono rifiutati di permettere a suo
padre, un video giornalista di nome Rami, di vederlo. Dopo otto estenuanti
ore, nelle quali hanno minacciato, deriso e picchiato il bambino, la polizia
lo ha lasciato andare, ma non prima di giustificare la loro brutalità dicendo
a suo padre che stavano cercando un ragazzino che lanciava pietre con una
maglietta blu, lo stesso colore dell'uniforme scolastica di Mohammed.
Terrorizzare adolescenti
Le forze israeliane hanno terrorizzato questi ragazzini al punto che alcuni
di loro sono stati spinti a pensare al suicidio. Questo è il caso del
quindicenne Fares Shyukhi.
Fares è stato sottoposto ad una perquisizione intima, schiaffeggiato, preso
a calci, minacciato e incarcerato dalle forze israeliane nel marzo dello
scorso anno con l'accusa di aver lanciato pietre e una bottiglia molotov
contro una colonia vicina a Gerusalemme est. Rilasciato il mese
successivo ma agli arresti domiciliari a tempo indefinito, la polizia di
frontiera ha continuato a tormentarlo.
E' stato di nuovo incarcerato nell'ottobre 2014 dopo che non si era
presentato a un'udienza in tribunale e rilasciato agli arresti domiciliari
meno restrittivi nel gennaio di quest'anno, solo dopo un tentativo di
suicidio. I suoi arresti domiciliari sono stati revocati in marzo ma da
allora la polizia israeliana lo ha arrestato due volte, in un'occasione in
modo violento.
Quando in dicembre la quattordicenne Malak al-Khatib è stata arrestata
nel villaggio di Beitin, in Cisgiordania, i soldati israeliani l'hanno presa a
calci, l'hanno pestata sul collo e l'hanno picchiata con un bastone fino a
farla svenire. Senza avvertire i suoi genitori, l'hanno trascinata per
interrogarla nella stazione di polizia, dove hanno urlato e l'hanno
minacciata di fare del male a lei ed alla sua famiglia se non avesse
confessato di aver lanciato pietre, cosa che ha firmato in ebraico, una
lingua che non capisce.
In violazione della Quarta Convenzione di Ginevra, Israele ha
imprigionato Malak in Israele. A causa di ciò, la sua famiglia non ha
potuto vederla o parlare con lei durante i 64 giorni in cui è rimasta in
arresto in Israele poiché, in quanto palestinesi residenti in Cisgiordania,
non hanno il permesso di entrare in Israele.
Un ragazzino palestinese di 15 anni è stato isolato allo stesso modo dalle
visite della sua famiglia o da colloqui telefonici durante i 115 giorni
passati in stato di arresto.
Modalità di comportamento crudeli
Il rapporto di HRW è solo il più recente tra quelli che raccontano nei
dettagli le modalità crudeli di arresto, tortura e incarcerazione di ragazzini
palestinesi, aggiungendosi alla montagna di prove che si sono andate
accumulando nel corso degli ultimi anni.
Un rapporto dell'UNICEF pubblicato nel 2013 ha evidenziato che il
trattamento crudele di oltre 7.000 ragazzini palestinesi sottoposti a
detenzione militare da parte di Israele è stato "molto esteso, sistematico e
istituzionalizzato," con bambini "svegliati in modo violento nel bel mezzo
della notte da parecchi soldati armati e trascinati a forza in un centro per
gli interrogatori legati e bendati, privati del sonno e in uno stato di
terrore."
Uno sconvolgente rapporto di Defense for Children International-Palestine
[sezione palestinese di una ong internazionale impegnata nella difesa dei
bambini. N.d.tr.] ha scoperto che "il 2014 non ha portato una tregua per i
ragazzini palestinesi, presi nel sistema di detenzione militare israeliano,
che vivano nelle zone residenziali della Striscia di Gaza o semplicemente
mentre vanno a scuola." Gli arresti, le torture e le uccisioni non solo sono
continuati, ma sembra siano diventati ancora più feroci.
Lo scorso mese alcuni membri del Congresso USA hanno inviato una
lettera al segretario di Stato John Kerry chiedendo di far pressione su
Israele affinché ponga fine al trattamento sistematicamente "crudele,
disumano e degradante" nei confronti dei bambini palestinesi. La lettera è
stata firmata da 18 membri della Camera dei Rappresentanti, una rara
fenditura nel carro armato pro-Israele che domina le manovre nel
Congresso.
HRW nota che l'appoggio militare incondizionato da parte degli USA a
Israele li rende complici degli abusi israeliani, che violano sia la
Convezione Internazionale sui Diritti Civili e Politici che la Convenzione
sui Diritti dei Minori. "In quanto più importante donatore di Israele, gli
USA dovrebbero fare pesantemente pressione per porre fine a queste
pratiche violente e a favore di riforme," ha affermato la responsabile per il
14
Medio Oriente di HRW, Sarah Leah Whitson.
Purtroppo il vento sta cambiando troppo lentamente per i bambini
palestinesi, continuamente presi di mira dalla macchina da guerra
israeliana. Come sottolinea Leah Whitson, "Israele è stato sotto
osservazione per anni a causa del fatto che le sue forze di sicurezza stanno
violando i diritti dei bambini palestinesi nei Territori Occupati, ma i
problemi continuano."
Finché Israele potrà contare sull'appoggio del Paese più potente al mondo,
continuerà a violare sfacciatamente i diritti fondamentali dei bambini
palestinesi con assoluta impunità.
Human Rights Watch, Rania Khalek Electronic Intifada
23 luglio 2015
(Traduzione di Amedeo Rossi)
link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2329