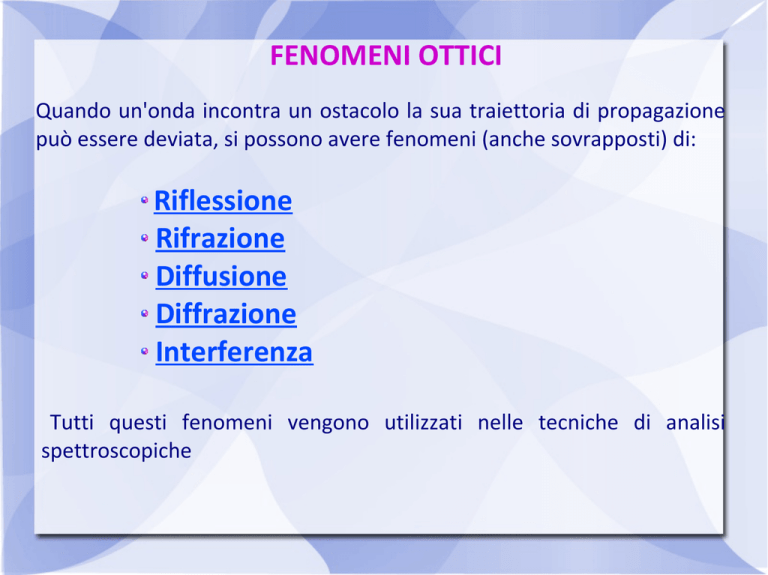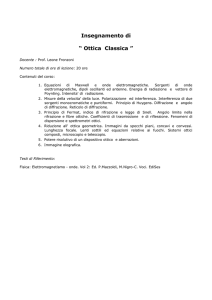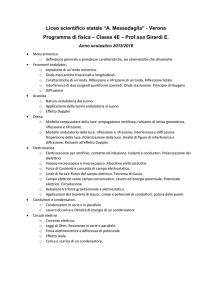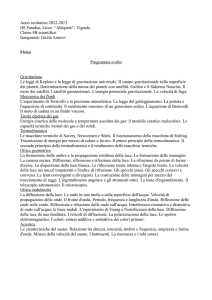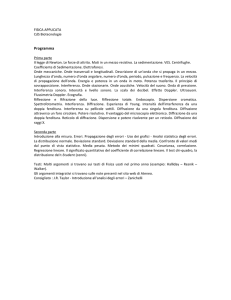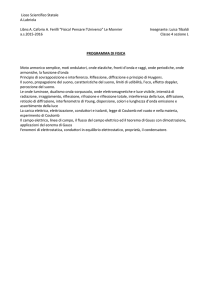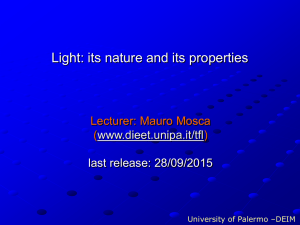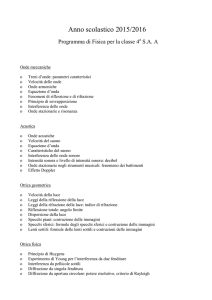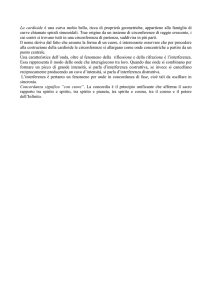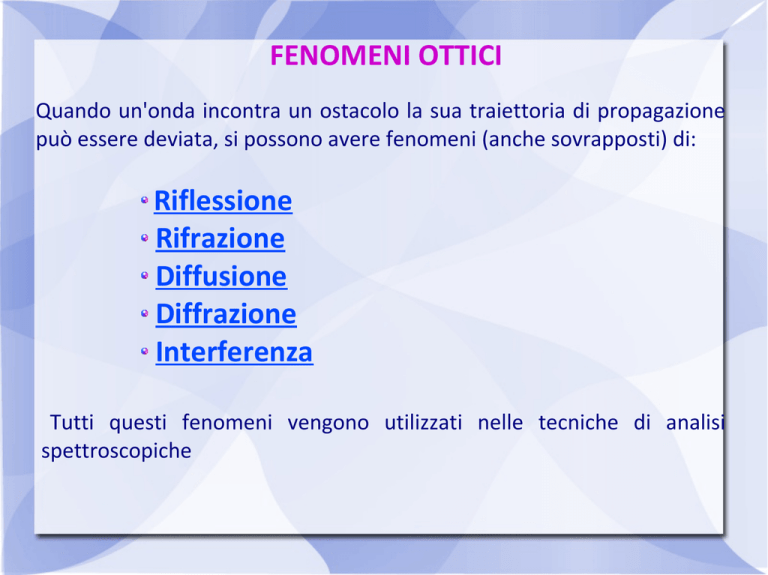
FENOMENI OTTICI
Quando un'onda incontra un ostacolo la sua traiettoria di propagazione
può essere deviata, si possono avere fenomeni (anche sovrapposti) di:
Riflessione
Rifrazione
Diffusione
Diffrazione
Interferenza
Tutti questi fenomeni vengono utilizzati nelle tecniche di analisi
spettroscopiche
RIFLESSIONE
La riflessione è il fenomeno per cui un'onda, quando colpisce
l'interfaccia tra differenti mezzi, cambia direzione e torna nel mezzo
di provenienza.
La lunghezza d'onda dell'onda riflessa è uguale a quella incidente
RIFLESSIONE
Se la superficie è liscia, cioè le scabrosità sono trascurabili rispetto
alla lunghezza d'onda, la riflessione è speculare:
LEGGI DELLA RIFLESSIONE
Il raggio incidente, il raggio riflesso e la normale alla superficie di
riflessione giacciono sullo stesso piano,
L'angolo di incidenza è uguale a quello di riflessione,
Il raggio incidente e quello riflesso sono su lati opposti rispetto alla
normale.
RIFLETTANZA
La riflettanza è il rapporto tra l'intensità della radiazione riflessa e
quella della radiazione incidente
R% = I ·100
I0
La spettroscopia di (o in) riflettanza trova applicazioni nel controllo
qualità di materie prime e prodotti finiti (p.es. cere per pavimenti,
detersivi) e nell'analisi degli strati superficiali dei dipinti.
RIFRAZIONE
La rifrazione è la deviazione subita da un'onda quando passa da un
mezzo ad un altro, nel quale la sua velocità di propagazione cambia; la
frequenza rimane costante, di conseguenza cambia la λ.
RIFRAZIONE
Quando il raggio passa da un mezzo meno denso ad uno più denso (p.es
dall'aria all'acqua, oppure al vetro) l'angolo di rifrazione r è minore
dell'angolo di incidenza i, invece quando passa da un mezzo più denso ad
uno meno denso il raggio si allontana dalla normale:
LEGGI DELLA RIFRAZIONE
Il raggio incidente, quello rifratto e la normale alla superficie di
separazione dei due mezzi giacciono sullo stesso piano
Il rapporto tra i seni dei due angoli è costante qualunque sia l'angolo
di incidenza e dipende soltanto dai due mezzi in cui la luce passa:
sen i = v1 = n2
sen r v2 n1
dove v1 e v2 sono le velocità della luce nei due mezzi e n1 e n2 i loro
indici di rifrazione assoluti
Una regola di carattere qualitativo per determinare la direzione della
rifrazione è che il raggio luminoso è sempre più vicino alla normale
dal lato del mezzo più denso.
RIFRAZIONE
Si definisce indice di rifrazione assoluto il rapporto tra la velocità
della luce nel vuoto e quella nel mezzo considerato:
n= c
v
Poiché c è sempre maggiore di v l'indice di rifrazione assoluto è
sempre >1
L'indice di rifrazione dipende dalla λ della radiazione incidente, dalla
temperatura e (per i gas) dalla pressione.
RIFRAZIONE
Riflessione totale: nel passaggio da un mezzo più rifrangente ad uno
meno rifrangente (p.es. dall'acqua all'aria) esiste un angolo limite oltre il
quale il raggio non riesce più a penetrare nel mezzo meno rifrangente e
viene completamente riflesso:
RIFRAZIONE
La dipendenza della rifrazione dalla λ viene sfruttata per realizzare la
dispersione della luce (cioè la separazione delle componenti
monocromatiche della luce bianca) tramite un prisma
Le radiazioni vengono deviate di più passando dal rosso (minore
frequenza) al violetto (maggiore frequenza)
Il prisma è quindi un buon dispositivo monocromatore.
RIFRAZIONE
La rifrattometria è una tecnica di analisi basata sulla determinazione
dell'indice di rifrazione, ha molteplici applicazioni, p.es. viene utilizzata
per:
Stabilire il contenuto zuccherino di succhi alimentari
Stabilire il grado alcolico di soluzioni idroalcoliche
Caratterizzare oli e grassi
Analisi delle urine e del sangue
Analizzare minerali e gemme
DIFFUSIONE
In fisica la diffusione ottica (o dispersione), scattering in inglese, si
riferisce a un'ampia classe di fenomeni in cui onde o particelle vengono
deflesse (ovvero cambiano traiettoria) a causa della collisione con altre
particelle. La deflessione avviene in maniera disordinata e in buona
misura casuale (il significato letterale di scattering è "sparpagliamento")
e per questo la diffusione si distingue dalla riflessione e dalla rifrazione,
che invece cambiano le traiettorie in maniera regolare e determinata.
DIFFUSIONE
La diffusione può presentarsi insieme alla riflessione, se le scabrosità
della superficie non sono trascurabili rispetto alla λ della luce
incidente
In questo caso si parla di riflessione diffusa:
DIFFUSIONE
In base alle dimensioni delle particelle incontrate si possono avere
differenti tipi di diffusione, tra le quali:
Diffusione di Rayleigh
Diffusione di Mie
Diffusione (o effetto) di Tyndall
DIFFUSIONE DI RAYLEIGH
Se le particelle hanno dimensioni molto più piccole (< 1/10) della λ
della luce incidente la diffusione è isotropa ( avviene con uguale
intensità in tutte le direzioni).
L'intensità della luce diffusa è proporzionale alla quarta potenza della
frequenza della radiazione
le frequenze maggiori sono diffuse
con maggiore efficienza, è questo il motivo per cui il cielo appare
azzurro:
DIFFUSIONE DI MIE
Se le particelle hanno dimensioni > 1/10 della λ della luce incidente la
diffusione dipende in misura minore dalla lunghezza d'onda.
Le goccioline d'acqua diffondono tutte le lunghezze d'onda della luce
visibile con intensità circa uguale e le nuvole e la nebbia quindi
appaiono bianche o grigie.
DIFFUSIONE DI TYNDALL
Per particelle ancora più grandi
come quelle dei sistemi colloidali,
delle sospensioni e delle dispersioni fini
l'intensità della luce diffusa dipende
dalla frequenza della luce incidente
la componente blu è diffusa meglio
farina sospesa in acqua
DIFFUSIONE
I fenomeni di diffusione sono alla base di due tecniche analitiche,
utilizzate perlopiù nella determinazione di solidi e oli dispersi nelle acque
e nell'aria, ma anche in biologia per lo studio di colture batteriche o per
la determinazione della massa molare di macromolecole:
La turbidimetria in cui si misura la luce diffusa davanti al campione,
La nefelometria in cui si misura la luce diffusa a 90° rispetto alla
direzione della luce incidente.
DIFFRAZIONE
Il termine diffrazione si riferisce ai fenomeni, che avvengono
quando un'onda incontra un ostacolo o una fenditura, che
abbia dimensioni simili alla sua λ: in accordo con il principio di
Huygens-Fresnel ogni punto della fenditura diventa, a sua
volta, una sorgente di onde che si propagano in tutte le
direzioni dello spazio:
DIFFRAZIONE
Le onde, quindi, aggirano gli ostacoli, se hanno dimensioni
dello stesso ordine di grandezza della loro λ
DIFFRAZIONE
Effetto della diffrazione delle onde sui frangiflutti a Campo di Mare (Brindisi)
INTERFERENZA
Se le onde passano attraverso due (o più) fenditure all'uscita si
avrà interferenza, con formazione di zone in cui le onde si
sommano o si annullano:
INTERFERENZA
L'interferenza propriamente riguarda l'interazione tra onde e non tra
onde e materia
INTERFERENZA
L'interferenza è un comportamento tipico dei fenomeni ondulatori:
quando due o più radiazioni monocromatiche percorrono lo stesso
mezzo nella stessa direzione possono verificarsi tre casi:
Le onde sono in concordanza di fase (rafforzamento), aumentano
ampiezza ed intensità
Le onde sono in opposizione di fase (interferenza totale),non c'è
onda finale
Nel caso intermedio l'onda finale ha un'ampiezza A, che si ottiene
dalla somma algebrica delle due ampiezze ed è sempre minore della
somma di quelle d'origine
INTERFERENZA
L'interferenza è un comportamento tipico dei fenomeni ondulatori:
quando due o più radiazioni monocromatiche percorrono lo stesso
mezzo nella stessa direzione possono verificarsi tre casi:
Le onde sono in concordanza di fase (rafforzamento), aumentano
ampiezza ed intensità
Le onde sono in opposizione di fase (interferenza totale),non c'è
onda finale
Nel caso intermedio l'onda finale ha un'ampiezza A, che si ottiene
dalla somma algebrica delle due ampiezze ed è sempre minore della
somma di quelle d'origine
INTERFERENZA
INTERFERENZA
L'interferenza è utilizzata in spettrofotometria sia come tecnica
analitica sia perché consente di ottenere monocromatori
L'interferometria trova applicazione in molti campi di ricerca,
in particolare in astrofisica: lo studio delle frange di
interferenza consente di misurare lo spostamento di corpi
celesti e di studiare i pianeti extrasolari
FILTRI
Diffrazione ed interferenza sono alla base dei filtri monocromatori,
che possono essere:
Filtri interferenziali
Reticoli di trasmissione
Reticoli di riflessione
dispersione di un prisma e di un reticolo
FILTRI
schema di un monocromatore :
A: sorgente di luce policromatica
B: fenditura d' entrata
C, E: specchi
D: filtro
F: fenditura d'uscita
G: radiazione monocromatica uscente
FILTRI
I filtri interferenziali sono sono costituiti da due lastre piane e
parallele di vetro (o altro materiale trasparente), le cui facce
interne sono rese semiriflettenti da uno strato sottile e
trasparente di argento(o altro conduttore):
FILTRI
L'effetto di filtro è causato dall'interferenza tra le radiazioni
uscenti, che sono in fase (e quindi danno interferenza costruttiva)
solo se la differenza di cammino ottico (che dipende dallo
spessore l ) tra loro è un multiplo intero della lunghezza d'onda,
in pratica passano solo le λ che soddisfano la relazione:
λ = 2l/n
dove n è un numero intero
FILTRI
I reticoli di trasmissione sono costituiti solitamente da una lastra
di vetro sulla cui superficie è incisa una trama molto fitta, anche
2000 fenditure al mm, di linee parallele, uguali ed equidistanti, a
distanze confrontabili con la lunghezza d'onda della luce; la
distanza tra le linee è detta ''passo del reticolo''
FILTRI
Le onde in uscita dai reticoli di trasmissione danno interferenza
costruttiva ad angoli θ diversi per le diverse λ e si ottiene così la
separazione: dsenθ = nλ; si ottengono più immagini, da quella
centrale di ordine m=0 a quelle di ordine m crescente a mano a
mano che si allontanano dal centro:
Separazione di due radiazioni
Frange d'interferenza di luce policromatica
FILTRI
Nei reticoli a riflessione di fase i solchi hanno un angolo di taglio
caratteristico (detto angolo blaze θ) e possono essere del tipo
échelette (la riflessione avviene sul lato più lungo) o échelle ( la
riflessione avviene sul lato più corto)
FILTRI
Anche per i reticoli a riflessione di fase l'interferenza dei raggi
uscenti è costruttiva ad angoli diversi per le diverse λ, dando
così la separazione delle radiazioni .
Un raggio laser ad argon policromatico colpisce un reticolo a riflessione di
silicio ed è separato in più raggi, uno per ogni lunghezza d'onda (da sinistra
a destra 458 nm, 476 nm, 488 nm, 497 nm, 502 nm e 515 nm)
Siti suggeriti
per le onde del mare (e non solo):
http://www.fmboschetto.it/images/galleria_onde.htm
per costruire uno spettroscopio con un CD:
http://www.reinventore.it/sala-professori/2013/07/lo-spettroscopio-col-cd/