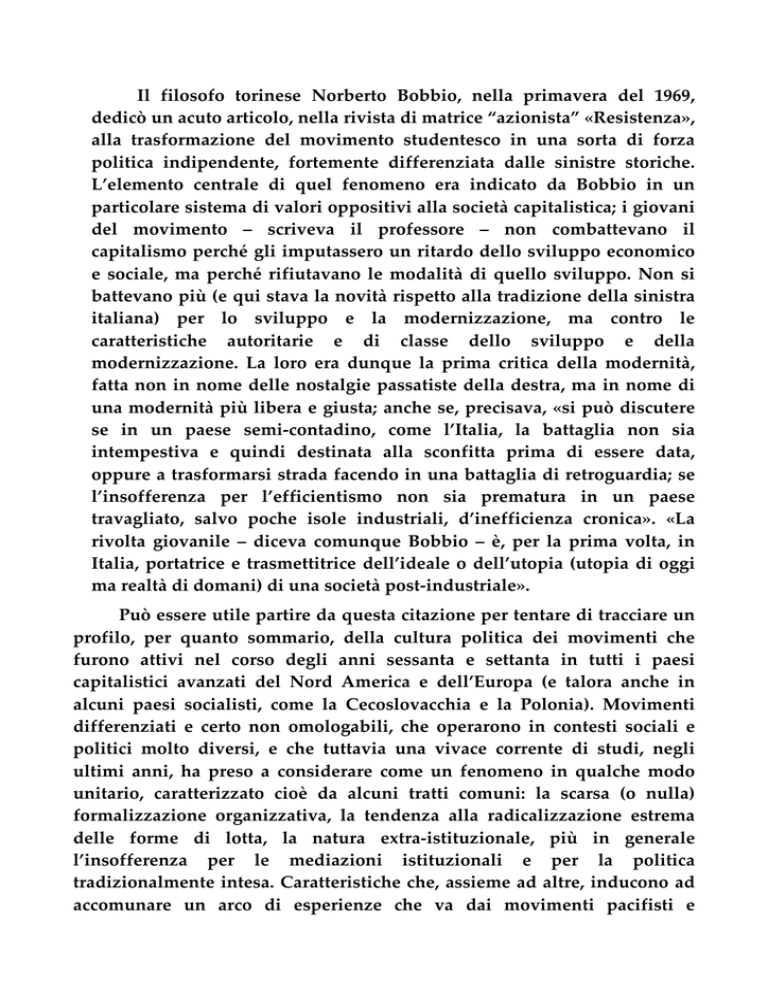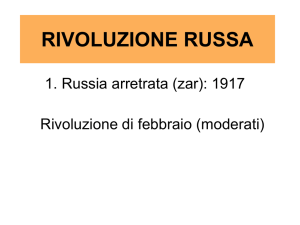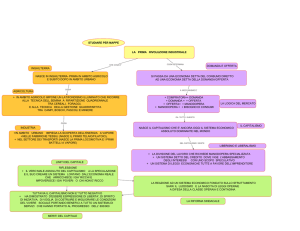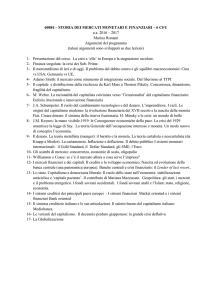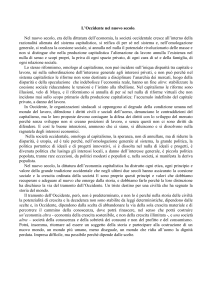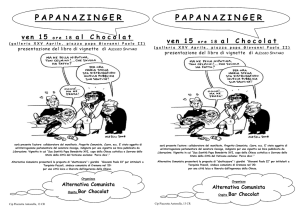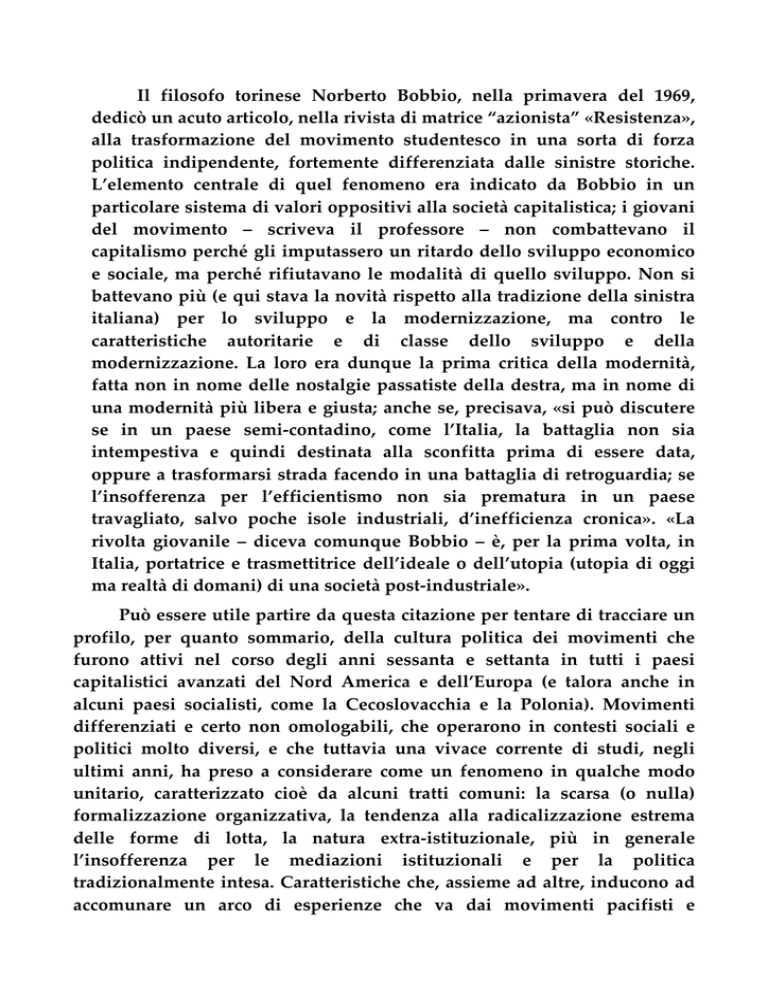
Il filosofo torinese Norberto Bobbio, nella primavera del 1969,
dedicò un acuto articolo, nella rivista di matrice “azionista” «Resistenza»,
alla trasformazione del movimento studentesco in una sorta di forza
politica indipendente, fortemente differenziata dalle sinistre storiche.
L’elemento centrale di quel fenomeno era indicato da Bobbio in un
particolare sistema di valori oppositivi alla società capitalistica; i giovani
del movimento – scriveva il professore – non combattevano il
capitalismo perché gli imputassero un ritardo dello sviluppo economico
e sociale, ma perché rifiutavano le modalità di quello sviluppo. Non si
battevano più (e qui stava la novità rispetto alla tradizione della sinistra
italiana) per lo sviluppo e la modernizzazione, ma contro le
caratteristiche autoritarie e di classe dello sviluppo e della
modernizzazione. La loro era dunque la prima critica della modernità,
fatta non in nome delle nostalgie passatiste della destra, ma in nome di
una modernità più libera e giusta; anche se, precisava, «si può discutere
se in un paese semi-contadino, come l’Italia, la battaglia non sia
intempestiva e quindi destinata alla sconfitta prima di essere data,
oppure a trasformarsi strada facendo in una battaglia di retroguardia; se
l’insofferenza per l’efficientismo non sia prematura in un paese
travagliato, salvo poche isole industriali, d’inefficienza cronica». «La
rivolta giovanile – diceva comunque Bobbio – è, per la prima volta, in
Italia, portatrice e trasmettitrice dell’ideale o dell’utopia (utopia di oggi
ma realtà di domani) di una società post-industriale».
Può essere utile partire da questa citazione per tentare di tracciare un
profilo, per quanto sommario, della cultura politica dei movimenti che
furono attivi nel corso degli anni sessanta e settanta in tutti i paesi
capitalistici avanzati del Nord America e dell’Europa (e talora anche in
alcuni paesi socialisti, come la Cecoslovacchia e la Polonia). Movimenti
differenziati e certo non omologabili, che operarono in contesti sociali e
politici molto diversi, e che tuttavia una vivace corrente di studi, negli
ultimi anni, ha preso a considerare come un fenomeno in qualche modo
unitario, caratterizzato cioè da alcuni tratti comuni: la scarsa (o nulla)
formalizzazione organizzativa, la tendenza alla radicalizzazione estrema
delle forme di lotta, la natura extra-istituzionale, più in generale
l’insofferenza per le mediazioni istituzionali e per la politica
tradizionalmente intesa. Caratteristiche che, assieme ad altre, inducono ad
accomunare un arco di esperienze che va dai movimenti pacifisti e
antimilitaristi, ai fenomeni studenteschi del Sessantotto (nati in realtà
alcuni anni prima nei campus universitari statunitensi), ai gruppi politici di
orientamento radicale, sino ai gruppi di base nelle fabbriche e nei servizi,
ai movimenti di protesta urbana sulla casa e i servizi sociali, a quelli dei
detenuti e dei militari di leva.
Si tratta, in altre parole, di quell’insieme di fenomeni che in genere
viene definito come “nuova sinistra”: termine nato, in realtà, alla fine degli
anni cinquanta nell’area anglosassone (di “new left” si parlava negli Stati
Uniti a proposito dei gruppi radicali legati al movimento per i diritti civili,
e in Gran Bretagna, nel 1960, nasceva la «New Left Review»), ma diventata
poi sinonimo di tutta una corrente politica, attiva nel mondo capitalistico
per oltre un ventennio. Sotto il profilo politico-ideologico, fu una corrente
collocabile senza dubbio nell’ambito della sinistra, ma con caratteristiche
di spiccata originalità, che la differenziavano tanto dal comunismo di
matrice terzinternazionalista, quanto dal socialismo democratico e
riformista; una sinistra estrema, la cui cultura non è riconducibile solo al
marxismo tradizionale, ma a tante influenze diverse, dallo strutturalismo
alla psicanalisi, e che coltivò forse la velleità di portare Marx oltre Marx, di
sottrarlo alle interpretazioni della vulgata comunista ufficiale (quella del
movimento operaio di osservanza sovietica) per restituirlo alla critica
radicale della società borghese. Una critica – come giustamente coglieva
Bobbio – non ai ritardi e alle aporie del capitalismo e della democrazia
borghese, ma ai loro caratteri costitutivi.
Non a caso, il fatto che la nuova sinistra partisse in genere dalla
critica al capitalismo, inteso come massimo sviluppo delle forze produttive
sociali, e alla democrazia, come mistificazione della partecipazione di tutti
alla cosa pubblica, era al centro di critiche severe da parte della sinistra
storica, per la quale si trattava di una critica sostanzialmente di élite, che
assolutizzava una tendenza del capitalismo moderno ancora di là da venire;
con il risultato di svilire e indebolire le battaglie della sinistra per uno
sviluppo e una modernizzazione adeguati alle esigenze delle classi
popolari. Accusa alla quale sovente si accoppiavano quelle di utopismo e
di velleitarismo, caratteristiche tipiche – secondo una certa cultura della
sinistra, soprattutto comunista – dei movimenti piccolo-borghesi, e non
autenticamente proletari.
Era evidente, in questo tipo di critiche, il persistere di quelle
concezioni del capitalismo in termini di sfruttamento assoluto, di miseria
crescente, di strutturale incapacità di avviare processi di modernizzazione
sociale, che a lungo fecero parte del bagaglio ideologico delle sinistre,
soprattutto in Europa, a volte ammantate di un marxismo asfitticamente
dogmatico (quello che portava i comunisti italiani e francesi, ad esempio, a
negare la crescita dei salari reali e dei consumi delle classi proletarie).
Concezioni di tipo democraticistico, per le quali il socialismo finiva – in
ultima analisi – per coincidere con lo sviluppo economico, più la
democrazia parlamentare, e che non potevano che mostrare insofferenza
per tutto quanto suonasse come implicito riconoscimento della capacità del
capitale di produrre (seppure in forme contraddittorie) ricchezza e
benessere.
Si spiega così, a mio avviso, l’atteggiamento ambiguo che
l’intellettualità progressista e i partiti democratici, socialisti e comunisti
ebbero nei confronti di molti movimenti di protesta, al loro nascere, diviso
tra l’appoggio alle istanze di rinnovamento e di riforma che in essi
comunque si esprimevano, e la diffidenza per l’eccesso di radicalismo che
vi si manifestava: mettere in discussione la scuola non solo per i suoi limiti
di classe, ma come meccanismo in sé di controllo sociale, negare a priori la
neutralità della scienza e della tecnica (e quindi la possibilità di un loro
uso non capitalistico), irridere al valore del lavoro quale fondamento della
società (di ogni società), rifiutare la democrazia politica come fosse, in ogni
modo, una truffa, non potevano che apparire – agli occhi delle sinistre –
come manifestazioni di un pericoloso infantilismo estremistico.
Non a caso, buona parte dei movimenti sociali visse nel corso degli
anni sessanta un processo di progressivo allontanamento dai partiti di
sinistra (da cui, in molti casi, erano addirittura nati: si pensi alle
organizzazioni giovanili studentesche). Il rifiuto aprioristico della delega
alle organizzazioni maggiori, l’esaltazione della lotta come unico fattore
dinamico della società, la ricerca – sovente – dello scontro a ogni costo,
l’insofferenza verso ogni mediazione istituzionale, un certo tipo di
linguaggio irrituale e non di rado volutamente provocatorio, erano tutti
elementi di una cultura che dalla sinistra, anche di matrice comunista, era
giudicata quanto meno ambigua. A ben vedere, la famosa poesia di Pier
Paolo Pasolini sugli studenti romani che, a Valle Giulia, si erano scontrati
con la polizia, nasceva anche da questo tipo di giudizi. E non è affatto
strano che esistessero simili diffidenze verso gli studenti e – più in
generale – verso certe forme di attivismo politico giovanile, perché agli
occhi di chi aveva visto nascere e trionfare il fascismo tutto ciò poteva
rievocare il ricordo dell’interventismo, dell’avanguardismo giovanile,
addirittura dello squadrismo. Né si può dire che, negli anni sessanta,
fossero problemi morti e sepolti: a più riprese, anche in anni recenti, alcune
manifestazioni di protesta politica (come quelle contro i trattati sulla
definizione del confine italo-jugoslavo) avevano avuto un carattere
nettamente di destra e avevano visto di nuovo gli studenti in piazza a
sventolare tricolori e ad aggredire gli antifascisti. È pienamente
comprensibile, dunque, che una parte della generazione che aveva vissuto
il fascismo e la guerra considerasse gli studenti un gruppo sociale ambiguo
e potenzialmente pericoloso. E non era così scandaloso e assurdo, ad
esempio, che in Germania il filosofo Jürghen Habermas nel 1967 definisse
certe manifestazioni radicali del movimento studentesco come “fascismo di
sinistra”; tesi che, più o meno sottovoce, circolava nel dibattito politico e
culturale della sinistra europea.
Alla radice di tutto ciò stava il fatto che un certo tipo di movimenti
erano il risultato di processi di crescita della società contemporanea che
la cultura progressista (compreso il marxismo volgarizzato delle sinistre
parlamentari) faticava a comprendere. Il ciclo di mobilitazione giovanile
internazionale, che culminò nel 1968 (e a questo proposito sarebbe giusto
non ricordare sempre e solo il maggio francese, ma anche quanto
avvenne negli Stati Uniti, che non fu meno clamoroso e dirompente), era
il frutto dello sviluppo “neocapitalistico” del dopoguerra, con tutto il
corollario della scolarizzazione di massa, dei nuovi modelli di consumo e
della diffusione dei grandi mezzi di comunicazione di massa; un
fenomeno di gigantesca trasformazione delle classi, che le culture
politiche tradizionali assolutamente non avevano previsto e che proprio
per questo diede l’impressione di un generale disordine, di un moto
improvviso (quindi pericoloso!) che veniva a turbare equilibri ritenuti
invece solidi e duraturi. Quando invece, a ben vedere, si trattava di
nient’altro che di mobilità sociale, del coinvolgimento di settori sempre
più ampi della piccola e media borghesia nel circuito produttivo
capitalistico, e delle forme di resistenza (opposizione, rifiuto) che ciò
inevitabilmente provocava, anche sul piano culturale; e qualcosa di
analogo stava accadendo a nuovi gruppi di lavoratori, immessi a viva
forza nelle fabbriche della produzione di massa, provenienti dalle
campagne interne o dall’estero, che non a caso furono i protagonisti (sul
finire degli anni sessanta) del più grande ciclo internazionale di lotte
operaie nella storia del capitalismo e della definitiva affermazione del
sindacalismo industriale di massa come modello organizzativo di classe.
Lo spazio politico e culturale che i movimenti della nuova sinistra
riuscirono a occupare, a fronte di quei fenomeni sociali, fu inversamente
proporzionale alla capacità delle sinistre storiche di capire cosa stesse
accadendo e di offrire a quelle masse in mobilità una teoria, adeguata
alle loro esigenze di lotta. Prigioniero di schemi ereditati da vecchie fasi
dello sviluppo capitalistico, il pensiero di sinistra (compreso certo
marxismo “ufficiale”) rifiutò nel complesso la sfida che veniva dai
movimenti, interpretandoli perlopiù come “estremismo”, “infantilismo”,
“soggettivismo piccolo-borghese”, e tentando (a volte con successo) di
ricondurli disciplinatamente all’ovile.
Indicativo di questo atteggiamento è la sufficienza (che è cosa ben
diversa dalla critica, anche la più radicale) con cui furono trattate in
genere le culture dei movimenti. Culture che intrecciavano
disinvoltamente individualismo e comunitarismo, elementi politici e
suggestioni della civiltà dei consumi di massa, un certo bagaglio
ideologico di matrice rivoluzionaria (comunista, anarchica, sindacalista)
e l’influenza delle avanguardie artistiche del Novecento. Un intreccio
fortemente contraddittorio, nel quale il pacifismo e le pratiche libertarie
di gruppo potevano convivere con la prassi rivoluzionaria delle
organizzazioni politiche, la lettura vorace e disordinata di testi marxiani
con la fruizione dei prodotti intellettuali di massa (cinema, fumetti,
televisione), i poster di Che Guevara – volendo banalizzare un po’ – con
quelli di Jimi Hendrix. Una contaminazione che era anche di linguaggi,
come dimostra (per esempio) il fatto che un’organizzazione politica di
estrema sinistra italiana, quale Lotta Continua, potesse scegliere come
“inno” una canzone di successo del mercato nordamericano (Eve of
Destruction, di Barry McGuire), modificandone il testo e facendola
diventare L’ora del fucile. E non c’è dubbio che fosse proprio la
contraddittorietà di questi intrecci a consentire alla “nuova sinistra” di
costituirsi come uno spazio comunicativo aperto, più ancora che come
uno spazio politico in senso stretto, nel quale potevano riconoscersi
soggetti tra loro anche molto diversi, dai giovani arrabbiati del
movimento beat agli studenti in lotta, dalle donne del primo
femminismo a settori minoritari del movimento operaio.
Può essere utile, per comprendere alcuni caratteri ideologici dei
movimenti, considerare quali fossero i testi più letti e discussi verso la
fine degli anni sessanta. Se prendiamo in esame L’uomo a una
dimensione di Herbert Marcuse, La società dello spettacolo di Guy
Debord e la Autobiografia di Malcolm X, che furono senza dubbio tra i
volumi che all’epoca circolarono maggiormente, possiamo renderci conto
della eterogeneità delle influenze politiche e culturali, che agirono sulla
formazione di una generazione di attivisti, soprattutto studenteschi.
Abbiamo infatti, nel primo caso, la versione forse più radicale (e per certi
versi politicamente ambigua) della critica francofortese della modernità;
nel secondo caso lo sviluppo estremo delle avanguardie artistiche
novecentesche, con la teorizzazione delle “situazioni creative” quale
unica risposta efficace all’alienazione dei meccanismi di produzione e di
consumo; e nel terzo l’espressione del rivoluzionarismo afroamericano
più spinto, frutto di un intreccio fra nazionalismo nero panafricanista e
culture religiose legate a una versione particolare dell’Islam. Teoria
critica, situazionismo, nazionalismo nero, dunque. Certo, ciò non
significa che queste opere siano rappresentative – sic et simpliciter –
della cultura politica dei movimenti; sarebbe assurdo, ad esempio,
dimenticare l’enorme diffusione dei testi marxiani e leninisti (che fece,
tra l’altro, la fortuna di alcune case editrici di sinistra), e la sterminata
produzione teorica di orientamento comunista che trasse origine dalle
lotte sociali di quegli anni e dall’ambito stesso dei movimenti. Si deve
quindi parlare, quanto meno, di un forte intreccio fra il marxismo (nelle
sue diverse versioni) e un insieme spurio di influenze di altra natura
(come dimenticare, ad esempio, il ruolo che ebbe in Italia un libro come
Lettera a una professoressa, di don Milani, profondamente intriso di
populismo cattolico?).
Anche a considerare un’opera, che pure si presentava con un solido
impianto marxiano, come Operai e capitale di Mario Tronti (considerato
una sorta di “manifesto” del cosiddetto operaismo italiano),
l’impressione è quella di una cultura politica difficilmente assimilabile
al comunismo storico. L’assolutizzazione degli interessi materiali operai
(«gli operai moderni, e non da oggi, vogliono soprattutto due cose:
lavorare poco e guadagnare molto»), le negazione quasi sprezzante di
alcuni valori forti del movimento dei lavoratori («l’etica del lavoro è
un’etica cristiano-borghese, quanto di più lontano e nemico per la
coscienza operaia»), lo schema interpretativo dello sviluppo capitalistico
(«prima la classe, poi il capitale»), l’immagine del comunismo come di un
processo che costituisce dentro alla società borghese il potere degli
operai: tutto, in Tronti, era agli antipodi del comunismo di derivazione
terzinternazionalista, e sembrava rimandare piuttosto a una rilettura,
originale, del sorelismo, applicato alle condizione della grande fabbrica
moderna (da qui anche l’esaltazione della classe operaia come «rude
razza pagana»). Un impianto concettuale che, a ben vedere, andava molto
al di là delle posizioni di Panzieri, con il quale pure (sino alla prematura
morte del dirigente socialista, una delle figure più alte del marxismo
italiano, messo ai margini del movimento operaio ufficiale) Tronti e altri
intellettuali di sinistra avevano collaborato nell’esperienze dei
«Quaderni rossi». Panzieri per certi versi si muoveva ancora,
teoricamente, nell’ambito del socialismo tradizionale (né si può dire,
ovviamente, quali sarebbero state le sue scelte personali alla fine degli
anni sessanta), Tronti sicuramente no, anche se continuò a militare nel
partito comunista. Il che costituisce forse un paradosso solo apparente,
che sarebbe molto utile approfondire e chiarire; ma a tutt’oggi
(nonostante il gran parlare dell’operaismo teorico e delle sue influenze
sul movimento di classe, non solo in Italia) non abbiamo purtroppo una
storia critica di quelle correnti eterodosse del pensiero comunista, che ci
aiuti a capirne di più; possiamo solo limitarci a osservare che,
curiosamente, la storiografia più legata alla tradizione socialista e
comunista ne ha tenuto davvero poco conto (è un po’ clamoroso, ad
esempio, che nella recente Enciclopedia della sinistra europea nel XX
Panzieri figuri solo di sfuggita, e non gli sia dedicata neppure una
scheda biografica).
Peraltro va sottolineato che nella storia dei movimenti degli anni
sessanta e settanta il biennio 1968-69 rappresentò uno spartiacque
decisivo, da un lato perché le lotte sociali assunsero allora un carattere
più marcato di radicalità, e dall’altro per il ruolo della conflittualità
operaia, che riportò al centro del dibattito internazionale temi e problemi
che in precedenza non erano affatto così decisivi per le esperienze della
nuova sinistra (si pensi alle tesi sulla definitiva integrazione nel sistema
della classe operaia, e al fascino che su molti attivisti studenteschi aveva
esercitato in questo senso Marcuse). Non c’è dubbio che a partire da quel
biennio tutti i movimenti di protesta, sia in Europa sia nel Nord America,
furono portati a intrecciare maggiormente le proprie culture
(sostanzialmente di matrice radicale) con quelle del movimento operaio
organizzato e, in qualche misura, delle sinistre storiche. Un fenomeno
che è stato sottolineato persino a proposito degli Stati Uniti, dove alcuni
movimenti – quello afroamericano e in parte anche quello studentesco –
finirono per amalgamare in qualche modo i propri linguaggi e le proprie
forme di organizzazione con elementi di tipo politico tradizionale, in
qualche caso addirittura vetero-comunista: si pensi a certa retorica
politica del Black Panther Party, nella sua ultima fase, o al paradossale
programma politico da socialismo reale dei Weathermen Underground,
un’organizzazione clandestina nata dalle ceneri del movimento
studentesco.
Ciò non vuol dire che, a partire dal secondo “biennio rosso” del
Novecento (come, con una certa forzatura storica, è stato definito il 196869), i movimenti mutassero alla radice la propria cultura politica di
fondo; significa però che dall’esplodere della conflittualità operaia in
forme e dimensioni di quella portata tutte quelle esperienze furono
inevitabilmente condizionate, nel senso di una maggiore politicizzazione
e di un’assimilazione di linguaggi, modi di agire e di organizzarsi che in
precedenza avevano un’influenza assai minore. Non si può, a mio avviso,
parlare dei movimenti sociali di nuova sinistra, dopo il 1968-69, senza
mettere al centro della riflessione quella sorta di egemonia che la classe
operaia industriale arrivò a esercitare in tutti i campi delle relazioni
sociali (non escluse quelle culturali). È una storia in larga parte ancora da
scrivere, ma che non può prescindere dal ruolo del conflitto di fabbrica,
in quegli anni, nel dettare i tempi della politica e della società.
La nuova sinistra, in quella nuova temperie, tentò in un primo
momento di presentarsi come il referente dei settori operai meno
integrati e qualificati (immigrati in Europa, neri di urbanizzazione più
recente negli Stati Uniti), in aperta e violenta polemica con le centrali
sindacali ufficiali. Non ebbe successo, tant’è vero che quasi tutte le
organizzazioni minoritarie di base, attive nelle fabbriche attorno al 196869, ebbero vita abbastanza breve e i loro militanti finirono per essere
assorbiti dalle strutture sindacali; e tuttavia non c’è dubbio che esercitò
un ruolo decisivo nell’orientare atteggiamenti e scelte di forti gruppi di
lavoratori, lungo tutti gli anni settanta (oltre a costituire una forza di
tutto rispetto tra i lavoratori dei servizi, in primo luogo nella scuola). E si
può forse avanzare l’ipotesi che in quegli anni, in presenza di una
fortissima e pervasiva politicizzazione della vita pubblica, i movimenti
di nuova sinistra siano stati (fatte le dovute distinzioni) quel che
all’inizio del Novecento era stato il sindacalismo rivoluzionario, con la
stessa violenta agitazione contro i compromessi delle organizzazioni
“riformiste” e la stessa ricorrente tendenza all’entrismo in esse, lo stesso
massimalismo delle parole d’ordine e la stessa fragilità di prospettive
politiche complessive. Ma anche questa è una riflessione che andrebbe
approfondita e sorretta con un’analisi storica rigorosa.
I movimenti degli anni sessanta e settanta, in ultima analisi,
possono essere indicati come l’espressione di una realtà sociale sempre
più complessa, in forte evoluzione e con tratti profondi di novità, e al
contempo di una cultura politica eterogenea, che ambiva (senza peraltro
riuscirvi appieno) a essere alternativa a quella delle sinistre storiche. Tra
la loro natura sociale e le ideologie che sovente utilizzarono, soprattutto
sul versante più direttamente politico, c’era una contraddizione latente,
che derivava dalla difficoltà di chiarire che cosa potesse sostituire l’idea
della rivoluzione politica, di derivazione terzinternazionalista, e al
tempo stesso del riformismo democratico. I movimenti sapevano cogliere
spesso elementi fondamentali delle trasformazioni, in atto nel
capitalismo, con grande capacità di anticipazione storica (si pensi al
discorso sulla “nuova classe operaia”, da Serge Mallet sino alle teorie sul
lavoro intellettuale di massa), ma quando dovettero confrontarsi con la
politica – e in particolare con il problema dello Stato – non riuscirono a
elaborare una vera rottura storica con gli apparati concettuali della
tradizione di sinistra. L’idea stessa di rivoluzione, che stava al centro del
loro discorso politico, finiva per risolversi o nella velleità di riprodurre le
esperienze rivoluzionarie classiche (la Russia bolscevica o la Cina
maoista) in modo nuovo e più libertario, senza rendersi conto della loro
non riproducibilità storica nella condizioni del capitalismo maturo, o in
una teorizzazione del movimento perenne, della “lotta continua”, di una
sorta di “azionismo” di massa insofferente di ogni mediazione
istituzionale, ma anche incapace di indicare tappe e obiettivi concreti
della prassi rivoluzionaria.
Movimenti sociali in larga parte non tradizionali, non seppero
mettere capo (almeno sotto il profilo politico, ché diverso è il discorso sul
piano dei linguaggi e delle forme di comunicazione) a una cultura
davvero nuova. E si può forse dire che la loro importanza storica derivi
proprio dall’essere stati (al tempo stesso) una delle ultime grandi
esperienze all’insegna delle ideologie radicali del Novecento, e
l’anticipazione di tendenze e sviluppi nuovi, irriducibili a quelle
ideologie. Dall’essere stati dentro e fuori il comunismo. Contraddizione
che ne fu la forza, ma anche il limite più vistoso.
Quei movimenti forse hanno contribuito a cambiare il mondo,
come in molti sostengono (e qualcuno si è spinto a fare un ardito
parallelo con i movimenti della metà dell’Ottocento: «ci sono state solo
due rivoluzioni mondiali. Una nel 1848. La seconda nel 1968. Entrambe
hanno fallito. Entrambe hanno trasformato il mondo»). Ma di certo lo
hanno fatto in un modo che non era quello progettato e sognato in quegli
anni di forti mobilitazioni collettive. La rivoluzione che si pensava
sarebbe venuta (spontaneamente, forse) dalle lotte non c’è stata, né
poteva esserci: almeno, non nei termini confusi in cui era prospettata. È
probabile, però, che per le centinaia di migliaia di attivisti che in tutto il
mondo, senza essere collegati tra loro da nessuna “internazionale”,
inseguirono il sogno di una rivoluzione comunista ma antiautoritaria,
egualitaria ma ricca delle mille diversità del presente, contavano più il
movimento in sé, la lotta continua, che il risultato finale. E si può quindi
dire di loro quello che Hannah Arendt scriveva dei giacobini francesi (e
che Peppino Ortoleva ha ripreso nel suo saggio sul ’68 in Europa e in
America), a proposito di una «domanda tormentosa, allarmata e
allarmante, che avrebbe perseguitato ogni rivoluzionario degno di
questo nome da Robespierre in poi: se la fine della rivoluzione
significava la fine della libertà pubblica, era desiderabile farla finire»?.
Bibliografia
Giovanni ARRIGHI, Immanuel WALLERSTEIN, Terence HOPKINS,
Antisystemic Movements, Roma, manifestolibri, 1992
Nanni BALESTRINI, Primo MORONI, L’orda d’oro, nuova ed. a cura di
Sergio Bianchi, Milano, Feltrinelli, 1997 (prima ed.: Milano, SugarCo,
1988)
Uwe BERGMAN, Rudi DUTSCHKE, Wolfgang LEFÉVRE, Bernd RABEHL,
La ribellione degli studenti, ovvero La nuova opposizione, Milano,
Feltrinelli, 1968
Conflitti in Europa. Lotte di classe, sindacati e Stato dopo il ’68, a
cura di Colin Crouch e Alessandro Pizzorno, Milano, Etas Libri, 1977
Donatella DELLA PORTA, Mario DIANI, I movimenti sociali, Roma, La
Nuova Italia Scientifica, 1997
Enciclopedia della sinistra europea nel XX secolo, diretta da Aldo
Agosti, Roma, Editori Riuniti, 2000
Marco GRISPIGNI, Elogio dell’estremismo. Storiografia e movimenti,
Roma, manifestolibri, 2000
Michael HARDT, Paolo VIRNO, a cura di, Radical Thought in Italy,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996
Saree MAKDISI, Cesare CASARINO, Rebecca KARL, a cura di,
Marxism beyond Marxism, New York, Routledge, 1996
Peppino ORTOLEVA, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in
America, Roma, Editori Riuniti, 1998 (prima ed.: 1988)
Franco OTTAVIANO, La rivoluzione nel labirinto. Sinistra e
sinistrismo dal 1956 alla fine degli anni Ottanta, Soveria Mannelli (Cz) –
Messina, Rubbettino, 1993
Le radici del ’68. I testi fondamentali che prepararono la rivolta di
una generazione, Milano, Baldini & Castoldi, 1998
Marco REVELLI, Movimenti e spazio politico, in Storia dell’Italia
repubblicana, vol. II, tomo 2, Torino, Einaudi, 1995
Marco SCAVINO, «La classe operaia deve dirigere tutto». Ascesa e
declino di una egemonia sociale, in La stagione dei movimenti, a cura di
Sergio Dalmasso, numero monografico di «Il Presente e la storia», n. 59,
giugno 2001
Il Sessantotto: l’evento e la storia, a cura di Pier Paolo Poggio,
«Annali della Fondazione Luigi Micheletti», n. 4, 1988-1989
Gayatri SPIVAK, In Other Wordls. Essays in Cultural Politics, New
York, Routledge, 1988
Gianni Statera, Storia di una utopia. Ascesa e declino dei movimenti
studenteschi europei, Milano, Rizzoli, 1973
Gli studenti e la nuova sinistra in America, a cura di Enrico Forni,
Mitchell Cohen e Dennis Hale, Bari, De Donato, 1968
Mario TRONTI, Operai e capitale, Torino, Einaudi, 1971 (nuova ed.
accresciuta; prima ed.: 1966)