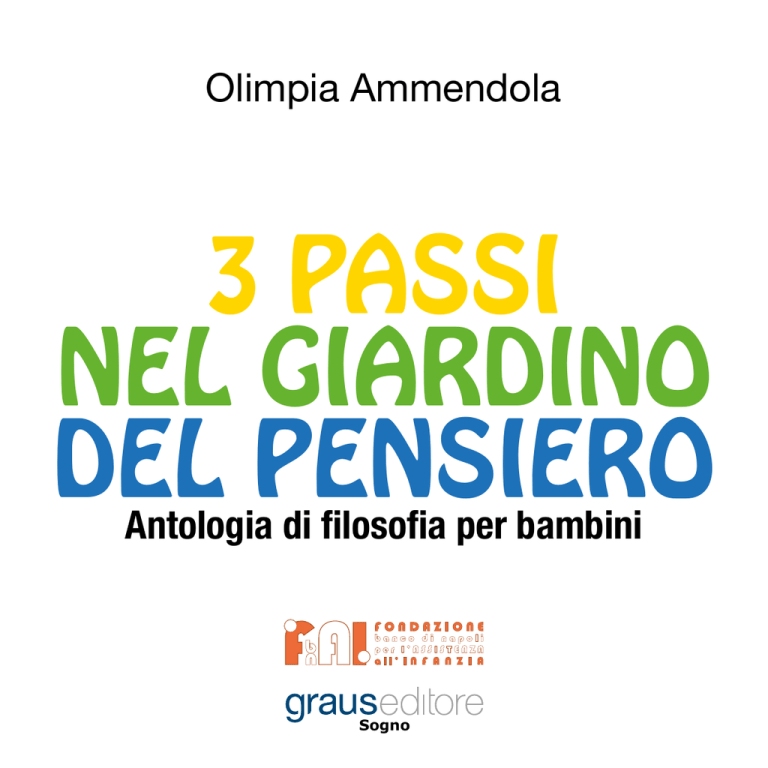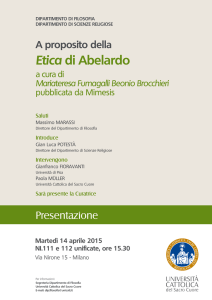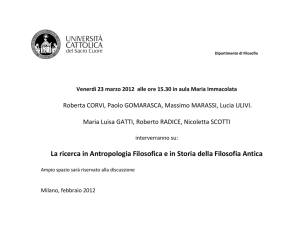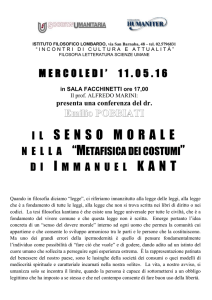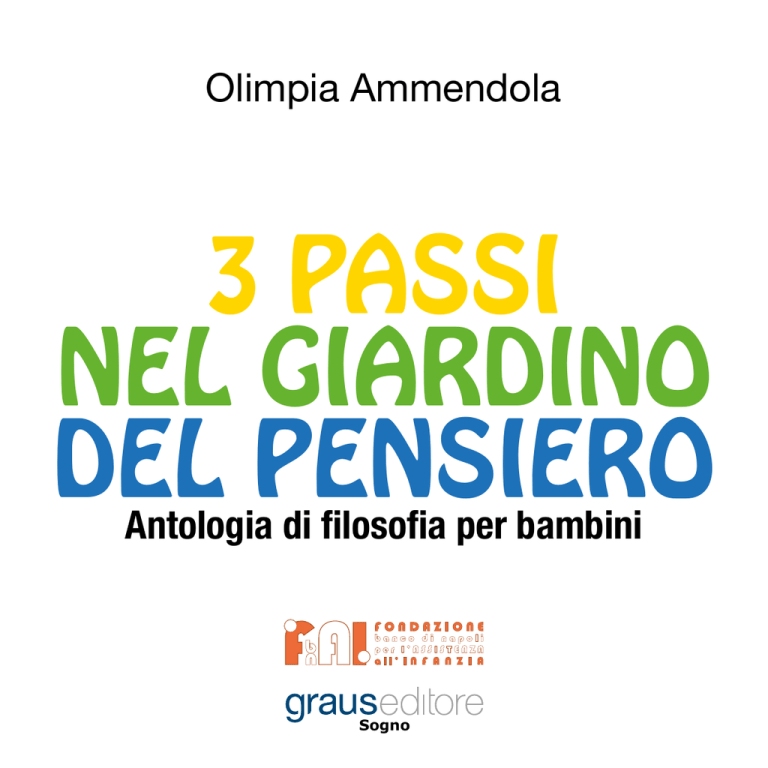
Olimpia Ammendola
3 PASSI
NEL GIARDINO
DEL
PENSIERO
Antologia di filosofia per bambini
Sogno
© 2012
sede di napoli:
9, piazza san domenico maggiore
palazzo sansevero
80134 napoli
tel/fax +39.081.7901211
sede di roma:
1055, via tuscolana
palazzina 59
cinecittà studios
00173 roma
tel. +39.06.72.29.37.55
www.grauseditore.it
[email protected]
collana
sogno
progetto grafico e regia sinestetica
mario esposito
illustrazioni
salvatore criscuolo
Al piccolo
Giuseppe Carotenuto
INDICE
PREFAZIONE dell’Autrice
PRESENTAZIONE di Pina Montesarchio
PRESENTAZIONE di Domenico Massaro
pagina6
8
9
IL PROBLEMA DEL MALE
Un furto di pere - Le Confessioni di Agostino
Il bene assoluto non esiste - Hobbes
Nella vita il bene prevale - Leibniz
Il bene è tale solo se è legge universale - Kant
Storia di un assassino - Hegel
12
13
15
17
19
21
IL PROBLEMA DELL’ORIGINE DELL’UNIVERSO
L’universo ha origine dall’acqua - Aristotele
Racconto biblico - Genesi
Il racconto di Timeo - Platone
La teoria di Tolomeo
La teoria di Copernico
24
26
27
29
31
32
IL PROBLEMA DELLA FELICITÀ
Storia del cane - Maestro Sufi
Frammenti
La filosofia forma e forgia l’animo - Seneca
La meditazione interiore - Marco Aurelio
Lettera a Meneceo - Epicuro
Lettera sulla morale - Cartesio
33
34
35
37
38
40
43
IL PROBLEMA DELLA CONOSCENZA
Il mito della caverna - Platone
Non giudichiamo gli altri - Montaigne
Il dubbio su ciò che ho imparato - Cartesio
Le regole del corretto ragionare - Cartesio
L’amicizia - Aristotele
L’amor proprio nemico della vera amicizia - Pascal
Ogni uomo ha bisogno di un altro uomol - Feuerbach
45
45
47
49
52
55
59
60
LA GIUSTIZIA E LA PACE
La settima lettera e la vicenda di Socrate - Platone
La tolleranza - Locke
Il potere giusto - Locke
Per la pace pepetua - Kant
La guerra è necessaria e inevitabile - Hegel
Lettera di Einstein a Freud - Einstein
La risposta di Freud - Freud
62
63
67
69
70
71
73
75
PREFAZIONE
Quando qualche anno fa mi accinsi a scrivere Il cielo stellato sopra di me,
non immaginavo che questa mia pubblicazione avrebbe aperto un percorso di lavoro così impegnativo e se da un lato la cosa senz’altro costituisce
una gran fatica, dall’altro non può non riempirmi di gioia l’aver saputo intuire quello che si è rivelato un bisogno inespresso del mondo dell’infanzia.
In questi due anni di sperimentazione nella scuola elementare, ho avuto la
possibilità di testare il mio libro e l’esperienza mi ha fatto capire, innanzitutto,
che il range d’età che avevo previsto è molto più ampio. In effetti il libro è stato
letto e apprezzato sia da bambini più piccoli dei 7 anni che più grandi dei 12. Infatti, anche se la metodologia proposta è senz’altro adatta ad un pubblico infantile, le
problematiche proposte non hanno età e quindi, Il cielo stellato è servito a riannodare fili e
discorsi rimasti sospesi anche per le persone adulte che hanno lasciato la filosofia del liceo senza mai averla
compresa. Una disciplina non compresa è un discorso che rimane incompiuto, non concluso, e non concludere un’esperienza dà la sensazione di un vuoto, non solo intellettuale ma anche affettivo e sentimentale.
Noi pensiamo sempre che il sapere sia qualcosa di arido, ci immaginiamo sempre come dei contenitori vuoti, per cui un contenuto in meno alleggerisce semplicemente il contenitore. Non pensiamo mai che durante
l’avventura della conoscenza attiviamo pezzi di noi, e che sempre, in qualunque momento, siamo soggetti
attivi anche quando la disciplina non ci “piace” e quindi fatica ad “entrarci dentro”. I bambini con i quali
ho lavorato, hanno partecipato non solo con tanto entusiasmo al progetto “Aletheia”, ma mi hanno anche
sollecitato a tante riflessioni su quella che, per me, era una prima volta e, per giunta, motivata da ragioni
completamente diverse da quelle che poi si sono imposte lungo il cammino. In tal senso, quest’esperienza
è stata una scoperta, un’avventura che ha cambiato i bambini, ma soprattutto me e, credo, le colleghe con
le quali ho condiviso quest’esperienza.
Un’esperienza che ha significato innanzitutto trasmettere ai bambini cosa vuol dire usare il cervello in modo
critico, cosa vuol dire accogliere le domande metafisiche, le domande ultime, quelle che un certo modo
di concepire la scienza e la conoscenza aveva lasciato in soffitta, ai margini del processo di ricerca. Fare
filosofia con i bambini ha significato innanzitutto anche per noi vivere le domande, analizzarle, entrarci dentro, esplorare la storia delle idee, la storia delle risposte che di volta in volta i filosofi hanno dato ai grandi
“perché” della vita umana, che anche i bambini già molto presto si pongono. Infatti, insegnare filosofia ai
bambini significa, senz’altro, far comprendere che la verità è un traguardo provvisorio, ma anche che non si
intende trasmettere soltanto sospetti o incertezze, perché il sospetto e l’incertezza sono un mezzo e non un
6
fine della ricerca filosofica è grazie alla filosofia che la scienza in Occidente è nata e cresciuta e ha cambiato
la vita dell’uomo e questo è un patrimonio troppo importante per poter esser considerato appannaggio
esclusivo di esperti o specialisti. Io credo che il libro che ho proposto possa essere agevolmente usato da
chiunque ritenga la cultura un grande cammino verso l’ignoto, che apprendere non debba servire a ridurre
l’ignoto che è davanti a noi. Anche perché non lo credo possibile. Pensare di ridurre l’ignoto apparteneva
ad una concezione cumulativa e progressiva della conoscenza. Oggi si è compreso che il sapere è costellato
da discontinuità, improvvisi salti, fratture, ricomposizioni con quanto si riteneva definitivamente superato.
La cultura è lo specchio dell’uomo che, come diceva Kant, è un legno storto. Inoltre, anche se è importante
capire come l’umanità ha cercato di affrontare e risolvere gli interrogativi che si è posta, più importante
ancora è comprendere che dobbiamo imparare ad abitare la domanda, a capire che tra domanda e risposta
non vi è un rapporto di simmetria, perché la prima è molto più ampia della seconda e che quella domanda
ha avuto, nel corso dei secoli, differenti modi di essere formulata e differenti percorsi di soluzione.
Il cielo stellato sopra di me cercava di trasmettere al bambino soprattutto questo, i differenti modi con i
quali i filosofi hanno formulato la domanda, che in quanto tale, resta in tutta la sua problematicità, ed è
rispetto a questo che dobbiamo imparare noi tutti, grandi e bambini, a porci: sapendo di non sapere, con
la sola consapevolezza che il passaggio alla maieutica è l’unico possibile, perché è l’unico che ci apre alle
varie possibilità e al rispetto delle differenze. 3 Passi nel giardino del pensiero vuole continuare e arricchire
il discorso iniziato, ma anche tentare un approccio differente, quello tematico. Non ho mai creduto che
l’approccio per temi fosse alternativo a quello storico. Anzi, ritengo che, soprattutto i bambini, abbiano
bisogno di sapere che la verità è figlia del tempo e che ogni tempo ha quindi elaborato un suo modo di
guardare alle questioni della filosofia. È necessario, dunque, contestualizzare i problemi che vengono posti, così come è necessario guardare ai problemi in sé e per sé nella loro significanza metatemporale, nella
loro trasversalità e interdisciplinarietà. È da questo bisogno che questa seconda opera è nata. I 3 Passi nel
giardino del pensiero sono i tre momenti indispensabili nella relazione didattica: l’emozione, il sentimento,
la logica. Forse in questi anni si è dato uno spazio eccessivo all’emozione e in generale al “sentire” degli
alunni, sacrificando gli aspetti logici e razionali che non possono essere mortificati né emarginati nella relazione educativa.
Ogni essere umano ha bisogno, in realtà, di vivere armonicamente tutte e tre queste componenti. Io credo
che, paradossalmente, una disciplina considerata da sempre molto astratta e lontana dalla concretezza
del vivere quotidiano, sia molto adatta ad aiutare l’allievo a crescere senza mortificare nessuna di queste
componenti. La filosofia nasce da un’emozione, la meraviglia che ogni essere prova di fronte alla natura, ai
problemi, all’ignoto cercando una spiegazione razionale. La filosofia, quindi, può sicuramente contribuire a
quello sviluppo armonico dell’essere umano che da sempre è l’obiettivo primo di ogni educazione.
L'Autrice
7
PRESENTAZIONI
La filosofia non può fare a meno di fondarsi sulle conquiste dei grandi pensatori che ci hanno preceduto. L’opera di Olimpia Ammendola è
espressione alta di questo bisogno. La storia della filosofia è quella del
pensiero che trova se stesso.
Una laminetta orfica fu trovata nella tomba di una giovinetta in una località della Magna Grecia, in cui, all’anima della defunta si consigliava
di non accostarsi alla prima fonte che avrebbe trovato, quella del Lete,
o della dimenticanza, bensì alla seconda, che scorreva dalla palude di
Mnemosine, cioè della Memoria. La salvezza consisteva nell’attingere alla
memoria: mantenere la memoria vuol dire mantenere l’identità. Significativo è anche il fatto che, per i Greci, Mnemosine era la madre delle Muse,
quindi la madre della civiltà: la civiltà è dunque fondata sulla memoria storica.
La filosofia, come sforzo di cogliere con la nostra ragione la razionalità presente nella realtà, è l’opera di
due millenni e mezzo. Il lavoro di tutte le generazioni che furono.
La filosofia è come un tentativo di dimostrare il teorema della realtà intera: nel ragionamento filosofico
nessun termine è superfluo o casuale. Hegel afferma: “Ogni filosofia è stata necessaria”.
Se il ragionare non è immediato, bensì mediato, è passaggio da un termine all’altro, è evidente che esso
non può svolgersi in un punto del tempo, in un attimo, bensì è un processo temporale, storico. La filosofia
si dispiega nella storia, la filosofia coincide con la sua storia.
I filosofi hanno soltanto interpretato diversamente il mondo, adesso bisogna cambiarlo è scritto da qualche
parte. Se anche la filosofia non abbia da vivere il cambiamento, resta questione aperta. Il cambiamento
sta nella diversa attenzione che da qualche tempo si vuole all’esercizio della sua pratica, di cui si fa ottima
interprete Olimpia Ammendola, che non esclude la conoscenza della filosofia nell’evolversi della sua storia,
bensì assume le ‘pagine’ dei filosofi come mattoni di un percorso sicuro eppure accidentato, luogo in cui
ai bambini e ai ragazzi sia dato perdersi e poi ritrovarsi, attraverso un lavoro continuo di decostruzione, di
smascheramento, di critica nei confronti di ciò che l’opinione vorrebbe imporre alla ragione con la forza
dell’ovvietà. L’antologia filosofica per bambini e ragazzi di Olimpia Ammendola realizza, altresì, un valido
contributo nell’ambito del lavoro di ricerca di Amica Sofia di cui l’autrice è da anni compagna di viaggio.
Pina Montesarchio
8
Il libro che hai tra le mani, o lettore, non è come tutti gli altri. Non vuole insegnarti né la grammatica né la
matematica, e neppure la geografia. Il suo interesse non concerne né le guerre né l’altezza delle montagne
o la formazione dei fiordi, poniamo, della Norvegia. È tuttavia un libro utile, anzi necessario. Si prende
cura di tutta la tua persona, ragione e cuore, sentimenti e passioni. L’ha pensato e realizzato una persona
adulta – la stessa che aveva già scritto un’antologia per bambini intitolata Il cielo stellato sopra di me (che
mi è piaciuto molto quando l’ho letto) – un’insegnante appassionata di una strana materia che si chiama
filosofia. Strana, ma antica, anzi la più antica tra quelle che conosci.
La filosofia, infatti, è nata molto tempo fa, nel VI sec. a. C., nelle ricche città commerciali della Grecia.
Ai suoi inizi era un’attività pratica e concreta, che nasceva dal bisogno dell’uomo di rispondere ai grandi
interrogativi dell’esistenza. Provo a fare un elenco di alcuni di questi interrogativi, senza avere la pretesa
di esaurirli tutti.
Eccoli:
- Che cos’è il bene e che cosa il male?
- Che cosa giusto e che cosa ingiusto?
- Perché esiste il mondo, la natura, gli alberi, le stelle; e perché io stesso sono venuto al mondo?
- È meglio esistere o non essere mai nati, specie se si nasce poveri o malati?
- In che cosa consiste la felicità di cui gli adulti parlano così spesso?
- Chi uccide o pensa solo a se stesso è felice?
- È bello avere amici con cui giocare e divertirsi. Sicuramente sì. Ma siamo anche sicuri che
gli amici possono essere cari anche quando non sono né ricchi, né felici né in buona salute?
- Dobbiamo rispettare gli altri: anche quando la pensano diversamente da noi?
- È più facile fare la guerra o costruire la pace?
- Come si costruisce la pace?
Ripeto, sono solo alcune delle domande che ognuno di noi può porsi. Tu stesso potrai aggiungerne altre,
dopo aver riflettuto su ciò che più ti sta a cuore.
9
Ma una cosa è certa: gli esseri umani non possono vivere senza porsi delle domande. Socrate, uno dei
più grandi filosofi di tutti i tempi, usava dire ai suoi giovani ascoltatori che una vita senza domande non
è degna di essere vissuta. Ma perché? Interroghiamoci anche su questa affermazione: “Una vita senza
domande non è degna di essere vissuta”.
In che senso?
Facciamo un esempio: poniamo che mi scappa una bugia, per difendermi da qualche errore che ho commesso o semplicemente per imbrogliare il prossimo. La strana materia che è la filosofia mi suggerisce di
non essere superficiale, dire la bugia, come fan tutti. Mi invita a riflettere. Sì la filosofia non costringe,
non bastona nessuno né infligge punizioni o multe, come fanno giudici e poliziotti. La filosofia ci lascia
liberi, ma dopo averci insegnato la strada della riflessione. Riflettiamo, dunque. Mettiamoci nei panni di
chi è costretto ad ascoltare la nostra bugia, la mamma, il babbo, l’insegnante, l’amico. Se io fossi al loro
posto, mi piacerebbe essere imbrogliato? Prova a rispondere. Per conto mio, la risposta è no. E, ancor più,
immaginiamo come sarebbe la nostra società se tutti dicessero bugie. Nessuno si fiderebbe più dell’altro.
Sarebbe una società insopportabile, anzi impossibile da viverci.
Ecco, dunque, che abbiamo guadagnato un punto fermo. Prima di agire dobbiamo farci delle domande su
quello che stiamo per fare. E solo dopo aver risposto ad esse in buona fede possiamo agire.
La filosofia c’insegna a porci correttamente le domande, ci aiuta a chiarirci le idee, perché sa che avere
idee valide su noi stessi, sui nostri comportamenti, su ciò che è bene o male, ecc., ci aiuta a vivere bene
insieme agli altri e a essere felici. Una volta che ci siamo correttamente interrogati se è bene o male dire
bugie, e abbiamo capito che è bene non dirle, sarà più facile per noi agire di conseguenza. Certo, a volte
qualche bugia ci scapperà lo stesso; ma sapremo che non è un bene. Nessuno di noi è perfetto – non ci è
nemmeno richiesta la perfezione – e, dunque, possiamo sempre sbagliare. La filosofia non ci serve per diventare perfetti né sapientoni, ma semplicemente per riconoscere i nostri errori e cercare di porvi rimedio.
In questo senso, la filosofia è utile a tutti, ragazzi, giovani o vecchi; perché a tutte le età è necessario far
funzionare bene la mente e ragionare correttamente.
L’antologia filosofica che segue potrà senz’altro esserti di grande aiuto in tal senso. Ogni capitolo affronta
un tema – il bene, il male, l’universo, la felicità, la tolleranza, la pace e la guerra – e ti offre qualche semplice brano tratto da un filosofo (antico o moderno, lontano o a noi vicino, non importa), perché tu possa
riflettere su ciò che ti vuol dire e insegnare. Il resto lo devi fare tu. Una volta capito come si affronta un
problema, sarai tu stesso a porti correttamente le domande e darti in piena libertà le risposte. In questo
modo crescerai in modo armonico: con lo sviluppo fisico e l’arricchimento delle tue conoscenze di storia,
geografia e matematica, conquisterai anche – grazie alla filosofia – una migliore conoscenza di te stesso.
Al lavoro, dunque, e buona lettura.
Domenico Massaro
10
BAMBINI
G. RODARI
IMPARATE A FARE LE COSE DIFFICILI
PARLARE AL SORDO
MOSTRARE LA ROSA AL CIECO
LIBERARE GLI SCHIAVI
CHE SI CREDONO LIBERI
11
IL PROBLEMA DEL MALE
Da dove nasce il male?
L’uomo che opera il male può essere felice?
Il pentimento annulla il male fatto?
Perché Dio ha creato il male?
Prova a rispondere alle domande
12
UN FURTO DI PERE
Nelle vicinanze della nostra vigna
sorgeva una pianta di pere carica di
frutti, d’aspetto e sapore, per nulla
allettanti. In piena notte, dopo aver
protratto i nostri giochi sulle piazze,
come usavamo fare pestiferamente,
ce ne andammo, da giovinetti depravatissimi quali eravamo, a scuoter la
pianta, di cui poi asportammo i frutti.
Venimmo via con un carico ingente
e non già per mangiarne noi stessi,
ma per gettarli addirittura ai porci.
Se alcuno ne gustammo, fu soltanto per il gusto dell’ingiusto.
Agostino, Le Confessioni
Perché Agostino e i suoi compagni rubano le pere?
Perché avevano fame
Perché provavano gusto a fare una cosa ingiusta
13
colora il disegno
IL BENE ASSOLUTO NON ESISTE
Ogni uomo chiama ciò che gli piace, bene, e male ciò che gli dispiace; cosicchè, dato che ognuno di noi è diverso dall’altro per quanto riguarda la
costituzione fisica, così siamo diversi anche riguardo alla comune distinzione di bene e male. Il bene assoluto non esiste. Infatti anche la bontà che
attribuiamo a Dio onnipotente, è la sua bontà per noi. E come chiamiamo
bene o male le cose che ci piacciono o ci dispiacciono, così chiamiamo
bontà o cattiveria le qualità o poteri mediante i quali tali cose lo sono.
Hobbes, “Elementi di legge naturale e politica” in Il pensiero etico politico
15
Fai un elenco di azioni buone e uno di azioni cattive, ad
ogni azione prova a dare un punteggio da uno a dieci e
confrontati con i tuoi compagni.
Azioni buone
16
Voto
Azioni cattive
Voto