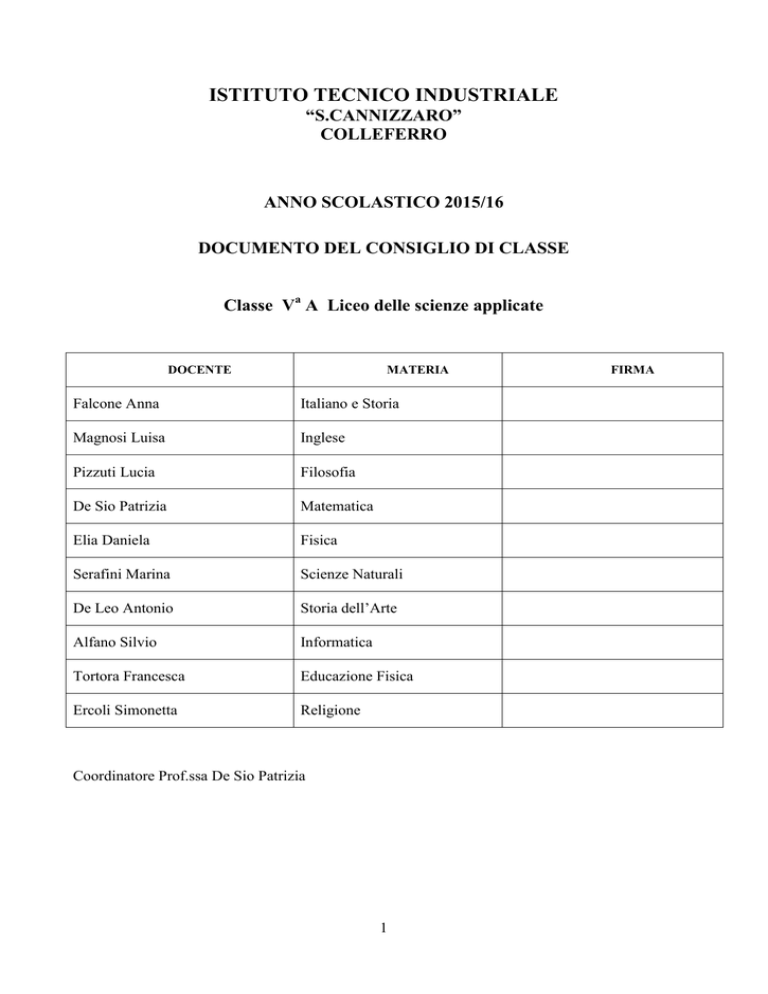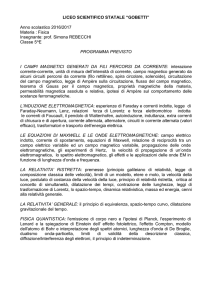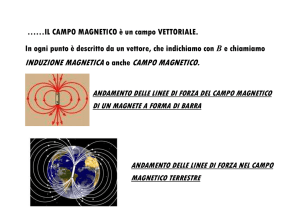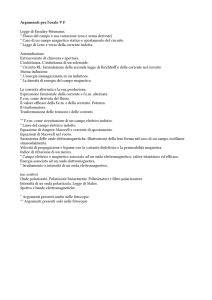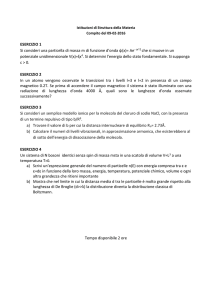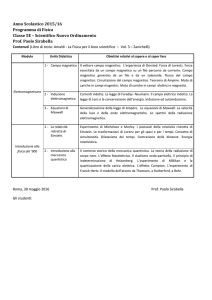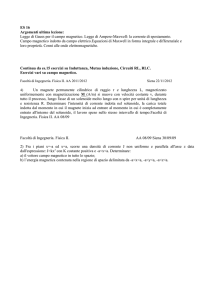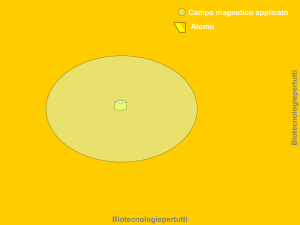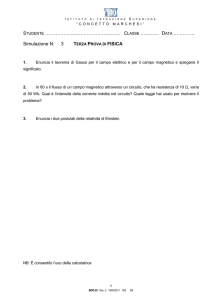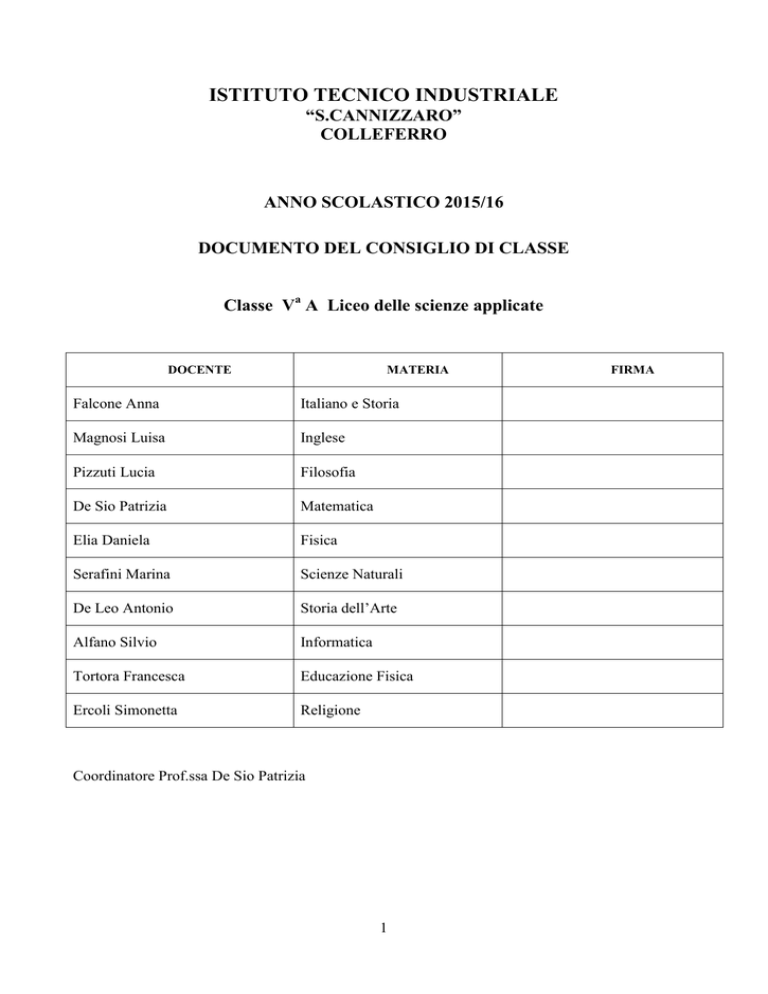
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“S.CANNIZZARO”
COLLEFERRO
ANNO SCOLASTICO 2015/16
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe Va A Liceo delle scienze applicate
DOCENTE
MATERIA
Falcone Anna
Italiano e Storia
Magnosi Luisa
Inglese
Pizzuti Lucia
Filosofia
De Sio Patrizia
Matematica
Elia Daniela
Fisica
Serafini Marina
Scienze Naturali
De Leo Antonio
Storia dell’Arte
Alfano Silvio
Informatica
Tortora Francesca
Educazione Fisica
Ercoli Simonetta
Religione
Coordinatore Prof.ssa De Sio Patrizia
1
FIRMA
PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 20 elementi tutti provenienti dallo stesso percorso ad eccezione di
un’alunna arrivata lo scorso anno da un altro istituto e dal fisiologico passaggio, alla fine del
biennio, di alcuni ragazzi verso altre specializzazioni.
Non è mai stata una classe particolarmente unita e compatta, anche se, proprio nella fase finale
dell’anno in corso i rapporti sono andati migliorando; al contrario hanno instaurato, in generale, con
tutti i docenti buone relazioni soprattutto sul piano umano dimostrandosi sempre pronti ad esporre
problematiche sia di carattere personale che, più in generale, riguardanti l’interazione con il mondo
degli adulti e con la società.
Hanno rivelato sensibilità verso alcune problematiche generazionali in particolare e, più in generale,
verso quelle di carattere sociale, partecipando attivamente a dibattiti scaturiti dall’attualizzazione di
fenomeni e processi storico-culturali e tecnico-scientifici.
Hanno seguito costruttivamente iniziative extrascolastiche traendo da tali esperienze motivi e spunti
di arricchimento per la loro formazione umana e culturale, a volte, criticamente, soprattutto alcuni,
hanno saputo estrapolare dalle varie attività punti di forza della loro personalità per una crescita più
consapevole e fruttuosa.
Si può dunque asserire che, nel corso del triennio, gli alunni hanno avuto un deciso cambiamento ed
una crescita positiva rispetto ai primi due anni. L’interesse e la partecipazione sono andate
aumentando, l’interazione con gli insegnanti è stata spesso frutto di un dialogo costruttivo che ha
offerto spunti per approfondimenti e collegamenti interdisciplinari. In questo clima anche gli
elementi più deboli ne hanno tratto vantaggio, partecipando comunque al dialogo educativo, anche
se poi l’impegno personale non è stato adeguato e costante in tutte le fasi dell’anno scolastico.
La classe si presenta, nel complesso, piuttosto eterogenea per capacità e livelli di partenza, ma è
formata, in generale, da alunni con discrete attitudini , buona volontà di apprendimento, dedizione
allo studio, corretto atteggiamento nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica.
Globalmente solo pochi elementi hanno stentato a raggiungere gli obiettivi minimi di
apprendimento.
La situazione complessiva, in merito ai risultati ottenuti, può essere così sintetizzata.
Un ristretto numero di alunni ha mantenuto incertezze e possiede conoscenze frammentarie, anche
se per lo più vicine alla sufficienza e comunque commisurate alle loro capacità.
La maggior parte riesce ad utilizzare le conoscenze acquisite e a rielaborare in modo autonomo con
risultati più che adeguati alle potenzialità ed alle inclinazioni.
Alcuni alunni, infine, riescono ad analizzare e correlare tra loro i contenuti delle varie discipline
rielaborandoli ed approfondendoli autonomamente, in modo decisamente positivo; in particolare tra
questi ultimi emergono alcuni elementi che, per il loro impegno sempre serio e motivato, hanno
avuto, fin dall’inizio, risultati costantemente di ottimo livello, soprattutto nelle discipline a loro più
congeniali.
La classe è stata seguita da un gruppo di docenti abbastanza stabile ad eccezione delle discipline di
Inglese e di Informatica che hanno avuto dei cambiamenti nel corso del quinquennio.
2
PROFILO DI INDIRIZZO
Il consiglio di classe, sulla base delle indicazioni contenute nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa, opzione scienze applicate, ha elaborato il seguente profilo di indirizzo con gli
obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità.
Conoscenze:
conosce i nuclei fondamentali delle discipline dell’indirizzo con particolare attenzione al
ruolo fondamentale delle discipline scientifiche e all’integrazione tra scienza e tecnologia
Competenze:
sa utilizzare sistemi e modelli logico-matematici
sa approfondire concetti, prìncipi e teorie scientifiche, processi tecnologici
sa utilizzare le tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche
sa utilizzare il materiale didattico nella realizzazione di un progetto
sa produrre in modo chiaro e corretto un testo
sa leggere interpretare testi letterari, scientifici e di altra natura
sa argomentare oralmente in modo corretto autonomo e fondato
sa utilizzare nello studio gli apporti della lingua straniera
sa analizzare in modo critico il reale ed interagire consapevolmente con esso
Capacità:
possiede capacità linguistiche ed espressive
possiede capacità logico-interpretative
possiede capacità di apprendimento e rielaborazione
possiede senso critico e flessibilità intellettuale
sa lavorare in gruppo
sa utilizzare collegare conoscenze di discipline diverse
sa organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità in modo autonomo anche
utilizzando gli strumenti informatici
sa comunicare efficacemente utilizzando in modo appropriato la lingua straniera
sa orientarsi dinanzi a nuove problematiche
3
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Nella riunione di inizio d’anno il consiglio di classe ha fissato le metodologie, gli strumenti per la
verifica, i criteri per la valutazione comune e i seguenti obiettivi formativi trasversali comuni a tutte
le discipline:
Area formativa:
per quanto riguarda la socializzazione si ritiene opportuno potenziare negli allievi la disponibilità ad
instaurare con tutti buoni rapporti, ad essere pazienti nell’ascoltare le esigenze degli altri e
soprattutto dei pari, a rispettare i tempi, gli spazi e i diritti di tutti durante il lavoro, il dibattito e le
verifiche in classe. Per quanto riguarda la responsabilizzazione, si reputa necessario sollecitare gli
alunni a consolidare la consapevolezza dei propri doveri, a spronarli verso un’autonomia sempre più
solida nell’esecuzione del lavoro individuale e nel rispetto delle scadenze, nonché delle regole della
convivenza scolastica e del comportamento in generale; si ravvisa inoltre indispensabile potenziare
la capacità nel riconoscere e valorizzare le proprie attitudini.
Area cognitiva:
potenziare la capacità di esposizione chiara e corretta del pensiero con particolare riguardo
all’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline;
potenziare l’acquisizione di un metodo di studio fondato sulla sistematicità e
sull’organizzazione razionale ed organica delle informazioni;
acquisire la consapevolezza che il sapere si basa su una continua revisione delle conoscenze;
potenziare l’acquisizione di autonomia nell’uso dei libri di testo e nella conduzione di
ricerche per approfondimenti;
potenziare lo sviluppo delle capacità logico interpretative;
accrescere la capacità di individuare collegamenti fra discipline diverse;
guidarli alla contestualizzazione dei saperi e dei testi;
far acquisire la capacità di relazionare con efficacia sulle conoscenze acquisite;
sviluppare il senso critico
Attraverso l’analisi dei risultati dell’anno scorso e le conversazione tra gli insegnanti è stata
compiuta la valutazione delle competenze di ingresso. Sulla base di tale valutazione e tenendo in
considerazione le indicazioni del consiglio di classe, ciascun docente ha elaborato il proprio piano
di lavoro, seguendo l’organizzazione modulare.
In tutte le discipline si sono svolte in orario curriculare attività di recupero e di potenziamento.
4
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Per favorire e potenziare l’apprendimento dei ragazzi sono stati utilizzati i seguenti metodi:
lezioni frontali
uso dei mezzi multimediali
discussioni in classe
sviluppo di un modulo all’interno della disciplina Informatica secondo la metodologia CLIL
attività di recupero in itinere in classe e/o secondo la modalità dello sportello pomeridiano
attività di integrazione e potenziamento
Alle attività curriculari si sono affiancate:
Attività di orientamento agli studi (organizzate dalla scuola)
INFS di Frascati per la Fisica moderna
Attività culturali
Proiezione di un film per tutta la scuola;
International Club;
Partecipazione al gruppo teatrale della scuola;
Progetto “Cinema e storia;
Partecipazione alle olimpiadi
della matematica, delle scienze naturali (biologia), della
fisica;
Conferenza sull’attività di spionaggio durante la prima guerra mondiale;
Incontro con Medici senza Frontiere.
In occasione della Settimana di diffusione della Cultura Scientifica e Tecnologica gli alunni
hanno partecipato alle seguenti conferenze:
Avio e l’Italia nello spazio
Centenario Relatività generale di Albert Einstein
Dal bosone di Higgs alla terapia dei tumori con l’adroterapia
Alcune di queste attività sono state svolte da tutta la classe, altre solo da alcuni alunni secondo
l’interesse o il merito.
5
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione di ciascun alunno gli insegnanti hanno concordato di tener conto:
della media dei voti riportati in ogni singola materia
dell’impegno e dell’interesse dimostrati nelle varie attività
della frequenza scolastica
del credito formativo
Su tale valutazione verrà elaborato il credito scolastico
Ciascun docente, nell’attribuire il proprio voto, giudica:
il livello di conoscenza dei contenuti del programma
le capacità logiche ed espressive
la capacità di rielaborazione autonoma
il raggiungimento degli obiettivi comuni programmati
In ogni prova di verifica si tenuto conto della seguente tabella:
TABELLA DEI LIVELLI DI PROFITTO
Descrizione
Obiettivi completamente raggiunti con
arricchimenti personali
Obiettivi completamente raggiunti
Obiettivi raggiunti con alcune incertezze
Obiettivi parzialmente raggiunti
Obiettivi in buona parte non raggiunti, le lacune
evidenziate però non sempre sono di gravità tale
da togliere all’alunno la possibilità di affrontare il
prosieguo dello studio
Gravi lacune in tutti gli obiettivi
Nessun obiettivo raggiunto
6
Voto
9-10
Giudizio
Ottimo
8
7
5-6
4-5
Buono
Apprezzabile
Accettabile
Insicuro
3-4
1-2
Inadeguato
Negativo
Ogni prova di verifica, finalizzata a misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi specifici di
ogni disciplina, è stata valutata seguendo la griglia di seguito riportata:
Acquisizione delle
conoscenze
Applicazione
conoscenze
Realizzazione
attività di
laboratorio
Comprensione,
analisi,
rielaborazione
Rifiuto verifica
(ingiustificato)
Livello pressoché
nullo
2
Non verificabili
2
Non verificabili
2
3
3
Non si orienta
anche se guidato
3
Conoscenze molto
sommarie,
frammentarie e
limitate
4
Non riesce ad
applicare le
scarse
conoscenze
Non riesce a
risolvere
completamente i
problemi
4
Difficoltà d’analisi
e nella soluzione di
problemi già trattati
Conoscenze
superficiali, errori
nell’uso della
terminologia
5
5
Conoscenze di base
adeguate ma non
approfondite
6
Fragile nell’analisi
5
e nella
rielaborazione se
non
opportunamente
guidato
Studio mnemonico, 6
imprecisione
nell’analisi e
insicurezza
nell’elaborazione
Conoscenze
adeguate, chiare e
complete
7
Qualche
difficoltà nella
gestione delle
tecniche di
soluzione dei
problemi
Qualche
imprecisione
nell’uso delle
tecniche di
soluzione che
gestisce in modo
adeguato anche
se meccanico
Applica e risolve
problemi con
consapevolezza
Conoscenze
complete e ben
approfondite
8
Applica e risolve
problemi
complessi con
consapevolezza
8
Applica
autonomamente
le sue
conoscenze
approfondendo,
ricercando e
trovando nuove
soluzioni
9 Comprende,
10 analizza e rielabora
anche situazioni
complesse o nuove
in modo personale,
originale e
consapevole;
stabilisce
autonomamente
relazioni tra gli
elementi
Conoscenze
9
complete, ben
10
approfondite,
arricchite da
autonome ricerche e
da contributi
personali
6
7
Si orienta in modo
autonomo nelle
situazioni ma
effettua analisi
superficiali
E’ autonomo
nell’effettuare
analisi complete ed
opportune sintesi
7
4
7
8
9/10
Abilità
espressive,
linguistiche
tecniche di
comunicazione
(documentazione)
Non verificabili
2
voto
Commette errori 3
espressivi che
compromettono
la comunicazione
Si esprime in
4
modo non
corretto e utilizza
termini non
adeguati
Insicuro ed
5
impreciso
nell’espressione,
nell’uso del
lessico specifico
3
Non commette
6
gravi e sostanziali
errori nella
comunicazione,
ma si esprime in
modo meccanico
e non autonomo
6
Comunicazione
corretta;
esposizione
chiara e forma
scorrevole
Espone con
proprietà di
linguaggio,
precisa
terminologia;
svolge con
chiarezza,
coerenza e
coesione vari tipi
di testi
Gestisce con
estrema
chiarezza,
completa
autonomia ed
originalità lo
strumento
linguistico;
notevole
ricchezza e
padronanza
lessicale.
7
7
8
8
2
4
5
9/10 9/10
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione, ovviamente, è stata sia di tipo formativo, effettuata durante lo svolgimento delle
unità didattiche (che non prevede cioè l’assegnazione di un voto, ma offre elementi di giudizio e di
auto valutazione per il docente e per lo studente), sia di tipo sommativo, alla fine di ogni unità
didattica e modulo (mirata in altre parole ad accertare e a misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi cognitivi prefissati)
Strumenti per la valutazione formativa sono stati:
colloqui
conversazioni e discussioni in classe
controllo dei lavori svolti autonomamente a casa o in classe nelle attività di gruppo
prove strutturate
La valutazione sommativa si è fondata su:
interrogazioni
prove scritte (anche svolte a casa)
relazioni orali e/o scritte
questionari (a risposta aperta)
brevi trattazioni
saggi brevi o articoli di giornali
analisi del testo letterario
La verifica degli obiettivi non cognitivi, non potendo essere oggetto di prove, è stata effettuata
attraverso l’osservazione dei comportamenti degli alunni durante il lavoro individuale, di gruppo, o
con l’intera classe e attraverso il controllo del lavoro svolto a casa in relazione a regolarità e
metodo.
Oltre alle prove scritte che ciascun docente ha fatto nella propria disciplina, sono state programmate
una simulazione della prova d’esame di Italiano, la simulazione nazionale della prova di
Matematica, due simulazioni della terza prova d’esame scegliendo la tipologia “B” ( dodici quesiti a
risposta singola) che ha coinvolto le seguenti materie di studio dell’ultimo anno di corso:
Informatica, Inglese, Scienze e Fisica. I testi delle prove sono in allegato.
Dalle valutazioni dei risultati ottenuti il CdC ritiene la tipologia “B” più congeniale alle
caratteristiche della classe, con durata della prova di almeno due ore.
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
DATA
02 Marzo 2016
PROVA
DISCIPLINE
DURATA
Terza prova
Scienze Naturali, Inglese, Fisica, Informatica
120 minuti
05 Maggio 2016 Terza prova
Scienze Naturali, Inglese, Fisica, Informatica
120 minuti
16 Maggio 2016 Prima prova
Italiano
6 ore
29 Aprile2016
Matematica
6 ore
Seconda prova
Qui di seguito vengono riportate le griglie di valutazione usate per le diverse prove.
8
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ITALIANO
TIPOLOGIA A
Comprensione
del testo
letterario
Corretta e
approfondita
Nel complesso
corretta, non
sempre
approfondita
Superficiale
Limitata
Conoscenze
specifiche
Organicità di
svolgimento
4 Corrette
approfondite
complete
e 4 Strutturazione
efficace ed
organica delle
conoscenze
rielaborate in
modo personale
3 Corrette ma non 3 Strutturazione
sempre
coerente ma
approfondite
semplice delle
conoscenze
rielaborate in
modo
meccanico
2 Superficiali
2 Strutturazione
disorganica e
confusa delle
conoscenze
1 Limitate
1
9
Correttezza
formale
3 Sintassi corretta
ed efficace,
lessico
appropriato e
vario
4
2 Sintassi corretta 3
ma
semplice
lessico generico
1 Periodare con
2
improprietà
formali e/o
lessicali e/o con
errori di
ortografia
Periodare con 1
gravi e diffuse
improprietà
formali e con
errori
d'ortografia
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ITALIANO
TIPOLOGIA B
Pertinenza
rispetto alla
tipologia e
comprensione
dei documenti
Comprensione
corretta e
approfondita;
elaborato
pertinente alla
tipologia
Conoscenze
concetti
e
Capacità
di
Correttezza
rielaborazione,
formale
senso critico,
organicità di
svolgimento
Struttura del
4 Conoscenze
3
4 Sintassi corretta 4
corrette,
discorso
ed efficace,
approfondite e
efficace ed
lessico
complete;
organica;
appropriato e
osservazioni
individuazione
vario
personali
di un punto di
vista personale
e critico
3 Conoscenze
2,5 Struttura del
3 Sintassi
3
corrette ma non
discorso
corretta,
sempre
organica,
ma
semplice,
approfondite;
rielaborazione
lessico generico
osservazioni
personale e
motivate
spunti
argomentativi
Comprensione
nel complesso
corretta, ma
non sempre
approfondita;
elaborato
globalmente
pertinente
Comprensione
2 Conoscenze
1,5 Strutturazione
2 Periodare con
2
superficiale o
superficiali;
coerente, ma
improprietà
limitata a ad un
osservazioni
semplice delle
formali e/o
numero molto
non
sempre
conoscenze,
lessicali e/o con
esiguo di
esatte
rielaborate in
errori di
documenti;
modo
ortografia
elaborato
meccanico
parzialmente
pertinente
Non sono presi 1 Conoscenze e 1
Strutturazione
1 Periodare con 1
in
esame
i
osservazioni
disorganica
e
gravi e diffuse
documenti o la
limitate
confusa
delle
improprietà
comprensione è
conoscenze
formali e con
errata
errori
d'ortografia
10
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI DI ITALIANO
TIPOLOGIA C e D
Aderenza alla
traccia
proposta e
completezza di
svolgimento
Svolgimento
pertinente e
completo
Svolgimento
pertinente che
non
approfondisce,
però, tutti gli
aspetti della
traccia
Svolgimento
solo
parzialmente
pertinente o
limitato a una
parte della
traccia
Svolgimento
poco pertinente
Conoscenze
concetti
4
3
2
1
e
Organicità di
svolgimento,
capacità
di
rielaborazione,
senso critico
Corrette
e 3
Struttura del
approfondite
discorso
complete
efficace ed
organica;
individuazione
di un punto di
vista personale
e critico
Corrette ma non 2,5 Struttura del
sempre
discorso
approfondite
organica,
rielaborazione
personale e
spunti
argomentativi
Superficiali
1,5 Strutturazione
coerente, ma
semplice delle
conoscenze,
rielaborate in
modo
meccanico
Limitate
Strutturazione
1
disorganica
e
confusa
delle
conoscenze
11
Correttezza
formale
4 Sintassi corretta 4
ed efficace,
lessico
appropriato e
vario
3 Sintassi corretta 3
ma
semplice
lessico generico
2 Periodare con
2
improprietà
formali e/o
lessicali e/o con
errori di
ortografia
1 Periodare con 1
gravi e diffuse
improprietà
formali e con
errori
d'ortografia
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
Sezione A: Valutazione PROBLEMA
INDICATORI
LIVELLO
L1
(0-4)
Comprendere
Analizzare la situazione
problematica, identificare i dati ed
interpretarli.
L2
(5-9)
L3
(10-15)
L4
(16-18)
Individuare
L1
(0-4)
Mettere in campo strategie risolutive
e individuare la strategia più adatta. L2
(5-10)
L3
(11-16)
L4
(17-21)
L1
(0-4)
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica
in maniera coerente, completa e
corretta, applicando le regole ed
eseguendo i calcoli necessari.
L2
(5-10)
L3
(11-16)
L4
(17-21)
Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della
strategia applicata, i passaggi
fondamentali del processo esecutivo e
la coerenza dei risultati.
L1
(0-3)
L2
(4-7)
L3
(8-11)
L4
(12-15)
DESCRITTORI
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale,
non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali,
o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i
codici matematici grafico-simbolici.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali,
o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche
errore
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza
parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi
inesattezze e/o errori.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le
relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici
grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie
alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua
gli strumenti formali opportuni.
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo
poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili.
Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua
con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più
adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le
possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua
gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo
migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le
procedure ottimali anche non standard.
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o
errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in
modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non
è coerente con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata.
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione
ottenuta è coerente solo in parte con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche
imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi
sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei
calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con
l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo
in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o
teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti
di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è
ragionevole e coerente con il problema.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura
risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non
appropriato o molto impreciso.
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la
fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate
(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con
qualche incertezza.
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed
esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra
un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.
12
Evidenze Punti
Sezione B: QUESITI
Quesiti
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)
CRITERI
Q1
COMPRENSIONE e CONOSCENZA
Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.
Q2 Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
P.T.
Q9 Q10
(0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-5) (0-4) (0-3) (0-3) (0-5) (0-4)
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE
Abilità di analisi.
Uso di linguaggio appropriato.
Scelta di strategie risolutive adeguate.
(0-4) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-5)
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-4)
CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO
Correttezza nei calcoli.
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure
anche grafiche.
ARGOMENTAZIONE
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(0-3) (0-3) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2) (0-4) (0-2) (0-2) (0-2)
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Punteggio totale quesiti
Calcolo del punteggio Totale
PUNTEGGIO SEZIONE A
(PROBLEMA)
PUNTEGGIO SEZIONE B
(QUESITI)
PUNTEGGIO TOTALE
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi
Punti
Voto
0-4
1
5-10 11-18
2
3
19-26 27-34
4
5
35-43
44-53
54-63
64-74
75-85
86-97
6
7
8
9
10
11
Voto assegnato ____ /15
13
98-109 110-123 124-137 138-150
12
13
14
15
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA
Conoscenze specifiche
(1 - 5)
Capacità di sintesi e
analisi (1-5)
Correttezza formale
(1-5)
Complete approfondite 5 Processi di sintesi ed
e pertinenti
analisi corretti ed
efficaci
5 Esposizione efficace
Lessico specifico
5
Soddisfacenti e
pertinenti
4 Processi di sintesi
corretti non sempre
approfondita l’analisi
4 Esposizione corretta
Lessico generico
4
Superficiali
3 Processi di analisi e
sintesi superficiali
Scarse e/o errate o non
pertinenti
3 Esposizione con
3
qualche improprietà
formale e/o lessicale
2- Processi di analisi e
2- Esposizione non sempre 21 sintesi approssimativi e 1 chiara con gravi
1
a volte errati o del tutto
improprietà formali
errati
1°QUESITO 2° QUESITO 3° QUESITO VOTO SINGOLA MATERIA
MATERIA
INFORMATICA
INGLESE
SCIENZE
FISICA
………./15
............./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
………./15
VOTO FINALE PROVA
………./15
………./15
………………/15
(il voto finale scaturisce dalla media aritmetica dei voti delle singole discipline con arrotondamento
in presenza di decimali)
14
RELAZIONE DI ITALIANO E STORIA
Insegnante Falcone Anna
Venti sono gli alunni che compongono il gruppo classe, provengono tutti dallo stesso percorso ad
eccezione di un’alunna che si è inserita in questo contesto nel precedente anno scolastico. Ho avuto
la possibilità di seguirli tutti fin dall’inizio del loro cammino nel corso del liceo delle scienze
applicate e,come per ogni scolaresca, anche per questa il percorso evolutivo è stato caratterizzato da
due fasi didattico - formative fondamentali: una relativa al biennio in cui è stata avviata
l’impostazione di quelle strutture fondamentali per l’acquisizione di un metodo di studio efficace e
personale; l’altra, del triennio, durante il quale, accanto al consolidamento delle competenze
preesistenti si è proceduto al potenziamento delle conoscenze di base ed all’approfondimento delle
tematiche disciplinari.
Ovviamente ognuno di loro ha seguito uno sviluppo relativo alla propria individualità e non per tutti
il cammino è stato lineare; anche questi ragazzi hanno vissuto le problematicità dell’adolescenza
attraversando quei particolari momenti d’instabilità emotiva che, a volte, hanno determinato
situazioni conflittuali e difficili; infatti non sempre sono stati compatti e solidali ma, grazie ad un
lavoro capillare e costante ed ai sani valori di cui gli allievi sono stati alimentati sia dalle famiglie
che dai docenti,si è riusciti a smussare delle spigolosità nei loro rapporti interpersonali per cui
,soprattutto nell’ultima fase di quest’anno, si sono maggiormente amalgamati e hanno affrontato
con serenità il cammino verso gi esami di stato. Dal punto di vista disciplinare il comportamento è
stato abbastanza corretto. Gli anni trascorsi insieme hanno consentito di realizzare un buon rapporto
basato sulla stima e rispetto reciproci. Con autorevolezza ma con comprensione sono stati
incoraggiati a tirar fuori.le loro qualità, a volte nascoste che li hanno spinti a seguire
costruttivamente iniziative extrascolastiche di vario genere traendo da tali esperienze motivi e
spunti di arricchimento per la loro formazione umana e culturale Anche per quanto concerne
l’aspetto didattico il cammino non è stato omogeneo così come il progresso nel profitto. Un gruppo
di allievi è in possesso di strumenti linguistici adeguati , di capacità organizzativa autonoma e
critica dei contenuti, hanno lavorato con serietà ed impegno, sono stati sempre attenti, rispettosi
delle consegne e puntuali nelle verifiche ottenendo risultati, per alcuni anche ottimi, per gli altri
buoni, nelle due discipline. Un altro gruppo ha acquisito una preparazione adeguata che permette di
muoversi con una discreta sicurezza nella disamina di fatti storici e letterari. Infine, un numero più
esiguo, meno costante, più indolente, poco partecipe, rivela una preparazione con conoscenze
modeste ed una capacità rielaborativa appena accettabile.
Lo svolgimento del programma ,nonostante abbia subito dei rallentamenti anche per le diverse
attività scolastiche che, pur se programmate, per motivi organizzativi non sono state più realizzate
con le modalità ed il rispetto dei tempi previsti, è stato comunque portato a termine. Le lezioni
frontali sono state affiancate dall’analisi di eventi di attualità che hanno permesso di affrontare
problematiche sulle quali gli studenti sono stati invitati a esprimere opinioni e giudizi; dibattiti e
discussioni su argomenti inerenti anche il loro vissuto quotidiano hanno arricchito l’attività
didattico – formativa così come alcune iniziative culturali a cui gli studenti hanno partecipato..
Rispetto alle verifiche scritte di italiano gli allievi si sono esercitati nelle diverse tipologie del
compito d’esame del quinto anno.
15
PROGRAMMA DI ITALIANO
Insegnante Falcone Anna
Il Romanticismo: caratteri generali del movimento in Europa
Il Romanticismo italiano. La polemica classico-romantica e la nuova cultura
A.W. Schlegel “Spirito classico e spirito romantico”
Madame de Stael: “Per una buona letteratura”
G. Berchet “Il nuovo pubblico”
P. Giordani : ”Ci vuole novità? Risposta a Madame de Stael”
Il dialetto e la poesia: G.G. Belli
G.G. Belli: “Cosa fa er papa”
“Er giorno der giudizio”
“La mammana in faccenne”
Giacomo Leopardi: un precursore solitario; le opere precedenti alla crisi del 1819;
lo Zibaldone opere in prosa degli anni venti; I grandi temi della
poetica leopardiana i Canti;
le Operette morali; disinganno, satira e politica degli ultimi anni.
Zibaldone: “Immaginazione degli antichi e sentimento dei
moderni”
“Immaginazione, poesia, rimembranza”
“La teoria del piacere”
“Tutto è male”
Canti : “Ultimo canto di Saffo”
“Il passero solitario”
“L’infinito”
“La sera del di’ di festa”
“Alla luna”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
“Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia”
“ La ginestra o il fiore del deserto” (vv 1/201)
Operette morali : “Dialogo della moda e della morte”
“Dialogo della natura e di un Islandese”
“Dialogo di un venditore di almanacchi”
Alessandro Manzoni : un intellettuale critico e partecipe, gli scritti giovanili; dagli
Inni sacri alla lirica civile, la riflessione sul teatro e sulle
tragedie. I Promessi sposi
Lettera a C. Fauriel “Lingua parlata e lingua letteraria”
Inni sacri : “La Pentecoste”
Odi : “Il cinque maggio”
Tragedie: “Adelchi”(atto III, scena 9, coro)
“Adelchi”(atto IV, scena 1, coro)
“ Lettre à M. Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans
16
la tragédie”
“Le funzioni del coro”(Prefazione al Conte di Carmagnola)
“Romanzo storico e romanzesco” (Lettera a C.Fauriel del 29
maggio 1822)
I promessi sposi : “L’incipit del romanzo”
“Una digressione: le gride (cap.1)
“La monaca di Monza” (cap. 10)
“Le imprese di un temibile tiranno” (cap
19)
“La fuga di Renzo” (cap. 17)
“Il sugo di tutta la storia” (cap. 38)
Dall’unità d’Italia alla Prima guerra mondiale: la storia, la cultura, lo spazio e il tempo della
letteratura
La Scapigliatura :una rivolta non solo letteraria
Il Naturalismo francese:caratteri generali
Edmond e Jules de Goncourt: “L’analisi clinica dell’amore”( Germinie Lacerteux,
prefazione)
Emile Zola. “Letteratura e scienza”(Le roman expérimental,III)
Emile Zola: “Il declino di Gervaise” (L’Assommoir cap III)
Il Naturalismo in Italia: Verismo e dintorni
Giovanni Verga: dalla Sicilia e ritorno; l’inizio della stagione verista; I Malavoglia; Le Novelle
rusticane,Mastro don Gesualdo, l’interruzione dei Vinti,un silenzio
emblematico.
“Fantasticheria”(Vita dei campi,I)
“Rosso Malpelo” (Vita dei campi III)
“Un documento umano”(Vita dei campi, Prefazione all’ Amante di Gramigna”)
“La vaga bramosia dell’ignoto” (I Malavoglia”)
“La casa del nespolo” (I Malavoglia, cap I)
“N’toni vuole partire” (I Malavoglia, cap II)
“L’ultimo addio di N’toni” (I Malavoglia cap XV
“La roba” (Novelle rusticane)
“La morte di don Gesualdo” (Mastro don Gesualdo, parteIV,cap 5)
17
Charles Baudelaire: la vertigine del moderno.
“Les fleurs du mal “:un’opera spartiacque nella storia della
letteratura.
“Le fleurs du mal: Spleen et Ideal “ “Corrispondenze”
“L’albatro”
“ Spleen “
“Le peintre de la vie moderne”
“Il dandy”
Simbolismo ed Estetismo : un orizzonte europeo; la lirica simbolista; bellezza, arte e vita:
l’Estetismo (caratteri generali)
Giovanni Pascoli: una vita nell’ombra; la poetica; la prima raccolta: Myricae; dai
Poemetti ai Poemi conviviali, altre raccolte poetiche, gli scritti
in prosa.
“Il fanciullino” ( Il fanciullino I-II )
“Lavandare” (Myricae: L’ultima passeggiata )
“Il lampo” (Myricae : Tristezze )
“Il tuono” (Myricae : Tristezze )
“X Agosto ( Myricae : Elegie )
“L’assiuolo ( Myricae : In campagna )
“I due fanciulli “ ( Primi poemetti )
“Nebbia” ( Canti di Castelvecchio )
“La mia sera” ( Canti di Castelvecchio )
“Il gelsomino notturno” ( Canti di Castelvecchio )
Gabriele D’annunzio: il vivere inimitabile; il letterato e il suo tempo; i “versi d’amore
E di gloria” le “prose di romanzi” le” prose di ricerca “gli
scritti giornalistici
“La sera fiesolana” (Alcyone)
“La pioggia nel pineto” ( Alcyone )
“L’attesa di Elena” ( Il piacere , libro I, cap 1 )
“Un esteta di fine secolo” ( il piacere, libro I, cap 2 )
“Il manifesto aristocratico di Claudio Cantelmo” ( Le vergini
delle rocce,libro I)
“Lo scempio edilizio dei nuovi ricchi” ( Le vergini delle rocce
libro I)
“Cecità e rumore” (Notturno)
“Morte della letteratura? Morte del libro!” (Intervista di Ugo
Ojetti)
I movimenti d’avanguardia e l’attività letteraria in Europa e in Italia : caratteri generali
Il Futurismo e il ruolo culturale delle riviste fiorentine
F. T. Marinetti: ”Manifesto del Futurismo”
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”
18
Il rinnovamento del romanzo
Luigi Pirandello: il figlio del Caos; L’umorismo; i romanzi “siciliani”; i grandi
romanzi umoristici, le novelle, il teatro.
“Il flusso continuo della vita” (L’umorismo,parte II,cap5 )
“Il nome” (Il fu Mattia Pascal, cap. 1- 2
“Un impossibile ritorno” (Il fu Mattia Pascal, cap 18 )
“Rientrando in città” ( Uno, nessuno e centomila, libro II,cap.11 )
“Non conclude” ( Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. 4 )
“Il treno ha fischiato” ( Novelle per un anno )
Italo Svevo: Trieste, città di frontiera; primo ritratto di un irrisoluto: Una vita.
Senilità ovvero l’incapacità di vivere ; fra inettitudine e ironia:
La coscienza di Zeno..
“La lettera di Annetta” ( Una vita, cap.15 )
“L’incontro con Angiolina” ( Senilità, cap. 1 )
“L’ultimo appuntamento” ( Senilità, cap. 12 )
“La morte del padre” (La coscienza di Zeno, cap.4 )
“Ritratto di Augusta” ( La coscienza di Zeno, cap. 6 )
“Psico-analisi” ( La coscienza di Zeno, cap. 8 )
Programma da svolgere dopo il 15 maggio
La poesia fra tradizione ed innovazione; l’Ermetismo
Giuseppe Ungaretti :sulla scena europea; una storia poetica; la poesia e la memoria;
forme e immagini; un poeta moderno.
“Eterno” ( L’allegria: Ultime )
“In memoria” ( L’allegria: Il porto sepolto )
“Veglia” ( L’allegria: Il porto sepolto )
“Fratelli” ( L’allegria: Il porto sepolto )
“Sono una creatura” ( L’allegria: Il porto sepolto )
“I fiumi” ( L’allegria: Il porto sepolto )
“Soldati” ( L’allegria: Girovago )
“L’isola” ( Sentimento del tempo. La fine di Crono )
“ Non gridate più” ( Il dolore: I ricordi )
Eugenio Montale: la ricezione di un “classico”; “Vissi al cinque per cento“; la
formazione di un “dilettante di gran classe” Un paesaggio
Ligure: Ossi di seppia; il privato e la storia: Le Occasioni
L’orrore della guerra: la bufera e altro, tra ironia e autobiografia.
Satura
“I limoni” ( Ossi di seppia: Movimenti )
“Non chiederci la parola…” ( Ossi di seppia )
“Meriggiare pallido e assorto” ( Ossi di seppia )
“ Spesso il male di vivere ho incontrato” ( Ossi di seppia )
“ Non recidere forbice quel volto” ( Le Occasioni: Mottetti )
“La casa dei doganieri” ( Le Occasioni: IV )
Salvatore Quasimodo: la poetica della parola
19
Dolore di cose che ignoro” (Erato ed Apollion )
“Tramontata è la luna” ( Lirici greci )
Caratteri generali del romanzo del secondo Novecento con riferimenti agli autori:
Primo Levi, Italo Calvino
Canti scelti della Divina Commedia “Paradiso” sono stati svolti nel quarto anno
Testo di letteratura utilizzato. E. Raimondi “Leggere come io l’intendo…”
“Edizioni scolastiche Bruno Mondadori”
20
PROGRAMMA DI STORIA
Insegnante Falcone Anna
Dalla Restaurazione ai Risorgimenti
Stati che si consolidano, stati che nascono
L’unificazione dell’Italia
L’età dell’industrializzazione
Tra emancipazioni nazionali e sudditanze coloniali
L’età delle grandi potenze
All’insegna di una politica nazionale di potenza
Il complesso itinerario dell’Italia
Un difficile tornante economico e la corsa alle colonie
Le matrici e i caratteri dell’imperialismo
Nuove culture politiche e progressi scientifici
Dalla “Belle époque” alla Grande guerra
All’alba del secolo tra euforia e inquietudini
Uno scenario mondiale in evoluzione
L’Italia nell’età giolittiana
La Grande guerra
Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie
I fragili equilibri del dopoguerra
La crisi del ‘29 e l’America di Roosevelt
Il regime fascista di Mussolini
Le dittature di Hitler e Stalin
La seconda guerra mondiale
Verso la catastrofe
Un immane conflitto
L’Italia spaccata in due
Programma da svolgere dopo il 15 maggio
Gli anni della guerra fredda
Un mondo diviso in due blocchi
La decolonizzazione: caratteri generali
L’America latina tra autoritarismo e populismo e la rivoluzione cubana
L’America di Kennedy e un’effimera distensione con l’URSS
L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta
Testo utilizzato: V. Castronovo “MilleDuemila” “ La Nuova Italia”
21
RELAZIONE DI INGLESE
Insegnante Magnosi Luisa
La classe V A. LSA risulta composta da 20 studenti, tutti provenienti dallo stesso gruppo classe.
Dal punto di vista disciplinare e comportamentale essa non ha presentato alcun problema e gli
studenti si sono dimostrati molto collaborativi e disponibili al dialogo educativo, nonostante
questo sia stato il primo anno in cui si è lavorato insieme.
Il comportamento di tutti è stato sempre educato e partecipe alle varie iniziative sia prettamente
didattiche che sociali.
Per quanto riguarda le abilità e le capacità individuali, la classe risulta essere alquanto eterogenea.
Diversi studenti sono dotati di certificazioni Cambridge (uno studente livello B1, due studenti
livello B2, due studenti livello C1 ed uno studente livello C2). Questo discreto numero di studenti,
con una ottima preparazione di base ed una buona capacità rielaborativa ha agito da traino positivo
all’interno della classe e pertanto la maggioranza degli studenti si è applicata costantemente
conseguendo risultati discreti o buoni. Soltanto per alcuni si evidenziano carenze pregresse e le
difficoltà maggiori emergono soprattutto nella esposizione orale.
Lo studio della disciplina è stato impostato, sia nei suoi contenuti strutturali che letterari, sul
concetto di lingua come strumento e non come fine dell’apprendimento, per ribadendo comunque
l’importanza della correttezza grammaticale, fonetica ed ortografica, in quanto insieme di regole
di base condivise dalla comunità dei parlanti, indispensabili per comprendere e per farsi
comprendere.
L’uso della lingua viva e parlata è stato inoltre stimolato da un uso abbastanza regolare del
laboratorio linguistico per l’ascolto di brani, visione di films in lingua originale ed anche uso della
rete per effettuare approfondimenti in lingua su argomenti letterari e storico-sociali.
Obiettivi disciplinari
Gli obiettivi specifici sono stati individuati in termine di conoscenze, competenze e capacità, così
come esplicitato nella programmazione annuale e nella riunione per materie.
All’interno della classe tali obiettivi sono stati conseguiti secondo livelli differenti ed il livello
della classe si può definire nel complesso discreto, con delle punte di eccellenza.
Conoscenze
Gli alunni conoscono argomenti riguardanti la storia e la letteratura inglese, nonché le principali
funzioni comunicative e le strutture grammaticali della lingua.
Competenze
Gli alunni sono in grado di:
- Sostenere una conversazione su argomento di carattere storico, sociale e letterario
- Descrivere eventi con una discreta padronanza lessicale e grammaticale
- Comprendere, analizzare e comporre testi di argomento storico letterario
Capacità
- Utilizzare discretamente lo strumento linguistico
- Organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo, operando in alcuni casi anche
gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
22
Metodologia e Mezzi
Per far conseguire gli obiettivi precedentemente esplicitati si è usato il metodo induttivo,
soprattutto nell’analisi dei testi letterari e deduttivo, in cui la lezione frontale ha avuto un
importante ruolo. I mezzi utilizzati sono stati l’uso del laboratorio linguistico, le ricerche su
internet, le fotocopie da altri testi, la visione di films in lingua e la stesura di mappe concettuali nel
tentativo di semplificare gli argomenti per gli alunni meno motivati.
Tempi e modalità delle Verifiche
Sono state effettuate, secondo la scansione temporale del trimestre e del pentamestre stabiliti a
livello d’istituto, 6 verifiche scritte ed un congruo numero di verifiche orali, ritenute necessarie nei
diversi casi specifici.
Si è proceduto all’ analisi ed alla elaborazione di testi scritti (questionari, quesiti a risposta
singola, quesiti a risposta multipla, cloze tests, true and false exercises, summaries…)
La comprensione e produzione orale della lingua sono state verificate tramite domande flash,
interrogazioni tradizionali ed esercizi di comprensione, spesso coadiuvati dall’uso del dizionario
monolingue.
Valutazione
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi effettuati dagli alunni, della
conoscenza dei contenuti e del lessico specifico, dell’interesse, dell’impegno
e della
partecipazione al dialogo educativo nonché della capacità di rielaborazione personale e di quella
di individuare analogie, differenze e collegamenti con altre discipline di indirizzo.
23
PROGRAMMA DI INGLESE
Insegnante Magnosi Luisa
Libri di testo in adozione
Spiazzi – Tavella “Performer” Culture & Literature Vol. 2 e Vol.3 Zanichelli
Specification 7 - An Age of Revolution
The House oh Hanover
The Industrial Revolution
The Agricultural Revolution
William Blake: Life and poetry
London
The Chimney Sweeper (from Songs of Innocence and Songs Experiences)
Specification 8 – The Romantic Spirit
The Romantic Age: Historical and Literary Background
Reading of part of the Preface of The Lyrical Ballads (fotocopia)
William Wordsworth: Life and poetry
Daffodils
My hearth leaps up
Samuel Taylor Coleridge: Life and poetry
The Rime of the Ancient Mariner
The Killing of the Albatross
John Keats: Life and poetry
La Belle Dame Sans Merci (fotocopia)
Bright Star
Visione del film “Bright Star”
Percy Bysshe Shelley: Life and Poetry
Ode to the West Wind
Jane Austen and the theme of love
Pride and Prejudice (trama, personaggi e temi).
Darcy proposes to Elizabeth
Visione del film “Pride and Prejudice”
Emily Bronte: life and literary production
Wuthering Heights (trama, personaggi e temi)
Specification 10 – Coming of Age
The Victorian Age: Home and foreign policy
Life in Victorian Towns
The Victorian Compromise
The Victorian Novel
Charles Dickens: Life and Literary Production
Oliver Twist (trama, personaggi e temi)
Oliver wants more
Visione del film “Oliver Twist”
Hard Times (trama, personaggi e temi)
Coketown
The Definition of a Horse
24
Specification 11 – A Two Faced Reality
New Aeshetic Theories
Aestheticism
Dandysm
Oscar Wilde: Life and Literary production
The Picture of Dorian Gray (trama, personaggi e temi)
I would give my soul
Visione del film “Dorian Gray”
Specification 13 – The Drums of War
The Edwardian Age
The Suffragette Movement
World War 1
Specification 14 – the Great Watershed
Sigmund Freud and the psyche
The Modernist Spirit
The Modern Novel
James Joyce: Life and Literary production
Dubliners (trama, personaggi e temi)
Ulysses (trama, personaggi e temi)
Specification 16 – A New World Order
The dystopian Novel
George Orwell: life and Literary Production
Animal Farm (trama, personaggi e temi)
1984 (trama, personaggi e temi)
Gli studenti hanno inoltre effettuato, a loro scelta, la lettura di una delle seguenti opere:
O. Wilde “the Picture of Dorian Gray”
J. Joyce “Dubliners”
G.Orwell “Animal Farm”
G. Orwell “1984”
25
RELAZIONE DI FILOSOFIA
Insegnante Pizzuti Lucia
La classe V A ha mantenuto nel corso dell’anno rapporti positivi sia all’interno
del proprio gruppo che verso l’insegnante ed ha manifestato un interesse
propositivo verso la materia. Qualche ragazzo si e’ distinto per l’ organicità di
metodo di studio e per l’ elaborazione critica personale , fungendo da traino
per gli altri compagni . La maggioranza della classe ha acquisito un livello
più che buono di conoscenza degli autori e di capacità di discussione razionale
relativa a problematiche filosofiche. Un piccolo gruppo ha raggiunto risultati
soddisfacenti, migliorando nel corso dell’anno soprattutto la capacità espositiva.
26
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Insegnante Pizzuti Lucia
Gli sviluppi del Kantismo
Dal criticismo all’idealismo
Dall’Io finito di Kant all’idealismo di Fichte
G.W.F. Hegel
I caratteri del romanticismo
I capisaldi del sistema
L’identità tra razionale e reale
La filosofia come giustificazione razionale della realtà
La dialettica
La fenomenologia dello Spirito
Coscienza, autocoscienza, ragione lo spirito,la religione e il sapere assoluto
L’enciclopedia delle scienze filosofiche
Feuerbach e K. Marx
Dalla critica della religione alla critica della società
Destra e sinistra hegeliana
Feuerbach e il socialismo utopistico
Marx: la critica ad Hegel
L’analisi della società capitalistica
La critica dell’economia borghese e l’alienazione
La concezione materialistica della storia
Genesi e destino del capitale
Schopenhauer
L’Irrazionalità del mondo e l’ascesi atea
Le radici culturali
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
La “volontà di vivere”
Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”
La vita è dolore
Kierkegaard
La fede come antidoto contro la disperazione
L’esistenza come possibilità
La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana
Gli stadi dell’esistenza umana
27
Il sentimento del possibile: l’angoscia
Disperazione e fede
Il Positivismo
I caratteri generale
F. Nietzsche
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
La nascita della tragedia
L’accettazione totale della vita
La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori
L’annuncio della morte di Dio
Il Superuomo
Dal Superuomo all’eterno ritorno
La volontà di potenza
Lo Spiritualismo
Bergson
Concezione del tempo
Lo Slancio Vitale
S. Freud
La rivoluzione psicoanalitica
I temi fondamentali
Sviluppi della psicoanalisi
28
RELAZIONE DI MATEMATICA
Insegnante De Sio Patrizia
La classe è composta da 20 elementi tutti provenienti dallo stesso percorso scolastico ad eccezione
di un’ alunna che è arrivata lo scorso anno da un altro istituto.
Sono stata la loro insegnante sin dal primo anno di liceo seguendoli nel loro processo di crescita sia
personale che scolastico. Sin dal primo anno il rapporto instauratosi con questa classe è stato
particolarmente positivo, stima e fiducia reciproca ed un rapporto insegnante- alunno proficuo per
entrambe le parti.
La loro partecipazione al dialogo educativo in classe non sempre ha dato esiti positivi per tutti,
infatti accanto ad elementi capaci, costanti nell’impegno, puntuali nelle consegne vi sono stati
elementi più discontinui che non hanno profuso nell’impegno domestico la stessa costanza ed
attenzione avuta in classe.
Per la valutazione si è tenuto conto del progresso conseguito dall’alunno rispetto al suo livello di
partenza, delle capacità individuali e delle abilità maturate in ambito cognitivo. La valutazione è
stata sia formativa che sommativa ossia sono stati effettuati controlli intermedi durante il processo
didattico (formativa) e al termine dello stesso (sommativa), per verificare l’acquisizione delle
finalità e degli obiettivi del programma. Al fine della valutazione sono stati eseguiti: questionari e
test di verifica, esercitazioni in classe, verifiche orali, compiti in classe.
All’interno della classe si sottolinea la presenza di un certo numero di alunni che raggiunge ottime
competenze e abilità come capacità di sintesi, personali procedimenti di deduzione e induzione,
capacità di affrontare con proprie strategie situazioni problematiche. Accanto a questi vi è un altro
gruppo che presenta discrete conoscenze dei contenuti ottenute lavorando con assiduità per tutto
l’anno. Vi è, inoltre, un esiguo numero di alunni che raggiunge livelli solamente sufficienti, vuoi
per discontinuità, per scarso impegno, nonché per effettive difficoltà pregresse.
29
PROGRAMMA DI MATEMATICA
Insegnante De Sio Patrizia
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Intervalli: aperti, chiusi, limitati e illimitati
Concetto di funzione reale di variabile reale. Funzioni algebriche e trascendenti. Insieme di
esistenza di una funzione: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere e fratte,
funzioni goniometriche, funzioni logaritmiche e funzioni esponenziali.
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione.
Grafico probabile di una funzione.
LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito. Limite di una funzione per x tendente a
più o meno infinito. Limite destro e sinistro di una funzione. Teorema di unicità del limite (senza
dimostrazione), teorema della permanenza del segno, teorema del confronto ( senza dimostrazione).
Limiti fondamentali. Teoremi sui limiti. Calcolo di limiti immediati. Forme indeterminate o di
indecisione.
Risoluzione delle forme indeterminate. Limiti notevoli.
Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui.
FUNZIONI CONTINUE
Funzioni continue. Punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza specie. Teorema
dei valori intermedi. teorema sull’esistenza degli zeri (senza dimostrazione).Teorema di Weierstrass
( senza dimostrazione).
DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Concetto di derivata e sua definizione . Derivata destra e derivata sinistra. Derivabilità e continuità
di una funzione. Significato geometrico della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva
in un suo punto. Punti angolosi e cuspidi. Continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni
elementari. Regole di derivazione. Derivata di una funzione composta. Derivata di una funzione
inversa. Derivate di ordine superiore. Differenziale di una funzione.
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teoremi di Rolle e di Lagrange: dimostrazione e relativa interpretazione geometrica. Conseguenze
del teorema di Lagrange: intervalli di monotonia delle funzioni. Regola di De L’Hopital. Calcolo di
limiti in forma indeterminata.
30
MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. Massimi e minimi
assoluti e relativi di una funzione. Criterio per l’esistenza di estremi relativi. Concavità di una
curva. Punti di flesso a tangente orizzontale, verticale ed obliqua.
Problemi di massimo e minimo.
STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Studio di una funzione. Studio del grafico di funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali ,
esponenziali, logaritmiche, goniometriche.
I grafici di una funzione e della sua derivata.
IL CALCOLO INTEGRALE
Integrale indefinito e le sue proprietà. Integrali
indefiniti immediati. Integrali immediati di
funzioni composte. Metodi elementari di integrazione indefinita: integrazione per scomposizione,
integrazione per parti, integrazione per sostituzione. Integrazione indefinita delle funzioni razionali
fratte.
Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito e suo significato
geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media.
Funzione integrale. Teorema di Torricelli. Legame tra l’integrale definito e le primitive di una
funzione. Applicazioni del calcolo integrale: calcolo dell’area di una superficie piana, calcolo del
volume di un solido di rotazione, calcolo dell’ area di una superficie di rotazione.
Integrali impropri.
Nella seconda decade di maggio verranno trattati i seguenti argomenti:
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni
differenziali lineari .
Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione.
31
RELAZIONE DI FISICA
Insegnante Elia Daniela
La classe è composta da 20 elementi e nel complesso si presenta molto eterogenea. La frequenza è
stata sufficientemente assidua. Le lezioni sono state costantemente svolte con l'intento di
raggiungere un clima di continuo dialogo, nel complesso, fatta qualche eccezione, la partecipazione
è stata particolarmente attiva. Durante tutto l'anno si è cercato di attuare un recupero sistematico,
anche sotto forma di brevi riepiloghi all'inizio di ogni lezione, vista anche la presenza di alcuni
elementi che hanno evidenziato difficoltà nel seguire il lavoro scolastico proposto in classe. Anche
a causa di questi fattori, lo svolgimento del programma ha subito un certo rallentamento, cosicché
non sarà possibile trattare tutti gli argomenti previsti in fase di programmazione di inizio anno. Non
tutti gli allievi hanno acquisito l'abitudine alla riflessione, allo studio e all'organizzazione autonoma
del lavoro personale. Sanno cogliere e apprezzare,pur se parzialmente, l'utilità del confronto di idee
e partecipazione al lavoro di gruppo. Nel complesso quasi tutti sanno sufficientemente utilizzare il
linguaggio specifico della materia e comunicare in modo chiaro le procedure seguite ed i risultati
raggiunti. Hanno conseguito una discreta capacità di distinguere la realtà fisica dai modelli via via
costruiti per la sua interpretazione, anche se molti trovano difficoltà nella risoluzione di problemi
applicativi. Per quanto riguarda il profitto raggiunto si possono individuare tre livelli: un primo
molto buono per chiarezza espositiva e impegno personale (tre o quattro elementi); un secondo,
numeroso, soddisfacente per impegno e partecipazione sia in aula sia a casa; un terzo
insoddisfacente perché, alla già scarsa partecipazione in aula, non è seguito un opportuno lavoro
individuale.
32
PROGRAMMA DI FISICA
Insegnante Elia Daniela
Unità
Contenuti
18.Il
2) Proprietà dei poli magnetici.
magnetis 3) Rappresentazione di campi
mo
magnetici mediante linee di
campo.
4) Campo magnetico terrestre.
5) Campi magnetici generati
da correnti.
6) Forza magnetica fra fili
rettilinei e paralleli percorsi
da corrente.
7) Unità di corrente come unità
di misura fondamentale del
SI.
8) Definizione operativa
dell’intensità del campo
magnetico.
9) Campi magnetici di alcune
distribuzioni di corrente.
10)
Teorema di Gauss
per il magnetismo e teorema
di Ampere.
11)
Forze magnetiche
sui fili percorsi da corrente e
sulle cariche elettriche in
movimento
12)
Moto di una carica
elettrica in un campo
magnetico
13)
Azione meccanica
di un campo magnetico su
una spira percorsa da
corrente e motore elettrico
14)
Definizione di
momento magnetico
15)
Proprietà
magnetiche della materia.
19.
45)
Esperimenti di
L’induzio Faraday sulla corrente
ne elettro indotta
magnetica 46)
Flusso di campo
magnetico concatenato con
un circuito
47)
Relazione fra la
variazione del flusso
concatenato con un circuito
e la forza elettromotrice
indotta (legge di FaradayNeumann)
48)
Verso della
corrente indotta (legge di
Lenz)
49)
Correnti di
Foucault
50)
Mutua induzione e
autoinduzione
51)
Induttanza di un
solenoide
52)
Analisi dei circuiti
RL
53)
Energia
immagazzinata in un
solenoide percorso da
corrente continua
54)
Circuiti elettrici a
corrente alternata
55)
Trasformatori e
linee di trasporto elettriche
Prerequisiti
Obiettivi
Obiettivi minimi
16)
Concetti di carica
elettrica, campo elettrico e
corrente.
17)
Grandezze
fondamentali del SI e
grandezze derivate.
18)
Significato delle
linee di campo.
19)
Proprietà del moto
circolare uniforme
20)
Elementi di
dinamica rotazionale del
corpo rigido.
21)
Eseguire
operazioni su vettori.
22)
Teorema di Gauss
relativo al campo elettrico.
23)
Calcolo della
circuitazione di un campo
vettoriale.
Conoscenze
24)
Sorgenti di campo
magnetico.
25)
Confronto fra poli magnetici
e cariche elettriche.
26)
Proprietà del campo
magnetico terrestre.
27)
Interazione magnetica fra
correnti elettriche.
28)
Proprietà dei campi
magnetici generati da fili rettilinei,
spire e solenoidi percorsi da corrente.
29)
Principio di funzionamento
di un motore elettrico.
30)
Caratteristiche dei materiali
diamagnetici, paramagnetici e
ferromagnetici.
Competenze
31)
Applicare la legge che
descrive l’interazione fra fili rettilinei
percorsi da corrente.
32)
Determinare il campo
magnetico prodotto in un punto dalla
corrente che scorre in un filo
rettilineo o in un solenoide.
33)
Sfruttare il teorema di
Ampere per determinare i campi
magnetici generati da particolari
distribuzioni di corrente.
34)
Determinare la forza su un
filo percorso da corrente o su una
carica elettrica in moto in un campo
magnetico uniforme.
35)
Determinare le variabili del
moto circolare uniforme di una carica
elettrica in un campo magnetico.
Conoscenze
66)
Fenomenologia
dell’induzione elettromagnetica e
origine della forza elettromotrice
indotta
67)
Proprietà di un generatore a
corrente alternata
68)
Effetti della mutua
induzione e dell’autoinduzione
69)
Proprietà dei circuiti RL
70)
Relazione fra intensità di
corrente e forza elettromotrice nei
circuiti a corrente alternata
71)
Proprietà e funzione di un
trasformatore
Competenze
72)
Applicare la legge di
Faraday-Neumann-Lenz
73)
Determinare l’induttanza di
un solenoide,note le sue
caratteristiche geometriche e
costruttive
74)
Calcolare l’energia
immagazzinata in un solenoide
percorso da una corrente continua
75)
Risolvere problemi sui
trasformatori
Conoscenze
36)
Sorgenti di campo
magnetico.
37)
Confronto fra poli magnetici
e cariche elettriche.
38)
Proprietà del campo
magnetico terrestre.
39)
Interazione magnetica fra
correnti elettriche.
40)
Caratteristiche dei materiali
diamagnetici, paramagnetici e
ferromagnetici.
Competenze
41)
Applicare la legge che
descrive l’interazione fra fili rettilinei
percorsi da corrente.
42)
Determinare il campo
magnetico prodotto in un punto dalla
corrente che scorre in un filo
rettilineo o in un solenoide.
43)
Spiegare il teorema di
Ampere applicandolo a particolari
distribuzioni di corrente.
56)
Concetti di
corrente elettrica e forza
elettromotrice
57)
Ruolo del
generatore elettrico in un
circuito e potenza erogata da
un generatore
58)
Definizione di
resistenza elettrica
59)
Prima legge di
Ohm e potenza assorbita da
una resistenza per effetto
Joule
60)
Campo magnetico
e sue sorgenti
61)
Interazione fra
magneti e forza magnetica
su un filo percorso da
corrente
62)
Campo magnetico
di un solenoide
63)
Definizione di
permeabilità magnetica
relativa di un materiale
64)
Concetto di flusso
di campo vettoriale
attraverso una superficie
65)
Elementi di calcolo
differenziale e integrale
33
44)
Determinare le variabili del
moto circolare uniforme di una carica
elettrica in un campo magnetico.
Conoscenze
76)
Fenomenologia
dell’induzione elettromagnetica e
origine della forza elettromotrice
indotta
77)
Effetti della mutua
induzione e dell’autoinduzione
78)
Proprietà dei circuiti RL
79)
Relazione fra intensità di
corrente e forza elettromotrice nei
circuiti a corrente alternata
80)
Proprietà e funzione di un
trasformatore
Competenze
81)
Applicare la legge di
Faraday-Neumann-Lenz
82)
Determinare l’induttanza di
un solenoide,note le sue
caratteristiche geometriche e
costruttive
83)
Calcolare l’energia
immagazzinata in un solenoide
percorso da una corrente continua
20.
Le 84)
Campo elettrico
onde
indotto e campo magnetico
elettroma
indotto.
gnetiche 85)
Propagazione del
campo elettromagnetico.
86)
Velocità della luce
in funzione delle costanti
dell’elettromagnetismo.
87)
Equazioni di
Maxwell.
88)
Caratteristiche di
un’onda elettromagnetica
armonica.
89)
Trasporto di
energia e quantità di moto
da parte delle onde
elettromagnetiche.
90)
Produzione e
ricezione di onde
elettromagnetiche mediante
circuiti oscillanti e antenne.
91)
Spettro
elettromagnetico e proprietà
delle sue diverse
componenti.
21.
Lo
spaziotempo
relativisti
co
di
Einstein
22.
La
massaenergia
relativisti
ca e la
relatività
generale
92)
Campi elettrico e
magnetico e rispettive
sorgenti.
93)
Concetto di
induzione elettromagnetica.
94)
Legge di FaradayNeumann-Lenz.
95)
Teorema di
Ampere.
96)
Proprietà generali
delle onde e grandezze
caratteristiche di un’onda
armonica.
97)
Definizione di
capacità e induttanza.
98)
Polarizzazione
della luce.
99)
Funzioni
goniometriche.
Conoscenze
100)
Campo magnetico variabile
come sorgente di campo elettrico e
campo elettrico variabile come
sorgente di campo magnetico.
101)
Significato delle equazioni
di Maxwell.
102)
Produzione, ricezione e
propagazione di onde
elettromagnetiche.
103)
Definizione di densità di
energia e intensità di un’onda
elettromagnetica.
104)
Relazione fra campo
magnetico e campo elettrico di
un’onda elettromagnetica armonica.
105)
Classificazione e
caratteristiche delle onde
elettromagnetiche in funzione della
loro lunghezza d’onda.
Competenze
106)
Stabilire direzione e verso di
un campo magnetico indotto.
Determinare la quantità di energia
trasportata da un’onda elettromagnetica
su una superficie in un certo intervallo
di tempo.
114)
Contesto storico
122)
Concetto di
Conoscenze
scientifico in cui si inserisce sistema di riferimento.
126)
Significato dell’esperimento
la teoria della relatività
123)
Principio di
di Michelson e Morley.
ristretta.
relatività classico.
127)
Enunciati dei due postulati
115)
Esperimento di
124)
Leggi classiche di
della relatività ristretta.
Michelson e Morley.
composizione degli
128)
Concezione relativistica
116)
Trasformazioni di
spostamenti e delle velocità. dello spazio tempo.
Lorentz
125)
Proprietà della
129)
Implicazioni dei postulati
117)
Postulati di
propagazione della luce.
relativistici nei concetti di
Einstein.
simultaneità , intervallo di tempo e
118)
Composizione
distanza.
relativistica delle velocità.
Competenze
119)
Diagrammi spazioApplicazione della legge di
tempo.
composizione relativistica delle
120)
Concetto di
velocità e delle leggi di dilatazione
simultaneità.
dei tempi e di contrazione delle
121)
Dilatazione dei
lunghezze.
tempi e contrazione delle
lunghezze.
134)
Massa e quantità di 141)
Relazioni classiche Conoscenze
moto relativistiche.
fra le grandezze dinamiche. 143)
Concetto relativistico di
135)
Energia cinetica
142)
Fondamenti di
massa.
relativistica.
cinematica relativistica.
144)
Conservazione della massa136)
Energia a riposo ed
energia.
energia totale.
145)
Idee fondamentali della
137)
Fotone come
relatività generale e loro conferme
quanto di energia.
sperimentali.
138)
Introduzione alla
Competenze
relatività generale: principio
146)
Applicare la relazione fra
di equivalenza e principio di
massa e velocità e le altre relazioni
relatività generale.
della dinamica relativistica.
139)
Incurvamento dello
spazio-tempo causato dalla
gravità.
140)
Verifiche
sperimentali della relatività
generale.
34
Conoscenze
107)
Campo magnetico variabile
come sorgente di campo elettrico e
campo elettrico variabile come
sorgente di campo magnetico.
108)
Significato delle equazioni
di Maxwell.
109)
Definizione di densità di
energia e intensità di un’onda
elettromagnetica.
110)
Relazione fra campo
magnetico e campo elettrico di
un’onda elettromagnetica armonica.
111)
Classificazione e
caratteristiche delle onde
elettromagnetiche in funzione della
loro lunghezza d’onda.
Competenze
112)
Stabilire direzione e verso di
un campo magnetico indotto.
113)
Determinare la quantità di
energia trasportata da un’onda
elettromagnetica su una superficie in
un certo intervallo di tempo.
Conoscenze
130)
Enunciati dei due postulati
della relatività ristretta.
131)
Concezione relativistica
dello spazio tempo.
132)
Implicazioni dei postulati
relativistici nei concetti di
simultaneità , intervallo di tempo e
distanza.
Competenze
133)
Applicazione della legge di
composizione relativistica delle
velocità .
Conoscenze
147)
Concetto relativistico di
massa.
148)
Conservazione della massaenergia.
149)
Idee fondamentali della
relatività generale e loro conferme
sperimentali.
Competenze
Applicare la relazione fra massa e
velocità .
23.
Le 150)
Scoperta
origini
dell’elettrone.
della
151)
Radiazione di
fisica dei corpo nero e ipotesi dei
quanti
quanti di Plance.
152)
Effetto
fotoelettrico.
153)
Effetto Compton.
154)
Spettri atomici.
155)
Primi modelli
atomici e atomo di Bohr.
156)
Nozioni di carica,
corrente, differenza di
potenziale.
157)
Grandezze
caratteristiche di un’onda
elettromagnetica
(frequenza,lunghezza
d’onda, intensità ecc.).
158)
Relazioni
relativistiche fra massa ed
energia e fra energia e
quantità di moto.
159)
Legge di Coulomb.
160)
Dinamica del moto
circolare uniforme e
concetto di momento
angolare.
Conoscenze
161)
Carenze concettuali della
fisica classica nella descrizione
dell’interazione fra radiazione e
materia e genesi del concetto di
quanto di energia.
162)
Proprietà dell’effetto
fotoelettrico e dell’effetto Compton e
loro interpretazione quantistica.
163)
Caratteristiche degli spettri
atomici ed evoluzione del modello
atomico.
Competenze
164)
Applicare a casi particolari
l’equazione di Einstein dell’effetto
fotoelettrico e la legge che esprime
l’effetto Compton
Utilizzare il modello di Bohr
nell’analisi degli spettri dell’atomo di
idrogeno e degli atomi idrogenoidi.
Conoscenze
165)
Carenze concettuali della
fisica classica nella descrizione
dell’interazione fra radiazione e
materia e genesi del concetto di
quanto di energia.
166)
Descrizione dell’effetto
fotoelettrico e dell’effetto Compton
Competenze
167)
Applicare a casi particolari
l’equazione di Einstein dell’effetto
fotoelettrico e la legge che esprime
l’effetto Compton
168)
Utilizzare il modello di Bohr
nell’analisi degli spettro dell’atomo
di Bohr.
Programma svolto sino al 15 Maggio 2016
Programma da svolgere successivamente al 15 Maggio 2016
24.
La 169)
Onde di de Broglie
meccanic
e principio di
a
complementarità.
quantistic 170)
Fondamenti della
a
meccanica ondulatoria di
dell’atom
Schrodinger.
o
171)
Principio di
indeterminazione di
Heisenberg.
172)
Effetto tunnel.
173)
Numeri quantistici
atomici.
174)
Principio di
esclusione di Pauli.
175)
Emissione e
assorbimento dei raggi X.
176)
Proprietà dei laser.
25.
La 197)
Tipi di legame
fisica
chimico.
dello stato 198)
Bande di energia
solido
nei solidi.
199)
Semiconduttori e
loro drogaggio.
200)
Giunzione p-n e
sue principali applicazioni.
201)
Superconduttori.
202)
Nuovi materiali e
nanotecnologia.
177)
Nozione di fotone.
178)
Proprietà generali
delle onde e grandezze
caratteristiche di un’onda
armonica.
179)
Condizioni di
interferenza costruttiva e
distruttiva.
180)
Proprietà della
figura di diffrazione
prodotta da una fenditura.
181)
Modello di Bohr
dell’atomo di idrogeno.
182)
Definizione di
momento angolare e
momento magnetico.
183)
Effetto meccanico
di un campo magnetico su
una spira percorsa da
corrente.
Conoscenze
184)
Complementarità fra onde e
corpuscoli.
185)
Significato della funzione
d’onda di Schrodinger.
186)
Enunciato e implicazioni del
principio di indeterminazione di
Heisenberg.
187)
Descrizione quantistica
dell’atomo come perfezionamento
del modello di Bohr.
188)
Principio di funzionamento
di un laser e proprietà della
radiazione emessa da questo tipo di
sorgente.
Competenze
189)
Calcolare la lunghezza
d’onda di de Broglie di una particella
e analizzare fenomeni di interferenza
e diffrazione che coinvolgono
elettroni o altre particelle.
190)
Spiegare mediante il
principio di esclusione di Pauli la
configurazione elettronica degli
atomi complessi.
Analizzare gli spettri di emissione e
assorbimento dei raggi X.
203)
Descrizione
Conoscenze
quantistica dell’atomo.
207)
Conduzione elettrica nei
204)
Principio di
semiconduttori.
esclusione di Pauli.
208)
Descrizione delle giunzioni
205)
Effetto
p-n e dei principali dispositivi a
fotoelettrico.
semiconduttore.
206)
Concetto di
209)
Fenomeno della
induzione elettromagnetica.
superconduttività e proprietà
magnetiche dei superconduttori.
210)
Sviluppi e prospettive della
scienza dei materiali.
Competenze
211)
Spiegare qualitativamente il
diverso comportamento elettrico di
conduttori, isolanti e semiconduttori
sulla base della teoria dei solidi a
bande.
35
Conoscenze
191)
Complementarità fra onde e
corpuscoli.
192)
Significato della funzione
d’onda di Schrodinger.
193)
Enunciato e implicazioni del
principio di indeterminazione di
Heisenberg.
194)
Descrizione quantistica
dell’atomo come perfezionamento del
modello di Bohr.
Competenze
195)
Calcolare la lunghezza
d’onda di de Broglie di una particella
e analizzare fenomeni di interferenza
e diffrazione che coinvolgono
elettroni o altre particelle.
196)
Spiegare mediante il
principio di esclusione di Pauli la
configurazione elettronica degli atomi
complessi.
Conoscenze
212)
Conduzione elettrica nei
semiconduttori.
213)
Descrizione delle giunzioni
p-n .
214)
Fenomeno della
superconduttività e proprietà
magnetiche dei superconduttori.
Competenze
Spiegare qualitativamente il diverso
comportamento elettrico di conduttori,
isolanti e semiconduttori sulla base
della teoria dei solidi a bande.
RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI
Insegnante Serafini Marina
Nel corso dell’anno la scolaresca si è dimostrata, ad eccezione di pochi elementi, partecipe
all’attività didattica e in alcuni casi in modo attivo e critico. L’atteggiamento degli alunni è
stato nel complesso corretto, anche se a volte per alcuni di loro si è reso necessario qualche
intervento deciso per superare una certa reticenza, per così dire, ad assumersi le proprie
responsabilità e alla fine per alcuni di loro c’è stata una considerevole crescita. Alcuni si
distinguono per un possesso sicuro degli strumenti linguistici della materia e per le capacità
di organizzazione autonoma e critica dei contenuti, oltre che per un interesse costante e
attivo aperto anche a momenti di approfondimento.
Per altri un impegno costante, sorretto da un’attenta partecipazione in classe hanno sopperito
al possesso poco sicuro del linguaggio scientifico.
Pochissimi, meno costanti continuano a rilevare una preparazione molto superficiale dovuta
ad una scarsa conoscenza degli argomenti trattati.
La classe nel complesso ha raggiunto una buona preparazione nelle discipline. E’ stato
fatto un percorso lungo e non certo privo di difficoltà per sviluppare in essi un maggior
senso di responsabilità nei confronti di ogni attività scolastica e per migliorare il metodo di
studio sono state fornite approfondite conoscenze dispensando termini e concetti con un
preciso linguaggio scientifico in modo da far suscitare in loro un senso critico e curiosità per
le tematiche di grande attualità sia per quanto riguarda le materie di interesse del
programma; tutto questo ha anche fornito l’occasione per approfondimenti e collegamenti.
Bisogna aggiungere che alcuni alunni hanno raggiunto ottimi risultati dal momento che già
possedevano buone competenze elaborative.
36
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Insegnante Serafini Marina
Chimica Organica, Biochimica, Biotecnologie
1. La Chimica Organica
1.1 La Chimica Organica Studia I Composti Del Carbonio
Le caratteristiche delle Catene Carboniose
Le Caratteristiche dei composti organici sono definite da gruppi funzionali
L’isomeria giustifica l’esistenza di moltissimi composti organici
Le formule di struttura delle molecole organiche
Principi Generali che correlano la struttura alle proprietà fisiche
1.2 La Nomenclatura Dei Composti Organici Segue Le Regole IUPAC
La nomenclatura dei composti organici fa riferimento agli alcani
1.3 Gli idrocarburi Sono Costituiti Esclusivamente Da Carbonio e Idrogeno
Gli alcani contengono solo legami singoli
La Conformazione degli alcani lineari
Le reazioni chimiche degli alcani avvengono per scissione omolitica
Gli alcheni e gli alchini presentano legami doppi e tripli
L’isomeria geometrica negli alcheni
Gli idrocarburi aromatici contengono anelli benzenici
I Composti Policiclici Aromatici
1.4 Gli Alcoli E Gli Eteri Sono Derivati Organici Dell’Acqua
L’importanza della funzione alcolica
Reazioni degli alcoli
Anche gli Eteri sono derivati organici dell’acqua
1.5 La Chiralità È un fattore importante nello studio delle molecole organiche
1.6 Aldeidi E Chetoni Contengono Il Gruppo Carbonile
Reazioni delle aldeidi e dei chetoni
1.7 Gli Acidi Carbossilici Contengono Il Gruppo Carbossile
Il gruppo carbossile possiede proprietà acide e subisce sostituzione nucleofila
1.8 Le Ammine Sono Derivati Organici Dell’Ammoniaca
1.9 I Polimeri Sono Costituiti Dalla Ripetizione Di Molte Unità Molecolari
Alcuni polimeri si trasformano per addizione di unità monomeriche
I polimeri si possono formare tramite reazioni di condensazione
37
Le reticolazioni danno maggiore resistenza alle fibre dei polimeri
Catene di polimeri inorganici contengono atomi diversi dal carbonio
2. Le Biomolecole: Carboidrati e Lipidi
2.1 I Monosaccaridi E I Disaccaridi
Funzioni e classificazione strutturale
Le unità costitutive dei carboidrati: i monosaccaridi
La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione
L’unione di due molecole di monosaccaride: i disaccaridi
2.2 I Polisaccaridi
Polisaccaridi con funzione di riserva: l’amido e il glicogeno
Polisaccaridi con funzione strutturale: cellulosa e chitina
2.3 I Lipidi
Funzioni e classificazione strutturale
Precursori lipidici: gli acidi grassi
Lipidi con funzione di riserva: i trigliceridi
Lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi
Lipidi con funzione strutturale: gli sfingolipidi
Struttura e funzione del colesterolo
2.4 Le Vitamine E I Derivati Lipidici
Le vitamine sono liposolubili o idrosolubili
3. Le Biomolecole: Proteine e Acidi Nucleici
3.1 Le Proteine
Funzioni delle proteine
Le unità costitutive delle proteine: gli amminoacidi
Classificazione strutturale degli α-amminoacidi
Il legame peptidico
Struttura primaria delle proteine
Struttura secondaria
Struttura terziaria
Struttura quaternaria
3.2 Rapporti Struttura-Funzione Nelle Proteine
La denaturazione delle proteine
Le molecole proteiche sono flessibili
Proteine che legano l’ossigeno
L’emoglobina è un tetramero
Regolazione della funzione dell’emoglobina: l’effetto Bohr
38
Regolazione della funzione dell’emoglobina: il 2,3-bisfosfoglicerato
Una proteina fibrosa: il collageno
3.3 Gli Enzimi
Struttura e funzioni degli enzimi
Classificazione e nomenclatura degli enzimi
Cofattori, coenzimi e vitamine idrosolubili
L’azione catalitica di un enzima
L’attività enzimatica
Regolazione dell’attività enzimatica
3.4 Gli Acidi Nucleici
Funzioni degli acidi nucleici
Le unità strutturali degli acidi nucleici: i nucleotidi
Il DNA
La doppia elica del DNA
Il “Dogma centrale della biologia”
L’RNA
mRNA, mRNA e tRNA
4. Il Metabolismo
4.1 Le Trasformazioni Chimiche All’Interno Di Una Cellula
Le reazioni della cellula sono organizzate in vie metaboliche
Le vie metaboliche sono convergenti, divergenti e cicliche
L’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche
NAD e FAD trasportano elettroni nel metabolismo
I processi metabolici sono finemente regolati
4.2 Il Metabolismo Dei Carboidrati
La glicolisi è la principale via catabolica del glucosio
Le fermentazioni permettono di ossidare il glucosio in assenza di O2
Il controllo della glicolisi e la via dei pentoso fosfati
La gluconeogenesi è la biosintesi del glucosio da piruvato, lattato e amminoacidi
Il glicogeno è un’importante riserva energetica
4.3 Il Metabolismo Dei Lipidi
La β–ossidazione è la via di degradazione degli acidi grassi
I corpi chetonici sono una fonte alternativa di energia
Il fegato produce riserve lipidiche e colesterolo
4.4 Il Metabolismo Degli Amminoacidi
La perdita del gruppo amminico è la prima tappa nel catabolismo degli amminoacidi
La biosintesi dell’urea consente di eliminar lo ione ammonio, una specie chimica
39
tossica
Gli amminoacidi precursori di numerose molecole
4.5 Il Metabolismo Terminale
La decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico porta alla produzione di acetilCoA
Il ciclo dell’acido citrico ossida l’acetil-CoA a C O2
4.6 La Produzione Di Energia Nelle Cellule
L’ossigeno è l’accettore finale nella catena di trasferimento elettronico
mitocondriale
La fosforilazione ossidativa accoppia le ossidazioni terminali alla sintesi dell’ATP
La fotosintesi trasforma in energia chimica la luce del sole
4.7 La Regolazione Delle Attività Metaboliche: Il Controllo Della Glicemia
La glicemia è il più importante parametro ematochimico
Dopo un pasto viene prodotta insulina
Durante il digiuno viene prodotto glucagone
Il metabolismo differenziato nelle cellule dell’organismo
5. Che Cosa Sono le Biotecnologie?
5.1 Una Visione D’Insieme Sulle Biotecnologie
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie
5.2 La Tecnologia Delle Colture Cellulari
5.3 La Tecnologia Del DNA Ricombinante
Tagliare il DNA
Incollare il DNA
Copiare il DNA
Amplificare il DNA: la PCR
Sequenziare il DNA
5.4 Il Conaggio E La Clonazione
Clonaggio del DNA
Biblioteche di DNA
Clonare organismi complessi
5.5 L’Analisi Del DNA
La tecnologia del Microarray
40
5.6 L’Analisi Delle Proteine
Proteine specifiche possono essere individuate con anticorpi
La proteomica
5.7 L’Ingegneria Genetica E Gli OGM
L’Ingegneria genetica applicata agli animali
5.8 Il Ruolo Dell’RNA
La tecnologia antisenso
La RNAi
I microRNA
I ribozimi e riboswitch
6. Le Applicazioni delle Biotecnologie
6.1 Le Biotecnologie Mediche
La Diagnostica
I trattamenti terapeutici
Gli anticorpi monoclonali
6.2 Le Biotecnologie Agrarie
L’Ingegneria genetica nelle piante
L’uso delle relazioni cooperative naturali
Il valore nutrizionale delle colture
l’igiene dei cibi
6.3 Le Biotecnologie Ambientali
La depurazione degli inquinamenti: il biorimedio
Materiali ed energia
Le applicazioni delle biotecnologie ai processi industriali
41
Scienze della Terra
5. La Tettonica delle Placche
5.1 La Dinamica Interna della Terra
5.2Alla ricerca di un “modello”
La struttura interna della Terra
La crosta
Il mantello
Il nucleo
5.3 Un Segno Dell’Energia Interna Della Terra: Il Flusso Di Calore
La temperatura interna della Terra
5.5 La Struttura Della Crosta
Crosta oceanica e crosta continentale
L’isostasia
5.6 L’Espansione Dei Fondi Oceanici
La deriva dei continenti
Le dorsali oceaniche
Le fosse abissali
Espansione e subduzione
5.7 Le Anomalie Magnetiche Sui Fondi Oceanici
5.8 La Tettonica Delle Placche
Le placche litosferiche
L’orogenesi
Il ciclo di Wilson
5.9 La Verifica Del Modello
Vulcani: ai margini delle placche o all’interno delle placche
Terremoti: ai margini delle placche o all’interno dei continenti
5.10 Moti convettivi e punti caldi
6. La Storia della Terra
6.1 La Storia Di Un Sistema Integrato
Un sistema “integrato”
Ricostruire la storia della Terra
6.2 La datazione nelle Scienze della Terra
Geocronologia e Geocronometria
42
I fossili e il processo di fossilizzazione
La storia della Terra è divisa in eoni, ere, periodi
6.3 Il Precambriano
Da una nube di polvere di stelle nasce il Sistema solare
Eone adeano: dalle origini a 4000 Ma fa
Eone archeozoico o archeano: da 4000 a 2500 Ma fa
Eone proterozoico: da 2500 a 570 Ma fa
6.4 Eone Fanerozoico. Il “tempo della vita manifesta” (da 542 Ma fa a oggi)
6.5 Era Paleozoica
Il paleozoico inferiore: antichi continenti alla deriva mentre la vita conquista le terre
emerse
Paleozoico superiore: nasce il supercontinente Pangea e scoppia la grande crisi biologica
6.6 Era Mesozoica
La frammentazione della Pangea
Il dominio dei rettili
L’estinzione in massa della fine del Cretaceo
6.7 Era Cenozoica
Le grandi catene montuose danno alla Terra il suo aspetto attuale
Dall’evoluzione dei mammiferi nascono i primati
6.8 Il Quaternario: Gli Ultimi 2.600.000 Anni
Le glaciazioni
Le glaciazioni provocarono grandi migrazioni
L’evoluzione umane
6.9 Storia Della Terra: Un Quadro Sinottico
6.10 Storia Geologica Del Territorio Italiano
7. Il Modellamento del Rilievo Terrestre
7.1 Le Forze Geodinamiche
Conoscenze di base
7.2 La Degradazione Meteorica
La disgregazione delle rocce
L’alterazione chimica delle rocce e dei suoli
I prodotti della degradazione meteorica
43
7.3 I Fenomeni Franosi
Tipi di frane
Le cause delle frane
7.4 L’Azione Morfologica Del Vento
Il prelievo e il trasporto dei detriti
Le forme di deposito prodotte dal vento
7.5 L’Azione Morfologica Delle Acque Correnti Superficiali
Erosione areale ed erosione lineare
Come agisce l’erosione fluviale
Lo “svasamento” delle acque fluviali
Le forme di deposito fluviale
Meandri e terrazzi fluviali
Le foci dei corsi d’acqua: i delta e gli estuari
7.7 L’azione Solvente Delle Acque Ed il Carsismo
L’ambiente carsico superficiale
L’ambiente carsico sotterraneo
L’evoluzione del carsismo e le risorse idriche delle zone carsiche
7.8 L’Azione Morfologica Dei Ghiacciai
Modalità di erosione glaciale
I circhi e le valli glaciali
Le forme di deposito glaciali
Il modellamento del paesaggio al ritiro dei ghiacciai
7.9 L’Azione Morfologica Del Mare Sulle Coste
Le onde come agenti abrasivi delle coste
L’azione costruttiva del mare
L’evoluzione delle zone costiere e i terrazzi marini
Una notevole varietà di coste
7.10 La Dinamica dei Litorali
Modificazioni recenti e attuali
Cause naturali e cause antropiche della dinamica dei litorali
44
RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
Insegnante De Leo Antonio
Ho seguito i ragazzi durante il primo anno, poi nel 2012/13, quando facevano il secondo, sono stato
trasferito per tornare l'anno successivo, riuscendo così a continuare il lavoro iniziato. L'interruzione
per un intero anno scolastico mi ha posto però nella condizione di dover riprendere le varie
tematiche dal punto dove erano state interrotte in maniera tale che gli studenti avessero un quadro
completo, organico e coerente del percorso, trovandomi pertanto a svolgere il programma di cinque
anni in quattro. Naturalmente non è stata tralasciata alcuna trattazione intermedia ma ho dovuto
rinunciare a sviluppare gli argomenti relativi all'arte dei nostri giorni fermandomi
all'impressionismo ed all'espressionismo, nonostante ciò non è stata penalizzata né l'integrità
dell'iter né il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per ciò che riguarda la classe all'interno del gruppo sono presenti elementi positivi sia dal punto di
vista didattico che della maturazione raggiunta, certo il livello di preparazione è tutt'altro che
omogeneo, mentre alcuni si distinguono per la serietà con cui affrontano gli studi sia in classe che
autonomamente, raggiungendo così una buona capacità espositiva ed argomentativa che li porta ad
esprimere anche liberi giudizi sulle tematiche trattate, altri non fanno corrispondere alle loro
potenzialità né la partecipazione in classe né lo studio autonomo, raggiungendo così un profitto
appena sufficiente. Nella classe è altresì presente un gruppo di ragazzi di livello intermedio che, pur
non eccellendo, raggiunge un grado di preparazione superiore alla sufficienza. In generale, quindi,
le proprietà di linguaggio sono buone e solamente per alcuni permane qualche incertezza espositiva
ed una certa elementarità. All'interno dell'ambiente classe vi sono gruppi di ragazzi molto coesi che
hanno seguito il medesimo percorso di studi sin dagli ordini scolastici inferiori, altri gruppi si sono
formati durante i cinque anni del presente corso mentre alcuni elementi risultano poco integrati e
piuttosto isolati.
L'interesse dei ragazzi nei confronti della materia non sempre è stato costante, questo ha portando
alcuni ad avere un quadro frammentario dei contenuti mentre altri, più coinvolti, sono riusciti a
costruire un sapere complesso che li ha portati ad interrelare i vari ambiti di esperienza.
45
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Insegnante De Leo Antonio
L'Ottocento
La nuova epoca
La borghesia e il mondo che cambia
Le rivoluzioni industriali
La crisi dei valori ottocenteschi
Il tempo permanente e il tempo frammentato: la concezione della modernità, il tempo breve.
Gericault, La zattera della Medusa
L'addio al passato, analisi del finale di Morte a Venezia di L.Visconti
Il realismo.
La realtà: ordine aprioristico e sistemi simbolici, il valore della parola, nominazione e senso,
l'ampliamento dei significati nella realtà trasfigurata.
L'Impressionismo
L'art pour l'art, l'ipocrisia borghese, l'arte delle accademie
Gli inizi, i Salon des Refusés,
Il nuovo sguardo sul mondo
Manet
L'ipocrisia borghese, l'arte crea scandalo
Le déjeuner sur l'herbe
Olympia
La luce
La fotografia
La realtà di Monet perde la nominazione, dimenticare il nome delle cose
Confronto tra due opere, Sisley, Isola della Grande Jatte e Monet, Regate ad Argenteil
Degas
Analisi delle opere:
La nuova prospettiva, narrazione critica del mondo, il racconto della mancanza, le relazioni umane:
La famiglia Bellelli
L'assenzio
Interno (lo stupro)
Scena di guerra nel Medioevo
La visione della donna:
Donna che si asciuga
Donna che entra nella vasca
Le ballerine:
Lezione di danza
L'espressionismo di Vincent Van Gogh
La vita
L'opera pittorica
Il Borinage, Van Gogh predicatore
Il credo religioso si sublima nell'arte
La malinconia di Vincent
La luce del Nord e la luce del Sud
Gli ultimi anni
Il soggiorno in Provenza, Arles
L'arrivo di Paul Gauguin
La follia e la morte
Campo di grano con corvi
46
Materiali speciali di approfondimento:
Finale del film Morte a Venezia di Luchino Visconti (Youtube)
Gustav Mahler, Adagietto della sinfonia n° 5 (Youtube)
Allen Ginsberg: Jukebox all'idrogen, L'urlo
Jimi Hendrix- Star Spangled Banner at Woodstock
Sito web: antoniodeleo.it - Lezioni, Dall'Impressionismo alla nascita delle avanguardie
Sito web: antoniodeleo.it - Lezioni trascritte, L'Ottocento
Sito web: antoniodeleo.it - Conversazioni, Conversazione sulle questioni ottocentesche, quali
riflessi sulla nostra epoca?
Sito web: antoniodeleo.it - Conversazioni, Conversazione sulla necessità dell'arte e della fisica
Sito web: antoniodeleo.it - Conversazioni, Conversazione sulla luce e sull'ombra
Sito web: antoniodeleo.it - Conversazioni, Conversazione sull'ordine e il disordine
Testi speciali di riferimento per alcune lezioni:
Arnold Hauser: Storia sociale dell'Arte, Vol. IV Arte moderna e contemporanea
Mario De Micheli: Le avanguardie artistiche del Novecento
Roberto Calasso: La folie Baudelaire
Reihnard Brand: Filosofia nella pittura
V. Van Gogh: Lettere a Theo
René Char: Le vicinanze di Van Gogh
J. Van Gogh: Vincent Van Gogh
Massimo Recalcati: Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh
Antonin Artaud: Van Gogh il suicidato della società
Pierre Drieu La Rochelle: Memorie di Dirk Raspe
J. Conrad: Cuore di tenebra
Umberto Galimberti: La terra senza il male, Jung: dall'inconscio al simbolo
Monet: Mon Histoire
47
RELAZIONE DI INFORMATICA
Insegnante Alfano Silvio
La programmazione di informatica prevedeva il completamento del linguaggio c++, iniziato lo
scorso anno e non completato per questione di tempo, perciò si è provveduto a completare la parte
che sarebbe stata propedeutica al programma da svolgere. Si è accennato alle memorie e al loro
indirizzamento per poi passare al cuore del corso incentrato sul linguaggio HTML5 con i relativi
fogli di stile per creare pagine web e la programmazione lato cliente in Javascript e lato server in
PHP.
Dopo verifica si è visto che la classe era disomogenea per quanto riguarda la programmazione,
infatti alcuni presentavano delle carenze, si è notato però un netto miglioramento della classe nella
parte relativa all’ HTML, non essendo un vero e proprio linguaggio di programmazione strutturato.
Il problema si è ripresentato quando si è parlato di programmare il client ed il server per ottenere
pagine dinamiche perché pur avendo studiato il linguaggio c++, potenzialmente utile a tale scopo,
avendo usato linguaggi affini ma pur diversi, sarebbe stato necessario un maggior numero di ore di
lezione per chiarire ogni dubbio.
Il programma nella parte finale è stato quindi ridotto per i problemi sopra esposti. A questo bisogna
aggiungere che è stato necessario dare spazio al modulo CLIL in co-presenza dell’ insegnante del
potenziamento di inglese ( 10 ore di lezione). Il corso è stato incentrato su argomenti teorici già
affrontati lo scorso anno e approfonditi in questa sede, il cui obiettivo è stato non solo il
potenziamento della lingua straniera ma l’apprendimento interculturale e interdisciplinare sulle
tecnologie informatiche .
Un ulteriore problema è dovuto al fatto che le ore di laboratorio hanno portato via molto tempo
perché non essendo prevista la figura dell’insegnante di laboratorio, è stato necessario risolvere
problemi hardware e software, di volta in volta per ogni gruppo di lavoro.
Gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche ed il loro
comportamento e stato sempre rispettoso nei confronti del docente.
Nel complesso gli obietti prefissati sono stati raggiunti con un eccellente grado di preparazione per
alcuni e più modesto per altri, cioè avendo acquisito competenze e competenze trasversali
relativamente alla materia di insegnamento.
48
PROGRAMMA DI INFORMATICA
Insegnante Silvio Alfano
Testi utilizzati: LORENZI /GOVONI - INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE PER
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE - ATLAS
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si presenta generalmente disponibile all'apprendimento durante le ore di lezione. Alcuni
allievi hanno assimilato ed approfondito, anche ad altissimo livello, gli argomenti svolti lo scorso
anno mentre altri necessitano di una rivisitazione degli argomenti relativi alla programmazione e
tendono ad uno studio mnemonico e ripetitivo. La rielaborazione personale degli argomenti svolti in
classe avviene in alcuni casi con grande fatica.
OBIETTIVI TRASVERSALI
capacità di utilizzare in completa autonomia i materiali didattici messi a disposizione e di
decodificarne il linguaggio tecnico;
- acquisizione di un metodo di analisi del testo volto ad evidenziare nodi concettuali e nozioni
significative, così da costruire percorsi logici per l'esposizione orale, che va sottratta alla casualità
e alla frammentazione tipiche dell'apprendimento basato solo sullo sforzo mnemonico;
- acquisizione della capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto e di usare con
proprietà la terminologia specifica di ogni argomento disciplinare.
- acquisizione della capacità di esprimersi in lingua inglese in specifici contesti tecnici
-
METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Si attueranno:
- lezioni frontali, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali dei singoli argomenti;
- esercitazioni;
- attività guidate in cui lo studente è condotto all'acquisizione di un concetto o di un'abilità
attraverso il lavoro di analisi; - attività di gruppo e a coppie;
- confronto collettivo dopo il lavoro di gruppo;
- momenti di verifica;
- attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati.
Si ricorrerà in particolar modo ad una didattica laboratoriale incentrata sull'operatività degli
studenti, sul loro saper fare, sulle strategie della scoperta.
Gli strumenti di verifica vengono distinti in:
- verifiche "formative ", relative al processo di apprendimento, in cui si ricorre anche a metodi di
registrazione informali;
- verifiche "sommative", che accertano il livello di abilità raggiunto, sulla base degli standard
minimi fissati per ogni modulo e degli obiettivi trasversali, in cui ci si ricorre ad una misurazione
formalizzata.
49
Si utilizzeranno a seconda delle necessità:
- prove scritte non strutturate per la rilevazione delle abilità più complesse e come sintesi di più
abilità; - prove semistrutturate;
- prove strutturate, prevalentemente per la misurazione del livello di raggiungimento di obiettivi più
specifici, soprattutto di conoscenza, comprensione ed applicazione;
- prove orali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe, per la verifica delle abilità di
comunicazione e per il controllo dei processi di apprendimento e di organizzazione dei contenuti.
METODOLOGIA CLIL
Alcuni moduli del programma sono stati svolti utilizzando la metodologia CLIL ( Contend and
Language Integrated Learning), cosi come descritto in sede di consiglio di classe per ottemperare
alle nuove indicazioni di legge. Alcune lezioni sono state svolte dai docenti di informatica e di
inglese che hanno lavorato in compresenza utilizzando ore aggiuntive dell’ insegnante di inglese.
In queste lezioni l’inglese è stato usato come strumento per apprendere. L’ausilio di video in
lingua inglese , opportunamente scelti per chiarezza, sinteticità della trattazione e facilità di ascolto,
hanno permesso un riferimento a materiale autentico. In sintesi, il contenuto di informatica è stato
introdotto attraverso materiale linguistico autentico, mettendo al centro dell’azione educativa i
bisogni linguistici e di apprendimento degli studenti.
ATTIVITA DI RECUPERO
Si mette in conto di effettuare interventi di recupero utilizzando parte dell’orario curricolare a tale
scopo. In particolare si prevede di utilizzare il lavoro di gruppo in laboratorio per gestire
contemporaneamente l'attività di recupero e quella di promozione delle eccellenze.
CONTENUTI
MODULO 1: Memorie ed indirizzamento.
Scema generale di un banco di memorie e relativi segnali. Classificazione delle memorie.
Memorie dinamiche e memorie statiche. Memorie sincrone ed asincrone. Capacità e
parallelismo. Diagrammi di tempificazione. Indirizzamento con il processore.
Schemi di interfacciamento memoria processore.
MODULO 2: Reti Internet (metodologia CLIL)
Aspetti evolutivi delle reti. I servizi per gli utenti.
Componenti di una rete, reti client server e peer to peer.
Classificazione delle reti per estensione: LAN, WAN, Intenet. Topologia di reti.
Internet ed extranet.
La sicurezza: firewall, tunneling, VPN.
Gli standard digitali per le reti pubbliche:ADSL
MODULO 3: Reti e Protocolli
Componenti di una rete, reti client server e peer to peer, topologia fisica e logica, protocollo
Ethernet.
Indirizzamento IP, protocolli di rete, modello a livello TCP/IP.
Servizi DNS e DHCP, concetto di default gateway.
Uso del programma Packet Tracer per la simulazione di reti.
50
MODULO 4:
Internet: comunicazione e servizi web
Storia di Internet. Internet ed Extranet.
Indirizzi internet con IP statico e IP dinamico. Il DSN.
I servizi di internet. Pagine statiche e pagine dinamiche.
Il ruolo del client e del server dal punto di vista hardware e software. Il browser e il server web.
I motori di ricerca.
La comunicazione: posta elettronica;Messaging Istant e chat; Videoconferenza e VoIP.
Il web 2.0 e social network
Il cloud computing. La sicurezza. Internet sui dispositivi mobili.
MODULO 5: Progettazione di pagine web
Il linguaggio HTML caratteristiche ed suo utilizzo. Struttura di una pagina html, tag ed attributi.
Uso dei tag: title, body, h1….h6, p, img, a, br. Uso degli attributi src, alt, href, weight, heigth.
Sistema RGB per l’attribuzione dei colori.
Uso del software Notepad++ per la creazione di pagine html.
MODULO 6: HTML e CSS per la creazione di layout
Tag div e attributi id e class. Fogli di stile a cascata in linea, incorporati e collegati.
Creazione di un sito composto da alcune pagine collegate tra loro con layout a due colonne e barra
di navigazione sinistra impostato con l’utilizzo dei CSS.
Layout di pagina a più colonne di tipo fluido, elastico e con posizionamento degli elementi assoluto
o float.
MODULO 7: Form e pagine web dinamiche
Form e loro utilizzo con elementi input e select. Tipi di input: casella di testo, password, checkbox,
radio, submit. Il linguaggio PHP per gestire i dati raccolti da form: metodi post e get per il
trasferimento dei dati e utilizzo di corrispondenti vettori associativi.
Linguaggio PHP : variabili semplici ed array, operatore di assegnazione, operatori aritmetici
e logici; istruzione si selezione if e switch, istruzioni di iterazione for e while; l’istruzione
echo.
Utilizzo del software Easyphp per simulare l’esecuzione su server del codice php prodotto.
Produzione di codice php per la gestione di un ordine: l’algoritmo conoscendo quantità e prezzi
calcola il conto.
51
RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA
Insegnante Tortora Francesca
La V A LSA è una classe che ho avuto il piacere di seguire per l’intera durata del corso di studi
superiori. Ha compiuto un percorso proficuo nell’ambito dell’educazione fisica che ha visto gli
alunni migliorare progressivamente sia sotto il profilo tecnico che motivazionale. Tutti gli alunni,
tranne rare eccezioni, hanno costantemente lavorato con metodo e partecipazione, manifestando
qualità e capacità al di sopra della media. I ragazzi hanno espresso un interesse costruttivo in
relazione ai contenuti della materia, e hanno colto gli stimoli didattici con profitto assai
soddisfacente. Nel corso degli ultimi anni i ragazzi hanno vissuto con entusiasmo anche
l’esperienza dei tornei sportivi scolastici, che ha visto coinvolta e partecipe anche e soprattutto la
componente femminile della classe, a volte svantaggiata dalle esercitazioni prettamente sportive
svolte in palestra. Abbiamo lavorato molto in funzione dell’educazione e del rispetto dei luoghi di
lavoro condivisi, del controllo e della canalizzazione dell’emotività, dell’accettazione dell’altro a
prescindere dalle sue capacità motorie e intellettuali. Anche sotto questo profilo mi ritengo assai
soddisfatta degli obiettivi raggiunti da tutti i ragazzi.
52
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
Insegnante Francesca Tortora
Finalità dell’insegnamento
·
Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
·
Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione .
·
Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico
di attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-tempo libero).
·
Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla
salute.
Obiettivi
Conoscenze
·
Conoscenza della terminologia disciplinare
·
Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto tecnico e sportivo
·
Conoscenza di alcuni argomenti teorici strettamente legati alla disciplina
Capacità
·
Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare).
·
Consolidamento degli schemi motori di base al fine del miglioramento delle capacità
coordinative.
Competenze
·
Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al
regolamento tecnico.
·
Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio
creativo e come vera e propria forma di comunicazione.
Verifica
L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di
apprendimento nonché la partecipazione e l’impegno nelle attività proposte.
53
PROGRAMMA DISCIPLINARE
Parte pratica
·
Esercizi di tonificazione generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi, nelle
varie stazioni.
·
Esercizi di destrezza e coordinazione generale
·
Attività di avviamento motorio gestite in autonomia.
·
Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto, tennis tavolo
·
Studio ed allenamento dei fondamentali individuali e di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio.
·
Partecipazione ai tornei d’Istituto di pallavolo.
54
RELAZIONE DI RELIGIONE
Insegnante Ercoli Simonetta
La classe 5A Lsa è composta da 20 alunni/e ( 8 femmine e 12 maschi).
Non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica una alunna e quattro alunni.
La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, disponibile al dialogo e ha utilizzato le
attività proposte come momenti di vera riflessione ed efficace confronto.
Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo.
PROGRAMMA
L’etica delle relazioni
L’etica della vita
L’etica della solidarietà
Il fatto religioso nella storia
I valori del cristianesimo
Religione e religioni
Religione e filosofia
55
MODULO CLIL-RELAZIONE FINALE
TITOLO: NETWORKS
DURATA: 8 ORE
Il modulo si è articolato in 5 incontri in co-presenza, che hanno avuto luogo nelle seguenti date:
22 febbraio (2 h)
7 marzo (1 h)
4 aprile (2 h)
11 aprile (2h)
2 maggio (1 h)
FINALITA': Potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere in una dimensione
interculturale e interdisciplinare. L'obiettivo principale è l'educazione plurilingue.
OBIETTIVI:
Organizzare un approccio innovativo dell'apprendimento, in quanto tentativo di superare i limiti
dei curricoli scolastici tradizionali, per migliorare l'integrazione curricolare e la conoscenza
"complessa" e "integrata" del sapere.
Creare uno strumento flessibile che permetta l'insegnamento per alcune lezioni durante l'anno
scolastico di un modulo parte di una materia.
Produrre uno strumento migliorativo che sviluppi la competenza della seconda lingua e le
conoscenze e le abilità nelle aree non linguistiche.
METODI:
Ascolto di 2 video in inglese con attività di listening comprehension.
Lezione frontale.
STRUMENTI Video, Internet, fotocopie.
STRUMENTI DI VERIFICA:
Valutazione della produzione scritta: al termine del percorso, agli studenti è stato sottoposto un test
(domande chiuse e aperte) atto a sondare le competenze linguistiche (da parte del docente di L2) e
concettuali (da parte del docente di materia).
Valutazione della produzione orale: è stata inoltre richiesta agli studenti l'esposizione orale in L2
dell' argomento trattato.
Particolare risalto è stato dato all'acquisizione della terminologia specifica.
56
TERZA PROVA (02/03/2016)
SCIENZE NATURALI
1)-Descrivere la struttura di un fosfogliceride e la sua funzione.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2)-Che cos’è l’isometria ottica e perché è importante in ambito biologico?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3)- Qual è il ruolo dell’RNA?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
57
FISICA
1)A quale fenomeno possono essere ricondotte le correnti di Focault?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................
2) Come è definita l’intensità di un’onda elettromagnetica?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
3) Che tipo di analogie si possono fare fra un circuito oscillante e il moto di una massa soggetta ad
una forza di Hooke?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
58
LINGUA INGLESE
1)Illustrate the role of nature in the main English poets.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Write a short paragraph about how the English novel develops in Pride and Prejudice and
Wuthering Heights.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) Describe the essential features of the Victorian Age.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
59
INFORMATICA
1)La rete internet e le applicazioni che vengono utilizzate da chi si collega alla rete,sono basate su
un’architettura client/server. Spiegare brevemente i due ruoli dal punto di vista hardware e software
e cosa sono i protocolli HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Illustrare brevemente la differenza tra pagine statiche e pagine dinamiche. Cosa significa
elaborazione lato client e lato server.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) Spiegare brevemente cosa si intende per sito internet (o web). Quale linguaggio viene utilizzato
per la formattazione delle pagine e come è strutturato un testo.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
60
TERZA PROVA (05/05/2016)
INFORMATICA
1)
Spiega cosa si intende quando,per un computer di un utente inserito in una rete, si parla di
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) e di DNS( Domain Name System).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) A cosa servono i fogli di stile a cascata CSS. Come possono essere utilizzati all’interno di un
documento HTML. Qual è la sintassi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Perché c’è l’esigenza di programmare il client oltre l’HTML. Cosa è uno “script”. ( Si parlava di
pagine dinamiche con elaborazione lato client e lato server)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
61
SCIENZE NATURALI
1) In che modo è possibile ottenere il DNA ricombinante in grado di produrre sostanze utili su
larga scala?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
2) Descrivere la struttura di un aminoacido e il suo comportamento in ambiente acido e in
ambiente basico.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3) Quali sono i meccanismi di regolazione dell’attività enzimatica?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
62
FISICA
data ___________
cognome nome _____________________
1) Perché la legge di composizione classica delle velocità perde significato in campo relativistico?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Perché applicando una forza costante non è possibile accelerare un corpo fino a superare la velocità
della luce?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Descrivere il diagramma spazio-tempo di Minkowski
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63
LINGUA INGLESE
Name:
Read the extract regarding Coketown from Hard Times by Dickens and illustrate the role and the
negative effects of industrialization.
It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed
it: but, as matters stood it was a town of innatural red and black like the painted face of a savage. It
was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke trailed
themselves for ever and ever, and never got uncoiled. It had a black canal in it, and a river that ran
purple with ill-smelling dye, and vast piles of building full of windows where there was a rattling
and trembling all day long, and where the piston of the steam- engine worked monotonously up and
down, like the head of an elephant in a state of melancholy madness.
Charles Dickens, Hard Times – Chapter 5
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Write a short paragraph illustrating the main themes of Aesthetic Movement and the figure of the
Dandy.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
64
With reference to Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray” consider the contents, the narrator
and the themes of the novel.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
65