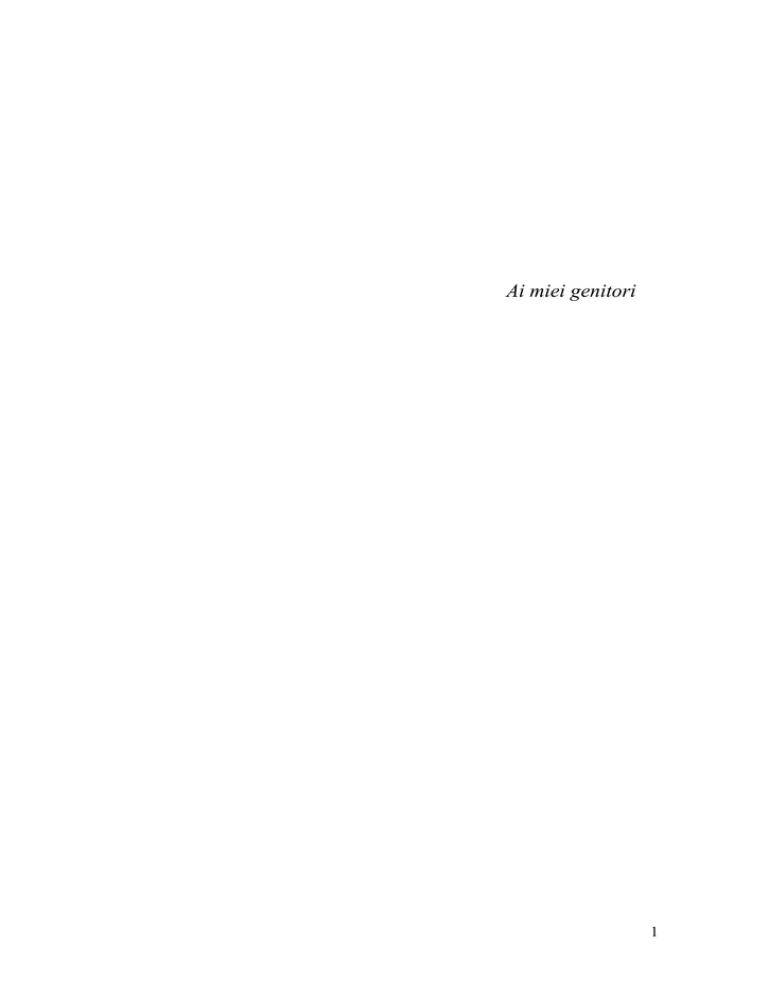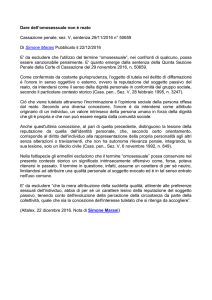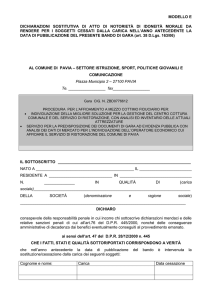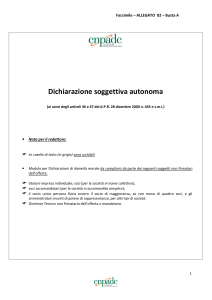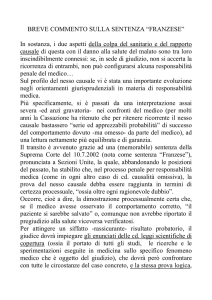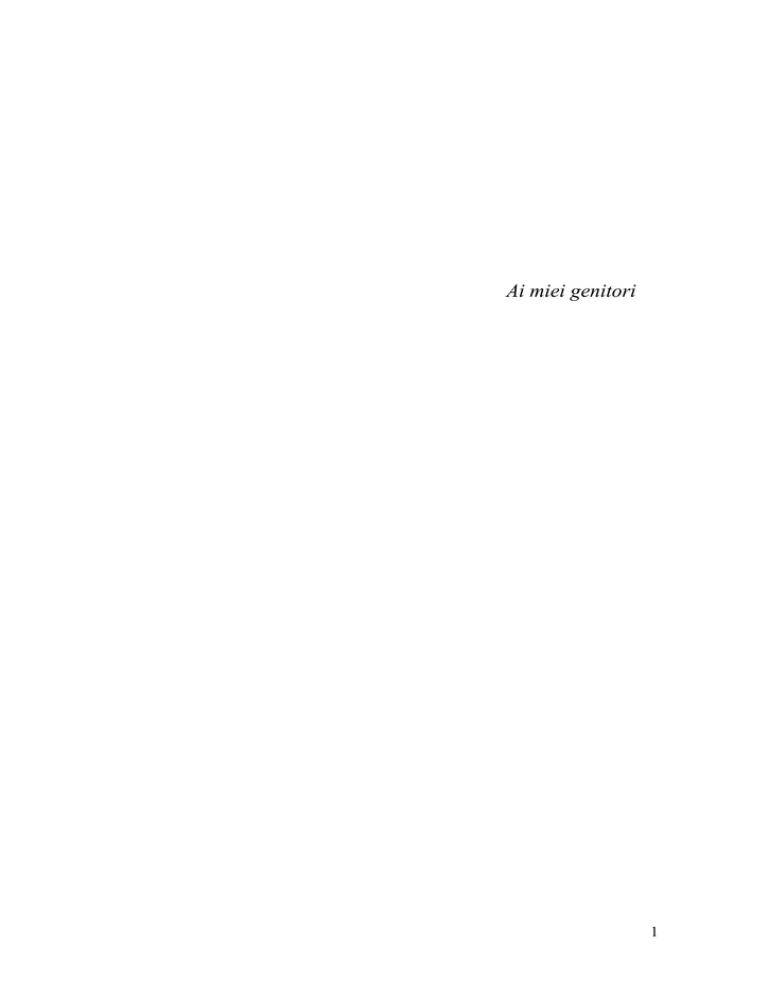
Ai miei genitori
1
Sommario
Sommario ............................................................................................................... 2
Introduzione........................................................................................................... 4
Capitolo I ................................................................................................................ 8
IL GIUDICATO PENALE ................................................................................... 8
1. La nozione di giudicato. ................................................................................. 8
2. L’essenza del giudicato penale. ..................................................................... 12
3. Il fondamento del giudicato penale. .............................................................. 17
4. La natura della cosa giudicata. ...................................................................... 22
5. L’autorità della cosa giudicata penale. .......................................................... 23
6. L’irrevocabilità. ............................................................................................. 26
7. I limiti dell’efficacia del giudicato penale. .................................................... 36
8. L’efficacia extrapenale del giudicato: ........................................................... 46
L’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno: b)
l’art. 651 c.p.p. .............................................................................................. 53
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno:
c) l’art. 652 c.p.p. .......................................................................................... 60
L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare: d) l’ art. 653
c.p.p. .............................................................................................................. 66
L’efficacia della sentenza penale in altri giudizi civili : e) l’art. 654 c.p.p. . 70
9. Il giudicato « convenzionale »....................................................................... 72
Capitolo II ............................................................................................................ 83
IL NE BIS IN IDEM............................................................................................ 83
1. Ratio e funzione del divieto........................................................................... 83
2. Provvedimenti aventi efficacia preclusiva..................................................... 90
3. L’identità del fatto. ...................................................................................... 100
3.1. La nozione di “fatto” ex art. 649 c.p.p................................................. 100
3.2. Condotta, evento e nesso di causalità secondo la teoria generale del
reato............................................................................................................. 107
3.3. Medesimo fatto. .................................................................................... 110
3.4. Titolo, grado e circostanze. .................................................................. 113
4. L’identità della persona. .............................................................................. 116
5. Le eccezioni apparenti al divieto. ................................................................ 118
6. La rilevabilità del ne bis in idem. ................................................................ 121
Capitolo III......................................................................................................... 124
NE BIS IN IDEM E FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO........ 124
1. Premessa. ..................................................................................................... 124
2. Il concorso di reati. ...................................................................................... 124
3. Il reato complesso........................................................................................ 131
4. Il reato progressivo. ..................................................................................... 137
5. Reato abituale. ............................................................................................. 142
2
6. Il reato permanente...................................................................................... 150
7. Il reato continuato. ...................................................................................... 157
7. Reato realizzato alternativamente da più condotte fungibili la cui somma non
importa concorso di reati................................................................................. 174
7. a)Reati di bancarotta. ............................................................................. 175
7. b) 1. Fatto antecedente e successivo non punibile.................................. 179
b) 2. Caratteri comuni dei fenomeni in esame. ........................................... 181
b) 3. Differenze con il reato progressivo. ................................................... 182
b) 4. Problemi relativi al diritto processuale: applicabilità del ne bis in idem
nei casi di antefatto e postfatto non punibili............................................... 185
Conclusioni. ....................................................................................................... 187
Bibliografia ........................................................................................................ 190
3
Introduzione
Ne bis in idem: nessuno può essere sottoposto a processo più di una volta per lo
stesso fatto. Questa sembra essere la definizione, al tempo stesso più semplice e
corretta, del ne bis in idem, antica formulazione latina che letteralmente significa:
“divieto di fare due volte la stessa cosa che riguardi la medesima questione”.
Come si può ben capire, questo principio era conosciuto fin dall’epoca del diritto
romano, e in particolare, già al tempo delle legis actiones, si parlava di bis de
eadem re ne sit actio, col quale si affermava che un diritto, una volta che fosse
stato anche solo in iudicium deductum e, anche se non ancora iudicatum, non
avrebbe più potuto costituire oggetto di un nuovo procedimento. Il suo campo di
applicazione, è da sempre stato quello del processo: civile, penale,
amministrativo.
Oggi, sicuramente non si sbaglia se si afferma che esso rappresenti uno tra i più
evidenti indici di uno stadio avanzato di civiltà giuridica. Il divieto del ne bis in
idem, in particolare, è tipico di un sistema accusatorio, il quale, come sappiamo,
prevede che vengano rispettati certi termini, tempi e forme, di cui esso è risultato
a ciò conseguente e quasi necessario. Nel metodo inquisitorio classico, invece,
ogni conclusione è perfettibile, ad infinitum; e dove manchino premesse adeguate
alla condanna, vengono fuori soltanto conclusioni provvisorie e, «l’absolutus ad
abservatione iudicii» rimane comunque, perseguibile.
Il principio del ne bis in idem, è stato accolto nel nostro sistema processuale
penale, sin dal primo codice di rito unitario del Regno d’Italia, ossia, sin dal
codice del 1865, e così, in seguito, è stato successivamente, riaffermato nei codici
del 1913, 1930, fino ad arrivare all’ultimo codice di procedura penale vigente,
cristallizzandosi, in particolare, all’interno della disposizione dell’art. 649 c.p.p.,
che dispone: «L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale
divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale
per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, grado e circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2 e
345».
4
Ora, l’obiettivo che ci proponiamo, è proprio quello di operare un’analisi, attenta
e capillare dell’art. suddetto, per cercare di individuarne il fondamento, capire su
quali basi su esso poggia, qual è la sua ratio.
Tutto ciò, evidentemente, non può prescindere da un breve excursus storico, circa
le origini e successive modificazioni e adattamenti che esso ha conosciuto, fino ad
arrivare all’attuale disciplina nel codice di procedura penale vigente. Qui,
pertanto, si comincerà proprio col guardare alla collocazione sistematica che il
legislatore gli ha riservato, per poi guardare in concreto quali sono i
provvedimenti cui esso si riferisce e soprattutto, quale significato dare ai concetti
di “medesimo fatto” e “medesima persona”, i quali, certamente rappresentano il
punto centrale per proseguire nella nostra indagine. Infine, prenderemo in
considerazione anche quelle che sono le eccezioni e limiti che il legislatore ha
previsto alla sua applicabilità e operatività.
In tutto ciò, ovviamente, cercheremo di seguire le principali teorie e orientamenti
interpretativi e applicativi formulati in dottrina e giurisprudenza nel susseguirsi
degli anni.
Il primo capitolo, in particolare, tratterà più da vicino il giudicato, da cui
evidentemente non si può prescindere. Il ne bis in idem, infatti, è un effetto del
giudicato e, anzi, secondo qualcuno, esso costituisce in assoluto, l’unico effetto
del giudicato penale. Ora, sulla scorta di questa teoria, evidentemente, il rischio
che si corre è proprio quello di confondere i due istituti o meglio, di sovrapporli:
ma così facendo – si è detto- si finisce per scambiare l’effetto con la causa. Il ne
bis in idem mira, infatti, a garantire non quella certezza oggettiva consistente nel
fatto che si possa prevedere in anticipo la valutazione giuridica dei comportamenti
possibili, bensì una certezza meramente soggettiva, in quanto il giudicato penale,
così delineato nell’art. 649 c.p.p., costituirebbe « un espediente pratico che sottrae
il singolo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale». Da
qui, la distinzione tra c.d. giudicato sostanziale e giudicato formale, di cui si
tratterà più ampiamente sempre nel primo capitolo, in cui, cercheremo, tra l’altro,
di individuarne l’essenza, la natura, i limiti e l efficacia che da esso ne derivano e,
più in particolare si prenderanno in esame i due concetti chiave di “autorità di
cosa giudicata” e “irrevocabilità” delle sentenze, dai quali sembrerebbe, proprio,
5
discendere l’operatività del ne bis in idem. L’auctoritas della cosa giudicata
penale imporrebbe, infatti, quale vincolo “negativo”, la preclusione di qualsiasi
nuovo giudizio de eadem re: in altre parole, esso obbliga i giudici a non
pronunciarsi nuovamente in ordine alla questione già decisa, qualora il successivo
giudizio riguardi lo stesso fatto e la stessa persona.
In ultimo, spostandoci su un piano più propriamente operativo, ci si propone di
vedere come, il suddetto divieto in esame, venga, concretamente, applicato.
Perché, se è vero quanto si è detto finora, ossia che, divieto di un secondo
giudizio, implica il fatto che un soggetto, condannato o prosciolto in un
precedente giudizio, per un determinato fatto di reato, non possa più essere
sottoposto ad un nuovo procedimento penale, per quello stesso fatto; c’è allora, da
chiedersi: come opera questo istituto rispetto a forme di manifestazione del reato
strutturalmente complesse e articolate, quali il concorso di reati, il reato
complesso, reato progressivo, abituale, permanente e continuato? e quale,
l’operatività del ne bis in idem, rispetto a ipotesi di reati, realizzati
alternativamente da più condotte fungibili, le quali, però, non danno luogo a
concorso di reati (ad esempio, reati di bancarotta, o le fattispecie, così chiamate
dalla dottrina, di fatto antecedente e successivo non punibili)? Perché è chiaro che
rispetto ad ipotesi di reato semplice, l’operare del ne bis in idem
non crea
particolari problemi. Ma, quello che, invece, noi ci chiediamo è questo: cosa
succede se, dopo che un soggetto sia stato condannato o assolto per uno dei reati
da lui commessi in concorso con altri, questi ultimi vengano scoperti, soltanto
dopo che ci sia stata sentenza su quei fatti precedentemente dedotti in giudizio?
Oppure, cosa succede, se dopo una sentenza di condanna,
pronunziata nei
confronti di una persona ritenuta colpevole di aver violato più volte la stessa
disposizione di legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, vengano
scoperte altre infrazioni della stessa disposizione, commesse dall’identico autore,
ancor prima della sentenza e, sempre in esecuzione di quello stesso progetto
criminoso
(del
quale erano
espressione
anche quelle altre violazioni
precedentemente accertate e per le quali l’autore era stato già giudicato)?
Dovranno, queste, esser considerate assorbite nella precedente sentenza oppure
dovrà, l’autore essere sottoposto ad un nuovo e autonomo procedimento? E,
6
accertata questa seconda alternativa, l’imputato, già una volta condannato, sarà
giudicato come se la nuova serie criminosa fosse del tutto indipendente dalla
precedente e perciò condannato ad una nuova ed autonoma pena sia pure nei limiti
di cui agli artt. 71 e ss. (richiamati dall’art. 81 c.p.)? e ancora, cosa significa
“medesimo fatto”, rispetto all’ipotesi di reato complesso o permanete, piuttosto
che abituale, e così per tutte le altre ipotesi di manifestazione di reato da noi prese
in esame?
7
Capitolo I
IL GIUDICATO PENALE
1. La nozione di giudicato.
Giudicato, o più precisamente, cosa giudicata, letteralmente significa: ciò su cui è
caduta la decisione del giudice; esprime, dunque, una « entità passata, fissa, ferma
nel tempo, a cui corrisponde in chiave di attualità ciò che è oggetto del giudizio»;
inoltre, è opportuno osservare, come « la determinazione del concetto con
l’adozione del participio passato fa subito pensare a qualcosa che è stato
realizzato, ma che è tuttora rimasto e per di più in posizione statica, fissa e perciò
non più mutabile».1
Con tale formula, si esprime la regola secondo la quale, lo svolgimento del
processo e la sentenza che lo definisce, impedisce che un altro processo possa
essere instaurato intorno alla stessa lite; in quanto, produce un effetto
(l’inammissibilità di una nuova azione de eadem re) rispetto alla stessa res dedotta
in giudizio.
Secondo la concezione corrente, il processo penale è sostanzialmente strutturato
su due momenti estremi ed opposti : l’inizio e la fine; il processo deve essere
ispirato ad un fine e soprattutto, tendere ad un fine: il fine è la risoluzione per
opera della giurisdizione, di una lite2.
In realtà, è la stessa fisiologia interna del processo penale a condurre gli atti,
che costituiscono e cadenzano il suo iter ordinario, verso un dictum definitivo ed
irrevocabile.
In questo il diritto mostra, come non mai, il suo esclusivo ed indissolubile
legame con le esigenze, i valori e le azioni dell’uomo. Sono gli uomini, prima di
tutto, che hanno bisogno di assicurare, ad un dato momento, certezza e stabilità
1
2
Leone, G., Manuale di diritto processuale penale, Jovene editore, Napoli, 1988, p.731.
Leone, G., Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988, p. 732.
8
alle situazioni giuridiche acquistate con l’esito del processo, questo sia
nell’interesse dell’individuo, che rinviene nella decisione intangibile la sicurezza
dei propri diritti (primi tra tutti la libertà), sia nell’interesse della società, che vi
trova il rispetto dell’ordinamento dopo la commissione del reato. A tale scopo,
l’ordinamento
processuale
penale
vuole
assicurare
e
salvaguardare
l’incontrovertibilità dell’accertamento giudiziario attraverso la costruzione di un
sistema normativo che da una parte, determina in modo specifico e progressivo i
mezzi di impugnazione consentiti e, dall’altra parte, garantisce stabilità e certezza
al dictum definitivamente prodottosi3.
Di cosa giudicata il codice di procedura penale, non parla mai esplicitamente, a
differenza del codice civile (art. 2909 c.c.) e del codice di proc. civ. ( art. 324
c.p.c.); ma nessuno dubita che il processo penale, come il processo civile e, forse
più dello stesso processo civile, tenda alla cosa giudicata. Il concetto di giudicato
penale è, tuttavia, costruito sulla base di una serie di disposizioni, le più
importanti sono l’art. 648 cp.p. che definisce la sentenza irrevocabile e, l’art. 649
c.p.p., che disciplina uno degli effetti del giudicato : il divieto di bis in idem; o,
meglio, per qualcuno, l’unica manifestazione esclusiva del giudicato penale.
Per cominciare, si può far riferimento a quella che è la sua collocazione
sistematica all’interno dell’attuale codice di procedura penale : «Da un esame
delle singole disposizioni del titolo I del libro X del c.p.p. emerge chiaramente,
però, come con la locuzione “giudicato” non si sia inteso fare riferimento ad un
preciso e omogeneo istituto giuridico, ma si è voluto adoperare in senso generale
un’espressione in cui farvi rientrare una pluralità di concetti.
Il legislatore, infatti, ci ha dato una nozione onnicomprensiva di “giudicato” che
viene ad indicare un vincolo dei privati e delle autorità pubbliche ad un precetto di
matrice giudiziaria, costruito per un caso concreto, che impone l’obbligo delle
parti di eseguirlo senza poterlo ulteriormente contestare; la preclusione, per lo
stesso o qualsiasi altro giudice futuro di fronte al quale sia riproposto l’ idem
factum nei confronti dell’ eadem persona a pronunciarsi sul merito; e inoltre, il
dovere di determinati giudici di usarlo come regola del decidere».4
3
4
Callari, F., La firmitas del giudicato penale,Giuffrè, Milano, 2009, p. 4.
Callari, F., La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, cit., p.6.
9
Bisogna interrogarci, a questo punto, sul significato di giudicato; e, per fare
questo, occorre partire con l’operare una importante distinzione terminologica tra
due concetti, apparentemente equivalenti, ma che in realtà, presentano degli
elementi di differenza: giudicato e cosa giudicata.
La parola giudicato, costituisce la traduzione letterale del vocabolo latino
“iudicatum”, che esprime il dictum immutabile del giudice, ossia sta ad indicare
la decisione definitiva ed irrevocabile emessa da parte dell’organo giurisdizionale.
Se volessimo fare un breve excursus storico dell’evoluzione storica di questo
istituto, si può ben vedere che, in origine, e più precisamente nel diritto romano di
età repubblicana, la sentenza, per il solo fatto di essere venuta ad esistenza,
determinava immediatamente il sorgere del
giudicato; poi, a seguito
dell’evoluzione dell’ordinamento processuale e la comparsa del giudizio di
appello, si è progressivamente affermata l’idea per la quale, non si ha giudicato,
al momento della mera emissione della sentenza, ma soltanto a seguito del
compiuto esperimento dei mezzi di impugnazione consentiti: è questo l’esatto
momento in cui si dice che la sentenza “passa in giudicato”. Questa innovazione
ha avuto una portata straordinaria perché, da questo momento in poi, «
nell’istituto della intangibilità del dictum penale, si sono venuti a distinguere due
profili che fino ad allora erano sostanzialmente coincidenti nella irretrattabilità del
risultato del processo: l’irrefragabilità del giudicato, che attiene alla irrevocabilità
della sentenza e il generale divieto di bis in idem»5.
“ Cosa giudicata” invece, deriva dalla espressione latina “res iudicata”. Nel
diritto processuale romano, possedeva uno specifico significato tecnico: essa
indicava, infatti, la situazione fatta valere in giudizio dall’attore e contestata dal
convenuto e che, attraverso il processo, veniva sottoposta al giudice e da questi
decisa in modo definitivo. E dunque, in ambito penale, la cosa giudicata
costituiva la materia del giudizio.
Sarà soltanto successivamente, e in particolare durante l’esperienza giuridica del
diritto intermedio, quando, a seguito dell’introduzione dei mezzi di impugnazione
del dictum del giudice, alle due espressioni concettuali originarie, si affiancò un
ulteriore elemento di distinzione, divenendo la res iudicata l’oggetto e il
5
Callari, F., La firmitas del giudicato penale, essenza e limiti, cit., p. 10-11
10
contenuto proprio soltanto della sentenza non più appellabile, ossia passata in
iudicatum.
Successivamente, durante il medioevo, nella esperienza giuridica dello ius
commune, si mantenne ferma da parte di alcuni doctores civilisti, l’idea che il
giudicato nascesse contestualmente alla emanazione della sentenza; essi avevano
come punto di riferimento, il diritto processuale romano vigente in età
repubblicana, e partendo da questo, ritenevano, come appunto si faceva allora, che
di fronte a una sentenza che fosse formalmente perfetta, cioè che fosse il risultato
di un procedimento corretto, acquisiva, nel momento stesso della pronuncia per il
solo fatto di essere stata emanata, il valore di giudicato.
Tutto ciò, era chiaramente il portato di una concezione propria dei giuristi dello
ius civile in quell’epoca, i quali, evidentemente, non erano ancora pronti a pensare
ad una sentenza che prima si forma, e poi successivamente, passa in giudicato;
anzi, al contrario, essi sostenevano fortemente che appunto, non ci fosse
differenza tra giudicato e sentenza, almeno da un punto di vista sostanziale. Tali
giuristi dicevano: « la realtà materiale è sempre la stessa, cioè la sentenza, e ciò
che cambia[va] è solo la sua qualificazione giuridica». In altri termini,” sententia
transit in nomen rei iudicatae”, cioè, « il passaggio in giudicato è un passaggio
meramente terminologico, come se si tratti del passaggio della decisione dal nome
di sententia al nome di res iudicata».6
Poco più tardi, grazie alla riflessione giuridica di Bartolo da Sassoferrato, grande
giurista, vissuto nella prima metà del 1300, si arrivò, finalmente, ad affermare che
la sentenza, avrebbe assunto l’efficacia di res iudicata soltanto quando fosse
divenuta irretrattabile, o perché non era stata prontamente impugnata o, perché
fosse stata esaurita la serie dei possibili reclami.
Questa concezione, poi, fu presa a riferimento da parte della Pandettistica tedesca,
e in particolare da Savigny, il quale, nella prima metà del XIX secolo, giunse a
distinguere tra le condizioni di cosa giudicata, quelle “sostanziali”e quelle
“formali” e sulla scia di questa interpretazione, si arrivò a una più raffinata
distinzione: cosa giudicata formale, con la quale si intendeva l’irrevocabilità della
6
Callari, F., La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, cit., p. 10-14.
11
pronuncia del giudice e, cosa giudicata sostanziale, la quale, invece, rappresenta,
la generale efficacia vincolante dell’accertamento giudiziario definitivo.
Questa
distinzione,
frutto
dell’elaborazione
concettuale
della
dottrina
processualista tedesca, fu ben presto accolta anche dalla dottrina e giurisprudenza
italiana. Già nel c.p.p. del 1930, troviamo le due accezioni di cosa giudicata,
anche se non indicate in modo esplicito: la prima era contenuta nell’art. 576 c.p.p
abr. e la seconda all’interno della disposizione dell’art. 90 c.p.p. abr.; e, tuttora,
all’interno del codice di procedura penale vigente, troviamo, negli artt. 648 e 649
c.p.p., riconfermata questa distinzione tra i due concetti, ma questa volta previsti
esplicitamente e, soprattutto, disciplinati in modo distinto.
2. L’essenza del giudicato penale.
Innanzitutto, il giudicato presuppone l’esistenza di una decisione e di un processo
anteriore; ma non basta, occorre che essa promani da un giudice penale e che sia
reso nell’esercizio della giurisdizione penale7. Il giudicato, in linea generale,
comporta un duplice effetto:
In primo luogo, implica che la sentenza diviene incontestabile in giudizio ad opera
delle parti; rispetto ad esso, infatti, le parti si vengono a trovare in una posizione
in cui risultano essere privi di ulteriori poteri processuali per proseguire il
processo o per istaurarne uno nuovo sul medesimo oggetto; non occorre, perciò,
configurare nei loro confronti uno specifico divieto che gli impedisce di
contestare la sentenza, bastando la constatazione che la legge non dà loro nuovi
poteri per farlo.8 A tal proposito, qualcuno afferma che il giudicato penale, sotto
il profilo più strettamente giuridico, deve essere inteso come (l’unica) causa di
estinzione della azione penale.9
In secondo luogo, e correlativamente al primo punto, abbiamo che la suddetta
sentenza passata in giudicato diviene intoccabile, da parte del giudice che l’ha
emessa, e da qualsiasi altro giudice; e anche in questo caso si può osservare che
7
Guarnieri, G., Regiudicata ( Dir. proc. pen. ), p. 229-234.
Lucarelli, U. L’istitiuto del giudicato: il giudicato penale e i suoi effetti civili, UTET, 2006, p.1.
9
Leone, G, Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988, p. 736.
8
12
tale effetto si realizza non a seguito di un divieto specifico, ma per semplice
mancanza di poteri in tal senso: ” nemo iudex sine actore”.10
Ora, per far sì che si producano tali effetti, il legislatore ha dotato il nostro sistema
processuale di due mezzi tecnici: la cosa giudicata formale e la cosa giudicata
sostanziale; è questa una distinzione che nasce nell’ambito della dottrina
processualcivilista, ma che trova pieno fondamento anche nel processo penale; «
la prima rappresenta l’efficacia del giudicato fuori dal processo, mentre la
seconda, esplica i suoi effetti dentro il processo, e cioè rispetto a ogni altro
giudice, il quale, laddove un primo giudice abbia già giudicato, non può più
tornare a giudicare»11.
Più analiticamente:
Giudicato sostanziale, è il comando giuridico stabilito dal giudice, e più
precisamente, nel processo penale altro non è che l’accertamento del fatto, dotato
dei caratteri di ufficialità, incontestabilità e autorità propri della funzione
giurisdizionale.
Vincenzo Manzini12 osservava che questo attributo della “intangibilità” del
giudicato non deriva, come affermava, invece, Calamandrei, da una “presunzione
di esattezza e dalla forza persuasiva della motivazione logica della sentenza”, ma
piuttosto, dal fatto che la sentenza in quel certo momento (passaggio in giudicato),
“costituisce, come la legge di cui è individuazione, un atto ufficiale di volontà,
cioè un comando di autorità”, anzi, secondo qualcun’altro13, è una “norma che in
efficacia supera persino la legge, in quanto, accerta il dovere di punire”.
Il provvedimento che contiene tale accertamento giudiziale, prende il nome di
giudicato c.d. formale nel momento in cui acquista carattere di irrevocabilità, una
volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari oppure scaduti i termini
perentori per la loro proposizione. (art. 648 c.p.p.). Ma al di là di questa
distinzione formale, nella sostanza, entrambi rappresentano due aspetti della
stessa realtà, tutte e due, cioè, mirano a salvaguardare l’intangibilità del risultato
del processo e, in particolare: la prima vuole impedire la possibilità di avere,
10
Lucarelli, U. L’istituto del giudicato, Il giudicato penale e i suoi effetti civili, cit., p. 1-2.
Carnelutti, F.Lezioni sul processo penale, vol.I, Milano 1949, p. 123-61.
12
Manzini V., Istituzioni di procedura penale, Padova, 1946, p. 324 ss.
13
Cordero, F., Guida alla procedura penale, Torino, 1986, p. 216.
11
13
nell’ambito dello stesso processo, una pluralità almeno ipoteticamente infinita di
sentenze, tutte sullo stesso oggetto; la seconda mira a impedire una illimitata
pluralità di processi de eadem re.
Come è stato giustamente osservato, se non si ponesse un limite al potere di
impugnazione o si desse al giudice la possibilità di revocare in qualunque
momento la sentenza emanata, l’imputato sarebbe esposto al rischio di essere
sottoposto a una irragionevole e illimitata possibilità di reiterazione di sentenze
sullo stesso oggetto, con grave pregiudizio alla sicurezza dei diritti.14
Ma premesso ciò, va fatta un’altra precisazione, altrettanto importante: il formarsi
del giudicato in senso formale, una volta raggiunta l’irrevocabilità della sentenza,
da solo non basta a garantire la incontestabilità del risultato del processo
contenuto nella sentenza, in quanto, è facile comprendere come tale garanzia
verrebbe ad essere nullificata dalla possibilità che la stessa lite o lo stesso fatto,
rispetto al quale l’imputato è stato condannato o prosciolto, potesse essere
nuovamente oggetto di un diverso procedimento e, di conseguenza, potesse essere
sottoposto di nuovo ad accertamento da parte di un giudice diverso: è, dunque, a
questo punto che entra in gioco la cosa giudicata sostanziale.
Carnelutti, distingueva due profili dell’auctoritas iudicati: l’imperatività e la
immutabilità. Egli riteneva che fosse più una ragione pratica a esigere che a un
certo punto il giudizio del giudice acquisti forza di comando. « Il comando –
diceva- nasce dal giudizio, anzi il giudizio non è giuridico se non matura nel
comando; ciò accade almeno per quel giudizio che mette fine al processo (…) Ciò
deve accadere e se non accadesse il processo non servirebbe a nulla; se, il giudizio
del giudice potesse essere mutato, mancherebbe del suo scopo, che è quello di
stabilire la certezza.15». Ma dall’altra parte, riteneva che, l’imperatività del
giudizio non implicasse affatto la sua immutabilità, né tantomeno bastava a
soddisfare le esigenze di certezza; proprio per questo si è giunti ai due profili della
imperatività e immutabilità del giudizio, nel senso che, normalmente si ritiene che
il giudicato non è imperativo se non è immutabile e, non è immutabile se non è
14
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato penale: il giudicato penale e i suoi effetti civili, UTET,
2006, p.3-5.
15
Carnelutti, F., Lezioni sul processo penale, I, 1949, p. 122-61.
14
imperativo.16
Lo stesso Autore affermava che, « l’espressione della natura
contenziosa del processo è la cosa giudicata» e «per virtù del giudizio pronunciato
dal giudice, la res in iudicium dedicta, diventa iudicata; così, la cosa giudicata
esprime il valore imperativo del giudizio». Egli, addirittura, riteneva di dover
equiparare il giudizio del giudice a quello del legislatore, « per cui la res iudicata
equivale a una lex specialis», ma con una differenza sostanziale: in quanto, la cosa
giudicata altro non è che « un accertamento della legge, cioè la risoluzione di una
incertezza intorno alla applicazione della legge, la cosa giudicata implica, dunque
la sua immutabilità »; questi, due aspetti della cosa giudicata, l’imperatività e
l’immutabilità del giudizio, sono in altre parole quello che noi abbiamo definito
con l’espressione di cosa giudicata formale e cosa giudicata in senso sostanziale.
Sotto un diverso profilo, si è voluto distinguere tra giudicato e preclusione. In
particolare, Chiovenda, diceva: « giudicato vi è, quando la sentenza «garantisce al
sub ditus legis un bene della vita»; se invece il giudice decide non intorno a
questo ma intorno al modo di condurre il processo, in questo caso sarebbe più
corretto parlare di preclusione anziché di giudicato». Ma qual è il “bene della
vita” che la sentenza penale garantisce? Cominciando a riflettere intorno all’
identità del processo penale e della pena, questa dottrina giunse alla conclusione
che “ il vero valore del processo penale sta nel vietare o nel comandare che il
processo continui passando dalla fase di cognizione alla fase di esecuzione”; e
questo perché, “il processo penale di cognizione, non serve che come introduzione
al processo di esecuzione: se il giudice assolve riconosce che non tanto il processo
deve proseguire quanto non doveva cominciare; se condanna, dispone appunto la
sua prosecuzione . Ciò significa che la sentenza penale, vuoi di proscioglimento,
vuoi di condanna, ha portata puramente processuale” Ne consegue che in materia
penale, più che di cosa giudicata si dovrebbe parlare di preclusione; «preclusione
che da una parte, da stabilità al processo e dall’altra parte serve a stimolare le parti
ad essere sollecite nell’esercizio dei diritti processuali».17
16
Carnelutti F., Contro il giudicato penale, in Scritti in onore di Vincenzo Manzini., Padova,
1951, p. 122-123
17
Carnelutti, F., Contro il giudicato penale, in sctritti in onore di Vincenzo Manzini, Padova,
1954, p.125-126.
15
Ma il concetto di preclusione può essere anche inteso in un altro senso. Il processo
penale è caratterizzato dallo svolgimento, secondo i tempi e i modi previsti dalla
legge processuale, di una serie di atti o attività cronologicamente ordinate e
finalizzate alla pronuncia di un provvedimento; ciascuno di questi atti, poi, fa
sorgere il dovere di porre in essere uno successivo, che era già stato realizzato in
adempimento di un dovere posto dal suo antecedente. Premesso ciò, «le parti
hanno la libertà di scegliere il loro comportamento processuale (principio
dispositivo) con la conseguenza che il mancato esercizio di quella determinata
attività impedisce il successivo compimento di un atto processuale o di una serie
di
atti
processuali,
causato
dalla
incompatibilità
con
un
precedente
comportamento processuale, che sia attuato mediante il compimento, o il mancato
compimento di un atto processuale»18 , per cui, per effetto di un precedente
comportamento, si crea un ostacolo all’esercizio di quella ulteriore attività (una
“preclusione”); e, un’applicazione del principio della preclusione, è costituito,
proprio, dallo sviluppo del processo nei vari gradi di giurisdizione, in cui tutte le
acquisizioni in fatto e in diritto, non investite da impugnazione, assumono una
certa “definitività” che va ricondotta proprio a questo principio della preclusione.
Il massimo della preclusione si ha nella “res iudicata” che impedisce il
compimento di qualsiasi ulteriore attività processuale ( salvo il rimedio di natura
sostanziale della revisione ).
In conclusione, si può affermare che due sono gli effetti del giudicato penale:
l’uno preclusivo, l’altro vincolante.19 Il primo comporta che l’imputato prosciolto
o condannato non può essere sottoposto una seconda volta a procedimento penale
per il medesimo fatto ( art. 649 c.p.p.); il secondo, invece, impone agli altri giudici
di ritenere “vero” il fatto accertato, distinguendo, qui, tra effetto vincolante ai fini
penali, e quello ai fini civili o amministrativi, su cui si tornerà più avanti.
18
19
Leone, G., Lineamenti di diritto processuale penale, Jovene editore, Napoli, 1956, p. 542 ss.
Tonini, P., Manuale di procedura penale, Milano, 2009, p. 805.
16
3. Il fondamento del giudicato penale.
L’opinione prevalente, è orientata nel senso di sostenere che la funzione del
giudicato vada individuata nella « coerenza pratica dell’ordinamento»20 e quindi
nella certezza del diritto; « la cosa giudicata si presenta anch’essa quale strumento
destinato a garantire la certezza del diritto»21; certezza che qui va intesa come «
complemento della certezza del diritto,
sotto l’aspetto astratto: quest’ultimo,
infatti, si realizza mediante la legge, la prima, invece, si realizza mediante la
giurisdizione22» (ciò coerentemente a quanti sostengono l’idea del giudicato come
lex specialis). Ma, «questi due aspetti sono collegati: la certezza in senso
oggettivo, nasce dalla stessa struttura stabile e oggettiva della norma che per la
sua rigidità e astrattezza, garantisce una valutazione uguale e certa per tutti i
comportamenti presenti e futuri e costituisce un rimedio contro l’insidia
dell’arbitrio »23.
La certezza del diritto, comunque, presenta una duplicità di significato; essa,
infatti, può essere intesa: o come prevedibilità della qualifica dei comportamenti
futuri, in modo tale da garantire a ciascuno la possibilità di conoscere in anticipo
come verranno valutate le proprie ( possibili) azioni, in quel determinato
ordinamento. A tal proposito, si diceva che «la certezza del diritto è una garanzia
di libertà», perché, non esiste libertà, « quando il soggetto non è mai sicuro dei
precisi confini della liceità dei suoi comportamenti, quando non possa trovare
nella legge i limiti all’esercizio dell’una o dell’altra sua libertà, ma nella
discrezionalità della pubblica autorità o quando un soggetto possa essere punito
per un fatto non previsto dalla legge come reato» (…) La certezza del diritto, però,
può essere anche intesa come intangibilità delle situazioni giuridiche acquisite; in
quest’ultimo caso, essa si realizza attraverso la sicurezza dei diritti: « attraverso –
cioè - la garanzia offerta dalla incontestabilità delle situazioni giuridiche, il
singolo acquista la sicurezza che si risolve in beneficio»24.
20
Lucareli, U, L’istituto del giudicato, Il giudicato penale e i suoi effetti civili, UTET, 2006, p.3.
Carnelutti F. , Efficacia diretta ed efficacia riflessa del giudicato penale, in Questioni sul
processo penale, Bologna, 1950, p.44.
22
Leone G., Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988, p 733.
23
Pugliese, G., Giudicato civile, Milano, Giuffrè, 1968, 800 ss.
24
Levi, A., La certezza del diritto in rapporto con il concetto di azione, in Scritti giuridici in onore
di F. Carnelutti, I, Padova, 1950, p. 86.
21
17
Secondo De Luca25, il giudicato assolve essenzialmente a due funzioni: da una
parte garantisce la sicurezza dei diritti ( o, meglio, la certezza dei diritti), dalla
altra assicura la pace sociale.
Rispetto al primo punto, si può ulteriormente distinguere la certezza del diritto in
una duplice accezione: in senso generale e teorico, ossia che non vi siano contrasti
all’interno dell’ordinamento, tra più sentenze, in ordine a un medesimo oggetto; e
in senso pratico: limitata, cioè, al singolo soggetto. In questo caso, è sufficiente
che una seconda decisione intervenga nei confronti della stessa persona e sullo
stesso oggetto già deciso con sentenza irrevocabile. È evidente, però, che se si
attribuisce al giudicato lo scopo di evitare decisioni tra loro logicamente
inconciliabili, implicitamente, si estende la sua efficacia verso i terzi e, dunque,
tutte le volte che si ripresenterà la stessa questione di fatto o di diritto, già
irrevocabilmente decisa in un separato processo, ma relativamente a un terzo
rimasto estraneo al primo processo, si dovrà impedire che la stessa questione sia
giudicata in maniera difforme.
In ogni caso, nel nostro ordinamento è stato
accolto il criterio pratico (art.649 c.p.p.)26, della preclusione.
Relativamente al secondo punto, si è detto che il procedimento penale è volto a
garantire il mantenimento della pace sociale, in altre parole, « il giudicato penale,
placa l’aspettativa di giustizia della società nei confronti di una notitia criminis e
placa l’aspettativa dei soggetti del reato e di quegli altri individui sui quali il reato
incide più o meno direttamente ». Dunque, secondo questa interpretazione, il
giudicato assolve a una funzione di prevenzione generale, ovvero sia nei confronti
della vittima del reato, sia nei confronti dei consociati.27
La certezza del diritto, come detto prima, può anche essere intesa come coerenza
logico-formale e, dunque, in questa prospettiva, il giudicato penale servirebbe
proprio a prevenire o reprimere un contrasto logico tra giudicati. Se si ammettesse
la possibilità di una indefinita pluralità di processi in relazione allo stesso fatto
avremmo altrettante pronunce, alcune delle quali conformi, altre difformi dalle
precedenti; si avrebbero così giudizi contraddittori.28 Sotto questo profilo, è
25
De Luca G., I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 111 ss.
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato, Il giudicato penale e i suoi effetti civili, UTEU, 2006, p.4.
27
Leone. G., Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988, p. 734-735.
28
De Luca G., Giudicato, (dir. proc. pen.) in Enc. Giur., Treccani, Roma, p.1-11.
26
18
evidente, come il giudicato svolga la funzione di prevenire o comunque reprimere
un eventuale conflitto tra giudicati. Sul punto, la dottrina ha operato, una
importante distinzione concettuale tra conflitto teorico e conflitto pratico di
giudicati.
Con l’espressione conflitto teorico, si intende l’ipotesi di inconciliabilità logica tra
due o più sentenze irrevocabili. Mentre, il conflitto pratico si verifica nel caso di
incompatibilità tra comandi contenuti in due o più sentenze irrevocabili
(ovviamente il conflitto pratico, data la sua natura, si differenzia da quello teorico,
in quanto presuppone che le sentenze in contrasto riguardino il medesimo fatto e
la medesima persona, dal momento che una incompatibilità tra due o più comandi
può verificarsi soltanto in questo caso).29
Il legislatore, allo scopo di prevenire o reprimere tali conflitti, ha dotato il nostro
ordinamento di appositi rimedi, che si distinguono propriamente, a seconda che
questi abbiano ad oggetto la prevenzione (o la risoluzione) di un conflitto teorico
o la prevenzione (risoluzione) di un conflitto pratico.
È stato, poi, anche osservato come l’incompatibilità logica delle sentenze non
Comporti sempre una incompatibilità tra i comandi in essa contenuti. Ciò, è
facilmente comprensibile se si fa questo esempio. Pensiamo all’ipotesi in cui,
«una sentenza di condanna assolva Tizio dall’imputazione di omicidio, e una
sentenza successiva che condanni Caio come compartecipe allo stesso reato
realizzato da Tizio, indicato quale autore principale»; mentre, al contrario,
l’incompatibilità tra i suddetti comandi non sempre importa una incompatibilità
logica tra le sentenze (pensiamo al caso in cui, con due distinti provvedimenti
Tizio, venga condannato a pene diverse per il medesimo fatto); è anche vero, però,
che, in linea generale, il conflitto tra giudicati può essere allo stesso tempo teorico
e pratico: così quando, il contrasto sussiste tra una sentenza di assoluzione e una
sentenza di condanna, entrambe irrevocabili e relative alla stessa persona e il
medesimo fatto30.
Su questo punto, c’è poi, da fare un’ altra considerazione non meno importante:
sostenere che il giudicato penale assolva a una funzione di prevenzione o
repressione, rispetto all’insorgere di eventuali pronunce contraddittorie, non può
29
30
Chiovenda G., Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923, p. 375.
Lozzi G., Favor rei e processo penale, Milano, 1965, p. 130 ss.
19
portare automaticamente a ritenere che esso produca i suoi effetti anche nei
confronti dei terzi, altrimenti si creerebbe una situazione in cui questi ultimi si
troveranno ad essere avvantaggiati o pregiudicati dai giudizi storici o dagli
apprezzamenti di diritto formulati dal giudice in un altro processo, al quale questi
erano estranei; ma, evidentemente, questo non può essere accettato, perché « il
giudicato inerisce al momento imperativo della decisione e non ai giudizi di fatto
o di diritto; esso è diretto a prevenire non già un conflitto teorico, ma solo e
semplicemente un conflitto pratico»31.
Comunque, in linea generale, tre sono le tipologie di conflitti tra giudicati, che si
possono realizzare: 1) conflitti esclusivamente teorici; 2) conflitti esclusivamente
pratici; 3) conflitti al tempo stesso pratici e teorici32; a tali conflitti, il legislatore
ha premunito il nostro ordinamento di rimedi, preventivi e repressivi.
Il rimedio diretto alla risoluzione di conflitti teorici è previsto nell’art. 630 lett. a),
che nell’elencare tassativamente i casi in cui è ammessa la revisione del
giudicato,dispone che questa è possibile…”se i fatti stabiliti a fondamento della
sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli
stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un
giudice speciale”. L’ inconciliabilità tra le sentenze irrevocabili, non deve essere
intesa come incompatibilità logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni,
ma, piuttosto, come incompatibilità oggettiva tra i fatti su cui si fondano le diverse
sentenze; inoltre, per “ fatti stabiliti a fondamento della sentenza”, devono
intendersi, appunto, proprio quei fatti ritenuti essenziali ai fini della decisione. Un
ipotesi tipica di conflitti esclusivamente teorici tra giudicati è il caso in cui
abbiamo una sentenza di assoluzione che assolva per insussistenza del fatto
l’autore principale del reato che entra in contrasto con una sentenza di condanna,
sottoposta a revisione, contro un’altra persona, che successivamente venga
ritenuta compartecipe in quello stesso reato. Nella sostanza, ciò che è emendabile
con la revisione è l’errore di fatto e non la valutazione del fatto, per cui “non è
ammissibile l’istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro
probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e poi per
31
32
Chiovenda G., Istituzioni di diritto processuale civile, II ed, Napoli, 1923 p. 920.
Lozzi, G., Giudicato, ( dir. pen.), cit., p. 918.
20
condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti diversi”.
33
Dunque, se è vero che per “ fatti stabiliti a fondamento della sentenza”
intendiamo gli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto-reato, ritenuto
a carico di che formula la richiesta, è anche vero che, « gli elementi in base a quali
si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità tali da dimostrare,
se accertati, che il condannato doveva essere prosciolto; essi dunque, non possono
consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze, che
abbiano a fondamento gli stessi fatti».34
Per quanto riguarda invece il problema della risoluzione dei conflitti pratici tra
giudicati, ossia il caso in cui nei confronti della stessa persona sono state emanate
due sentenze irrevocabili, vediamo che questo è espressamente considerato dal
legislatore, in una sola ipotesi, ovvero quando le due sentenze siano di condanna;
a tal proposito, la disposizione normativa di riferimento è quella contenuta
nell’art. 669 c.p.p., rubricato “Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la
stessa persona” la quale dispone che, “Se più sentenze di condanna divenute
irrevocabili, sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo
fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la
condanna meno grave, revocando le altre”.
Tale disciplina, tanto è applicabile proprio in quanto, la pluralità di sentenze, oltre
che sullo stesso imputato, riguardano anche il “medesimo fatto”; l’idea che in caso
di conflitto pratico tra giudicati, debba eseguirsi la sentenza con cui venne
pronunciata la sentenza meno grave è chiaramente ispirata al principio del favor
rei, tanto è vero che si è osservato come, nel caso di identità della pena irrogata
con le due pronunce, debba comunque applicarsi quella che comporti una
“pronuncia accessoria” tale da essere più favorevole al condannato (es.,
sospensione condizionale della pena); si può notare come, in quest’ultimo caso, i
giudicati più gravi sono revocati, non sono, invece, modificati nel loro
contenuto.35
In linea generale, invece, quello che emerge in tema di conflitti tra giudicati è che
quì il principio del favor rei opera come vero e proprio principio generale.
33
Cassazione 15.05.1999, in CED, Cass., n. 214643
Cassazione, 9.7.97, Garrone, in CED, Cass., n. 208608.
35
Casazione, 9.7.98, Conigliano, in Riv. pen., 99, 392.
34
21
4. La natura della cosa giudicata.
Relativamente alla natura della cosa giudicata sono state formulate varie teorie.
Tra le più importanti, possiamo ricordare:
La teoria del quasi contratto giudiziale; secondo la quale « le parti, con il
promuovimento dell’azione, si obbligano ad osservare la sentenza del giudice
(obligatio judicatum solvi); e,...il giudicato si pone come novazione contrattuale
del diritto controverso ».36
Ma, evidentemente, questa teoria nel processo penale non trova applicazione, in
quanto, come è stato giustamente osservato, il c.d. contratto giudiziale,
presuppone disponibilità dei diritti o degli interessi dedotti in giudizio; mentre il
processo penale è dominato in gran parte dal principio dell’indisponibilità.37
La teoria dell’equità presuppone una equità intesa nel senso di evitare che il
procedimento penale si traduca per l’imputato in una pregiudizievole spada di
Damocle e, cioè, che la ricerca della responsabilità non assuma carattere
permanente. Questa teoria parte sostanzialmente dall’idea che raggiungere una
giustizia assoluta, sia obbiettivo pressoché impossibile , e si fonda sul seguente
interrogativo:” quale garanzia esiste per portarci a dire che in un secondo giudizio
sia possibile ottenere una maggiore aderenza alla giustizia rispetto a un primo
giudizio già conclusosi?” In realtà, è stato osservato, come a questa teoria non gli
si possa riconoscere una piena autonomia, ma è più corretto farla rientrare nella
concezione che riconduce il fondamento della cosa giudicata al principio della
certezza giuridica; in quanto, è stato affermato che « la possibilità di una decisione
ingiusta è male minore di un regime di incertezza giuridica; e, nell’intento di
pervenire ad una giustizia assoluta e irraggiungibile, si rinuncerebbe alla
realizzazione dell’unica giustizia possibile, quella relativa e limitata ».38
La teoria della finzione ( o presunzione) di verità che risale, invece, a Ulpiano e
secondo questa una sentenza passata in giudicato, in quanto espressione di verità,
sarebbe inattaccabile, («res iudicata pro veritate accipitur»).
36
Rocco. U. L’autorità della cosa giudicata ed i suoi limiti soggettivi, Roma, 1917, p. 53. 105;
Trattato di diritto processuale civile, Torino, 1966 vol.4, p. 305.
37
Leone. G., Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988 p. 735.
38
Leone. G., Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988, p. 725-736.
22
La teoria della cosa giudicata come verità giudizialmente accertata, « che segna
perciò il raggiungimento del fine e della fine del procedimento penale con
l’armonica soddisfazione di due interessi procedurali»: «l’interesse della
repressione e l’interesse della libertà dell’innocenza»39.
E infine, va segnalata, la teoria della natura del giudicato secundum eventum litis.
Recentemente, si è affermato un nuovo indirizzo dottrinale che si pone all’interno
del tradizionale dibattito sulla natura del giudicato; esso viene argomentato
prendendo come base il principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza di cui all’art. 27 co.2 Cost. e, da qui, si giunge a differenziare la
natura del giudicato penale a seconda che esso sia di condanna o di assoluzione40.
Secondo questa impostazione, il giudicato di condanna genera “una realtà
sostanziale”, in quanto introduce nella realtà giuridica un reato, che prima non era
consentito configurare come tale, proprio per l’operare di quel principio
costituzionale espresso nell’art. 27 co.2 Cost.; dunque, in questa prospettiva, il
giudicato riveste la funzione di “produttore di reati”, e, addirittura, si è affermato
che “ se non esistessero giudicati, non esisterebbero neanche reati”. Secondo
questa impostazione, il giudicato penale, si porrebbe a metà tra il diritto
sostanziale e il diritto processuale41.
Al contrario, il giudicato di assoluzione ha natura esclusivamente di tipo
processuale, in quanto esso si limita a dichiarare l’innocenza di un individuo, ma,
evidentemente, questo non introduce alcun elemento di novità nella realtà
giuridica, poiché, per il prosciolto, tale realtà è già garantita per l’operare di quella
presunzione di non colpevolezza espresse nell’art. 27 co. 2 Cost.
5. L’autorità della cosa giudicata penale.
Solitamente, per indicare una sentenza passata in giudicato, si parla di “autorità”
di cosa giudicata. Ma che cosa vuol dire questa espressione?
39
Rocco A. , Cosa giudicata, 1904. p. 235 ss.; Rocco U. , L’autorità della cosa giudicata, p. 48 ss.
D’Orazi M., La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di
ammissibilità, Padova, CEDAM, 2003, p. 127.
41
D’Orazi M., La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di
ammissibilità, Padova, Cedam, 2003, P. 115.
40
23
Se è vero che la sentenza che definisce un processo, una volta passata in
giudicato, implica la sua incontestabilità e la sua immutabilità, in quanto produce
l’effetto di rendere inammissibile una nuova azione de eadem re, rispetto appunto
a quella dedotta in giudizio, allora è qui che dobbiamo individuare quella
”auctoritas” che assiste la pronuncia del giudice.
« L’autorità, non coincide con la cosa giudicata, ma è un attributo della stessa, che
si esprime nella formula “ auctoritas rei iudicata”, dove l’attributo sta ad indicare
proprio un accrescimento (“ab augendo”) del valore giuridico della decisione».42
“Auctoritas”, infatti, etimologicamente, deriva dal verbo latino “augere”, che vuol
dire: “accrescere”, “aumentare”, “rafforzare” e, più specificamente, in questo
caso, assume il
significato di “avvalorare”, “dar peso”, “credito” e quindi
“valore” al quid decisum, che appunto costituisce l’oggetto della pronunzia del
giudice; tale espressione, dunque, «sta ad indicare l’accrescimento e la
sublimazione del valore giuridico dell’accertamento giudiziario», o ancora, come
è stato affermato, « esprime l’efficacia cogente generale, normativamente
riconosciuta, dell’accertamento giurisdizionale definitivo».43
L’auctoritas rei iudicatae può configurarsi idealmente secondo due modelli
completamente differenti sia per il modo di operare, sia nella sfera di
applicazione.
Secondo un primo modello, questa “auctoritas”, in linea generale, imporrebbe
quel vincolo “negativo” , il quale comporta la preclusione di un qualsiasi nuovo
giudizio de eadem re.; in particolare, in materia penale, esso obbliga i giudici dei
processi futuri a non pronunciarsi nuovamente in ordine alla questione già decisa,
qualora il successivo giudizio riguardi l’accusa per lo stesso fatto a carico della
medesima persona. Nell’altra accezione, il vincolo è “positivo” e obbliga i futuri
giudici a uniformarsi al contenuto della sentenza passata in giudicato.
Ma, a sua volta, la stessa « efficacia “negativa” della cosa giudicata sostanziale,
la quale appunto, si realizza nell’impedire qualsiasi nuovo giudizio sullo stesso
oggetto, può in astratto manifestarsi in due modi: o vincolando i giudici dei
processi successivi de eadem re a pronunciarsi in modo non difforme da quanto è
stato già giudicato, oppure attraverso il divieto di statuire nuovamente su ciò che
42
43
De Luca G., Giudicato , (dir. pen.), in Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, p. 912-923.
Callari F. , La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano, 2009, p. 18.
24
si è già detto». Quest’ultimo è quello che il nostro legislatore ha accolto e
codificato all’ interno della disposizione dell’art. 649 c.p.p., ossia attraverso la
regola del divieto del bis in idem; «disposizione che è ricollegata unicamente al
passaggio in iudicatum della sentenza pronunciata con riferimento ad un
determinato fatto e nei confronti di una determinata persona, prescindendo
completamente dallo specifico contenuto materiale dell’accertamento racchiuso
nella decisione penale irrevocabile».44
Rispetto all’ “autorità” della cosa giudicata, molto è stato detto:
Ludovico Mortara, tra il IX e X secolo diceva: « ogni sentenza pronunciata da un
organo giurisdizionale possiede una sua propria naturale e legittima autorità, cui
l’opera sindacatrice e correttrice di un altro organo potrà in seguito modificare o
revocare, ma che non manca fin dal primo momento delle condizioni necessarie
per vivere stabilmente e per divenire irrevocabile»; la giustificazione di questa sua
asserzione era nella “presunzione di conformità alla legge” della decisione; e
proprio tale presunzione, le assicura “l’autorità piena quantunque condizionata
all’evento della riforma o dell’annullamento”.
Vincenzo Manzini partiva, invece, dall’idea che “l’autorità di cosa giudicata”,
pendenti i termini delle impugnazioni ordinarie, fosse ancora allo stato di potenza,
di energia meramente virtuale; ma anche dell’idea che la sentenza contenesse in sé
quanto necessario e sufficiente a determinare la suddetta autorità.45
Carnelutti, al contrario, sosteneva che «la sentenza fosse efficace anche prima di
essere immutabile e sebbene fosse soggetta a gravame»; sostenendo che «
l’imperatività si può avere senza e soprattutto, prima dell’immutabilità »; ma
affermare questo, vuol dire, ridurre l’importanza dell’ attributo di “autorità” di
cosa giudicata: « essa infatti, non può consistere nella imperatività della sentenza
che è la sua efficacia naturale e costante, indipendente dalla sua definitività e
propria della pronuncia giudiziale, nella qualità di atto emanato dall’autorità dello
Stato».46 Più tardi, lo stesso Autore, però, aggiungerà che: « la sentenza va intesa
come comando, cioè, in quanto contiene la formulazione di una volontà di
contenuto imperativo; ma questo comando- aggiunge- anche quando
44
Callari F., La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, cit., p. 19 ss.
Ruggeri S., Giudicato penale e accertamenti non definitivi, Milano, 2004, p. 26.
46
Carnelutti F., Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1986 , p. 381-393.
45
25
sia pienamente efficace, non solo è suscettibile di riforma, ma è anche esposto al
rischio di essere contraddetto da un altro comando pronunciato anch’esso da un
organo dello Stato; così l’efficacia di una sentenza non può in sé e per sé,
impedire a un altro giudice posteriore, investito anch’esso della pienezza dei
poteri esercitati dal giudice che ha emesso la sentenza, di riesaminare il caso
deciso e di giudicare in modo difforme. Solo una ragione di utilità politica e
sociale interviene ad evitare questa possibilità, rendendo il comando immutabile
quando il processo sia giunto alla sua conclusione con la preclusione delle
impugnative contro la sentenza in esso pronunziata». Ma allora l’autorità della
cosa giudicata, secondo il suo autorevole parere, «non si identifica solo con la
definitività e intangibilità dell’atto che pronuncia il comando, ma è una qualità
speciale che investe l’atto anche nel suo contenuto e rende così immutabili, oltre
l’atto nella sua esistenza formale, ma anche gli effetti dell’atto medesimo».47
Sulla scia del pensiero carneluttiano, Liebman48, dal canto suo, considerava
l’autorità della cosa giudicata « qualche cosa in più che si aggiunge agli effetti
normali della sentenza (dichiarativo, costitutivo,esecutivo), per accrescere la loro
stabilità»; dunque, la distinzione tra l’efficacia naturale della sentenza e l’autorità
della cosa giudicata, a suo parere, consisterebbe semplicemente nel fatto che
quest’ultima conferirebbe alla prima la “immutabilità”, ossia una diversa qualità.
Ma questa teoria è stata molto criticata, soprattutto, per l’aver identificato l’
“auctoritas” della cosa giudicata alla immutabilità o stabilità della sentenza, ma,
tra i vari significati di “auctoritas” come è stato giustamente osservato49, non ce
n’è uno che corrisponda a” immutabilità o stabilità, invece, tutti si aggirano
intorno al concetto di “validità”, “peso”, “valore”.
6. L’irrevocabilità.
«Le forze proprie dell’autorità del giudicato penale sono due: l’una positiva (
l’actio iudicati) , giudicato quale titolo esecutivo per attuare lo ius puniendi;
l’altra negativa ( l’exceptio rei iudicatae ) o preclusione processuale (divieto del
47
Carnelutti F., Lezioni sul processo penale, 1949, I, p.122 ss.
Liebman T., Efficacia ed autorità della sentenza, Padova, 1935, p. 24-48.
49
Carnelutti F. , Efficacia, autorità e immutabilità della sentenza, in Riv. dir. proc. pen. 1935,
p.205 ; e Pugliese G. , Giudicato civile, Milano, Giuffrè, 1968, p. 811.
48
26
bis in idem) , principio per cui “ res iudicata pro veritate habetur”»50. Ma, se
questo è vero, è altrettanto vero che questa autorità si fonda sulla irrevocabilità
della sentenza; solo la sentenza irrevocabile è munita dell’ “autorità della cosa
giudicata” :« res iudicata dicitur quae finem controversia rum pronuntiatione
iudicis accipit, quod vel condemnatione vel absolutione contingit».51 In altre
parole, il giudicato si forma nel momento in cui la sentenza diventa irrevocabile;
ovviamente, deve trattarsi di una sentenza giuridicamente esistente, non potendo
acquistare l’autorità di cosa giudicata la sentenza inesistente.
Ma quando la sentenza diviene irrevocabile?
Innanzitutto, bisogna fare delle precisazioni concettuali su alcuni termini, che in
prima approssimazione possono sembrare equivalenti, col rischio di usarli come
sinonimi, ma che in realtà hanno un contenuto, almeno dal punto di vista
strettamente processuale, assolutamente diverso.
Innanzitutto, il concetto di irrevocabilità, va tenuto distinto da quello di
definitività, perché definitività, implica « l’assenza di una necessità automatica di
prosecuzione del processo », ad esempio, nel caso di sentenza di non doversi
procedere per mancanza di una condizione di procedibilità; l’irrevocabilità,
implica, invece, « l’esaurimento della situazione giuridica processuale e che, si
ricollega di regola al passaggio in giudicato della sentenza ».52
Il riferimento normativo è nell’art. 648 c.p.p. , il quale ci dà proprio la definizione
di ciò che si deve intendere per “irrevocabilità” delle sentenze e dei decreti penali.
I provvedimenti presi in esame sono la sentenza e il decreto penale; la piena
equiparazione, dal punto di vista sostanziale, fra il decreto penale e la sentenza di
condanna è ormai un punto fermo. Ciò si fonda proprio sul fatto che il decreto
penale, al pari della sentenza, definisce il rapporto processuale dichiarando la
responsabilità dell’imputato ed applicando la sanzione; nel previgente codice
invece, si prevedeva espressamente nei confronti dei decreti penali di condanna,
l’azione c.d. revocatoria (art. 506 ul. co. c.p.p. 1930).
50
Manzini V., Istituzioni di diritto processuale penale, 1946,p. 324 ss.
D. 42,1,1
52
Cassazione, 17.11.75, Esposito, in Cass. Pen. 77, 1173 e Cassazione, 13.6.80, Di Mauro, in
Cass. Pen. 81, 1570.
51
27
Inoltre, il concetto di “irrevocabilità”, è strettamente connesso a quello di
“esecutività” ; questo emerge, chiaramente, dal richiamo fatto dall’art. 648 c.p.p,
all’art. 650 c.p.p., rubricato “ Esecutività delle sentenze e dei decreti penali”, il
che, appunto, porta il giudicato penale, ad «assumere un ruolo nell’ambito della
esecuzione »53; più precisamente, dire che la sentenza :irrevocabile è esecutiva
(art. 650 c.p.p.), vuol dire che essa ha “attitudine ad essere eseguita”, in quanto,
una volta terminato tutto l’iter processuale, quell’accertamento definitivo di
colpevolezza e la relativa sanzione può avere attuazione. Ma esecutività è cosa
diversa, e non va confusa con l’esecutorietà della sentenza, che sta invece ad
indicare la effettiva esecuzione della sentenza; d’altra parte, come è stato
correttamente osservato, la esecutorietà, non deriva necessariamente dalla
irrevocabilità, pensiamo al caso dell’applicazione provvisoria delle misure di
sicurezza (art. 312 c.p.p.) o delle sentenze di non luogo a procedere che non sono
mai irrevocabili.
In ogni caso, la stretta connessione tra irrevocabilità ed esecutività, emerge
chiaramente dalla lettura congiunta degli artt. 648 e 650 c.p.p.. L’art. 650 c.p.p.
disciplina, infatti, l’ “esecutività dei provvedimenti giurisdizionali ,(“ Salvo che
sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali, hanno forze esecutiva
quando sono divenuti irrevocabili” ). In sostanza, mentre l’art. 648 c.p.p. fissa il
presupposto essenziale per l’inizio della fase esecutiva del processo, almeno con
riguardo ai due provvedimenti presi in considerazione (la sentenza e il decreto
penale); l’art. 650 c.p.p., fa scaturire dalla sopravvenuta irrevocabilità del
provvedimento la sua forza esecutiva.
Ma, prima ancora, ciò emerge, altrettanto chiaramente, dalla Relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale vigente, in cui, si dice espressamente
che “ il fondamento dell’esecuzione” viene riconosciuto nel “titolo esecutivo
costitutivo del provvedimento irrevocabile”, intendendosi per “provvedimento”
ogni atto della autorità giudiziaria ordinaria ( sentenza, ordinanza, decreto) che
non sia più soggetto ad impugnazione ed abbia conseguito il carattere della
“definitività”.
53
Guarnieri, G., Regiudicata ( dir. proc. pen.), in Novissimo Digesto, XV, X., p.,246.
28
L’art. 648 c.p.p. si compone di tre commi: il primo comma, prevede quelle che
sono le due condizioni fondamentali affinché si possa parlare di irrevocabilità del
provvedimento, ossia, deve trattarsi di provvedimento pronunciato in giudizio e
contro il quale non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
Quindi, appartengono a questa categoria: a) tutte le sentenze pronunciate dalla
Corte di cassazione
(sentenze che sono inoppugnabili per definizione) per le quali, l’irrevocabilità
scatta dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso (artt. 606 e ss. c.p.p.); b) per quanto riguarda,
invece, le sentenze impugnabili emesse dai giudici di merito, l’irrevocabilità della
sentenza, si ha: 1) quando, pur essendo ammesso l’appello o
il ricorso per
cassazione, siano scaduti i termini senza che l’impugnazione sia stata proposta da
almeno alcuno dei soggetti legittimati a proporla; 2) quando, una volta proposto
l’appello, questo sia stato dichiarato inammissibile dal giudice a quo, e siano
inutilmente scaduti i termini per ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza che
dichiara l’inammissibilità ( art. 591 co.2 c.p.p. ) ; o quando pur essendo stato
proposto ricorso in cassazione contro l’ordinanza suddetta, la Cassazione lo abbia
dichiarato inammissibile o lo abbia rigettato; 3) quando il giudice d’appello abbia
confermato o riformato la sentenza di primo grado e non sia stato proposto ricorso
in Cassazione contro la sentenza d’appello nei termini. Infine, il terzo comma
dell’art. 648 c.p.p. si occupa di individuare le condizioni che determinano il
verificarsi dell’irrevocabilità dei decreti penali di condanna: a parte le dovute
differenze fra opposizione ed impugnazione, la disciplina è la stessa di quella
dettata per le sentenze. Le differenze che rimangono sono stanzialmente due: 1)
l’opposizione può essere proposta solo nella fase immediatamente successiva
all’emissione del decreto stesso e, se ammissibile, il processo proseguirà nelle
forme previste dall’art. 461 c.p.p., pervenendosi così ad una sentenza e con la
conseguenza che allora dovranno applicarsi i primi due commi; 2) inoltre, a
decidere sull’ammissibilità dell’opposizione è lo stesso giudice che ha emesso il
provvedimento.
Si è parlato, anche, di una “irrevocabilità condizionata” dei decreti penali, in
quanto, se è vero che essi acquistato “ forza esecutiva”, una volta divenuti
29
irrevocabili ( art.650 co 1° c.p.p. ), è anche vero che, nel caso in cui il decreto sia
stato pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato, l’esecuzione
rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a
quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non
sia definito con pronuncia irrevocabile ( art. 463 co. 1° c.p.p. ). Quindi, in questo
caso, il decreto non diviene irrevocabile fino al termine del giudizio dei
coimputati.
A tal proposito, è stata ritenuta
“sovrabbondante” l’espressione
dell’art. 464 ult. co. c.p.p.: « il giudice revoca il decreto di condanna anche nei
confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione,
ove l’opponente sia prosciolto perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla
legge come reato, ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione
»; in quanto « l’effetto estensivo giova ai non opponenti anche in mancanza di una
“revoca” espressa e in ogni caso, non si tratta di una revoca di un provvedimento
esecutivo, dunque il termine è stato usato in senso improprio ».54
Fino al momento in cui la sentenza o il decreto penale di condanna non siano
divenuti irrevocabili, il processo non può, considerarsi ancora definitivamente
concluso.
Un’altra importante disposizione è quella contenuta nell’art. 588 c.p.p. rubricato
“ Sospensione dell’esecuzione”, che è opportuno leggere in combinato disposto
con gli artt. 648 e 650 c.p.p. L’art. 588 c.p.p. pone una regola generale, ossia
quella della sospensione dell’esecuzione del provvedimento dal momento della
pronuncia e durante i termini per impugnare fino all’esito
del giudizio di impugnazione. La norma termina con l’inciso "salvo che la legge
disponga altrimenti"; questa si riferisce alle eccezioni alla regola generale di
sospensione, quali quelle di cui agli artt. 318 e ss. (in tema di misure cautelari
reali, per quanto attiene al riesame delle ordinanze di sequestro conservativo e
preventivo, nonché, prettamente per il sequestro preventivo, per quanto riguarda
l’eventuale appello e ricorso per cassazione), all’art. 479 c. 2 (per quanto riguarda
il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dispone la sospensione del
dibattimento), all’art. 573 c. 2 (relativa all’impugnazione per i soli interessi civili
54
Giuovene, A., Giudicato, in Digesto, ed. IV, vol. V, UTET penale, 1991, p. 426.
30
in rapporto alle disposizioni penali del provvedimento impugnato), all’art. 666 c.
7 (in tema di impugnazioni avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione),
all’art. 680 c. 3 c.p.p. (per l’appello al tribunale di sorveglianza contro le sentenze
concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza). Da ciò, si può
ben comprendere come l’irrevocabilità della sentenza sia strettamente collegata
alla più o meno possibilità di proporre impugnazione.
Più in particolare, vediamo che, rispetto a una sentenza di primo grado che sia
appellabile, due sono i possibili sviluppi: 1) se l’appello non viene proposto per
inerzia dei soggetti legittimati e né tantomeno, viene fatto ricorso immediato per
Cassazione, ai sensi dell’ art. 569 c.p.p., avremo che la sentenza diviene
irrevocabile nel giorno in cui scadono i termini per impugnare; 2) se, invece,
l’appello è proposto nei termini, ma è inammissibile, l’irrevocabilità si verrà a
determinare nel momento in cui l’ordinanza con cui il giudice ad quem dichiara
l’inammissibilità dell’appello, passa in giudicato.
Nel caso in cui sia stato
proposto ricorso per Cassazione, contro la sentenza del giudice d’appello o contro
la sentenza di primo grado, nel caso di ricorso immediato per Cassazione ( c.d.
ricorso per saltum), l’irrevocabilità della sentenza sopraggiunge nel giorno stesso
in cui la Corte di Cassazione pronuncia ordinanza di rigetto o di inammissibilità
del ricorso stesso. Per quanto riguarda la sentenza emessa dal giudice dell’appello,
se contro questa non è stato proposto ricorso per Cassazione, la sentenza diviene
irrevocabile dal giorno in cui risultano scaduti i termini per proporre il ricorso.
È possibile notare come in tutte le varie ipotesi previste, quello che cambia è
soltanto il momento in cui si determina l’irrevocabilità della sentenza ma il
meccanismo che collega l’irrevocabilità alla dinamica dell’impugnazione è
sempre lo stesso.
Ora, si è detto che l’irrevocabilità è concetto strettamente collegato a quello di
esecutività; ma questa stretta connessione non implica che i due concetti siano
coincidenti, e questo emerge chiaramente dalla lettura dell’art. 650 c.p.p.: lo
capiamo bene, prima di tutto dall’inciso iniziale “salvo che sia disposto
diversamente” e, in secondo luogo, dal riferimento alle sentenze di non luogo a
procedere.
Nel primo caso, con l’espressione “salvo che sia disposto
diversamente”, il legislatore ci ha voluto dire che possano esserci ipotesi in cui si
31
dia esecuzione alla sentenza non irrevocabile; qui si sta facendo riferimento al
fenomeno della c.d. "esecuzione provvisoria delle sentenze", che riguarda le
ipotesi in cui, appunto, certi provvedimenti del giudice, ancorché non irrevocabili,
sono immediatamente esecutivi; si può fare l’esempio di un comando che, benché
contenuto in un provvedimento di condanna, non ha affatto un contenuto
sanzionatorio penale: può trattarsi per esempio, di una decisione che attiene ai
“capi civili” della sentenza. In proposito, infatti, a conferma di ciò l’art. 540 c.p.p.
dispone che “la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno venga
dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando
ricorrano giustificati motivi”, stabilendo, al secondo comma, la immediata
esecutività della condanna al pagamento della provvisionale ex art. 539 c.p.p.
Stesso discorso vale nell’ipotesi di una decisione concernente misure di sicurezza,
la cui applicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 312 c.p.p., può essere disposta in
ogni stato e grado del procedimento, se sussistono le condizioni previste nell’art.
medesimo. Nel secondo caso, invece, a proposito delle sentenze di non luogo a
procedere, vediamo bene che questa ultime non rientrano nella categoria dell’art.
648 c.p.p., in quanto emesse all’esito dell’udienza preliminare, ma, tuttavia, ciò
non toglie che esse non possano avere esecuzione, infatti, nell’art. 650 co. 2 c.p.p.
è espressamente detto che questa diventano esecutive quando cessano di essere
soggette ad impugnazione. Le sentenze di non luogo a procedere « non acquistano
mai autorità di cosa giudicata, perché in esse la negazione della pretesa punitiva
non è obbiettivo giuridico, ma causa giustificatrice della inopportunità di un
definitivo giudizio in sede di dibattimento»55; ma la ragione per cui il legislatore
ha ritenuto di non dar loro la caratteristica della irrevocabilità, ma solo quella
della esecutività, risponde più che altro a una esigenza di coerenza logica in
quanto si tratta di provvedimenti che sono sottoponibili a revoca, ai sensi dell’art.
434 ss. c.p.p., per cui sarebbe stato contraddittorio definire “irrevocabile” un
provvedimento che per sua natura è revocabile.
Una questione particolare è quella che attiene al c.d. giudicato parziale. Va,
innanzitutto, premesso che, ogni procedimento, come può riguardare un solo
imputato e una sola imputazione, può anche riguardare più imputati e, pertanto,
55
Vannini O., Manuale di diritto processuale penale italiano, Milano, 1953,p. 567.
32
avere ad oggetto più imputazioni (c.d. processo cumulativo). Ora, nel corso del
processo, l’imputato o gli imputati possono scegliere di proporre impugnazione
soltanto relativamente ad alcuni “capi” della sentenza, ossia la parte della sentenza
che potrebbe essere oggetto di una autonoma decisione, oppure possono proporre
impugnazione soltanto contro alcuni “punti” ( “punto” della sentenza è quella
singola tematica che deve essere risolta per decidere una o più imputazioni).
Evidentemente, rinunciare a impugnare un “capo” di imputazione della sentenza
cumulativa, comporta che questa diventerà irrevocabile relativamente a
quell’imputato e a quel capo, in quanto non è stata proposta impugnazione.
Dall’altra parte, la proposizione dell’impugnazione nei confronti soltanto di alcuni
“punti”, genera una “preclusione” ad una eventuale successiva contestazione su
quei punti che non hanno costituito oggetto dell’impugnazione..
Nell’ipotesi in cui non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo
della sentenza si è in presenza di un “giudicato parziale”, nel senso che la sentenza
relativamente a quel capo diviene irrevocabile e, quindi, eventuali nuovi elementi
sopravvenuti non possono più incidere in quel processo su quella imputazione, ma
dovranno eventualmente formare oggetto di un altro procedimento, quello di
revisione. In prima lettura, sembrerebbe potersi fare lo stesso discorso anche in
relazione ai casi di preclusione, tenendo presente che anche in questa ipotesi
l’esame del “punto” che non ha costituito oggetto di impugnazione, è precluso
all’esame del giudice a i poteri di iniziativa delle parti. Tuttavia, il nostro
ordinamento fissa una disposizione, contenuta nell’art. 129 c.p.p., che, in
applicazione al principio del favor rei, stabilisce, l’obbligo della immediata
dichiarazione di determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del
processo, ai fini della cui applicazione è di fondamentale importanza la
distinzione tra capi della sentenza divenuti irrevocabili e capi o punti rispetto ai
quali invece, si è verificata soltanto una preclusione. Nel primo caso, infatti, la
decisione non può più essere modificata, in quel processo; nel secondo caso, non
essendo l’accertamento divenuto definitivo, ma sussistendo soltanto una
preclusione di natura processuale, il giudice dovrà applicare l’art. 129 c.p.p. ogni
qual volta ne ricorrano, a suo avviso gli estremi.
33
Dunque, l’effetto di cosa giudicata, può riguardare anche soltanto parte di una
decisione, la quale, appunto, si scinderà dalle altre parti, diventando irrevocabile
e acquistando efficacia esecutiva, mentre le altre continueranno a essere oggetto di
valutazione del giudice: è il caso dell’annullamento parziale pronunciato dalla
Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 624 co 1° c.p.p..
Di “giudicato parziale” in senso proprio, è infatti, possibile parlare solo nel caso
in cui, di una sentenza, vengano annullati uno o più capi; questa ipotesi sembra
appunto trovare una soluzione proprio nell’art. 624 c.p.p. ( Se l’annullamento non
è pronunziato per tutte le parti della sentenza, questa ha autorità di cosa
giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte
annullata...). Con tale espressione, si intendono quelle disposizioni idonee a
esaurire il contenuto di una sentenza, « tale che le pene inflitte con le disposizioni
non annullate sono immediatamente eseguibili »56; « laddove si sia di fronte a
“questioni” che, se pur autonome logicamente, non siano idonee a costituire
pronunce autosufficienti, non è corretto definirle oggetto di giudicato:
semplicemente il loro esame è precluso in sede di rinvio »57. Il secondo comma ,
poi, precisa che “la corte di cassazione, quando occorre dichiara nel dispositivo
quali parti della sentenza diventano irrevocabili “: è questo un rovesciamento
dell’abrogato disposto dell’art. 545 co. 2° c.p.p. 1930 che faceva riferimento alla
necessaria indicazione delle parti della sentenza, sopravvissute.58
Tutte le volte in cui l’impugnazione si limiti ad investire solo talune questioni, le
altre diventano irrevocabili con una specie di « formazione progressiva » del
giudicato59; cosicché, i “punti” della decisione non investiti dai motivi di appello,
sarebbero res iudicata e non proponibili in sede di ricorso. Nel vigente c.p.p., si
dice che su quei punti della decisione non oggetto dell’annullamento con rinvio, si
determina il giudicato solo congiuntamente alla irrevocabilità, dell’intero ; la
formazione progressiva del giudicato va intesa nel senso di dare esecutività
56
Cass., Sez., II, 27.3.1981, in Mass. Uff., 149410; Cass. Sez., I, 9. 12.1987, in Mass.
Uff.,,175076; Cass., Sez., I, 13.6.1987, in Mass. Uff., 177891.
57
Cass., Sez., VI, 17.1.1985, in Mass. Uff., 168851.
58
Giovene, A., Giudicato, in Digesto, ed. IV, vol. V, UTET penale, 1991, p. 440.
59
Cordero, Procedura penale, Milano, 1987, p. 790.
34
progressivamente a quelle parti della sentenza le cui questioni siano logicamente
connesse con quelle oggetto dei motivi dell’appello (i c. d. punti della decisioni)60.
L’altro problema che si pose, agli occhi della dottrina e della giurisprudenza, era
quello che concerneva l’interpretazione e quindi, il significato da attribuire alla
espressione “parti della sentenza”; in quanto, mentre la locuzione “ autorità di
cosa giudicata”, ha un esatto significato, lo stesso non può dirsi per il termine
“parti della sentenza”. Vari furono gli orientamenti interpretativi, ma alla fine
furono le Sezioni Unite della Cassazione61 (Cass., sez. un. 19 febbraio 1988- 23
novembre 1990, Agnesi) a risolvere espressamente il problema interpretativo
suddetto, affermando che con il termine “parti della sentenza” deve intendersi “
qualsiasi situazione avente una autonomia giuridico-concettuale” e quindi, questo
va riferito non solo alle questioni che concludono il giudizio in relazione ad un
determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che nell’ambito di una stessa
contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame” .
L’autorità di cosa giudicata deriva dalla “irrevocabilità della pronunzia in
relazione al rapporto processuale”; diversa è, invece, la eseguibilità che deriva
dalla formazione di un titolo esecutivo.
Infine, con la sentenza Cellerini del 19 gennaio 1994, la Suprema Corte ha
approfondito il concetto di “parti non annullate della sentenza”, precisando che
per tali “devono intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai esaurita ogni di
decisione nel merito e che hanno così acquistato perché definitive autorità di cosa
giudicata”. Infine, per “connessione essenziale”, dobbiamo intendere l’ipotesi in
cui la parte annullata costituisce una premessa indispensabile rispetto a quella non
annullata.62
60
Giovene, A., Giudicato, in Digesto, ed., IV, vol. V, UTET penale, 1991, p. 440-1.
Cass. Sez. un., 23 novembre 1990, Agnesi.
62
Tonini P., Manuale di procedura panale, cit., p.837.
61
35
7. I limiti dell’efficacia del giudicato penale.
Il problema si pone in questi termini, ossia occorre capire se il giudicato penale
abbia o no efficacia anche in rapporto a persona diversa da quella nei cui confronti
sia stata pronunciata la sentenza irrevocabile.
Giuseppe De Luca, rispetto al problema dei limiti di efficacia del giudicato
penale, faceva un ragionamento molto semplice, egli diceva: « poiché, il
contenuto della sentenza è dato da un giudizio e da un comando » , tutto sta nel
capire se l’autorità, ossia ”quel particolare modo di essere che la legge attribuisce
alla sentenza”, si riferisce, appunto, al giudizio o al comando. Perché, è chiaro,
nel primo caso, è proprio per una « esigenza logica, che la decisione spieghi
efficacia nei confronti dei terzi», e non , si può dire che questo trova un limite
nell’oggetto del processo, perché « un giudizio, assistito da tale autorità, possiede
l’attitudine a svincolarsi dal processo in cui è sorto, per espandersi e proiettarsi nel
futuro fino a coinvolgere le posizioni dei terzi rispetto ai quali si ripresenti una
situazione identica a quella decisa ». Se invece, l’autorità la si riferisce al
comando, «è naturale, che la decisione, sia limitata all’oggetto del processo e
l’efficacia che ne deriva sarà limitata alle sole parti del processo ».
Tutta la storia dell’evoluzione dell’istituto della cosa giudicata è oscillato tra
questi due poli a seconda che si desse prevalenza all’uno o all’altro momento.
Partendo dalle origini, vediamo che nell’esperienza giuridica del diritto romano, si
aveva un idea di giudicato nel senso che quest’ultimo era idoneo a esplicare la sua
efficacia soltanto nei confronti delle parti del processo, ma questa concezione
rispondeva più che altro a un criterio di natura pratica: il giudicato non era altro
che una « regola pratica di procedura, diretta a soddisfare un bisogno pratico, per
cui una volta conseguito lo scopo, attraverso il comando, questo era destinato a
perdere ogni rilevanza63» (“res iudicata condemnatione vel absolutione
contingit”)64. All’epoca vigeva, dunque, la limitazione soggettiva del giudicato,
“res iudicata aliis non praeiudicat “, per cui la res iudicata inter alios non poteva
valere neanche nei confronti del complice; tale principio, rimase fermo per tutto il
periodo del diritto intermedio, e anzi, era sentito come espressione di esigenza di
63
64
De Luca, G., I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 40 ss.
Fr.1, Dig. De re iud., 42.1.
36
equità e di certezza (sicurezza) dei diritti. (“sententia lata contra unum non
praeiudicat sociis vel aliis in conseguentiam )65. Anche Baldo era dello stesso
avviso; egli, infatti, affermava, il principio della “invulnerabilità del terzo”, sia
pure esso complice, di fronte al giudicato intervenuto nei confronti dell’attore
principale. ( “In accusatione criminali sententia cum uno lata, aliis non
praeiudicat”); c’è poi da tener presente che tale principio della limitazione
soggettiva del giudicato, non valeva soltanto con riguardo alle sentenze di
condanna, ma anche rispetto a quelle di assoluzione (“ sententia absolutoria lata
pro criminoso non proderit sociis utpote quod separatae sunt eorum causae, licet
fere sit unum factum”). Alla base di tutto questo ragionamento, c’era « l’esigenza
di certezza del diritto…e l’esigenza di evitare che il singolo fosse sottoposto ad
una irragionevole e illimitata reiterazione dei giudizi »66.
Il principio della efficacia erga omnes del giudicato, si manifesterà, soltanto più
tardi, con le prime codificazioni e all’interno di una concezione dell’ordinamento
giuridico, come organismo unitario di norme,
legato alla corrente del c.d.
legalismo giuridico, secondo il quale, l’attività del giudice, lungi dall’essere
attività creativa, era “ingabbiata” all’interno di uno stretto sillogismo giuridico,
all’interno del quale, il giudice, avrebbe dovuto solo, in quanto “ bocca della
legge”, limitarsi a dare un giudizio di legalità, cioè un giudizio di conformità alla
legge. La sua attività era «condotta su un piano rigorosamente logico e formale e si concludeva – con un atto autoritativo di un organo dello Stato»; premesso ciò,
era evidente che al giudicato gli andava attribuita la capacità di imporsi con
efficacia erga omnes; in altre parole, quel giudizio che era frutto di una attività
rigorosamente logica e formale, condotta attraverso l’utilizzo del metodo
sillogistico, era, dunque, per natura, vero e pertanto, avrebbe dovuto avere
efficacia in tutti i processi in cui quella stessa questione, si fosse ripresentata;
quindi, l’utilizzo del metodo sillogistico era considerato, non solo come «
strumento di deduzione, ma anche e, soprattutto, come strumento di acquisizione
della verità».67
65
Zasio, in Dig. 42, 1, 63 de re iudicata, n. 76 ss.
De Luca, G., I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 91 ss.
67
Chiovenda, G., Principi sul processo penale, p. 401-2.
66
37
Arturo Rocco, scriveva così: «la cosa giudicata è l’accertamento, il
riconoscimento e la convinzione della verità, o in una parola, la certezza, e poiché,
della certezza, non è lecito dubitare, è naturale, il dire che la cosa giudicata sia la
verità»68; inoltre, nel caso di concorso di reato, egli diceva che il giudicato
formatosi sulla sentenza, emessa contro l’autore principale, avrebbe chiaramente
vincolato, la successiva decisione del giudice chiamato a giudicare il complice;
tutto ciò, si traduce, in altri termini in una « limitazione della giurisdizione »,
qualora, si ripresenti in un successivo giudizio, quella stessa questione, già decisa
irrevocabilmente in un precedente giudizio.69 La formulazione di una efficacia
che si estendesse erga omnes del giudicato penale, nasce dal fatto, che
progressivamente, l’originario concetto romanistico di cosa giudicata, dall’ essere
circoscritto al solo momento imperativo della decisione, finì per subire un
processo di alterazione in due sensi: uno all’interno del processo, l’altro
all’esterno. All’interno, il giudicato, si estese ai motivi della decisione, con la
conseguenza di attribuire al giudicato un valore tale da andare oltre l’ambito del
processo nel quale il giudizio si era formato; invece, all’esterno, si ebbe che, al
giudicato, venne progressivamente attribuita una efficacia vincolante erga omnes,
nel senso che « le ripercussioni logiche della sentenza non si arrestavano di fronte
ai terzi che, invece erano costretti a subirne le conseguenze.»70. Su questo punto,
in realtà, la Cassazione, era stata molto chiara, in una sentenza, aveva
espressamente affermato il principio della limitazione soggettiva del giudicato: «
la parte dispositiva della sentenza costituisce la decisione del giudice, mentre la
motivazione, ha un valore documentario di mezzo a fine, che attesta per quali
ragioni, il giudice è pervenuto a una determinata statuizione; ove, poi, vi siano più
imputati e la sentenza del primo giudice sia diventata irrevocabile per uno di essi,
non potrebbe mai sostenersi il giudicato sull’accertamento dei fatti nei confronti
68
Rocco, A., Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell’azione penale, Modena,
1900, p. 266.
69
Rocco, A., Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell’azione penale, cit., p.
271.
70
De Luca, G., I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 166 ss.
38
degli altri appellanti, i quali hanno tutto l’interesse a che sia rivalutato ed
eventualmente completato il materiale probatorio ».71
Nonostante ciò, la dottrina processualpenalista era orientata nel senso di dare al
giudicato penale efficacia erga omnes, intesa non nel senso che essa dovrebbe
valere nei confronti di tutti e come tale non possa essere oppugnata; ma nel senso
che alla sentenza debba essere riconosciuta una efficacia vincolante positiva,
rispetto ad altri giudizi penali, instaurati nei confronti di terzi, nei quali si
ripresenti la stessa questione di fatto o di diritto già decisa; su questo punto, poi, si
cercarono di dare varie giustificazioni. Da una parte c’era chi riteneva di trovare
una spiegazione del fenomeno, nel carattere pubblicistico e nella struttura stessa
del processo penale, ma anche sulla convinzione della natura del giudicato come
espressione di verità72; chi ancora, vedeva nell’ accertamento della sentenza
penale un « valore obbiettivo », e in quanto tale, non poteva essere limitato alla
persona, nei confronti della quale fosse stata esercitata l’azione penale, ma doveva
estendersi anche ai terzi, sia che si trattasse di sentenza di assoluzione, che di
condanna.73
Dall’altra parte, c’era chi tentava di giustificare l’ estensione dell’efficacia del
giudicato erga omnes, nel fenomeno del rapporto di pregiudizialità tra i reati. A
tal proposito, si affermava, che avesse efficacia vincolante positiva: 1) il giudicato
formatosi sul reato presupposto, rispetto al reato dipendente74; 2) il giudicato
formatosi nei confronti dell’autore principale, rispetto ai compartecipi; 3) per
quanto riguarda poi, il concorso di più persone nello stesso reato, si diceva che : «
è la stessa unità del reato che implica l’assoluta impossibilità di convivenza tra un
giudicato che garantisce ad un imputato di concorso in un reato il riconoscimento
della insussistenza del fatto e, un altro che, nei confronti di un altro imputato di
concorso nel medesimo reato dichiara il farro sussistente.75 ».
71
Cassazione, 5 febbraio 1952, in Giust. Pen., 1952, II, c. 803; e Cass., 4 aprile 1952, in Giust.
Pen., 1952, III, c. 489.
72
Manzini, V., Diritto processuale penale italiano, v. IV, Torino, 1949, p. 440. e, Rocco, A.,
Trattato sulla cosa giudicata come causa di estinzione dell’azione penale, v. I, Modena, 1900, p.
229.
73
Santoro, Manuale di diritto processuale penale, Torino, 1954, p.396 e, Bellavista, Lezioni di
diritto processuale penale, Milano, 1960, p. 448.
74
Leone, G., Trattato di diritto processuale penale, Napoli, 1961, v. III, p.330 e, Foschini, La
pregiudizialità nel processo penale, Milano, 1942, p. 392.
75
Leone, G., Trattato di diritto processuale penale, Napoli, 1961, v. III, p.330.
39
Ma c’era chiaramente anche chi, al contrario, propugnava la tesi della assoluta
insensibilità del terzo di fronte al giudicato penale, qualunque fossero stati i
legami tra i reati o fra i soggetti che avessero concorso a realizzarli.76 Ben presto,
infatti, ci si accorse che attribuire una tale efficacia al giudicato penale, avrebbe
potuto comportare gravi iniquità nei confronti dei terzi; cominciò, allora, a
emergere una concezione assai più restrittiva e più sensibile a un generale
principio di favor rei.
In passato, il problema relativo al fenomeno della efficacia erga omnes, si è
prestato a varie soluzioni interpretative elaborate dalla dottrina; il punto di
partenza era capire “ quanto e perché, i terzi, sebbene terzi e non parti, dovrebbero
comportarsi secondo la cosa giudicata altrui”77; il problema, si poneva con
particolare attenzione proprio in materia di processo penale, in cui, « oggetto
dell’accertamento, è non già la fattispecie penale, ma l’effetto che ne consegue,
cioè il dovere di punire; - e appunto, bisogna capire, se- l’accertamento del dovere
di punire , possa spiegare efficacia verso i terzi tutte la volte, in cui viene a
costituire il presupposto, positivo o negativo, della esistenza di altri rapporti»78.
Lo stesso Carnelutti, era contrario alla possibilità di una efficacia erga omnes del
giudicato, ma questo perché, secondo lui, il giudicato, si risolve nel puro e
semplice ne bis in idem, e perciò, quello che rileva ai fini del giudicato, non è
tanto l’accertamento contenuto nella decisione, ma piuttosto, il fatto della
sentenza, cioè la sentenza come fatto giuridico”79. Egli faceva, a tal proposito, un
esempio: « se la condanna di Tizio per furto potesse pregiudicare la situazione di
Caio, imputato di ricettazione della cosa proveniente da quel furto, ciò si
risolverebbe in senso negativo, perché oggetto della decisione sarebbe il reato di
Tizio e non il reato di Caio, così che il giudice investito della cognizione di
76
Venditti, Cosa giudicata penale. Efficacia riflessa in altri giudizi, in Arch. riv. giur., 1950, p.
602.; Ondei, Inesistenza dell’efficacia riflessa dei giudicati penali, estr. dalla Giust. Pen., 1948;
Addamiano, Sulla ininfluenza del giudicato penale nel processo penale, in Arch. pen., 1951, II, p.
169 ss.
77
Carnelutti, F., Efficacia diretta ed efficacia riflessa del giudicato penale, in Questioni sul
processo penale, Bologna, 1950, p. 89.
78
Carrnelutti, F., Efficacia diretta ed efficacia riflessa della cosa giudicata, in Riv. dir. comm.,
1923, I, p. 6.
79
Carnelutti, F., Principi sul processo penale, cit., p. 264.
40
quest’altro reato non dovrebbe essere vincolato a ritenere la furtività della cosa
acquistata dall’imputato.80»
È stato, invece, da alcuni sostenuto che, qualora la sentenza passata in giudicato,
fosse stata emanata con la formula “il fatto non sussiste”, il giudicato stesso
avrebbe avuto efficacia erga omnes; e questo perché prosciogliere per
insussistenza del fatto, corrisponderebbe alla « dichiarazione giudiziale che
nessuna persona ha mai potuto commettere il fatto, perché tale fatto non è mai
accaduto»81; accanto a questa si affiancò sulla base dello stesso ragionamento,
l’idea che, anche per la sentenza di proscioglimento, emessa con la formula “ il
fatto non è previsto dalla legge come reato”, il giudicato dovesse assumere
efficacia erga omnes;, addirittura, ci fu chi, sulla scia della suddetta
interpretazione, si spinse a estenderla anche alle ipotesi di proscioglimento basato
sulla presenza di una causa obbiettiva di estinzione del reato. Anche in questo
caso, si diceva: quella dovrebbe valere come dichiarazione che quel reato da
chiunque commesso debba considerarsi estinto), e, ancora, a sostegno di questa
tesi c’era l’ulteriore argomentazione, secondo la quale, nel caso di
proscioglimento per insussistenza del fatto, un eventuale nuovo procedimento e
dunque, una eventuale sentenza di condanna, sarebbe caduta nel nulla, in quanto
sarebbe stata esposta ad un giudizio di revisione, ex 579 c.p.p. abr.
Ma, questa teoria venne duramente criticata, in quanto si diceva che, in ogni caso,
tale affermazione, non era idonea a dimostrare che il terzo avesse potuto
beneficiare dell’accertamento relativo alla insussistenza del fatto nel caso in cui
quel fatto stesso fosse stato oggetto di un nuovo processo concernente altra
persona; e anche l’affermazione che nell’ipotesi di proscioglimento per
insussistenza del fatto, la sentenza di condanna emanata contro un terzo e avente
ad oggetto l’accertamento del fatto in precedenza dichiarato insussistente, sarebbe
destinato a cadere nel nulla attraverso il giudizio di revisione, non reggeva, in
quanto, se,
pur non essendo i fatti posti a fondamento delle due sentenze
irrevocabili, fosse errata la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto,
anziché quella di condanna, non sarebbe stato possibile, quell’accertamento
80
81
Carnelutti, F., Lezioni sul processo penale, v. IV, Roma, 1949, p.86.
Vannini, O., Manuale di procedura penale italiana, Milano, 1953, p. 256.
41
previsto all’art. 555 c.p.p. abr., per cui la sentenza di condanna non avrebbe
potuto essere annullata.
Taluni, propugnavano l’idea di giudicato, « come verità universale, che ha le sue
radici nei principi della cosa giudicata e che è destinata a staccarsi dall’alveo del
processo in cui si è formato per vivere di una vita autonoma e per essere
“esportato” in altri giudizi, che si svolgono nei confronti dei terzi, in cui si
ripresenti la stessa questione già irrevocabilmente decisa »82
Qualcun altro, poi, affermò che, « quando si tratti di reato, l’accertamento se il
fatto sussiste e se costituisce violazione della legge penale, è di pubblico interesse
e quindi va oltre il rapporto personale del soggetto di fronte al quale si svolge
l’azione penale; e lo stesso deve dirsi quando non si tratti l’oggetto della
imputazione, ma di un reato che sia presupposto giuridico di un altro giudicato di
fronte alla stessa persona; se il giudice decide che il fatto non sussiste o non
costituisce reato, la stessa indagine non è poi ammessa per accertare il reato che
abbia per suo presupposto l’esistenza di quel fatto ».83; peraltro, alcuni, sempre in
questo senso, estendevano l’efficacia vincolante del giudicato, non solo all’
assoluzione per insussistenza del fatto e per inesistenza del reato, ma anche al
caso di insufficienza di prove.84
In generale, la possibilità di estendere gli effetti della cosa giudicata ai terzi, si
basa sulla teoria della c.d. “riflessione della cosa giudicata” , che è quel fenomeno
per il quale «la determinazione del rapporto già giudicato, rimarrebbe immutabile
e si comunicherebbe ad altre persone partecipi di un rapporto dipendente da quello
già deciso oppure a questo connesso ».85
Si parla, in questa ipotesi, anche di efficacia indiretta del giudicato penale, che è
diversa dall’ efficacia diretta. Tale distinzione, proviene della elaborazione della
dottrina processulcivilista. La prima si realizza quando esiste un nesso di
pregiudizialità tra i reati, nel senso che la sussistenza di un reato è condizionato
dall’esistenza di un altro reato; o, ancora, essa si manifesta quando, esiste una
82
Chiovenda, G., Principi sul processo penale, p. 402.
Sabatini, G., Istituzioni di diritto processuale penale, Napoli, 1933, p. 335.
84
Aloisi, Manuale pratico di procedura penale, v. IV, Milano, 1943, p. 522.
85
Guarnieri, Autorità della cosa giudicata penale nel giudizio civile, Milano, 1942, p. 232 ss. e,
Leone, G.,, Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988, p. 328 ss. e, Frasali, Sistema
penale italiano, v. IV, Torino, 1958, p. 95.
83
42
connessione inscindibile tra la posizione del soggetto nei cui confronti la sentenza
passata in giudicato, sia stata emessa e la posizione del terzo (si pensi per
esempio, all’ipotesi di concorso di più persone in un reato).
Più in particolare, in materia di processo penale, si ha pregiudizialità sostanziale
tra fattispecie penali, quando un effetto giuridico (la condanna o l’assoluzione)
entra a far parte, come elemento costitutivo di una fattispecie, e ne condiziona il
prodursi di altri effetti giuridici; diverso è, invece, il fenomeno della connessione,
che si ha quando tra le fattispecie vi è una semplice comunanza di fatti giuridici.
Più analiticamente, possiamo dire che pregiudizialità sostanziale tra reati, si
realizza in talune ipotesi ben precise:
1) la prima categoria è costituita dai reati accessori, che presuppongono
l’esistenza di reati principali ( ad es. ricettazione, favoreggiamento, calunnia …);
in tutte queste ipotesi, infatti, l’esistenza di un precedente delitto, si pone come
presupposto, o meglio, come requisito del nuovo reato. Per esemplificare, nel caso
della ricettazione ( art. 648 c.p. ), possiamo dire che, affinché la ricettazione
esista, la res deve avere provenienza delittuosa; ma, se la ricettazione non è
accertata insieme al reato presupposto, mediante un procedimento cumulativo,
bisogna domandarsi, quale influenza avrà, l’accertamento, del primo reato, (sia
esso positivo che negativo), sul giudice chiamato a giudicare il secondo reato;
oppure in relazione ai reati rispetto ai quali, altri reati presupposti, costituiscono
per essi, cause di esclusione della punibilità o di diminuzione della pena, o ancora
di applicazione di una pena diversa.
2) una seconda categoria, può essere quella in cui una stessa persona sia giudicata
in processi diversi, per due reati in concorso formale tra di loro ( art. 81 c.p.),
poiché identica è “ l’azione od omissione” comune ai due reati, allora anche qui ci
si chiede se l’accertamento relativo all’esistenza o meno, della condotta, effettuato
dal primo giudice possa vincolare effettivamente anche il secondo giudice.
3) altra ipotesi è quella del concorso di più persone nel medesimo reato: in questo
caso, le diverse fattispecie hanno in comune l’evento.
La domanda è :se i
concorrenti, venissero giudicati in processi separati, quale efficacia avrà il
giudicato di condanna o di assoluzione, formatosi nei confronti di alcuni rispetto
al provvedimento instaurato nei confronti degli altri concorrenti? Perché se si
43
ammettesse una efficacia ultra rem del giudicato, il concorrente sottoposto
successivamente a procedimento penale per il medesimo fatto verrebbe a essere
avvantaggiato o pregiudicato dalla sentenza intervenuta nei confronti dell’autore
principale.
4) in ultimo, altra ipotesi è quella di recidiva, abitualità o professionalità; si è
osservato86 come, in questo caso, tra i reati, esista un rapporto di pregiudizialità
che si manifesta sul piano del diritto sostanziale, prima che su quello processuale,
in quanto in questi casi, è la condanna che condiziona l’esistenza del reato.
Contro la teoria della efficacia erga omnes del giudicato, l’art. 90 c.p.p abr.
forniva un importante spunto di riflessione. Dalla lettura di esso e argomentando a
contrario , si poteva ricavare il principio della rigorosa limitazione degli effetti
adversus omnes del giudicato penale, in particolare in quanto, questo, oltre a non
trovare alcun fondamento normativo all’interno del diritto positivo, era più che
altro
in
evidente
contrasto
con
un
fondamentale
principio,
garantito
costituzionalmente, ossia con il diritto di difesa (art. 24 co. 2º Cost. ). I sostenitori
di questa tesi, dicevano che « l’equivoco nel quale si incorreva nel parlare di
efficacia erga omnes del giudicato penale, consisteva nel fatto che, con tale
formula si intende fare riferimento non già alla circostanza, del resto pacifica, che
la sentenza penale, come fatto giuridico debba valere nei confronti di tutti e come
tale non può essere oppugnata, ma sull’altra circostanza secondo cui alla sentenza
penale irrevocabile dovrebbe essere riconosciuta una efficacia vincolante positiva,
diretta o riflessa, nei confronti di terzi (…) che si trovano in un rapporto di
pregiudizialità, col fatto accertato nella prima sentenza passata in giudicato».87
Più di recente, un altro autore88 ha affermato che le ragioni che portano alla
esclusione del principio dell’efficacia assoluta su altro giudicato penale sono: a) l’
art. 649 c.p.p. ( ex art. 90 c.p.p.), se da una parte vieta il bis in idem nei riguardi
dell’ eadem persona, dall’altra parte, non esclude il bis in idem nei confronti di
persona diversa; dunque, ai sensi dell’ art. 649 c.p.p., sarebbe possibile, per
esempio, che ad una assoluzione di Tizio, per insussistenza del fatto, segua
condanna di Caio, per correità con Tizio nel medesimo fatto. Questo dimostra,
86
De Luca, G., Giudicato, (dir. pen.), in Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, p. 912-923.
De Luca, G., Giudicato, (dir. pen.), cit., p. 912-923.
88
Bucolo, F., Sul giudicato penale, in La giustizia penale, 1963, parte III, p. 423 ss.
87
44
chiaramente, come la esclusione pronunciata nella sentenza riguardante Tizio, non
alcuna efficacia preclusiva nel giudizio contro Caio; potrà semmai incidere, « su
ciò che attiene al libero convincimento del giudice», potrà, in altre parole, avere
tutt’al più una “ mera influenza psicologica”; poi chiaramente, nel caso di
eventuale contrasto tra giudicati, toccherà alla corte di Cassazione, decidere in
sede di revisione se l’errore è nella sentenza di assoluzione o in quella di
condanna; con ciò, tenendo sempre presente che, se può revisionarsi il giudicato
di condanna, per trasformarlo in assoluzione, altrettanto non può dirsi per quello
di assoluzione che resta sempre nella posizione di intangibilità; b) dal carattere del
processo penale, il quale si “ personalizza” nella figura dell’imputato, non può a
questo opporsi un giudicato emesso in altro processo penale di cui egli non ne
fece parte; perciò, a escludere che il giudicato penale possa far stato in un altro
giudizi penale riguardante un diverso imputato, sono proprio 1) il principio del
contraddittorio, principio garantito costituzionalmente, il quale si attua appunto
con la “contestazione, con l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza
dell’imputato”; 2) il principio del libero convincimento del giudice, che “respinge
ogni specie di prova legale e di verità formale e si ispira alla ricerca della verità
sostanziale.
Inoltre, secondo tale Autore, il giudicato penale, non fa stato in altro giudizio
penale, nemmeno con riguardo alle “questioni pregiudiziali ad altro procedimento
penale”.
Altrettanto recentemente, a confutare la teoria della efficacia del giudicato rispetto
ai terzi, c’è stato da una parte chi, partendo proprio dal fatto che essa costituisce
violazione del diritto di difesa, costituzionalmente sancito all’art. 24 co. 2° Cost.,
propose una forma, pressoché atipica di giudicato: ossia un giudicato che operi
solo eventum litis, cioè solo in utilibus dei terzi: si diceva , cioè, che il giudicato
dovesse esplicare la sua efficacia nei confronti dei terzi, ma esclusivamente in
riferimento alle sole sentenze di assoluzione, emesse con la formula “il fatto non
sussiste”.89
Ma anche questa teoria non andò esente da critiche in quanto si osservava,
giustamente, che, in tal modo, si finiva per dare al giudizio del giudice, basatosi
89
Manzini, V., Trattato di diritto processuale penale italiano, IV, Torino, 1949 e Aloisi, Manuale
pratico di procedura penale, IV, Milano, 1943.
45
esclusivamente sulla sua conoscenza storica di quel fatto, valore di verità assoluta,
obbiettiva e universale; ma il giudizio che il giudice dà ha carattere relativo e
cogente, proprio perché esso si basa sul materiale probatorio che in quel momento
egli ha a disposizione, con la conseguenza che se tale materiale probatorio
dovesse cambiare, anche il giudizio verrebbe a modificarsi90; e, dunque, un terzo
contro il quale fosse fatto valere un giudicato di condanna verrebbe a essere
«espropriato della verità»91.
8. L’efficacia extrapenale del giudicato: a) considerazioni
introduttive.
Come si è sopra detto, il giudicato penale, genera sostanzialmente due effetti:
quello preclusivo e vincolante92. Il primo si sostanzia nell’ impossibilità per cui
l’imputato prosciolto o condannato sia di nuovo sottoposto a procedimento penale
per il medesimo fatto storico, preclusione contenuta nella disposizione dell’art.
649, co.1º ( c.d. divieto di bis in idem ). Invece, l’effetto vincolante del giudicato
produce l’obbligo per gli altri giudici di ritenere “vero” il fatto accertato; ma su
quest’ultimo punto, occorre fare una ulteriore distinzione, tra come questo effetto
vincolante si pone in relazione ad altri processi penali piuttosto che all’interno di
successivi giudizi civili o amministrativi.
Nel primo caso, occorre sottolineare che la sentenza penale irrevocabile non ha
alcun effetto vincolante nei confronti di altri processi penali, e per altri,
intendiamo, sia l’ipotesi di nuovo processo sul medesimo fatto, ma contro altri
imputati, in cui, evidentemente, il giudice potrà accertare nuovamente il
medesimo fatto storico, e potrà ritenere che esso sia stato commesso con diverse
modalità, o perfino che esso non è estinto; sia il caso di un successivo processo
penale, questa volta, contro il medesimo imputato, ma avente ad oggetto un fatto
storico diverso. In quest’ultimo caso, il giudice, potrà valutare diversamente le
prove già considerate nella precedente sentenza in cui era già stato accertato quel
90
Leone, G., Trattato di diritto processuale penale, Napoli, III, 1961, P. 330 e 335; II, p. 336. e,
Foschini, G., La pregiudizialità nel processo penale, Milano, 1942, p. 243-246 e, Calamandrei, G.,
La sentenza civile come mezzi di prova, in Studi sul processo civile, I, Padova, 1947, p. 162 ss.
91
Capograssi, Prefazione alla certezza del diritto, p. 14.; e De Luca, G., I limiti soggettivi della
cosa giudicata penale, Milano, 1963, p.66.
92
Tonini, P., Manuale di procedura penale, 9ªed. Giuffrè editore, 2009. p. 805 ss.
46
fatto. In entrambe le ipotesi, dunque, la sentenza irrevocabile di condanna, non
produce effetto vincolante nei successivi processi penali, e ciò si capisce bene,
mancando, nel primo caso, il requisito del “medesimo imputato” e nel secondo
quello di “medesimo fatto”. La sentenza irrevocabile ha un’efficacia preclusiva
soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione, al medesimo fatto.
Per quanto riguarda, invece, l’efficacia del giudicato in altri giudizi civili o
amministrativi, il legislatore, ha predisposto, a tal riguardo, una apposita
disciplina contenuta negli artt. 651-654 c.p.p.
Sotto questo aspetto, il nuovo codice di rito è stato piuttosto rivoluzionario, in
quanto, con la sua entrata in vigore, ha segnato una completa rottura rispetto al
passato: in particolare, esso ha apportato il pieno superamento della vecchia
impostazione di derivazione ottocentesca, teorizzata,in particolar modo, da
Ludovico Mortara. Essa patendo dal principio della unità della giurisdizione, si
fondava poi, su due principi fondamentali: il primato della giurisdizione penale,
vista come quella che si esercita nell’interesse della collettività e, dunque,
precedenza obbligatoria del processo penale; e sulla conseguente forza vincolante
del giudicato in esso formatosi. Questa teoria, in verità, era già nota al nostro
ordinamento, essendo, infatti, posta quale fondamento della disciplina stabilita
all’art. 13, co. 1,º c.p.p. 1913 : « Nel giudizio civile per il risarcimento del danno,
promosso o proseguito dopo la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, questa
ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del
risarcimento». Da essa, derivò, poi, un’ulteriore regola non scritta ma considerata
quale jus receptum, secondo cui, le prove raccolte in sede penale sarebbero state
destinate a rivestire nel giudizio civile o amministrativo la medesima efficacia che
avrebbero avuto se fossero state raccolte direttamente in quel giudizio. Nel codice
di procedura penale del 1930, essa, invece, trovava compiuta formulazione
nell’art. 3. c.p.p. .; e ulteriore conferma era contenuta nell’art. 295 c.p.c, che fino
al 31 dicembre 1992, recitava così: « Il giudice dispone che il processo ( civile )
sia sospeso nel caso previsto dall’art. 3 c.p.p. e in ogni altro caso in cui egli debba
risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende
l’esito della causa». Infine, l’art. 24 co. 2º c.p.p., che si poneva rispetto all’art. 3
in rapporto di genus a species, disponeva che l’azione civile per restituzioni e/o
47
risarcimento dei danni da reato doveva essere sospesa fino a che sull’azione
penale, non fosse intervenuta sentenza irrevocabile dibattimentale o sentenza
istruttoria di proscioglimento non più impugnabile. Era, inoltre, previsto che,
qualora si fosse manifestato nel giudizio civile un fatto nel quale fosse stato
possibile ravvisarsi un reato perseguibile d’ufficio o a querela, il giudice, avrebbe
dovuto farne rapporto al procuratore della Repubblica.
Identiche regole, poi, erano previste per i giudizi davanti alle giurisdizioni
amministrative e per i giudizi disciplinari davanti alle autorità pubbliche.
Nessuno, dunque, dubitava che alla decisione penale fosse attribuita forza
imperativa per il giudice extrapenale.
La prima conseguenza di tutto ciò era la sottrazione di determinati “oggetti” di
conoscenza all’autonomo potere di accertamento del giudice extrapenale, e questo
si verificava, in particolare,
nelle ipotesi contemplate negli art. 25, 27 e 28 abr.; dai quali la dottrina fece
derivare tre tipi di vincoli per il giudice extrapenale. Nel primo, tale vincolo si
concretizzava nella «improponibilità», «improsegiubilità» o «non riproponibilità»
dell’azione civile in sede propria, allorquando in un precedente processo penale
fosse stata dichiarata la insussistenza del fatto o la non attribuibiltà dello stesso
all’imputato, o la sua commissione ma nell’esercizio di una facoltà legittima o
nell’adempimento di un dovere93.
Nel secondo e nel terzo, si configuravano, invece, veri e propri vincoli di carattere
decisorio per il giudice nel giudizio extrapenale; in particolare, l’art. 27 poneva il
divieto al giudice extrapenale di mettere in discussione « la sentenza o il decreto
penale di condanna pronunciato contro il colpevole o il responsabile civile, quanto
alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato».
Per ultimo, l’art. 28 finiva, poi, per completare il quadro già delineato dalle
precedenti disposizioni, statuendo che dalla sentenza irrevocabile di condanna o di
proscioglimento dovesse discendere un effetto vincolante nel giudizio extrapenale
quando quest’ultimo avesse avuto ad oggetto un diritto, il cui riconoscimento
dipendesse dall’accertamento dei materiali oggetto del giudizio penale. Questi
93
Sul punto vedi, Terrusi, F., Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo, in Digesto
delle discipline penalistiche, vol. XI, UTET, Torino, 1996, p. 31-47
48
vincoli, secondo qualcuno94, « non attenevano alla potestà di ius dicere del
giudice extrapenale, ma si riferivano, esclusivamente all’oggetto su cui esso
poteva vertere, tanto che, si riteneva che, non la giurisdizione fosse diversa, ma le
materie attribuite ai diversi organi all’ interno dell’unica giurisdizione dello
Stato». Si capisce bene, dunque, quanto gli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. abr. risentissero
fortemente di quella concezione da cui discendeva quale corollario l’idea della
preminenza della giurisdizione penale su ogni altra diversa giurisdizione,
all’interno di una più generale concezione, basata sull’idea dell’ unicità della
funzione giurisdizionale esercitata dagli organi giudiziari dello Stato Sovrano.
Secondo questa impostazione, infatti, il giudicato penale, sia esso di condanna che
di assoluzione avrebbe avuto efficacia erga omnes nei giudizi civili di danno, così
come in ogni altro giudizio extrapenale che avesse avuto ad oggetto diritti o
interessi il cui riconoscimento giurisdizionale fosse dipeso dall’accertamento dei
medesimi fatti materiali. Ne conseguiva, inoltre, la pregiudizialità penale, ossia la
subordinazione del corso e della sorte dei giudizi extrapenali rispetto alla
formazione del giudicato penale vincolante.
Da un punto di vista meramente processuale, invece, ne derivava la previsione ex
lege della sospensione necessaria dei giudizi extrapenali, fino al momento in cui
nel giudizio penale non fosse stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Evidentemente, tutto ciò, pur non precludendo in assoluto la possibilità di
esercitare l’azione civile nella propria sede naturale, ossia dinanzi al giudice
civile, finiva per spingere il danneggiato a proporre azione penale.
A rompere questo assetto procedimentale fu la Corte Costituzionale, la quale con
due sentenze agli inizi degli anni ’7095, dichiarò l’illegittimità costituzionale degli
artt. 25, 27 e 28 c.p.p., nella parte in cui prevedevano l’efficacia vincolante del
giudicato penale anche nei confronti dei soggetti che non avessero partecipato o
che comunque non fossero stati posti nelle condizioni di partecipare al giudizio
penale, in quanto essi contrastavano palesemente con gli artt. 3 e 24 Cost.
L’intervento della Corte Costituzionale fu decisivo, proprio perché, da quel
momento, si ebbe il venir meno dell’ efficacia erga omnes del giudicato penale
nei giudizi extrapenali e, di conseguenza, si affermò la sua efficacia relativa,
94
95
Terrusi, F., Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo, cit.
C. Cost. n. 55/1971 e C.Cost. n. 99/1973.
49
ossia nei efficacia dei soli confronti dei soggetti che avessero avuto quantomeno
la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in quel giudizio penale. In
altre parole, con la limitazione dell’ effetto vincolante del giudicato alle sole parti
presenti, o quanto meno, poste in grado di partecipare al giudizio penale, si venne
a smantellare radicalmente la vecchia impostazione, di efficacia assoluta, o,
quanto meno, ultra partes del giudicato penale: si posero, così, le basi per una
relativizzazione della sua portata96.
Il valore innovativo dell’ intervento della Corte Costituzionale, con le due
sentenze suddette , finì, poi, per incidere fortemente sulle direttive di politica
processuale dettate dalla l. 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al Governo per
l’emanazione del nuovo codice di procedura penale. Quattro furono i punti
fondamentali di questa legge: 1) innanzitutto, si affermava la generale tendenza
verso l’autonomia e la separazione dei giudizi, i quali avrebbero dovuto essere
preferibilmente promossi davanti al rispettivo giudice naturale; 2) veniva
sottolineata la necessità di circoscrivere la possibilità che il giudicato penale
esplicasse una efficacia vincolante ultra partes limitatamente a quei soggetti che
avessero preso parte al giudizio penale o che quantomeno fossero stati posti nelle
condizioni di parteciparvi; 3) furono, inoltre, posti dei limiti ai casi in cui i
procedimenti extrapenali “ pregiudicati” avrebbero dovuto essere necessariamente
sospesi fino a quando
nel processo penale “ pregiudicante” non fosse stata
pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione; 4) furono,
infine, rafforzati i poteri processuali spettanti alla parte civile costituita. A questo
riguardo, la scelta di fondo era sempre ispirata all’affermazione della separazione
dei processi: nella sostanza, si faceva una distinzione: si voleva dare alla persona
offesa un ruolo meramente “penalistico”, cioè un interesse volto soltanto ad
ottenere la persecuzione penale del reo; mentre al danneggiato, che si fosse
costituito parte civile, un ruolo meramente “civilistico”, cioè volto a tutelarne
l’interesse ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente derivato dal
reato97.
96
Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di Chiavario, VI, Torino,
1989, p. 443.
97
Tonini, P.,Manuale di procedura penale, 9ª ed., Giuffrè editore, 2009, p. 148-149.
50
Il codice di procedura penale del 1988 recepì queste direttive e affermò, così, la
parità dei diversi ordini giurisdizionali e la sostanziale autonomia e separazione
dei giudizi.
In particolare, il venir meno della pregiudizialità dell’azione penale su quella
civile è stato più volte confermato dalla Corte di Cassazione, che, in più occasioni,
ebbe modo di affermare: “Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è più
riprodotta la disposizione di cui all’art. 3, 2° co., del codice abrogato, si deve
ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell’unità
della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo
stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e
separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate
ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75, 3° co., del nuovo
c.p.p., il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal
processo penale e il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento
dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio”98.
Questa nuova impostazione, è stata, tuttavia, attenuata dal riconoscimento al
giudicato penale del valore preclusivo sugli altri giudizi nelle specifiche e limitate
ipotesi descritte dagli artt. 651 e 652 c.p.p. con riferimento rispettivamente al
giudicato di condanna e di assoluzione nel giudizio civile e amministrativo di
danno; dall’ art. 653 c.p.p., relativamente al giudicato assolutorio nei giudizi
disciplinari e, infine, dall’art. 654 c.p.p., con riguardo al giudicato assolutorio o di
condanna negli “altri” giudizi civili o amministrativi. Ma, comunque, essendo tale
efficacia extrapenale del giudicato, una eccezione al principio di autonomia e
separazione tra i giudizi, si è sostenuto, in dottrina, che gli artt. 651-654 c.p.p.,
dovrebbero essere, comunque, oggetto di una interpretazione restrittiva99.
Rimane, ancora, però, un punto sul quale vale la pena interrogarsi. Occorre,
infatti, domandarsi, come vada intesa, alla luce della nuova impostazione, la
correlazione tra l’art. 295 c.p.c., che dispone la sospensione necessaria del
giudizio civile per pregiudiziale trattata da altro giudice e l’istituto del giudicato.
In più occasioni, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul punto,
ribadendo che esso va inteso «nel senso dell’esistenza di una obbiettiva relazione
98
99
Cass. 7 maggio 1997, n. 3992 e Cass. 27 febbraio 1996, n. 1501 in Foro it. 1997, I, 1758.
Catelani, G., Manuale dell’esecuzione penale, 5ª ed., Giuffrè, 2002, p. 186.
51
di pregiudizialità giuridica tra i due giudizi, la quale ricorre solo quando la
definizione dell’antecedente logico della quaestio prejudicata venga postulata con
effetto di giudicato»100. Ne consegue che la sospensione necessaria del processo
civile, oggi, occupa una posizione soltanto residuale; c’è però, un orientamento
giurisprudenziale e dottrinario, secondo il quale rimarrebbe al giudice la
possibilità di applicare l'istituto della sospensione "facoltativa" del giudizio. E’
stato, infatti, osservato che non solo il giudizio civile può pur sempre essere
influenzato da quello penale nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma
anche che alcune fattispecie concrete possono presentare caratteristiche tali da
rendere opportuna una sospensione del giudizio; e le ragioni che legittimano e
giustificano
tale
sospensione
consistono
proprio
nell’evitare
quella
contraddittorietà di giudicati che andrebbe a pregiudicare alla essenza stessa della
giustizia; queste stesse ragioni sono d'altronde richiamate dall'art. 211 disp. att.
c.p.p. Numerose sentenze della Suprema Corte101 hanno, quindi, sottolineato, da
una parte, che « la sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. e' necessaria
solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o
amministrativa pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una
espressa disposizione di legge ovvero quando per il suo carattere pregiudiziale,
costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la
decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con
efficacia di giudicato»; dall'altra, che «al di fuori di questi presupposti, la
sospensione cessa di essere necessaria e, quindi obbligatoria, ma il disporla o
meno rientra pur sempre nel potere discrezionale del giudice di merito, potere
insindacabile in sede di legittimità». Tuttavia, la più recente giurisprudenza di
legittimità si è pronunciata in senso contrario, affermando che, in realtà, non vi è
alcuno spazio per una sospensione «facoltativa» o «discrezionale» del processo,
anzi, deve, piuttosto, escludersi che il processo civile possa essere sospeso dal
giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale102.
100
Cass. civ., Sez. Un., 19.10.1993 CED, Cass., n. 483984; Cass., civ., Sez, I, 29.11.1993, ivi, n.,
484522; Cass., civ., Sez., I, ivi, n., 485406.
101
Cass. Civ. Sez. II, 4 aprile 1997, n. 2905; Cass. Civ. Sez. Un., 19 febbraio 1997; Cass. Civ, 18
gennaio 1985, n. 129; Cass. Civ. 6 febbraio 1982, n. 702.
102
In tal senso, Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14670; ordinanza 25 luglio 2003, n. 11567;
ordinanza 24 novembre 2006, n. 24946.
52
Con l’ordinanza del 28 gennaio 2005, n. 1813 e, più di recente, con l’ordinanza 16
dicembre 2009 n. 26433 la Suprema Corte ha, poi, ribadito che la nuova disciplina
è, ormai, ispirata all'abbandono dell'istituto della sospensione obbligatoria a
favore di quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da
parte di ogni giudice delle questioni giuridiche di fatto rilevanti per la propria
decisione. Ancora, un disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo è stato
sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale detto istituto si
porrebbe in contrasto sia con il canone della durata ragionevole del processo, che
la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo così come previsto ai sensi
dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 3 del 2001, oltre
che con l'analogo principio enunciato dall'art. 6 della Convenzione CEDU, da cui
è derivata la recente L. n. 89 del 2001 in tema di durata irragionevole del
processo; sia con il principio di uguaglianza ( art. 3 Cost.) e di tutela
giurisdizionale ( art. 24 Cost.).
L’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di
danno: b) l’art. 651 c.p.p.
Ai sensi dell’ art. 651 c.p.p., 1º comma, la sentenza penale di condanna
pronunciata in dibattimento, una volta divenuta irrevocabile, ha autorità di cosa
giudicata, ed è quindi vincolante, nel giudizio civile di danno promosso contro il
condannato quanto « all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua
illiceità o all’affermazione che l’imputato lo ha commesso ». Presupposto per
l’applicazione di tale disposizione è che il giudizio civile o amministrativo, nel
quale si richiama l’efficacia penale di condanna, verta sullo stesso fatto
costituente reato e tra gli stessi soggetti.
A differenza dell’abrogato art. 27 del vecchio c.p.p., l’attuale art. 651 c.p.p.,
richiede espressamente che la sentenza sia pronunciata “a seguito di
dibattimento”. Si è voluto, così, limitare l’efficacia vincolante nei giudizi di
danno, alle sole sentenze penali, che si fondano su un accertamento in cui è
garantito
pienamente
il
contraddittorio
e,
perciò,
che
siano
almeno
tendenzialmente più affidabili; per converso, rimangono escluse tutte quelle
decisioni prese in procedimenti caratterizzati da una limitata garanzia per le parti
dell’esercizio del loro diritto di difesa. Ne deriva che non hanno alcuna efficacia
53
sul giudizio civile: a) il decreto penale di condanna, ancorché divenuto esecutivo
ai sensi dell’art. 460, 5º comma c.p.p.; b) le sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti, emesse sia nelle udienze preliminari che nella fase del
giudizio; c) le sentenze di proscioglimento ( estinzione del reato per amnistia e
prescrizione) o di improcedibilità ( mancanza di querela ); d) le sentenze
conseguenti a patteggiamento ( art. 445, co. 1 bis c.p.p.): queste ultime, anche se
sostanzialmente sono sentenze di condanna, perché applicano una sanzione,
rimangono fuori dal campo di applicazione dell’art. 651 c.p.p., in quanto mancano
del presupposto dell’ accertamento della responsabilità103. Ciò trova conferma
espressamente nell’art. 445 co. 1bis c.p.p., il quale nega l’efficacia del giudicato
penale nei giudizi civili e amministrativi alla sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti, pur se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, ai
sensi dell’art. 448 c.p.p.; nonostante ciò, però, non mancano pronunce, in
particolare nella giurisprudenza contabile, secondo cui bisogna riconoscere anche
a tali sentenze autorità di giudicato104.
In genere, però, si sostiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, pur non avendo l’efficacia propria del giudicato, « può essere
liberamente valutata dal giudice (...), quale elemento di cognizione utile a
delineare il quadro probatorio necessario alla pronuncia della responsabilità (…)
»105, in quanto va riconosciuto in esso un « indiscutibile elemento di prova per il
giudice di merito »106. Cioè, in altri termini, si dice che queste sentenze, pur non
avendo efficacia vincolante, nel giudizio extrapenale ( e ciò, senza disconoscere il
dato storico del fatto che sia stata emessa una sentenza applicativa di una pena
negoziata), comunque,
possono, essere prese in considerazione da parte del
giudice civile o amministrativo, alla stregua di ogni altro possibile elemento
probatorio.
Detto questo, però, qualcuno ha rilevato che, se è vero che l’articolo in esame fa
esclusivo riferimento alle sole sentenze pronunciate « in seguito a dibattimento»,
dovranno allora venire in rilievo, anche quelle emesse alla fine di un giudizio
103
Gaito, A., Codice di procedura penale ipertestuale, UTET, 2006, p., 2802.
C. Conti, Puglia, 29-3-99, n. 25
105
C. Conti s.r. 2-10-97, n. 68/A , in R. C. conti 97, f. 4, 71; e C. conti Liguria 17-10-95, n. 89
ivi, 95, f. 5.,116.
106
C. Cass. civile, 24-2-01, n. 2724.
104
54
direttissimo o immediato; questi riti, infatti, per quanto speciali, presuppongono
comunque lo svolgimento di un dibattimento107.
L’art. 651 al comma 2º estende, poi, l’efficacia preclusiva, analoga a quella
riconosciuta al comma 1º per le sentenze pronunciate in dibattimento, alla
sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p. ). Ciò è, tuttavia,
subordinato alla condizione che non vi sia stata opposizione della parte civile che
non abbia accettato il rito abbreviato, o in via esplicita, cioè attraverso
dichiarazione espressa, oppure in via implicita, ossia costituendosi parte civile
dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato o abbandono
del processo prima che abbia inizio la trattazione della causa.
L’esplicito riferimento, poi, alla « sentenza…di condanna » , è servito a impedire
che si continuasse a collegare il vincolo del giudicato alle decisioni che dichiarano
estinto il reato ( per amnistia o prescrizione ), o improcedibile l’azione penale, nel
caso in cui per giungere a una tale declatoria fosse stato necessario accertare il
fatto di reato ascritto all’imputato108.
A differenza di quanto poi avveniva nel c.p.p. abrogato, nel sistema vigente, si è
espressamente previsto che i decreti penali di condanna, pur se divenuti
irrevocabili, non possiedono efficacia vincolante nei giudizi risarcitori; e ciò trova
espressa conferma nell’art. 460, co. 5º c.p.p. ; lo stesso vale per le pronunce di
proscioglimento, per concessione del perdono giudiziale, le quali sono ormai da
considerarsi prive di autorità di cosa giudicata nel giudizio di danno ( sul punto
anche l’art. 10 disp. proc. pen. min. esclude qualsiasi efficacia extrapenale alle
sentenze, sia di condanna che di assoluzione, emesse nel processo penale a carico
dei minorenni)109.
Ma, per meglio specificare l’oggetto del vincolo che deriva dall’art. 651 c.p.p.,
vediamo, dalla lettura dell’articolo medesimo, che il legislatore ha utilizzato una
formula piuttosto dettagliata, basata sul separato riferimento a tre situazioni: ossia,
all’accertamento della « sussistenza del fatto », della sua « illiceità penale » e «
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso ». Con questa formula, il
107
Gaito, A., Esecuzione penale, in AA.VV., Profili del nuovo codice di procedura penale, a cura
di G. Conso- V. Grevi, CEDAM, 1996, p. 925.
108
Spengher, G., Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale, p. 55.
109
Conco-Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, CEDAM, 2005, p.
2204.
55
legislatore sembra alludere alla tradizionale tripartizione del reato in fatto,
antigiuridicità e colpevolezza e, quindi, all’accertamento di tutti gli elementi
necessari e sufficienti a costituire il reato.
Ma vale la pena, a questo punto, soffermarci ad analizzare, più da vicino quali
siano i limiti del “fatto”, e cioè quali siano gli accertamenti materiali rilevanti ai
fini giudizio civile o amministrativo di danno.
Dottrina e giurisprudenza, al riguardo, concordano nel ritenere che nel “fatto”
siano compresi la condotta del colpevole, l’evento e il rapporto di causalità110.
Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione « il vincolo in sede civile derivante dal giudicato penale concerne i
fatti, nella loro realtà oggettiva e fenomenica, presi in considerazione in sede
penale ( condotta, evento e nesso di causalità) mentre, al contrario, il giudice
civile è del tutto libero di valutare quei fatti, storicamente accertati nel giudizio
penale, in via autonoma». In sostanza, si dice, « una volta preso atto che nel
giudizio penale, sia intervenuto un accertamento del fatto, questo e solo questo è
da ritenersi incontrovertibile in sede civile »111. Secondo una interpretazione più
estensiva, invece, si è ritenuto che l’oggetto dell’accertamento incontestabile non
andasse limitato al solo dispositivo, ma dovesse, invece, riferirsi a tutti i fatti in
concreto presi in considerazione dal giudice, e in particolare, a quei fatti che siano
stati rilevanti al fine di pervenire alla sentenza di condanna, comprese le
circostanze; ciò in quanto si è detto che: « le questioni (…) trattate nelle sentenze
penali (…) in parte motiva, spiegano diretta e sostanziale influenza sul
correlativo dispositivo, costituendo il presupposto logico e necessario della
decisione adottata. Non può, infatti, non considerarsi accertato un fatto che
rappresenta un passaggio obbligato, una conditio sine qua non, dell’accertamento
del fatto contestato; vanno semmai esclusi solo quegli accertamenti incidentali,
come tali non compresi nella contestazione, che non rilevano ai fini della
decisione.
Ne consegue che i punti della motivazione non coperti dall’autorità di giudicato
extrapenale, potranno liberamente essere considerati dal giudice civile o
110
V. Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 1997, n. 6373; Cass. civ. sez. I, 8 ottobre 1999, n. 11283.
Cass. 2.11.2000, n. 14328, in Foro it., 2001, I, 1218; in CED, Cass. n. 3858/1984, in CED,
Cass. n. 378/1969, Cass. n. 3935/1968.
111
56
amministrativo, il quale è libero anche di rivalutare le prove già formatesi nel
processo penale e ammettere la prova contraria112.
Si afferma, inoltre, che
il vincolo posto dal giudicato penale copra soltanto
quanto sia stato fatto oggetto del relativo giudizio, senza precludere al giudice la
cognizione di eventuali elementi che vengono introdotti per la prima volta nel
giudizio civile o amministrativo.113 Se, infatti, per esempio, il giudice penale nel
pronunciare condanna al risarcimento danno non si sia pronunciato su una parte
della pretesa risarcitoria, il vincolo posto dal giudicato, in questo caso, vale con
esclusivo riferimento a ciò che è stato, sul piano concreto, oggetto di valutazione
da parte del giudice penale114.
Controversa è, invece, la questione relativa all’accertamento dell’elemento
psicologico del reato: questo è, in genere, ritenuto vincolante in sede extrapenale,
anche se, in realtà, la giurisprudenza contabile è più orientata in senso opposto: si
ritiene, infatti, che l’art. 651 « esclude ogni effetto vincolante per ciò che riguarda
l’elemento psicologico (…), consentendo al giudice contabile di valutare
liberamente i fatti accertati e (…) procedere a una autonoma qualificazione e
graduazione della colpa»115.
Il giudicato penale di condanna copre, poi, l’accertamento della « l’illiceità penale
del fatto»: sono, quindi, vincolanti per il giudice civile o amministrativo gli
accertamenti relativi alla inesistenza di scriminanti e alle condizioni oggettive di
punibilità eventualmente richieste dalla fattispecie incriminatrice.
Esso,
evidentemente, però, come è stato giustamente osservato, non può coprire, anche,
il tema della illiceità civile, dal momento che nel processo penale non è possibile
valutare « l’esistenza delle esimenti civilistiche, quali per esempio quella prevista
all’art. 1127 co. 2 c.c. ( danno evitabile con la ordinaria diligenza del creditore
)»116. E ciò è evidente, in quanto abbiamo a che fare con due categorie concettuali
assolutamente diverse tra di loro: illiceità e antigiuridicità penale, rispetto alla
diversa nozione di ingiustizia del danno, civilmente rilevante; nozione,
112
Tonini, P., Manuale di procedura penale, Milano, 2002, p.674.
Zencovich, Z., La responsabilità civile da reato, Padova, CEDAM, 1989, p. 451.
114
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato, Il giudicato e i suoi effetti civili, cit., p., 175.
115
C. conti s.r. 22-10-92 n.808, in R. C. conti, 92, f. 6, 42; e C. conti, 2-4-93, n. 40, Nuovo dir. 93,
535; C. conti 19-4-91, n.146.
116
Tonini, P. Manuale di procedura penale, cit., p. 710.
113
57
quest’ultima, che corrisponde, più che altro, all’idea di “violazione di quelle
regole di condotta che governano la vita sociale e che impongono doveri di
rispetto degli interessi altrui”117. Detto questo vediamo che non è assolutamente
possibile un sovrapposizione tout court delle prime sulle seconde118.
D’altro canto, l’esplicito richiamo alla sola illiceità penale vuol dire che « nel
giudizio civile o amministrativo c’è piena libertà di accertamento in riferimento
agli eventuali profili di antigiuridicità che derivano dal contrasto con norme
extrapenali»119. Più in generale, si è detto che il giudice civile, pur essendo
vincolato dall’accertamento materiale del fatto, è, però, libero di attribuirgli una
diversa qualificazione giuridica120.
La sentenza irrevocabile di condanna ha, per ultimo, efficacia extrapenale, anche
relativamente all’« affermazione che l’imputato abbia commesso il fatto
costituente reato ». Questa formula ha sostituito quella precedente, contenuta
nell’art. 27 c.p.p. abr., con la quale si faceva riferimento alla « responsabilità del
condannato », da cui derivava che il giudice della lite risarcitoria non poteva
assolutamente procedere autonomamente all’esame di essa121.
Tra i soggetti che risentono della efficacia vincolante del giudicato penale, si
colloca, innanzitutto l’imputato, nei cui confronti la sentenza può essere fatta
valere incondizionatamente, in quanto, nel processo penale, è posto in condizione
di difendersi in ogni momento, fin dalla fase delle indagini preliminari. In secondo
luogo, è situato il responsabile civile, che sia intervenuto o sia stato citato nel
processo penale, eccetto colui che abbia perso la qualità di parte a seguito della
sua esclusione (art. 86, 2° co. c.p.p.). Va precisato che l’azione civile nei confronti
del responsabile civile non subisce alcuna sospensione in attesa dell’esito del
giudizio penale, anche se quest’ultimo possa avvalersi della sentenza122. Nella
pratica, tale regola sembra non avere molto spazio e sembra, invece, ridursi a
un'unica ipotesi: è il caso in cui vi sia una pluralità di danneggiati dal reato e che
117
Bianca, Diritto civile, V, 1994, p. 586 ss.
Terrusi, F., Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo, in Dig. Disc. Pen., XI,
1996, UTET, p. 42.
119
Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di Chiavario, VI, Torino,
1989, p. 453.
120
Zencovich, Z., La responsabilità civile da reato, Padova CEDAM, 1989, p. 450.
121
Conso G.- Grevi V., Commentario breve al codice di procedura penale, CEDAM, 1987, p.120.
122
Chiliberti, A., Azione civile e niovo processo penale, 2ª ed., UTET, 2006, p. 1039.
118
58
solo uno o alcuni di essi provvedano a costituirsi parte civile in sede panale,
citando il responsabile civile ( o comunque costui intervenga volontariamente nel
processo) mentre altri propongono l’azione di danno in via autonoma in sede
civile, ove potranno appunto avvalersi, nei confronti sia dell’imputato che del
responsabile civile, del giudicato di condanna penale123.
Sebbene, poi, l’assenza di un esplicito riferimento codicistico, nell’ambito dei
soggetti coinvolti, deve ricomprendersi anche il danneggiato. Il silenzio della
legge pone non poche incertezze: pertanto, secondo alcuni, la interpretazione più
ragionevole sarebbe quella di attribuire senz’altro efficacia di giudicato alla
pronuncia di condanna, ancorché sfavorevole al danneggiato, quando sussistono le
condizioni che, ai sensi dell’art.651, comporterebbero l’efficacia della pronuncia
assolutoria e di rimettere, invece, quando non sussistano tali condizioni, allo
stesso danneggiato, la facoltà di scegliere se avvalersi o meno del giudicato di
condanna Quanto, invece, al soggetto interessato a far valere in sede civile il
giudicato penale di condanna124, c’è chi, partendo dal presupposto che, in
sostanza, interessato a far valere quella sentenza penale di condanna nel giudizio
civile, è proprio il danneggiato, e siccome la norma in esame non dà rilevanza alla
circostanza che costui si sia o meno costituito parte civile nel processo penale o
che, in caso negativo, sia stato o meno posto nelle condizioni di farlo, si deve
ritenere, per tale ragione, che se un danneggiato si sia costituito parte civile, altro
danneggiato potrà avvalersi della sentenza, e potrà avvalersene anche chi, già
costituito parte civile e vittorioso nell’azione civile in sede penale, intenda far
valere altre ragioni di danno125. Quest’ultimo potrà ugualmente avvalersi della
efficacia della sentenza ove in sede penale, nonostante la condanna dell’imputato,
la sua domanda sia stata respinta o perché non siano stati provati i danni lamentati
o perché questi non siano stati ritenuti connessi causalmente al reato. C’è anche
chi, però, ritiene che il giudicato di condanna produca i suoi effetti
necessariamente nei confronti di quest’ultimo, nel caso di sospensione per
pregiudizialità di cui all’art. 75 co.3º c.p.p., mentre egli sarà libero di avvalersi del
giudicato ove sia stato estraneo al giudizio penale, anche se non posto in grado di
123
Ghiara, Art. 652, in Commento al codice di procedura penale, VI, Torino, 1991, p. 454.
Ghiara, , Art. 652, cit., p. 449.
125
Chiliberti, A., cit., p.1037.
124
59
partecipare, o vi sia stato incidente probatorio cui non abbia preso parte e di cui
non abbia fatto accettazione126.
Inoltre, premesso che l’efficacia extrapenale della sentenza emessa a seguito di
giudizio abbreviato è esclusa quando vi si opponga la parte civile che non abbia
accettato il rito; il che vuol dire che se il danneggiato trasferisce la sua azione in
sede civile egli sarà soggetto agli effetti del giudicato soltanto nell’ipotesi in cui,
prima di revocare la propria costituzione di parte civile, abbia accettato il rito
abbreviato.
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di
danno: c) l’art. 652 c.p.p.
L’art. 652 c.p.p. prevede che la sentenza di assoluzione, pronunciata in seguito a
dibattimento, o a giudizio abbreviato accettato dalla parte civile, ha efficacia di
giudicato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo
ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima (art. 50-54 c.p.), nel giudizio civile e
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal
danneggiato o nel suo interesse ( il riferimento al giudizio promosso
“nell’interesse del danneggiato” è stato introdotto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97,
art. 9 co. 1º) e sempre che quest’ultimo si sia costituito parte civile o, sia stato
comunque posto nelle condizioni di costituirsi parte civile, salvo il caso in cui lo
stesso abbia esercitato l’azione in sede civile ai sensi dell’art. 75 co. 2º c.p.p.).
In altre parole, ogni qualvolta la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata con
una delle suddette formule enunciate nell’art. 652 c.p.p., e salvo il rispetto dei
limiti soggettivi fissati dalla norma, il giudice civile o amministrativo, respingerà
la domanda per i danni derivanti dal delitto come se sulla stessa si fosse già
formato il giudicato127. Pertanto, l’effetto preclusivo del giudicato assolutorio
scaturisce soltanto quando in sede penale risulti accertata una delle suddette
126
Spangher, G., Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale, Giuffrè, 1995,
p.31-68.
127
Conso-Grevi, Commentario breve al codice di procedura penale, CEDAM, 2005, p. 2209.
60
situazioni, e non anche quando l’assoluzione dell’imputato sia stata determinata
dalla mancanza, contraddittorietà, o insufficienza delle prove a carico128.
Secondo tale impostazione, in particolare, non avrà efficacia alcuna, in sede civile,
l’accertamento che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
tale. In tali ipotesi, infatti, la sentenza è sì, di assoluzione, ma presuppone
l’accertamento che il fatto sussiste e che l’imputato lo ha commesso, e cioè
presuppone gli elementi di segno opposto a quelli che possono avere efficacia di
giudicato in base al 1° comma dell’art. 652 c.p.p.129.
Questa tesi, tuttavia, non è condivisa dalla più recente giurisprudenza della Corte
di Cassazione, la quale ha affermato che, analogamente a quanto già avveniva
con riguardo all’art. 25 del vecchio codice, anche l’art. 652 c.p.p., avente
contenuto pressoché identico, deve essere “estensivamente interpretato, a
salvaguardia del principio dell’unità della funzione giurisdizionale, nel senso che
non solo l’assoluzione dell’imputato, all’esito del dibattimento, perché il fatto non
sussiste o per non aver commesso il fatto o perché questo è stato compiuto
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ma anche
l’assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” (adottata, di regola,
per carenza dell’elemento psicologico del reato) ha efficacia preclusiva nel
giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, ogni qual volta
l’illecito civile sia caratterizzato, dal punto di vista psicologico, in maniera
identica all’illecito penale”130.
Tale posizione, fondata, per lo più, sulla continuità tra disposizioni del vecchio e
nuovo codice, suscita, però, qualche perplessità se si considera il contenuto delle
direttive di politica processuale dettate dalla legge n. 81/87, recante la delega al
Governo per l’emanazione del nuovo c.p.p. Questa, infatti, afferma il principio
dell’autonomia e separazione dei giudizi, i quali vanno preferibilmente promossi
davanti al loro rispettivo giudice naturale ed ha indicato come limitate ed
128
Cass. civ., 9-5-00, n. 5885, in Diritto e Giustizia, 2000, f. 19, 48; Cass. civ. 30-3-98, n. 3330,
Foro it., 98, I, 2913; Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, p. 567; Ghiara, , in
Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di Chiavario, VI, Torino, 1989, p. 465;
Spangher, Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e processo penale, cit., p. 57.
129
Vedi per esempio, Cass. civ. 26-2-1999, n.1678, in Mass. Giust.civ., 99, 414, in tema di azione
diretta a ottenere l’adempimento delle obbligazioni nascenti da un rapporto giuridico per il quale
era stato escluso il reato di truffa.
130
V. Cass. pen. Sez. IV, 9 marzo 2001, n. 9795, in Arch. nuova proc. pen., 2001, 420.
61
eccezionali le ipotesi in cui al giudicato penale deve essere riconosciuto valore
preclusivo sugli altri giudizi. In tale ottica, sembra doversi preferire la tesi,
tutt’oggi sostenuta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui l’art. 652 c.p.p.,
costituendo una deroga al generale principio del “favor separationis”, deve essere
interpretata restrittivamente. Vincolanti sono, in definitiva, soltanto le sentenze di
assoluzione pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste», «l’imputato non
l’ha commesso», «il fatto è stato commesso nell’adempimento di un diritto o
nell’esercizio di una facoltà legittima».
Vale la pena di precisare che l’art. 652 c.p.p. fa espresso riferimento alla «
efficacia di giudicato »; questo è servito, senza dubbio, a eliminare qualsiasi
perplessità circa la natura giuridica del vincolo discendente dalla sentenza penale
di assoluzione, diversamente da quanto accadeva nel vigore del previgente art. 25
c.p.p. abr. che conteneva una formula diversa e sicuramente maggiormente
ambigua ( « l’azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta »)131.
L’efficacia vincolante del giudicato di assoluzione è, inoltre, collegata, anche qui.,
all’ « accertamento », anziché alla « dichiarazione », delle diverse cause di
proscioglimento; infatti, mentre l’art. 25 abr. richiedeva, ai fini del vincolo
extrapenale, che fosse « stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso, ecc.), l’attuale disposizione normativa impone che tale
situazione risulti effettivamente accertata132; si ritiene, dunque che «l’efficacia del
giudicato assolutorio imponga un approfondito esame postumo delle motivazioni
della sentenza penale»133.
Si deve notare che l’art. 652 fa esclusivo riferimento ai giudizi aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni prodotti dal reato o le restituzioni ( rispetto alle quali si
esplica l’effetto preclusivo del giudicato penale ). Pertanto, nel caso di esercizio di
un’azione civile diversa da quella di danno, deve ritenersi consentito il riesame
dei fatti già emersi nel processo penale.
Hanno efficacia extrapenale, innanzitutto, le sentenze irrevocabili di assoluzione
emesse in seguito a dibattimento, e la ragione qui è la stessa già vista per l’articolo
131
Terrusi, F., Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo, in Dig. Disc. Pen., XI,
1996, UTET, p. 40.
132
Ghiara, art. 652 c.p.p. in Commentario al nuovo codice di procedura penale, M. Chiavario,
Torino, UTET, 1989, p. 456;
133
Siracusano, Assoluzione ( Dir. proc. pen. ), in Enc. Dir., III, 1958, p. 935 ss.
62
precedente: sta, cioè, nel fatto che la decisione in questo caso è emessa rispettando
pienamente la garanzia del contraddittorio. Ma, il vincolo di giudicato è
ricollegato anche alle sentenze irrevocabili emesse nel giudizio abbreviato,
sempre a condizione che la parte civile abbia accettato il rito. Sono, invece,
escluse: a) le sentenze di non luogo a procedere ( art. 425 c.p.p.) essendo non
emesse a seguito di dibattimento e inidonee a diventare irrevocabili; b) le sentenze
emesse nel corso della fase predibattimentale, in quanto il c.d. proscioglimento
anticipato è possibile soltanto per le formule che non rientrano nell’ambito di
applicazione dell’articolo in esame ( « il reato è estinto », « l’azione penale non
doveva essere iniziata o proseguita»); c) sentenze di non doversi procedere ( per
mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato), che
seppur emesse al termine del dibattimento, come è stato giustamente osservato,
sono « prive in tutto o in parte, di un accertamento completo sul fatto»134.
Occorre, a questo pento, inquadrare più precisamente qual è il suo concreto
ambito di applicazione. Primo punto è l’accertamento che « il fatto non sussiste »;
con tale formula, secondo la giurisprudenza, si intende la mancanza di uno degli
elementi oggettivi del reato ( azione, evento o nesso di causalità); l’assenza,
invece, dell’elemento soggettivo- psicologico del reato, che si renderebbe con la
formula « il fatto non costituisce reato », non impedisce il riesame dei fatti
nell’ambito del successivo giudizio civile o amministrativo.
« L’imputato non lo ha commesso », fa, invece, riferimento alla impossibilità di
riferire oggettivamente il fatto all’imputato; in altre parole, abbiamo che l’evento
suddetto si è effettivamente verificato, ma l’imputato non ne risulta coinvolto, né
come autore principale, né come semplice partecipe; ciò per quanto concerne i
reati materiali, mentre, in riferimento ai reati formali, vuol dire che l’imputato
non ha proprio posto in essere la condotta descritta dalla fattispecie
incriminatrice135.
In fine, con la formula « il fatto è stato compito nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima», il legislatore ha voluto far riferimento,
nella prima ipotesi, all’esistenza di una causa di giustificazione, di cui agli artt. 51
c.p., rubricato “ Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”, nonché l’
134
135
Cass. civ. 10-4-97, n. 3119, in Mass. giust., civ.,97, 567.
Cordero, Procedura penale, 7ª ed., Giuffrè, 2003, p. 981.
63
art. 53 c.p ( uso legittimo delle armi) ; mentre, nel secondo caso, “esercizio di una
facoltà legittima”, si fa riferimento a una delle scriminanti contenute nel codice
penale, quali il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) e di legittima difesa (art.
52 c.p.). Proprio in relazione alle cause di giustificazione, si è detto che « come
esse hanno il potere di far evaporare l’antigiuridicità penale, così di regola,
determinano l’eliminazione della illiceità civile»136.
Per quanto riguarda, invece, l’ambito di applicazione soggettiva, occorre
innanzitutto osservare che l’art. 652 c.p.p., si occupa della sola posizione del
danneggiato; e ciò è evidente, in quanto il giudicato penale assolutorio,
pronunciato con quelle ampie formule terminative già viste sopra, non può che
andare esclusivamente a suo scapito; ma è anche vero che non si fa alcun
riferimento alla possibile estensione del giudicato nei confronti delle altre parti
destinate a essere convenute nel giudizio risarcitorio. È vero altresì, che l’art. 2 n.
23 l. d. circoscrive l’efficacia extrapenale della sentenza assolutoria al solo
giudizio di danno che si svolga tra quanti « hanno partecipato o sono stati posti in
grado di partecipare al processo penale» .
Inoltre, l’art. 652 c.p.p., ci dice che il giudicato penale di assoluzione può essere
fatto valere dall’imputato o dal responsabile civile nei confronti del danneggiato
che si sia costituito parte civile in sede penale o che, comunque, sia stato posto in
condizione di farlo. Dunque, partendo dal presupposto che si tratta di una
preclusione che va introdotta nel processo penale attraverso una eccezione, in
senso tecnico, della parte interessata ( imputato o responsabile civile), la quale ha
l’onere di provare che sia stato effettivamente garantito il diritto alla difesa della
parte avversa, si è sostenuto che l’esistenza del giudicato vincolante non possa
essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Nel vigore dell’abrogato codice, la Corte di Cassazione aveva, in più occasioni,
affermato che « per l’opponibilità del giudicato penale ad un soggetto che risulti
essere stato persona offesa dal reato è sufficiente che costui abbia avuto la
possibilità giuridica e di fatto di parteciparvi in tale veste »137. Nell’attuale
codice, invece, si pone, quale condizione imprescindibile, l’accertamento che il
136
Guarnieri, G., Giudizio ( Rapporto tra il giudizio civile e il penale ), in Noviss. Dig. It., Torino,
VII, 1961, p. 893 ss.
137
V. Cass. 20 maggio 1987, n. 4622, in Mass. Giust. civ., 1987, f. 5.
64
danneggiato sia stato citato per l’udienza preliminare (art. 419 co.1º c.p.p.) o per il
dibattimento (art.456 co.3º; art. 552,co. 3º), non essendo sufficiente la mera
comunicazione dell’informazione di garanzia.
L’efficacia del giudicato è esclusa anche nel caso in cui la sentenza assolutoria sia
stata emessa con incidente probatorio al quale il danneggiato non sia stato posto in
grado di partecipare per qualsiasi motivo, a meno che non ne abbia fatto
accettazione, anche in modo tacito, per esempio, avvalendosi delle risultanze
dell’incidente probatorio ( art. 404 c.p.p.).
Infine, l’efficacia della sentenza irrevocabile è esclusa se il danneggiato dal reato,
posto in condizione di costituirsi parte civile, promuove l’azione in sede civile
prima della pronuncia penale di primo grado, perché, in tal caso, vige l’autonomia
dei due giudizi sancita dall’art. 75 co.2º c.p.p.
Dunque, dal «combinato disposto degli artt. 75 e 652 c.p.p., emerge come
l’efficacia della sentenza assolutoria nel giudizio di danno, sia direttamente
correlata alla condotta processuale del danneggiato, cioè rimessa, in sostanza, alla
sua scelta preventiva di esercitare la pretesa risarcitoria nel giudizio civile, solo in
caso negativo determinandosi il vincolo del giudicato. Al contrario, il
danneggiato, potrà sempre usufruire della sentenza di condanna, quali che siano
state le sue scelte preventive »138.
Infine, anche il giudicato penale assolutorio, formatosi all’esito del giudizio
abbreviato, ha efficacia extrapenale, ma ciò, limitatamente al caso in cui la parte
civile abbia prestato il proprio consenso allo svolgimento del reato abbreviato;
esso, al contrario, sarà inefficace quando il danneggiato non abbia accettato il rito
semplificato, revocando la costituzione di parte civile, oppure quando egli,
sebbene posto in condizione, abbia scelto di non partecipare al processo penale e
invece abbia proposto l’azione per il risarcimento del danno davanti alla
giurisdizione civile, pur dopo l’emissione e della sentenza penale139.
In
quest’ultima ipotesi, abbiamo una evidente eccezione alla regola generale per cui
la sentenza assolutoria pronunciata al termine del dibattimento ha efficacia di
giudicato nel processo civile. Ma la ratio va individuata nel fatto che, nel
138
Gaito, A., Esecuzione, in AA.VV., Profili del nuovo codice di procedura penale, a cura di
Conso G. e Grevi V., Padova, 1998, p.743 ss.
139
Gaito., A., Codice di procedura penale ipertestuale, UTET, 2001, p. 2199.
65
momento in cui l’imputato chiede il giudizio abbreviato, non è ancora scaduto il
termine perentorio per la costituzione di parte civile, cosicché il danneggiato non
può ritenersi pienamente « posto in condizione di costituirsi e pertanto non può
essere soggetto a quel giudicato formatosi in via anticipata»140. Invece, «una volta
accettato il rito abbreviato, seppure tacitamente, la sentenza avrà efficacia anche
se la costituzione di parte civile viene successivamente revocata e la sentenza
penale assolutoria farà stato nel processo civile che il danneggiato eventualmente
introduca per lo stesso petitum o anche chiedendo restituzioni e/o risarcimento
diverse da quelle invocate in sede penale»141.
L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare: d) l’ art.
653 c.p.p.
Secondo tale disposizione, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di
condanna ha efficacia vincolante nei giudizi disciplinari dinanzi a pubbliche
autorità. Chiaramente, anche qui, la responsabilità disciplinare deve fondarsi sul
medesimo fatto che è stato oggetto del giudizio penale e non su fatti diversi che
possono
essere
accertati
liberamente
dall’autorità
investita
del
potere
disciplinare142.
Per quanto riguarda le sentenze di assoluzione, si deve osservare che l’effetto
preclusivo è collegato esclusivamente all’accertamento che « il fatto non sussiste
o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso». Per
la prima e per l’ultima formula terminativa, non si pongono particolari problemi;
evidentemente, si sta facendo riferimento alla mancanza di uno degli elementi
oggettivi del reato e alla impossibilità di riferire oggettivamente il fatto
all’imputato. Con l’altra formula ( “il fatto non costituisce illecito penale” ),
invece, si intende, probabilmente, la circostanza che il fatto non costituisce reato o
non è previsto dalla legge come tale. È, questa, una formula piuttosto ambigua,
che non sembra coincidere con nessuna delle altre formule terminative richiamate
dall’art. 652 c.p.p. e, pertanto, secondo un altro orientamento, si deve dire, più in
generale, che al di fuori delle più ampie formule assolutorie in cui la sentenza
accerta che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”, la
140
Ghiara, Art. 653 c.p.p., in Commentario al nuovo codice di procedura penale, cit., p. 461.
Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Giuffrè, 1993, p. 575-576.
142
Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit., p. 822.
141
66
pubblica autorità è vincolata soltanto a ritenere che il fatto non è penalmente
illecito, ma può liberamente
143
responsabilità disciplinare
valutarlo sotto un altro profilo; quello della
.
Sono, comunque, escluse, le sentenze di non luogo a procedere, i decreti di
archiviazione, le sentenze pronunciate nel corso della fase predibattimentale e
quelle di non doversi procedere emesse in seguito a dibattimento.
Quanto, invece, alle sentenze di condanna , queste, hanno efficacia vincolante, nel
successivo giudizio disciplinare, « quanto all’accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso
»; sono, inoltre, ricomprese, non soltanto, le sentenze dibattimentali, ma anche
quelle emesse all’esito del giudizio abbreviato o del procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti, in quest’ultimo caso, però, nei casi
tassativamente indicati dalla legge144.
C’è, poi, da osservare, che la circostanza secondo cui la pubblica autorità, non
abbia partecipato o non sia stata posta in condizione di partecipare al giudizio
penale è ininfluente; essa resta comunque vincolata dal giudizio penale, anche se
non sia stata messa in grado di partecipare al relativo processo penale; si ritiene,
tuttavia, che i suoi interessi siano rappresentati dal pubblico ministero; il quale,
dal suo canto, ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p., è tenuto ad informare la
pubblica autorità, nel caso in cui egli abbia promosso azione penale contro un
dipendente dello Stato o di altro ente pubblico, o ancora, quando l’impiegato sia
stato arrestato o si trovi in custodia cautelare. Ricevuta tale informazione, l’
autorità pubblica, potrà decidere se costituirsi parte civile, laddove sia derivato un
danno alla pubblica amministrazione, oppure, iniziare un autonomo procedimento
disciplinare contro quell’imputato. A tal proposito, il nuovo codice non contempla
più espressamente la sospensione del giudizio disciplinare; pertanto, esso potrà
continuare a svolgersi nonostante la pendenza del processo penale. Tuttavia, in
alcune leggi speciali, è prevista la possibilità per la pubblica autorità di
sospenderlo (vedi art. 117 d.p.r. 10.1.1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato; art. 28 r.d.l. 31.5.1946, n. 511 sulle guarentigie della magistratura; art.
11 d.p.r. 31.10.1981, n.737, relativo al personale dell’amministrazione della
143
144
Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit., p. 821.
Cass. civ., 27-7-01, n. 10313.
67
polizia di stato). È fatta salva, poi, l’ipotesi di sospensione necessaria prevista
dall’art. 211 disp. att. c.p.p., in cui si prevede l’obbligo di sospendere il suddetto
procedimento soltanto dopo l’esercizio dell’azione penale145. Ma sul punto,
occorre fare qualche passo indietro. Inizialmente, l’ art. 9 l. 9 febbraio 1990, n. 19,
poneva quale principio avente carattere generale, il fatto che il pubblico
dipendente non avrebbe potuto subire la destituzione di diritto in modo
automatico a seguito di condanna penale.
La legge, tuttavia, prevedeva che la destituzione poteva infliggersi all’esito di un
procedimento disciplinare, il quale, avrebbe dovuto promuoversi entro centottanta
giorni dalla data in cui l’amministrazione avesse avuto notizia della sentenza
irrevocabile di condanna e che avrebbe dovuto concludersi nei successivi novanta
giorni.
Nel caso in cui, poi, vi fosse stata sospensione cautelare dal servizio in ragione
del procedimento penale, la medesima misura avrebbe conservato efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo che, in ogni modo, non poteva superare i
cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare sarebbe stata,
senz’altro, revocata di diritto.
Alcuni, hanno sostenuto che l’effetto della norma, è stato, sostanzialmente, quello
di far assumere una valenza quasi giurisdizionale al procedimento disciplinare
che, poi, sarebbe stato condotto nel rispetto dei diritti e delle garanzie di difesa.
A rompere questo assetto, fu la legge 27 marzo 2001, n. 97, la quale modificò la
disciplina relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
Ora, premesso questo, la domanda è: il procedimento disciplinare deve essere
necessariamente sospeso fino a che non sia definito il procedimento penale cui
esso è collegato?
A dare una risposta, è stata la Cass. civile (sez. III), la quale, con una sentenza del
27 luglio 2001, (la n.10284), ha affermato che “ la sospensione del processo è
necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o
amministrativa, sia imposta da una espressa previsione di legge, ovvero quando,
145
68
Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit., 2009, p. 822.
per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logicogiuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata e il cui
accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi
presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e quindi, obbligatoria per il
giudice, ed è meramente facoltativa, tanto che disporla o meno, rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che quando pendano
contemporaneamente, nei confronti della medesima persona, un procedimento
penale e un procedimento disciplinare, quest’ultimo non deve essere
necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da
una specifica disposizione di legge, perché la definizione del processo penale non
costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare,
non solo perché questo si fonda su un diverso presupposto, della violazione delle
regole deontologiche e non di norme penali, ma anche perché dal combinato
disposto dell’art. 653 c.p.p. e 211 disp, att. , si evince il venir meno, con l’entrata
in vigore del nuovo c.p.p.del principio del c.d. pregiudiziale penale sancito all’art.
3 c.p.p .abrogato.
Sempre la Cass. civile sez. un. con una sentenza del 16 giugno 200, n. 444 ha
stabilito che « la mancata riproduzione, in seno al nuovo c.p.p. della disposizione
di cui all’art.3 comporta il venir meno del principio della pregiudiziale penale con
la conseguenza che in tema di giudizi disciplinari, l’efficacia del giudicato penale
è regolata, in via esclusiva dall’art.653 che attribuisce alla sola sentenza
irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, efficacia di
giudicato nel procedimento per responsabilità disciplinare».
Infine, l’art.1 l. 97/01 ha introdotto un’ulteriore novità: è stato, infatti, aggiunto
all’art. 653, il co. 1bis che attribuisce anche alla sentenza penale irrevocabile di
condanna, efficacia di giudicato nel procedimento per responsabilità disciplinare,
con riferimento all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Per quanto riguarda, invece, la sospensione cautelare, rivestendo essa, natura
meramente
precauzionale, vediamo che essa, nella sostanza, si attua con
l’allontanamento dal servizio del dipendente coinvolto in gravi mancanze o
69
irregolarità, ma ciò non toglie che si possa, poi, sfociare in un procedimento di
carattere penale contro il medesimo.
L’efficacia della sentenza penale in altri giudizi civili : e) l’art. 654
c.p.p.
L’art. 654 c.p.p., infine, disciplina l’efficacia del giudicato penale, di condanna o
di assoluzione, negli « altri giudizi » civili o amministrativi, aventi finalità diverse
da quelle risarcitorie. Presupposto imprescindibile è che il processo civile abbia ad
oggetto un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dagli
stesse fatti materiali, oggetto del giudizio penale e, dunque, che esista un rapporto
di pregiudizialità tra l’accertamento effettuato in sede penale e il successivo
giudizio civile o amministrativo. In altre parole, è richiesta l’identità dei fati tra i
due giudizi, una « coincidenza » degli oggetti dell’accertamento in entrambe le
sedi146.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione soggettivo, vediamo che l’art. 654
c.p.p. ci dice espressamente che le sentenze penali di assoluzione o di condanna,
pronunziate “in seguito a dibattimento”, hanno nei giudizi civili o amministrativi,
in esame, efficacia di giudicato nei confronti dell’imputato, della parte civile e del
responsabile civile che si sia costituito parte civile che si sia costituito o sia
intervenuto volontariamente nel processo. Non basta, dunque, che quest’ultimo sia
stato posto nelle condizioni di intervenire, come quanto avviene nelle ipotesi
previste dall’art. 651 c.p.p., dove il giudicato penale di condanna è opponibile al
responsabile civile quando questi sia stato citato o sia intervenuto nel processo
penale, ma è necessaria, nell’ipotesi in esame, la sua effettiva presenza nel
processo. Si tratta in altre parole, delle sole parti effettive e non potenziali del
processo penale147.
Un altro punto particolarmente discusso è se l’efficacia extrapenale suddetta possa
essere fatta valere solo tra soggetti che abbiano preso parte al processo penale
(imputati, parti civili, responsabili civili), oppure se gli effetti del giudicato
possano essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse, purché titolare di una
146
Terrusi, F., Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo, in Dig. Disc. Pen., XI,
1996, UTET, Torino, p. 44.
147
Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit.,p. 825.
70
situazione giuridica soggettiva connessa al fatto di reato148. La prima soluzione è
costantemente seguita dalla Corte di Cassazione149 e da chi ritiene, partendo
proprio dal dato letterale dell’art. 654 c.p.p., nella parte in cui dice « parti in causa
», che ciò abbia costituito il pieno superamento della vecchia impostazione,
contenuta nel previgente art 28 c.p.p abr., del vincolo erga omnes del giudicato
penale; non mancano, tuttavia, orientamenti contrari, volti ad affermare che il
giudicato può esser fatto valere anche da persone che non siano state parti in quel
processo penale150.
Tuttavia, per l’esplicarsi della efficacia della sentenza penale di condanna o di
assoluzione negli “altri giudizi” civili, sono necessarie due condizioni.
Innanzitutto, è indispensabile che il giudice penale abbia ritenuto i fatti materiali
accertati “rilevanti” e, quindi, utili e decisivi, ai fini della decisione. Essi devono,
in altre parole, aver costituito il presupposto logico-giuridico della sentenza
penale. Ciò risulta ulteriormente confermato dall’espressa indicazione che deve
trattarsi di fatti « oggetto del giudizio penale », volendosi sottolineare il
riferimento proprio a quei fatti oggetto dell’imputazione, ossia quelli il cui
riconoscimento o la cui esclusione non sia la fonte della decisione, né tanto meno
la sua semplice premessa, ma proprio il tema oggetto della pronuncia151
Va inoltre, osservato come il legislatore faccia riferimento unicamente ai fatti
ricompresi nell’elemento oggettivo del reato e non anche in quello soggettivo; non
vi risultano inclusi, dunque, la qualificazione giuridica, né i fatti che sono stati
utilizzati ai fini del suo convincimento o che sono stati accertati per risolvere
questioni pregiudiziali o incidentali152.
In secondo luogo, occorre che la legge civile non ponga “ limitazioni alla prova
della posizione soggettiva controversa”; le limitazioni alle quali si fa riferimento,
sono le limitazioni probatorie di cui agli art. 2721-2726 e 2729, co. 2º, relative
alla prova testimoniale e alle presunzioni. Ciò vuol dire, in altre parole, che
148
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato, Il giudicato penale e i suoi effetti civili, UTET, 2006, p.
185.
149
Cass., Sez. Trib., 18.1.2002, n. 516, in Giust. civ., 2002, I, 615; Cass., Sez. Trib., 27.8.2001, n.
11272, cit., 2002, I, 408.
150
Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit.,p. 825.
151
Spangher, G., Nuovi profili tra processo civile e processo penale, cit., p. 47.
Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit., p. 824; Guarnieri, Giudizio ( Rapporto tra il
processo penale e il processo civile ), in Noviss. Dig. it. VII, Torino, 1961, p. 893.
152
71
quando la legge civile pone dei limiti alla prova, il giudice civile non è vincolato
agli accertamenti che il giudice penale ha compiuto e che hanno portato alla
sentenza di condanna o di assoluzione. Tutto ciò ha un senso: quello di evitare che
la costituzione nel processo penale possa costituire una scappatoia per aggirare i
limiti previsti dalla legge extrapenale.
9. Il giudicato « convenzionale ».
Come, si è più volte detto nei paragrafi precedenti, ove vi sia stata una sentenza
irrevocabile, il giudicato comporta la non modificabilità dell’accertamento del
fatto: si impone un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Il giudicato ha un
effetto preclusivo e ciò, sia in caso di condanna che di assoluzione. Il legislatore
vuole evitare che il medesimo imputato sia sottoponibile indefinitamente a
successivi procedimenti penali che abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico
per il quale è stato condannato o prosciolto.
Gli effetti del giudicato, tuttavia, possono venir meno in un caso solo. È ammessa
una impugnazione straordinaria (la revisione: artt. 629 ss. c.p.p.), contro la sola
sentenza di condanna, purché dopo l’intervenuta irrevocabilità della sentenza,
sopravvengano o si scoprano nuove prove che dimostrino che il condannato
doveva essere prosciolto (art. 630 c.p.p.).
È evidente, dunque, che in tale occasione, il legislatore ha ritenuto prevalente
l’esigenza di giustizia su quella di certezza; e, la straordinarietà della revisione sta
proprio nel fatto che la relativa richiesta non deve essere presentata entro limiti
temporali determinati: essa, può, infatti, “aggredire” il giudicato153.
Ma al di fuori dei casi di revisione, che peraltro il legislatore ha tassativamente
indicato nell’art. 630, lett. a) a d) c.p.p., vale la regola dell’effetto preclusivo del
giudicato, secondo cui l’accertamento del giudice penale non è più modificabile.
Ebbene, proprio rispetto a quest’ultimo punto, di recente una sentenza della Corte
costituzionale ha segnato una svolta nel nostro ordinamento processuale penale. Si
tratta della sentenza n. 113 del 4 aprile 2011, con la quale la Corte, ha definito
finalmente il grado di resistenza del giudicato penale, rispetto alla spinta delle
153
72
Tonini, P., Manuale di procedura penale, undicesima edizione, Giuffrè, Milano, 2010, p. 874.
decisioni di matrice transnazionale e, in particolare delle decisioni provenienti
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per violazione di una delle norme della
Convenzione stessa.
Il caso da cui si è partiti per poi, arrivare alla suddetta sentenza, è stato il caso
Dorigo, nel quale è emers, proprio, l’inadeguatezza e quindi, l’incompletezza dei
rimedi straordinari previsti dall’attuale codice di procedura penale, in relazione
agli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la CEDU. Ai sensi dell’art. 46
della Convenzione, «gli Stati contraenti devono conformarsi alle sentenze
definitive pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, laddove
quest’ultima abbia ravvisato una violazione della Convenzione stessa, o dei suoi
Protocolli».
In particolare, quando la Corte constata una tale violazione, sullo Stato convenuto
grava l’obbligo di ripristinare la situazione anteriore alla violazione accertata e,
solo in via sussidiaria e residuale di accordare un’equa soddisfazione alla parte
lesa. Più precisamente, ai sensi dell’art. 41 CEDU, lo Stato convenuto, accertata la
violazione, ha «l’obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme
attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare misure generali e/o
individuali necessarie». Ciò in quanto, alla luce dell’ultimo articolo citato, le
somme assegnate a titolo di equo indennizzo, avrebbero unicamente come effetto
quello di «accordare un risarcimento per i danni subiti dagli interessati nella
misura in cui questi costituiscano una conseguenza della violazione che non può
in ogni caso essere cancellata»154.
Invece, la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre
in essere, è stata puntualmente individuata dalla Corte europea nella restituito in
integrum in favore dell’interessato; deve trattarsi in altre parole di misure che
siano in grado di porre «il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione
equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata inosservanza (…)
della Convenzione». Ma quel che è ancor più considerevole è che in vista di
questa finalità, lo Stato convenuto, è chiamato anche a rimuovere gli impedimenti
che, a livello di legislazione nazionale, si frappongono al conseguimento di tale
obiettivo: «ratificando la Convenzione»- si è detto- «gli Stati contraenti si
154
Guida al diritto, Il sole 24 ore, n. 17, 23 aprile, 2011, p. 45.
73
impegnano a far sì che il loro diritto interno sia compatibile con quest’ultima» e,
dunque, anche «ad eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni
eventuale ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente»155.
La Corte di Strasburgo, peraltro, ha individuato nella riapertura del processo, il
meccanismo più consono ai fini della restitutio in integrum, segnatamente nei casi
di accertata violazione delle garanzie stabilite dall’art. 6 della Convenzione. Si
tratta, in realtà, più che altro di un “obbligo di risultato”: lo Stato membro resta,
pertanto, libero di scegliere i mezzi per adempiere al proprio obbligo di eliminare
la violazione, «purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute
nella sentenza della Corte»156.
In vista di ciò, larga parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa, si è dotata
di un’apposita disciplina, intesa a permettere la riapertura del processo penale
riconosciuto “non equo” dalla Corte Europea. Ma, mentre in altri Paesi, pur in
assenza di uno specifico intervento normativo, la riapertura è stata comunque
garantita, mediante un’applicazione estensiva dei mezzi straordinari di
impugnazione, già previsti dalle varie legislazioni nazionali, in Italia, sino ad
oggi, nelle ipotesi in cui la Corte Europea accertava la violazione delle garanzie
prescritte dal “diritto a un processo equo”, previste dall’art. 6 della Convenzione,
l’ordinamento processuale penale non è mai stato in grado di assicurare ai
ricorrenti una restituito in integrum, ma solo un risarcimento del danno.
Di qui, l’inadempienza dello Stato italiano, e, in mancanza di una disciplina
processuale ad hoc, si è da subito consolidata una profonda insoddisfazione per
una riparazione meramente pecuniaria a fronte della violazione dei diritti
fondamentali riconosciuti dalla CEDU.
Infatti, per il timore di introdurre nell’ordinamento uno strumento che “svilisse” il
giudicato, il legislatore si è ben guardato dall’adottare una specifica disciplina, e
anzi ha proposto dei rimedi piuttosto complessi, che poi alla fine si sono rivelati
inidonei allo scopo.
Si era, innanzitutto, proposto l’utilizzo di quell’altro mezzo straordinario di
impugnazione,
introdotto
di
recente
nell’ordinamento,
ossia
il
ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti
155
156
74
Guida al diritto, cit., p. 45- 46.
Guida al diritto, cit., p. 47- 48.
pronunciati dalla Corte di Cassazione (art. 625 bis c.p.p.); rimedio che la
giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto utilizzabile in via analogica, al fine di
dare esecuzione alle sentenze della corte di Strasburgo che avessero accertato
violazioni di garanzie convenzionali157.
Ma, come si può capire bene, questo, non può dare una risposta esaustiva al
problema, risultando strutturalmente inidoneo ad assicurare la riapertura dei
processi di fronte a violazioni che non si siano verificate nell’ambito del giudizio
di Cassazione. Ma poi, la stessa Corte, in una sentenza ha precisato che tale
«ricorso è
inammissibile – innanzitutto - se presentato per motivi diversi
dall’errore materiale o di fatto» (con la precisazione che errori materiali sono,
quelli definiti dall’art. 130 c.p.p. come «errori od omissioni che non determinano
la nullità e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell’atto».
Si tratta cioè, di errori che consistono nella falsa percezione di ciò che emerge in
modo chiaro e inequivoco dagli atti e che, tuttavia, siano stati tali da aver indotto
la Cassazione ad affermare l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, la cui
insussistenza
(o,
rispettivamente,
sussistenza)
risulti
invece
in
modo
incontrovertibile dagli atti interni al giudizio di legittimità158), e, in secondo luogo,
che «le disposizioni regolatrici di tale mezzo straordinario di impugnazione, in
quanto deroganti al principio di inoppugnabilità delle decisioni della Suprema
Corte, non sono suscettibili di applicazione analogica»159.
Da escludersi era, inoltre, anche l’impiego dell’istituto della restituzione in
termini per la proposizione dell’impugnazione (art. 175 co. 2, c.p.p.): trattandosi
di meccanismo che, come risulta evidente dalla norma appena citata, risulta
utilizzabile unicamente per porre rimedio alle violazioni della CEDU collegate
alla disciplina del processo contumaciale160.
L’altra soluzione che, allora, si propose era quella che faceva leva sull’art. 670
c.p.p.: in forza di questa disposizione, nel caso in cui la Corte europea, avesse
accertato che la condanna fosse stata pronunciata in violazione delle regole
sull’equo processo, riconoscendosi, in tal caso, il diritto del condannato alla
157
Guida al diritto, cit.
Cass., Sez., II, 23 maggio- 14 giugno 2007, Previti, in Guida dir., 2007, 29, 93.
159
Guida al diritto, cit.
160
Guida al diritto, cit.
158
75
rinnovazione del giudizio, il giudice dell’esecuzione sarebbe tenuto a dichiarare
l’ineseguibilità del giudicato161. Ma anche questo strumento è stato, tuttavia,
considerato inadeguato, perché, come si è giustamente osservato, esso si limita
soltanto a “congelare” il giudicato, impedendone l’esecuzione, ma non lo elimina,
collocandolo, a tempo indeterminato, in una sorta di “limbo processuale”.
L’Italia, dunque, è stata, per anni, reiteratamente censurata, peraltro con toni
molto pesanti,
per l’inadempienza correlata appunto all’assenza, nel nostro
ordinamento di un meccanismo atto a consentire la riapertura del processo
dichiarato “non equo”.
Nel caso sopra citato, la Corte d’Appello di Bologna, alle prese con due richieste
di revisione presentate dal difensore di un condannato, Dorigo, che stava
scontando la pena agli arresti domiciliari (pena inflitta dalla Corte di Assise di
Udine per associazione con finalità di terrorismo e altri reati), aveva sollevato
questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 10 e 27 Cost.
dell’art. 630, comma 1, lett. a), nella parte in cui esclude dai casi di revisione
l’impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale
di condanna si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6
CEDU.
Giova, a tal proposito, ricordare che il processo Dorigo, era, infatti, stato già
giudicato da Strasburgo come in contrasto con l’art. 6 CEDU (equo processo) sin
dal 1998, in quanto, il giudizio di colpevolezza era stato pronunciato sulla base di
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tre coimputati non
esaminati in dibattimento, essendosi avvalsi della facoltà di non rispondere.
Vale, inoltre, la pena ricordare che questo meccanismo di “recupero”, mediante
lettura delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal coimputato è stato, proprio,
il risultato di un’altra sentenza di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla
Corte costituzionale (la n. 254 del 1992), in relazione all’art. 513 c.p.p.
In
quell’occasione, infatti, il Tribunale di Roma, con due ordinanze del 1991, aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 co. 2, c.p.p., prima, in
riferimento alla parte in cui « non consent[isse] di dare lettura dei verbali delle
161
76
Guida al diritto, cit., p. 49.
dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini
preliminari o nell'udienza preliminare, dalle "persone indicate nell'art. 210" - cioè
dalle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei
confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, ovvero imputate
di un reato collegato a quello per cui si procede -, qualora queste compaiano in
dibattimento ma si avvalgano della facoltà di non rispondere». Ad avviso del
remittente, infatti, la norma contrastava con l'art. 3 della Costituzione per
irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui al primo
comma dello stesso art. 513, il quale consente la lettura delle dichiarazioni
precedentemente rese dal coimputato in procedimento non separato che rifiuti di
sottoporsi all'esame. Con la seconda ordinanza, invece, il Tribunale di Roma,
sollevava nuovamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo
comma c.p.p., ma questa volta, nella parte in cui «vieta[va] che si potesse dare
lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle
indagini preliminari o dell’udienza preliminare da coimputato dello stesso reato o
di reato connesso giudicato separatamente e citato ai sensi dell’art. 210 c.p.p.,
qualora lo stesso, comparso, avesse dichiarato di volersi avvalere della facoltà di
non rispondere». Ciò, era evidentemente in contrasto con l’art. 3 Cost., per
irrazionale disparità di disciplina, all'interno del medesimo secondo comma
dell'art.513, tra il caso di imputato di procedimento connesso di cui non si possa
ottenere la presenza e quello di analogo imputato che compaia ma rifiuti di
rispondere (essendo solo nella prima ipotesi possibile la lettura); con gli artt. 24 e
112 della Costituzione, secondo cui costituisce esigenza fondamentale dello Stato
assicurare l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale; nonché,
infine, all'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il divieto in esame,
sottraendo alla cognizione del giudice dichiarazioni contenenti riferimenti a fatti
rilevanti ai fini della decisione, comporterebbe l'impossibilità di una corretta ed
adeguata motivazione della decisione medesima. La Corte, pertanto, ritenne
evidentemente fondata la questione e così dichiarò l’illegittimità costituzionale
dell’art. 513 c.p.p.
Possiamo dire, dunque, che è stata, proprio, la stessa Corte costituzionale, con la
suddetta sentenza, ad innestare nel nostro rito penale, il meccanismo poi ritenuto
77
dalla Corte di Strasburgo in contrasto con l’art. 6, § 3, lett. d) della CEDU, poiché
privava l’accusato del diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico,
determinando così la non equità del processo. Disposizione, a cui, peraltro, la
nostra Costituzione ha dato pieno riconoscimento. Con la legge costituzionale 23
novembre 1999, il legislatore costituzionale, ha, infatti, introdotto nell’art. 111
Cost., cinque nuovi commi, in cui si sintetizzano, i principi cardine ai quali deve
informarsi ogni processo, e in particolare, quello penale. Si tratta dei principi che
sono solitamente racchiusi nell’espressione “giusto processo”. Come si può
facilmente osservare, il comma 3°, di tale disposizione, in cui è contenuto il
catalogo dei diritti spettanti alla “persona accusata di un reato” è dichiaratamente
modellato sull’art. 6, § 3, lett. d) CEDU. Esso, infatti, statuisce che « l’imputato
ha il diritto, davanti al giudice di interrogare o far interrogare le persone che
rendano dichiarazioni a suo carico».
Ora, rispetto alla prima ordinanza della Corte d’Appello di Bologna con la quale
si dichiarava l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p. lett. a), rispetto agli articoli 3, 10 e
27 Cost., la Corte, ebbe modo di osservare che la questione era manifestamente
infondata, in quanto nessuno dei tre parametri costituzionali era, in realtà,
pertinente. Il primo, perché il concetto di inconciliabilità delle sentenze attiene ai
“fatti” su cui si fondano le decisioni, e non alla contraddittorietà logica delle
valutazioni in esse effettuate.
Non il secondo perché l’art. 10, co. 1, non comprende le norme pattizie che non
riproducano principi o norme consuetudinarie del diritto internazionale.
E, neppure l’ultimo, se si considera che la presunzione di innocenza non ha nulla a
che fare con i rimedi volti a eliminare eventuali errores in procedendo o in
iudicando162.
Nel respingere la questione la Corte, non ha, tuttavia, mancato, un “pressante
invito” al legislatore, affinché colmasse con strumenti ritenuti più idonei la lacuna
normativa in contestazione.
Ma, di fronte ad una mancata risposta del legislatore, la questione è stata
successivamente, riproposta, sempre dalla stessa Corte d’Appello di Bologna,
questa volta, però, con significative e decisive differenze rispetto alla precedente.
162
78
Guida al diritto, cit., commento di P. Gaeta, p. 52- 56.
Innanzitutto, questa volta la censura viene indirizzata globalmente all’intero art.
630 c.p.p.; ma soprattutto, la violazione, ora, è allegata ad un diverso e nuovo
parametro, rappresentato dall’art. 117 Cost. Rispetto a quest’ultimo, vale la pena
ricordare, che la giurisprudenza costituzionale, dopo le sentenze n. 348 e 349 del
2007, è stata costantemente orientata nel senso di ritenere che le norme della
CEDU, integrassero, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale
espresso dall’art. 117 Cost., nella parte in cui impone la conformazione della
legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
In questa prospettiva, pertanto, ove si profili un eventuale antinomia tra CEDU e
Costituzione, così come tra CEDU e legge interna, è fatto obbligo ai giudici (ed
agli operatori in genere), innanzitutto, di servirsi di tutte le risorse disponibili sul
piano dell’interpretazione, in particolare esperendo il tentativo di assegnare alla
legge un significato “convenzionalmente” conforme; con la precisazione che,
ovviamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, va interpretata alla luce
degli orientamenti manifestati dalla Corte di Strasburgo, insuscettibili, tra l’altro,
di essere piegati o, adattati dagli operatori interni alle esigenze dell’applicazione,
in forza degli schemi e canoni interpretativi usualmente adottati in ambito
nazionale (primo su tutti, quello dell’interpretazione conforme a Costituzione).
Ma, ove tale intervento non fosse esperibile, non potendo, il giudice nazionale
disapplicare direttamente le norme interne contrarie alla CEDU, a differenza di
quanto avviene in caso di contrarietà al diritto UE, egli dovrà necessariamente,
denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità
costituzionale. A sua volta la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare
l’interpretazione della Convenzione data dalla Corte europea, resta comunque,
legittimata a verificare se la norma della Convenzione si ponga eventualmente in
contrasto con altre norme della Costituzione. Ora, nel caso di specie, laddove la
Corte di Strasburgo ritenga, l’obbligo degli Stati di uniformarsi alle proprie
sentenze definitive, sancito ex art. 46 CEDU, da cui deriva, anche l’impegno degli
Stati a permettere la riapertura dei processi su richiesta dell’interessato come
forma di restitutio in integrum, tale interpretazione, non può certo ritenersi
contraria con le tutele offerte dalla nostra Cost.: garanzie, che tra l’altro con
79
particolare riferimento all’art. 6 CEDU, trovano pieno riconoscimento, come già
detto, appunto nell’art. 111 Cost.
La Corte, si trovava, allora, da una parte di fronte a un vulnus costituzionale e alle
continue sollecitazioni provenienti da Strasburgo ad intervenire e dall’altra parte,
aveva di fronte l’esigenza di rispettare l’intangibile discrezionalità del legislatore
nel ventaglio degli interventi normativi possibili. Ecco che allora, essa preferì
limitarsi a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate
nella parte in cui non prevedano un meccanismo idoneo a rendere effettivi i diritti.
La Corte ha, in sostanza, scelto - come qualcuno ha giustamente osservato - la
strada delle sentenze additive di principio, con le quali, essa non introduce una
norma positiva, immediatamente applicabile, ma si limita a porre un “principio”
che, sebbene debba essere attuato attraverso un successivo intervento del
legislatore, può entro certi limiti costituire, in via transitoria, un riferimento per il
giudice nella decisione dei casi concreti; e, inoltre, già il fatto di far riferimento
alla revisione, implica, in qualche modo, un’opzione della Corte, verso un istituto,
che potrebbe condizionare potenzialmente il successivo intervento legislativo.
È stata, però, generalmente riconosciuta anche la difficoltà di avvalersi della
revisione quale rimedio più idoneo, proprio per come essa è strutturata dall’attuale
codice di rito e, atteso il fatto che il contrasto tre sentenza europee e giudicato
interno non rientra in alcuna delle ipotesi descritte dall’art. 630 c.p.p.
L’istituto della revisione, infatti, si configura tradizionalmente come uno
strumento volto a comporre il contrasto tra la “verità processuale” consacrata dal
giudicato e la “verità storica”, per la sopravvenienza di elementi fattuali “esterni”
al processo.
Evidentemente, diversa è la prospettiva nel caso in cui vi sia un accertamento
della Corte europea di una eventuale violazione dell’art. 6 CEDU. In tal caso,
infatti, come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale, si tratta di «porre
rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente insuperabili con
riguardo agli errores in procedendo) ad un vizio «interno» al processo, tramite
una riapertura del medesimo che ponga l’interessato nelle condizioni in cui si
sarebbe trovato in assenza della lesione».
80
In altre parole, nella prospettiva della violazione dell’art. 6 CEDU, la conseguente
“revisione” del giudicato postula, non la contrapposizione di una rappresentazione
storica ad un’altra (incompatibile) rappresentazione storica, ma, piuttosto, si
contrappone la prima rappresentazione a un giudizio di valore, ossia un giudizio
sul quomodo del precedente accertamento.
In secondo luogo, va osservato, che tradizionalmente, il meccanismo della
revisione è finalisticamente orientato all’esito assolutorio (art. 631 c.p.p.), in
quanto ciò che viene reputato iniquo è la decisione e non già, il processo. Mentre,
invece, la “revisione” per violazione della norma CEDU esige solo la riparazione
ad una violazione procedurale, emendata la quale sarà assolutamente indifferente
l’esito del giudizio.
Queste due osservazioni, sono già da sole sufficienti a far sorgere dubbi circa
l’idoneità della revisione a garantire l’adeguamento alle sentenze della Corte
europea. Ma, tuttavia, nonostante, tali difficoltà, si è riconosciuto che
indubbiamente, proprio quel meccanismo di riapertura del processo, che è alla
base della revisione, è ad oggi, l’unico strumento maggiormente idoneo a
garantire la conformità dell’ordinamento nazionale alle sentenze CEDU.
Da questa sentenza, possiamo facilmente comprendere come, le sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo, assumano una particolare rilevanza all’interno
degli ordinamenti processuali nazionali e, come nel caso di specie, laddove un
processo interno, che dispone una privazione della libertà personale, venga da
essa, giudicato contrario all’art. 6 della Convenzione.
Possiamo allora concludere che per questi casi, per ora l’unica soluzione resta la
revisione del processo interno, così da eliminare quei vizi che la Corte europea
ritiene essere contrari alla Convenzione, senza, però, entrare in alcun modo in
merito alla fondatezza o meno del giudizio di colpevolezza; e, anche se tutto ciò,
implica necessariamente di rimettere in discussione il giudicato !
Il problema, tuttavia, rimane aperto: la stessa Corte costituzionale ha, più volte,
espressamente invitato il legislatore ad intervenire, ribadendo il fatto, che egli,
comunque, rimane libero di scegliere uno strumento specifico, diverso dalla
revisione, che permetta di adeguarsi alle sentenze della Corte europea.
81
In attesa di un intervento del legislatore, tuttavia, la Corte precisa che spetta «ai
giudici comuni di trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo,
avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione»163.
163
82
Guida al diritto, cit., commento di M. Castellaneta, p. 57- 59.
Capitolo II
IL NE BIS IN IDEM
1. Ratio e funzione del divieto.
“Ne bis in idem” è una antica formulazione latina, che letteralmente significa,
divieto di fare una seconda volta, qualcosa che riguardi una medesima questione.
Accanto a questo significato generico, se ne è venuto precisando un altro più
tecnico e specifico, ossia quello di divieto di una seconda pronuncia, e ancor più
precisamente di una seconda pronuncia giurisdizionale,su una medesima
questione già giudicata. Infatti, il campo di applicazione proprio del principio in
esame è stato da sempre quello del processo di qualsiasi tipo, civile, penale o
amministrativo.
Già nel diritto romano, e più precisamente al tempo delle legis actiones, si
affermò il principio del bis de eadem re ne sit actio, col quale si affermava che un
diritto, una volta che fosse stato anche solo in iudicium deductum e, anche se non
ancora iudicatum, non avrebbe più potuto costituire oggetto di un nuovo
procedimento164. Il momento preclusivo era rappresentato dalla litis contestatio,
con la quale si concludeva la prima fase del giudizio. Il processo per legis
actiones, infatti, era distinto in due fasi, la prima c.d. in iure, caratterizzata
dall’intervento dello Stato, attraverso la persona di un magistrato, e la seconda
apud iudicem, caratterizzata, invece, dall’attività del privato cittadino di fronte a
uno iudex privatus. La litis contestatio rappresentava proprio il momento finale
della legis actio, ossia dell’intervento dello Stato, cosicché con essa, cessava
l’azione del pubblico potere165. Di qui, evidentemente, il ruolo primario e decisivo
che si attribuiva a questo momento essenziale e decisivo del primo stadio del
processo, nel quale si produceva la c.d. consunzione processuale ( consumptio per
litis contestationem), volendo con ciò significare che, dopo di essa, si aveva una
164
165
De Luca. I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, Giuffrè, 1963, p.136.
Cogliolo, P., Esecuzione di cosa giudicata, Torino, 1883, p. 12.
83
consunzione (o consumazione) dell’azione che si risolveva, appunto, nel divieto di
riproporre la medesima azione in un successivo giudizio166.
Il cenno più antico relativo al principio del ne bis in idem risale a Cicerone, il
quale diceva: «et acta agimus, quod vetamur vetere proverbio»167. In altro
scrittore, non giurista168, il riferimento è più ampio: «solete t illud quaeri, quo
referatur, quod scriptum est: bis de eadem re ne sit actio’ id est, hoc bis’ ad
actorem an ad actionem?Haec ex iure obscuro»169.
Infine, nelle Institutiones di Gaio troviamo proprio la descrizione relativa
all’applicazione e agli effetti della massima in esame: « tollitur adhuc obligatio
litis contestazione, si modo legitimo iudicio fuerit actio. Nam tunc obligatio
quidem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis contestazione; sed si
condemnatus sit, sublata litis contestazione incipit ex causa iudicati teneri. Et hoc
est, quod apud veteres scriptum est ante litem contestatam dare debitorem
oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem
iudicatum facere oportere»170. In altre parole, si diceva che una stessa actio non
avrebbe potuto essere esercitata o fatta valere due volte, qualunque fosse stato
l’esito che dall’esercizio compiutone la prima volta ne fosse derivato.171
Anche nei sistemi processuali moderni tale principio, inteso come inammissibilità
di una seconda pronuncia sulla medesima questione, trova pieno accoglimento. Si
tratta di un principio generale che ha valenza extrapenale perché tende a evitare
che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti. Esso- si è detto- ha, in
comune con la tradizione romanistica proprio la conseguenza della denegatio
actionis,- (l’impossibilità, cioè, di esperire l’azione penale su di un fatto già
giudicato), seppur «diverse siano le cause dirette: nel diritto romano l’esercizio
dell’autonomia privata…e nel processo penale odierno, la sentenza irrevocabile di
condanna o di proscioglimento»172.
166
Cogliolo, Esecuzione di cosa giudicata, cit., p. 8; De Luca, G., I limiti soggettivi della cosa
giudicata penale, Milano, Giuffrè, 1963, p. 40 ss.
167
Cicerone, Laelius de amicitia, cap. 22, § 85.
168
Quintiliano, in Istitutiones oratoriae, VII, cap. 6, §4.
169
Cornil, Une conjecture sur l’origine de la maxime “bis de eadem re ne sit actio”, in studi in
onore di P. Bonfante , vol. III, Milano, 1930, p. 53 e 44.
170
Gaio, Institutiones, III, 180.
171
Andorioli, V., Ne bis in idem, in Noviss. Dig.it., XI, Torino, 1965, p.185-186.
172
Andrioli, voce, Ne bis in idem, in Noviss. Dig. It.,cit., p.186.
84
Anche il nostro ordinamento ha da sempre accolto questo principio; e anzi,
secondo un autorevole parere, esso rappresenta l’unico effetto tipico del giudicato
penale173. Già il codice del 1865 lo prevedeva espressamente nell’art. 518, e così
anche il codice del 1913 lo stabiliva nella disposizione dell’art. 435, fino ad
arrivare, poi, all’ultimo codice di procedura penale abrogato, il quale poneva la
disciplinava del divieto del ne bis in idem nell’articolo 90, rubricato
“Inammissibilità di un secondo giudizio” . Oggi, nell’attuale codice di rito, esso,
invece, trova una compiuta formulazione nell’art. 649 c.p.p., sotto il titolo:
“Divieto di un secondo giudizio”, il quale dispone che “L’imputato prosciolto o
condannato con sentenza penale diventi irrevocabile, non si può essere di nuovo
sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene
diversamente considerato per il titolo, il grado e le circostanze”.
L’art. 649 c.p.p., in altre parole, attribuisce alla sentenza di condanna o di
assoluzione che sia divenuta irrevocabile, cioè assistita dal c.d. giudicato formale,
efficacia di giudicato sostanziale, inteso come vincolo a non più sentenziare sullo
stesso fatto e nei confronti delle medesime persone. Tale principio si configura,
pertanto, come dovere del giudice successivamente adito di declinare la decisione
in tal modo paralizzando una nuova identica azione penale essendosi resa
processualmente consumata proprio nel giudicato sostanziale discendente dal
primo giudizio174. Esso- si è detto- è espressione del c.d. principio di consunzione
(o consumazione), « in virtù del quale non può entrare nel mondo giuridico un
provvedimento che abbia lo stesso contenuto pratico di quello già assunto
irrevocabilmente»175. Ne deriva che il divieto in esame appartiene alla categoria
della preclusione processuale. L’effetto preclusivo è, appunto, collegato all’essere
stata pronunciata nei confronti di un dato soggetto una sentenza irrevocabile su di
un determinato fatto, a prescindere dal contenuto dell’accertamento176. È ormai
173
Lozzi, G., Giudicato (dir. proc.pen.), in Enc. Giur., p. 913.
Cass. III, sent. n. 2970 del 16.11.1995, in AA. VV., Codice di procedura penale, a cura di Gatti
g., 1988, p. 1744-1751.
175
Andrioli, voce, Ne bis in idem, in Noviss. Dig. It.,cit., p. 186; e. Rocco, A., Sul concetto di
decisione giudiziaria penale, quale presupposto formale della cosa giudicata penale, in Opere
giuridiche, III, Roma, 1933, p. 67.
176
De Luca, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Giuffrè, 1989, p. 124; Lozzi, G.,
Giudicato (dir. proc.pen.), in Enc. dir.,XVIII, Milano, 1969, p. 913; Rivello, P.P., Commento
all’art. 649 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., coordinato da M. Chiavario, vol. V, UTET, 1986,
p. 424; e v. Cass., Sez., I, 24.1.1995, Sorgato, in CED, Cass., n. 200695.
174
85
comunemente riconosciuto, infatti, che il giudicato penale, a differenza di quello
civile (art. 2909 c.c.), non svolge efficacia di accertamento della fattispecie
criminosa dedotta in giudizio, proprio perché nessuna norma prescrive ai giudici
di successivi procedimenti penali di uniformarsi all’accertamento contenuto nella
decisione irrevocabile177, ma la preclusione opera prima.
L’art. 649 c.p.p. ha ripreso, in larga parte, il contenuto del previgente art. 90 c.p.p.
abr., tanto che rimangono i medesimi nodi interpretativi già profilatisi sotto
l’imperio del vecchio codice e tanto che risultano ancora attuali le diverse
soluzioni allora prospettate; esso, tuttavia, si presenta in una collocazione
sistematica del tutto nuova. Se, infatti, la corrispondente norma del codice di rito
previgente era inserita nel libro I (Diposizioni Generali), Titolo III (Delle parti),
Capo II (Delle parti private), Sezione I (Dell’imputato), oggi, invece, lo troviamo
all’interno del libro X dedicato all’esecuzione e, in particolare, nell’ambito del
Titolo I (Giudicato).
È stata, così, recepita l’impostazione già accolta nel progetto del 1978 con l’art.
612, rubricato “divieto di un secondo processo”, il quale, pur ripetendo
sostanzialmente i contenuti del previgente art. 90 c.p.p. abr., era però, contenuto
nel libro XI (Esecuzione), Titolo I (Disposizioni generali), Capo I (Giudicato).
Tuttavia, il trasferimento di tale principio nel libro dedicato all’Esecuzione ha
suscitato non poche perplessità. Si osservò, infatti, che, se è vero che tale divieto
assume il ruolo di fondamentale garanzia di certezza di carattere soggettivo,
sottraendo l’imputato, ad una teorica illimitata possibilità di persecuzione penale,
meriterebbe, allora, una collocazione più adeguata, data la sua natura.
Si può, poi, osservare che la rubrica dell’art. 649 c.p.p. ha sostituito con il termine
“divieto”, quello di “inammissibilità”, contenuto nel previgente art. 90 c.p.p. abr.
A proposito della precedente dizione “inammissibilità di un secondo giudizio”, c’è
stato chi, in passato, ha ritenuto che essa fornisse un supporto letterale alla tesi per
cui «l’inammissibilità andasse riferita al procedimento e non già ai singolo
atti»178. In realtà, come fu, poi, autorevolmente osservato179, la contrapposizione
tra le due tesi (quella per cui l’inammissibilità andrebbe riferita ai singoli atti, e
177
Cass., 24.6.1998, Ottaviano, in Cass. pen., 2000, 400.
Sabatini, G., Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Torino, 1953, p.80.
179
Galli, G., L’inammissibilità dell’atto processuale penale, Milano, 1986, p. 49.
178
86
quella secondo cui, invece, essa concernerebbe l’intero procedimento), non ha, in
realtà, alcun fondamento; sarebbe stato semmai più opportuno, «combinare i due
criteri, in quanto, l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento
determina inammissibilità dei singoli atti dei quali esso consta e quindi dell’intero
procedimento».
Tuttavia, secondo un autorevole parere, l’attuale codice, con il termine “divieto”,
ha forse adottato una formulazione impropria180; esso, però, si è aggiunto, «ha il
merito di avvicinarsi maggiormente alla effettiva sostanza della situazione
delineata, consistente appunto, in un assoluto divieto di non fare»181. Del resto,
secondo qualcun altro, se si fosse utilizzato il termine “preclusione”, si sarebbero
«creati certamente degli equivoci, giacché, l’area della preclusione, almeno
comunemente,
viene limitata al singolo processo dal quale trae origine,
assumendo così una valenza meramente endoprocessuale, non certo compatibile
con l’estensione extraprocessuale propria del ne bis in idem».
L’istituto del ne bis in idem, in sostanza, è volto non a scongiurare il rischio di una
contraddizione teorica tra giudicati, ma soltanto a prevenire un conflitto pratico
fra più decisioni, affinché il singolo individuo sia sottratto dal rischio di
un’indefinita reiterazione di procedimenti in ordine allo stesso episodio, e sia così
assicurata le certezza in senso soggettivo. E l’art. 649 c.p.p. si pone, proprio, quale
norma di “sbarramento”, volta cioè a evitare che un individuo possa essere
assoggettato ad una pluralità di decisioni in relazione allo stesso fatto182. Ciò,
inoltre, si evince dall’evidente collegamento fra l’istituto in argomento e lo
strumento previsto dall’art. 669 c.p.p., che mira proprio a rimediare ai casi in cui,
nonostante il divieto suddetto, siano state pronunciate contro la stessa persona per
il medesimo fatto più sentenze irrevocabili, imponendo al giudice dell’esecuzione
di ordinare l’esecuzione della sentenza meno grave e di revocare le altre.
Pur appartenendo alla tradizione dello stato liberaldemocratico, discendendo dai
valori dello Stato di diritto, e pur, essendo espressamente previsto, elevato a rango
di diritto civile o politico, nei più importanti trattati internazionali a tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali, tuttavia, il principio del ne bis in idem non
180
Cristiani, A., Manuale del nuovo processo penale, Torino, 1991, p. 498.
Galli, G., L’inammissibilità cit., p. 50.
182
Rivello, P.P., voce Ne bis in idem, in Riv.it. dir. e proc. pen., 1991, p. 476-528.
181
87
trova un esplicito riconoscimento nella nostra Costituzione, e ciò nemmeno a
seguito della recente riforma dell’art. 111 Cost; anche se, già nei lavori
dell’Assemblea Costituente si discusse sulla opportunità di costituzionalizzare o
meno tale divieto. Ciononostante, l’interprete si è spinto a tentare di ricercarne un
fondamento in alcune norme costituzionali.
Si è detto, a tal proposito, « il
principio del ne bis in idem a ben vedere, esprime il giusto equilibrio tra due
interessi contrapposti: l’uno, all’apertura illimitata dei processi al sopraggiungere
di prove nuove, mediante la riproposizione dell’azione penale, o l’introduzione di
impugnazioni straordinarie sfavorevoli; l’altro, è l’interesse alla c.d. “quiete
penalistica»183. «Dietro la possibilità di una riapertura del processo, anche in
senso sfavorevole, sta un interesse costituzionale, non espresso ma evidente nella
trama della Costituzione, alla punizione dei reati, secondo verità. Emerge dal
tessuto costituzionale alla punizione dei reati che l’accertamento degli stessi
avvenga secondo verità»184.
Espressioni di tale principio le troviamo in varie norme costituzionali, come
quella che prevede la obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), ma
soprattutto nelle norme che consentono limitazioni o privazioni di diritti
costituzionali per l’accertamento dei reati: artt. 13 co.2 e 3, Cost; 15 co.2, Cost.
Anche l’art. 111 co.5, nel prevedere alcune limitazioni al funzionamento del
contraddittorio, è funzionale al superiore interesse all’accertamento della verità185.
È stato affermato, ancora, che l’interesse contrapposto all’illimitato potere di
accertamento e repressione dei reati , in ogni tempo, può essere compreso alla luce
dell’art. 25 co.2, Cost., il quale, nel sancire l’irretroattività della norma penale
incriminatrice, stabilisce il diritto di ciascuno di sapere anticipatamente cosa gli è
vietato; cosa, in altri termini, sia ritenuto rilevante dalla sanzione penale. L’art. 25
è stato considerato volto a « tutelare l’interesse ad una “quiete penalistica”, nel
senso che il cittadino deve poter contare su un quadro penalistico (sostanziale e
processuale) stabile. Questo interesse alla “quiete penalistica”, se sotto il profilo
sostanziale, si traduce nella irretroattività della norma penale incriminatrice; sul
183
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato e i suoi effetti civili, UTET, 2003, p. 105-106.
D’Orazi M., La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di
ammissibilità, Padova, CEDAM, 2003, p. 153.
185
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato e i suoi effetti civili, UTET, 2003, p. 105-106.
184
88
piano processuale, esso fonda proprio il principio del ne bis in idem »186. Ebbene,
dopo una certa fase del processo, la situazione penalistica deve stabilizzarsi anche
sul piano processuale, rendendo la situazione del cittadino non modificabile,
anche di fronte a nuove prove. Questo, si è detto, è un interesse del tutto
omogeneo ai valori costituzionali vigenti, non solo nel senso di un generico favor
rei, quanto piuttosto sul piano di una visione “contrattualistica”, per cui, da un
certo momento in avanti, non è consentito al potere pubblico modificare
unilateralmente la situazione penalistica dei cittadini187.
Si è osservato, inoltre, come questo interesse alla c.d. “quiete penalistica”, in
ambito processuale, troverebbe fondamento, oltre che nell’art. 25 co. 2 Cost.,
anche nell’art. 27 co. 2 Cost. In relazione a quest’ultimo profilo deve, infatti,
osservarsi come il sistema processuale penale tenda al provvedimento definitivo
che rappresenta per l’imputato un rischio (di essere considerato colpevole, di
subire una sanzione maggiore di quella attesa o ritenuta giusta). Egli è, dunque, in
una situazione di incertezza e di potenziale pericolo, fino al provvedimento
definitivo. La norma costituzionale si riferisce, però, proprio a un provvedimento
definitivo che è, sì, potenzialmente nocivo per l’imputato (nel caso di condanna),
ma, anche, conclusivo di quella situazione di incertezza processuale.
La definitività, si è detto, «non deve essere intesa solo come requisito che
permette di superare la presunzione di innocenza ma anche come momento finale
della incertezza , inevitabilmente connessa al processo. Emerge allora, dal sistema
costituzionale, che il giudicato rappresenta proprio il momento finale di questa
“incertezza” per l’imputato; dopodiché egli ha interesse ad essere posto, in
relazione a quel fatto, in condizione di “quiete penalistica”, al riparo da
“sorprese”, in questo caso processuali»188. Ora, atteso che la ratio del principio in
esame è quella di garantire la incontrovertibilità del risultato del processo, e
dunque dare garanzia di certezza di carattere soggettivo all’imputato, sottraendolo
ad una illimitata possibilità di persecuzione penale, occorre, a questo punto,
accertare se « il ne bis in idem si fondi su una esigenza di logica giuridica, come
186
D’Orazi, M., loc. cit., 2003, p. 160.
D’Orazi, M., loc. cit., 2003, p. 161.
188
D’Orazi, M., loc. cit., 2003, p. 161-162.
187
89
sembra sostenere l’Attardi189, ovvero costituisca una semplice direttiva legislativa
storicamente variabile e condizionata dalla struttura di un determinato
ordinamento»190.
De Luca, a tal riguardo, osserva come, più che «in una impossibilità logica, il
principio del ne bis in idem, trov[i] la sua ragion d’essere in un motivo di utilità
pratica: ciò spiega perché, in concreto, il ne bis in idem, che
impedisce la
reiterazione di un atto avente la stessa direzione pratica di quello già posto in
essere, assuma atteggiamenti diversi e abbia un ambito di applicazione diverso a
seconda dei criteri di identificazione, scelti dal legislatore, contenuti appunto in
norme convenzionali:« ciò basta per dimostrare che il principio suddetto si fonda,
non già su schemi logici aprioristicamente presupposti, ma su criteri di mera
opportunità pratica». Si è aggiunto, inoltre, che: «l’operazione di controllo, nella
quale si risolve l’identificazione dei fatti, rispetto ai quali opera il ne bis in idem,
avviene alla stregua di indici che il legislatore assume preventivamente come
termini su cui valutare il rapporto di identità, indipendentemente dalla loro
rispondenza a canoni di assoluta logica»191. Ma, allora, essendo tali criteri o
parametri sui quali si misura l’identità del tutto convenzionale, avremo che fatti
ontologicamente diversi si considerano come se fossero identici. Ciò risulta
chiaramente dal contenuto dell’art. 649 c.p.p., in cui si afferma il principio
secondo il quale i fatti si considerano identici anche se vengono diversamente
considerati per il titolo, grado e circostanze192.
2. Provvedimenti aventi efficacia preclusiva.
La preclusione processuale, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., consegue alle decisioni
irrevocabili, fatta eccezione per le sentenze di proscioglimento per difetto di una
condizione di procedibilità successivamente sopravvenuta (art. 345 c.p.p.) e di
morte del reo erroneamente dichiarata (art.69 comma 2 c.p.).
189
Attardi, La cosa giudicata, estr. da Jus, Milano, 1949, p. 33.
De Luca, G. I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, Giuffrè, 1963, p. 141.
191
De Luca, G., I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, cit., p. 142.
192
De Luca, G., Giudicato II (dir. proc. pen.), in Enc. giur., XVI, Roma, Treccani, 1990, p. 5- 11.
190
90
L’individuazione dei provvedimenti aventi efficacia impeditiva avviene mediante
il riferimento alla categoria della irrevocabilità e, perciò, implicitamente al
contenuto dell’art. 648 c.p.p.
L’irrevocabilità delinea, per così dire, un’area intangibile che preclude al giudice
di pervenire ad una nuova decisione nei confronti della stessa persona sulla
medesima questione già decisa con sentenza passata in giudicato.
Risultano, in altre parole, ostative ad un secondo giudizio le sentenze di merito
pronunciate in giudizio non più soggette ad impugnazione e i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili. In questa prospettiva, si presentano privi di ogni
efficacia preclusiva un insieme di provvedimenti, tra i quali rilevano la sentenza
emessa in sede di udienza preliminare e il provvedimento di archiviazione. Tale
interpretazione restrittiva emerge da un orientamento giurisprudenziale che è
solito disconoscere alla sentenza di non luogo a procedere capacità preclusive di
un nuovo giudizio, data l’esistenza per questa di un apposito procedimento di
revoca (artt. 434- 437 c.p.p.). Di qui la conclusione, maggioritaria in
giurisprudenza, secondo la quale «la forza preclusiva del non luogo a procedere si
caratterizza per un’intensità minore rispetto a quella tipica del ne bis in idem»193.
La Cassazione ha, tuttavia, precisato che « la sentenza emessa a norma dell’ art.
425 c.p.p., oltre a dispiegare un efficacia esclusiva rebus sic stantibus, può sortire
anche un effetto preclusivo irreversibile, analogo a quello del ne bis in idem,
precisamente nell’ipotesi di non luogo a procedere per estinzione del reato,
rispetto alla quale non sarebbe possibile configurare neppure in via ipotetica la
sopravvenienza di presupposti per un nuovo esercizio dell’azione penale»194.
Si ritiene inoltre, che pur essendo le sentenze di non luogo a procedere sempre
“revocabili”, « se si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a
quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio», ciò non esclude
che, ove manchino in concreto le condizioni per la sua revocabilità, tale tipo di
sentenza precluda ugualmente il nuovo esercizio dell’azione penale per lo stesso
fatto contro la stessa persona195. In sostanza, pur ritenendosi escluse le sentenze di
193
Cass. Sez., III, 18.1.1994, Bignami, in Cass. pen., 1994, 1523, 2456 e Cass. 17.1.1994, Piona,
in Giust. pen, 1996, III, 512.
194
Cass. 8.11.1996, Privitera, in Cass. pen., 1998, 838,
195
Cass. Sez. VI, 8. 11. 1996, Privitera, in Cass. pen., 1998, p. 838; Cass. Sez. V, 29.1.1992,
Rapezzi, in CED, Cass., n. 190258.
91
non luogo a procedere dal giudicato formale di cui all’art. 648 c.p.p., attesa la
revocabilità delle stesse pur dopo il decorrere dei termini di decadenza delle
impugnazioni ordinarie, è pur vero che, fino a quando non risultino integrati i
requisiti dell’art. 434 c.p.p., opera comunque l’effetto preclusivo proprio del
giudicato196.
Per quanto riguarda, il provvedimento di archiviazione, evidentemente, esso non
rientra nell’ambito delimitato dall’art. 649 c.p.p., non possedendo nessuna delle
caratteristiche elencate (viene emesso in fase procedimentale e possono essere
riaperte le indagini), e non esistendo una norma ad hoc che gli attribuisca specifici
effetti vincolanti. Tuttavia una sorta di effetto preclusivo, seppure non assoluto,
gli è stato riconosciuto in una pronuncia della Corte Costituzionale. In tale
occasione, è stata considerata corretta l’emissione del decreto di archiviazione una
volta accertata una causa ostativa di un secondo giudizio perché non è ipotizzabile
un obbligo per il Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale al solo fine di
instaurare un processo che dovrà terminare con la formula del “non doversi
procedere” per l’esistenza di un precedente giudicato197.
Quando, poi, la causa ostativa derivante dal precedente giudicato emerga nel corso
del giudizio di cassazione, la Suprema Corte, verificata la sussistenza del
contrasto tra la sentenza gravata e un’altra precedente, anziché emettere sentenza
di proscioglimento, ai sensi del 649 co 2º, ordinerà l’esecuzione di quella più
favorevole al condannato e annullerà senza rinvio l’altra198. Si tratta di una regola
che anticipa la norma di chiusura, contenuta nell’art. 669 c.p.p. Se, infatti, la
norma di sbarramento di cui all’art. 649 c.p.p. non è rispettata e un soggetto viene
assoggettato ad una pluralità di decisioni in relazione allo stesso fatto troverà
applicazione proprio l’art 669 c.p.p. che offre, si è detto,199 «una tutela di tipo
processuale avanzata contro il rischio di un cumulo di sentenze di condanna” in
relazione ad’unica fattispecie criminosa». Esso, in particolare, dispone che, nel
caso in cui « più sentenze divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la
196
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili, UTET, 2006, p.
114.
197
C. Cost., 12.1.1995, n. 27, in Giust. cost., 1995, 262; vedi anche Cass. Sez. V, 12.12.1991,
Cittaro, in Cass. pen., 1994, 1880, 1149.
198
Tranchina, L’esecuzione, in Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale,
II, Milano, 2004.
199
Rivello, P.P., Art. 649 c.p.p., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, p. 476- 528.
92
stessa persona e per il medesima fatto, il giudice ordina l’esecuzione della
sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre».A tal
proposito, nella Relazione al progetto preliminare del c.p.p. del 1988, si osservava
che: «una applicazione rigorosamente formale dei principi generali avrebbe
portato all’esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile per prima, essendo
stata quella, o quelle successive, erroneamente pronunciate in violazione del ne
bis in idem». Ma, si aggiungeva:« nel sistema vigente, esigenze di equità hanno
determinato, in applicazione al principio del favor rei, la prevalenza della
condanna meno grave»200. Dall’altro lato, si è, allo stesso tempo, rilevato che nel
nostro ordinamento non è prevista alcuna pregiudiziale penale e che
l’impugnazione straordinaria della revisione prescinde dalla violazione del ne bis
in idem, operando esclusivamente in bonam partem e, dunque, non in tutti casi di
inconciliabilità tra giudicati. Nel caso, infatti, di conflitto fra una sentenza di
condanna e una sentenza di assoluzione, soltanto la condanna può essere revocata
azionando il rimedio straordinario della revisione, laddove gli elementi posti a
base della domanda siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato
doveva essere prosciolto a norma degli artt. 529-530-531 c.p.p., mentre il
contrasto teorico sarebbe destinato a permanere laddove l’errore fosse insito nella
sentenza di proscioglimento.
In dottrina, si è, poi, affermato che la preclusione di un nuovo giudizio non può
derivare esclusivamente dalle sole sentenze di merito “pronunciate in giudizio”,
ma dovrebbe essere collegata, piuttosto, anche a quelle pronunciate a conclusione
del giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta delle parti201.
Ricorrente è stata, poi, la questione di legittimità costituzionale del principio del
ne bis in idem, come disciplinato dal legislatore sia del codice abrogato, sia di
quello attualmente in vigore, sotto il profilo della necessaria irrevocabilità della
sentenza contenente il decisum, essendo parso, in contrasto con l’art. 3 Cost. che
la non reiterabilità del procedimento per uno stesso fatto contro la stessa persona
non sia anche prevista in caso di sentenza non passata in giudicato.
200
Cass. Sez. I, 18.4.1995, in Cass. pen., 1997, 1398, con nota di Alessandra Bassi.
Dean, L’accertamento giudiziale nei procedimenti semplificati e l’efficacia extrapenale del
giudicato, in Gaito, A., I giudizi semplificati, Padova, 1989, p. 355.
201
93
La giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 90 c.p.p. abr. è sin dall’inizio
rimasta ferma su una posizione di rigida osservanza del limite testuale insito in
detta disposizione, escludendo che l’esistenza di una sentenza non irrevocabile
emessa in un primo procedimento potesse legittimare nel processo successivo
promosso contro la stessa persona e per il medesimo fatto, la pronuncia di non
doversi procedere per impromovibilità dell’azione penale202.
In tale ottica la Corte Costituzionale dichiarò non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 90, rilevando che non può dirsi «violato il
principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. per il motivo che nella sua funzione
preclusiva della reiterazione di un procedimento penale, la norma denunciata non
equipara le due situazioni giuridiche, quella della sentenza divenuta irrevocabile
rispetto a quella che tale ancora non sia». La Corte ha, infatti, sottolineato come le
due situazioni siano profondamente differenziate sul piano giuridico e, che il
diverso trattamento è di per sé giustificato, tanto più perché, « l’ordinamento
processuale penale appresta, a tutela dell’unità del processo, altri istituti, dalla cui
applicazione risulta oltremodo difficile che ad un procedimento terminato con
sentenza, benché non ancora irrevocabile, ne possa seguire un altro per lo stesso
fatto»203. E così, lungo la stessa linea si è mossa la giurisprudenza della Corte di
Cassazione nei primi anni di applicazione del nuovo codice di rito, ribadendo, che
l’art. 649 c.p.p. tende proprio ad evitare la duplicazione dei giudicati nei soli casi
in cui sia già intervenuta sentenza irrevocabile, con la conseguenza che il divieto
del ne bis in idem è rigorosamente subordinata all’esistenza di decisioni connotate
dal requisito della irrevocabilità. E così, recentemente si è detto che l’esistenza di
una sentenza irrevocabile è condizione tassativa ed inderogabile per l’applicazione
dell’art. 649: « il divieto di sottoporre taluno a procedimento penale, quando per
lo stesso fatto sia stato celebrato un precedente giudizio, opera solo a condizione
che quest’ultimo sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti
irrevocabili, come testualmente dispone l’art. 649 c.p.p., con la conseguente
illegittimità della sentenza che disponga di doversi procedere, nei confronti
dell’imputato, sul solo presupposto che questi sia sottoposto ad altro giudizio per
202
Cass. Sez. I, 7 marzo 1985, Monitoro, in CED, Cass. n. 168614; Cass., Sez., I, 8 giugno 1982,
Bolognini, ivi, n., 154900; Cass., Sez., I, 8 giugno 1982, Chiavalon, ivi, n. 154895.
203
Corte cost. 14.1.1976, n. 6, in GIC, 1976, I, 35.
94
il medesimo fatto, sebbene ancora non concluso mediante un provvedimento
irrevocabile»204. In un simile contesto interpretativo è stata, pertanto, dichiarata
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione
della legittimità costituzionale di tale disposizione, «nella parte in cui non prevede
il divieto di un secondo giudizio anche rispetto a sentenza non irrevocabile, in
quanto, atteso il carattere generale della norma, non violerebbe né il principio di
uguaglianza, né i diritti di difesa»205. Quanto appena detto, non vuol dire, però
implicitamente, che nel nostro ordinamento processuale, sia possibile l’effettiva
reiterazione di più procedimenti penali contro la stessa persona per il medesimo
fatto, solo perché la sentenza precedente non sia divenuta irrevocabile.
L’interesse del singolo a non doversi difendere più volte dalla medesima
imputazione, si è osservato, è identico sia nel caso in cui nel primo procedimento
la sentenza non sia ancora divenuta irrevocabile, sia nel caso in cui, invece, tale
circostanza si sia realizzata; come pure non appare logico che, indipendentemente
dalla conclusione del primo procedimento con sentenza, irrevocabile o meno, egli
possa essere contemporaneamente sottoposto a distinti procedimenti o processi
penali relativi alla medesima vicenda. Si tratta, allora, di accertare se il sistema
processuale vigente recepisca simili istanze di logica e libertà, ovvero se debba,
invece, ritenersi accolta una concezione del principio del ne bis in idem
rigorosamente ancorata al ferreo requisito della esistenza di un precedente
giudicato206.
Al riguardo, possiamo notare, come la compattezza, di quell’indirizzo che per
lungo tempo ancorava il divieto del ne bis in idem alle sole sentenze che fossero
ormai divenute irrevocabili, ha iniziato a subire una prima incrinatura, da quando
con una pronuncia del 1986, la Cassazione diede avvio a un nuovo orientamento
giurisprudenziale che faceva leva sulla portata generale del ne bis in idem. In tale
occasione, in presenza di un’ordinanza che disponeva l’applicazione di una misura
cautelare nei confronti di chi era stato prosciolto con sentenza non ancora
definitiva, la Suprema Corte, dichiarò illegittima la nuova misura cautelare perché
in contrasto con il principio generale del ne bis in idem. In tal caso, si
204
Cass., Sez., III, 23.2.2005, Massa, in CED, Cass., n., 230872.
Cass. Sez., III, 23 gennaio 1996, Castellano, in CED, Cass., n., 207105.
206
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato e i suoi effetti civili, UTET, 2003, p. 105-106.
205
95
argomentava partendo proprio dalla presunzione dalla portata generale del
principio di cui è espressione l’art. 649 c.p.p., che si traduce, anche prima del
passaggio in giudicato, in un divieto di inizio del nuovo procedimento penale. Si
diceva- « è vero che l’art. 649 c.p.p., collega il divieto di un secondo giudizio alla
pronuncia di una sentenza o di un decreto penale che siano divenuti irrevocabili,
ma ciò non significa che, fino a quando non sia stata pronunciata una sentenza
irrevocabile, possano legittimamente svolgersi, nei confronti della stessa persona
e per lo stesso fatto, più procedimenti penali. L’art. 649 c.p.p., come le norme sui
conflitti positivi di competenza o come l’art. 669 c.p.p. (che disciplina il caso in
cui siano emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), è
espressione di un generale principio di ne bis in idem, che tende innanzitutto a
evitare che per lo stesso fatto-reato, si svolgano più procedimenti e si emettano
più provvedimenti, l’uno indipendente dall’altro, e, in secondo luogo, mira a porre
rimedio alle eventuali violazioni di detto principio»207. La decisione appena
ricordata ha dato, così, l'avvio ad un consistente filone interpretativo
uniformemente rivolto ad attribuire all'art. 649 c.p.p. una dimensione applicativa
più ampia di quella che traspare dalla enunciazione letterale, strettamente correlata
al principio generale dell'ordinamento processuale che, vieta la duplicazione del
processo contro la stessa persona per il medesimo fatto208. Secondo questa
giurisprudenza, l’improcedibilità per bis in idem, opera anche in prevenzione, e
ciò perché si diceva: « posto che l’art. 649, al pari delle norme sui conflitti di
competenza e dell’art 669, costituisce espressione generale del principio del ne bis
in idem, non è da discutersi che esso sia consentito, in pendenza di un
procedimento in grado di appello, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei
confronti della stessa persona un nuovo procedimento ed emessa un’ordinanza di
custodia cautelare».
La stessa giurisprudenza costituzionale, superando la ristretta interpretazione,
proposta nel 1976,
ha indicato una possibilità di ritenere sussistente una
accezione più piena del principio del ne bis in idem », rilevando come
207
Cass., sez., V, 10.7.1995, Pandolfo, in Cass. pen., 1996, 2667.
Cass. sez.VI, 11.2.1999, Siragusa, in Cass.pen., 2000, 399; Cass. sez. VI, 25.2.2002, Suslsenti,
ivi, 2003, 3861; Cass. sez. I, 30.4.2003, Mortero, in CED, Cass., n., 225004; Cass. sez. VI,
18.11.2004, Fontana, in CED, Cass., n., 230760.
208
Cass. sez. III, 23.5ì4.1996, Poloni, in Cass. pen., 1997, 2819.
208
96
l’operatività del principio di cui all’art. 529 c.p.p. (“Sentenza di non doversi
procedere”), possa essere estesa fino a « comprendere tutte le ipotesi in cui per
quel medesimo fatto l’azione penale non avrebbe potuto essere coltivata in un
separato procedimento perché già iniziata in un altro ». A sostegno di questa tesi,
si è osservato, che diversamente da altri ordinamenti, in cui il giudicato appare
come un ostacolo al diritto di impugnare le sentenze penali assolutorie, ovvero
presenta un effetto vincolante, imponendo al giudice di uniformarsi alla
precedente pronuncia, il dettato dell’art 649 c.p.p., disciplina il ne bis in idem
come un dovere del giudice adito successivamente di declinare la decisione; in
altre parole, «nel constatare una situazione di preclusione nascente dall’essersi già
proceduto altra volta per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona, il
giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza declinando la propria investitura»209.
E, il 2º comma dell’art. 649 c.p.p., offre al giudice un’alternativa, quanto alla
individuazione precisa del tipo di pronuncia da emettere, in relazione al momento
processuale in cui la causa preclusiva viene rilevata210.
Non sono mancate, tuttavia, talune disposizioni della Cassazione, le quali si sono
poste al di fuori dell’alternativa tra l’applicabilità o meno dell’art. 649, nella
convinzione che, nella disciplina apprestata per i conflitti di competenza, potesse
individuarsi il rimedio atto a risolvere le ipotesi di contemporanea pendenza di
distinti procedimenti penali a carico della medesima persona per fatti identici;
riservando, invece, la pronuncia di improcedibilità dell’azione penale, fondata
sull’art. 649 c.p.p., ai soli casi di esistenza di una sentenza già passata in
giudicato211. A sostegno di questa tesi, si argomentava dal disposto dell’art. 28
lett. b) c.p.p. il quale, come possiamo notare, descrive una tipica situazione di
litispendenza, allorché identifica un conflitto positivo nei casi in cui «due o più
giudizi ordinari contemporaneamente prendono…cognizione del medesimo fatto
attribuito alla medesima persona». Si è sostenuto allora, che, nel caso di
procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fattoreato, la competenza spetterebbe al giudice del procedimento che si trova nella
209
Gaito, A., Ne bis in idem, in Codice di procedura penale ipertestuale, Tomo I, UTET, 2006, p.
2786-2792.
210
Gaito, A., Esecuzione, in AA.VV., Compendio di procedura penale, a cura di G. Conso- V.
Grevi, Padova, 2003, p. 928.
211
Cass. Sez. III, 23.5.1996, Poloni, in Cass. pen., 1997, 2819.
97
fase più avanzata e che, l’unificazione deve essere realizzata con l’applicazione
del criterio della progressione attraverso l’assorbimento dell’un procedimento
nell’altro212.
Ma, data l’incertezza argomentativa manifestata dalla Cassazione sul punto in
questione, sono intervenute di recente le Sezioni Unite, alle quali si deve
l’elaborazione del principio di litispendenza penale quale criterio risolutore dei
casi di ne bis in idem, pur in assenza di precedente sentenza passata in
giudicato213. Sulla stessa linea, essa ha, altresì, censurato la prassi, insorta in
alcuni casi, di ricorrere a meccanismi dilatori atti a frenare il corso del primo
processo fino a quando il secondo non fosse giunto alla stessa fase e grado del
precedente così da rendere possibile la riunione dei due procedimenti, oppure, alla
sospensione del processo successivo, fino alla conclusione del primo con sentenza
irrevocabile; perché ritenuta abnorme, in quanto contrastante con la tassatività
delle ipotesi di sospensione del processo penale (art. 3 e 50 c.p.p.). Essa, ha
giustamente osservato che, se il riferimento al conflitto positivo è indubbiamente
corretto nei casi di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, in
quanto la contemporanea cognizione dell’identica regiudicanda
ad opera di
giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un conflitto
positivo “proprio”, risolubile mediante l’applicazione dell’art. 28 c.p.p.; il
problema rimane, invece, a proposito dei casi di contemporanea pendenza di più
processi, caratterizzati dall’ eadem res iudicanda innanzi alla stessa sede
giudiziaria, non essendo questi, espressamente contemplati dal legislatore. Si può,
tuttavia, facilmente comprendere che in questi casi non può ritenersi corretta
l’estensione della normativa sui conflitti positivi di competenza, proprio in
quanto, non vi è alcuna implicazione riguardante questione di competenza per
territorio e per materia. E questo, si è osservato, vale non soltanto, se i
procedimenti duplicati pendano dinanzi a giudici dello stesso ufficio, nella stessa
fase o in fasi differenti, ma anche quando, essi si trovino in gradi diversi. Ad essi,
peraltro, non potrebbe applicarsi neanche la procedura sui conflitti cd “atipici”, di
cui all’art. 28 c.p.p, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della
212
Cass., Sez. I, 8 maggio 1989, Rotolo, in CED, Cass. n. 181325; Sez., I, 21 ottobre 1988,
Chirico, ivi, n. 179854; Sez., I, 10 marzo1986, Salerno, ivi, n. 172390.
213
Cass. Sez. Un., 28.6.2005, Donati, in Giur.. e dir., 2005, n.40, 66.
98
giurisprudenza, i conflitti atipici sono caratterizzati da situazioni in cui «il
contrasto tra i giudici sulla competenza ad adottare provvedimenti necessari allo
sviluppo del rapporto processuale, dà luogo a una situazione di stasi o di paralisi
dell’attività processuale che non ricorre nella fattispecie in esame, in cui al
contrario, ciascuno dei processi risulta pienamente idoneo a svilupparsi
autonomamente fino alla formazione del giudicato»214. Si è, allora, ritenuto che
tale lacuna normativa andasse risolta in via analogica, attraverso l’applicazione
delle «norme che regolano casi simili o materie analoghe ovvero il ricorso ai
principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato »215. Ma, se si esclude
che nel processo penale possa trovare applicazione il meccanismo sancito dall’art.
39 c.p.c., in materia di litispendenza civile, in quanto- « la prevalenza del criterio
della prevenzione rispetto a quello della competenza accolto in detta norma non
risulta compatibile con l’assoluta pregiudizialità della competenza del giudice in
materia penale, in piena sintonia con il principio costituzionale del giudice
naturale »216, non rimane, allora, che fare ricorso al principio generale sancito
dall’art. 649 c.p.p.217 L’art. 649- si è detto: «costituisce un singolo, specifico,
punto di emersione del principio del ne bis in idem, che permea l’intero
ordinamento dando linfa a un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e
delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità
e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto, va riconosciuto il ruolo di
principio generale dell’ordinamento dal quale, a norma dell’art. 12 disp. prel. cod.
civ., dal quale il giudice non può prescindere, quale necessario referente
dell’interpretazione logico-sistematica».
È comune in dottrina, l’opinione che l’istituto della preclusione, attinente
all’ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di
manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un
impedimento all’esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza
dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o dal
precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero dal pregresso esercizio
214
Cass, sez, un., 28.6.2005, Donati, in Giur. e dir., 2005, n.40, 70
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato, cit., p.105-106.
216
Cass, sez, un., 28.6.2005, Donati, in Giur. e Dir., 2005, n.40, 70
217
Lucarelli, U., L’istituto del giudicato, cit., p.105-106.
215
99
dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente
considerata quale conseguenza della consumazione del potere. «Insuperabili
esigenze di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che lo stesso ufficio
del Pubblico Ministero che ha esercitato l’azione penale in relazione a una
determinata imputazione non può successivamente promuovere un nuovo
processo contro la stessa persona e sul medesimo fatto, per la semplice ragione
che, restando immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, è
definitivamente consunto il potere di azione di cui quell’ufficio è titolare». E,
l’eventuale situazione patologica, cui darebbe luogo l’illegittima reiterazione
dell’azione penale, potrà essere rimossa attraverso l’adozione di una sentenza di
non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.p. o di non luogo a procedere ai
sensi dell’art. 425 c.p.p. Qualora poi, l’azione penale non fosse stata ancora
esercitata, dovrà essere emesso decreto di archiviazione, apparendo illogico che il
Pubblico Ministero sia tenuto a promuovere un processo destinato a concludersi
con una sentenza di improcedibilità dell’azione penale »218.
3. L’identità del fatto.
3.1. La nozione di “fatto” ex art. 649 c.p.p.
L’art. 649 c.p.p. pone un duplice limite all’operare dell’istituto del ne bis in idem,
e più precisamente, esso pone un limite soggettivo, consistente nella identità tra la
persona condannata o prosciolta con sentenza irrevocabile e la persona nei cui
confronti viene instaurato il nuovo processo penale; e un limite oggettivo, per il
quale, il ne bis in idem opera se il nuovo procedimento ha per oggetto “il
medesimo fatto” in relazione al quale era stata emanata la pronuncia irrevocabile
sia pure diversamente considerato “per il titolo, grado e circostanze”.
Il punto delicato, ora, sta proprio nel determinare la nozione di “medesimo fatto”.
Ma prima ancora, è necessario interrogarsi sul significato da attribuire al concetto
di “fatto”, di cui all’art. 649 c.p.p., su cui, peraltro, molto si è discusso in dottrina
e giurisprudenza.
218
Cass. Sez. Un., 28.6.2005, Donati, cit., 73.
100
Sembra certo, come è stato giustamente osservato, che « il fatto nel processo
penale, rivesta particolari caratteristiche che lo differenziano e lo individuano
rispetto al concetto indicato con lo stesso nome nel diritto sostanziale penale. In
sede processuale, viene infatti in considerazione come un fatto “in concreto”che si
distingue dalla massa dei fatti penalmente rilevanti»219. Occorre a questo punto,
chiederci: qual è il fatto di cui si discute nel processo, e soprattutto, è possibile
ritenere che l’oggetto del giudicato costituisca anche l’oggetto del processo? E,
ancora, entrambi debbano individuarsi nel “fatto “ di cui all’art. 649 c.p.p?
Quest’ultima è assai discutibile giacché presuppone, come è stato giustamente
osservato, «in primo luogo che l’oggetto del processo sia costituito dal fatto di
reato e, in secondo luogo, che l’oggetto del giudicato coincida con l’oggetto del
processo»220.
Per quanto riguarda il primo punto, è stato esaurientemente dimostrato che
l’oggetto del processo è l’accertamento di un effetto giuridico e non di una
fattispecie. Si dice, infatti,- «lo scopo del processo, non è quello di stabilire se vi
sia stato o meno un reato, ma quello di verificare se un determinato individuo
debba o no essere punito»221. Ma si aggiunge anche, che il giudicato penale, non
sembrerebbe neppure ricollegabile all’accertamento del dovere di punire, come
era stato da qualcuno ritenuto, «ove si ritenga che passino in giudicato, pure le
sentenze meramente processuali, dato che l’accertamento ivi contenuto riguarda
l’esistenza non del dovere di punire, ma di condizioni di procedibilità»222.
Premesso ciò, ci riponiamo la questione: qual è il “fatto” di cui si discute nel
processo? È proprio il fatto, così come si è verificato, effettivamente nel mondo
reale?
A tal riguardo, qualcuno ha osservato che «se anche il fatto storico si è svolto in
modo diverso, non perciò il fatto preso in esame dal processo muta
necessariamente. Ciò, in altre parole, vuol dire che, l’identità del fatto processuale
rimane intatta, anche se si scopre che in realtà il fatto storico si è svolto in maniera
219
De Luca, G., Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale, in Riv.
proc. pen., 1960, p. 191.
220
Lozzi, G., Profili di una indagine sui rapporti tra ne bis in idem e concorso formale di reati,
Milano, Giuffrè, 1974, p. 1- 5
221
Lozzi, G., Profili cit., 1974, p. 1-5.
222
Lozzi, G., loc. ult. cit., p. 7.
101
diversa; tanto per fare un esempio,essa non cambia, anche se si constata che la
somma derubata era costituita da un foglio di mille lire, piuttosto che da dieci
fogli di mille lire, o da quindici sterline d’oro; che apparteneva a Tizio piuttosto
che a Caio; che fu sottratta in una sola volta o in più riprese e, qualche volta
perfino in tempi e in luoghi diversi»223. E ciò perché, l’« l’unità o la pluralità dei
fatti, non si può stabilire con criteri matematici, ma richiede una valutazione
normativa: così il fatto cessa di essere il medesimo allorquando il quadro intero
della situazione si è totalmente trasformato tale da formare oggetto di un nuovo
processo su esso modellato. Ne consegue, pertanto, che il fatto va valutato nella su
totalità»224. Appare, poi, evidente che agli effetti della preclusione di un nuovo
processo penale, l’oggetto del giudicato è determinato in modo assai più ampio
rispetto all’oggetto del processo. Il legislatore, infatti, in ossequio al principio del
favor rei, ha fissato dei criteri convenzionali per l’interprete che è chiamato a
compiere l’operazione di confronto tra il fatto, per il quale l’imputato è stato
condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile, e quello oggetto del secondo
giudizio che si intende instaurare, al fine di stabilirne la diversità o la identità. Ma,
essendo,
il criterio o parametro sul quale si misura l’identità, del tutto
convenzionale, può, dunque, accadere che fatti ontologicamente diversi possono
considerarsi come se fossero identici. E, ciò risulta chiaramente proprio leggendo
il disposto di cui all’art. 649 c.p.p., in cui si afferma il principio secondo il quale
anche quando il fatto sia diversamente considerato per il titolo, grado e
circostanze, divengono irrilevanti, rispettivamente, «il processo psicologico (dolo,
colpa, preterintenzione), che accompagna l’accadere materiale, il verificarsi o
meno dell’evento (rapporto tra delitto tentato e delitto consumato), nonché gli
elementi esteriori che accompagnano il realizzarsi della condotta (il termine
circostanze sembra usato in senso tale da comprendere non solo le aggravanti e le
attenuanti, ma anche ogni altra modifica dell’accadimento, la quale determini un
mutamento della norma sostanziale applicabile)»225.
223
Lozzi, G., loc. ult. cit., p. 8-9.
Guarnieri, In tema di inammissibilità di un nuovo giudizio per il medesimo fatto, in Giust .pen.
1948, parte terza, Tribunale penale di Ravenna, 6 dicembre 1946, vol. LIII, Milano, 1948.
225
Pagliaro, Fatto (dir. proc.pen.), in Enc. Dir., vol. 1064, Milano, 1991, p. 964- 966.
224
102
Un punto che è sicuramente fuori discussione è che, ai fini dell’operare del ne bis
in idem il fatto oggetto del nuovo procedimento deve essere proprio il fatto in
precedenza giudicato e non un fatto a quello identico. La stessa Cassazione, in più
occasioni, ha avuto modo di affermare che « la inammissibilità di un nuovo
giudizio, sancita dall’art. 90 c.p.p. (ora art. 649 c.p.p), presuppone una completa
identità cronologica esistente fra gli elementi del fatto giudicato e quelli del fatto
attribuito nel nuovo procedimento alla stessa persona, perché il giudicato si forma
in relazione all’episodio cui si riferisce la pronuncia e non a quelli successivi »226.
Detto questo però, rimane ancora aperto il problema di attribuire un significato
alla nozione di “fatto”, ai sensi dell’art. 649 c.p.p. A tal riguardo, si possono
ritenere ancora valide le varie soluzioni già formatesi in merito all’art. 90
dell’abrogato codice di procedura penale.
Il primo punto da chiarire è, anzitutto, se debba guardarsi al “fatto” nella sua
configurazione storica, naturalistica, o nella sua valutazione giuridica. In altri
termini, si tratta di stabilire se il fatto sia un determinato comportamento visto
nella sua individualità statica, prescindendo, quindi, dalla valutazione giuridica
del comportamento stesso, oppure se si risolva proprio in una tale valutazione,
ossia nel concetto di fattispecie legale227. Sul punto, dottrina e giurisprudenza, e la
stessa dottrina al suo interno, hanno da sempre avuto opinioni alquanto divergenti.
Da un lato parte della dottrina propendeva per l’individuazione del fatto in una
accezione meramente naturalistica, quale espressione di vita in cui s’è tradotta in
essere l’azione delittuosa del soggetto»228. Questa tesi è stata, tuttavia, criticata e,
per certi versi, considerata addirittura inaccettabile. Si diceva- infatti- « non si
può prescindere da una valutazione normativa al fine di stabilire quali elementi,
nel complesso di quelli che integrano una determinata situazione storica, debbano
essere presi in considerazione dal giudice come giuridicamente rilevanti»229. E,
poi, se si applicasse la tesi in questione, si giungerebbe all’assurda conclusione
per cui se il fatto giudicato e quello esaminato nel successivo procedimento
dovessero divergere, la “medesimezza” che preclude l’esercizio dell’azione penale
226
Cass, pen., in Mass. Uff., 1966, 94; e, Cass. Sez. Un., 13.2.1965, in Giust. pen., 1965, III, 353.
Lozzi, G., Profili di una indagine tra ne bis in idem e concorso formale di reati, p. 39-55.
228
Bettiol, G., Istituzioni di idirtto e procedura penale, Padova, CEDAM, 1995.
229
Lozzi, G., cit, p. 39- 55.
227
103
verrebbe sempre meno, anche se la divergenza non presenti alcuna rilevanza
giuridica230. Del resto, qualcun altro ha osservato che «il fatto considerato nella
sentenza irrevocabile può anche, non coincidere con il fatto naturalisticamente
inteso (è questo, il caso della sentenza ingiusta che non riproduce esattamente il
dato storico) e, ciononostante, il termine di raffronto, al fine di stabilire la
sussistenza o meno del ne bis in idem, sarà sempre il fatto ritenuto in sentenza»231.
Sempre a riguardo della tesi suddetta, si è, altresì, osservato che “il fatto”, pur
nella sua accezione meramente naturalistica, si presenta comunque, come una
entità composta di due elementi: condotta ed evento. È da chiedersi, allora, se la
nozione di “fatto” adottata dal legislatore sia comprensiva di ambedue questi
elementi oppure no.
Alcuni Autori sostenevano che l’identità del fatto, ai fini dell’applicabilità della
regola del ne bis in idem, andasse valutata con riferimento esclusivo alla condotta
sulla quale avesse giudicato la sentenza irrevocabile, con esclusione di ogni altro
elemento della fattispecie legale232. A questa conclusione, peraltro, si giungeva
argomentando dalla stessa formulazione della regola dell’art. 90 c.p.p.,( oggi art.
649 c.p.p.) il quale, nel momento in cui stabilisce la improcedibilità per il
medesimo fatto, «ancorché diversamente considerato per il titolo, grado e
circostanze », dimostra palesemente di considerare irrilevanti sia la qualificazione
giuridica del fatto in genere (titolo), sia l’evento in ispecie (grado e
circostanze)233. Ma l’obiezione che emergeva sul punto è la seguente: se partiamo
dalla considerazione che i concetti di “fatto”, “condotta” ed “evento” altro non
sono che il prodotto di una astrazione, o meglio- come qualcuno diceva- «frutto
della arbitraria scomposizione della realtà», allora è chiaro che ancorare il
concetto di “fatto” alla sola condotta, porta con sé il rischio che, «ad un certo
momento, astraendo più del dovuto, le conclusioni finiscano col cadere
nell’assurdo»234. Per fare un esempio, si diceva: «se la condotta si esaurisce nel
230
Mantovani, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, 1966, p. 395.
De Luca, G., Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale, in Riv.
proc. pen., 1960, p. 195.
232
Bellavista- Tranchina, Lezioni di diritto processuale penale, 10ª ed., Milano, Giuffrè, 1987, p.
710; Pagliaro, Fatto (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., vol. 1064, Milano, p. 964- 966; Leone, G.,
Manuale di diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1988, p. 737- 747.
233
Bellavista- Tranchina, Lezioni di diritto processuale penale, cit., p. 708- 715.
234
Cordero, F. Procedura penale, 2006, Milano, Giuffrè, p. 1219 ss.
231
104
gesto di qualcuno che getta qualcosa dalla finestra, tale da integrare la fattispecie
di cui all’art 674 (getto pericoloso di cose), in base alla premessa che “fatto” ex
art. 90 equivale a condotta, si dovrebbe concludere che una eventuale pronunzia
su quella, precluda un successivo processo per omicidio quando il getto di cose sia
consistito nel lasciar cadere un corpo contundente sul capo di una persona, dopo
aver preso accuratamente la mira e tutto ciò sembra aberrante». Ma allora, per
evitare che il riferimento del “fatto” alla mera condotta, conduca a situazioni
paradossali, si è detto che la nozione di “condotta”, quale punto di individuazione
del “fatto”, vada definita in relazione al suo oggetto materiale («perché e in
quanto, non è concepibile una azione transitiva indipendentemente dall’oggetto
sul quale essa va a cadere»). Si può, allora, facilmente comprendere perché una
sentenza irrevocabile che, ad esempio, abbia pronunciato su una imputazione di
omicidio doloso, impedisca l’instaurazione di un nuovo processo, per omicidio
colposo ai danni della stessa persona: in questo caso, evidentemente, il mutamento
dell’elemento psicologico, non comporta una modificazione nella identità del fatto
inteso come condotta, data l’identità dell’oggetto materiale di essa. E, ancora, si
può
capire
agevolmente
come
una
sentenza
che
abbia
pronunciato
irrevocabilmente su un’imputazione di reato tentato non consenta di procedere ex
novo per una imputazione di reato consumato o, infine, che intervenuta una
sentenza irrevocabile, su un reato di lesioni, non si possa, una volta che il ferito
sia deceduto, in conseguenza alle lesioni, procedere per un reato di omicidio.
Premesso tutto questo, si è, tuttavia, osservato come anche una concezione
meramente normativa del “fatto”, se intesa con riferimento alla nozione di
fattispecie legale, sia da considerarsi inaccettabile, in quanto, chiaramente
smentita, anch’essa, dall’art.90 c.p.p. 1930.
La questione è che «non si può prendere in considerazione soltanto la situazione
storica o soltanto lo schema legale, ma bisogna seguire una via intermedia che
tenga conto di entrambi». «La distinzione tra situazione di fatto, costituita da
accadimenti o modo di essere della realtà empirica e, situazione di diritto come
previsione legislativa, è frutto di una astrazione, giacché la situazione concreta,
essendo unica, è nel contempo, situazione di fatto, qualificata dal diritto e,
105
situazione di diritto, realizzatasi nel fatto»235 Nello stesso tempo, si è aggiunto che
«nessuna identificazione del “fatto” su cui si è pronunciato o su cui deve
pronunciarsi il giudice è possibile se non si astraggono, attraverso il riferimento
ad un modello legislativo, dal complesso della situazione storica, gli elementi e i
requisiti che appaiono rilevanti. Bisogna, allora, enucleare « il fatto, che è un
segmento della storia, della realtà (…),foggiando dal fatto medesimo una
rappresentazione il cui contenuto è ricalcato sullo stampo offerto dallo schema
legale al cui modello occorre riferirsi»236.
Partendo da queste considerazioni, un’altra parte della dottrina, ha sostenuto
fermamente che il termine “fatto” rilevante ai fini dell’operare del ne bis in idem,
non andasse interpretato in senso meramente naturalistico o normativo, bensì
ricercando una soluzione che si ponesse a metà strada fra fatto storico e schema
legale. Si è parlato, a tal proposito, di fattispecie giudiziale, che altro non è che il
risultato del processo di astrazione compiuto dal giudice nel corso del giudizio
svolto al fine di verificare la corrispondenza del fatto alla norma incriminatrice237.
Si diceva- «nel rapportarsi allo schema legislativo, il giudice elimina, sì, tutti gli
elementi della situazione storica che non rientrano nel modello legale, ma vi
ricomprende una descrizione più particolareggiata del fatto».
Pertanto, il “fatto” di cui all’art. 90, non coincide né con la fattispecie legale, né
col fatto storico, ma con la c.d. fattispecie giudiziale, vale e dire con la
rappresentazione del fatto storico compiuta dal giudice238.
Al contrario, la giurisprudenza, che da parte sua, assegnava al concetto di “fatto”,
un significato più coerente con tutto il sistema penale nel suo complesso,
ritenendo che esso coincidesse con ciò che, nell’ambito della teoria generale del
reato, viene definito “elemento materiale” del reato, costituito cioè, da condotta,
evento e nesso di causalità. Secondo questa impostazione, ne derivava che il fatto
poteva considerarsi il medesimo, soltanto qualora, vi fosse stata «perfetta identità
materiale, riferita a tutti e tre gli elementi
235
costitutivi della fattispecie, e
Foschini, La regiudicanda, in Annali della Università di Macerata, 1956, p. 35.
De Luca, G., Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale, in Riv. it.
dir. e proc. pen, 1960, p. 194.
237
De Luca, Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale, cit., p. 202;
Bellora, Ne bis in idem e reato progressivo, ivi, 1990, p. 1644.
238
Lozzi, G., Profili cit., p. 39- 55.
236
106
contemplasse identità di condizioni di tempo, luogo e persona»239. Risulta
necessario riprendere, a questo punto, riprendere seppur brevemente, la teoria
generale del reato, per comprendere meglio i significati di “condotta”, “evento” e
“nesso di causalità”.
3.2. Condotta, evento e nesso di causalità secondo la teoria
generale del reato.
Rispetto al primo elemento, si può iniziare col dire che la condotta ( o azione in
senso lato ), almeno da un punto di vista generale, indica « ogni contegno o
comportamento dell’uomo che abbia il suo principio nel soggetto». Secondo
questa nozione, è facile comprendere, come anche gli atti che si svolgono
nell’ambito della coscienza, siano essi pensieri, desideri, propositi o violazioni
costituirebbero “condotta”»240. Ma evidentemente, al diritto penale, tali atti non
interessano. Il reato è sempre un avvenimento che si realizza nel mondo esteriore,
e dal momento che l’atto meramente interno o psichico non si traduce in un
comportamento esterno, esso non è mai punibile. “Condotta”, dunque, per il
diritto penale, non è qualsiasi comportamento ma, solo quello che si manifesta
esteriormente. La condotta poi, può assumere due forme: una positiva e l’altra
negativa, ossia, può consistere in un fare o in un non fare. Nel primo caso si parla
di azione, nel secondo di omissione. Ora, l’azione, consiste in un movimento del
corpo del soggetto percepibile dall’esterno. Chiaramente, occorre sottolineare che
l’azione, molte volte, si presenta nella forma di un procedimento complesso,
ossia, come una serie o molteplicità di movimenti del corpo, che chiamiamo
“atti”. Ne consegue che l’insieme degli atti, costituisce l’azione241.
239
Cass. Sez. I, 13.10.1992, Malorgio, in CED, Cass., n. 195092; Cass. Sez., V, 3.12.1992,
Bellicoso, ivi, Cass., n. 194324; Cass. Sez. I, 10.6.1986, Porgi; nello stesso senso, in dottrina, vedi
Guarnieri, Regiudicanda, (dir. proc. pen.), in Noviss. Dig. It., vol. XV, Torino, 1968, p. 230.
240
Antolisei, F., Manuale di diritto penale, parte generale, 16ª ed., Giuffrè editore, 2003, p. 220.
241
Ma perché si abbia unità di azione, sono necessarie due condizioni. Innanzitutto occorre che
essi siano guidati da un unico scopo. Per fare un esempio, pensiamo a colui che colpisce più volte
una persona con un pugnale al fine di ucciderla, non fa tante azioni quante sono le ferite inferte,
ma compie un’unica azione. Questo, tuttavia, non basta. Occorre, inoltre, che esse si svolgano in
un unico contento. Pensiamo a colui che in diverse occasioni diffonde notizie calunniose per
screditare una persona. Ebbene, in questo caso, perché si abbia unità di azione è necessario
qualcosa in più; oltre alla unicità dello scopo è richiesta anche la contestualità; perché è pacifico
che se tra gli uni e gli altri atti, dovesse trascorrere un rilevante lasso di tempo, non si avrebbe più
unità di azione, ma al contrario, avremmo una molteplicità di azioni.
107
Per quanto concerne, invece, l’omissione, è opportuno ricordare almeno due teorie
che sono state formulate sul punto. La prima è la c.d. teoria dell’aliud agere,
secondo la quale il momento centrale dell’omissione sta in una azione positiva,
che il soggetto compie, mentre si astiene dal fare quella che da lui ci si
attendeva242.
L’altra teoria è quella che tutt’al contrario, afferma che la vera essenza della
omissione, sta proprio nel non aver agito in un determinato modo: nel non aver
compiuto una determinata azione. L’omissione, in altri termini, altro non è che il
mancato compimento dell’azione che ci si attendeva da un determinato
soggetto243.
Per quanto concerne l’evento, anche per esso, risulta necessario menzionare
almeno due teorie interpretative. La prima è quella che è stata definita concezione
cd naturalistica. Essa afferma che evento è sinonimo di effetto, risultato. L’evento
richiama, uno stato di fatto, una situazione in rapporto al principio di causalità.
Evento non è perciò, propriamente ogni fatto, ma quell’avvenimento che si
presenta congiunto ad un altro fatto mediante un nesso causale; e siccome nel
campo del diritto, viene in considerazione la condotta dell’uomo, per evento si
intende il risultato della condotta medesima. L’evento, in senso tecnico, è solo
l’effetto della condotta che il diritto prende in considerazione, in quanto connette
al suo verificarsi conseguenze di carattere penale244.
L’altra concezione, è quella che è stata definita giuridica. Secondo quest’ultima,
l’evento consiste nell’offesa (lesione o esposizione a pericolo) dell’interesse
protetto dal diritto245.
242
L’omissione, dunque, secondo questa teoria, non consiste in un quid vacui, in un nulla, e ciò,
proprio perché l’omittente non rimane inerte, ma fa qualcos’altro; in altre parole, è vero che egli
non compie l’azione che da lui ci si aspettava, ma ne compie un’altra.
243
Chiaramente, poi, come è stato giustamente osservato, al diritto penale, non interessano tutte le
omissioni, ma solo quelle che consistono nel non compimento di azioni prescritte dall’ordine
giuridico; e poi, c’è sempre da aggiungere che l’omissione in tanto è addebitabile, in quanto colui
che avrebbe dovuto attivarsi, aveva la concreta possibilità di agire, valutate tutte le circostanze del
caso. Antolisei, F., Manuale cit., p. 220 ss.
244
Tale effetto può essere fisico ( la distruzione di un oggetto), fisiologico ( la morte di un uomo)
o psicologico ( la percezione di una espressione calunniosa o diffamatoria). S i tratta pur sempre di
un effetto naturale della condotta umana, effetto che per tale qualità si distingue nettamente dalla
condotta medesima e cioè, dal movimento corporeo della condotta.
245
La differenza tra le due concezioni è profonda, perché « l’evento, inteso come modificazione
del mondo esteriore rilevante per il diritto penale, è un’entità che si aggiunge alla condotta
dell’uomo: è un’entità naturale, distinta e diversa dal comportamento del soggetto, mentre l’offesa
108
L’ultimo punto da analizzare è il nesso di causalità. Ebbene, perché una
modificazione del mondo esteriore (evento) possa essere attribuita all’uomo, è
necessario che si sia verificata in conseguenza alla sua azione: occorre, in altre
parole, che tra l’una e l’altra esista un nesso di causalità. Ciò, in linea generale è
espresso nell’art. 40 del nostro codice penale. In merito ad essa sono state
formulate varie teorie, tra le principali, possiamo tuttavia ricordare, quella della
condicio sine qua non; e la cd teoria della causalità adeguata.
Secondo la prima, perché si abbia rapporto di causalità è sufficiente che l’uomo
abbia realizzato una condizione qualsiasi dell’evento: basta, in altri termini, che
abbia posto in essere un antecedente indispensabile per il verificarsi del risultato.
Questa teoria può sintetizzarsi con la formula: “la condotta è causa dell’evento, se
senza di essa, l’evento non si sarebbe verificato”; e in senso negativo, “la condotta
non è causa dell’evento, se senza di essa, l’evento si sarebbe verificato
ugualmente”.
Secondo la teoria della causalità adeguata, invece, affinché per il diritto esista un
rapporto di causalità occorre che l’uomo abbia determinato l’evento con un’azione
proporzionata, adeguata. Ciò pone però un problema. Si tratta di capire quando
una azione può considerarsi adeguata. È adeguata l’azione che è in generale
idonea a determinare l’effetto; in altri termini, l’azione che si presenta atta a
determinarlo sulla base dell’id quod plerumque accidit246.
Sul punto, l’Antolisei247, ha fatto una precisazione. Egli sostiene che « per
giungere a una causalità che risponda alle esigenze del diritto, bisogna
innanzitutto partire dalla considerazione che la causalità a cui partecipa l’uomo e
cioè la causalità umana, presenta delle caratteristiche speciali. «Esiste- aggiungeun campo più o meno largo in cui l’uomo, può dominare con i suoi poteri
conoscitivi e volitivi, dunque, solo i risultati che rientrano in questa sfera possono
considerarsi come causati dall’uomo, perché, se anche non gli ha voluti, era in
del bene protetto è lo stesso fatto umano considerato dal punto di vista della tutela giuridica. E,
anche le conseguenze delle due concezioni, sono diverse, perché mentre per quella naturalistica
l’evento può mancare nel reato, la concezione giuridica, al contrario, lo considera come dato
essenziale». Antolisei, F., Manuale cit., p. 220 ss.
246
Chiaramente, l’idoneità dovrà stabilirsi in astratto ex ante, alla stregua dell’esperienza di casi
simili (tale idoneità, non è altro che la probabilità). La conseguenza di questa teoria è che però non
si considerano causati dall’uomo, gli effetti che al momento dell’azione, si presentavano
improbabili, vale a dire, gli effetti straordinari o atipici dell’azione medesima.
247
Antolisei, F., Manuale cit., p. 220 ss.
109
grado di impedirli. Essendo dominabili dall’uomo, tali risultati vanno, pertanto,
imputati a lui. Per contro, gli altri effetti, quelli che si svolgono al di fuori del
raggio di azione dell’uomo e che per tale motivo non possono essere»248.
3.3. Medesimo fatto.
Dopo questa lunga premessa intesa a capire quale significato attribuire alla
nozione di “fatto” utilizzata dal nostro legislatore nell’art. 649 c.p.p., possiamo
tornare al nostro oggetto di indagine: il “medesimo fatto”. Anche per
quest’ultimo, risultano ancora valide le interpretazioni già formatesi sotto la
vigenza del vecchio codice di procedura penale, in relazione all’art. 90. In
particolare, possiamo notare come già nella Relazione al progetto preliminare del
c.p.p. del 1988249, veniva confermata la soluzione della inesperibilità dell’azione
penale anche per quei casi in cui «il fatto oggetto della sentenza divenuta
irrevocabile non fosse stato più il medesimo per essere sopravvenuto un evento
prima non verificatosi, che lo avesse reso più grave (es. passaggio da un tentativo
di omicidio alla consumazione, o da un delitto di pericolo a un delitto di danno)».
Concludeva su questo punto il Relatore: «ho creduto opportuno conservare il
divieto di un nuovo procedimento anche se il fatto- base oggetto del giudizio
possa essere diversamente definito per il titolo, grado e circostanze, a cagione di
elementi già esistenti, ma ignorati nel momento del giudizio stesso o sopravvenuti
dopo che la sentenza divenne irrevocabile».
È evidente, dunque, che quell’operazione di confronto che il giudice deve fare, tra
il fatto in precedenza già giudicato e quello oggetto del nuovo procedimento che
si intende instaurare, non avviene secondo i criteri della logica, ma sulla base di
criteri del tutto convenzionali che l’ordinamento predispone. Come è stato meglio,
da qualcuno osservato, «ai sensi dell’art. 90 (oggi art. 649 c.p.p.), l’elemento
identificatore, dell’oggetto del processo, non è la fattispecie sostanziale che è stata
accertata con la sentenza diventata irrevocabile, ma il fatto storico, per mezzo del
quale è possibile ricostruire la fattispecie e conseguentemente determinare
248
Da quanto appena detto, emerge che, per l’esistenza del rapporto di causalità, occorrono due
elementi: uno positivo e l’altro negativo. « Quello positivo, consiste nel fatto che l’uomo con la
sua azione debba aver posto in essere una condizione dell’evento, e cioè un antecedente senza il
quale l’evento non si sarebbe verificato. Quello negativo, consiste, invece, nel fatto che il risultato
non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali».
249
Relazione al progetto preliminare al c.p.p. 1988, p.23.
110
l’oggetto del processo. Il ne bis in idem, tende appunto ad evitare che si torni
nuovamente a decidere non tanto sullo stesso fatto, ma sullo stesso oggetto del
processo, che si è chiuso con sentenza definitiva e irrevocabile»250.
Certo- si aggiunge251- «il legislatore, avrebbe potuto scegliere come elemento
identificatore la fattispecie sostanziale stessa, nella totalità degli elementi che
concorrono a integrarla, così come risulta dalla sentenza che l’ha accertata. In tal
caso, l’identificazione sarebbe stata estremamente facile: sarebbe stato, cioè,
sufficiente l’individuazione del nomen iuris, che contrassegna ogni singolo reato».
Ma, in realtà, risulta chiaramente dalla formulazione dell’art. 649 c.p.p. (ex. art.
90), che il legislatore, considera del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione dl
principio del ne bis in idem, il mutamento del titolo del reato: ciò porta ad
escludere l’utilizzo del criterio del nomen iuris, come elemento identificatore.
Escluso questo criterio, «non restava al legislatore altra scelta che far coincidere l’
elemento identificatore della fattispecie sostanziale, con il fatto che della
fattispecie è elemento costitutivo e parte integrante». Si notava che «se il fatto si
fa consistere in una determinata situazione reale, considerata nella sua essenza
fenomenica, del tutto avulsa dalla sua qualificazione giuridica, bisogna ammettere
che in nessun caso, sarebbe possibile effettuare quella operazione di confronto in
cui consiste la identificazione: e ciò per la semplice ragione che il dato storico
così concepito nella varietà e nella complessità della sua trama e nel confuso
amalgama degli elementi e delle modalità attraverso cui si manifesta è
irriproducibile». Si è osservato, a questo proposito, che la differenza tra
Tatbestand legale e Tatbestand concreto, è la stessa differenza che intercorre tra
il modello e la copia, tra lo schema e l’esempio. Ciò significa che, assumendo il
fatto, nel suo significato di Tatbestand concreto (ad es. il fatto dell’omicidio), non
possono certo ricomprendersi in questa nozione tutti gli elementi che concorrono
ad integrarlo, ma soltanto quelli che servono a caratterizzarlo (ad es., come
omicidio). Si utilizza, in questa prospettiva, il criterio della cd fattispecie
giudiziale, da cui ne deriva che l’operazione di confronto che si svolge tra due
fatti giuridici, individuabili attraverso il loro riferimento ad uno schema, altro non
250
251
De Luca, G., Giudicato II (dir. proc.pen.) in Enc. Giur., Treccani, vol. XV, Roma, p. 5- 11.
De Luca, G., Giudicato II, cit.
111
è che è una copia del modello contenuto nella fattispecie legale252. Ma quali sono
gli elementi della fattispecie giudiziale che devono rimanere immutati affinché
possano considerarsi identiche le due fattispecie giudiziali e quali invece, gli
elementi la cui variazione non elimina il rapporto di identità?253 Si è detto: «il
passaggio da una fattispecie giudiziale ad un’altra comporta sempre diversità in
ordine agli elementi della fattispecie stessa [a differenza di quanto avviene se
muta semplicemente il nomen iuris e rimangono invariati gli elementi del fatto
storico preso in considerazione] non dovendosi confondere la fattispecie legale
con il nomen iuris che serve semplicemente a contrassegnarla254. Se, infatti, per
un mero errore di denominazione, è stato definito appropriazione indebita il
comportamento di chi, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, il mutamento del nomen iuris non implica
diversità della fattispecie giudiziale; ove, invece, si ritenga riferibile ad un
comportamento concreto prima lo schema legale dell’appropriazione indebita e
poi lo schema della truffa, ciò implica variazione degli elementi costitutivi della
fattispecie giacché, ad esempio, l’attività in cui si è concretato l’artifizio o raggiro
e ricompresa nella fattispecie giudiziale della truffa, non è considerata nella
fattispecie giudiziale della appropriazione indebita.
Ma, nonostante il cambiamento della fattispecie giudiziale determini «un
mutamento dei suoi elementi costitutivi e quindi del fatto giuridico che ne sta alla
base»255, non sempre, tuttavia, rileva tale mutamento ex art. 90, per il quale,
appunto, l’identità delle fattispecie giudiziale sussiste se la
diversità
obbiettivamente ravvisabile tra di esse concerna il titolo, il grado, le circostanze.
Resta ferma, invece, come si è già accennato, la posizione della giurisprudenza sul
punto, secondo la quale, locuzione “medesimo fatto”, va intesa come coincidenza
di tutte le componenti della fattispecie concreta, onde tale espressione fa
riferimento alla «identità storico-naturalistico del reato, i tutti i suoi elementi
costitutivi identificati nella condotta, nell’evento e nel rapporto di causalità, in
riferimento alle stesso condizioni di tempo, luogo e di persona»256.
252
De Luca, G., Giudicato cit.
Lozzi, G., Profili di una indagine tra ne bis in idem e concorso formale di reati, cit., p.. 39- 55.
254
De Luca, Concorso cit., p. 195.
255
De Luca, loc. cit..
256
Cass. Sez. Un., 28.6.2005, Massa, Donati, in Mass. Uff., 231799.
253
112
Interpretazione, questa, che come si è già osservato, contrasta palesemente con il
tenore letterale dell’art. 649 c.p.p. che consente di valutare il fatto considerandolo
essenzialmente per la condotta, dato che l’identità sussiste anche nell’ipotesi in
cui il fatto venga “considerato diversamente…per il grado”; poiché un
“grado”diverso si risolve oggettivamente in un diverso evento (delitto tentato e
consumato). Se ne deduce, allora, l’irrilevanza del verificarsi o meno dell’evento
al fine di affermare o escludere l’identità del “fatto”.
3.4. Titolo, grado e circostanze.
S i è visto, dunque, che il legislatore, ai fini della operatività del ne bis in idem,
considera irrilevanti sia il mutamento del titolo, sia del grado che delle
circostanze. Ebbene, bisogna riconoscere che se non crea particolari problemi
l’interpretazione da darsi al richiamo che l’art. 649 c.p.p.
fa al “titolo” in
relazione ad un medesimo fatto (es. concussione-corruzione; tentata violenza
carnale- atti di libidine violenta; ipotesi di reato doloso -ipotesi di reato colposo)
ed
alle
circostanze,
aggravanti
o
attenuanti,
meno
semplice
appare
l’interpretazione che deve darsi alla locuzione “grado”. Iniziamo proprio ad
analizzare quest’ultimo. Se facciamo un breve excursus circa l’evoluzione che il
principio del ne bis in idem ha conosciuto all’interno delle varie legislazioni
processualistiche del nostro Stato, possiamo notare come già nel codice del 1865,
in particolare nell’art. 518, si prevedeva che: «l’accusato assolto, o riguardo al
quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere
sottoposto a processo, né accusato, pel medesimo fatto». Qui, evidentemente non
si faceva alcun richiamo ad una diversa valutazione, né per il grado né per altri
elementi.
Nel progetto per il nuovo di rito. del Regno d’Italia, veniva di nuovo riproposta la
stessa formulazione, se non fosse per il fatto che veniva fatta una precisazione. Si
diceva che «un nuovo giudizio per il medesimo fatto era escluso anche se il fatto
fosse stato diversamente definito»257. Si giunse, così, alla formulazione dell’art.
435 c.p.p. 1913, che disponeva così: «L’imputato assolto, anche in contumacia,
con sentenza diventata irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a
procedimento per quel medesimo fatto neppure se esso venga diversamente
257
Vedi art. 499 del Progetto al c.p.p. 1911.
113
considerato per titolo, grado o quantità di reato». A tal proposito, chiariva la
Relazione al progetto preliminare, che «il giudicato irrevocabile può solo formarsi
su una specie di fatto rigorosamente identificata e circoscritta nei suoi termini,
quale che possa essere la definizione giuridica cui abbia a prestarsi sotto il profilo
del titolo, del grado e della quantità di reato». Il riferimento al “grado”, in
particolare, derivava dalla teoria del Carrara, il quale identificava i delitti secondo
la “qualità” (cioè il titolo), la “quantità” e, per l’appunto il “grado”. Secondo la
suddetta teoria258, « la quantità è ciò per cui avviene che un fatto criminoso sia un
delitto, piuttosto che un altro delitto»; in sostanza è «ciò che distingue titolo
criminoso da titolo criminoso». «La quantità»- si diceva- «è ciò che permette di
discernere tra due o più delitti quale è rispetto all’altro più grave, per
proporzionarvi la giusta imputazione (venivano, infatti, menzionate tra gli
elementi che potevano concorrere a determinare la quantità di un reato, le
circostanze aggravanti). Nel concetto di grado, dunque, venivano collocati tutti
quegli elementi per i quali «la qualità astratta rimane sempre la istessa, ma si
modifica la gravità concreta del malefizio per una accidentale deficienza dei suoi
elementi costitutivi…». «Ciò che attiene al grado di un delitto- aggiungeva lo
stesso Carrara- è ciò che lo degrada senza però denaturarlo». Attengono al
“grado”, secondo la suddetta teoria, cause “fisiologiche” attinenti alla imputabilità
del soggetto , quali l’età, il sonno, il sordomutismo, la pazzia, l’ubriachezza,
anche cause “ideologiche” quali l’ignoranza e l’errore e inoltre la coazione,
l’impeto degli affetti, l’ubriachezza, i fenomeni del “tentativo”, del “delitto
mancato” e della “complicità”.
Il Manzini259affermava, invece, che il “grado” riguardasse «la qualificazione
giuridica del reato, e non il fatto in sé, che, pur aumentando il grado, può
assumere un titolo anche essenzialmente diverso, mentre la diversità di titolo
risulta già essere stata presa in considerazione espressamente dal legislatore».
Secondo questa diversa impostazione, pertanto, il grado implica una «diversa
“quantità penale” che può assumere in concreto il medesimo fatto astrattamente
considerato dalla norma, se posto in relazione ad altri elementi che lo
accompagnano»; e, si aggiungeva, «se per “fatto” si intende, il complesso degli
258
259
Carrara, Programma, Parte generale, § 128 ss.
Manzini, V., Trattato di diritto processuale penale, vol. V, Torino, 1956, p. 456.
114
elementi oggettivi essenziali del reato, ne consegue che gli elementi che possono
mutarne la “quantità penale” sono elementi estrinseci a questo. La verificazione di
un evento più grave non “denatura” il reato, ma ne determina una diversa gravità.
Stessa cosa dovrebbe dirsi per le cause di esclusione della punibilità e della
imputabilità, per il concorso di persone nel reato, nonché per le c.d. condizioni di
maggiore punibilità del reato»260.Inoltre- si osservava a riguardo- che non è
certamente previsto nel nostro sistema che, ad esempio, taluno assolto per aver
agito in stato di legittima difesa o per errore sul fatto o, viceversa, condannato
come unico autore del reato, possa venir nuovamente giudicato ove si accerti che
non vi fu legittima difesa o errore sul fatto o che determinò altri a commettere il
reato. «Tutte queste ipotesi -si concludeva- non possono che trovare la loro
previsione nel richiamo dell’art. 90 al “grado”, cioè ad una diversa gravità
concreta del reato derivante da elementi che lasciando inalterato il fatto nei suoi
elementi costitutivi, e quindi il titolo del reato, gli fanno tuttavia assumere un
diverso livello di quantità penale261.
In definitiva, come possiamo, sintetizzare, oggi, il concetto di “grado” di cui
all’art. 649 c.p.p.? Possiamo dire, in breve, che “grado” può essere utilizzato al
fine di individuare tutte quelle situazioni che, senza spostare il titolo del reato,
importano maggiore o minore gravità del reato, dell’imputabilità o della
responsabilità. È il caso del passaggio dal tentativo al quella del reato consumato,
nel qual caso né nuovi elementi di fatto, né nuove prove, né una diversa
valutazione del fatto valgono a distruggere la forza del giudicato262. Altra ipotesi
che può delinearsi in tema di regiudicata riconducibile all’ipotesi di cambiamento
del grado è quella che si verifica in tema di rapporti tra reato di pericolo e reato di
danno; così, se taluno è stato giudicato per un reato di pericolo, non può essere
chiamato successivamente a rispondere per un reato di danno.
Quanto al “titolo”, dovrebbe, invece, intendersi sia il semplice mutamento di
qualificazione giuridica conseguente a una variazione dell’elemento soggettivo
(omicidio anziché doloso, colposo), sia al verificarsi dell’evento (omicidio
260
Antolisei, F., Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1960, p. 284.
Cantagalli, Ne bis in idem e nozione di medesimo fatto, in Giust. pen., III, 1964, p. 152- 158.
262
Leone, G., Manuale di diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1988, p. 737- 747.
261
115
preterintenzionale anziché lesioni colpose). Il passaggio da una fattispecie legale
all’altra non significa, quindi, di per sé stesso, diversità del fatto.
Per ultimo, il concetto di “circostanza” viene data dallo stesso codice penale. Essa
riguarda i cd. accidentalia delicti: «il sopravvenire di eventi che integrerebbero
una circostanza del reato, o di nuove prove che ne dimostrerebbero la sussistenza
non vale ad intaccare la forza del giudicato e a dar luogo a un nuovo
procedimento. Contro colui che ad esempio è stato giudicato per furto semplice,
non può essere promossa nuova azione penale per furto aggravato»263. Pertanto,
anche il passaggio dalla fattispecie semplice a quella circostanziata incontra il
veto del ne bis in idem.
4. L’identità della persona.
L’altro presupposto per l’operare del divieto del ne bis in idem è l’identità della
persona. Come si evince dall’art 649 c.p.p., il vincolo del ne bis in idem opera
esclusivamente nei confronti della persona a cui il giudicato si riferisce, non già
nei confronti di eventuali concorrenti cui la sentenza irrevocabile non abbia fatto
riferimento (es. partecipanti al fatto, successivamente scoperti). Quindi, assolta
una persona dalla imputazione di furto per insufficienza di prove, e, passata in
giudicato la sentenza, il giudicato che riguarda esclusivamente il prosciolto non
impedisce che altre persone successivamente scoperte siano sottoposte a
procedimento penale e condannate come colpevoli di aver concorso nello stesso
fatto. La giurisprudenza, a tal proposito, ha affermato che il giudicato penale che
si è formato nei confronti di un imputato per un determinato fatto, non vincola il
giudice che è chiamato ad accertare quel medesimo fatto nei confronti di altri
imputati. Il divieto del ne bis in idem- si dice- «esplica una funzione di garanzia
per la persona imputata nel nuovo processo e ne postula l’identità con il soggetto
irrevocabilmente condannato o prosciolto. Pertanto, il giudice del procedimento
penale a carico del concorrente può rivalutare il comportamento del soggetto già
263
Leone, G., Manuale, cit., p. 737- 747.
116
giudicato ma solo al fine di accertare la sussistenza e il grado della responsabilità
dell’imputato da giudicare»264.
La dottrina, dall’altra parte, ha puntualizzato che, l’identità va stabilita in
relazione alla qualità assunta nel processo dalla persona, per cui, chi ha rivestito la
qualità di imputato in un determinato processo può certamente essere assoggettato
a un secondo procedimento per il medesimo fatto in veste di responsabile civile o
di civilmente obbligato per la pena pecuniaria265.
L’effetto preclusivo, dunque, è collegato all’essere stata pronunciata nei confronti
di un dato soggetto una sentenza irrevocabile su di un determinato fatto, e ciò, a
prescindere dal contenuto dell’accertamento (ricollegandosi, essa alla sola
irrevocabilità della sentenza), cosicché «stante l’autonomia di ciascun rapporto
processuale, non si produce alcun effetto riflesso nei confronti di terzi»266. «Il
processo penale, non conosce alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, esclusa
proprio da tutta la disciplina della connessione, secondo la quale l’unificazione dei
procedimenti è affidata, pure nei casi più gravi di connessione materiale, alla
discrezione del giudice ed è soltanto eventuale»267. I conflitti tra giudicati- come
si è già osservato- potranno, poi, essere sempre evitati in via preventiva, mediante
l’unificazione dei procedimenti connessi, ovvero mediante il funzionamento delle
pregiudiziali, e in linea riparatrice, mediante la revisione.
Vi è, tuttavia, solo un caso nel quale l’efficacia di giudicato vale erga omnes268, e
cioè anche nei confronti di quelle persone alle quali la sentenza non si riferisce: è
il caso in cui l’imputato sia stato prosciolto con la formula della “insussistenza del
fatto”. Ciò è evidente, perché la sentenza che proscioglie con tale formula finisce,
in sostanza, col costituire la dichiarazione giudiziale che «nessuna persona ha
potuto commettere il fatto, perché tale fatto non è mai accaduto»269. La
264
Cass. Sez. I, 16 novembre- 1dicembre 1998, Hass e Priebke, in Cass. pen.., 1997, 2176 e in
Foro it., 1999, II, 273.
265
Tonini, P., Manuale di procedura penale, Milano, 2009, p. 807 ss.
266
De Luca, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale,cit., 1983, p. 124; Lozzi, G., Giudicato,
cit., p. 913; Rivello, P.P., Commento all’art. 649 c.p.p., in commento al nuovo c.p.p., coordinato
da M. Chiavario, vol. V, UTET, 1989- 1991, p. 424; Rivello, P.P., Analisi dell’art. 649 c.p.p, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, P. 483. per la giurisprudenza, Cass. Sez. I, 24.1.1995, Sorgato, in
CED, Cass. n., 200695.
267
Leone, G, Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1988, p. 737- 747.
268
Vannini, O., Manuale di diritto processuale penale, Milano, Giuffrè, 1953.
269
Bassi, A., I limiti oggettivi dell’effetto preclusivo derivante dal giudicato penale, in Cass. pen,
1992, 1403, 861.
117
“insussistenza del fatto”- si aggiunge- non è la stessa cosa della “insussistenza di
prove” sulla esistenza del fatto. La sentenza con la quale si proscioglie l’imputato
per “insufficienza di prove” non esclude certamente l’esistenza del fatto, né
tantomeno si esclude che ulteriori accertamenti o, ulteriori indagini nei confronti
di nuovi soggetti possano anche provarne l’esistenza. Ora, se è vero, che tali
indagini non possono più farsi nei confronti del prosciolto per il principio del ne
bis in idem, non è detto che non possano farsi nei confronti di terzi, dopo il
giudicato.
5. Le eccezioni apparenti al divieto.
Dopo aver analizzato, i presupposti del divieto del bis in idem, occorre ora,
soffermarsi sull’ultimo periodo dell’articolo 649 c.p.p. che detta:« salvo quanto
disposto agli artt. 69 co.2 e 345c.p.p ». In questa espressione, sono,
evidentemente, contenute le due eccezioni che il legislatore ha posto al divieto in
questione. In particolare, l’art. 69 co. 2º, afferma che “la sentenza non impedisce
l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona,
qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata
erroneamente dichiarata”. L’art. 345 c.p.p., pone, dalla’altra parte, un’altra
eccezione. Tale articolo, infatti, dispone che: “il provvedimento di archiviazione,
la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più
soggette a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della
querela, della istanza, della richiesta o della autorizzazione a procedere, non
impediscono l’esercizio della azione penale per il medesimo fatto e contro la
medesima persona, se in seguito è proposta la querela, l’istanza, la richiesta, è
concessa l’autorizzazione, ovvero se è venuta meno la condizione personale che
rendeva necessaria l’autorizzazione.” ; e al comma 2º, aggiunge che “la stessa
disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione
di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1”.
Quest’ultima disposizione riprende, in linea generale, il vecchio art. 17 c.p.p.
1930, in merito al quale si era affermato270, che la sentenza di cui, appunto,
all’art. 17 c.p.p. seppure, sentenza meramente processuale, costituisce giudicato.
270
Leone, G., Manuale di diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1988, p. 737- 747.
118
«Naturalmente, il giudicato»- si aggiungeva- «non può che investire quanto
effettivamente è stato deciso, e cioè, nel caso di specie, l’accertata mancanza di
una condizione di procedibilità e quindi la non proponibilità o la non
proseguibilità dell’azione penale». Pertanto «un nuovo processo che si radichi su
un’azione penale proponibile o proseguibile (per la sopravvenienza della
condizione di procedibilità)in tanto è possibile, in quanto non tocca il giudicato,
ma anzi lo presuppone e lo rispetta».
Ciò, in altre parole, vuol dire che nella sentenza di cui all’art.345 è contenuta una
pronuncia nella quale si accerta che l’azione penale non poteva essere iniziata o
proseguita. Una pronuncia, quindi, che non soltanto investe il merito, ma che,
anche, esclude in radice la (valida) presenza dell’azione penale. Premesso questo,
«quello che accade dopo, non è certo da considerarsi un rinnegamento della cosa
giudicata, in quanto non si ripropone l’azione penale, perchè- dato l’irrevocabile
accertamento precedente, della non proponibilità o proseguibilità dell’azione
penale- questa (l’azione penale),viene per la prima volta promossa o ripresa al
punto in cui era rimasta paralizzata dalla mancata condizione di procedibilità»271.
Pertanto, ove si inizi un altro procedimento, per essersi verificata quella
condizione di procedibilità, sarà ravvisabile (posto che il fatto rimane identico),
un’eccezione al ne bis in idem; eccezione limitata, però, soltanto alle suddette
ipotesi e per di più comprovante che il giudicato non è caratterizzato
dall’accertamento contenuto nella sentenza giacché, se così fosse, non si sarebbe
resa necessaria la previsione della deroga suddetta, essendo l’accertamento
ravvisabile nel giudicato diverso da quello oggetto del procedimento instaurato in
seguito alla presentazione della querela.
È stato peraltro, sostenuto che «l’efficacia ostativa ricollegabile alla sentenza di
proscioglimento per mancanza di una condizione di procedibilità- nei confronti di
un processo iniziato successivamente, sul presupposto dell’erronea dichiarazione
relativa alla mancanza della querela- non consegue all’identità dell’oggetto
dell’accertamento, bensì alla medesimezza del fatto materiale imputato, da cui,
discende il divieto di un nuovo procedimento, se in seguito alla modificazione del
271
Leone, G., Manuale, loc. ult. cit.
119
titolo, del grado o delle circostanze, il reato per il quale nuovamente si procede
risulti perseguibile d’ufficio»272.
Tuttavia, in dottrina, qualcun’altro ha fermamente sostenuto la tesi secondo la
quale, in realtà, «l’art. 17 c.p.p. (oggi, art. 345 c.p.p.), non importerebbe alcuna
eccezione al ne bis in idem, poiché il proscioglimento irrevocabile, per mancanza
di una condizione di procedibilità, avendo il valore di accertamento in ordine
all’assenza della condizione in parola ( con conseguente impossibilità di
sottoporre il prosciolto ad un nuovo processo sul presupposto, ad esempio, della
sussistenza della querela ritenuta mancante), non potrebbe impedire un altro
procedimento ove sopravvenisse tale condizione»273.
Quanto, invece, all’erroneo proscioglimento per morte dell’imputato, è evidente
che qui, siamo in presenza di una sentenza inesistente, la quale, come tale, non
passa mai in giudicato e, pertanto, non preclude una nuova azione.
Si è osservato, inoltre, che il fatto che l’art. 649 (e prima ancora l’art. 90 c.p.p.
abr.) parli di preclusione processuale in rapporto alle sentenze irrevocabili e non
alle sentenze passate in giudicato, non è certo un dato irrilevante, ma esso, al
contrario, ha una portata assolutamente decisiva. Pensiamo all’ipotesi di un
soggetto prosciolto con sentenza irrevocabile, dall’imputazione di lesioni colpose
lievi, per mancanza di querela: ora, se la querela venisse presentata in tempo, non
c’è dubbio che l’imputato potrà, certamente, essere sottoposto a nuovo
procedimento penale. Se, invece, dopo la sentenza irrevocabile il soggetto passivo
dovesse morire in seguito alla lesione (omicidio colposo, dunque, identità di
fatto), la questione che si pone è questa: si può tornare a procedere, in quanto il
fatto, ora, è perseguibile d’ufficio? La risposta è semplice: se il principio della
preclusione processuale derivasse dall’autorità di cosa giudicata, il prosciolto, nel
caso dell’esempio di cui sopra, dovrebbe essere sottoposto a procedimento penale,
in quanto non sussiste
giudicato penale nella sentenza dichiarativa della
mancanza di querela; ma, poiché il principio della preclusione processuale è
basato, appunto, sulla irrevocabilità della sentenza, si è detto: « non è consentito
aggiungere alle eccezioni dell’art 90 un’altra eccezione».
272
De Luca, G., I limiti soggettivi alla cosa giudicata penale, p. 157; Manzini, V., Trattato di
diritto processuale penale, vol. IV, 6ª ed., 1972, p. 591.
273
Cordero, F., Processo penale, Milano, 1971, p. 685.
120
Infine, vale la pena osservare, come l’art. 90 del c.p.p. abr, faceva salvo, in ultima
ipotesi, anche il disposto dell’art. 402 c.p.p. 1930, rubricato “ Casi di riapertura”,
il quale prevedeva che, chi fosse stato prosciolto nell’istruzione, avrebbe potuto
essere sottoposto a nuovo procedimento per il medesimo fatto, laddove fossero
sopravvenute nuove prove a suo carico e, a condizione che non fosse intervenuta
una causa di estinzione del reato. Si escludeva, in tal modo, l’effetto del ne bis in
idem, nel caso di sentenze istruttorie suscettibili di riapertura dell’istruzione. Si
diceva, infatti, che la riapertura di questa, integrasse un limite per l’irrevocabilità
delle sentenze istruttorie, così come la revisione costituisse un limite per
l’irrevocabilità delle sentenze di condanna. Questa asserzione, peraltro, è stata
successivamente contestata: si riteneva, infatti, «impossibile instaurare un
parallelo tra la revisione e la riapertura della istruzione», ma proprio in quanto- si
diceva- «i requisiti, particolarmente rigorosi, che caratterizzano l’inammissibilità
della revisione ne dimostrano il suo carattere eccezionale; mentre il fatto che la
sopravvenienza di nuove prove a favore o a carico dell’imputato, senza che
richiedere, peraltro, carattere “decisivo”, basti a giustificare la riapertura
dell’istruzione, conferma, evidentemente, il suo carattere non eccezionale e,
quindi, la possibilità di considerare le sentenze istruttorie come mere “sentenze
alla stato degli atti” non idonee a costituire cosa giudicata»274.
6. La rilevabilità del ne bis in idem.
Confermando un orientamento che può dirsi ormai consolidato, la Cassazione ha
affermato che l’imputato, che invoca la preclusione, derivante dal giudicato
formatosi sul medesimo fatto, ha l’onere di produrre innanzi al giudice di merito
la sentenza irrevocabile, mentre non ha alcun fondamento giuridico la pretesa che
debba essere il giudice, avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 507 c.p.p., a
provvedere alla sua acquisizione, in quanto, è vero che quest’ultimo ha il potere di
assumere ogni mezzo di prova, ma ciò purché sia assolutamente necessario ai fini
della decisione. Al suo potere di rilevare ex officio determinate questioni, infatti,
274
Nuvolone, Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale, 1943, p. 141- 142.
121
non corrisponde un dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a loro
fondamento275.
Si è, dunque, sostenuto che la regola del ne bis in idem, come appena detto, può
operare soltanto dopo che sia stata prodotta nel giudizio davanti al giudice di
merito la sentenza irrevocabile, per il necessario accertamento, sia del passaggio
in giudicato, sia dell’univocità del fatto. Ma se per un verso, è vero che nel nostro
ordinamento esiste la possibilità di esperire l’exceptio rei iudicatae, è anche vero
che il dovere del giudice di dichiarare l’esistenza della preclusione, non può
certamente essere subordinato, esclusivamente, ad un’iniziativa di parte. Egli,
infatti, può rilevarla, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento276.
Potrà rilevarla, pertanto, anche il giudice per le indagini preliminari, ovvero il
giudice al quale viene chiesta l’ammissione di un decreto penale di condanna277.
Tutto ciò con la precisazione che la preclusione derivante da precedente giudizio
può essere rilevata soltanto nel giudizio principale e non anche in sede incidentale
o davanti al giudice dell’impugnazione cautelare278.
C’è, poi, da osservare che l’accertamento della sussistenza dello stesso fatto, ai
fini del ne bis in idem, non può formare oggetto di valutazione, per la prima volta
nel giudizio di legittimità. La violazione del divieto del ne bis in idem è, infatti,
questione di fatto, riservata alla valutazione del giudice di merito; pertanto si
capisce bene perché essa non può essere dedotta per la prima volta davanti al
giudice di legittimità, «a meno che ratione temporis non sia stato possibile
dedurla in grado di appello perché la sentenza di riferimento era passata in
giudicato dopo quel giudizio»279. La Cassazione stessa ha ribadito che «il divieto
del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. postula una preclusione derivante dal
275
Cass. Sez. I, 28 aprile 2004, n. 23181/04, Suarez, in Cass. pen., 2005, 3007; e conforme Cass.
Cass. Sez., VI, 17 giugno 2003, n. 29740/03, Mulino, ivi, 2004, p. 3654:“ la parte che invoca la
preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fato ha l’onere di produrre innanzi al
giudice di merito la sentenza irrevocabile; non ha alcun fondamento giuridico che debba
provvedere alla sua acquisizione il giudice avvalendosi dei suoi poteri di cui all’art. 507 c.p.p.; e,
Cass. Sez., V, 29 gennaio 2007, n. 9180/07, in CED, Cass. n. 236259.
276
Cass. Sez., I, 20 dicembre 1950, in Mass. Pen., 1951, col. 141.
277
Cass. Sez. I, 14.5.2004, Cascella, in Mass. Uff. 229283; Cass. Sez. VI, 5.6.2003, Rebeschi, in
Mass. Uff., 226365; Cass. Sez, V, 16.12.1986, Bosco, in Cass. pen, 1988, p. 630.
278
Cass., 17.7.1995, Zafforo, in CED, Cass. pen., n. 202630.
279
Cass. Sez., I, 14 maggio 2004, n. 31123/04, Cascella, in Cass. pen., 2005, p. 3008; e conforme
Cass. Sez. VI, 5 giugno 2003, Rabeschi, ivi, 2005, p. 94: “l’accertamento della sussistenza del
fatto, ai fini del ne bis in idem, non può formare oggetto di valutazione per la prima volta da parte
del giudice di legittimità”.
122
giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona e presuppone la
produzione innanzi al giudice di merito della sentenza irrevocabile, per il
necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento che
della identità del fatto; ciò non può essere effettuato dinanzi alla corte di
cassazione perché è precluso al giudice di legittimità l’accertamento del fatto e la
parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali la cui valutazione
è rimessa esclusivamente al giudice di merito. L’imputato non rimane, peraltro,
senza tutela potendo egli, far valere la suddetta preclusione dinanzi al giudice
dell’esecuzione»280. Va osservato, infatti che la preclusione derivante da
precedente giudicato, pur se non fatta valere nel giudizio di cognizione, può essere
sollevata e rilevata per la prima volta anche in sede esecutiva281.
280
Cass. Sez., II, 24 settembre 2004, Chiaberti, in Cass. pen. 2006, p. 1506.
Cass. Sez., I, 2 febbraio 2005, Boheim, in CED, Cass. pen., n. 23161; pubblicata anche in Foro
it., 2005, II, c. 249; Cass. Sez. V, 15 gennaio 2003, Lo giudice, CED. Cass., n. 224981.
281
123
Capitolo III
NE BIS IN IDEM E FORME DI
MANIFESTAZIONE DEL REATO.
1. Premessa.
Il nostro oggetto di indagine, in quest’ultimo capitolo, si concentrerà su come il
fenomeno del ne bis in idem si rapporti in relazione a una serie di forme di
manifestazione del reato, e, in particolare, si prenderanno in esame le seguenti
ipotesi: il concorso di reati, il reato complesso, reato progressivo, abituale,
permanente e continuato, e da ultimo, quelle altre eventuali figure criminose,
realizzate alternativamente da più condotte fungibili, la cui somma non importi,
tuttavia, concorso di reati.
2. Il concorso di reati.
Nel diritto sostanziale, l’espressione concorso di reato si riferisce all’ipotesi in cui
un unico soggetto è al contempo responsabile di più reati282.
Il fenomeno è disciplinato dagli artt. 71 e seguenti del codice penale, nei quali si
distingue tra concorso materiale e concorso formale di reati.
Il primo problema che si pone, sul piano del diritto sostanziale è quello di
carattere
sanzionatorio.
In
un
sistema
penale
«orientato
in
senso
generalpreventivo- retributivo», - scriveva il Mantovani- «tre sono i criteri, in
astratto, possibili» per individuare la pena applicabile: a)
in primo luogo,
abbiamo il c.d. cumulo materiale, per il quale si applicano tante pene quanti sono i
reati commessi (tot crimina tot poene); b) un secondo criterio, è quello del c.d.
cumulo giuridico, per il quale si applica la pena del reato più grave, aumentata
proporzionalmente alla gravità delle pene concorrenti, ma in modo, comunque,
282
«Più che un istituto giurisìdico autonomo, il concorso di reato è un nomen iuris per indicare
l’attribuzione di più reati ad un medesimo soggetto». Mantovani, F., Diritto penale, Parte
generale, CEDAM, 2007, p. 448- 489.
124
complessivamente inferiore a quello che risulterebbe dal cumulo materiale; e,
infine, c ) ’ultimo criterio possibile è quello del c.d. assorbimento, per il quale si
applica soltanto la pena per il reato più grave, intendendosi in questa assorbite le
pene minori.
Circa il trattamento sanzionatorio relativo al concorso di reati, inoltre, il nostro
diritto vigente, distingue tra concorso materiale e concorso formale di reati.
In particolare, si ha concorso materiale quando il soggetto ha posto in essere più
reati con più azioni od omissioni283.
Di solito si distingue tra concorso materiale omogeneo, che si ha nell’ipotesi in cui
ad essere violata più volte è la stessa norma penale ( ad es., si commettono più
furti o più omicidi), ed eterogeneo, il quale si manifesta nel caso in cui, invece, ad
essere violate sono più norme diverse (ad es., si commette un furto, un omicidio,
un falso).
A tal proposito, il codice Rocco respinse non solo il sistema dell’assorbimento,
ma anche quello del cumulo giuridico, già adottato dal codice Zanardelli, perché
ritenuto troppo blando. Esso, accolse, invece, come principio base, il sistema del
cumulo materiale delle pene, sia pure, però, mitigato da opportuni temperamenti,
consistenti soprattutto nel fissare dei limiti insuperabili di pena. Pertanto, salvo i
limiti suddetti, al soggetto responsabile di più reati, si applicherà la somma
aritmetica delle pene stabilite per ciascuna infrazione. Si è anche osservato che
«se è vero che, per il concorso materiale l’ordinamento conserva il principio del
tot crimina tot poena, è anche vero che, ciò non vuol dire che siano allora,
indifferenti i rapporti che intercorrono tra i vari reati di cui un individuo sia
chiamato a rispondere. I reati in questione, possono essere legati da un vincolo
che si suole distinguere in :a) “ideologico”, che si ha quando un reato è
commesso allo scopo di eseguirne un altro ( Es. omicidio per derubare la vittima);
b) “consequenziale”, allorché un reato venga commesso per realizzare gli effetti
di un altro reato, assicurando a sé o ad altri, il profitto relativo, oppure per
283
«Esso, si verifica, pertanto, sia nel caso in cui con una sola sentenza si debba pronunciare
condanna per più reati contro una medesima persona (art. 71 c.p.), sia nel caso in cui, dopo una
condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o
posteriormente, ovvero allorché contro la stessa persona si debbano esegire più condanne (art. 80
c.p.)». Antolisei, F., Manuale di diritto penale, Parte generale, 16ª ed., Giuffrè, Milano, 2003, p.
515- 545.
125
occultarlo, o comunque, per ottenerne l’impunità ( Es. cagionata la morte di un
neonato, se ne distrugge il cadavere); c) “occasionale”, nei casi in cui la
commissione di un reato offra l’occasione per commetterne un altro ( Es. ladro,
nel rovesciare uno scrigno per sottrarre del denaro, trova un documento che lo
compromette e lo distrugge)»284.
Si ha, invece, concorso formale, quando il soggetto ha posto in essere più reati
(dolosi o colposi o dolosi e colposi) con una sola azione od omissione. Anch’esso
va distinto ulteriormente in omogeneo ed eterogeneo a seconda che si violi la
stessa norma più volte o più norme diverse. Ciò che distingue il concorso formale
da quello materiale è, pertanto, il rilievo che la molteplicità di reati viene posta in
essere non già con più azioni od omissioni, ma con una sola azione e con una serie
di atti che formano un tutt’uno, perché diretti ad un unico scopo e realizzati in
modo continuativo (contestualmente)285.
Ma quand’è che il soggetto, col suo comportamento, pone in essere un reato solo
o più reati? Per rispondere a tale domanda, possiamo riportare quanto scriveva il
Mantovani286. Secondo quest’ultimo, infatti, tre sono le principali teorie a
riguardo: a) la concezione naturalistica; b) la concezione normativa; c) la
concezione normativa su base ontologica.
a) Secondo, la prima concezione, l’unità e la pluralità dei reati va desunta da
strutture preesistenti in rerum natura. Pertanto, l’agire umano costituirà un solo
reato o più reati a seconda che esso sia naturalisticamente unico o plurimo. Si
avrà, cioè, uno o più reati, a seconda che si abbia rispettivamente, un’unica azione
o più azioni, un unico evento o più eventi, un’unica volontà o più volontà.
«L’insuccesso di questa opinione è che in rerum natura non esiste né pluralità, né
unità, ma soltanto una serie meccanicistica di movimenti muscolari, di atti
psicologici, di accadimenti. Unità e pluralità sono concetti di relazione, di valore,
284
Antoisei, F., Manuale di diritto penale, cit.
«Presupposto del concorso formale di reati, quale previsto dall’art. 81 co. 1, è, dunque, l’unicità
del fatto, che non va però confusa con l’unicità di intenzione» (Cass., Sez. V, 82/154674). E,
«attesa la non necessaria coincidenza tra fatto in senso naturalistico e fatto in senso giuridico, può
verificarsi che all’unicità di un determinato fatto storico faccia riscontro una pluralità di fatti
giuridici. Ciò, è quanto si verifica nel concorso formale di reati, in cui con un’unica azione si
cagionano più eventi giuridici». Crespi- Forti- Zuccalà, Art. 81 (concorso formale di reati), in
Commentario breve al c.p., CEDAM, 2008, p. 368 ss.
286
Mantovani, F., Diritto penale, Parte generale, cit.,, p. 448- 489.
285
126
e come tali determinabili e variabili a seconda del parametro fisico, fisiologico,
biologico, psicologico, etico- sociale, giuridico con cui vengono valutati».
b) Secondo la concezione c.d. normativa, «l’unità o la pluralità va desunta
esclusivamente dalla norma penale. Esso è l’unico metro per decidere se il fatto
storico è valutato dal diritto penale come un solo illecito o come più illeciti. In tal
caso si deve ammettere una assoluta libertà creativa del diritto che non sarebbe
vincolata da alcuno schema ontologico e razionale».
c) Più complessa è l’ultima teoria, ossia quella normativa. Secondo quest’ultima,
infatti, pur affermandosi che la norma penale costituisce il primo punto di
partenza logico per valutare se quel fatto storico vada considerato come unico o
plurimo, tuttavia si riconosce che esistono determinati schemi ontologici,
determinati per lo più da sistemi di valori, che devono costituire la struttura
portante di ogni sistema penale razionale e progredito. Ed è questa- secondo
l’Autore- la concezione più conforme al volto costituzionale del nostro diritto
penale, incentrato su principi di materialità, offensività e soggettività. Essiaggiunge- « indicano il minimum per aversi unità di reato, al di sotto del quale il
legislatore non può scendere».
Si è detto anche che la caratteristica essenziale del concorso formale è che «il fatto
concreto presenti una complessità di elementi per cui una parte di esso
corrisponde contemporaneamente a due figure di reato, mentre nelle parti residue
corrisponde, disgiuntamente, per alcuni elementi, ad una figura e per altri ad
un’altra». Si portava, a riguardo l’esempio dell’ipotesi di violenza sessuale sulla
propria sorella: «l’unione sessuale- si diceva- corrisponde tanto all’incesto quanto
al delitto di cui all’art. 609 bis c.p., mentre il vincolo di sangue è proprio
dell’incesto e il costringimento è proprio della violenza carnale». «In altri termini,
si ha che due o più disposizioni di legge prendono in considerazione una stessa
parte del fatto e, inoltre, ciascuna, una parte diversa»287. Ma perché si abbia
concorso formale di reati, si richiede, evidentemente, «che l’azione unica sia
accompagnata e sorretta dall’elemento soggettivo tipico proprio di ciascuna
fattispecie criminosa (…). Ciò significa che perché si abbia pluralità di reati,
287
De Luca, Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale, in Riv. proc.
pen., 1960, p. 187; Lozzi, G., Profili di un’indagine sui rapporti tra ne bis in idem e concorso
formale di reati, Giuffrè, 1974, p. 71.
127
nonostante l’unicità dell’azione è necessaria la presenza di una pluralità di
processi volitivi, sicché al moltiplicarsi delle lesioni faccia riscontro il
moltiplicarsi
degli
elementi
psicologici,
propri
di
ciascuna
fattispecie
incriminatrice e, nell’ipotesi di plurima violazione della medesima disposizione di
legge, che ciascuna di queste sia sorretta dall’elemento soggettivo richiesto per
l’integrazione del reato»288. E,« non potendosi la pluralità di violazioni farsi
puramente e semplicemente derivare dalla pluralità delle persone offese, è
necessario, quando si verifica tale condizione, un quid pluris, consistente nella
riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a
realizzare l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice, nei confronti di
ciascuna, distintamente, di dette persone (…) Ne deriva che se l’azione è unica ed
unico è l’atteggiamento psicologico che sorregge il comportamento del colpevole,
unico è il reato che egli commette»289.
Il codice Rocco, a differenza di quello precedente, considerava il concorso
formale alla stessa stregua di quello materiale (tot crimina, tot poena). Nel 1974, è
intervenuta una riforma, con la quale si è abbandonato il sistema del cumulo
materiale, per accogliere, invece, quello del cumulo giuridico. E, superando la
controversia sulla maggiore o minore gravità del concorso omogeneo rispetto a
quello eterogeneo, si è stabilita per entrambe le forme, la medesima misura di
aumento della pena base.
Dopo aver illustrato, in linea generale, cosa si intende per concorso di reati nel
diritto penale sostanziale, possiamo tornare al nostro oggetto di indagine, ossia
all’analisi della operatività del ne bis in idem per questa particolare forma di
manifestazione del reato, ovviamente distinguendo a seconda che si tratti di
concorso materiale o formale. Si tratta, in altre parole, di stabilire se il giudicato
penale su uno dei reati concorrenti precluda o meno un successivo giudizio per
l’altro reato. Naturalmente, in merito al concorso materiale la risposta non può che
essere negativa, giacché tale concorso si realizza allorquando con più azioni od
omissioni siano compiute più violazioni di legge. Trattasi, infatti, di una pluralità
288
289
Cass., Sez., I, 87/178225.
Cass., Sez., II, 97/210458.
128
di condotte distinte a cui fa riscontro una pluralità di fattispecie290; pertanto,
l’irrevocabilità della sentenza che concerne un reato non preclude il nuovo
giudizio su un fatto materialmente concorrente a quello già giudicato. Vi sono,
poi, reati le cui fattispecie prevedono condotte plurime, valutabili congiuntamente
o disgiuntamente. Nel caso dell’art. 616 c.p, l’essere stato assolto dal giudizio di
aver “distrutto” la corrispondenza non preclude il successivo giudizio per
“aver(ne) preso cognizione” e viceversa. Si tratta, cioè, di fatti diversi in quanto
derivanti da condotte diverse. Se, dunque, per il primo fatto è intervenuta una
condanna, il secondo, invece, per quanto diverso, non consente un nuovo giudizio,
ma solo perché altrimenti, si violerebbe l’art. 616 c.p.. Si è detto, a tal riguardo,
che qui, «l’effetto preclusivo nasce dalla norma penale e non processuale»291.
Più complesso appare il problema che si pone, allorquando le violazioni di legge
siano realizzate con una sola azione od omissione come, appunto, avviene nel
concorso formale di reati. Anche in questo caso, bisogna distinguere a seconda
che tale concorso sia omogeneo ( ossia, ove sia violata più volte la medesima
disposizione di legge) ovvero eterogeneo (nel caso in cui siano compiute più
violazioni di diverse disposizioni di legge). Al riguardo, si è detto che, tanto
nell’una che nell’altra ipotesi, «ascrivere alla stessa persona un nuovo reato
equivarrebbe, invero, a dare una diversa considerazione del medesimo fatto, inteso
appunto come condotta»292. Se, dunque, si assume come premessa, la
considerazione che per fatto si intenda la condotta, individuata dall’oggetto
materiale su cui essa cade, trova conferma l’opinione secondo cui la preclusione
non opera nei casi di concorso formale omogeneo, in cui, a fronte di una sola
condotta, vi siano più fatti, data la pluralità di oggetti fisici su cui essa ricade. Si
pensi al colpo d’arma da fuoco, o all’esplosione di una bomba che provochi due
vittime: il giudicato intervenuto su un omicidio, non preclude il processo in ordine
al secondo omicidio, giacché, per la diversità dell’oggetto materiale, può ritenersi
diverso pure il fatto, e cioè, la condotta293.
290
Cass., Sez., II, 19.12.1973, in Mass. Uff., n. 126894; Cass., Sez., I, 8.6.1982, ivi, n. 154896;
Cass., Sez., V, 5.3.1975, ivi, 1976, 183, 66.
291
Giovene, Giudicato, in Digesto disc. pen., UTET, 1991, p. 430.
292
Pagliaro, Fatto (dir. proc. pen.), in Enc, dir., XVI, 1867, p. 964.
293
Lozzi, G., Giudicato, in Enc. dir., vol. 1066, Milano, p. 918- 923.
129
Nel caso di concorso formale eterogeneo ( si pensi alla persona che con una falsa
testimonianza incolpi di un reato taluno che egli sa innocente, realizzando così
anche il delitto di calunnia), l’identità della condotta parrebbe, invece, precludere
l’esperibilità del’azione penale per il reato su cui si è pronunciata la sentenza
irrevocabile294, e ciò sul presupposto che la pluralità di eventi coincida con la
pluralità di fatti, in quanto violazioni di diversi interessi tutelati dalla stessa norma
penale, sempreché nell’altro giudizio non sia stata esclusa la sussistenza del fatto
o la commissione di esso da parte dell’imputato295. Più precisamente, si è, in
passato, sostenuta296 la necessità di distinguere l’ipotesi in cui con un’unica azione
si cagionino due eventi materiali, da quella in cui la condotta integri di per sé due
illeciti penali senza dover essere seguita da alcun evento in senso naturalistico:
nella seconda situazione, ci troveremo di fronte ad un vero e proprio concorso
formale di reati. Nella prima, invece, si realizzerebbe un semplice concorso
formale di condotte. I due casi- si aggiungeva- debbono esser tenuti nettamente
distinti, in quanto, se una sola condotta determina due modificazioni del mondo
esterno rilevanti per il diritto, si avranno tre distinti fatti storici, cioè, il
comportamento e i due eventi naturalistici; mentre ove la condotta integri nel
contempo due fattispecie criminose il fatto storico risulterebbe unico (…) Di
conseguenza, nel concorso di reati vero e proprio, il procedimento instaurato
successivamente alla formazione del giudicato concernerebbe esclusivamente il
fatto storico già preso in esame; nel concorso di condotte, invece, «il
procedimento successivo involgerebbe un fatto storico “nuovo” (il secondo evento
materiale)»297.
Esiste ancora un’altra ipotesi rientrante nello schema del concorso formale
eterogeneo: e più precisamente, allorché l’unica condotta provochi un solo evento
naturalistico, ma integri due diversi reati: condannato o assolto per l’azione o
l’omissione considerata a prescindere dai suoi effetti causali (ad es. omesse
294
Leone, G., Trattato di diritto processuale penale, III, Napoli, 1961, P. 345-346.
Cass., Sez., IV, 7.4.1971, in Cass. pen., 1972, 941, 1286; Cass., Sez., III, 22.10.1984, in Mass.
Uff., n. 177500: Cass., Sez., IV, 12.11.1971, ivi, n. 120126; Cass., Sez., I, 14.7.1972, ivi, n.
155255; Cass., Sez., II, 12.2.1985, ivi, n. 169107; Cass., Sez., VI, 19.3.1985, ivi, n. 170026; Cass.,
Sez., IV, 2.3.1987, ivi, n. 175851; Cass., Sez., V, 6.12.1988, ivi, 180517.
296
Conso, G., I fatti giuridici processuali penali, 1955, p. 95- 96.
297
Lozzi, G., Profili di una indagine sui rapporti tra ne bis in idem e concorso formale di reati,
Milano, Giuffrè, 1974, p. 57- 89,
295
130
cautele), l’autore resta perseguibile rispetto al delitto conseguente (omicidio
colposo), sebbene unica sia la condotta298. Per contro, sempre in base a questa
impostazione restano coperte dal divieto di un secondo giudizio altre situazioni
riconducibili sempre al concorso formale eterogeneo, ma caratterizzate dal fatto
che l’unica condotta integra di per sé due illeciti penali senza però, essere seguita
da alcun evento naturalistico :« l’art. 649 c.p.p., infatti, vieta un secondo giudizio
sul medesimo fatto anche se considerato sotto un titolo diverso; ed è quanto
succede nel caso di specie, in cui, appunto, il fatto cade sotto due titoli»299. A
conclusioni di questo tipo è giunta, anche, la giurisprudenza300.
In generale, quest’ultima, ha affermato che non ricade nella preclusione del ne bis
in idem, l’ipotesi del concorso formale di reati, senza, tra l’altro, distinguere tra
concorso omogeneo ed eterogeneo, «potendo e dovendo la vicenda criminosa
essere valutata alla luce di tutte le implicazioni penalistiche, col possibile riesame
in direzione delle ipotesi delittuose rimaste estranee al giudizio precedente». E,
talvolta, - aggiunge- «si avverte che la possibilità di instaurare il nuovo
procedimento è subordinata alla condizione che nel giudizio già definito non sia
stata dichiarata l’insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte
dell’imputato»301.
3. Il reato complesso.
Il reato complesso trova la sua collocazione sistematica all’interno del titolo III
del c.p., dedicato in linea generale al “reato”. La fattispecie complessa viene
considerata dal legislatore un’ipotesi di concorso apparente di norme302. Nel caso
298
Cordero, F., Procedura penale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 2006, p. 1212.
Cordero, F., Procedura cit., p. 1209.
300
Cass., 3-12-1992, Bellicoso, in Riv. pen., 92, p. 426, ove si è deciso che l’imputato condannato
in un primo giudizio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, non avrebbe potuto più essere
chiamato successivamente a rispondere di lesioni volontarie; e, Cass., 8-11-1996, Privitera, in cui
si è ravvisata l’identità del fatto tra una contestazione di peculato e una di abuso di ufficio.
301
Cass., 24-5-2000, Laenza, in Cass. pen., 2003, p. 165; e, Cass., 8-4-1999, Carta, ivi, 2000, p.
1997.
302
Abbiamo concorso di norme, allorché oiù norme appaiono, almeno prima facie, tutte applicabili
ad un medesimo fato. Deve trattarsi di norme non identiche, ma diverse, perché in tal caso non
avremmo un concorso di norme, ma soltanto norme diverse, tutte relative allo stesso fatto, ora
vietandolo, ora comandandolo o, addirittura, consentendolo. Occorre dunque, innanzitutto, la
pluralità di norme e, in secondo luogo, l’identità del fatto che appare contemplato contestualmente
da più disposizioni normative. Il ché è possibile se e in quanto incorrano tra le fattispecie relazioni
299
131
di specie, il fatto che integra il reato complesso integra anche il reato semplice,
ma, in virtù dell’art. 84 c.p., si applica ad esso solo la norma che prevede il reato
complesso. Dallo stesso articolo, «si evince, infatti, che esso rappresenta proprio
la risultante della fusione o della unificazione legislativa di almeno due reati, da
cui origina una fattispecie astratta unitaria e autonoma, con nuova e diversa
denominazione, ovvero una forma aggravata di una delle due fattispecie
criminose»303. Tuttavia, è stato notato, che« l’art. 84 c.p., non specifica quali
rapporti debbano intercorrere tra i distinti fatti criminoso perché possa dirsi
integrato un reato complesso, e ne viene lasciata la determinazione alla norme
incriminatrici di parte speciale (…) Tuttavia, la dottrina, ha evidenziato che la
ratio dell’unificazione legislativa dei singoli fatti implica “un punto comune di
incidenza” tra gli stessi: viene, cioè, evidenziato un rapporto di mezzo a fine che
collega i fatti delittuosi, e che giustifica la confluenza in un'unica fattispecie
legale»304. L’importanza del concetto di “unificazione giuridica di più reati” è
stata ribadita dalla Cassazione, a partire dagli anni ’70, con la sentenza 29 marzo
1971, n. 599, quando la Corte ha rinvenuto un’ipotesi di reato complesso «nel
caso in cui una fattispecie criminosa fosse considerata dalla legge come elemento
costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, in modo da perdere la propria
autonomia nell’unica figura criminosa assorbente, a seguito della unificazione di
tutti gli elementi che integrano il tipo di reati» (…) «Non è sufficiente, invece, la
parziale identità di alcuni elementi comuni tra le fattispecie. Non basta che più
fatti di reato abbiano qualche elemento comune, ma occorre che uno di essi
convenga interamente in un’altra fattispecie criminosa, tanto da perdere la propria
autonomia e diventare elemento costitutivo o circostanza aggravante della stessa.
In difetto di tali presupposti, si considera integrato il concorso formale di reati»305.
Non è configurabile il reato complesso neanche nell’ipotesi in cui una fattispecie
di specialità (unilaterale) o specialità reciproca (bilaterale). Si ha specialità quando una norma
(speciale) presenta tutti gli elementi di un’altra norma (generale), con almeno un elemento in più.
Si ha, invece, specialità reciproca, quando nessuna norma è speciale o generale, ma ciascuna è al
tempo stesso generale e speciale, perché entrambe presentano accanto ad un nucleo di elemento
comuni, elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti elementi dell’altra.
Mantovani, F., Diritto penale, Parte generale, cit., p. 448- 489.
303
Caringella, F. Garofoli, R., Reato complesso, in Studi di diritto penale, Giuffrè editore, 2002, p.
1055- 1085.
304
Caringella, F. Garofoli, R., Reato complesso, cit., 1055- 1085.
305
Cass., 23 aprile 1983, n. 3528.
132
criminosa si presenti quale presupposto di un successivo reato, o sia commisurata
allo scopo di commetterne un altro: in tale ultimo caso, infatti, si configura un
mero rapporto teleologico fra i due illeciti, che non esclude un concorso di
reati306.
L’Antolisei307 distingueva il reato complesso in due sotto- fattispecie. In
particolare, egli parlava di reato composto (o complesso in senso stretto) e reato
complesso in senso lato.
Il primo è espressamente disciplinato dall’art. 84, co. 1º, c.p. Ciò significa che
quando un fatto, che di per sé stesso costituisce reato, è considerato da una
disposizione di legge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di
un altro reato, si applica soltanto la disposizione in parola. Esso, dunque- come si
evince espressamente, dall’articolo in esame- può presentarsi in due forme. Nella
prima, «i singoli reati vi rientrano tutti come elementi costitutivi, dando luogo a
un nuovo titolo di reato». L’esempio tipico è la rapina (art. 628 c.p.), i cui
elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e dalla violenza privata (art. 610
c.p.). Questa tipologia di reato complessivo è detta anche “speciale”, in quanto
caratterizzata dalla sussistenza di più reati operanti in chiave paritetica, in quanto
entrambi elementi costitutivi di un nuovo stesso reato308.
La seconda forma contempla l’ipotesi in cui «i singoli reati che formano il reato
composto vi rientrano uno come elemento costitutivo e l’altro come circostanza
aggravante, lasciando inalterato il titolo del reato- base». È il caso, ad esempio,
del furto aggravato con violazione di domicilio, o del sequestro di persona a scopo
di estorsione, seguito da morte del sequestrato.
La natura sostanziale di tale figura giuridica è data, insomma, dalla riunione di più
reati in uno solo, sia esso semplice o circostanziato309. Non bisogna, tuttavia,
dimenticare- come sottolineava lo stesso Autore- che deve comunque trattarsi di
reati diversi, e non già di una molteplicità di reati della stessa specie, come
avviene ad esempio nella relazione incestuosa, perché, in questo caso dovremmo
parlare più propriamente di reato a condotta plurima.
306
Caringella, F. Garofoli, R., Reato complesso, cit.
Antolisei, F,. Manuale di diritto penale, Parte generale, cit., 2003, p. 537.
308
Caringella, F. Garofoli, R., Reato complesso, cit.
309
«La scindibilità in più fatti criminosi minori – si è detto- è caratteristica essenziale del reato
composto».
307
133
Per quanto concerne, invece, il reato complesso in senso lato, esso- secondo
l’Antolisei- si manifesta, ogni qualvolta si abbia un reato che, « in tutte o in
alcune delle ipotesi contemplate nella norma incriminatrice, contiene in sé
necessariamente almeno un altro reato meno greve. Per l’esistenza di questa
fattispecie giuridica non occorre la riunione di due o più reati: ne basta uno solo
con l’aggiunta di un elemento ulteriore»310. Esempio tipico è quello della violenza
sessuale (art. 609 bis c.p. ), la quale comprende la violenza privata (art. 610 c.p.) e
presenta l’ulteriore elemento dell’atto sessuale, elemento che da solo non
costituisce reato. Un altro caso di reato complesso in senso lato è la violenza o
minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 336 c.p.).
Questo, infatti, «include necessariamente la violenza privata con la particolarità
che il soggetto passivo è un pubblico ufficiale o incaricato d un pubblico servizio.
Nella figura giuridica ora delineata il reato minore rimane assorbito nel reato
maggiore, e perciò, non è punibile separatamente». Il reato complesso così inteso
- aggiunge l’Autore- «non trova, tuttavia, il suo fondamento nell’art. 84 c.p.:
questa disposizione, infatti, non può essere interpretata in modo da abbracciare
qualunque reato che ne contenga necessariamente un altro minore311.
Il suo
fondamento giuridico, va piuttosto ravvisato, nel principio di specialità, di all’art.
15 c.p., in quanto la fattispecie meno grave è speciale rispetto a quella che ne
prevede il secondo , e, perciò, ne esclude l’applicabilità». Ciò trova conferma, per
esempio, in relazione all’ipotesi della violenza sessuale: se confrontiamo la
disposizione che la disciplina (art. 609 bis c.p.) con quella che contempla la
violenza privata (art. 610 c.p.) è evidente il rapporto di specialità fra le due
fattispecie: l’art. 610 c.p., comprende, infatti, tutti gli elementi della violenza
sessuale (art. 609 bis c.p.), nella quale, il quid pluris degli atti sessuali costituisce
l’elemento specifico o specializzante. Inoltre, vale la pena tener presente- come
giustamente sottolineava lo stesso Autore- che la contenenza del reato meno
310
Antolisei, F., Manuale di diritto penale, Parte generale, cit., p. 540.
«Il suo fondamento giuridico, va piuttosto ravvisato, nel principio di specialità, di cui all’art. 15
c.p., in quanto la fattispecie meno grave è speciale rispetto a quella che ne prevede il secondo, e
perciò, ne esclude l’applicabilità». Ciò trova conferma, per esempio, in relazione all’ipotesi di
violenza sessuale: se confrontiamo la disposizione che la disciplina (art. 609 bis c.p.) con quella
che contempla la violenza privata (art. 609 c.p.) è evidente il rapporto di specialità fra le due
fattispecie: l’art. 610 c.p., comprende, infatti, tutti gli elementi della violenza sessuale (art. 609 bis
c.p.), nella quale il quid pluris degli atti sessuali costituisce l’elemento specifico o specializzante.
Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., p. 540.
311
134
grave in quello più grave può essere di due tipologie: esplicita o implicita. La
prima si ha quando il reato incluso è espressamente indicato dalla legge col
relativo nomen iuris, come nel delitto previsto dall’art. 630 c.p. (sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione), il quale presenta come elemento
costitutivo quel sequestro di persona che è indicato nell’art. 605 c.p. Abbiamo,
tuttavia, una contenenza esplicita anche nel caso in cui la descrizione del reato
incorporante comprende la descrizione di quello incorporato. Ciò avviene, ad es.,
nei vari reati che implicano la violenza o la minaccia per costringere taluno a fare,
tollerare od omettere qualche cosa ( artt. 294, 336, 338, 609 bis, ecc. ), reati che
includono, e perciò assorbono, il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p.
La contenenza, al contrario, è implicita quando l’inclusione del reato minore nel
reato maggiore, evidentemente, non si desume direttamente dalla norma
incriminatrice, ma «dalla natura intrinseca del fatto in essa stessa configurato (…)
Esistono, invero, molte ipotesi delittuose che per la loro essenza naturale non
possono essere realizzate senza che l’agente realizzi prima o contemporaneamente
un’altra ipotesi delittuosa meno grave. Si tratta di fatti che rappresentano un maius
rispetto ad altri e che necessariamente, quando vengono posti in essere implicano
la realizzazione anche dei minori (…) Così come, non è possibile uccidere senza
percuotere o ferire; non si possono compiere fatti di devastazione (art. 419c.p.)
senza danneggiare cose mobili o immobili (art. 635 c.p.); non si può ridurre taluno
in schiavitù (art.600 c.p.) senza compiere un sequestro di persona (art.605
c.p.)»312 e via dicendo. Ma questi reati, prendono più propriamente il nome di
reati progressivi, dei quali si parlerà più specificamente in seguito.
Si è, infine, osservato che la “unicità del reato complesso” implica anche unicità
di lesione, in quanto tra i due o più beni giuridici lesi contemplati dalle norme solo
uno prevale sugli altri. L’incidenza lesiva unitaria si riflette sul dolo del soggetto
agente che, nel rappresentarsi i singoli fatti delittuosi, deve considerare anche il
vincolo strumentale o modale che li lega. In particolare, affinché possa
configurarsi un reato complesso, è necessario che i singoli reati concorrano a
delinearne la fattispecie e si realizzino in tutti i loro elementi costitutivi, compresa
la fattispecie complessa.
312
Antolisei, F., Manuale di diritto penale, Parte generale, cit., p. 540.
135
Da un punto di vista meramente sanzionatorio, è evidente che il reato complesso
presenta una maggiore gravità rispetto a quella del concorso tra le singole
fattispecie. Ad es. in materia di rapina, il legislatore considera molto più grave che
la violenza venga utilizzata per la realizzazione di un furto e non che vi siano
autonome ipotesi di violenza e di furto completamente sganciate tra di loro.
Questo perché il disvalore derivante da due reati unificati è notevolmente
superiore e, infatti, di solito viene espressamente prevista una pena ad hoc molto
elevata. Per fare un esempio, si pensi alla differenza tra la pena da comminare in
caso di rapina, ex art. 628 c.p. (da 3 a 10 anni) e quella che consegue al furto ex
art. 624 c.p. (da 15 gg a 3 anni di reclusione), mentre per il reato di violenza
privata è prevista la reclusione fino a 4 anni, da un minimo di 15 gg. È
perfettamente evidente il disvalore aggiuntivo che il legislatore associa alla
fattispecie complessa.
Dopo aver illustrato brevemente, la struttura del reato complesso, la sua disciplina
sostanziale e sanzionatoria, è necessario ora precisare la ratio che ha ispirato il
legislatore nel prevedere tale figura criminosa. La giustificazione che viene
maggiormente adottata in dottrina,
attiene alla necessità di sottrarre questa
fattispecie dalla disciplina del concorso di reato, o meglio, di evitare il rischio di
una doppia incriminazione per la medesima fattispecie di reato. Si è osservato,
infatti, che « se non fosse una regolamentazione legislativa espressa a prevedere la
punibilità dei singoli fatti criminosi, come un solo reato (complesso), si
rischierebbe l’applicazione congiunta della disciplina del reato complesso e di
quella dei singoli reati semplici». Ad esempio, riguardo al reato di cui all’art. 628
c.p., vi sarebbe la possibilità di considerare integrato il reato di rapina, con quello
di furto e di violenza e, quindi, di reputare esistente un concorso di reati, con
doppia incriminazione per le medesime fattispecie313.
In tema di reato complesso, si pone il quesito se ed in che termini il giudicato sul
reato complesso oppure sul reato che di esso costituisce elemento costitutivo,
313
In realtà, questa seconda motivazione non risulta pienamente convincente per numerosi autori, i
quali hanno aloro volta osservato che il reato complesso rappresenta una figura inutile, e che, di
conseguenza, anche la disciplina dell’art. 84 c.p. è fondamentalmente superflua. Si dice, infatti,
che «per evitare il rischio di doppia incriminazione, sarebbe sufficiente applicare il principio di
specialità, di cui all’art. 15 c.p., rispetto al quale, l’art. 84 c.p., ne costituisce una mera
applicazione legale». Antolisei, F., Manuale di diritto penale, cit., p. 463; Pagliaro, Fatto (dir.
proc. pen. ), in Enc. dir., vol. XVI, Milano, 1967, p. 634.
136
precluda un nuovo procedimento. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza
irrevocabile sul reato complesso, la giurisprudenza nega la possibilità di celebrare
un nuovo giudizio per il singolo reato componente314. Dal canto suo, la dottrina315
evidenzia come a tale indagine si renda necessario distinguere a seconda che il
reato complesso sia costituito da un solo reato con l’aggiunta di un ulteriore
elemento (è il caso della violenza carnale che comprende la violenza privata e
l’ulteriore elemento della congiunzione carnale) oppure due o più reati [es. x e y,
fatti distinti (ad esempio furto e violenza privata), costituiscono reati
corrispondenti alle norme N¹, N²; e, N³, ne configura la somma dei due reati, sotto
un terzo nomen delicti (rapina)]316. Ora, nella prima ipotesi, il giudicato sul reato
complesso preclude il procedimento sulla fattispecie criminosa integrante un
elemento costitutivo del reato complesso e il giudicato sulla fattispecie predetta il
procedimento sul reato complesso. Nella seconda ipotesi, invece, la sentenza
irrevocabile sul reato complesso preclude l’instaurazione di un nuovo
procedimento avente per oggetto uno dei reati componenti; mentre il giudicato
avente per oggetto uno dei reati costitutivi preclude un procedimento sul reato
complesso ma non sull’altro o sugli altri reati costitutivi del reato complesso: è
evidente, infatti, come in quest’ultimo caso, la condotta presa in esame dai due
procedimenti sia diversa317.
4. Il reato progressivo.
Si tratta di una figura largamente accolta nel diritto penale italiano, ma che non
trova una esplicita previsione come figura generale nella legge scritta.
Anche’essa è inserita tra le varie situazioni cui può dar luogo il concorso
apparente di norme e, più precisamente, essa è stata, per lungo tempo, indicata
come una delle deroghe (accanto al reato continuato e al reato complesso), alle
regole generali sul concorso di reati. «È certo, infatti, che di fronte al reato
progressivo si applica una sola disposizione di legge incriminatrice, quella – cioè 314
Cass., 21.10.1999, Giordano, in Riv. pen., 2000, p. 401.
Cordero, F.., Procedura penale., Milano, Giuffrè, 1966, p. 671; Lozzi, Giudicato, in Enc. dir.,
1066, p. 918- 923; Giovene, Giudicato, in Dig. disc. pen., vol. V, 1991, p. 430.
316
Cordero, F., Procedura penale, cit., 1966, p. 671.
315
137
che prevede la figura criminosa del reato così come realizzata secondo la
fattispecie legale in cui è prevista, senza tener conto ai fini penali, degli altri
specifici reati per cui l’attività del colpevole necessariamente passa per arrivare e
integrare la fattispecie criminosa in questione»318. Varie sono le nozioni di reato
progressivo che ci offre la dottrina italiana. Paoli scrive: «si ha reato progressivo
quando una attività criminosa maggiore è comprensiva di una attività criminosa
minore, attraverso la quale occorre necessariamente passare per compiere
l’altra»319.
Grispigni, asseriva, invece, «il reato progressivo si ha quando l’agente da una
condotta iniziale che realizza un tipo di reato, passa ad un’ulteriore attività che
realizza una forma di reato più grave, che include tra i suoi elementi costitutivi
quello più semplice e meno grave» (…) La stessa locuzione reato progressivo,
«esprime proprio il trascorrere da fatti meno gravi a quelli più gravi della stessa
specie, o di specie analoga e al tempo stesso si vuole indicare nella figura
compiuta il punto di arrivo dell’episodio delittuoso»320.
Vi è, poi, una corrente, che a partire da Guglielmo Sabatini, riteneva che «reato
progressivo si avrebbe soltanto in quei casi in cui esista una espressa previsione di
legge, per la quale si preveda l’assorbimento di una fattispecie legale minore in
un’altra più grave, della quale la prima costituisce il presupposto necessario (…)
Ferma restando la pluralità dei fatti, ciascuno dei quali, preso di per sé solo,
costituirebbe autonoma figura di reato, fermo restando il requisito della unicità del
soggetto che realizzi i fatti stessi e, fermo restando che il fatto successivo e più
grave debba implicare necessariamente la violazione di norme che prevedono
offese meno gravi dello stesso bene giuridico od anche di altri beni giuridici, ma
sempre meno importanti di quelli offesi dal reato progressivo nel suo insieme,
occorrerebbe l’esistenza di una espressa disposizione di legge che escluda
l’applicazione della fattispecie minore e conduca con ciò all’assorbimento delle
pena meno grave in quella più grave»321. Questa tesi che, talvolta, è stata ripresa
318
Vassalli, G., voce, Reato progressivo, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 1155.
Paoli, G., Principi di diritto penale, vol. III, 1929, Padova, CEDAM, p. 33- 34.
320
Grispigni, F., Diritto penale italiano, 1947, Milano, Giuffrè.
321
Ma esempi di reato progressivo, secondo questa teoria, fermandoci al solo dato del codice
penale, sarebbero forniti soltanto dall’art. 307 c.p., per cui l’assistenza ai partecipi di banda armata
o di cospirazione è punita solo in quanto l’agente non sia concorrente nel reato o favoreggiatore;
319
138
anche dalla giurisprudenza322, è tuttavia, da considerarsi, in linea generale,
eccessivamente restrittiva e troppo formale323.
Un’altra teoria che vale la pena ricordare è quella del Ranieri. Egli identificava il
reato progressivo in questi termini: «una fattispecie legale penale astrattamente
considerata che ne contiene necessariamente in sé altre, la cui realizzazione,
necessariamente passa attraverso la realizzazione delle fattispecie minori (non
importa se lesive dello stesso bene giuridico e di tutti i soggetti passivi offesi dalla
maggiore) (…) e, la cui pena, non può che essere secondo la chiara intenzione
della legge, se non la pena stabilita per la fattispecie legale più ampia».
L’Antolisei- come si è già visto nel paragrafo precedente- inquadra questa figura
come una specie di reato complesso in senso lato, individuandolo, più
esplicitamente, come un caso di c.d. contenenza implicita, nella quale
«l’inclusione del reato minore nel maggiore non si desume dalla dizione di norma
incriminatrice (come avviene per la violenza carnale rispetto alla violenza privata
o per il sequestro di persona a scopo di estorsione rispetto al sequestro di
persona), ma dalla natura intrinseca del fatto in essa configurato». Sul punto,
peraltro, s’era pronunciato anche il Mantovani, secondo il quale, la ragione della
diversa denominazione deriva sostanzialmente «dal diverso angolo visuale con
cui i due fenomeni vengono guardati dai diversi autori: visti secondo la struttura
della fattispecie legale si presentano come reati complessi, visti nel dinamismo
della attività criminosa (da minus a maius) si presentano come reati
progressivi»324. Ovviamente, in questa categoria- come sottolineava, giustamente,
il Ranieri-
non può ricomprendersi « ogni delitto consumato rispetto alla
corrispondente figura di delitto tentato (il tentativo e la consumazione- si dicevasono, infatti, forme di manifestazione di uno stesso reato) ed ogni delitto di
pericolo rispetto al corrispondente delitto di danno. Esempi classici di reato
dall’art. 474 c.p., che punisce l’introduzione nello Stato e il commercio di opere dell’ingegno e di
prodotti industriali con segni mendaci quando il soggetto non abbia concorso nel più grave delitto
di contraffazione e casi analoghi. Le altre ipotesi comunemente rappresentate dalla dottrina come
figure di reato progressivo sarebbero, invece, da includersi, a seconda dei casi, in altre categorie.
Sabatini, G., Il reato progressivo nel sistema alle deroghe al concorso di reati, in Studi in onore di
Ugo Conti, Città di Castello, 1932, p. 51 ss.
322
Cass., 6.7.1956, in Riv. pen., 1957, p. 498; Cass., Sez. Un., 4.7.1953, in Giust. pen., 1953, II, c.
1057.
323
Vassalli, G., voce, Reato progressivo, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 1155.
324
Mantovani, F, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 448- 489.
139
progressivo sono invece,: il delitto di invasione di terreni (art. 633 c.p.), rispetto a
quello di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), il delitto di tratta e
commercio di schiavi (art. 601 c.p.), rispetto al sequestro di persona (art. 605
c.p.), e il delitto di devastazione non soltanto rispetto al danneggiamento ma
anche rispetto ad altri delitti contro la pubblica incolumità e contro la pubblica
economia. La stessa Cassazione, ha affermato che perché si abbia reato
progressivo, non occorre che i reati siano necessariamente di un unico tipo.
Essenziale è soltanto che non si possa realizzare la figura maggiore senza
realizzarne in concreto anche una minore o più minori. «Anche nel saccheggio,
che resta l’esempio classico del reato progressivo, si possono avere soltanto furti o
anche soltanto rapine, o gli uni e gli altri, certo si è che non si può avere
saccheggio senza né gli uni né gli altri»325.
Il reato progressivo, tuttavia, non va, infatti, confuso con altre fattispecie
criminose quali la c.d. progressione criminosa; il c.d. reato di passaggio e il fatto
antecedente o successivo non punibile, di cui anche si parlerà più avanti.
In tema di reato progressivo, per la maggior parte della dottrina, il divieto di un
secondo giudizio trova applicazione tanto nel caso di giudicato
sul reato di
maggiore gravità, quanto nel caso di giudicato sul reato meno grave326. Già a
livello meramente testuale deve, infatti, ritenersi irrilevante che lo stesso fatto sia
in un secondo tempo diversamente considerato per il “grado” ;e “grado” sta
appunto ad « indicare la misura dell’evento nei reati progressivi»327.
In ogni caso, possiamo vedere- come scrive anche Giovanni Leone328- che in
caso di giudizio per reato progressivo possono, in concreto, presentarsi le seguenti
situazioni:
a) giudicato di condanna per il fatto che costituisce il reato più grave. «Poiché la
pena di questo abbraccia la sanzione per tutti i fatti compresi nella situazione di
progressione delittuosa, il giudicato consuma l’azione penale nei confronti anche
di quei fatti che, per quanto non dedotti specificamente in imputazione, sono
325
Cass., Sez. Un., 2 aprile 1946, in Giust. pen., 1946, II, c. 283; Cass., Sez., I, 22 novembre 1946,
ivi, 1947, II, c. 204; Cass., Sez. Un., 26 marzo 1960, ivi, II, c. 737.
326
Cordero, F., Procedura penale, cit., p. 1210 ss: Giovene, Giudicato, in Dig. disc. pen., cit., p.
429; Lozzi, G., Giudicato, cit., p. 738.
327
Cordero, F., Procedura penale, cit., p. 1210,
328
Leone, G., Manuale di procedura penale, seconda edizione, Napoli, Jovene, 1962, p. 481- 487.
140
riportabili alla attività progressiva, su cui è caduto il giudicato». Ad esempio, la
condanna per partecipazione al delitto di procurato aborto (art. 547c.p.) impedisce
un nuovo processo per istigazione all’aborto (art. 548 c.p.); o, ancora, la condanna
per associazione a delinquere (art. 416 c.p.), impedisce un nuovo processo per
assistenza agli associati (art. 418 c.p.) e così via;
b) giudicato di assoluzione per il fatto che costituisce il reato più grave o il fatto
ultimo della serie progressiva. Non si esclude, in questo caso, che la medesima
persona possa essere chiamata in un nuovo processo a rispondere di un nuovo
fatto meno grave o facente parte della serie progressiva, che però non sia stata
dedotta nel precedente giudizio. Si dice, infatti, « nessuna ragione può escludere
che colui che sia stato assolto dal’imputazione di partecipazione al delitto di
procurato aborto o di associazione a delinquere possa essere successivamente
chiamato a rispondere per istigazione all’aborto o di assistenza agli associati per
delinquere». Va precisato che ciò è, tuttavia, possibile, solo e, a condizione che,
sul fatto meno grave non si sia formato in alcun modo giudicato, neanche
implicitamente: il che accade se esso costituiva parte del fatto imputato;
c) giudicato di assoluzione per il fatto che costituisce il reato meno grave o una
fase iniziale o intermedia della progressione criminosa. Non impedisce un nuovo
processo per i fatti costituenti più grave reato o una fase diversa della
progressione, quando - si aggiunge- « non sia indispensabile all’economia del
reato la preesistenza dei fatti integranti i reati meno gravi»;
d) giudicato di assoluzione o di condanna in quei casi in cui eccezionalmente il
reato progressivo si realizza in un’azione unica. In questo caso eccezionale, data
l’unità dell’azione, si afferma l’assoluta inderogabilità della cosa giudicata, anche
se questa si riferisca all’evento meno grave. In tal caso, l’unità dell’azione ci
riporta alla regola secondo cui la diversa qualificazione del titolo di reato ( ad es.
omicidio invece di lesioni) non intacca l’autorità del giudicato;
e) giudicato di condanna per il fatto che costituisce il reato meno grave, mentre il
fatto più grave si verifica o viene a conoscenza successivamente. Esso,
evidentemente, mentre da una parte non può impedire che sia perseguito il fatto
costituente il reato più grave, non può dall’altra parte, condurre ad una duplice
punizione (quella del reato meno grave e quella del reato più grave), quando il
141
diritto sostanziale ne commina una sola (quella del reato più grave). In tal caso,
applicando i principi che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato per la
situazione analoga del reato continuato, s’istituirà un giudizio suppletivo che, nel
caso di riconosciuta responsabilità per il nuovo fatto, condurrà all’applicazione di
una pena unica comprensiva di quella già applicata col giudicato precedente.
5. Reato abituale.
Si definisce abituale, il reato nel quale il comportamento criminoso viene prodotto
dalla reiterazione (da parte del reo) di più condotte identiche ed omogenee. È
dunque un reato a condotta, necessariamente plurisussistente. Premesso questo, si
può ben osservare che, né il codice penale vigente, come peraltro neanche quello
abrogato, dà una definizione di reato abituale, né tanto meno si rinviene un
qualsiasi riferimento a tale figura. Eppure non sono poche le fattispecie penali
caratterizzate sul piano della struttura obiettiva, della reiterazione di più fatti
omogenei e perciò considerate, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, quali esempi
tipici di reati abituali329.
È ormai sufficientemente condivisa in dottrina l’opinione che il reato abituale è
caratterizzato dalla reiterazione abituale di più fatti omogenei, richiesta- ma talora
soltanto “ammessa” (è il caso del reato eventualmente abituale), da alcune norme
incriminatrici per la realizzazione del fatto costitutivo di reato. A tale figura è
riferibile la qualificazione di reato “necessariamente abituale”330. In ogni caso, «il
carattere unitario del reato abituale malgrado esso consista in una serie
discontinua di episodi, non può essere validamente contestato: unico è il fatto di
reato sul piano normativo, anche se è necessario (o è ammesso) che sia costituito
da più fatti materiali; ciascuno di questi, rispetto alla fattispecie complessiva è
329
Si è detto, infatti, che « si tratta, più che latro, di una categoria giuridico- penale non meramente
descrittiva, ma operativa sotto numerosi profili». Petrone, M., Reato abituale, CEDAM, 1999, p.
1.
330
Quanto, invece, alla figura del reato “eventualmente abituale” – si è detto- « essa ricorre quando
la fattispecie ammette… una realizzazione in definitivamente protratta nel tempo, in modo che il
verificarsi di uno degli elementi in essa contenuti non renda impossibile l’ulteriore prolungarsi
della realizzazione stessa». Essa, sta ad indicare, in altre parole, «quei casi in cui la norma si
potrebbe dire che tolleri la reiterazione abituale, in quanto attribuisce rilevanza, allo stesso titolo,
sia la fatto singolo che alla ripetizione di più fatti omogenei: senza che questo comporti né
concorso di reati né continuazione». Gallo, Reato permanente ed omesso conferimento di grano
all’ammasso, in Riv. it. proc. pen., 1948, p. 333 ss. e, Petrone, M., Reato abituale, cit., p. 1 ss.
142
soltanto un “momento del fatto” e, legato com’è agli altri , finisce per dissolversi
nel reato complessivo. La rilevanza penale, insomma, è comunque attribuita a
quel titolo, alla pluralità di fatti reiterati e omogenei, sulla base di un legame
oggettivo che gli unisce. Unità, che, peraltro, come vedremo, «non è meramente
esteriore, ma si basa su un dato intrinseco al fatto e precisamente sulla omogeneità
degli episodi e sul legame di persistente frequenza che li unisce»331.
Si è soliti, inoltre, distinguere tra reato abituale proprio e reato abituale improprio.
Alla prima categoria appartengono quei reati, costituiti da una serie di determinate
azioni, le quali considerate autonomamente sono di per sé irrilevanti. Il Manzini,
scriveva, « reati abituali sono quelli, la cui nozione esige, come elemento
costitutivo, la reiterazione abitudinaria o professionale di fatti, che, presi
singolarmente, non sarebbero reati»332.
Pensiamo al caso di delitto di
sfruttamento di prostitute, ipotizzato dall’art. 534 c.p. Ebbene, perché possa
integrarsi il delitto in esame non basta un fatto isolato: non basta, cioè, che
l’agente si faccia consegnare una sola volta del denaro da una prostituta; occorre,
invece, una certa ripetizione di tali atti, una certa serie di consegne di denaro
ricavato dalla prostituzione. «Ad integrare questa figura occorre che l’agente
ponga in essere una serie di determinate azioni, che il legislatore ha indicato
esplicitamente, in modo che entrino nella struttura giuridica del reato»333.
Occorre, allora, precisare in che senso si ammette nella complessa struttura del
reato abituale la pluralità di eventi334. L’evento che consegue alla singola azione
non ha alcuna rilevanza giuridica. La legge penale, infatti, non ricollega alcuna
sanzione alla realizzazione di una singola azione, per quanto accompagnata dal
suo elemento fattuale. Tutto ciò vuol dire che la legge richiede qui una pluralità di
331
Petrone, M., Reato abituale, cit., p. 31 ss.
Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano secondoil nuovo codice del 1930, vol. I, UTET,
1933, n. 234, p.573.
333
Leone, G., Del reato abituale, permanete e continuato, Napoli, Jovene, 1933, p. 1 ss.
334
Di essi – si è detto- « non può dirsi che siano eventi in senso giuridico, ameno che non si voglia
ammettere che il reato abituale risulti composto da una pluralità di reati. Ma, così dicendo, si
verrebbe a dissolvere l’autonoma struttura del reato abituale, in quanto si ridurrebbe a mero reato
continuato, o reato abituale del secondo tipo (…) Ma non può neanche dirsi che tali eventi abbiano
una mera significazione naturalistica (…) Vero è che per evento si intende anche “qualunque
avvenimento verificatosi, tutto ciò che è evvenuto, vale a dire qualunque cosa accaduta, ma in
realtà dobbiamo preferire la tesi secondo la quale i singoli eventi corrispondenti alle singole azioni,
hanno una connotazione intermedia tra quella naturalistica e quella giuridica». Leone, G., Del
reato abituale, cit. e, Pergola, Il reato, n. 286, p. 313- 314.
332
143
eventi, collegati dall’elemento psicologico, i quali individualmente non hanno
carattere criminoso»335. Se ne deduce pertanto, che nel reato abituale, l’evento,
inteso in senso meramente giuridico interviene soltanto nel momento finale e
conclusivo, quando cioè, si sarà costituita l’intera serie di azioni che il legislatore
richiede per la integrazione del reato.
Nel reato abituale improprio, le singole condotte integrano di per sé reato e la
reiterazione della condotta dà luogo o a una figura di reato più grave o a
un’aggravante336. «Anch’esso costituisce un’unità indissolubile, alla cui
formazione concorrono le singole entità». Va, innanzitutto, distinto dal reato
permanente perché, nel reato abituale i singoli momenti delittuosi corrispondenti
alle consumazioni dei singoli reati sono “indipendenti”, nel senso che non può
dirsi che tra l’una e l’altra azione si mantenga la violazione del bene giuridico: «il
reato abituale ha una successione di momenti di realizzazione, tra i quali v’è
soluzione di continuità». E la differenza con il reato continuato è evidente: per
questi, infatti, la legge non esige quel nesso del medesimo disegno criminoso. Per
quanto riguarda, poi, l’elemento psicologico- si aggiunge- che, «data la
derivazione del reato in esame da una pluralità di singoli reati, non può negarsi
che vi sia una pluralità di elemento volontario e, nel caso di delitti dolosi, un dolo
plurimo; deve comunque riconoscersi data la identità dei soggetti attivi, la
esistenza di un certo nesso psicologico tra i singoli reati. Momento consumativo, è
quello che, con il perfezionamento dell’ultima azione, segna il compimento della
serie»337.
Possiamo capire da questi brevi cenni, dunque, che il reato abituale, ha senz’altro
una struttura particolarmente complessa. Possiamo, in generale, riassumerla in tre
punti fondamentali:
a) dalla reiterazione di più fatti338;
335
Leone, G., Del reato abituale, cit.
Sul punto, vedi Grispigni, Diritto penale italiano, II, Milano, 1952, p. 206; Leone, G., Del
reato abituale, permanete e continuato, Napoli, Jovene, 1933, p. 259 ss.
337
Leone, G., Del reato abituale, cit..
338
Quanto al suddetto requisito, ossia alla ripetizione di più fatti, vale la pena osservare che, in
teoria, a livello di fattispecie astratta, esso è necessario solo per quelli che vengono, appunto,
definiti, “reati necessariamente abituali”. Ma in pratica – come è stato giustamente osservato- « è
evidente che anche esso è necessario anche per reati eventualmente abituali. Anche questi ultimi,
infatti, per essere abituali in concreto, devono presentarsi come reiterazione di più fatti: altrimenti
avremmo un reato istantaneo!».
336
144
b) dalla identità o, comunque, dalla omogeneità di tali fatti339;
c) dal nesso di abitualità tra i fatti stessi340.
Rispetto a quest’ultimo punto, vale la pena osservare, come contrastanti siano le
opinioni in dottrina: il nesso in questione, richiesto con forza da alcuni autori, è
negato fermamente, da altri. Tra i primi si sostiene, infatti, che «senza questo
legame, da un lato non si potrebbe individuare nel reato abituale una offesa
unitaria e, dall’altro lato, non avrebbe senso l’unificazione di più episodi identici
nel reato abituale improprio ed in quello eventualmente abituale. Gli episodi non
legati da nesso da abitualità resterebbero distaccati e, se dotati di autonoma
rilevanza penale, non potrebbero sfuggire alle regole del concorso o della
continuazione»341. Il Manzini a conferma di ciò scriveva che «il nesso della
abitualità tra i vari fatti della medesima specie è contemporaneamente condizione
di punibilità dei fatti stessi ed elemento essenziale del reato»342.
Non mancano, peraltro, in dottrina, posizioni contrarie, secondo cui, pur essendo
tipica del reato abituale la ripetizione di più fatti omogenei, questa sarebbe al
tempo stesso necessaria e sufficiente ad integrare il reato, non occorrendo, che tra
i vari episodi sussista un nesso di abitualità. «Due sono gli elementi che
contrassegnano il reato abituale: 1° che l’abitualità significa tendenza alla ripetuta
commissione di un determinato fatto, direzione della volontà; 2° che il legislatore
Non c’è dubbio che comunque, la figura caratteristica è quella del reato necessariamente abituale,
nel quale il fatto costitutivo, se non ripetuto non può integrare (quel titolo) il reato. Posto questo, è
il caso di sottolineare che la reiterazione dei più fatti non dà vita ad altrettante condotte bensì, a
frammenti di un’unica condotta, la quale potrà essere commissiva o, anche, omissiva. Petrone, M.,
Reato abituale, cit., p. 16 ss.
339
Il secondo requisito affinché si sia in presenza di un reato abituale, è che i fatti che
compongono il fatto tipico siano identici o, quanto meno, omogenei. Ciò significa che essi, « quale
che sia l’aspetto materiale, devono possedere la stessa carica offensiva, ossia devono concorrere
alla lesione o alla messa in pericolo dello stesso interesse che è, appunto, quello protetto dalla
norma che prevede il reato di cui si tratta. Ed è in tale identità offensiva che si coglie il carattere
unitaro del reato abituale. La suddetta omogeneità deve sussistere in tutti i casi». L’offesa,
peraltro, non è soltanto il risultato della omogeneità dei fatti componenti il reato abituale, ma
anche della loro persistente frequenza. Così, ad esempio, nel delitto di maltrattamenti in famiglia,
la sofferenza della vittima – proprio a causa della reiterazione della persistente frequenza, è ben
diversa ( e non solo “maggiore”) rispetto a quella conseguente ad un episodio isolato, anche se
esso costituisce di per sé reato (es. percosse, ingiuria). Petrone, M., Reato abituale, cit.
340
L’ultimo elemento caratteristico del reato abituale è l’esistenza di un particolare legame che
unisca i vari episodi della stessa serie; in quanto – si è detto- « la semplice e meccanica ripetizione
di più fatti omogenei non è sufficiente ad integrare la figura del reato abituale, anzi, è proprio su
questo requisito che si sorregge la qualificazione di tale reato». Petrone, M., Reato abituale, cit.
341
Petrone, M., Reato abituale, cit.
342
Manzini, V., Trattato di diritto penale italiano secondo il nuovo codice del 1930, vol. I, UTET,
1933, n. 234, p. 573.
145
nel disciplinarla è stato costretto a fissare rigorosamente e necessariamente gli
elementi donde essa possa desumersi»343.
Il problema del nesso di abitualità non è semplice; la questione, va più che altro
posta in questi termini:- si è detto- «non è sul piano della inclinazione che si pone
il requisito della abitualità, dal momento che le varie norme in materia non
contengono alcuna indicazione implicita né esplicita in questo senso (…) Il nesso
in questione, ha natura obiettiva, e dunque, è cosa diversa dalla inclinazione. Esso
non può che consistere nella frequenza, e dunque, non nella sporadicità degli
episodi della serie: più precisamente si può indicare quel nesso obiettivo quale
rapporto di persistente frequenza tra i vari episodi della serie (…) »344. Si è
ancora, osservato che, in realtà, «è lo stesso legislatore, che fa riferimento al
concetto di frequenza per connotare l’abitualità, seppure a fini diversi. Così, ad
esempio, per costituire un aggravante inerente alla persona del colpevole (e quindi
soggettiva: art. 70), quale quella prevista dall’art. 94, 2 c.p., in tema di
ubriachezza abituale, ove si parla di persona, oltre che dedita all’uso di bevande
alcooliche, anche sia in stato di frequente ubriachezza. Ovvero negli artt. 102,
103, 104 e 105 c.p., che prevedono quelle forme qualificate di pericolosità che
sono l’abitualità e la professionalità; in cui, oltre alla caratteristica soggettiva di
essere dediti al reato, si richiede in sostanza proprio il connotato oggettivo della
frequenza»345.
Il problema che si pone, in tema reato abituale, è se il giudicato emesso su alcuni
fatti che costituiscono tale reato possa precludere o meno l’instaurazione di un
successivo giudizio sugli altri fatti, eventualmente scoperti successivamente al
giudicato stesso, ma sempre rientranti nel medesimo reato abituale.
Esaminiamo innanzitutto, l’ipotesi del giudicato di condanna. Questo,
ovviamente- si è detto- «consuma l’azione penale e quindi la pretesa punitiva,
relativamente al fatto deciso». Si tratta, ora di vedere, come giustamente suggeriva
il Leone, cosa debba intendersi per “medesimo fatto”, data la complessità del fatto
nel reato abituale. È evidentemente, questo, un problema più di fatto che di diritto.
In linea generale, secondo lo stesso Autore, deve escludersi la possibilità di
343
Leone, G., Del reato abituale, permanente e continuato, XI, 1993, p. 81- 82.
Sabatini, G., Istituzioni di diritto penale, I, Catania, 1946, p. 276.
345
Petrone, M., Reato abituale, cit.
344
146
rinnovare l’azione penale per tutta quella serie di azioni, poste dal precedente
giudice a fondamento della sentenza di condanna. Ciò vale anche per un
frammento di tale fatto così composto, ossia per una singola azione o per un
ridotto gruppo di azioni e, anche infine, per quella/e azione che pur non essendo
stata esplicitamente contemplata nel giudicato o perché trascurata o perché
ignorata dal giudice, si riannoda alla serie che costituisce l’elemento materiale del
reato abituale già giudicato e punito. Si diceva a riguardo, «se per esempio, taluno
sia stato condannato per delitto di sfruttamento di prostitute, compiuto in un
determinato periodo di tempo,- che la sentenza dovrà anche approssimativamente
fissare- le altre azioni di simil genere, successivamente scoperte, compiute però
nello stesso periodo di tempo contro lo stesso soggetto passivo, costituendo un
frammento del complesso giudicato, si rifiuteranno di essere nuovamente
giudicate (…) Se, invece, le azioni, conosciute dopo il giudicato sono svincolate
da qualsiasi nesso col fatto giudicato e sono relative ad un diverso fatto di
sfruttamento, non vi è ragione per precludere l’esercizio di una nuova azione
penale: così se si scoprissero altre azioni di sfruttamento, commesse in tempo più
lontano e separate da un lungo distacco cronologico dal fatto giudicato»346.
Quello che si afferma qui, è la possibilità che una, o più azioni, pur non essendo
conosciute al momento del giudizio, se rientrano nei limiti fissati dal giudicato, ne
rimangono comunque coperte. Questo era stato già affermato da una dottrina
tedesca (vedi in particolare, Bennecke e Beling), secondo la quale l’autorità (o,
c.d. “forza obbligatoria”: Rechtskraft ) della cosa giudicata si estende su tutto il
complesso dei fatti; pertanto, la plurima conoscenza di uno o più fatti, non
avrebbe potuto autorizzare un nuovo procedimento. E ciò, non perché, l’autorità
giudiziaria- come sosteneva la stessa dottrina- nel precedente giudizio, fosse stata
comunque in grado di utilizzare l’intero complesso dei fatti, e, anzi, il fatto che ne
avesse omessi alcuni, o perché non ne aveva avuto conoscenza o perché li aveva
ritenuti irrilevanti, non avrebbe avuto alcuna rilevanza, in quanto la pretesa
punitiva- si diceva- una volta esaminata dal tribunale sarebbe stata di per sé
sufficiente ad escludere ogni ulteriore procedimento; ma piuttosto, deve dirsi che
il divieto di un nuovo giudizio per il caso in cui vengano scoperte alcune azioni
346
Leone, G., Del reato abituale, cit., p. 530 ss.
147
appartenenti alla serie giudicata e ancorché costituenti parte o frammento del fatto
giudicato, poggia proprio sul carattere unitario del reato in questione. Il Borsari,
infatti, scriveva: «gli atti di prostituzione, d’usura ecc. (…) si riuniscono
concettualmente e formano un’unità giuridica, e sono a considerarsi come
elementi di un fatto unico»347. Il Leone, più semplicemente, diceva: «il sottoporre
ad un secondo giudizio le stesse azioni punite con un precedente giudicato, sia
pure in compagnia con altre, distrugge in pieno il principio del ne bis in idem».
Ovviamente tutto questo vale anche per i reati abituali c.d. impropri :tutto ciò che
ha formato materia del precedente giudizio, rientra nei cancelli del giudicato: al
secondo giudice, pertanto, è precluso ogni giudizio su tale materiale processuale.
Vi è, tuttavia, oggi concordia in dottrina348 nel ritenere che il giudicato di
condanna intervenuto nei confronti di una serie di episodi integranti reato abituale
non impedisca l’apertura di un nuovo procedimento per un altro gruppo di azioni
a loro volta costituenti reato abituale; ma con la precisazione che nel successivo
giudizio non sarà possibile tener conto delle condotte precedentemente giudicate e
punite.
Guardiamo ora, all’ipotesi di giudicato di assoluzione, in particolare, in tema di
reato abituale proprio. È possibile che il giudice assolva perché la serie di azioni
presentate in giudizio è a suo avviso incompleta, e tale da non riuscire ad integrare
il reato imputato. Pensiamo all’ipotesi in cui, si denunzi all’autorità giudiziaria
uno sfruttamento di prostitute, e il giudice assolve perché le poche azioni portate a
sua conoscenza le ritiene insufficienti a costituire il reato denunziato. E ciò è
esatto, in quanto, in materia di reato abituale proprio, la condotta incompleta
costituisce una situazione giuridica, la quale come tale non è suscettibile di
punizione perché allo stato, penalmente irrilevante. Se però accade che,
successivamente alla sentenza di assoluzione, vengano commesse altre azioni
collegabili, specie per quanto attiene all’elemento psicologico, alle precedenti,
bisogna domandarsi se sia possibile opporre l’exeptio rei iudicatae, per evitare
che si riportino all’attenzione del giudice le precedenti azioni, sulle quali
pronunciò l’assoluzione.
347
Borsari, Dell’azione penale, Torino, UTET, 1866, n. 423, p. 520.
Conso- Grevi, in AA. VV., Commentario breve al codice di procedura penale, Padova,
CEDAM, 2005, p. 2201- 2202.
348
148
La risposta è semplice: la sentenza con la quale si assolve l’imputato, sul
presupposto che le azioni dedotte in giudizio siano insufficienti a costituire la
particolare figura di reato abituale, non può impedire che, intervenute altre azioni,
il secondo giudice le esamini, insieme a quelle su cui era caduto il precedente
giudicato, per vedere se ora è integrato il reato stesso. Questa specie di sentenza,
non può, infatti, come lo stesso Autore sottolineava, riportarsi sotto lo schema
dell’ art. 649 c.p.p., «proprio perché, presupposto di questo sistema è la identità
del fatto, ma, qui, nessuno oserebbe dubitare che il fatto, per l’intervento delle
successive azioni, sia mutato sostanzialmente ».
La questione, secondo il Leone, va piuttosto portata sotto il profilo della
particolare struttura del reato abituale.
Nel reato abituale (proprio), infatti,
l’elemento materiale, come abbiamo visto, è costituito da una serie di azioni:
queste azioni stanno tra loro in un certo rapporto e, nel momento in cui interverrà
l’ultima azione che completerà la serie, acquisteranno, per effetto di una sorta di
“efficacia retroattiva” di quest’ultima (azione), rilevanza giuridica, che
evidentemente, non avevano nel momento in cui comparvero. Dunque, non può
che trattarsi di sentenza di assoluzione, laddove, le azioni portate in giudizio non
siano sufficienti ad integrare il reato abituale (proprio), in quanto quelle azioni su
cui è caduta la pronuncia giurisdizionale, erano in quel momento penalmente
irrilevanti. Però, il problema che poneva il Leone, è il seguente: se, dopo il
giudizio di assoluzione, dovessero comparire altre azioni, riconducibili mediante
un unico nesso a quelle già giudicate, è evidente che nessuno potrà impedire al
secondo giudice di prenderlo in esame, onde emettere eventualmente una sentenza
di condanna. La particolarità di questa ipotesi- aggiungeva- sta in questo: «che
mentre l’esame delle nuove azioni giammai dedotte in giudizio, è libero da
qualsiasi vincolo con il precedente giudicato, trattandosi di elementi di fatto
nuovi, il giudizio sulle azioni già giudicate può apparire una violazione della res
iudicata. Può apparire, ma non lo è,- aggiungeva- perché (…), a parte che il
nuovo giudizio cade su di un più vasto complesso di azioni, parte delle quali è già
giudicata, e poi, basta rilevare che il precedente giudicato, poggia su di una
situazione giuridica incerta, che se non giungerà a maturazione, resterà qual è, ma
che in caso opposto acquisterà quella rilevanza, che in un momento originario non
149
aveva. Il giudicato, pertanto, è legato, nella sua sorte, a quella situazione giuridica
(…) Se, infatti, i successivi elementi, perfezionando la situazione giuridica
originaria, danno rilevanza a quegli elementi precedenti, crolla il fondamento su
cui poggiava quella sentenza assolutoria. Sarebbe strano ammettere che quella
stessa sentenza, che pronuncia l’assoluzione sul presupposto che il materiale
dedotto in giudizio sia insufficiente ed abbia bisogno di essere vivificato da nuovi
elementi, debba precludere il giudizio su questo materiale, qualora i nuovi
elementi richiesti dovessero comparire»349. Una tale sentenza è stata infatti anche
definita di assoluzione “con riserva”; la quale addirittura, è stata paragonata alla
sentenza che assolve per difetto di una condizione di punibilità; la quale, infatti,
comporta la possibilità di una riproposizione dell’azione penale su quel
“medesimo fatto”, laddove intervenga successivamente tale condizione.
6. Il reato permanente.
Si tratta di un reato di creazione propriamente giurisprudenziale. Esso si verifica
quando
l’offesa
commessa
dall’agente
a
un
bene
giuridico
tutelato
dall’ordinamento si protrae per effetto di una condotta persistente e volontaria350.
Come si può ben capire, il reato permanente ha una struttura particolarmente
complessa. Concentriamoci, innanzitutto, sulla condotta. Innanzitutto, partendo
dalla stessa espressione utilizzata dal legislatore, possiamo ben capire che si tratti
di un reato di durata, caratterizzato dal fatto che l’evento lesivo e la sua
consumazione perdurano per un certo periodo di tempo. Il reato, in particolare, si
349
Leone, G., Del reato abituale, cit.
Fin dal 1902 si è cercato di darne una definizione. In particolare il Campus scriveva che il reato
permanente corrisponde alla «violazione di quei diritti che per la loro speciale natura non sono
suscettibili di essere distrutti o diminuiti, ma solamente ostacolati nel loro libero esercizio o nella
loro realizzazione, producendosi necessariamente per un tempo più o meno lungo sotto forma di
un fatto continuato, realizzato attrverso la specifica permanenza della infrazione» Campus, Studio
sul diritto permanente, p. 25- 26. Ma, prima ancora di lui, l’Escobedo diceva: «allorché gli effetti
permanenti, non dicontinui, del reato sono di natura e di carattere tale da offendere e menomare la
personalità umana nei suoi diritti essenziali, o da contraddire all’assetto politico e giuridico dello
Stato, nelle norme o nei principi che lo informano, o da offendere la pubblica morale o, da porre in
pericolo l’incolumità e la sanità pubblica, per modo da costituire una condizione di cose
antigiuridiche, contraria essenzialmente all’ordine morale e politico e spesso pericolosa; in tal caso
gli effetti permanenti che dal reato medesimo ne protrae la consumazione fino a quando essi
durano e conseguentemente danno al reato medesimo un carattere permanente». Escobedo,
Ancora sulla nozione di reato permanente specie sui rapporti di bigamia, in Giust. pen., 1927, col.
819 ss.
350
150
compone di due fasi: una fase iniziale, in cui il soggetto agente pone in essere tutti
i fatti necessari affinché si verifichi il fatto illecito, poi vi è la fase della
continuazione, che secondo la giurisprudenza consiste nel persistere, da parte del
soggetto agente della condotta
351
. Iniziamo ad esaminare, la condotta nella sua
prima fase. Si è detto subito, che essa, in realtà, non presenta alcuna peculiarità,
«giacché si atteggia nella forma ordinaria in cui si esprime ogni condotta
punibile»352. Esattamente scrive il Massari: «Il reato permanente non è diverso da
ogni altro reato, per quanto attiene al decorso esecutivo anteriore alla
consumazione del reato». Il Vannini, dall’altra parte scriveva: «Il reato
permanente non può mai rivestire la figura di reato materiale, poiché nel reato
materiale la consumazione implica esaurimento dell’attività esecutiva che la
precede, mentre il concetto di permanenza implica un’azione esecutiva che si
protrae ininterrottamente oltre i limiti della raggiunta consumazione»353.
Evidentemente, «questa prima fase della condotta, può atteggiarsi negli aspetti più
diversi, senza una particolare sua forma di realizzazione.
È stato altresì, sottolineato che «permanenza non significa continuazione
ininterrotta dell’attività esecutiva (…) Il concetto di permanenza si riferisce, più
che altro, alla seconda fase della condotta; la prima, può, invece, essere anche
discontinua (…); ma allora fino a questo momento, non può palarsi di
permanenza, la quale non sarebbe riferibile né all’evento, perché in questa fase,
evidentemente non è ancora comparso, ma neanche alla condotta, la quale, come
abbiamo appena detto, può essere anche discontinua. Si può concludere, allora,
che il carattere di permanenza o di continuità, non può che investire la parte
successiva a questo momento, e può riferirsi sia all’evento che alla condotta nella
sua seconda fase, sia ad ambedue»354.
Vediamo allora, questa seconda fase della condotta. Sul punto, il Leone, esordisce
dicendo che «permanenza, anche secondo il significato letterale, vuol indicare ciò
che è stabile, che dura. Quello che è stabile, che dura, e che rimane nel reato
351
Leone, G., Del reato abituale, permanente e continuato, Jovene, Napoli, 1933, p. 379.
Può, pertanto, esser una condotta semplice o composta, commissiva od omissiva; « può tanto
esplodere direttamente nella violazione della norma, quanto essere separata da un periodo di tempo
ecc.»
353
Vannini, O., Lineamenti di diritto penale, n. 43, Firenze, casa editrice poligrafica universitaria,
1933, p. 137.
354
Leone, G., Del reato abituale, permanente e continuato, cit. p. 403 ss.
352
151
permanente, è in primo luogo l’evento, cioè, quello stato di compressione del
bene, che la norma prevede. Nel sequestro di persona, ad esempio, dal momento
in cui si verifica la privazione della libertà del soggetto passivo, finché questo non
sia restituito in libertà, dura quella privazione, e perciò, dura l’evento»355. Ed
aggiunge: «che il fatto che l’evento nel reato permanente sia continuativo è
indiscusso. Se, infatti, nell’esempio del sequestro di persona, la vittima riuscisse a
liberarsi, e poi, in un momento successivo fosse di nuovo (anche se
immediatamente dopo la liberazione, anche se l’agente la insegua per la strada e la
riacciuffi), privata della libertà, diremo che esiste un secondo reato, essendosi
interrotta la continuità dell’evento». Secondo il Massari356,inoltre, essa non solo è
continuativa, ma è anche omissiva. Ma allora chiediamoci: davvero, la condotta
nella seconda fase del reato permanente è di natura negativa- omissiva?
Secondo il Vannini, «non è ammissibile una omissione nella seconda fase
esecutiva del reato permanente
perché se il reato è di azione positiva,
corrispondente a quell’azione che è enunciata nel precetto penale, tale deve essere
anche nella seconda fase (…)». Il Ranieri, dal canto suo, affermava che: «l’attività
dell’agente che protrae l’avvenuta consumazione (…) è anch’essa causa non di un
evento diverso, ma dello stesso evento- ed aggiunge che- «essa si risolve in una
persistente condotta attiva, consistente nel protrarre la medesima azione»357. Altri,
semplicemente, dicevano che se permanenza è permanenza nel reato, e se il reato
è di attività diretta, la permanenza non può che essere permanenza di attività
diretta.
Dall’altra parte tra i sostenitori della natura omissiva della condotta nella seconda
fase del reato permanente, si osservava che « col designare come omissiva questa
seconda fase della condotta, non si vuole definire di natura omissiva il reato
permanente: giacché è in rapporto all’evento, che un reato può qualificarsi come
commissivo od omissivo, mentre lo sviluppo positivo o negativo della condotta
criminosa non vale a spostare il punto di qualificazione del reato (…) E poiché qui
l’evento è già in atto, e perdura così come è stato prodotto, appare di evidente
355
Leone, G., Del reato abituale, permanente e continuato, cit. p. 425 ss.
Massari, Il momento esecutivo del reato: contributo alla teoria dell’atto punibile, n. 37, 1923,
Pisa: Mariotti, p. 94- 95.
357
Ranieri, Gli aspetti del reato: il reato come azione, p. 418 ss.
356
152
chiarezza l’affermazione che il reato in questa seconda fase mantiene il carattere
che aveva all’inizio di essa, costituendo un reato commissivo od omissivo,
secondo che l’evento in corso costituisca una modificazione del mondo esterno o,
all’opposto, una mancata modificazione di esso; senza, pertanto, che la natura
omissiva di questa seconda fase della condotta valga a trasformarne il carattere.
Se, invece, il fatto con il quale si avvera il momento iniziale dello stato di
consumazione, ha carattere commissivo, anche il reato permanente dovrà essere
commissivo, quantunque la permanenza sia data da un atteggiamento meramente
negativo. Se quel fatto, invece, è omissivo, omissivo sarà pure il reato
permanente»358.
Il punto che rimane ancora da analizzare è il momento in cui il reato può dirsi
consumato. Evidentemente il reato permanente cessa nel momento in cui il reo
mette fine alla sua condotta volontaria di mantenimento dello stato
antigiuridico359.
Nel nostro ordinamento penale sono previste diverse figure di reato permanente,
tra le quali possiamo ricordare: la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.): il plagio
(art. 603 c.p.); il sequestro di persona (art, 605 c.p.) e, l’indebita limitazione della
libertà personale (art. 607 c.p.).
Si è soliti distinguere, inoltre, tra reati necessariamente permanenti e reati
eventualmente permanenti. Secondo una chiara definizione del Manzini360,alla
costituzione dei primi, «è assolutamente necessaria un’attività antigiuridica,
positiva o negativa, protratta per un tempo più o meno lungo»; mentre, nei
secondi «il fatto preveduto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si
concretano gli elementi costitutivi dell’ipotesi tipica del reato, ma può anche
protrarsi con un’ininterrotta attività positiva o negativa, che in ogni suo momento
riproduce l’ipotesi stessa»361.
358
Leone, G., Del reato abituale, permanente e continuato, cit.. p. 456.
Il Manzini affermava che la consumazione si avvera ma non si esaurisce nel momento in cui si
concretano gli elementi costitutivi del reato, aggiungendo che « essa si protrae fino alla cessazione
dell’attività del delinquente».
Il Massari, dal canto suo, sosteneva che uno dei caratteri distintivi del reato permanente fosse
proprio, « la permanenza nella consumazione del reato (…), ne discende, allora, che il periodo
consumativo di esso, non può che corrispondere alla permanenza stessa: esso, pertanto, cessa,
proprio, col cessare della permanenza stessa.»
360
Manzini, V., Trattato cit., vol. I, n. 233, p. 569- 570.
361
Leone, G., Del reato abituale, permanente e continuato, cit., p. 422 ss.
359
153
Anche per il reato permanente, data la sua particolare e complessa struttura, ai fini
della operatività del ne bis in idem, si pone la questione di determinare cosa si
intenda per “medesimo fatto”. La Cassazione, ha osservato che certamente « è
fuori discussione che costituisca fatto diverso, ai fini della preclusione del
giudicato, quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi dello
stesso reato, rappresenta tuttavia l’ulteriore estrinsecazione dell’attività del
soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo, da quella posta in essere in
precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile (…) »362. Maggiori incertezze
mostra, però, la giurisprudenza nel determinare gli esatti limiti temporali, nel caso
in cui il giudicato abbia per oggetto un reato permanente non ancora cessato.
Secondo un primo indirizzo, ai fini del divieto di un secondo giudizio,
l’individuazione temporale del fatto, quando manchi ogni indicazione relativa alla
sua durata, deve avvenire con riferimento alla pronuncia della sentenza, sia essa di
assoluzione che di condanna363. Stando ad un altro orientamento, l’estensione
degli effetti preclusivi del giudicato alla porzione di condotta anteriore alla
pronuncia di primo grado vale esclusivamente nel caso di sentenza che accerti la
responsabilità dell’imputato; nell’ipotesi di assoluzione, non essendosi verificata
alcuna interruzione della permanenza, il divieto di un secondo giudizio copre
soltanto i fatti verificatisi sino alla data indicata nella contestazione,
indipendentemente dalla data di pronuncia delle sentenza assolutoria364.
Dall’altra parte in dottrina, c’è chi afferma che a fronte del giudicato assolutorio è
ammissibile un nuovo procedimento, salva l’impossibilità di tener conto della
parte di condotta già giudicata al fine di ritenere integrata la permanenza nel
secondo giudizio365. Ma non va neppure trascurata l’opinione di chi come il
Cordero, che identificando, il reato permanente come «una condotta a durata più o
meno lunga, di cui ogni segmento di essa, basti alla consumazione, diceva:
premesso che« il giudicato vale rispetto alla res deducta: chiamiamola, ad
esempio
362
a-b,
è ovvio che l’assolto o condannato sia perseguibile su b-c,
Cass., 13 giugno 1987, Napoli, in CED, Cass. pen., 1989, p.407.
Cass., 4 ottobre 2000, Drago Ferrante, in CED, Cass. pen., 2002, p. 259.
364
Cass., 14 novembre 1997, Maranto, in CED, Cass. pen., 1998, P. 2345.
365
Lozzi, G., Giudicato, in Enc.dir., vol., 1066, Milano, 1991, p. 918- 923.
363
154
altrimenti egli delinquerebbe in piena licenza. Ciò in quanto, si tratta di fatti
diversi (…) Tutto sta nell’individuarne gli estremi»366.
C’era, poi, il Leone, il quale sosteneva che il punto di partenza stesse proprio nella
lettera dell’art. 90 c.p.p. ( oggi, art. 649 c.p.p.). Esso, come più volte detto, limita
l’efficacia del giudicato al fatto esaminato. Ora, su questo« (medesimo) fatto,
evidentemente, non può essere chiamata a pronunciarsi di nuovo l’autorità
giudiziaria. Ma, aggiungeva, allo stesso tempo che, «tutto ciò che appartiene a un
momento posteriore al fatto giudicato è fuori della sfera di efficacia della res
iudicata: non può il giudicato precedente statuire per il futuro (…) Si verrebbe,
altrimenti, a porre colui che è stato una volta condannato per un reato permanente,
nelle condizioni di continuare impunemente nella sua condotta antigiuridica fino a
quando, venendo privato della libertà non si interrompa naturalmente l’azione
antigiuridica. Il giudicato, avrebbe in tal caso un effetto negativo, o meglio, un
contenuto autorizzativo. E, ciò non è assolutamente pensabile, non soltanto
rispetto alle norme di legge, ma anche ai principi generali del diritto. E aggiungeche rispetto a questo, non regge neanche l’obiezione di chi affermava che il reato
è unico e che pertanto, un secondo giudizio violerebbe la massima del ne bis in
idem. Quanto, affermava dunque, il Leone, è accettabile purché si ritenga il reato
permanente scindibile in tante porzioni, ciascuna delle quali, caratterizzata da una
propria condotta. Il principio dell’unicità del fatto nel reato permanente, infatti,
condurrebbe ad una soluzione insostenibile, portando ad una sorta di presunzione
di impunità, ove- ad esempio- il proscioglimento irrevocabile, non valendo come
interruzione, consentisse di assorbire atti posteriori. Ciò, non può essere in alcun
verso plausibile!
Nei delitti associativi, per esempio, «l’effetto interruttivo della permanenza del
reato deve ricollegarsi alla sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la
responsabilità dell’imputato, da ciò consegue che la porzione della condotta
illecita successiva a detta pronuncia, pur non ontologicamente distinguibile dalla
precedente, rimane perseguibile a titolo di reato autonomo. Qualora, viceversa, sia
stata pronunciata assoluzione, non può ritenersi operante in virtù di tale sentenza
alcun effetto interruttivo della permanenza della condotta criminosa proprio
366
Cordero, F., Procedura penale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 2006, p. 1219 ss.
155
perché è carente l’accertamento di un reato, da ciò conseguendo esclusivamente la
preclusione del giudicato di cui all’art. 649 c.p.p.; in tale ipotesi, pertanto, il
divieto di un secondo giudizio vale soltanto per i fatti verificatisi fino alla data
indicata nella contestazione, indipendentemente dalla data di pronuncia delle
sentenza assolutoria»367.
Si deve, pertanto, affermare che la sentenza di condanna per una figura di reato
permanente vale ad interrompere la permanenza del reato. Il problema a questo
punto, è accertare quale sentenza abbia siffatta efficacia; quella di condanna di
primo grado o quella irrevocabile. La dottrina è sul punto divisa.
Il Manzini, per esempio, riteneva che solo la sentenza irrevocabile avesse tale
efficacia, giacché «la semplice condanna non irrevocabile, senza che fosse
intervenuto alcun atto coercitivo che fosse tale da interrompere necessariamente il
fatto della permanenza, non sarebbe sufficiente a sciogliere l’unità del reato,
perché l’applicazione della norma penale non è definitiva, ed è incerto se lo
diventerà»368. E, prima di lui, c’era stato chi, all’opposto, aveva fermamente
sostenuto che già «la permanenza posteriore alla sentenza di primo grado avrebbe
potuto dar luogo a nuovo giudizio e a nuova condanna»369. A tale teoria aderì la
Cassazione, con una sentenza del 19 febbraio 1932, nella quale si osservò che «la
sentenza penale, anche se ancora sottoposta a gravame, ha di per sé l’efficacia di
scindere, indipendentemente da una querela ad essa posteriore, la permanenza,
perché è sempre una sentenza di condanna, che, accertando sia pure in modo non
irrevocabile, fino a quando non sia da altra sentenza riformata, la responsabilità,
costituisce un provvedimento pienamente idoneo a far desistere dalla
commissione di altra azione, identica a quella cui la sentenza si riferisce, essendo
inerente ad ogni sentenza di condanna penale di prevenire, col fatto stesso
dell’accertamento della responsabilità». Nonostante ciò, in giurisprudenza si è
sempre continuato a discutere circa il c.d. “effetto interruttivo”: ossia il momento
a partire dal quale, l’eventuale seguito del fatto costituisse fatto diverso. Essa, a
volte si è espressa nel senso di affermare che il nuovo corso del fatto, cominci
367
Cass., 14 novembre 1997, Maranto, in CED. Cass. pen., 1998, p. 2345.
Manzini, V., Trattato di diritto penale, vol. I, n. 233, p. 571.
369
Escobedo, Querela ed imputazione in rapporto ai reati permanenti, in La procedura penale
italiana, 1921, coll. 200 ss.
368
156
dalla condanna in primo grado370, altre volte lo ha fatto risalire alla sentenza
irrevocabile371.
Punto indiscusso, anche per la Cassazione, è tuttavia, che il
secondo giudizio non potrebbe comunque mai prendere in considerazione
nuovamente il comportamento illecito già diventato res iudicata372.
Per quanto riguarda la sentenza di proscioglimento, non ci sono molti rilievi da
fare. Va solo osservato che laddove una sentenza abbia assolto, negando il reato al
fatto imputato, nessun motivo giuridico, può ostacolare un nuovo giudizio ed una
eventuale condanna nel caso che l’individuo precedentemente assolto permanga in
tale condotta. Se, infine- aggiungeva- il proscioglimento, è stato pronunciato per
una causa soggettiva (mancanza dell’elemento volontario; mancanza del dolo; non
imputabilità o non punibilità; sussistenza di cause di esclusione del reato ecc.)
nessun motivo potrà interdire un nuovo giudizio per la successiva permanenza con
la conclusione di una condanna, qualora venga a mancare la causa che determinò
il precedente proscioglimento»373.
Anche la Cassazione, ha affermato che la sentenza di assoluzione della prima
contestazione non vincola il successivo giudizio ameno che, la decisione di
proscioglimento travolga la materialità del reato: nei casi in cui invece il fatto non
costituisce reato per cause oggettive o comunque inerenti all’imputato la
preclusione non sarebbe applicabile in quanto «nel segmento di condotta
posteriore alla sentenza, tali ipotesi potrebbero essere venute meno»374.
7. Il reato continuato.
Il reato continuato rappresenta una particolare ipotesi di concorso materiale
trattato specificamente dal legislatore nell’art. 81, co. 1º c.p.
Si ha reato
continuato, quando con più azioni od omissioni esecutive di uno stesso disegno
criminoso, un medesimo soggetto commetta, anche in tempi diversi, più
violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità (art. 81, 1
370
Cass., 8 giugno 1983, in Giust. pen., 1984, III, c. 77; Cass., Sez., III, 15 febbraio 1969, in Mass.
Uff., n. 113839; Cass., Sez., III, 29 dicembre 1980, ivi, n. 148902.
371
Cass., 26 marzo 1973, in CED, Cass. pen., 1975, p. 430, 498; Cass., Sez., VI, 7 dicenbre 1973,
in Mass. Uff., n. 127470.
372
Cass., Sez., III, 13 luglio 1984, ivi, n. 166486.
373
Leone, G., Del reato abituale, permanente e continuato, Napoli, Jovene, 1933, p. 562.
374
Cass., Sez., I, 4 luglio 1987, in Mass. Uff., n. 173873.
157
c.p.). In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo375.
L’istituto della continuazione, altro non è che una finctio iuris, per la quale più
reati concorrenti vengono considerati come un solo reato, e ciò, si è detto, al fine
di attenuare il rigore materiale del cumulo delle pene. Ciò è vero, tant’è che il d.l.
11 aprile 1974, nell’innovare la disciplina del reato continuato, ha ricalcato
proprio la logica del favor rei: si è aggiunta, infatti, all’ipotesi tradizionale della
violazione della stessa disposizione di legge, quella concernente la violazione di
diverse disposizioni di legge. Ciò vuol dire che il giudice nell’applicare l’aumento
della pena- base fino al triplo, non potrà mai infliggere una pena in misura uguale
o superiore a quella che sarebbe stata applicata attraverso il cumulo materiale376.
È possibile ricavare dalla stessa definizione che il legislatore ci dà del reato
continuato, i suoi elementi costitutivi. Questi sono: 1) più azioni od omissioni
esecutive, commesse anche in tempi diversi; 2) più violazioni della stessa
disposizione di legge, anche se di diversa gravità; 3) identità del disegno
criminoso.
Si è osservato, ai fini della configurabilità della continuazione dei reati, che
venuto meno con la riforma del 1974, il requisito della omogeneità delle
violazioni, l’identità del disegno criminoso, ha acquistato sempre più rilevanza.
L’unicità del disegno criminoso- si è detto- può essere riconosciuto anche tra reati
non omogenei, e ciò perché,
«la continuazione dei reati ha fondamento
prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati
375
Ciò rappresenta una deroga al concorso materiale di reati, consistente proprio nel doversi
considerare, in quest’ipotesi, più violazioni, invece che come altrettanti reati, reato unico. Si è
detto, infatti: « la differenza tra reato continuato e reato che tale non è, anche se formato da una
pluralità di azioni, sta proprio nel fatto che mentre nel reato unitario l’obiettivo del soggetto è
unico, anche se l’azione si articola in una pluralità di momenti successivi, nel reato continuato
invece, vi è una pluralità di obiettivi tenuti assieme da un unico progetto o disegno criminoso».
Crespi- Forti- Zuccalà, Commentario breve al codice penale, CEDAM, 1999, p. 376.
376
Si è anche osservato che il reato continuato, comprendendo oggi, anche l’ipotesi di violazione
di diverse disposizioni di legge, lungi dall’essere un reato unico, costituisce, in verità, la risultante
di più reati aventi distinta autonomia e unificati, solo per determinati effetti giuridici, da
quall’elemento ideativo comune, che è l’identità del disegno criminoso. « L’unificazione può,
infatti, operare soltanto se sussiste il requisito della unicità del disegno criminoso, per aversi il
quale è necessario che le singole violazioni di legge siano parte integrante di un unico programma
predeterminato nelle sue linee fondamentali e diretto ad un determinato fine». (Cass., Sez. I,
80/145389).
158
dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall’unicità dello scopo che
l’agente si è prefissato, il quale è rinvenibile anche nel contesto logico- temporale
di commissione dei reati»377.
Ma cosa si intende, effettivamente, per identità di disegno criminoso?
Oggi si è sempre più orientati a considerarlo in senso soggettivo, ossia come
ideazione, o, volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma
complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni, di volta in
volta commesse con singole determinazioni sul piano volitivo. Ciò, esige che lo
scopo sia sufficientemente specifico; che la rappresentazione dell’agente
ricomprenda tutta la serie degli illeciti, che si inquadrano nel programma,
concepito nelle sue linee generali ed essenziali, sicché una divergenza essenziale
escluderebbe l’illecito o gli illeciti dal disegno criminoso e quindi dalla
continuazione. Ed infine, occorre che il programma criminoso sia prefigurato fin
dalla consumazione del primo reato378. Ai fini della configurabilità del reato
continuato occorre, dunque, la prova certa che le singole violazioni furono tutte
deliberate e volute, almeno a grandi linee, ma pur sempre con una precisa
definizione dei contorni e delle circostanze operative, fin dal momento in cui
l’agente decise di dare inizio alla sua attività illecita, programmandone durata,
portata ed esecuzione; delineandosi, in questo modo, quando tale condizione
ricorra, una figura criminosa nuova- connotata dalla unicità dell’elemento
soggettivo e della pluralità di quello oggettivo379.
Sicuramente, «l’accentuazione del ruolo del medesimo disegno criminoso
(avvenuta principalmente con la riforma del 1974),
soggettivo- psichico, ha ridotto anche
377
378
nonché il suo carattere
l’importanza dell’elemento oggettivo,
Cass., Sez., I, 06/234018.
Crespi- Forti- Zuccalà, Reato continuato, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 376
ss.
379
Tuttavia, una giurisprudenza meno rigorosa, ha ritenuto non « necessaria la predeterminazione,
fin dal primo momento, di ciascuna azione facente parte della condotta criminosa con altrettanto
dettagliata programmazione delle modalità delle azioni criminose nel loro graduale susseguirsi, ha
invece, ritenuto che fosse sufficiente una generica programmazione dei crimini aventi tutti finalità
di raggiungimento dello scopo propostosi dall’agente. È, dunque, sufficiente l’accertamento della
serie di reati come facenti parte di un unico programma delinquenziale, anche se le singole
fattispecie concrete possono costituire, di tale programma, aspetto esecutivo soltanto eventuale; sì
che può ben ritenersi sussistere il reato continuato ove risulti accertato che nel programma di
azione preventivamente ideato, alcuni episodi siano stati previsti soltanto come eventuali e legati
allo svolgimento dei fatti così come si sarebbero potuti verificare». (Cass., Sez. I, 86/172350).
159
costituito dal requisito cronologico, ossia dalla vicinanza o dalla lontananza sul
piano temporale dei diversi illeciti»380. Poiché, infatti, non può escludersi, in linea
generale, che una persona si proponga di commettere due o più reati anche a
distanza di tempo, il solo dato cronologico relativo all’intervallo tra le diverse
violazioni, non è da solo sufficiente ad escludere la sussistenza del nesso della
continuazione; ne consegue, pertanto, che l’unicità del disegno criminoso può
ravvisarsi anche nella commissione di fatti tra loro differenziati nel tempo. A ciò,
è stato però aggiunto che se è vero che esso (l’unicità del disegno criminoso) non
può fondarsi soltanto sulla base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso
tra i vari episodi criminosi381, senza dubbio, potrà, comunque, essere considerato
come principio di prova positiva382. (…) Al contrario, la lontananza temporale tra
i reati di per sé costituisce oggettivamente un indizio negativo nella direzione di
ritenere sussistere il vincolo della continuazione, per la regola di esperienza che
connota psicologicamente la condotta umana, improntata di norma all’azione o
omissione come conseguenza immediata dell’ideazione e volizione (…) Dunque,
in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni
tanto
più
deve
ritenersi
improbabile
una
programmazione
unitaria
e
predeterminata almeno nelle linee fondamentali»383.
A ciò, si è inoltre, aggiunto che «l’identità del disegno criminoso, va comunque
negata qualora, malgrado la continuazione spazio- temporale e il nesso funzionale
riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi
sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo
invece in risalto l’occasionalità di uno dei due»384. L’accertamento che il giudice,
380
Cass., Sez., I, 91/187740.
Cass., Sez., 22 gennaio 1992, Fichiera, in CED, Cass., n. 189350; Cass., 11 maggio 1992,
Morotti, ivi, n. 190530; Cass., 10 ottobre 1996, Talarico, ivi, n. 205972; Cass., Sez., VI, 6 febbraio
2009, n. 5205, ivi, n. 242476.
382
« E’ evidente – si diceva- che il breve lasso di tempo tra la consumazione di due fatti criminosi
può costituire il principio di prova indiretta della esistenza del medesimo disegno criminoso,
disegno che poi va accertato sulla base degli altri indizi».
383
Cass., 24 gennaio 1994, Basile, in CED, n. 196677; Cass., 28 maggio 1999, Paoletti, ivi, n.
184909; Cass., 11 dicembre 1991, Moro, ivi, n. 189289; Cass., Sez., I, 27 gennaio 2009, n. 3747,
ivi, n. 245337.
384
Cass., Sez., VI, 24 maggio 2007, n. 358005, in CED, Cass., n. 237643.
«Siffatta occasionalità si riscontra ogni qual volta che il reato successivo venga commesso per
l’insorgenza di fattori del tutto estranei, per loro natura all’originario disegno criminoso. La
Cassazione, ha peraltro, aggiunto che, non rientrano «tra gli indici rilevatori dell’identità del
disegno criminoso, oltre che alla distanza cronologica tra i fatti, anche le modalità della condotta,
381
160
chiamato a deliberare su una istanza di applicazione della disciplina della
continuazione, deve, in sostanza, concentrarsi su tre essenziali problemi: ossia,
deve «dapprima verificare la credibilità intrinseca sotto il profilo della logica e
della congruità, dell’asserita esistenza di un unico, originario programma
delittuoso, indi, analizzare i singoli comportamenti incriminanti per individuare le
particolari specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente; infine verificare
se i detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le
circostanze in cui si sono manifestati, per lo spirito che gli ha informati, per le
finalità che gli ha contraddistinti, possono considerarsi, valutata anche la natura
dei beni aggrediti, come l’esecuzione diluita nel tempo, del prospettato, originario
unico disegno criminoso»385. Ai fini del riconoscimento della continuazione, poi,
costituisce in sede di giudizio di cognizione, un vero e proprio onere della prova a
carico dell’imputato, l’allegazione degli specifici elementi dai quali è desumibile
l’unicità del disegno criminoso: l’imputato che chiede l’applicazione della
continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con
sentenza irrevocabile di condanna ha l’onere di esibire copia della decisione
emessa o, almeno di fornire i dati necessari per la relativa acquisizione. In caso di
inosservanza di tale onere potrà far valere la sua istanza in sede di esecuzione.
Tuttavia, il riconoscimento da parte del giudice di merito, del nesso della
continuazione tra i vari reati può e deve aver luogo anche e soltanto per iniziativa
del giudice, senza cioè, che sia necessaria apposita e specifica deduzione
difensiva, richiedendosi eventualmente all’imputato la semplice allegazione a
prospettare la sua sussistenza386.
Va, inoltre, aggiunto che l’istituto della continuazione, non può sussistere per i
reati colposi, in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene ad un momento
psicologico (dolo) che, chiaramente, non può sussistere per questi reati, nei quali
l’evento non è voluto, è “contro l’intenzione” ( art. 43 c.p.: è colposo,o contro
l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente (…)
la sistematicità e le abitudini programmate di vita, le tipologie dei reati, il bene protetto,
l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e luogo. Per aversi unità di
disegno criminoso è necessario e sufficiente che quando si commette il primo reato, sussista già la
volontà di commetterne altri». (Cass., Sez. II, 95/204716).
385
Cass., Sez., I, 92/190807.
386
Crespi- Forti- Zuccalà, Reato continuato, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 376
ss.
161
Non si esclude, però, che l’unicità del disegno criminoso possa essere collegata
alla natura contravvenzionale di alcuni reati (ovviamente, sempre che siano posti
in essere con dolo). Essa, andrà «desunta da elementi presuntivi e di natura
indiziaria, tenendo conto delle modalità della condotta, della sistematicità e delle
abitudini programmate di vita, della tipologia del reato, del bene protetto,
dell’omogeneità o non dei reati, delle condizioni di tempo e spazio, della brevità
dell’intervallo cronologico (…)»387.
Il problema principale che si pone relativamente all’operatività del ne bis in idem
in rapporto al reato continuato è questo: cosa succede, se dopo una sentenza di
condanna pronunziata nei confronti di una persona ritenuta colpevole di aver
violato più volte la stessa disposizione di legge in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, vengano scoperte altre infrazioni della stessa disposizione di
legge, commesse dall’identico autore ancor prima della sentenza e, sempre in
esecuzione di quello stesso disegno criminoso (del quale erano espressione anche
quelle altre violazioni precedentemente accertate e per le quali l’autore era stato
già giudicato)? Dovranno, queste, esser considerate assorbite nella precedente
sentenza oppure dovrà, l’autore essere sottoposto ad un nuovo e autonomo
procedimento? E, accertata questa seconda alternativa, l’imputato, già una volta
condannato, sarà giudicato come se la nuova serie criminosa fosse del tutto
indipendente dalla precedente e perciò condannato ad una nuova ed autonoma
pena (sia pure nei limiti di cui agli artt. 71 e ss. (richiamati dall’art. 81 c.p.)?
Ritengo, che prima di rispondere a queste domande, occorra ancora trattare due
ulteriori questioni di diritto sostanziale: 1) innanzitutto, bisogna domandarsi se il
reato continuato vada considerato quale reato unico, oppure, al contrario, che le
singole violazioni di legge che lo caratterizzano, conservino una propria
autonomia; 2) e, in secondo luogo, laddove dovesse prevalere quest’ultima
ipotesi, bisogna individuare quale sia stata la ratio che ha ispirato il legislatore,
nel prevedere mediante la previsione del reato continuato, una deroga alla
disciplina del concorso di reati.
Il primo punto, è stato ed è indubbiamente molto dibattuto sia in dottrina che in
giurisprudenza. Evidentemente, la questione ha rilevanza non tanto su di un piano
387
Cass., Sez., I, 5 novembre 2008, n. 4486, in CED, Cass., n. 242098.
162
meramente teorico, in quanto, l’adesione all’una o all’altra, comporta rilevanti
conseguenze, più che altro, sul piano pratico. Secondo l’opinione prevalente, i
reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi come un unico
reato, e ciò, innanzitutto ai fini dell’applicazione della pena principale. Il regime
sanzionatorio è infatti unitario essendo, i diversi reati, commessi in esecuzione di
un medesimo disegno criminoso. Essi sono infatti assoggettati ad un’unica pena,
determinata in base all’istituto del cumulo giuridico, ossia irrogando la pena
prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Si tratta più che altro
di una unità fittizia, che vale limitatamente, rispetto determinati effetti, come ad
esempio ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena388.
Si ritiene, inoltre, che il reato continuato sia unico anche ai fini della dichiarazione
di abitualità o di professionalità del reato. Al di fuori di questi limitati istituti, i
reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso conservano la
loro autonomia: si considerano cioè come reati distinti. Ciò, vale ad es., ai fini
della applicabilità della amnistia impropria o indulto, che andranno verificati in
relazione a ciascun singolo reato389.
Le Sezioni Unite, hanno di recente affermato che l’unitarietà del reato continuato
deve affermarsi solamente ove vi sia un’apposita disposizione normativa in tal
senso o, dove la soluzione unitaria garantisca una soluzione più favorevole al reo,
non dovendo dimenticare che il trattamento maggiormente favorevole per il reo è
alla base della ratio del reato continuato390. Non esiste, dunque, secondo le
Sezioni Unite, una struttura unitaria da assumere come punto di partenza di rilievo
generale. Ne deriva che al di fuori di queste ipotesi, non vi è alcuna unitarietà di
388
Secondo una costante giurisprudenza, può essere concessa – entro i limiti di legge- anche chi è
stato condannato per più reati uniti dal vincolo della continuazione, con un’unica sentenza o con
sentenze separate, atteso che, in tal caso, la pluralità di sentenze è ammissibile a una condanna
unica. Cass., 13 novembre 2000, Panebianco, in CED, Cass., n. 217889
389
La giurisprudenza si è espressa nel senso di dire che ai fini della applicabilità dell’amnistia, è
giuridicamente possibile la scissione del reato continuato nelle sue singoli componenti, qualora
l’unificazione si risolva non in un beneficio, ma in un danno per il condannato, incompatibile con
l’esigenza del favor rei connessa, alla quale si ispira l’istituto previsto dall’art. 81 c.p. (Cass., 3
luglio 1998, Luparelli, in CED, Cass., n. 211426). E, lo stesso è stato previsto per l’indulto, per cui
il reato continuato deve essere scisso nei reati che lo compongono e nei vari episodi che attengono
a ciascuno dei reati in continuazione, con la conseguente possibilità di applicazione del beneficio
ai reati o agli episodi rientranti nel limite temporale di applicazione dell’indulto. (Cass., Sez., I, 16
marzo 2005, n. 18740, in CED, Cass., n. 231768). E, anche ai fini della prescrizione del reato, il
relativo termine andrà computato con riferimento a ciascun singolo reato commesso in esecuzione
di un medesimo disegno criminoso.
390
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2008, n. 3286, Chiodi, in CED, Cass., n. 241755.
163
cui tener conto e di conseguenza, vige e opera la considerazione della pluralità dei
reati nella loro autonomia e distinzione. La suddetta soluzione è stata, peraltro,
confermata anche dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 115 del
1987 ha rilevato che, «dopo la riforma del 1974, con la quale era stata modificata
la formulazione originaria dell’art. 81 c.p., estendendosi il trattamento
sanzionatorio previsto per l’ipotesi di reato continuato anche all’ipotesi di
violazione di disposizioni di leggi diverse, con l’introduzione di una nozione
eterogenea di reato continuato, non conserva più importanza il problema della
unità reale o fittizia dei reati»391
Premesso questo, dobbiamo ora, rispondere alla seconda domanda; ossia, occorre
indagare quale sia stata la ratio, che ha ispirato il legislatore nel prevedere la
figura del reato continuato. Secondo la giurisprudenza, la deroga al regime del
cumulo materiale delle pene è stata prevista dal legislatore per il reato continuato
in considerazione della minore pericolosità del reo, che si renda responsabile di
reati, non distinti tra di loro, ma sorretti da un vincolo unitario392. Si ritiene, cioè,
che quando una pluralità di reati sia manifestazione di un unico programma, il
comportamento del soggetto è meno grave, essendo stato unico l’impulso
criminoso del soggetto393. Dunque, osserva la Cassazione «che la ratio della più
mite disciplina sanzionatoria del reato continuato sta nell’apprezzamento del
minor disvalore sociale che connota più reati che non scaturiscono da altrettanti
diversi progetti, ma conseguono invece a un’unica determinazione criminosa, che
abbia informato di sé tutti i singoli e diversi reati posti in essere in tempi
diversi»394.
Concentriamoci allora, sull’oggetto principale del nostro esame. Evidentemente,
non crea alcun problema il caso in cui una persona commetta, in tempi diversi, più
violazioni della stessa disposizione di legge con più azioni od omissioni, esecutive
391
Anche la giurisprudenza era dello stesso avviso: « la riforma del 1974 ha fatto perdere quella
caratteristica essenziale del reato continuato, data dalla omogeneità delle violazioni, che costituiva
l’originaria condizione per la riconducibilità ad un unico reato delle plurime condotte illecite
sorrette dall’identità del disegno criminoso». Peraltro, si notava come la stessa riforma avesse
soppresso l’inciso «le diverse violazioni si considerano come un solo reato».
392
Cass., Sez., IV, 11 febbraio 2009, n. 14432.
393
Mantovani, F., Diritto penale, Parte generale, CEDAM, 2007, p. 478; Findaca- Musco, Diritto
penale, Parte generale, 2007, p. 655; Ramponi, R., Nuovi profili del reato continuato, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1978, p. 604 ss..
394
Cass., 27 novembre 1996, Scalese, in CED, Cass., n. 206607.
164
di
un
medesimo
disegno
criminoso,
le
quali
siano
tutte
scoperte
contemporaneamente. Questa ipotesi, infatti, rientra senza dubbio, nell’ambito di
applicazione degli ultimi due commi dell’art. 81 c.p.
Le cose, però, cominciano a complicarsi se passiamo a quest’altra ipotesi: una
persona, con più azioni od omissioni, svolte in tempi diversi ed in esecuzione di
un medesimo disegno criminoso commette più violazioni della stessa disposizione
di legge. Ma soltanto alcune di queste vengono scoperte, e soltanto per queste
l’autore viene condannato e, la sentenza passa in giudicato. Ma che cosa succede
se successivamente vengono scoperti ulteriori fatti legati da un vincolo di
continuazione a quelli su cui era già intervenuto in precedenza il giudicato395?
Come opera in questi casi la regola del ne bis in idem?
Si è rilevato in passato, che occorre considerare quale punto fermo che i singoli
fatti debbano essere commessi anteriormente a qualsiasi atto processuale,
iniziatore o prosecutore dell’azione penale, di cui il reo abbia avuto conoscenza396
in quanto, si riteneva che la conoscenza che il reo avesse dell’inizio o della
esistenza a suo carico di un procedimento penale per i fatti precedentemenete
commessi, fosse sufficiente ad interrompere la persistenza del disegno criminoso
iniziale. La giurisprudenza, più recente, è tuttavia, maggiormente orientata nel
ritenere che nessun atto processuale, né la denunzia, né la contestazione del reato,
né l’arresto e neppure la sentenza non definitiva di condanna, possa essere
considerato come interruttivo del disegno criminoso dell’agente e ostacolare il
riconoscimento alla continuazione397. Ed è anche prevalente, in giurisprudenza,
l’orientamento per cui, in tema di interruzione del nesso di continuazione,
l’intenzione del reo di eseguire l’originario programma criminoso, non può essere
influenzato da alcun elemento del tutto formale, qual è quello del passaggio in
giudicato di una sentenza, che è indipendente dal comportamento del reo e
soprattutto dalle caratterizzazioni soggettive delle azioni da lui poste in essere. Si
395
Sul punto, Giovanni Leone, fa una precisazione. Egli dice: nonostante, « normalmente si parla
di reati “scoperti” dopo il giudicato e derivanti dal medesimo disegno criminoso (…), tuttavia,
pare più opportuno parlare di “fatti venuti a giudizio” dopo la condanna irrevocabile per reato
singolo o continuato: giacché deve guardarsi al rapporto tra il momento in cui si giudicano questi
altri fatti di continuazione ed il giudicato senza che il problema muti di aspetto». Leone, G., Del
reato abituale, permanente e continuato, cit., p. 538 ss.
396
Manzini, V., Trattato di diritto penale, vol. II, N. 495, P. 564.
397
Cass., 2 febbraio 1993, Grassa, in CED, Cass., n. 193303; Cass., 12 febbraio 1999, Ciancio, ivi,
n. 212605; Cass., Sez., IV, 6 marzo 2007, n. 20169, ivi, n. 236611.
165
ritiene, piuttosto, che l’interruzione del disegno criminoso, vada accertata in
concreto dal giudice, caso per caso, essendo ben possibile che il predetto disegno
criminoso permanga, o, addirittura venga rafforzato e continui ad essere
realizzato, pur durante lo stato di detenzione o dopo una sentenza diventata
irrevocabile di condanna per taluno dei reati che di quel disegno criminoso sono
realizzazione398.
Analogamente, in dottrina, si tende ad escludere l’efficacia interruttiva della
sentenza definitiva, sostenendo che l’interruzione è un fenomeno psicologico che
va sempre provato in concreto.
In dottrina399, l’opinione dominante è quella che vede respingere l’efficacia
preclusiva del giudicato sui fatti posteriormente venuti a giudizio, mantenendo,
però, fermo il giudicato medesimo per i fatti che ne formano oggetto. Si è giunti
perciò, alla seguente conclusione. a) nel caso che i fatti di continuazione siano
giudicati posteriormente ad un giudicato cadente su un reato unico, «la prima
condanna conserva tutta la sua autorità di cosa giudicata, ed anzi serve di base alla
seconda, che ne accoglie il dispositivo, modificando soltanto la pena in
conseguenza del reato o dei reati che prima non furono giudicati»; b) nel caso che
il giudicato precedente ebbe per oggetto un reato continuato « i reati
posteriormente scoperti… devono esercitare il loro effetto sulla responsabilità del
colpevole, applicando per essi la pena per il reato più grave, aumentata fino al
triplo». In entrambi i casi, comunque, è necessario che il giudice accerti che quei
fatti venuti a sua cognizione si rapportino al medesimo disegno criminoso, da cui
derivò il fatto (o i fatti) caduto sotto il precedente giudicato: nel caso che questa
indagine risulti negativa, il giudizio attuale non avrà alcun legame col precedente
giudicato. Chiaramente, la discrezionalità del secondo giudice è limitata solo
all’aumento di pena,:non potendo egli, in alcun modo, riprendere in
considerazione la pena comminata per il precedente reato nell’ipotesi sub a), o la
pena- base nell’ipotesi sub b). Per variare, infatti, la pena precedente o la penabase, rispettivamente nei due casi sopra esaminati, occorrerebbe riesaminare il
398
Cass., 2 dicembre 1993, Parenti, in CED, Cass., n. 196527, Cass., 24 maggio 1994,
Buonconsiglio, ivi, n. 196678; Cass., 26 febbraio 1995, Del Moro, ivi, n. 210196; Cass., Sez., VI,
12 marzo 2004, n. 23031, 229917.
399
Manzini, V., Trattato di diritto penale, vol. II, n. 495, p. 564 ss.
166
fatto per il quale è stata comminata la detta pena: un tale riesame costituirebbe,
evidentemente, una manifesta violazione del ne bis in idem. Il problema come si
può ben capire, si pone, anche sotto quest’altro profilo. Fin dai primi tempi di vita
del codice penale del 1889, buona parte della giurisprudenza riteneva che «ove
contro taluno, posteriormente ad una sentenza di condanna passata in giudicato
per un dato reato, si proceda per un altro fatto costituente il medesimo reato,
commesso prima di detta sentenza, si doveva infliggere per tale fatto una novella
pena, tale da cumulare con la precedente secondo le norme ordinarie del concorso
di reati e di pene400. Questa tesi postula che il reato continuato sia in sé una
pluralità di reati, che però, ai fini della pena viene considerato un reato solo, ma
che riacquista l’intera propria fisionomia e produce quindi le conseguenze tipiche
della pluralità di reati, quando interviene un qualche fatto giudicato, idoneo a
rompere tale unità. Unità che pertanto, appare soltanto fittizia. I punti deboli di
questa soluzione erano, tuttavia, facilmente individuabili. Era agevole osservare,
infatti, che il reo, in questo modo, sarebbe stato condannato tante volte e con tante
pene autonome per quanti processi avesse subito, e col rischio di ricevere una
sanzione assai più grave di quella che avrebbe subito nel caso di un solo giudizio.
A queste prime considerazioni, si aggiungeva che se, è vero, che il reato è unico:
un fatto unico non può essere dedotto in giudizio più di una volta (…) Varrebbe
insomma anche per il reato continuato il principio del ne bis in idem: perciò, una
volta giudicato l’imputato quale responsabile di un reato continuato per avere
commesso un cero numero di violazioni della medesima disposizione con più
azioni od omissioni, a nulla varrebbe rileverebbe il fatto che dopo il passaggio in
giudicato della sentenza si sia scoperto che lo stesso imputato aveva commesso
altre infrazioni della stessa disposizione sempre in esecuzione di quell’unica
risoluzione criminosa,»401, il giudice, dovrà semplicemente pronunziare sentenza
con cui dichiara che non si deve procedere contro l’imputato perché l’azione
penale non può essere esercitata.
400
Cass. pen., 7 febbraio 1923, Trazzi, in Riv. pen., diretta da L. Lucchini, vol. XCVIII, Roma, p.
144.
401
Sabatini, G., Il reato continuato, p. 229; Aloisi, Manuale pratico di procedura penale, Milano,
1932, p. 553 ss.
167
Tuttavia, di fronte al silenzio della legge, l’interprete si è spinto a cercare varie
soluzioni.
Uno dei tentativi più complessi in tema di rapporti tra reato continuato e cosa
giudicata, è quello che viene sinteticamente individuato con la formula giudizio
suppletivo. Sotto il governo del codice del 1889 esso vanta tra i suoi fautori,
l’Impallomeni e l’Alimena. Secondo il primo, nel caso di pluralità di reati
commessi da un solo autore non esistono tante responsabilità per quanti sono i
reati, ma una sola responsabilità; e, l’unità o la pluralità dei reati doveva essere
risolto in funzione della dell’unità o pluralità delle determinazioni criminose402.
Ma allora, se ne deduce, data l’unità del reato continuato, che si dovrebbe avere
un’unica sentenza e che la pena inflitta dovrebbe scaturire da un unico globale
apprezzamento della situazione, da una valutazione contestuale di tutti gli episodi:
attraverso un giudizio unico. Perciò, quando da un reato fossero rimasti fuori
alcuni fatti, non è esatto demandare al secondo giudice il compito di «esaminare
la successiva azione punibile in confronto con quella precedentemente giudicata e
infliggere quel di più di penalità che avrebbe meritato l’unico reato continuato, se
in tutti i suoi elementi si fosse presentato prima del giudizio»403, ma, «gli si
sarebbe dovuto riconoscere il potere di rivedere globalmente tutti i fatti, perché
soltanto in questo modo sarebbe stato possibile formulare una sanzione veramente
adeguata alla colpevolezza del soggetto»404. Il secondo giudice avrebbe, insomma,
dovuto avere piena libertà nel determinare la pena unica per tutta la situazione di
continuazione: una pena, cioè, che si riferisse tanto ai nuovi fatti, quanto a quelli
già giudicati, e non un semplice aumento di pena per gli episodi nuovi, così come
volevano i fautori del giudizio suppletivo. Ma rispetto questo, si obiettava, che in
questo modo veniva ad essere sacrificato chiaramente il principio della
intangibilità del giudicato; e la risposta che prevalentemente veniva data a tale
obiezione è che: «se è vero che il reato continuato è un reato unico, è anche vero
che non si poteva lasciare impuniti quei nuovi fatti scoperti successivamente al
giudicato. In ogni caso, il «precedente giudicato non veniva toccato, né distrutto.
402
Impallomeni, Concorrenza reale e concorrenza formale di reati, in Istituzioni di diritto penale,
Torino, UTET, 1921, p. 7 ss.
403
Impallomeni, Il codice penale illustrato, col. I, Firenze, Civelli, 1890, p. 279.
404
Gregoraci, Delle regole della continuazione se i vari reati che lo compongono vengono
giudicati separatamente, in Riv. pen., XCIX, 1924, p. 81.
168
(…) anzi, lo si rispettava, prendendolo come elemento integratore di una unità
giuridica di cui gli altri elementi vengono dal secondo giudice riconosciuti e
dichiarati (…) la prima sentenza perciò non sarebbe stata posta nel nulla, ma
“assorbita” dalla seconda»405. Nello stesso senso, l’Alimena scriveva: «la
costatazione dei fatti nuovi scoperti non viola la cosa giudicata, anzi la ribadisce.
Dire che oggi si scopre un fatto, il quale è avvinto al fatto conosciuto ieri, non
significa distruggere questo, significa, invece, riconoscerlo, mentre all’opposto,
non si comprende come il fatto conosciuto ieri debba distruggere quello
conosciuto oggi. Né si dica che, essendo il reato continuato un reato unico, esso
sia sempre quello che è, anche senza tenere conto dei fatti successivamente
scoperti, poiché si risponde che l’unità del reato non esclude la valutazione della
diversa insistenza nella risoluzione e della maggiore entità materiale del fatto»406.
È facile però, individuarne le contraddizioni e le incoerenze anche di questa
soluzione. Il Delitala, osservava, per l’appunto, che il reato continuato è frutto di
una finzione del legislatore, il quale ha considerato come unità, una pluralità di
violazioni che di per sé costituiscono altrettanti reati perfetti. Se mancassero le
disposizioni sul reato continuato i singoli fatti verrebbero valutati come altrettanti
reati ed il giudice dovrebbe applicare per ognuno di essi una apposita sanzione
secondo le regole generali del concorso di reati, a nulla rilevando l’unità della
risoluzione criminosa. Ma se invece, si afferma, l’unità del reato continuato allora,
bisogna rispettare il principio del ne bis in idem. E, rispetto a questo, se si ritiene
che l’unità del reato continuato sia soltanto fittizia, e che in realtà, al di sotto di
questa artificiosa unificazione si nasconde una pluralità di reati, non è allora una
ingiustizia che alcuni reati, quelli sfuggiti dal giudizio, restino impuniti?
Ovviamente, «se, invece, quell’unità, anziché fittizia, fosse stata reale, di certo
questo problema non sarebbe sorto.
Il problema dei rapporti tra reato continuato e cosa giudicata non verrà risolto
esplicitamente neppure dal codice del 1930.
In dottrina e in giurisprudenza,
tuttavia, si formularono varie soluzioni. In particolare, abbandonata la soluzione
del ne bis in idem, si adottarono rispettivamente due diverse soluzioni, ricorrendo
405
Stoppato, nota in Temi Veneta, XXIII, 1893, p. 38 ss.
Alimena, Del concorso di reati e di pene, in Principii di diritto penale, Napoli, Pierro, 1914, p.
426.
406
169
a seconda dei casi, ora al giudizio suppletivo, ora al sistema dei giudizi separati.
In ogni caso, la maggioranza sembrava più che altro orientata verso la soluzione
del giudizio suppletivo, attraverso il quale si sarebbe garantita l’intangibilità del
giudicato e nello stesso tempo, si assicurava la comminazione di una sanzione per
tutte le violazioni nel rispetto delle regole della continuazione. Ben presto, però,
anche tra i sostenitori di questa soluzione ci si rese conto che, il giudizio
suppletivo non era il metodo migliore per garantire effettivamente il salvataggio
del giudicato.
Una soluzione completamente opposta la propose il Pisapia, il quale se da un lato
affermava l’unità del reato continuato, dall’altro, propugnava la intangibilità del
giudicato.« Nessuna importanza avrebbe avuto il fatto che fosse rimasto fuori dal
primo processo, dal momento che il principio del ne bis in idem precluderebbe
comunque l’esercizio dell’azione penale per i fatti accertati successivamente». E,
nello stesso senso, l’Aloisi, affermava che doveva «essere considerata legittima la
pretesa dell’imputato, assolto o condannato, di vedere assicurata la propria
tranquillità contro ogni possibile esercizio della azione penale per i fatti di
continuazione che avrebbero potuto essere compresi nel primo giudizio e per
qualsiasi motivo non lo furono»407.
Queste osservazioni, non escludevano, tuttavia, la preoccupazione di lasciare
impunite le violazioni che fossero rimaste fuori il primo giudicato; tanto che in
seguito, anche coloro che, inizialmente propendevano per l’applicabilità della
soluzione nel ne bis in idem, finirono per rinunciare ad essa a favore di quella del
giudizio suppletivo. Non mancarono, peraltro, sia in dottrina408, che in
giurisprudenza409 critiche sia all’una che all’altra soluzione. In particolare, alla
prima si opponeva «l’assurda iniquità delle sue conseguenze, dal momento che il
reo di più reati potrebbe essere condannato per uno soltanto, e talvolta, neppure
per il più grave»; alla seconda, invece, si obiettava «l’impossibilità di scindere il
giudicato in due parti, delle quali una soltanto immutabile (la pena base) e l’altra
modificabile (l’aumento per la continuazione), perché in tal modo verrebbe in
407
Aloisi, Manuale pratico di procedura penale, cit., p. 535 ss.
Giuliani, Riflessioni in tema di giudicato e continuazione, p. 482, nota alla sentenza, Cass. pen.,
18 febbraio 1975.
409
Cass. pen., 20 febbraio 1947, Bruni, in Riv. pen., 1947, p. 464.
408
170
realtà violato il giudicato: ed è irrazionale- si aggiungeva- attribuire al secondo
giudice il compito di infliggere una frazione di pena !». Pertanto, di fronte
all’esigenza di procedere sempre per tutte le violazioni in continuazione e di
calcolare sempre la pena-base sulla violazione più grave, ma anche di mantenere
fermo in ogni caso il giudicato, si prospettava quest’altra soluzione: nel caso di
fatti accertati successivamente alla sentenza e commessi per altro prima della
pronuncia della stessa e in continuazione con quelli che furono oggetto della
decisione, i giudici di cassazione affermarono che «le norme sulla continuazione
non sono applicabili nel rapporto tra un reato che sia oggetto di un giudizio in
corso ed altro reato già giudicato, allorché quest’ultimo costituisca violazione
meno grave del primo (…). La diversa soluzione, quella che ritiene la
continuazione del reato, comporterebbe infatti a una duplice violazione dell’art.
81 c.p.; giacché l’avvenuta formazione del giudicato imporrebbe di mantenere
ferma la misura della pena inflitta con la prima sentenza, e quindi su tale pena si
dovrebbe apportare l’aumento per la continuazione: con l’effetto doppiamente
illegittimo, che la pena sarebbe applicata per la violazione più lieve, invece che
per quella più grave e, e che l’aumento per la continuazione sarebbe commisurato
a tale pena- base»410.
Il Pagliaro, dall’altra parte, cercava di dimostrare la possibilità di rispettare
integralmente l’art. 81, ul. co. c.p., e perciò fissare la pena sulla base della
infrazione più grave, pur mantenendo ferma l’intangibilità del giudicato. Egli,
adottava in linea generale la tesi del giudizio suppletivo, ma negava che essa
potesse essere estesa tout court anche a quei casi in cui la prima sentenza
riguardasse fatti meno gravi. Diceva, «posto che il principio del giudicato deve
essere rispettato, non si può poi affermare, quasi fosse un’ovvia conseguenza, che
allora l’aumento della continuazione deve essere calcolato sulla pena- base inflitta
nel precedente processo, anche se ciò significa porre a fondamento della sanzione
la violazione meno grave (…) L’avere osservato la regola della intangibilità del
giudicato non dispensa dal rispettare anche il principio espresso dall’art. 81 c.p.,
secondo il quale la pena base deve essere calcolata in relazione alla violazione più
grave». Con ciò, voleva dire che, pur mantenendo l’intangibilità del giudicato,
410
Cass. pen., 27 febbraio 1963.
171
bisogna rispettare necessariamente anche il principio secondo il quale la pena
deve essere calcolata sulla base della violazione più grave anche se questa viene in
luce in un secondo momento» (…) «Questo potrebbe avvenire- aggiungevalasciando libero il secondo giudice di determinare la pena per i fatti sottoposti al
suo giudizio e di paragonare poi la gravità dei fatti da lui giudicati con quella
degli episodi giudicati dal suo predecessore, nel rispetto dell’accertamento e della
valutazione compiuti da quest’ultimo: se conclude che il nuovo reato è più grave
di quello già giudicato, il giudice, senza avere in alcun modo preso in esame i fatti
che furono oggetto della precedente sentenza e quindi senza violare il principio
del giudicato, deve applicare la norma dell’art. 81 c.p. e in conseguenza:1)
determinare la pena da infliggere per il nuovo reato; e, 2) determinare l’aumento
per la continuazione, commisurando questo aumento alla gravità dell’altro reato,
così come già accertata con sentenza passata in giudicato»411. In questo la
sentenza emessa nel secondo giudizio, avendo un contenuto più ampio, avrebbe
ricompreso in sé quella a contenuto meno ampio, cosicché in sede di esecuzione si
applicherà quest’ultima. «Sicché, in sede di esecuzione, l’assorbimento della
pena inflitta con la prima sentenza nella pena inflitta nella seconda, non si verifica
attraverso una violazione del giudicato. Il secondo giudice, infatti, non modifica in
alcun modo quanto era stato precedentemente deciso: il giudicato è salvo»412.
Ma come può, anche in questo caso, non ritenersi violato il principio
dell’intangibilità del giudicato?
La questione, come abbiamo potuto osservare, non è mai stata di facile soluzione,
principalmente perché erano in gioco due interessi contrapposti: da una parte il
“mito dell’intangibilità del giudicato” e dall’altro esigenze di giustizia sostanziale.
Ma qualcuno, ha sostenuto che proprio «la mancanza, nella legge scritta, di una
esplicita soluzione del problema in questione, imporrebbe di per sé una verifica
della effettiva estensione della regola della intangibilità del giudicato. (…) C’è,
peraltro, nel nostro ordinamento un valore che costituisce una importante
alternativa rispetto a quello del giudicato. Questo valore, è costituito appunto dalla
regola dettata dall’art. 81 co. 2 e 3 c.p., che stabilisce che le diverse violazioni
compiute in esecuzione di un medesimo disegno criminoso devono essere
411
412
Pagliaro, I reati connessi, p. 87 ss.
Pagliaro, I reati connessi, cit., p. 91 ss.
172
considerate come un solo reato: secondo alcuni, dato il silenzio della legge, la
regola della unità costituisce nel nostro ordinamento una reale alternativa a quella
della intangibilità del giudicato: «essa non può quindi essere aprioristicamente
sacrificata dal dogma della cosa giudicata»413. Ma allora se questo è vero, «il
giudice deve sempre considerare come un unico reato tutte le violazioni di una
stessa disposizione di legge compiute in esecuzione del medesimo disegno
criminoso e, nel compiere questa operazione, deve seguire compiutamente il
dettato dell’art. 81 co. 2 e 3 c.p., anche se questa soluzione implica un
superamento del precedente giudicato; perché non si può accettare che il principio
del ne bis sostanziale possa soccombere di fronte alle esigenze della certezza di
cui è portatore l’art. 90 c.p.p. »414.
Sul punto, sono peraltro, intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, per
affermare che una interpretazione corretta del principio della intangibilità del
giudicato, imporrebbe «di non consentire che tale istituto impedisca di applicare
l’istituto della continuazione all’intero sviluppo esecutivo dell’unico disegno
criminoso, perché ciò finirebbe proprio col violare l’art. 90 c.p.p. abr. (oggi art.
649 c.p.p.), ammettendo che, per lo stesso fatto di reato continuato, il giudicabile
venga sottoposto a due distinti giudizi con relativo cumulo di pene, mentre il
legislatore prescrive che si determini una pena unica mediante un’unica
complessiva valutazione»415. E, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 9
aprile 1987, n. 115, riprendendo per intero le motivazioni delle Sez. Un. Penali, ha
ribadito che non può ritenersi preclusa al secondo giudice del reato più grave, la
cognizione del reato continuato, proprio perché l’unicità del disegno criminoso tra
le plurime violazioni «non è certo subordinata alla sede della violazione più grave,
ma riguarda l’unicità del programma». Ma allora si dovrebbe dire che il reato
continuato, non ha struttura unitaria, ma anzi è un’ipotesi derogativa, definita da
qualcuno, sui generis al sistema del concorso di reati: in quanto, pur ammettendo
che il reato continuato, non distrugge la pluralità dei reati, non può estendersi il
giudicato formatosi su alcuni reati ad altri, che non abbiano costituito oggetto di
tale pronunzia.
413
Coppi, F., Reato continuato e cosa giudicata, Jovene, Naopli, 1969, p. 313.
Coppi, F., Reato continuato e cosa giudicata, cit., p. 318.
415
Cass., Sez. Un., 21 giugno 1986, in CED, Cass. pen., 1986, p. 1739,
414
173
Si ritiene416 allora che la riunione delle varie violazioni deve avvenire in modo
tale da consentire all’ultimo giudice quella libera valutazione della gravità di tutte
le infrazioni (questo implica automaticamente il superamento del precedente
giudicato): il secondo giudice quindi, proietta davanti a sé tutti i fatti, li valuta
secondo quanto finalmente essi si manifestano nel quadro della continuazione,
individua la violazione più grave, determina la pena- base, che esplicitamente
pone al posto della precedente e ne fissa quindi gli aumenti guardando
esclusivamente alla gravità delle violazioni (vecchie e nuove), quale a lui risulta:
si comporta, insomma, come se tutte le violazioni venissero per la prima volta
sottoposte a giudizio. Non avrebbe allora senso invocare qui, la intangibilità del
giudicato, per garantire al certezza del diritto. È vero che il giudicato mira a
garantire quelle certezza della situazione definita con la sentenza discendente
dalla impossibilità di sottoporre la res iudicata a nuovi giudizi; ma è anche vero
che «l’accertamento delle nuove violazioni e la necessità di sanzionarle, può
essere soddisfatta soltanto attraverso un’operazione fondata sull’aggancio delle
nuove e delle vecchie violazioni ed è proprio questo passaggio obbligato, imposto
dalla particolare natura del reato continuato, che rende lecito il superamento della
precedente statuizione in ordine alla pena contenuta nella sentenza passata in
giudicato». «Alla luce di questa giustificazione appare evidente che il
superamento del primo giudicato è voluto dall’ordinamento nel momento in cui
viene dettata una norma come quella dell’art. 81 co. 2 e 3 c.p (…) Se poi,
nell’accertamento successivo alla sentenza definitiva, si scoprono infrazioni meno
gravi di quelle già giudicate, si avrà che tutte le infrazioni devono essere
ricomprese nell’unità di reato»417.
7. Reato realizzato alternativamente da più condotte fungibili
la cui somma non importa concorso di reati.
Non mancano ipotesi nelle quali, sebbene, sembri configurarsi un concorso
materiale eterogeneo, sussiste ugualmente un’unità normativa di reato. Ciò si
verifica principalmente in quei casi, che la dottrina tedesca, era solita chiamare
416
417
Coppi, F., Reato continuato e cosa giudicata, cit., p. 329.
Coppi, F., Reato continuato e cosa giudicata, cit., p. 330.
174
“alternative Mischgestetze” e, nei quali una accorta interpretazione delle norme
conduce a riconoscere che le diverse descrizioni legislative non configurano
ciascuno un autonomo comportamento tipico, ma costituiscono semplici modalità
di previsione di un medesimo tipo delittuoso. La ripetizione di fatti
apparentemente rispondenti ciascuno ad una fattispecie- si diceva- è, in realtà, in
questi casi, ripetizione di fatti normativamente omogenei, i quali, pertanto, se la
norma è congegnata in modo da abbracciare tanto una unità, quanto una pluralità
di comportamenti possono essere riassunti in un solo reato. Così, ad esempio, le
varie ipotesi di contrabbando, purché commesse contestualmente, lasciano intatta
l’unità del reato. In proposito, infatti, si diceva: « le varie ipotesi di contrabbando
previste dalla legge doganale, nonostante la loro particolare configurazione diretta
a tutelare nel miglior modo i diritti della finanza, non si differenziano per l’evento
che, reale o presunto, tentato o consumato, consiste pur sempre nella sottrazione
della merce ai diritti di confine, ma si differenziano solo per la condotta
delittuosa. E pertanto, tra le diverse ipotesi non può esistere né concorso materiale
né concorso formale di reati, ma solo concorso di norme per cui il giudice non può
ritenere che un solo reato di contrabbando, applicando una sola delle pene»418.
7. a)Reati di bancarotta.
Ma vi rientrano anche i fatti di bancarotta, i quali, pur essendo talvolta assai
diversi da un punto di vista naturalistico ed essendo descritti diversamente dalla
legge, non danno mai luogo a concorso materiale, anche se commessi a distanza
di tempo l’uno dall’altro419. Proprio in relazione a questi, c’è stata una recente
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenuta proprio a chiarire la
natura di tali fatti. La questione era posta in questi termini: si trattava di una
ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma rispetto alla quale, il giudice
dell’udienza preliminare, riteneva che l’azione penale non potesse essere
proseguita, per l’esistenza di un precedente giudicato, a norma dell’art. 649 c.p.p.
Egli, infatti, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito e, facendo leva sulla
mera comparazione formale tra i fatti sottoposti al suo esame e quelli di bancarotta
preferenziale (art. 216 co. 1, l.fall.) e semplice (art. 217 co. 3, n. 4, l.fall.) relativi
418
419
Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1952, in Giust. pen., 1953, II, p. 865.
Pagliaro, A., Concorso di reati, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 670.
175
al medesimo fatto e oggetto di una precedente sentenza, col quale, peraltro, era
stata applicata una pena patteggiata, riteneva che dato il carattere unitario del reato
di bancarotta, non era consentito in presenza di un giudicato su tale illecito,
l’inizio di un nuovo e differente processo per ulteriori e diversi fatti di bancarotta
accertati successivamente, ostativi del divieto del ne bis in idem, in quanto questi
ultimi erano comunque assorbiti nel disvalore dell’unico reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale già giudicato e, dunque, non davano luogo a una
pluralità di reati.
Si propose, allora, ricorso per Cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli
art. 649 c.p.p. e 219 l. fall., per i seguenti motivi: a) innanzitutto si diceva che la
tesi privilegiata dalla sentenza impugnata avrebbe portato a risultati assolutamente
irragionevoli, come confermava il caso in esame, in cui l’imputato dopo aver
patteggiato la pena meno grave per i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta
semplice, avrebbe potuto beneficiare della declatoria di improcedibilità per il
diverso e più grave reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; b) in secondo
luogo, l’art. 649 c.p.p., prevede in linea generale il divieto di un secondo giudizio
per il “medesimo fatto”, intendendosi con questo, il fatto cristallizzatosi nella
sentenza divenuta irrevocabile; ma quei fatti storici portati in giudizio erano
assolutamente differenti per condotta e conseguenza da quelli precedentemente
giudicati, il che voleva dire che essi sono logicamente diversi tra di loro, con
conseguente inapplicabilità del divieto del ne bis in idem; d) l’art. 219 co. 2 l. f.,
inoltre, prevedendo un aumento di pena, ove vengano commessi più fatti tra quelli
previsti in ciascuno dei precedenti articoli 216, 217, 218, persegue la finalità di
mitigare il rigore sanzionatorio conseguente al concorso materiale di più reati di
bancarotta, che vengono unificati solo quoad poenam, rimanendo ferma
l’innegabile autonomia ontologica dei singoli fatti di bancarotta, ciascuno dei
quali è idoneo a fondare una decisione di responsabilità penale; e) secondo,
invece, il contrario orientamento espresso dalla sentenza impugnata implica che il
trattamento sanzionatorio da riservare ad un soggetto che si sia reso responsabile
di più fatti di bancarotta dipenderebbe non già, da dalla valutazione delle condotte
complessivamente considerate, ma dalla tempistica di emersione e di
contestazione dei vari fatti, con conseguenze irragionevoli. La Quinta sezione
176
penale, a cui era stata rimessa ratione materiae il ricorso, rilevando un contrasto
giurisprudenziale sulla natura del reato di bancarotta, ne rimise allora, la decisione
alle Sezioni Unite. Le interpretazioni erano due: da un lato la tesi della concezione
unitaria del reato, per cui si
ravvisa nella pluralità di fatti tipici, commessi
nell’ambito della stessa procedura concorsuale, una circostanza aggravante e,
inoltre, considera le diverse violazioni- in deroga alle norme sul concorso
materiale e sulla continuazione- come un solo reato, con l’effetto della operatività
della preclusione di un secondo giudizio; dall’altra la concezione pluralistica del
reato, che ravvisa nei più fatti tipici descritti dalla norma incriminatrice,
fattispecie autonome e ontologicamente diverse, le quali concorrono tra di loro e
sono unificate solo quoad poenam. Si segnalava, inoltre che nonostante fosse
razionale la scelta di politica criminale finalizzata a disciplinare in maniera
peculiare il concorso di reati e a contenere il potere sanzionatorio del giudice in
relazione a plurime e autonome fattispecie incriminatrici in materia di bancarotta
patrimoniale,
non
poteva
essere
considerata
altrettanto
razionale
una
interpretazione della disciplina speciale che, riconducendo ad unità fatti
ontologicamente
diversi,
ne
precludesse
il
completo
accertamento
ed
eventualmente la punizione, ponendosi peraltro, in contrasto con la logica del
sistema penale, e con gli art. 3 e 112 Cost. Inoltre, si sottolineava che la
preclusione connessa al divieto del ne bis in idem operasse soltanto in relazione
allo “stesso fatto”, il quale, come si è visto,
ricorre soltanto quando vi sia
corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in
tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso di causalità) e con
riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona420.
La Corte di Cassazione ha, tuttavia, privilegiato la concezione unitaria del reato di
bancarotta. A proposito, interessante è l’analisi che essa fa del contenuto e della
portata delle norme incriminatrici (artt. 216, 217, 218 l. fall.), richiamate dall’art.
219 co. 2, l. fall. È noto- dice- «che vi sono disposizioni a più norme (o norme
miste cumulative) che contengono diverse ipotesi incriminatrici, aventi ciascuna
una propria autonomia ontologica e una propria autonoma rilevanza penale, e
norme a più fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che viceversa
420
Cass., Sez. Un., 28 settembre 2005, n. 34655, cit.
177
prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso
di realizzazione di più fattispecie, che degradano a semplici modalità di
realizzazione di un unico tipo di reato».
L’art. 216
l. fall., in particolare,
«apprezzato nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della
disposizione a più norme, prevedendo ipotesi di reato assolutamente eterogenee
tra di loro, per condotta, oggettività giuridica, gravità, tempo della consumazione
e per sanzione prevista. Ma esso, contiene, tuttavia, anche norme a più fattispecie
alterative o fungibili. È il caso delle condotte di distrazione, occultamento,
dissimulazione, distruzione o dissipamento di cui al primo comma, le quali se
hanno ad oggetto lo stesso bene, sono per così dire in rapporto di “alternatività
formale”, di “alternatività di modi”, nel senso cioè «che le diverse condotte
descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e
integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere in immediata
successione cronologica, due o più di tali condotte che, essendo omogenee tra di
loro, ledono lo stesso bene giuridico. Così, anche al primo comma, n. 2, si
prevedono fattispecie alternative, in particolare: la sottrazione, distruzione o
falsificazione di libri o di altre scritture contabili» (…) L’art. 217, l. fall. è,
invece, una «disposizione a più norme, prevedendo ipotesi di bancarotta semplice
riconducibili a condotte ontologicamente diverse e distinte tra di loro. Infine, l’art.
218, l. fall., prevede una sola fattispecie delittuosa: il ricorso abusivo al credito,
dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza dell’impresa commerciale». In
definitiva, le Sezioni Unite, con la sentenza 26 maggio 2011 n. 21023, aderendo
alla seconda teoria prospettata, hanno stabilito che: «più condotte tipiche di
bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la
propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, che vengono
unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico; la disposizione di cui
all’art. 219, comma 2, n. 1 l. fall. non integra, sotto il profilo strutturale, una
circostanza aggravante, ma detta una particolare continuazione, in deroga a quella
ordinaria di cui all’art. 81 c.p., in tema di reati fallimentari».
Deve, pertanto escludersi con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub
iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato (divieto del bis in idem ex art. 649
178
c.p.p.) intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa
procedura concorsuale.
7. b) 1. Fatto antecedente e successivo non punibile.
Bisogna, pertanto, tener presente la possibilità che in alcuni casi, sebbene sembri
configurarsi un concorso di reati, questo sia, in realtà, soltanto apparente. Questa
possibilità è data, perché il concorso di norme può aversi non solo dove l’unità
dell’accadimento sia naturale, ma anche, dove la unità stessa sia normativa, cioè
sussista rispetto ai fini dell’ordinamento. Di conseguenza il problema se «il
concorso sia effettivo o apparente, può sorgere non solo quando il processo
esecutivo sia unico (unità naturale dell’accadimento), ma anche nelle ipotesi in cui
le norme si riferiscano a comportamenti, ciascuno dei quali sia realizzato con un
autonomo processo esecutivo, purché la unità normativa dell’accadimento
sussista. Si tratta di quelle ipotesi che la dottrina suole riportare allo schema
dell’antefatto e postfatto non punibili»421.
Con questi due termini, buona parte della dottrina penalistica, ha accolto ed
introdotto nella teoria del concorso di norme e del concorso di reati le figure poste
in rilievo dalla dottrina tedesca sotto il nome, appunto di, straflose Vor- und
Nachtat. Senonché, vediamo che queste ultime, sono rappresentate da condotte
costituenti reato, che si presentano rispettivamente, come la naturale premessa o la
normale conseguenza di un altro reato. La qualificazione di irrilevanza
dell’antefatto o del postfatto, la possiamo vedere implicitamente riflessa in alcune
disposizioni di legge. Possiamo fare qualche esempio. Sono annoverabili nella
categoria dell’antefatto non punibile: la sfida a duello e l’accettazione della sfida
nel caso in cui il duello segua e i duellanti debbano quindi essere puniti per tale
più grave delitto (ipotesi ormai abrogata - art. 394 c.p., art. 396 c.p.); gli atti di
libidine violenti a cui faccia seguito, in unicità di contesto la violenza carnale
sullo stesso soggetto (art. 521 c.p., art. 519 c.p.); il fatto del pregiudicato autore di
un furto o di un tentativo di furto con effrazione che sia stato anche colto in
possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 624 ss c.p., art. 56
c.p., art. 707 c.p.); il tentativo, perfetto o imperfetto, commesso immediatamente
prima di ritentare o consumare lo stesso reato contro la stessa persona presa
421
Pagliaro, A., Concorso di reati, in Enc. dir., cit., p. 670.
179
precedentemente di mira; l’istigazione all’aborto seguita dal concorso delle
manovre abortive (art. 548 c.p., art. 546 c.p.); la minaccia su di un delitto seguita
dall’attuazione immediata dello stesso; e anche ( ma questi ultimi esempi rivelano
a nostro avviso confusione con altre situazioni) il sequestro di persona realizzato
come primo atto del plagio (art. 603 c.p., art. 605 c.p.), gli atti contrari alla
pubblica decenza seguiti dal compimento di atti osceni (art. 726 c.p., art. 527
c.p.); le lesioni colpose o l’omicidio colposo preceduti da una contravvenzione
nella quale sia da ravvisarsi l’attività colposa che è stata causa o concausa
dell’evento (per es. art. 36 codice della strada che contempla il reato di eccesso di
velocità; omessa custodia di animali ex art. 672 c.p., ecc.).
Rientrano, invece, nella figura del postfatto non punibile: la distribuzione o il
commercio di sostanze alimentari nocive da parte di chi abbia già partecipato
all’adulterazione, contraffazione od avvelenamento di esse (art. 444 c.p., art. 439
ss. c.p.); la adibizione di locali a convegni di persone dedite all’uso di stupefacenti
da parte di chi abbia già concorso a commettere nei confronti delle stesse persone
il delitto di commercio o somministrazione di sostanze stupefacenti (art. 447 c.p.
abr.; art. 446 c.p.); l’uso di un atto falso da parte di chi abbia già concorso nella
falsificazione di esso (art. 489 c.p.; art. 476 s. c.p.); ai quali si aggiungono anche i
casi di favoreggiamento commesso da chi abbia già concorso nel delitto
presupposto (art. 648 c.p.), della rivendita od altra destinazione della cosa da parte
dello stesso ladro o da chi la cosa abbia ottenuto a mezzo di truffa o di altro delitto
contro la proprietà, nonché la distruzione, dispersione o deterioramento della cosa
rubata da parte del ladro (art. 635 c.p.; art. 624 ss. c.p.). In alcuni casi, la predetta
qualificazione è implicita, come avviene tutte le volte in cui il postfatto si
identifichi con uno dei mezzi ordinari di attuazione del fine proprio del reato
principale. Così, il danneggiamento della cosa rubata non è che l’espressione,
penalmente irrilevante, del potere di disposizione su di essa illecitamente
conseguito dall’autore422.
La considerazione congiunta dei due fenomeni in esame, abituale nella dottrina, si
spiega probabilmente per l’identità della ratio che porta a ritenere in entrambi i
casi punibile solo il fatto più grave. Sembra, tuttavia, tuttora valida l’impostazione
422
Vassalli, G., Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in Enc. dir., 1958, Milano, Giuffrè,
p. 508- 518.
180
accolta dalla prevalente dottrina che, pur riconoscendo la validità concettuale delle
categorie dell’antefatto e del postfatto, nega tuttavia l’esistenza di una vera e
propria teoria dell’antefatto e del postfatto non punibili nel nostro diritto.
b) 2. Caratteri comuni dei fenomeni in esame.
È chiaro, innanzitutto, che tanto nel fatto antecedente non punibile, quanto nel
fatto successivo non punibile, ci si trova in presenza di una pluralità di fatti o di
condotte, l’una successiva all’altra in ordine cronologico, in ciascuna delle qualiconsiderata disgiuntamente dall’altra- sarebbe astrattamente possibile ravvisare un
reato: l’agente, prima compie atti di libidine violenta diversi dalla congiunzione
carnale e poi, commette violenza carnale; prima (essendo pregiudicato) si munisce
di chiavi false e poi ruba o, viceversa, prima ruba una cosa e poi la distrugge;
prima falsifica un determinato atto e poi ne fa un determinato uso e via dicendo.
E, trattasi evidentemente di una pluralità di condotte che è tale sia dal punto di
vista naturalistico che da quello giuridico, nel senso che ognuna di esse,
naturalisticamente distinte, basterebbe di per sé sola (se l’altra non concorresse)
ad integrare un’autonoma fattispecie legale. Questa prima constatazione ci
permette di distinguere agevolmente i fenomeni in esame dai casi di concorso
formale eterogeneo, il quale è, invece, caratterizzato, dall’unicità naturalistica
della condotta, o meglio, dall’esistenza di un’unica fattispecie concreta, nonché da
quei casi di concorso apparente di norme che sono contraddistinti dalla esistenza
di un’unica azione, alla quale sembrerebbero attagliarsi due norme penali. Questa
stessa constatazione della esistenza di una pluralità di fattispecie concrete ci
consente anche di distinguere l’antefatto e postfatto non punibili dal reato
progressivo, nel quale pure si avrebbe pluralità di fattispecie legali, ma unicità di
fattispecie concreta.
In secondo luogo, possiamo notare che nei fenomeni in esame, si ha una pluralità
di fatti diversi, rappresentanti diversi gradi o stati o tipi di offesa al medesimo
bene, ma sempre tali che, se costituissero altrettanti reati, violerebbero ognuno
una diversa disposizione della legge penale. Ciò basta a distinguere dette ipotesi
dalle figure del concorso formale omogeneo e dal reato continuato, nelle quali si
hanno più violazioni della medesima disposizione di legge, nonché della figura
del reato abituale.
181
Il bene a cui tali fatti diversi recano offesa, inoltre, deve appartenere ad un
medesimo soggetto o ad una medesima cerchia di soggetti tutelati. Per giunta,
secondo l’orientamento più seguito, i due o più fatti (condotte), devono essere
legati dalla unicità del fine, o meglio, dal presupposto di mezzo a fine. Ecco che
allora, questi si distinguono anche dalle ipotesi delle c.d. fattispecie legali miste,
alternative o cumulative (nel caso in cui il soggetto si trovi ad aver realizzato due
o più tra le fattispecie previste nella c.d. norma penale mista o congiunta). La
differenza, è più che altro una differenza di carattere formale. Le fattispecie legali
miste sono infatti contemplate in un’unica disposizione di legge, mentre
l’antefatto e il postfatto non punibili, se fossero puniti ricadrebbero sotto una
disposizione di legge diversa da quella che contempla il fatto prevalentemenete
punito.
b) 3. Differenze con il reato progressivo.
Il punto è oggetto di notevole controversia, in quanto molte sembrano essere le
analogie; eppure, una distinzione appare necessaria. Anche a non voler
considerare, come qualcuno riteneva, il reato progressivo come caratterizzato da
una unicità di fattispecie concreta (chi vuol devastare non vuol che devastare e
devasta, anche se per far ciò danneggia più cose; chi vuole saccheggiare non vuol
che saccheggiare e saccheggia anche se per far ciò commette più furti), è però,
vero, che esistono nelle nostre leggi comuni e speciali, delle fattispecie legali le
quali necessariamente ne contengono almeno un’altra, la quale non può trovare
applicazione perché evidentemente assorbita nella maggiore: oltre che alla
devastazione e al saccheggio, basti pensare all’avvelenamento di acque o sostanze
destinate all’alimentazione (art. 439 c.p.), la cui fattispecie necessariamente
implica quella della detenzione di materie tossiche al fine di attentare alla
pubblica incolumità (art. 435 c.p.) e nella interruzione di un pubblico servizio (art.
331 c.p.), la quale necessariamente implica quella d’omissione di atto del servizio,
prevista come reato nell’art. 328 c.p. «Questo rapporto di necessità, che ha tante
volte permesso di parlare per il reato progressivo di unicità, anziché di pluralità di
azione, manca invece, nell’antefatto e postfatto non punibili. Se nel reato
progressivo, infatti, abbiamo la piena inclusione di una fattispecie legale (minore)
in un’altra (maggiore) che prevale ed è la sola a venire applicata; tale situazione,
182
non è rinvenibile nelle due fattispecie in esame, dove le fattispecie legali
rimangono separate anche nella concreta realizzazione e dove la non punibilità
dell’una è determinata dall’idea, secondo l’id quod plerumque accidit, che esso
costituisca la normale premessa del fatto più grave o il suo normale sbocco: sì che
ben può dirsi che il suo disvalore è già incluso nel disvalore del fatto
principale»423
Ciò, non è tutto. La dottrina, ha introdotto nel nostro ordinamento un’ulteriore
figura: quella della c.d. progressione criminosa. Anche qui, grandi sono le
analogie tra l’antefatto e il postfatto non punibile e quest’ultima figura; e, ciò
perché, anche la progressione criminosa è caratterizzata da una pluralità di
fattispecie concrete, apparentemente integrative di più fattispecie legali, anche qui
si ha l’identità del soggetto attivo e del soggetto contro il quale le due o più azioni
vengono commesse; ed infine, anche qui è necessaria, la quasi contestualità tra il
primo e il secondo fatto, senza la quale si cade nel concorso materiale. Il Ranieri,
che è stato anche uno tra i primi e più illustri autori ad elaborarne una teoria,
diceva: «si ha progressione criminosa quando una fattispecie legale penale,
realizzata in antecedenza, viene concretata ancora per la via della realizzazione
successiva di altra fattispecie legale penale, nella quale già si trova implicita» o,
ancora, «quando l’agente, di una condotta iniziale, che si concreta in un
determinato reato, in unità di contesto, e con offesa ulteriore di uno stesso bene
giuridico di maggiore importanza, che implica quello del bene precedentemente
aggredito, ma sempre appartenente al medesimo soggetto, passa ad una condotta
successiva, in nesso causale con l’antecedente, realizzando un reato più grave che
contiene il meno grave».
Tuttavia una distinzione appare possibile e necessaria. Il fatto antecedente non
punibile, come è stato giustamente sottolineato, appare infatti- caratterizzato da un
rapporto di mezzo a fine, che manca nella progressione criminosa, dove il
progredire dell’offesa da un’offesa meno grave ad una più grave nei confronti
dello stesso soggetto passivo o dello stesso bene avviene in dipendenza di più
risoluzioni successive. Il Mantovani, infatti, scrive che la progressione criminosa
si configura in presenza di «un passaggio contestuale, determinato da risoluzioni
423
Vassalli, G., Antefatto non punibile, postfatto non punibile, cit., p. 508- 518.
183
successive, da un fatto corrispondente ad una fattispecie legale ad un fatto
corrispondente ad un’altra fattispecie legale più grave, strutturalmente implicante
la prima». Ed è «proprio questo rapporto di mezzo a fine, tenuto presente dal
legislatore, perché caratteristico di certe attività criminose, secondo l’id quod
plerumque acidit, che permette, di interpretare la volutas legis come rivolta ad
applicare una sola norma, quella che contempla il fatto ulteriore e più grave (…)
Così pure un rapporto di mezzo a fine vuolsi vedere nel postfatto non punibile, nel
senso che esso rappresenta appunto uno di quei modi ordinari di realizzazione del
fine caratteristico del reato principale, che il legislatore non può non aver tenuto
presente, secondo la regola dell’id quod plerunque accidit, nel momento in cui
poneva la norma incriminatrice del reato principale»424.
In dottrina, infine e, in particolare il Ranieri, ha introdotto ancora un’ulteriore
distinzione. Egli parlava di reato di passaggio, il quale si configurerebbe ogni
qual volta, «un soggetto trascorre da un reato meno grave ad un altro più grave
che realizza la condotta criminosa iniziale, come ad esempio nei casi di minaccia
di commettere atti di devastazione e saccheggio, fino all’attuazione della stessa,
consistente nella commissione di fatti di devastazione e saccheggio. In questi casi,
infatti , il concorso materiale è escluso in quanto il reato successivo più grave,
realizzando la condotta criminosa iniziale,assorbe l’antecedente, che vi si trova
implicato, per rivolgersi verso di esso la condotta iniziale, che l’attua svolgendosi
in prosecuzione così che la pena è soltanto quella del rato più grave.
Ma, in realtà, se si guarda bene, l’espressione “reati di passaggio” non designa
alcuna figura diversa da quelle già viste e, come diceva qualcuno, «non può essere
accolta come rappresentativa di una situazione autonoma e distinta (…) Se infatti
tale espressione viene usata nei confronti di un’unica fattispecie concreta
realizzante più fattispecie legali, altro non è se non uno dei modi per esprimere il
reato progressivo. Se invece, essa viene usata nei confronti di una pluralità di
fattispecie concrete, delle quali la più grave viene ad assorbire la meno grave che
la precede, si versa nella materia della progressione criminosa ove il passaggio
424
Vassalli, G., Antefatto non punibile, postfatto non punibile, cit.
184
avvenga per effetto di più risoluzioni successive e, in caso contrario in quella
dell’antefatto non punibile»425.
b) 4. Problemi relativi al diritto processuale: applicabilità del ne bis in
idem nei casi di antefatto e postfatto non punibili.
Ora, premesso che, se è vero che l’antefatto e il postfatto non punibili, devono
considerarsi come dei non- reati, nessuna questione degna di particolare rilievo
potrà nascere nel campo del diritto processuale, per esempio, in ordine all’azione
penale e alla sue condizioni di promovimento e d’esercizio, in ordine alla
competenza, in ordine alla efficacia della cosa giudicata. Tuttavia, l’unico tema
degno di nota nel campo del diritto processuale, appare quello di limiti di
applicabilità del principio del ne bis in idem nei casi in cui sia intervenuto
giudicato su uno dei fatti quando la punibilità dell’uno esclude, secondo quanto
previsto dal nostro legislatore, la punibilità dell’altro. Ora, nel caso di giudicato di
assoluzione o di proscioglimento, intervenuto per uno dei due fatti, deve
evidentemente dirsi che questo non esclude mai, di per sé solo, la procedibilità nei
confronti dell’altro fatto, che in tanto è “non punibile”, in quanto il soggetto sia
stato riconosciuto responsabile ad altro titolo. Più complesso è il problema
dell’efficacia del giudicato di condanna. Mentre infatti è evidente che, in caso di
condanna per il fatto prevalente o più grave (quello in vista della punizione del
quale il legislatore esclude la punibilità del fatto antecedente o del fatto
successivo), non si può procedere per il fatto antecedente o successivo, si potrebbe
dubitare di tale soluzione nel caso in cui il giudicato di condanna fosse
intervenuto proprio per l’antefatto o il postfatto non punibili. Per questa ipotesi è
stato giustamente osservato426 che, mentre non sembra possibile impedire la
persecuzione del fatto costituente il reato più grave, non si può nemmeno arrivare
ad una duplice punizione, per un «malinteso rigore del principio della
regiudicata», quando invece, il diritto positivo sostanziale ne vuole una sola. In tal
caso- si aggiunge- la soluzione sarebbe quella del giudizio suppletivo, volto, nel
caso ove sia riconosciuta la responsabilità per il nuovo fatto, «ad una sentenza
425
426
Vassalli, G., Antefatto non punibile, postfatto non punibile, cit.
Leone, G., Lineamenti di diritto processuale penale, Napoli, Jovene, 1956, p. 547.
185
nella quale si determinerà la pena unica comprensiva di quella già applicata col
giudicato precedente».
186
Conclusioni.
Il divieto di un secondo giudizio nei confronti di chi sia stato destinatario di una
«sentenza o decreto penali divenuti irrevocabili», sancito nell’art. 649 c.p.p.,
costituisce l’espressione più immediata delle esigenze di certezza e di stabilità
poste a base dell’istituto del giudicato. Emesso il provvedimento, esaurita la serie
delle impugnazioni ordinarie ovvero, decorsi i termini per la loro proposizione e,
formatosi, in tal modo, il “giudicato formale”, si ha consunzione del potere
giudiziale di decidere sulla medesima questione cosicché la sentenza diviene
incontestabile dalle parti e irretrattabile da parte del giudice.
Nella materia che è oggetto della nostra indagine, molto si è scritto e, soprattutto,
molto si è dibattuto, in dottrina e in giurisprudenza. I punti principiali della
questione, sono da sempre stati problemi di qualificazione, di individuazione delle
varie situazioni e soprattutto di interpretazione delle nozioni di “identità” e
“medesimezza” del fatto, ai fini di delimitare a chiare linee l’area di operatività
del ne bis in idem.
Il problema dell’operatività o meno del ne bis in idem, non è di poco conto, esso,
infatti, più che su un profilo meramente teorico, ha rilevanti ripercussioni su un
piano più propriamente pratico, giacché ad essere in gioco, sono due interessi
contrapposti di fondamentale importanza: l’uno, l’interesse ad una giustizia
sostanziale, ossia l’interesse alla punizione dei reati e soprattutto a che questi
vengano accertati e puniti secondo verità; l’altro, l’esigenza di garantire una
certezza in senso soggettivo: ossia, di evitare che il soggetto venga a trovarsi in
una sorta di “limbo processuale”, “sospeso”, in una situazione di permanente
incertezza, col rischio di vedersi sottoposto ad una, teoricamente illimitata,
possibilità di reiterazione di procedimenti penali in ordine allo stesso fatto.
La questione non è di poco conto. Ma se si guarda alla natura del ne bis in idem, si
capisce bene che esso non svolge efficacia di accertamento della fattispecie
criminosa dedotta in giudizio, e ciò, proprio in quanto non esiste nessuna norma
che prescrive ai giudici dei successivi procedimenti penali di uniformarsi
all’accertamento contenuto nella precedente decisione, diventata irrevocabile.
187
La preclusione opera a un livello precedente e, in virtù, di un’operazione quasi
meccanica del giudice: quest’ultimo, infatti, dovrebbe limitarsi a valutare
l’identità dei fatti, indipendentemente dal contenuto dell’accertamento della
sentenza e dichiarare, se del caso, la non proponibilità o proseguibilità dell’azione
penale, per l’esistenza di un precedente giudicato. Di qui, il c.d. principio di
consunzione (o consumazione) dell’azione penale, per cui « non può entrare nel
mondo del diritto un provvedimento che abbia lo stesso contenuto pratico di
quello già assunto irrevocabilmente». L’effetto preclusivo è collegato, dunque,
esclusivamente, al fatto che sia stata pronunciata nei confronti di un dato soggetto
una sentenza irrevocabile su un determinato fatto a prescindere dal suo
accertamento.
Premesso questo, non va neppure dimenticato che l’operatività del ne bis in idem
si fonda non già su schemi logici aprioristicamente presupposti, ma su criteri di
mera opportunità pratica, frutto della scelta discrezionale del legislatore di quegli
indici, posti in norme convenzionali, che egli assume preventivamente come
termini su cui valutare il rapporto di identità tra i vari fatti. Pertanto, essendo
questi criteri meramente convenzionali, si potrebbe avere che fatti, seppur
ontologicamente diversi, vengano considerati come se fossero uguali ai fini
dell’operatività del ne bis in idem.
Peraltro, anche in rapporto, alle varie forme di manifestazione del reato, prese in
esame, si è visto, che sostanzialmente due sono le esigenze in questione: da una
parte, garantire l’intangibilità del giudicato e dall’altra, l’interesse a ché non si
lascino impuniti reati commessi dal medesimo soggetto e rientranti nello stesso
fatto, ma scoperti solo successivamente alla sentenza pronunciata sui fatti
precedentemente dedotti in giudizio.
Non è stato semplice, venire ad una conclusione e trovare un punto di equilibrio
tra i due interessi, soprattutto, in passato, in cui, forte era l’influenza del c.d.
“mito dell’intangibilità giudicato”, tanto che, pur di non compromettere il
principio dell’autorità, imperatività e irretrattabilità del giudicato, si finiva per
sacrificare le esigenze di giustizia sostanziale. Oggi, invece, è evidente che la
soluzione è ispirata, più che altro, a esigenze di certezza e di giustizia sostanziale
e pertanto, molti sono stati i temperamenti e gli adattamenti che l’istituto in
188
questione ha subito, soprattutto di recente, a seguito, degli ultimi approdi
giurisprudenziali e normativi.
Occorre, da ultimo, sottolineare che, di recente, vi è stata una importante
evoluzione sistematica. La giurisprudenza ha interpretato il ne bis in idem come
principio generale dell’intero sistema processuale e, ha ritenuto precluso un
secondo giudizio in relazione al medesimo fatto attribuito alla stessa persona
anche in presenza di un processo ancora pendente e non definito con sentenza
irrevocabile.
In ogni caso, si richiede che i due processi siano pendenti contemporaneamente,
che siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso Pubblico Ministero, che non
siano riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza (previsti ai sensi
dell’art. 28 c.p.p.) e, infine, che siano stati devoluti, anche se in fasi o gradi
diversi, alla cognizione di giudici appartenenti alla stessa sede giudiziaria.
Possiamo, peraltro, concludere che il principio della preclusione processuale,
tradizionalmente finalizzato ad evitare una duplicazione di attività in ordine allo
stesso fatto già irrevocabilmente deciso, è oggi, più che altro, posto quale
baluardo da porre a salvaguardia dei principi della ragionevole durata del
processo, della efficienza ed economia processuale427.
427
Chiovenda, G., Cosa giudicata e preclusione, in Riv. it. scien. Giur., 1933, p. 3 ss; ora in ID.
Saggi di diritto processuale civile (1894- 1937), vol. III, Milano, 1933, p. 231 ss.
189
Bibliografia
ADDAMIANO, A., Sulla influenza del giudicato penale nel processo
penale, in Arch. pen., 1951, II, p. 169 ss.
ALIMENA, B., Del concorso di reati e di pene, in Principii del diritto
penale, Napoli, Pierro, 1944, p. 426 ss.
ALOISI, U., Manuale pratico di procedura penale, vol. IV, Milano,
1943.
ANDRIOLI, V., voce: Ne bis in idem, in Noviss. Dig. it., vol. XI,
Torino, 1965, p. 185 ss.
ANTOLISEI, F., Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano,
Giuffrè, 1960.
Manuale di diritto penale, Parte generale, 16ª ed., Milano, Giuffrè,
2003.
ATTARDI, A., La cosa giudicata, estr. da Jus, p. 33 ss.
BASSI, A., I limiti oggettivi dell’effetto preclusivo derivante dal
giudicato penale, in Cass. pen., 1992, 1403, p. 861,
BELLAVISTA, G., Lezioni di procedura penale, Milano, Giuffrè,
1960.
BELLAVISTA, G. – TRANCHINA, G., Lezioni di procedura penale,
10ª ed., Milano, Giuffrè, 1987.
BELLORA, C., Ne bis in idem e reato progressivo, in Riv. it. dir. e
proc. pen., Milano, Giuffrè, 1990, p. 164.
BETTIOL, G., Istituzioni di diritto e procedura penale, Padova,
CEDAM, 1995.
BIANCA, M., Diritto civile, vol, V, Milano, Giuffrè, 1994.
190
BORSARI, L., Dell’azione penale, Torino, UTET, 1866, n. 423.
BUCOLO, F., Sul giudicato penale, in La giustizia penale, III, 1963,
p. 423.
CARRARA, F., Programma, Parte generale, § 128 ss.
CALAMANDREI, F., La sentenza civile come mezzi di prova, in
Studi sul processo civile, I, Padova, 1947, p. 162 ss.
CALLARI, F., La firmitas del giudicato penale, Milano, Giuffrè,
2009.
CANTAGALLI, R., Ne bis in idem e nozione di medesimo fatto, in
Giust. pen., III, 1964, p. 152- 158.
CAPOGRASSI, G., Prefazione alla certezza del diritto, F. L. De
Onate, Roma, Gismondi, 1950.
CARINGELLA, F. – GAROFOLI, R., Reato complesso, in Studi di
diritto penale, Milano, Giuffrè, 2002, p. 1055- 1085.
CARNELUTTI, F., Efficacia, autorità e immutabilità della sentenza,
in Riv. dir. proc. pen., 1935, p. 205.
Lezioni sul processo penale, vol. I, Milano, Giuffrè, 1949.
Efficacia diretta e efficacia riflessa del giudicato penale, in Questioni
sul processo penale, Bologna, 1950.
Contro il giudicato penale, in Scritti in onore di Vincenzo Manzini,
Padova, CEDAM, 1951, p. 122 ss.
CATELANI, G., Manuale sull’esecuzione penale, 5ª ed., Milano,
Giuffrè, 2002.
CHILIBERTI, A., Azione civile e nuovo processo penale, 2ª ed.,
Torino, UTET, 2006.
191
CHIOVENDA, G., Principi di diritto processuale civile, Napoli,
1923.
Istituzioni di diritto processuale civile, 2ª ed., Napoli, 1923.
Cosa giudicata e preclusione, in Riv. it. scien. giur., 1933, p. 3 ss; ora
in ID Saggi di diritto processuale civile (1894- 1937), vol. III, Milano,
1933, p. 231 ss.
CICERONE, Laelius de amicitia, cap. 22, § 85.
COGLIOLO, P., Esecuzione di cosa giudicata, Torino, 1883.
CONSO, G., I fatti processuali penali, Milano, Giuffrè, 1955.
CONSO, G. – GREVI, V., Commentario breve al nuovo codice di
procedura penale, Padova, CEDAM, 1987
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, Padova,
CEDAM, 2005.
COPPI, F., Reato continuato e cosa giudicata, Napoli, Jovene, 1969.
CORDERO, F., Guida alla procedura penale, Torino, 1986.
Processo penale, Milano, Giuffrè, 1971
Procedura penale, Milano, Giuffrè, 1987.
Processo penale, Milano, Giuffrè, 2006.
CORNIL, Une conjecture sur l’origine de la maxime “bis de eadem re
ne sit actio”, in Studi in onore di Pietro Bonfante, vol. III, Milano,
1930.
CRESPI- FORTI- ZUCCALA’, Reato continuato, in AA. VV.
Commentario breve al codice penale, Torino, UTET, 1999, p. 376 ss.
CRISTIANI, A., Manuale del nuovo processo penale, Torino, 1991.
192
DEAD, L’accertamento giudiziale nei procedimenti semplificati e
l’efficacia extrapenale del giudicato, in A. Gaito, I giudizi
semplificati, Padova, CEDAM, 1989, p. 355.
DE LUCA, G., Concorso formale e limiti oggettivi della cosa
giudicata penale, in Riv. proc. pen., 1960, p. 191.
I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, Giuffrè, 1963.
Giudicato ( dir. proc. pen.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969.
Giudicato II ( dir. proc. pen.), in Enc. giur., XV, Roma, Treccani,
1990.
D’ORAZI, M., La revisione del giudicato penale. Percorsi
costituzionali e requisiti di ammissibilità, Padova, CEDAM, 2003.
ESCOBEDO, G., Ancora sulla nozione di reato permanente specie sui
rapporti di bigamia, in Giust. pen., 1927, col. 819 ss.
Querele ed imputazione in rapporto ai reati permanenti, in La
procedura penale italiana, 1921, col. 200 ss.
FINDACA - MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna,
Zanichelli, 2007.
FOSCHINI, G., La pregiudizialità nel processo penale, Milano,
Giuffrè, 1942.
La regiudicanda, in Annali della Università di Macerata, Milano,
Giuffrè, 1956.
FROSALI, R. A., Sistema penale italiano, vol. IV, Torino, 1958.
GAIO, Istitutiones, III, 180.
GAITO, A., Esecuzione penale, in AA. VV. Profili del nuovo codice
di procedura penale, a cura di G. CONSO- V. GREVI, Padova,
CEDAM, 1996.
193
Esecuzione, in Compendio di procedura penale, a cura di G. CONSOV. GREVI, Padova, 2003, p. 928.
Codice di procedura penale ipertestuale, UTET, 2001, p. 2199 ss.
Ne bis in idem, in Codice di procedura penale ipertestuale, Tomo I,
UTET, 2006, p. 2786- 2792.
GALLI, M., L’inammissibilità dell’atto processuale penale, Milano,
1986.
GALLO, M., Reato permanente e omesso conferimento di grano
all’ammasso, in Riv. it. prc. Pen., 1948, p. 333 ss.
GHIARA, Art. 649 c.p.p., in Commentario breve al codice di
procedura penale, a cura di M. Chiavario, VI, Torino, 1989.
Art. 652, in Commento al codice di procedura penale, VI, Torino,
1991, p. 454 ss.
GIOVENE, A., Giudicato, in Digesto penale, ed. VI, vol. V, UTET,
1991.
GIULIANI, L., Riflessioni in tema di giudicato e continuazione, nota
alla sentenza Cass. pen., 18 febbraio 1975.
GREGORACI, G., Delle regole della continuazione se i vari atti che
la compongono vengono giudicati separatamente, in Riv. pen., XCIX,
1924.
GRISPIGNI, F., Diritto penale italiano, I, Milano, Giuffrè, 1947.
Diritto penale italiano, II, Milano, Giuffrè, 1952.
GUARNIERI, G., In tema di inammissibilità di un nuovo giudizio per
il medesimo fatto, in Giust. pen., 1948, III, c. Tribunale penale
Ravenna, 6 dicembre 1946.
Regiudicanda, in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, p. 230 ss.
194
Giudizio ( Rapporto tra il giudizio civile e il giudizio penale), in
Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1961, p. 893 ss.
Guida al diritto, n. 17, 23 aprile 2011, p. 44- 59.
IMPALLOMENI, G.B., Concorrenza reale e concorrenza formale di
reati, in Istituzioni di diritto penale, Torino, UTET, 1921.
Il codice penale illustrato, col. I, Firenze, Civelli, 1980.
LEVI, A., La certezza del diritto con il concetto di azione, in Scritti
giuridici in onore di F. Carnelutti, I, Padova, 1950, p. 81- 95.
LIEBMAN, T., Efficacia ed autorità delle sentenze, Padova, 1935.
LEONE, G., Del reato abituale, permanente e continuato, Napoli,
Jovene, 1933.
Lineamenti di diritto processuale penale, Napoli, Jovene, 1936.
Trattato di diritto processuale penale, vol. III, Napoli, 1961.
Manuale di diritto processuale penale, Napoli, Jovene, 1956.
Manuale di diritto processuale penale, Napoli, Jovene, 1988.
LOZZI, G., Profili di un indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e
concorso formale di reati, Milano, Giuffrè, 1974.
Favor rei e processo penale, Milano, 1965.
Giudicato ( dir. pen.), in Enc. dir., Giuffrè, 1969, p. 913- 923.
LUCARELLI, U., L’istituto del giudicato e i suoi effetti civili, UTET,
2003.
MANTOVANI, F., Concorso e conflitto di norme nel diritto penale,
1966.
Diritto penale, Parte generale, CEDAM, 2007.
195
MANZINI, V., Trattato di diritto penale italiano secondo il nuovo
codice penale 1930, vol. I, UTET, 1933, n. 234.
Istituzioni di procedura penale, Padova, 1946.
Diritto processuale penale italiano, vol. IV, Torino, 1949.
Trattato di diritto processuale penale, vol. V, Torino, 1956.
MASSARI, E., Il momento esecutivo del reato: contributo alla teoria
dell’atto punibile, n. 37, Pisa: Mariotti, 1923.
NUVOLONE, P., Contributo alla teoria della sentenza istruttoria
penale, Padova, 1943.
PAGLIARO, A., Concorso di reati, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961,
p. 670.
Fatto ( dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. 1064, XVI, Milano, p. 964966.
QUINTILIANO, in Istitutiones oratoriae, VII, cap. 6, § 4.
RAIMONDI, S., Rapporti tra giudicato penale e responsabilità
amministrativa, in Le sanzioni disciplinari, Giuffrè, 2003, p. 180 ss.
RAMPONI, R., Nuovi profili del reato continuato, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1978, p. 604 ss.
RANIERI, S., Manuale di diritto penale, Padova, CEDAM, 1952.
RIVELLO, P.P., voce: Ne bis in idem, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
Milano, Giuffrè, 1991, p. 476- 528.
Commento all’art. 649 c.p.p., in AA. VV., Commento al nuovo codice
di procedura penale, coordinato da m. Chiavario, vol. IV, UTET,
1991.
ROCCO, A., Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione
dell’azione penale, Modena, 1900.
196
Sul concetto di decisione giudiziaria penale, quale presupposto
formale della cosa giudicata penale, in Opere giuridiche, III, Roma,
1933, p. 67 ss.
ROCCO, U., L’autorità della cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi,
Roma, 1917.
RUGGIERI, S., Giudicato penale e accertamenti non definitivi,
Milano, Giuffrè, 2004.
SABATINI, G., Il reato progressivo nel sistema alle deroghe al
concorso dei reati, in Studi in onore di Ugo Conti, Città di Castello,
1931, p. 51 ss.
Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Torino,
1933.
Istituzioni di diritto penale, I, Catania, 1946.
SANTORO, E., Manuale di procedura penale, Torino, 1954.
SIRACUSANO, D., Assoluzione ( dir. proc. pen.), in Enc. dir., III,
1958, p. 935 ss.
SPANGHER, G., Nuovi profili nei rapporti tra processo civile e
processo penale, in AA. VV., Nuovi profili nei rapporti tra processo
civile e processo penale, Milano, Giuffrè, 1995, p. 31.
TERRUSI, F., Rapporti tra giudicato penale e giudizio
amministrativo, in Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, p. 31- 47.
TRANCHINA, G., L’esecuzione, in Dir. proc. pen., II, Siracusano, D.,
Galati, D., Tranchina, G., Zappalà, E., Milano, Giuffrè, 2004.
TONINI, P., Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2009.
VANNINI, O., Lineamenti di diritto penale, n. 43, Firenze, casa
editrice poligrafica universitaria, 1933.
Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 1953.
197
VASSALLI, G., Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in
Enc. dir., vol. II, Milano, Giuffrè, 1958, p. 505- 519.
Voce: Reato progressivo, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, Giuffrè,
1987, p. 1155.
VENDITTI, R., Cosa giudicata. Efficacia riflessa in altri giudizi, in
Arch. riv. giur., 1950, p. 602.
ZASIO, in Dig. 42, 1, 63 de re iudicata, n. 76 ss.
ZENCOVICH, V. Z., La responsabilità civile da reato, Padova,
CEDAM, 1989.
198