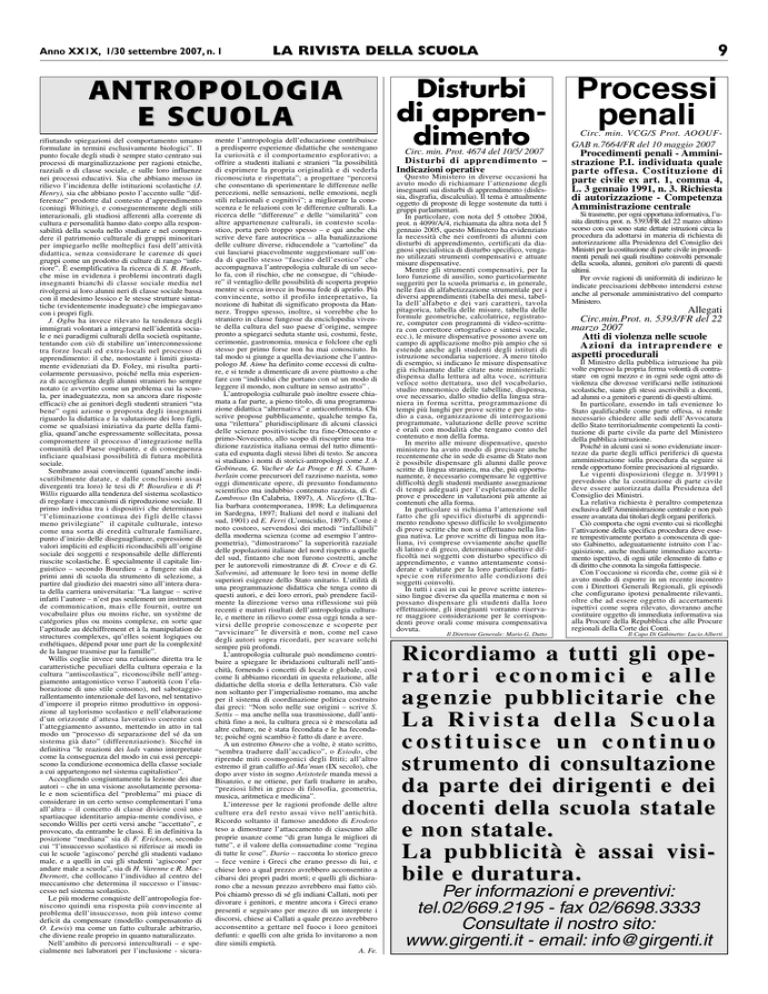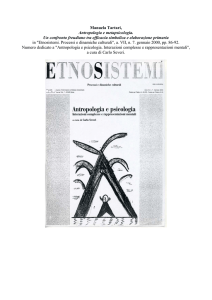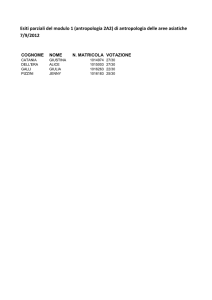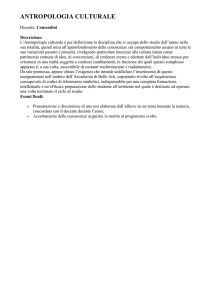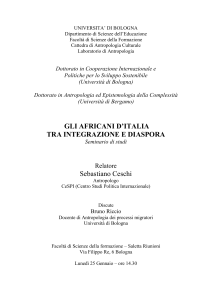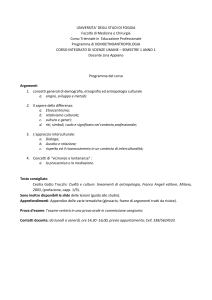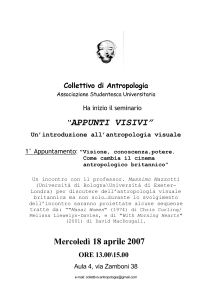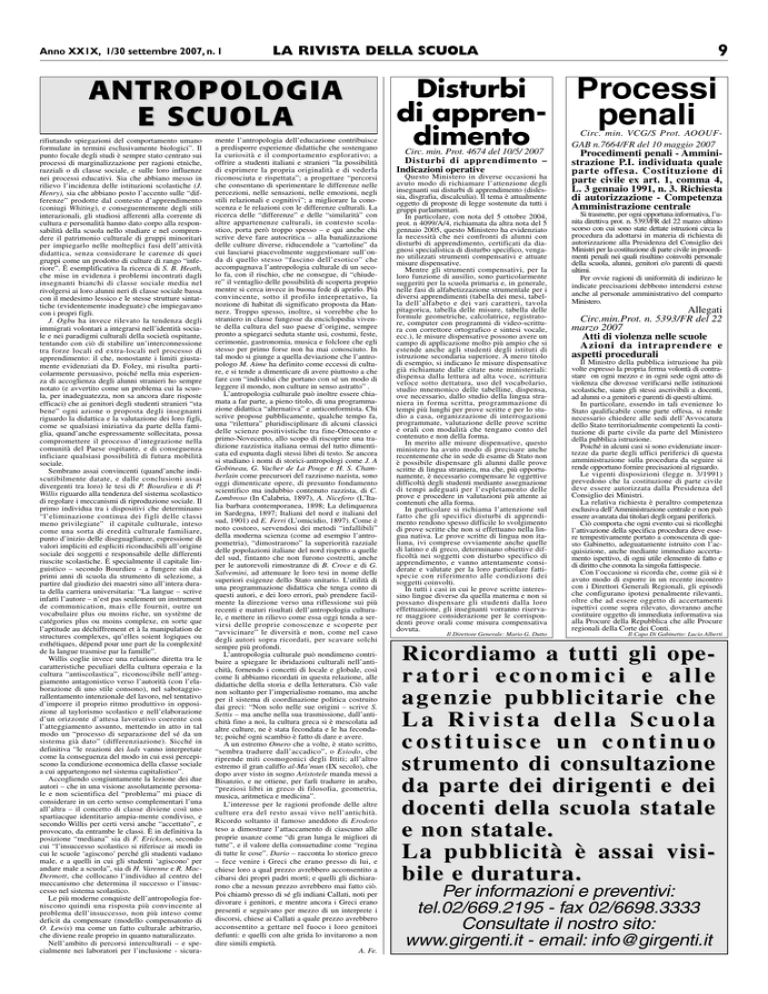
Anno XX1X, 1/30 settembre 2007, n. 1
ANTRO P O L O G IA
E SC U O L A
rifiutando spiegazioni del comportamento umano
formulate in termini esclusivamente biologici”. Il
punto focale degli studi è sempre stato centrato sui
processi di marginalizzazione per ragioni etniche,
razziali o di classe sociale, e sulle loro influenze
nei processi educativi. Sia che abbiano messo in
rilievo l’incidenza delle istituzioni scolastiche (J.
Henry), sia che abbiano posto l’accento sulle “differenze” prodotte dal contesto d’apprendimento
(coniugi Whiting), e conseguentemente degli stili
interazionali, gli studiosi afferenti alla corrente di
cultura e personalità hanno dato corpo alla responsabilità della scuola nello studiare e nel comprendere il patrimonio culturale di gruppi minoritari
per impiegarlo nelle molteplici fasi dell’attività
didattica, senza considerare le carenze di quei
gruppi come un prodotto di culture di rango “inferiore”. È esemplificativa la ricerca di S. B. Heath,
che mise in evidenza i problemi incontrati dagli
insegnanti bianchi di classe sociale media nel
rivolgersi ai loro alunni neri di classe sociale bassa
con il medesimo lessico e le stesse strutture sintattiche (evidentemente inadeguate) che impiegavano
con i propri figli.
J. Ogbu ha invece rilevato la tendenza degli
immigrati volontari a integrarsi nell’identità sociale e nei paradigmi culturali della società ospitante,
tentando con ciò di stabilire un’interconnessione
tra forze locali ed extra-locali nel processo di
apprendimento: il che, nonostante i limiti giustamente evidenziati da D. Foley, mi risulta particolarmente persuasivo, poiché nella mia esperienza di accoglienza degli alunni stranieri ho sempre
notato (e avvertito come un problema cui la scuola, per inadeguatezza, non sa ancora dare risposte
efficaci) che ai genitori degli studenti stranieri “sta
bene” ogni azione o proposta degli insegnanti
riguardo la didattica e la valutazione dei loro figli,
come se qualsiasi iniziativa da parte della famiglia, quand’anche espressamente sollecitata, possa
compromettere il processo d’integrazione nella
comunità del Paese ospitante, e di conseguenza
inficiare qualsiasi possibilità di futura mobilità
sociale.
Sembrano assai convincenti (quand’anche indiscutibilmente datate, e dalle conclusioni assai
divergenti tra loro) le tesi di P. Bourdieu e di P.
Willis riguardo alla tendenza del sistema scolastico
di regolare i meccanismi di riproduzione sociale. Il
primo individua tra i dispositivi che determinano
“l’eliminazione continua dei figli delle classi
meno privilegiate” il capitale culturale, inteso
come una sorta di eredità culturale familiare,
punto d’inizio delle diseguaglianze, espressione di
valori impliciti ed espliciti riconducibili all’origine
sociale dei soggetti e responsabile delle differenti
riuscite scolastiche. È specialmente il capitale linguistico – secondo Bourdieu - a fungere sin dai
primi anni di scuola da strumento di selezione, a
partire dal giudizio dei maestri sino all’intera durata della carriera universitaria: “La langue – scrive
infatti l’autore – n’est pas seulement un instrument
de communication, mais elle fournit, outre un
vocabulaire plus ou moins riche, un système de
catégories plus ou moins complexe, en sorte que
l’aptitude au déchiffrement et à la manipulation de
structures complexes, qu’elles soient logiques ou
esthétiques, dépend pour une part de la complexité
de la langue trasmise par la famille”.
Willis coglie invece una relazione diretta tra le
caratteristiche peculiari della cultura operaia e la
cultura “antiscolastica”, riconoscibile nell’atteggiamento antagonistico verso l’autorità (con l’elaborazione di uno stile consono), nel sabotaggiorallentamento intenzionale del lavoro, nel tentativo
d’imporre il proprio ritmo produttivo in opposizione al taylorismo scolastico e nell’elaborazione
d’un orizzonte d’attesa lavorativo coerente con
l’atteggiamento assunto, mettendo in atto in tal
modo un “processo di separazione del sé da un
sistema già dato” (differenziazione). Sicché in
definitiva “le reazioni dei lads vanno interpretate
come la conseguenza del modo in cui essi percepiscono la condizione economica della classe sociale
a cui appartengono nel sistema capitalistico”.
Accogliendo congiuntamente la lezione dei due
autori – che in una visione assolutamente personale e non scientifica del “problema” mi piace di
considerare in un certo senso complementari l’una
all’altra – il concetto di classe diviene così uno
spartiacque identitario ampia-mente condiviso, e
secondo Willis per certi versi anche “accettato”, e
provocato, da entrambe le classi. È in definitiva la
posizione “mediana” sia di F. Erickson, secondo
cui “l’insuccesso scolastico si riferisce ai modi in
cui le scuole ‘agiscono’ perché gli studenti vadano
male, e a quelli in cui gli studenti ‘agiscono’ per
andare male a scuola”, sia di H. Varenne e R. MacDermott, che collocano l’individuo al centro del
meccanismo che determina il successo o l’insuccesso nel sistema scolastico.
Le più moderne conquiste dell’antropologia forniscono quindi una risposta più convincente al
problema dell’insuccesso, non più inteso come
deficit da compensare (modello compensatorio di
O. Lewis) ma come un fatto culturale arbitrario,
che diviene reale proprio in quanto naturalizzato.
Nell’ambito di percorsi interculturali – e specialmente nei laboratori per l’inclusione - sicura-
9
LA RIVISTA DELLA SCUOLA
mente l’antropologia dell’educazione contribuisce
a predisporre esperienze didattiche che sostengano
la curiosità e il comportamento esplorativo; a
offrire a studenti italiani e stranieri “la possibilità
di esprimere la propria originalità e di vederla
riconosciuta e rispettata”; a progettare “percorsi
che consentano di sperimentare le differenze nelle
percezioni, nelle sensazioni, nelle emozioni, negli
stili relazionali e cognitivi”; a migliorare la conoscenza e le relazioni con le differenze culturali. La
ricerca delle “differenze” e delle “similarità” con
altre appartenenze culturali, in contesto scolastico, porta però troppo spesso – e qui anche chi
scrive deve fare autocritica – alla banalizzazione
delle culture diverse, riducendole a “cartoline” da
cui lasciarsi piacevolmente suggestionare sull’onda di quello stesso “fascino dell’esotico” che
accompagnava l’antropologia culturale di un secolo fa, con il rischio, che ne consegue, di “chiudere” il ventaglio delle possibilità di scoperta proprio
mentre si cerca invece in buona fede di aprirlo. Più
convincente, sotto il profilo interpretativo, la
nozione di habitat di significato proposta da Hannerz. Troppo spesso, inoltre, si vorrebbe che lo
straniero in classe fungesse da enciclopedia vivente della cultura del suo paese d’origine, sempre
pronto a spiegarci seduta stante usi, costumi, feste,
cerimonie, gastronomia, musica e folclore che egli
stesso per primo forse non ha mai conosciuto. In
tal modo si giunge a quella deviazione che l’antropologo M. Aime ha definito come eccessi di culture, e si tende a dimenticare di avere piuttosto a che
fare con “individui che portano con sé un modo di
leggere il mondo, non culture in senso astratto” .
L’antropologia culturale può inoltre essere chiamata a far parte, a pieno titolo, di una programmazione didattica “alternativa” e anticonformista. Chi
scrive propose pubblicamente, qualche tempo fa,
una “rilettura” pluridisciplinare di alcuni classici
delle scienze positivistiche tra fine-Ottocento e
primo-Novecento, allo scopo di riscoprire una tradizione razzistica italiana ormai del tutto dimenticata ed espunta dagli stessi libri di testo. Se ancora
si studiano i nomi di storici-antropologi come J. A
Gobineau, G. Vacher de La Pouge e H. S. Chamberlain come precursori del razzismo nazista, sono
oggi dimenticate opere, di presunto fondamento
scientifico ma indubbio contenuto razzista, di C.
Lombroso (In Calabria, 1897), A. Niceforo (L’Italia barbara contemporanea, 1898; La delinquenza
in Sardegna, 1897; Italiani del nord e italiani del
sud, 1901) ed E. Ferri (L’omicidio, 1897). Come è
noto costoro, servendosi dei metodi “infallibili”
della moderna scienza (come ad esempio l’antropometria), “dimostrarono” la superiorità razziale
delle popolazioni italiane del nord rispetto a quelle
del sud, fintanto che non furono costretti, anche
per le autorevoli rimostranze di B. Croce e di G.
Salvemini, ad attenuare le loro tesi in nome delle
superiori esigenze dello Stato unitario. L’utilità di
una programmazione didattica che tenga conto di
questi autori, e dei loro errori, può prendere facilmente la direzione verso una riflessione sui più
recenti e maturi risultati dell’antropologia culturale, e mettere in rilievo come essa oggi tenda a servirsi delle proprie conoscenze e scoperte per
“avvicinare” le diversità e non, come nel caso
degli autori sopra ricordati, per scavare solchi
sempre più profondi.
L’antropologia culturale può nondimeno contribuire a spiegare le ibridazioni culturali nell’antichità, fornendo i concetti di locale e globale, così
come li abbiamo ricordati in questa relazione, alle
didattiche della storia e della letteratura. Ciò vale
non soltanto per l’imperialismo romano, ma anche
per il sistema di coordinazione politica costruito
dai greci: “Non solo nelle sue origini – scrive S.
Settis – ma anche nella sua trasmissione, dall’antichità fino a noi, la cultura greca si è mescolata ad
altre culture, ne è stata fecondata e le ha fecondate; poiché ogni scambio è fatto di dare e avere.
A un estremo Omero che a volte, è stato scritto,
“sembra tradurre dall’accadico”, o Esiodo, che
riprende miti cosmogonici degli Ittiti; all’altro
estremo il gran califfo al-Ma’mun (IX secolo), che
dopo aver visto in sogno Aristotele manda messi a
Bisanzio, e ne ottiene, per farli tradurre in arabo,
“preziosi libri in greco di filosofia, geometria,
musica, aritmetica e medicina”.
L’interesse per le ragioni profonde delle altre
culture era del resto assai vivo nell’antichità.
Ricordo soltanto il famoso aneddoto di Erodoto
teso a dimostrare l’attaccamento di ciascuno alle
proprie usanze come “di gran lunga le migliori di
tutte”, e il valore della consuetudine come “regina
di tutte le cose”. Dario – racconta lo storico greco
– fece venire i Greci che erano presso di lui, e
chiese loro a qual prezzo avrebbero acconsentito a
cibarsi dei propri padri morti; e quelli gli dichiararono che a nessun prezzo avrebbero mai fatto ciò.
Poi chiamò presso di sé gli indiani Callati, noti per
divorare i genitori, e mentre ancora i Greci erano
presenti e seguivano per mezzo di un interprete i
discorsi, chiese ai Callati a quale prezzo avrebbero
acconsentito a gettare nel fuoco i loro genitori
defunti: e quelli con alte grida lo invitarono a non
dire simili empietà.
A. Fe.
Disturbi
di apprendimento
Circ. min. Prot. 4674 del 10/5/ 2007
Disturbi di apprendimento –
Indicazioni operative
Questo Ministero in diverse occasioni ha
avuto modo di richiamare l’attenzione degli
insegnanti sui disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia). Il tema è attualmente
oggetto di proposte di legge sostenute da tutti i
gruppi parlamentari.
In particolare, con nota del 5 ottobre 2004,
prot. n 4099/A/4, richiamata da altra nota del 5
gennaio 2005, questo Ministero ha evidenziato
la necessità che nei confronti di alunni con
disturbi di apprendimento, certificati da diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano utilizzati strumenti compensativi e attuate
misure dispensative.
Mentre gli strumenti compensativi, per la
loro funzione di ausilio, sono particolarmente
suggeriti per la scuola primaria e, in generale,
nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i
diversi apprendimenti (tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tavola
pitagorica, tabella delle misure, tabella delle
formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale,
ecc.), le misure dispensative possono avere un
campo di applicazione molto più ampio che si
estende anche agli studenti degli istituti di
istruzione secondaria superiore. A mero titolo
di esempio, si indicano le misure dispensative
già richiamate dalle citate note ministeriali:
dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura
veloce sotto dettatura, uso del vocabolario,
studio mnemonico delle tabelline, dispensa,
ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di
tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni
programmate, valutazione delle prove scritte
e orali con modalità che tengano conto del
contenuto e non della forma.
In merito alle misure dispensative, questo
ministero ha avuto modo di precisare anche
recentemente che in sede di esame di Stato non
è possibile dispensare gli alunni dalle prove
scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive
difficoltà degli studenti mediante assegnazione
di tempi adeguati per l’espletamento delle
prove e procedere in valutazioni più attente ai
contenuti che alla forma.
In particolare si richiama l’attenzione sul
fatto che gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento
di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle
di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di
apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei
soggetti coinvolti.
In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si
possano dispensare gli studenti dalla loro
effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa
dovuta.
Il Direttore Generale: Mario G. Dutto
Processi
penali
Circ. min. VCG/S Prot. AOOUFGAB n.7664/FR del 10 maggio 2007
Procedimenti penali - Amministrazione P.I. individuata quale
parte offesa. Costituzione di
parte civile ex art. 1, comma 4,
L. 3 gennaio 1991, n. 3. Richiesta
di autorizzazione - Competenza
Amministrazione centrale
Si trasmette, per ogni opportuna informativa, l’unita direttiva prot. n. 5393/FR del 22 marzo ultimo
scorso con cui sono state dettate istruzioni circa la
procedura da adottarsi in materia di richiesta di
autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la costituzione di parte civile in procedimenti penali nei quali risultino coinvolti personale
della scuola, alunni, genitori e/o parenti di questi
ultimi.
Per ovvie ragioni di uniformità di indirizzo le
indicate precisazioni debbono intendersi estese
anche al personale amministrativo del comparto
Ministero.
Allegati
Circ.min.Prot. n. 5393/FR del 22
marzo 2007
Atti di violenza nelle scuole
Azioni da intraprendere e
aspetti procedurali
Il Ministro della pubblica istruzione ha più
volte espresso la propria ferma volontà di contrastare on ogni mezzo e in ogni sede ogni atto di
violenza che dovesse verificarsi nelle istituzioni
scolastiche, siano gli stessi ascrivibili a docenti,
ad alunni o a genitori e parenti di questi ultimi.
In particolare, essendo in tali evenienze lo
Stato qualificabile come parte offesa, si rende
necessario chiedere alle sedi dell’Avvocatura
dello Stato territorialmente competenti la costituzione di parte civile da parte del Ministero
della pubblica istruzione.
Poiché in alcuni casi si sono evidenziate incertezze da parte degli uffici periferici di questa
amministrazione sulla procedura da seguire si
rende opportuno fornire precisazioni al riguardo.
Le vigenti disposizioni (legge n. 3/1991)
prevedono che la costituzione di parte civile
deve essere autorizzata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
La relativa richiesta è peraltro competenza
esclusiva dell’Amministrazione centrale e non può
essere avanzata dai titolari degli organi periferici.
Ciò comporta che ogni evento cui si ricolleghi
l’attivazione della specifica procedura deve essere tempestivamente portato a conoscenza di questo Gabinetto, adeguatamente istruito con l’acquisizione, anche mediante immediato accertamento ispettivo, di ogni utile elemento di fatto e
di diritto che connota la singola fattispecie.
Con l’occasione si ricorda che, come già si è
avuto modo di esporre in un recente incontro
con i Direttori Generali Regionali, gli episodi
che configurano ipotesi penalmente rilevanti,
oltre che ad essere oggetto di accertamenti
ispettivi come sopra rilevato, dovranno anche
costituire oggetto di immediata informativa sia
alla Procure della Repubblica che alle Procure
regionali della Corte dei Conti.
Il Capo Di Gabinetto: Lucio Alberti
Ricor diamo a tutti gli ope ratori economici e alle
a g enzie pub b licitar ie c he
La Rivista della Scuola
costituisce un continuo
str umento di consultazione
da par te dei dir ig enti e dei
docenti della scuola sta tale
e non sta tale .
La pub b licità è assai visi bile e dur a tur a.
Per informazioni e preventivi:
tel.02/669.2195 - fax 02/6698.3333
Consultate il nostro sito:
www.girgenti.it - email: [email protected]