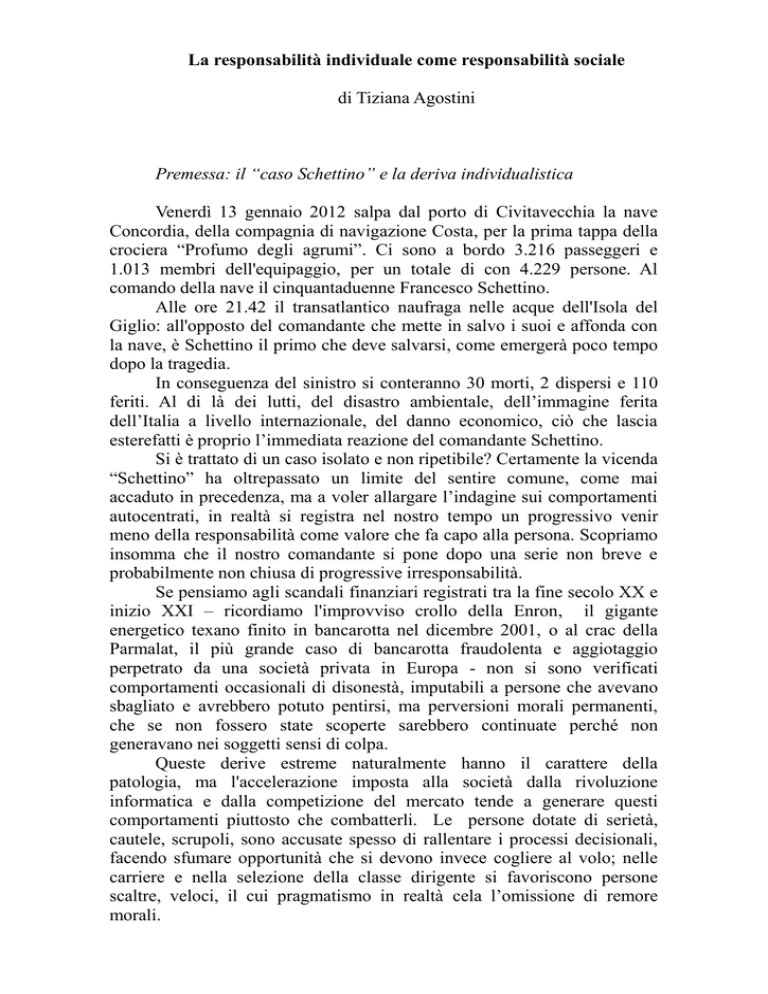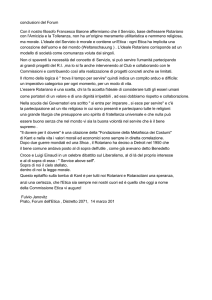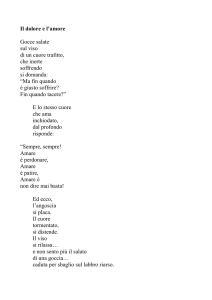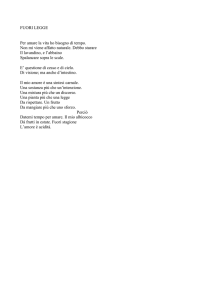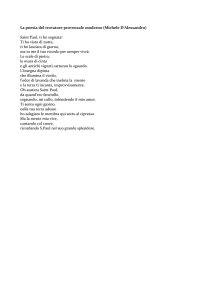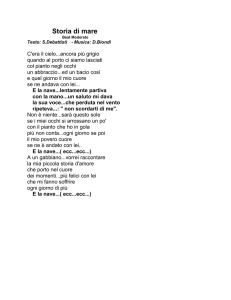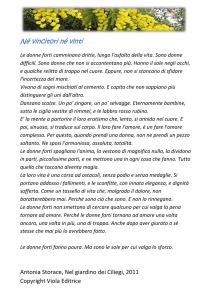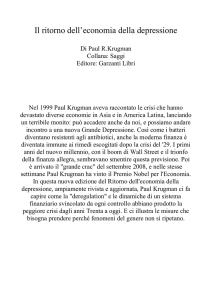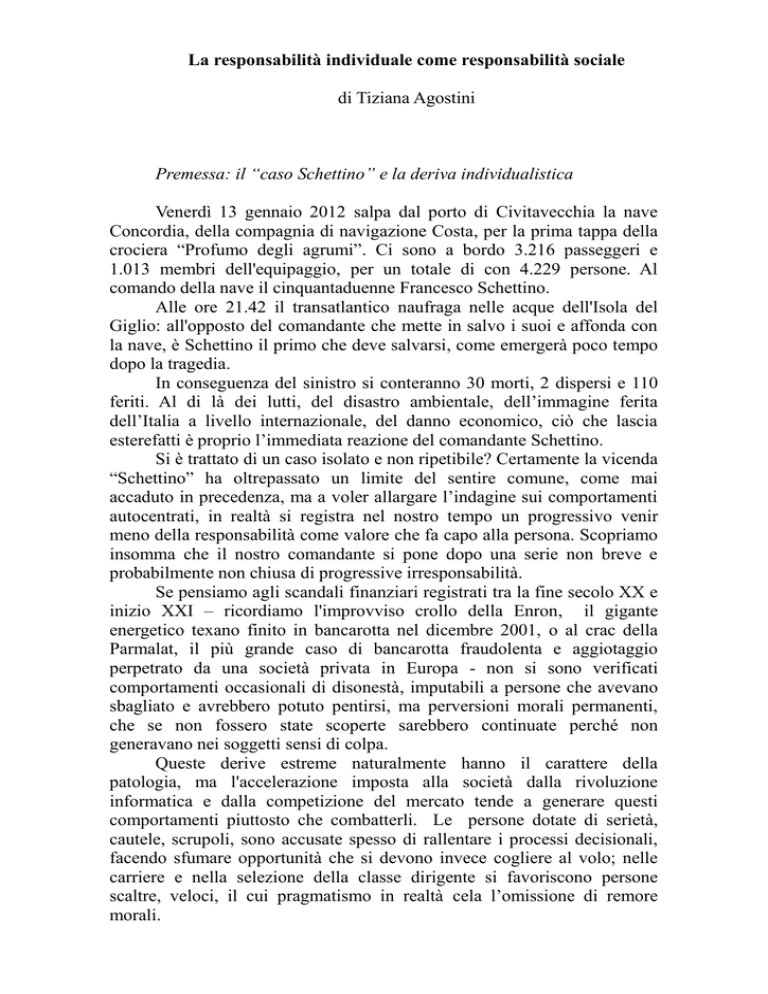
La responsabilità individuale come responsabilità sociale
di Tiziana Agostini
Premessa: il “caso Schettino” e la deriva individualistica
Venerdì 13 gennaio 2012 salpa dal porto di Civitavecchia la nave
Concordia, della compagnia di navigazione Costa, per la prima tappa della
crociera “Profumo degli agrumi”. Ci sono a bordo 3.216 passeggeri e
1.013 membri dell'equipaggio, per un totale di con 4.229 persone. Al
comando della nave il cinquantaduenne Francesco Schettino.
Alle ore 21.42 il transatlantico naufraga nelle acque dell'Isola del
Giglio: all'opposto del comandante che mette in salvo i suoi e affonda con
la nave, è Schettino il primo che deve salvarsi, come emergerà poco tempo
dopo la tragedia.
In conseguenza del sinistro si conteranno 30 morti, 2 dispersi e 110
feriti. Al di là dei lutti, del disastro ambientale, dell’immagine ferita
dell’Italia a livello internazionale, del danno economico, ciò che lascia
esterefatti è proprio l’immediata reazione del comandante Schettino.
Si è trattato di un caso isolato e non ripetibile? Certamente la vicenda
“Schettino” ha oltrepassato un limite del sentire comune, come mai
accaduto in precedenza, ma a voler allargare l’indagine sui comportamenti
autocentrati, in realtà si registra nel nostro tempo un progressivo venir
meno della responsabilità come valore che fa capo alla persona. Scopriamo
insomma che il nostro comandante si pone dopo una serie non breve e
probabilmente non chiusa di progressive irresponsabilità.
Se pensiamo agli scandali finanziari registrati tra la fine secolo XX e
inizio XXI – ricordiamo l'improvviso crollo della Enron, il gigante
energetico texano finito in bancarotta nel dicembre 2001, o al crac della
Parmalat, il più grande caso di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio
perpetrato da una società privata in Europa - non si sono verificati
comportamenti occasionali di disonestà, imputabili a persone che avevano
sbagliato e avrebbero potuto pentirsi, ma perversioni morali permanenti,
che se non fossero state scoperte sarebbero continuate perché non
generavano nei soggetti sensi di colpa.
Queste derive estreme naturalmente hanno il carattere della
patologia, ma l'accelerazione imposta alla società dalla rivoluzione
informatica e dalla competizione del mercato tende a generare questi
comportamenti piuttosto che combatterli. Le persone dotate di serietà,
cautele, scrupoli, sono accusate spesso di rallentare i processi decisionali,
facendo sfumare opportunità che si devono invece cogliere al volo; nelle
carriere e nella selezione della classe dirigente si favoriscono persone
scaltre, veloci, il cui pragmatismo in realtà cela l’omissione di remore
morali.
A questa darwiniana selezione sociale al negativo si accompagna
nelle nostre comunità il venir meno dei legami interpersonali e dello spirito
di solidarietà tipico della civiltà contadina.
Nella dimensione rurale del vivere, scandita da ritmi ordinari e
caratterizzata dalla sedentarietà, un individuo nel corso della sua vita
entrava in relazione al massimo con due-trecento persone e si sentiva in
qualche maniera ad esse obbligato: oggi che metà della popolazione vive in
metropoli le incontra in un giorno.
Vedere troppe persone significa non riconoscerle, non distinguerle e
dunque non potersi rispecchiare in esse creando una empatia e conseguenti
legami diretti o sociali. Poiché l'individuo per crescere ha bisogno di
imitare l’altro, il non poter emulare i propri simili determina un senso di
totale smarrimento. La più grave forma di solitudine è infatti quella del
singolo risucchiato dalla folla indistinta. Meglio allora per lui ripiegarsi,
isolarsi per non essere travolto da una sorta di inondazione permanente,
perché evitare gli altri può diventare anche un modo per sopravvivere.
E se un po’ di anni fa i ragazzi si erano messi gli auricolari per
utilizzare il nuovo mezzo di riproduzione sonora inventato, il walkman,
oggi il cosiddetto sounding out, il separarsi dalla colonna sonora della città
genera forme progressive di autismo digitale. Non ci interessano più i
vicini di casa o i vicini di sedile, in treno piuttosto che in metropolitana.
Perdiamo la curiosità per l’altro, reprimiamo i sentimenti, per timore di
esporci, preferiamo rimanere centrati su noi stessi, passando il tempo a
consultare gli schermi dei nostri strumenti tascabili la cui funzione di
telefoni è solo una delle possibilità che ci offrono. Il pronome inglese io
“I”, come osserva Aime nel suo saggio La morte del prossimo (Einaudi,
2009), non a caso è divenuto il prefisso dei nuovi prodotti multimediali di
largo consumo più ambiti: I-Phone, I-Pad, I-Mac.
La lontananza dagli altri non è solo una scelta che va ascritta alla
libertà dell’individuo, ma un effetto indotto dalle condizioni odierne di
esistere, e determina una situazione di privazione relazionale, capace di
generare patologie del soggetto e della collettività. L'individuo solo
incontra la depressione e, in un circolo vizioso, sente venir meno la forza e
la spinta per andare incontro all'altro.
Siamo di fronte ad una sorta di declino di civiltà e se già altre epoche
hanno conosciuto il declino, il nostro è quello di più vaste proporzioni,
visto che il degrado umano generato dall’urbanesimo e da una certa crescita
economica coinvolge il pianeta intero.
Ma guardare ancora una volta alla storia, trovando analogie con il
nostro tempo, può fornire qualche spunto per tracciare un cammino
nuovamente positivo.
Pensiamo ad esempio al declino dei Romani, certamente determinato
dall'arrivo dei barbari, ma anche da una crisi interna della società, una vera
e propria crisi morale, come ricorda Agostino nella Civitate Dei, che aveva
spostato la mentalità comune dalla veritas alla vanitas. E le due logiche si
contrappongono perché la vanità dà il primato all'apparenza, alla maschera
rassicurante che indossiamo e dentro alla quale perdiamo la nostra unicità
di persone, mentre la verità fonda le sue scelte sui valori permanenti, sulla
dignità del soggetto.
L’effetto “butterfly”
Di fronte allo smarrimento epocale che stiamo vivendo, alla società
liquida dove anche i valori perdono solidità, come dimostrato da Zygmund
Baumann nei diversi scritti dedicati a questo tema, anche quando ci
sentiamo animati dalle migliori intenzioni, può sembrare difficile o
velleitario reagire, per non trasformarci in novelli don Chisciotte in lotta
contro la deriva sociale che fa sembrare monete fuori corso la
responsabilità individuale e il valore della relazione interpersonale.
Ma forse, anche in quanto rotariani, è necessario che guardiamo
dentro a noi stessi e anziché accusare l’altro o gli altri, la società o il
destino cinico e baro, ci assumiamo la responsabilità del nostro tempo. Una
responsabilità che parta da una decisione personale e assuma carattere
sociale e politico, per gli effetti che determina nella polis, quella locale
nella quale operiamo e quella globale a cui tutti apparteniamo.
Assumersi la responsabilità come gesto volontaristico senza aspettare
che altri provvedano – persone o istituzioni che siano – significa
automaticamente svolgere nei fatti quella funzione di leadership, a cui ogni
rotariano ambisce, ma che così gli può derivare non tanto da un desiderio di
supremazia sull’altro, ma dalla capacità di mettersi in gioco. La vera
funzione del leader è propria di colui che evita di stare a guardare e
prendere in mano la situazione per passare all’azione, a costo anche di
compiere un gesto solitario ed isolato, che però mette in moto una catena
positiva di reazioni.
Non dobbiamo temere che i nostri comportamenti si disperdano nella
massa indistinta delle persone come se le nostre azioni fossero stille
d’acqua nell’oceano, ma avere la convinzione che dal nostro agire dipenda
la salvezza dell’umanità.
Questo tipo di comportamento è chiamato, come è noto, effetto
butterfly: un battito d’ali di una farfalla a Macao o a Hong Kong può far
crollare un grattacielo a Chicago o la Borsa di Wall Street.
La responsabilità sociale è in primo luogo un fatto individuale e in
questa dimensione va declinata: ammoniva ancora nel 1966 don Lorenzo
Milani in una lettera alla studentessa napoletana Nadia Neri che lo avrebbe
voluto riferimento collettivo: «So che vorreste che io fossi un uomo
pubblico a disposizione di tutti … non si può amare tutti gli uomini. Si può
amare una classe sola. Ma non si può nemmeno amare tutta una classe
sociale se non potenzialmente. Di fatto si può amare solo un numero di
persone limitato, forse qualche decina, forse qualche centinaio. E siccome
l'esperienza ci dice che all'uomo è possibile solo questo, mi pare evidente
che Dio non ci chiede di più».
Il magistero di Paul Harris
In un contesto non molto differente dalle metropoli di oggi,
caratterizzate da polverizzazione sociale e assenza di legami comunitari, si
trovò ad operare Paul Harris nella Chicago di inizio Novecento, la più
grande new town del secolo scorso, passata nel volger di pochi decenni,
dopo il devastante incendio del 1871, da poche migliaia di abitanti ad oltre
un milione, grazie al tumultuoso sviluppo economico registrato in quegli
anni. Lo stesso Harris vi era approdato dalla provincia, in cerca delle
opportunità professionali che la città sembrava offrire per la sua carriera di
avvocato, ma a prezzo dello sradicamento e della solitudine.
Proprio a Chicago egli maturò l’idea di creare non una nuova
associazione, ma una associazione nuova. Facendo leva sulla tradizionale
inclinazione americana all’associazionismo - rilevata ancora all’inizio
dell’Ottocento da Alexis de Tocqueville nel suo saggio La democrazia in
America quale carattere costitutivo della società dei pionieri degli Stati
Uniti –, ma superando l’idea di associazione fondata su persone affini per
orizzonte ideale o scopo professionale, egli mise insieme soggetti con
caratteri culturali, credo e attività lavorative differenti. Lo scopo non era
infatti perseguire una unità di intenti, ma una differente modalità
relazionale, basata sull’idea della sociabilità, ovvero sulla capacità di stare
insieme mettendo in primo piano non le identità personali ma i bisogni
individuali che richiedono di essere soddisfatti. Le condizioni dell’amicizia
rotariana vengono dunque legate al’idea di farsi carico dell’altro non in
quanto uguale a me, ma in quanto differente, eppure accomunato dalle
stesse necessità, reali e ideali.
L’idea del servire è la naturale conseguenza di questo pensiero, che
rifiuta la dimensione della carità, ma sviluppa quella di sentirsi responsabili
attivamente della comunità nella quale ci è capitato di vivere. Il prestigio
personale, a cui Paul Harris per primo ambisce, oltre ad una esistenza ricca
di rapporti, scaturisce in conseguenza a questo responsabilità individuale
che il rotariano deve assumere.
Paul Harris non è né un missionario, né un filantropo, né un utopista,
ma una persona che si è interrogata cercando di dare soluzioni personali a
bisogni anche collettivi, cancellando il deserto sociale di Chicago, come
egli stesso definisce il clima nel quale si era trovato ad operare.
Le risposte che si offrono alla comunità attraverso l’assunzione
personale di responsabilità qualificano la persona e la fanno diventare un
punto di riferimento della comunità nella quale opera.
Il sodalizio rotariano, va davvero sottolineato, non nasce
fortuitamente, ma in conseguenza ad un puntuale interrogarsi in primo
luogo del suo fondatore: come afferma Paul Harris nella sua autobiografia
My road to Rotary gli elementi che lo avevano generato erano stati un
misto di idealismo, ambizione, entusiasmo e determinazione.
La responsabilità rotariana
Ancor oggi essere rotariani significa assumere un volontario codice
etico in cui l’impegno personale è la cifra distintiva dell’interesse per gli
altri.
Il rotariano nel suo servire mette da parte le visioni
provvidenzialistiche e guarda alla comunità per quello che essa rappresenta
o, potremmo dire, parte dalla dimensione umana nella sua finitezza con
l'intento di trascenderla.
Punto di partenza è l’egualitarismo nel quale è chiamato a credere,
simboleggiato dalla ruota dentata, che rappresenta una forza semplice ma
irriducibile. Il rotariano impara a stare con gli altri a partire dai commensali
che siedono al suo tavolo per abituarsi a stare in relazione col mondo: solo
assumendosi la responsabilità del vicino ci si può far carico dell’intero
pianeta, non viceversa.
Già ammoniva in tal senso Jean Jacques Rousseau, quando
affermava che un filosofo ama i Tartari per essere dispensato dall'amare i
propri vicini, così come oggi è più facile adottare un bambino a distanza
che guardare la povertà sotto casa, perché la solidarietà ravvicinata
spaventa e compromette.
La vicinanza è invece una diga naturale a protezione dei sentimenti,
del nostro essere umani; sconfigge l’insensibilità e l’egolatria per costruire
le condizioni di una civil society.
Non c’è spazio nel Rotary per gli Schettino di turno.
Il rotariano non abbandona la nave e i suoi passeggeri al loro destino,
non si volta, o non dovrebbe voltarsi dall’altra parte quando vede un
problema che gli si presenta, ma se ne assume la responsabilità, in primo
luogo come fatto personale. È orgoglioso di appartenere ad una elite,
selezionata non dal sangue, dal denaro o dalla furbizia, ma dal talento,
dall’interesse per l’altro e dalla dedizione alla comunità.
Egli sa, come afferma Enzo Bianchi in L’altro siamo noi (Einaudi,
2010) che: «ritrovare la propria qualità di cittadini significa essere attori di
una storia collettiva, capaci di immaginare se stessi assieme agli altri, tesi a
riscoprire valori comuni e principi etici condivisi, attraverso i quali
edificare la polis, rifiutando che sia la forza a prevalere. Certo questo
richiede volontà».
Buon lavoro a tutti noi!