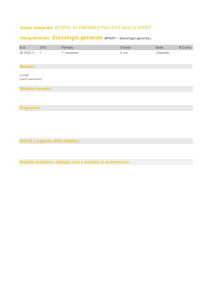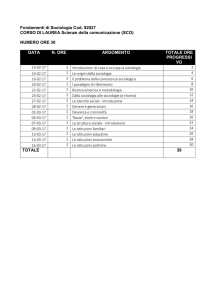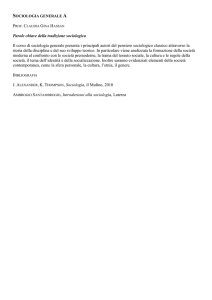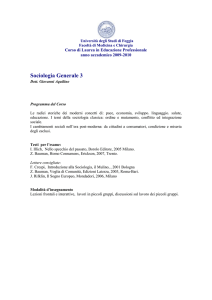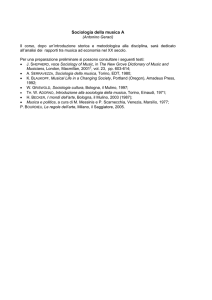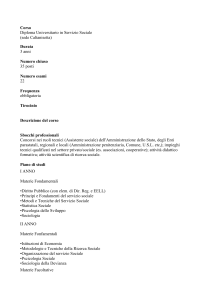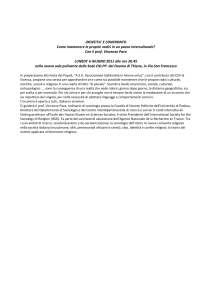N e w s l e t t e r
Novembre 2005, Anno 2, Numero 10
Sociologia e Ricerca Sociale
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
Ricerca Sociale
R i c e r c a
5
S o c i a l e
Prosegue, con questo articolo, la rubrica dedicata ai percorsi lungo i quali i docenti della
nostra facoltà e, più in generale, dell’Ateneo torinese sono diventati sociologi e sociologhe.
Questa volta abbiamo intervistato la professoressa Chiara Saraceno, titolare della cattedra di
Sociologia della Famiglia, coordinatrice del dottorato in Ricerca Sociale Comparata, oltre che
Presidente del Centro interdisciplinare di ricerche e studi delle donne (CIRSDe).
Intervista a Chiara Saraceno
di Michele Manocchi
D: Professoressa Saraceno, come si è avvicinata alla
sociologia?
R: Casualmente. Io appartengo a una generazione che non ha
incontrato la sociologia nel proprio percorso formativo. Non
c’era neanche un insegnamento di sociologia all’università,
quando l’ho fatta io. Io sono laureata in filosofia, e credo che
tra i sociologi della mia generazione siano tre i percorsi verso
la sociologia più rappresentati: chi proveniva da filosofia, chi
da lettere e chi da economia. Quella filosofica è un tipo di
formazione che io ritengo molto importante. Pensi che quando
sono andata a insegnare all’Università di Trento alla fine del
1968 – un fatto che ha deciso della mia vocazione sociologica
– gli studenti allora in agitazione chiedevano proprio corsi di
filosofia dato che per lo più provenivano da istituti tecnici e
non avevano mai studiato filosofia. Eppure si rendevano conto
che dietro il materialismo storico, dietro Marx, come dietro la
scuola di Francoforte – gli autori e la scuola di pensiero cui si
ispirava gran parte del movimento – c’era una tradizione di
pensiero filosofico che non poteva essere ignorata. Al di là di
questa notazione biografico-generazionale, In generale credo
che la preparazione filosofica costituisca una buona base per
destreggiarsi tra teorie e concetti, e credo aiuti anche ad
assumere un certo rigore intellettuale.
Ciò detto, la mia propensione sociologica, se così si può dire, è
emersa in realtà già con la tesi di laurea. Io mi sono laureata
in filosofia teoretica alla Cattolica di Milano col professor
Bontadini, con una tesi nata dalla lettura di Weber, e in
particolare da L’etica protestante e lo spirito del capitalismo:
ho cercato di ricostruire alcune delle teorie che Weber
presentava. La mia tesi era molto complicata, andava da
Johnatan Edwards a William James, dal puritanesimo al
pragmatismo americano, fino a Dewey. Cercavo una continuità
tra questi autori e le loro idee, tra il puritanesimo e il pragmatismo. Quindi questo è stato il mio primo contatto con la
sociologia. Ma non credo che sia per questo che sono diventata sociologa.
D: E cos’è che l’ha portata verso la sociologia?
R: Ho iniziato l’intervista con l’avverbio “casualmente”: credo
che sia importante, soprattutto per i giovani studiosi, considerare quanto ci sia di casuale nelle vicende biografiche e
professionali di ognuno di noi. E con questo mi vengono in
mente anche alcuni discorsi che sento oggigiorno sulla
precarietà della situazione dei giovani e sulla mancanza di
quelle certezze che invece caratterizzavano, a dire di alcuni, la
vita lavorativa e privata fino a qualche decennio fa. Io non
sono d’accordo con questa visione e credo invece che anche
allora, ai miei tempi (gli anni sessanta-settanta), la precarietà
fosse una condizione “normale” dei giovani. Solo che era
considerata in positivo, come apertura di possibilità. E ciò era
reso possibile, anche psicologicamente, non perché ci fossero
maggiori strumenti di protezione dai rischi – anzi forse ce ne
erano meno – ma perché eravamo in un contesto in cui
prevaleva l’idea e l’orizzonte simbolico dello sviluppo, del
miglioramento.
Ma veniamo alla sociologia. Mi sono laureata nel 1965; per un
paio d’anni ho insegnato in un liceo e intanto facevo
l’assistente “volontaria” in filosofia teoretica, che era l’unico
modo per restare nell’ambiente universitario. In quegli anni è
arrivato alla Cattolica Alberoni, con la prima cattedra di sociologia, affiancato successivamente da Baglioni. Alberoni fece
una cosa intelligente, e se si vuole dovuta: voleva costituire un
nucleo di ricercatori in sociologia e iniziare ad insegnarla a
Milano. Per questo decise di raccogliere giovani ricercatori e
assistenti, provenienti da molte e diverse discipline. Ne faceva
parte anche mio marito, anch’egli laureato in filosofia e
anch’egli assistente in filosofia teoretica. Questo gruppo era
composto da soli uomini. A quei tempi la condizione delle
donne nell’università era molto più difficile di quella odierna,
soprattutto all’Università Cattolica.
D: Come è entrata a far parte anche lei di questo
gruppo?
R: Tutti i componenti del gruppo di Alberoni, ed anch’io,
parteciparono alla prima occupazione dell’Università Cattolica,
nel 1967, e alle varie azioni di contestazione, assolutamente
non violente (sciopero della fame, lettura in pubblico della
Costituzione, di “Lettera ad una professoressa” e così via).
Questo ha rafforzato il gruppo, che da allora ha mantenuto
saldi rapporti di amicizia. È da questo insieme di persone che
Alberoni ha pescato i giovani sociologi che poi si è portato a
Trento quando si è allontano dalla Università Cattolica alla fine
del 1968. Questa volta l’invito è stato rivolto anche a me. È da
questo momento che io ho deciso di diventare sociologa: ho
rinunciato a partecipare a un concorso per un posto di ruolo
nelle scuole medie superiori per un contratto annuale a Trento.
La precarietà, dunque, come vede, era condizione imprescindibile e non ha riguardato solo il mio caso, ma era un
fenomeno diffuso: i contratti annuali andavano per la
Novembre 2005, Anno 2, Numero 10
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
maggiore e l’ambiente universitario era molto difficile da
conquistare. Come le ho detto, in Cattolica io ero assistente
volontaria, ovvero non percepivo alcun riconoscimento
economico, ma questo non voleva dire che io potessi fare
quello che volevo: per mantenere questo ruolo, ogni anno
dovevo pubblicare su una rivista scientifica almeno un articolo
e dovevo partecipare alle sessioni di esame. La prima volta
che mi hanno pagato per il mio lavoro universitario è stato a
Trento.
D: Cos’è, allora, che fa pensare ai giovani d’oggi di
essere più precari?
R: Come dicevo prima, è cambiato il contesto economico ed
anche il discorso pubblico. Noi eravamo oggettivamente
precari, ma in un contesto che appariva pieno di possibilità. In
più, devo aggiungere, che sono cresciuta in una famiglia nella
quale accettare le sfide, rischiare, era non solo accettato, ma
incoraggiato. L’unico momento in cui ricordo di aver vissuto un
possibile rischio è stato quando, una volta scoppiato il
movimento femminista, di cui io facevo parte, fui oggetto di
discussioni nel Consiglio Comunale di Trento: alcuni consiglieri
sostenevano che non era possibile dare un incarico di
insegnamento ad una “così selvaggia”. Allora l’Università di
Trento era privata e finanziata dalla Provincia. Quindi la voglia
di esercitare un controllo politico era molto forte.
Perché sono diventata sociologa? Devo dire per merito, o
colpa, o responsabilità di Alberoni che, senza conoscermi
realmente, decise di portarmi con sé a Trento. Ma poi ho preso
le mie strade, e gli argomenti, le ricerche di cui mi sono
occupata nella mia carriera mi hanno plasmato, mi hanno fatto
diventare la sociologa che sono oggi. Anche nella scelta dei
temi da affrontare il caso ha avuto il suo peso.
D: Ci spieghi...
R: All’inizio io mi occupavo di filosofia, tenevo dei brevi
seminari, con moltissimi studenti e studentesse, parlando dei
grandi pensatori della filosofia: Hegel, Kant, il materialismo
storico. Prima di arrivare a Trento, a onor del vero, avevo già
messo il naso nella sociologia, collaborando con mio marito ad
una ricerca sulla religiosità giovanile, per la quale lui aveva
pubblicato Giovani e secolarizzazione e poi insieme avevamo
pubblicato, con un titolo storicamente molto connotato:
Ideologia religiosa e conflitto sociale. Come detto, tuttavia,
devo ad Alberoni il fatto di essere diventata sociologa. Ma
un’altra persona, alla quale intellettualmente mi sento più
legata, ha determinato l’inizio del mio lavoro di ricerca rivolto
alle famiglie. Questa persona è Manoukian, uno dei primi
sociologi della famiglia in Italia. Anche lui era a Trento e mi ha
chiesto di collaborare con lui al corso universitario che teneva.
Facevo dei seminari, delle lezioni per gli studenti lavoratori il
sabato e la domenica, e l’interesse per la famiglia ha
cominciato a svilupparsi in questa collaborazione, per me
molto affascinante. Poi lui è andato via, io sono entrata in
modo più attivo nel movimento delle donne e ho incominciato
a fare ricerca anche in questo ambito e questo da un lato ha
contribuito a creare il mio profilo intellettuale, ma in parte non
è stata una partecipazione delle più semplici.
N e w s l e t t e r
Sociologia e Ricerca Sociale
6
D: Perché?
R: Da un lato io non ero più una studentessa, ero più vecchia
rispetto alla media delle donne coinvolte. E poi insegnavo, per
cui ero dall’altra parte della barricata. In secondo luogo facevo
una cosa che era del tutto disdicevole per quei tempi dentro al
movimento delle donne, ovvero pubblicavo col mio nome,
invece di celarmi/annullarmi dentro al movimento. Per di più,
nonostante i miei testi avessero una ispirazione “militante”,
ambivano pur sempre ad essere testi di sociologia, argomentati sia empiricamente che teoricamente, non dei pamphlet.
D: Per cui lei ha vissuto una situazione molto
particolare...
R: Sì, all’università ero una delle poche donne in un ambiente
prevalentemente maschile e maschilista; ero una sociologa,
ma mi occupavo di cose di poco conto, a detta degli altri, più
influenti e più riconosciuti sociologi, quali la famiglia e le
condizioni delle donne. Ricordo un episodio particolare. A
livello nazionale, i sociologi avevano creato un’associazione
per iniziare a organizzarsi. Eravamo un gruppo di giovani, dal
quale poi, molti anni dopo, nacque l’Associazione Italiana di
Sociologia (AIS). Quando c’erano queste riunioni di giovani
sociologi, con nomi molto importanti degli ambienti accademici
di allora, io ero guardata con sospetto, quasi dall’alto al basso:
loro si occupavano di cose serie, di classi, di economia,
eccetera. Io invece di questioni “private”, politicamente e
socialmente irrilevanti…
Riflettendo retrospettivamente, tutto sommato se dovessi dire
che cosa ha contribuito, a prescindere dai contenuti, al mio
profilo intellettuale, credo sia stata la mia posizione di
straniera, che non considero una virtù, ma che riassume bene
ciò che mi è capitato. Sono sempre stata, diciamo, “sulla
porta”, in uno stato né di appartenenza né di nonappartenenza. Uno degli aspetti positivi di questa situazione è
la libertà di scelta: io potevo scegliere di non-appartenere.
Come donna mi muovevo in un mondo di soli uomini; ero
sposata quando non era di moda farlo dentro al movimento
femminista; ero già non più studentessa seppur giovane (o
almeno apparivo più giovane di quanto non fossi); nel
movimento femminista ero percepita non come una di loro,
ma al margine; ho avuto figli quando dentro al movimento la
maggior parte o era troppo giovane per pensarci, o li aveva
già avuti e rivendicava l’importanza di dedicarsi ad altro. Alla
riscoperta della maternità da parte del movimento io avevo le
figlie già grandi. Mi occupavo di temi “marginali” rispetto a
quelli ritenuti importanti. Il dover in qualche modo sempre
legittimarmi mi ha dato questa dose di aggressività che se
vuole mi rende anche un po’ antipatica, ma che mi ha anche
dato una certa libertà interiore. Sapere di essere sempre sotto
osservazione e guardata di sottecchi, potremmo dire, mi ha
spinto a fare sempre meglio le cose di cui mi occupavo, a non
lasciare nulla di scontato e a difendere le posizioni che di volta
in volta andavo assumendo. Questo mi ha obbligata a
approfondire molto alcuni aspetti dei temi di cui mi sono
occupata. Inoltre, sapere di fare delle cose che comunque non
erano considerate “importanti” mi ha reso un po’ più laica
Novembre 2005, Anno 2, Numero 10
Scrivi alla redazione >>
[email protected]
verso le mie stesse attività di ricerca, consentendomi di avere
libertà anche dal mio stesso lavoro e dai miei stessi interessi,
insomma consentendomi di guardare al mio lavoro con
passione e con un utile distacco.
L’interesse sociologico per la famiglia quindi ha questa doppia
origine: la collaborazione con Manoukian e la partecipazione al
movimento delle donne. Ma è stata questa seconda a segnare
in modo profondo la elaborazione del mio approccio teorico.
D: Verso quali altri ambiti si è poi mossa?
R: Per noi che partivamo dal punto di vista delle donne,
occuparci di famiglia ha significato inevitabilmente occuparci di
welfare state , ed è così che sono diventata anche una
sociologa del welfare, partendo appunto dalla famiglia.
Inevitabile è stato un approccio multidisciplinare, perché
guardare alla famiglia e al welfare significa occuparsi ad
esempio di sociologia del lavoro e di sociologia delle istituzioni
e dei processi di formazione delle decisioni.
L’altro grande tema di cui mi sono occupata, e per il quale in
qualche modo sono riconosciuta, è la povertà. In questo caso,
da parte mia non c’è stata, però, alcuna scelta: sono stata
messa di fronte a questo tema. Le “donne” le ho scelte io, la
“famiglia” è arrivata come logica conseguenza. La “povertà”
invece mi è arrivata del tutto inaspettata, anzi posso dire che
sia stata la povertà a scegliere me, e all’inizio anche per
ragioni, diciamo, improprie. Nel 1984 entrai a far parte della
Commissione di Indagine sulla povertà, presieduta da
Ermanno Gorrieri. C’era stato il movimento delle donne, quindi
a livello politico si ritenne che l’interrogativo se ci fosse una
specificità femminile nell’esposizione al rischio di povertà si era
posta anche in Italia, tanto più che essa era molto presente
nel dibattito internazionale (la “femminilizzazione della
povertà”) e la stessa Commissione Europea lo aveva affrontato. In una Commissione ove tutti rappresentavano qualche
“parte” (per lo più “politica”) io ero stata indicata per “rappresentare le donne”. Ovviamente questa compartimentalizzazione – o lottizzazione – era assurda sul piano tematicoconoscitivo. Perciò incominciai a studiare come una matta, per
acquisire tutte le conoscenze possibili sulla questione della
povertà. Ho imparato moltissimo da Ermanno Gorrieri con cui
ebbi una collaborazione per me splendida. Ovviamente, mi
guadagnai subito le riserve di altri sociologi che da tempo si
occupavano di povertà, tema per me assolutamente inedito.
D: Beh, sono molte le occasioni che ha colto...
R: Trovo interessanti queste congiunzioni, e in parte credo che
siano un fenomeno generazionale: ad alcune, non tante,
donne della mia generazione sono capitate delle occasioni, si
sono verificate alcune possibilità per andare a riempire degli
spazi lasciati vuoti, o creati ex novo, su temi ritenuti marginali,
meno importanti, e per i quali i grandi sociologi di allora non
intendevano perdere tempo. Siamo state buttate a nuotare,
inserite in ambienti di alto profilo, costrette a confrontarci con
professionisti affermati, e spronate a giustificare sempre in
modo puntuale i risultati dei nostri lavori, il valore delle
ricerche condotte su temi apparentemente di secondo piano.
N e w s l e t t e r
Sociologia e Ricerca Sociale
7
Oggi, ogni tanto guardo ai più giovani, e pur non volendo dare
giudizi gratuiti sono portata a fare delle comparazioni. Oggi i
giovani sono molto più solidi come formazione, più specializzati, ovviamente sto parlando di quelli bravi, difendono molto
di più il loro profilo, si connotano molto di più nel loro ambito.
Noi eravamo in contatto con realtà più diversificate, avevano
delle reti di contatti più ampie, aperte, ed eravamo portate a
confrontarci anche con realtà e persone lontane dall’ambiente
universitario, a fare altri lavori (non necessariamente per
soldi), a frequentare altri ambienti. Questo, almeno per quanto
mi riguarda, mi ha aiutato a pormi problemi che forse non
sarebbero emersi se fossi rimasta nell’ambiente universitario e
basta, a vedere le cose da altri punti di vista. Penso alle
centinaia di assemblee di genitori o di operatori sociali cui
sono stata invitata a parlare e da cui ho imparato a mia volta.
Oggi, la specializzazione che caratterizza i giovani studiosi ha
dei pregi immensi, ma porta con sé alcuni pericoli di chiusura,
di monotematicità.
D: Lei, professoressa, ha scritto anche in merito all’età
e al corso della vita...
R: Sì. Questo è un filone però più esterno rispetto alla mia
attività di ricerca. Posso dire di essere stata una delle prime in
Italia a pormi il problema dell’aspetto dinamico del corso della
vita. È un filone assolutamente consolidato negli Stati Uniti, fin
dagli anni Cinquanta, mentre qui in Italia ha tardato molto ad
arrivare e ad essere sistematizzato. Anche questo incontro è
stato casuale. Ero negli Stati Uniti durante un anno di congedo
e stavo cercando testi su famiglia, donne, eccetera, in queste
magnifiche biblioteche statunitensi, con tutti i volumi a vista
su grandi scaffali. Nello scaffale in cui stavo prendendo un
libro sono inciampata in questa vastissima letteratura sull’età
e il corso della vita, rendendomi conto che ero di fronte a un
lavoro immenso, di cui non avevo mai sentito parlare prima.
Per me è stata una rivelazione. Si tratta più che di un tema di
un vero e proprio approccio, di un modo diverso di guardare al
mondo che ci circonda, un modo che una volta appreso non lo
si può più ignorare. Per me è stato un po’ come l’approccio di
genere: ha cambiato la mia visuale su molte questioni.
D: In sintesi, cosa caratterizza la sua storia?
R: La curiosità e la tenacia. La curiosità mi ha consentito di
cogliere le occasioni anche impreviste. La tenacia mi ha
consentito di non perdermi. Ho un forte senso del dovere e
sono anche orgogliosa, ahimè. Quando mi sono trovata in
situazioni anche molto difficili, come ad esempio l’incontro con
il tema allora per me sconosciuto della povertà, ho comunque
reagito in modo forte: una volta preso l’incarico, dovevo
portarlo a termine nel migliore dei modi. Ho sempre voluto
poter dire la mia su tutto. Confesso che ho un forte senso di
me, della mia dignità. Ci sono state e ci sono anche molte
insicurezze. Ma ciò che per me è sempre contato è non farmi
mettere i piedi in testa da nessuno e per reazione ho
sviluppato questo misto di orgoglio, senso del dovere, e a
volte durezza che mi caratterizza e del quale in fondo non mi
rammarico.