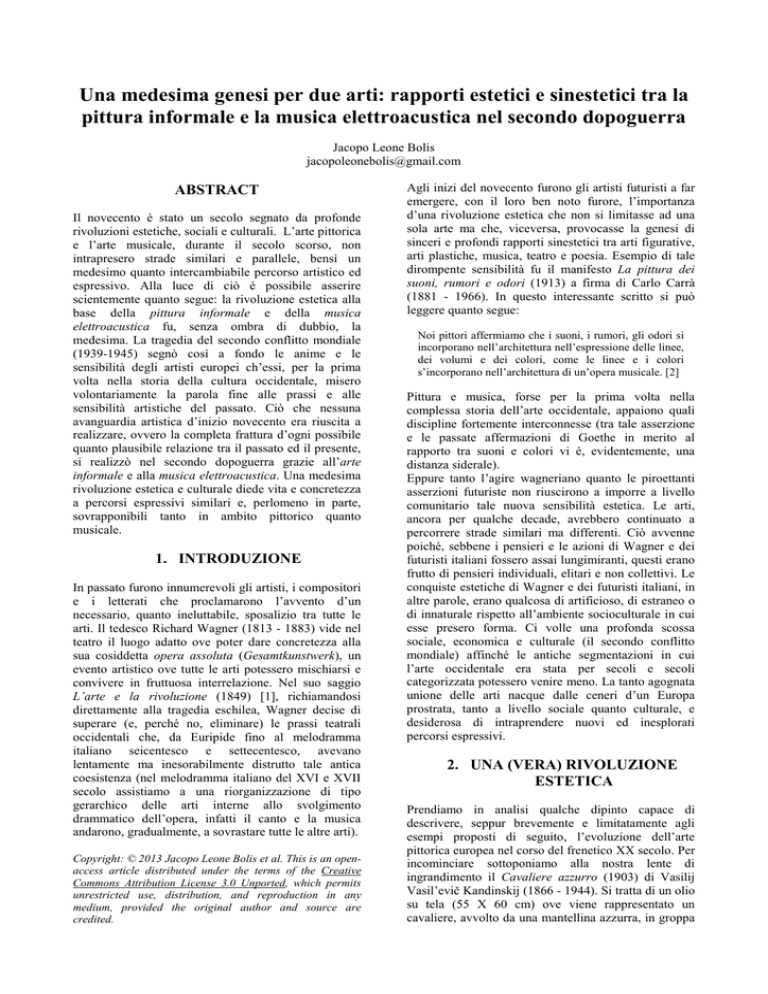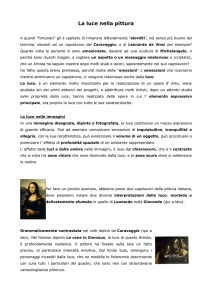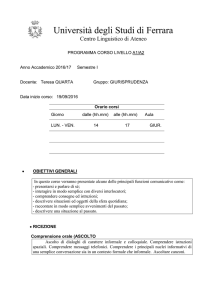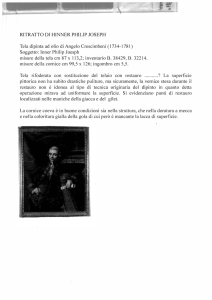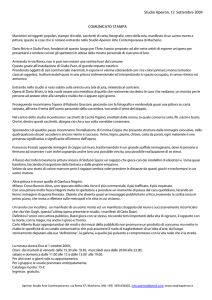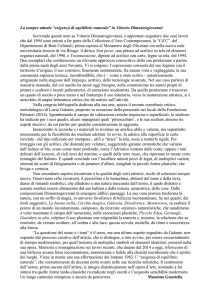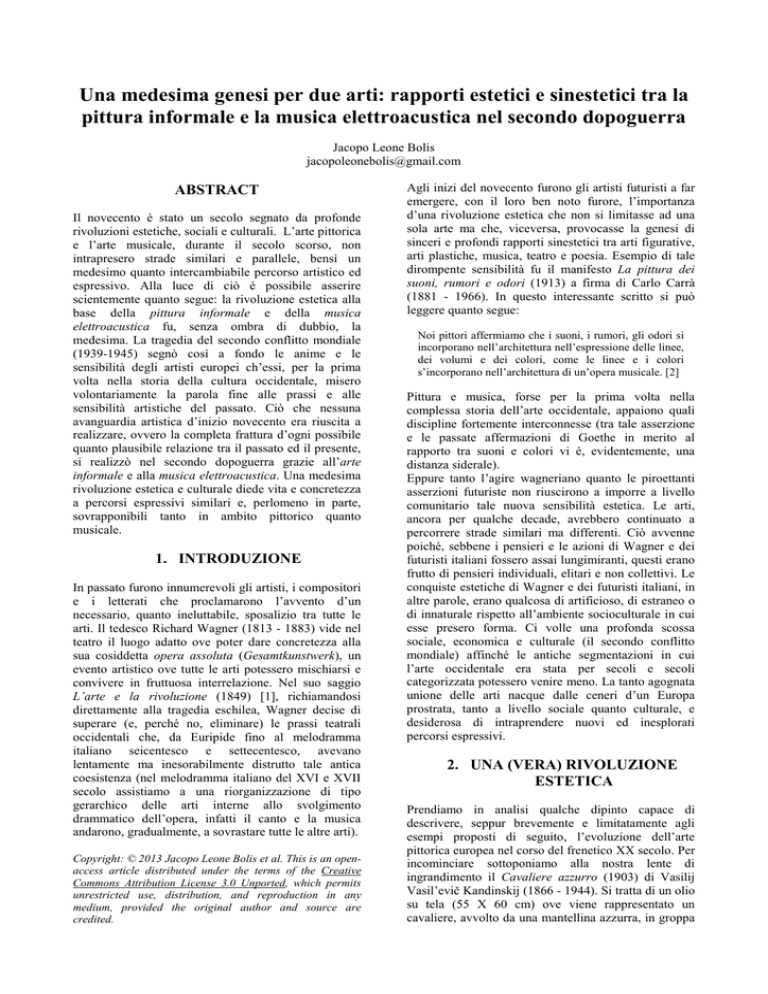
Una medesima genesi per due arti: rapporti estetici e sinestetici tra la
pittura informale e la musica elettroacustica nel secondo dopoguerra
Jacopo Leone Bolis
[email protected]
ABSTRACT
Il novecento è stato un secolo segnato da profonde
rivoluzioni estetiche, sociali e culturali. L’arte pittorica
e l’arte musicale, durante il secolo scorso, non
intrapresero strade similari e parallele, bensì un
medesimo quanto intercambiabile percorso artistico ed
espressivo. Alla luce di ciò è possibile asserire
scientemente quanto segue: la rivoluzione estetica alla
base della pittura informale e della musica
elettroacustica fu, senza ombra di dubbio, la
medesima. La tragedia del secondo conflitto mondiale
(1939-1945) segnò così a fondo le anime e le
sensibilità degli artisti europei ch’essi, per la prima
volta nella storia della cultura occidentale, misero
volontariamente la parola fine alle prassi e alle
sensibilità artistiche del passato. Ciò che nessuna
avanguardia artistica d’inizio novecento era riuscita a
realizzare, ovvero la completa frattura d’ogni possibile
quanto plausibile relazione tra il passato ed il presente,
si realizzò nel secondo dopoguerra grazie all’arte
informale e alla musica elettroacustica. Una medesima
rivoluzione estetica e culturale diede vita e concretezza
a percorsi espressivi similari e, perlomeno in parte,
sovrapponibili tanto in ambito pittorico quanto
musicale.
1. INTRODUZIONE
In passato furono innumerevoli gli artisti, i compositori
e i letterati che proclamarono l’avvento d’un
necessario, quanto ineluttabile, sposalizio tra tutte le
arti. Il tedesco Richard Wagner (1813 - 1883) vide nel
teatro il luogo adatto ove poter dare concretezza alla
sua cosiddetta opera assoluta (Gesamtkunstwerk), un
evento artistico ove tutte le arti potessero mischiarsi e
convivere in fruttuosa interrelazione. Nel suo saggio
L’arte e la rivoluzione (1849) [1], richiamandosi
direttamente alla tragedia eschilea, Wagner decise di
superare (e, perché no, eliminare) le prassi teatrali
occidentali che, da Euripide fino al melodramma
italiano seicentesco e settecentesco, avevano
lentamente ma inesorabilmente distrutto tale antica
coesistenza (nel melodramma italiano del XVI e XVII
secolo assistiamo a una riorganizzazione di tipo
gerarchico delle arti interne allo svolgimento
drammatico dell’opera, infatti il canto e la musica
andarono, gradualmente, a sovrastare tutte le altre arti).
Copyright: © 2013 Jacopo Leone Bolis et al. This is an openaccess article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License 3.0 Unported, which permits
unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original author and source are
credited.
Agli inizi del novecento furono gli artisti futuristi a far
emergere, con il loro ben noto furore, l’importanza
d’una rivoluzione estetica che non si limitasse ad una
sola arte ma che, viceversa, provocasse la genesi di
sinceri e profondi rapporti sinestetici tra arti figurative,
arti plastiche, musica, teatro e poesia. Esempio di tale
dirompente sensibilità fu il manifesto La pittura dei
suoni, rumori e odori (1913) a firma di Carlo Carrà
(1881 - 1966). In questo interessante scritto si può
leggere quanto segue:
Noi pittori affermiamo che i suoni, i rumori, gli odori si
incorporano nell’architettura nell’espressione delle linee,
dei volumi e dei colori, come le linee e i colori
s’incorporano nell’architettura di un’opera musicale. [2]
Pittura e musica, forse per la prima volta nella
complessa storia dell’arte occidentale, appaiono quali
discipline fortemente interconnesse (tra tale asserzione
e le passate affermazioni di Goethe in merito al
rapporto tra suoni e colori vi è, evidentemente, una
distanza siderale).
Eppure tanto l’agire wagneriano quanto le piroettanti
asserzioni futuriste non riuscirono a imporre a livello
comunitario tale nuova sensibilità estetica. Le arti,
ancora per qualche decade, avrebbero continuato a
percorrere strade similari ma differenti. Ciò avvenne
poiché, sebbene i pensieri e le azioni di Wagner e dei
futuristi italiani fossero assai lungimiranti, questi erano
frutto di pensieri individuali, elitari e non collettivi. Le
conquiste estetiche di Wagner e dei futuristi italiani, in
altre parole, erano qualcosa di artificioso, di estraneo o
di innaturale rispetto all’ambiente socioculturale in cui
esse presero forma. Ci volle una profonda scossa
sociale, economica e culturale (il secondo conflitto
mondiale) affinché le antiche segmentazioni in cui
l’arte occidentale era stata per secoli e secoli
categorizzata potessero venire meno. La tanto agognata
unione delle arti nacque dalle ceneri d’un Europa
prostrata, tanto a livello sociale quanto culturale, e
desiderosa di intraprendere nuovi ed inesplorati
percorsi espressivi.
2. UNA (VERA) RIVOLUZIONE
ESTETICA
Prendiamo in analisi qualche dipinto capace di
descrivere, seppur brevemente e limitatamente agli
esempi proposti di seguito, l’evoluzione dell’arte
pittorica europea nel corso del frenetico XX secolo. Per
incominciare sottoponiamo alla nostra lente di
ingrandimento il Cavaliere azzurro (1903) di Vasilij
Vasil’evič Kandinskij (1866 - 1944). Si tratta di un olio
su tela (55 X 60 cm) ove viene rappresentato un
cavaliere, avvolto da una mantellina azzurra, in groppa
al suo cavallo dal candido manto. Questo binomio
uomo/animale è colto in pieno movimento mentre si
slancia con fervore sulle verdi distese d’una collina.
L’elemento dinamico intrinseco all’opera è reso
esplicito soprattutto grazie al librarsi della mantellina
del cavaliere. Quest’ultima si staglia lungamente alle
spalle di questi come percossa da forti folate di vento.
Inoltre, ad aumentare significativamente la pregnanza
dell’elemento cinetico internamente a questa piccola
opera pittorica, interviene la postura fisica del cavallo.
Quest’ultimo, infatti, è rappresentato quasi in volo,
lievemente distaccato da terra con i suoi arti e con la
coda che, similmente alla mantellina del suo cavaliere,
si stende per la sua intera lunghezza. Questa piccola
tela degli inizi del ‘900 ci rivela un gusto ed una vena
pittorica ancora fortemente legate all’allora recente
rivoluzione impressionista svoltasi prevalentemente in
Francia durante la seconda metà del XIX secolo ad
opera di artisti quali Edouard Manet (1832 - 1883),
Paul Cézanne (1839 - 1906) e Claude Monet (1840 1926). La natura, nella sua accezione più complessa,
non veniva più colta e rappresentata dagli artisti nella
sua oggettività esteriore (per quanto tale finalità, anche
all’interno della più recente corrente iperrealista
statunitense, non possa essere mai effettivamente
raggiunta) ma, viceversa, veniva profondamente riletta
dalla ragione e dall’animo degli artisti che vi si
dedicavano. Ebbe così inizio una rivoluzione artistica
di portata storica. La realtà oggettiva veniva ripudiata e
ad essa andava sostituendosi un’individualistica ed
estremamente soggettiva rappresentazione del reale. Il
concetto di bello, dapprima collettivo e comunitario,
stava mutando in maniera irreparabile in favore
dell’individuo, delle sue esigenze e delle proprie ed
indiscutibili volontà.
Probabilmente ispirato dal dipinto Les grandes
Baigneuses (1906) di Paul Cézanne, lo spagnolo Pablo
Picasso (1881 - 1973) dipinse nel 1907 una delle sue
opere più conosciute ed apprezzate: Les Demoiselles
d'Avignon , olio su tela (243,9 x 233,7 cm), oggi
conservato presso il MoMA di New York. Il dipinto
rappresenta cinque prostitute presso il bordello di calle
Avignon a Barcellona. Le figure femminili, tuttavia,
sono ampiamente deformate, rivisitate e manomesse
dal pennello del pittore. Tramite tale profonda rilettura
della fisicità delle prostitute, il quadro perde ogni
carica erotica convenzionale e, viceversa, strizza
apertamente l’occhio ad una sensibilità fisiognomica di
matrice africana. I volti delle prostitute sono allungati,
squadrati, così come i loro arti ed i loro seni.
Quest’opera è stata giustamente definita dalla critica
una delle prime realizzazioni pittoriche di Picasso ove
sia possibile scorgere un gusto estetico anticipatore
delle future conquiste cubiste. Nel 1921 questa
tendenza alla semplificazione geometrica del reale e
alla sua riproposizione sulla tela deprivando,
volontariamente, la propria prassi artistica d’ogni
prospettiva spaziale dal passato sapor rinascimentale,
portò il celebre artista spagnolo alla stesura del dipinto
I tre musici, olio su tela (200,7 x 222,9 cm), conservato
anch’esso presso il MoMA di New York. Quest’opera,
pienamente inseribile all’interno della corrente estetica
del cosiddetto cubismo sintetico, mostra tre figure
maschili intente ad eseguire della musica (per
l’esattezza si tratta di due personaggi carnevaleschi,
Arlecchino e Pulcinella, ai quali sono associate una
chitarra ed un clarinetto, ed un monaco cantore che
stringe in pugno una partitura deformata ed illeggibile).
Le figure sono stilizzate e squadrate quasi all’eccesso.
Il tutto appare estremamente irrealistico essendo
deprivato d’ogni profondità spaziale in favore d’uno
schietto
desiderio
rappresentativo
di
natura
bidimensionale. Il filtro posto dall’artista alla
percezione ed alla rappresentazione del reale sulla tela
è sempre più marcato. Questo gioco estetico fondato
sulla reinterpretazione del reale porterà il già citato
Kandinskij all’abbandono d’ogni desiderio figurativo
in favore di composizioni pittoriche incentrate su mere
rappresentazioni grafico-geometriche ove ai tipici
soggetti della pittura occidentale (es. rappresentazioni
sacre, naturalistiche) andarono a sostituirsi quadrati,
cerchi, linee dritte, curve e macchie di colore delle più
disparate forme. Era nato l’astrattismo. Quasi
contemporaneamente alle prime sperimentazioni
astratte di Vasilij Kandinskij (e forse con un animo
ancor più rivoluzionario di questi) il pittore russo
Kazimir Severinovič Malevič (1878 - 1935) iniziò ad
insinuare nella cultura pittorica europea il gusto per le
figurazioni geometriche. La sua pittura, le cui guide
estetiche egli sintetizzò con intelligenza nel suo
manifesto del suprematismo [3], abbandonò assai
presto ogni mero desiderio rappresentativo/figurativo
in favore d’un gusto geometrico proto-minimale
fondato su evidenti quanto significativi contrasti
cromatici (Malevič tornerà all’arte figurativa solo in
vecchiaia a partire dal 1930 ca.). Esempi lampanti di
tale suo particolare gusto estetico sono Cerchio nero
(1913), olio su tela (109 X 109 cm), e Quadrato nero
(1913), olio su tela, (109 X 109 cm), entrambi oggi
conservati presso il Museo di Stato Russo di
Pietroburgo. [4]
Del resto anche nel futurismo italiano d’inizio XX
secolo notiamo una profonda rilettura della realtà a noi
tutti circostante. Quest’ultima venne trasportata sulla
tela tramite profonde ed esplicite manomissioni nel
tentativo di palesarne l’intrinseca dinamicità (per i
futuristi la vita era pulsione tanto razionale quanto
emotiva, lotta per la sopravvivenza, spasmodica ricerca
dell’azione). Il movimento, il gesto plastico e vigoroso,
diventano le finalità ed i sentiti desideri dei più illustri
pittori futuristi dell’epoca (es. La città che sale di
Umberto Boccioni del 1910 e Il cavaliere rosso Cavallo e cavaliere del 1913 di Carlo Carrà). Eppure,
anche se la trasposizione del movimento all’interno
della tela portò ad una rilettura profonda del reale
oggettivo da parte degli artisti futuristi, un qualche
desiderio figurativo certo non mancò in talune loro
realizzazioni pittoriche. Questa commistione quasi
paritetica di desideri figurativi e profonde ed
individualistiche riletture del reale trovò felice
sposalizio in alcune opere di Fortunato Depero (1892 1960). Prendiamo, ad esempio, La rissa (1926), olio su
tela (149 x 255 cm), oggi conservato al MART di
Rovereto (Trento - Italia). In questo dipinto,
utilizzando una raffinata tricromia (bianco-grigionero), il pittore italiano rappresentò un’umanità futura
quasi robotizzata intenta ad arrecarsi violenza
all’interno di un locale, una specie di locanda/osteria
dall’evidente sapore avveniristico. Da evidenziarsi
come, in questa bella tela di Depero, passato e futuro
s’incontrino e si sovrappongano perfettamente nello
svolgersi d’una socialità che ha mantenuto quasi del
tutto inalterati i propri antichissimi riti (così come
l’uomo del passato spendeva parte del proprio tempo
ubriacandosi presso l’osteria del proprio paese o rione,
così l’uomo del futuro darà vita e materia alle proprie
pulsioni sociali all’interno d’una locanda). In questa
tela avviene una profonda e biunivoca relazione tra
figura e reinterpretazione del reale. Le figure umane
sono stilizzate, disumanizzate, rese tramite un color
nero opaco a cui si aggiungono addizioni geometriche
che ne snaturano ulteriormente tanto la parvenza
esteriore quanto l’essenza stessa. L’uomo non è più
tale, egli è un insieme ben strutturato di mattoncini
geometrici ben accatastati gli uni sugli altri, eppure, per
quanto fortemente manomesso dall’artista, l’uomo,
nella sua nuova bruttura, è pur sempre percepito come
tale dal fruitore dell’opera. Alla luce di quanto finora
asserito non ci deve certo sorprendere la geniale
intuizione del critico italiano Gillo Dorfles (n. 1910)
secondo la quale l’arte occidentale precedente al
secondo conflitto mondiale (1939 - 1945) è e resta
un’arte strettamente connessa con il gusto e le prassi
pittoriche di tradizione medioevale e rinascimentale:
Fino agli anni immediatamente precedenti la seconda
guerra mondiale pittura e scultura erano ancora legate –
sia pure attraverso a un tenue cordone ombelicale – con
la ‘grande arte’ che dal rinascimento giungeva,
ininterrotta, sino ai primi decenni del nostro secolo.
Cubismo, futurismo, pittura metafisica, avevano
significato una resa più o meno modificata della realtà
del mondo esterno, e un progressivo abbandono di
canoni naturalistici, ma alla base dell’opera d’arte c’era
pur sempre la presenza o la suggestione d’un immagine,
d’un nucleo immaginifico sia implicito che esplicito, e a
questo nucleo rimaneva ancorata la composizione stessa.
[5]
Seppur tramite parole differenti e, sicuramente meno
esplicite, il medesimo concetto è stato espresso anche
dalla critica d’arte francese Dora Vallier nel suo scritto
L’arte astratta (1964):
Successivamente, a partire dal 1945, si assiste a un’altra
astrazione che non è più la ricerca della forma ma, al
contrario, il desiderio di esprimere, prima nella forma e
anche al di fuori di essa, tutta la ricchezza e la
spontaneità della vita interiore: l’artista si proietta senza
alcuna mediazione nella sua opera, nei termini di quella
che è stata chiamata astrazione ‘lirica’ o ‘informale’ […]
La pittura astratta del dopoguerra sarà gestuale (action
painting, come la chiamano gli americani) o calligrafica
(alla maniera dell’Estremo Oriente) o informale. Tutte
tendenze che rifiutano il controllo della coscienza e che,
per questo, mettono in discussione la tecnica. Se
inizialmente
l’artista
astratto
si
accontentava
dell’indipendenza totale dei colori e delle forme, adesso
sente il bisogno di trasgredire i mezzi tecnici
tradizionali. [6]
La vera e propria cesura tra l’arte del passato e l’arte
contemporanea avvenne negli anni immediatamente
seguenti al secondo dopoguerra quando artisti quali il
franco-tedesco Wolfang Schultze detto Wols (1913 1951), il francese Georges Mathieu (n. 1921), l’italiano
Giuseppe Capogrossi (1900 - 1972) e gli americani
Mark Tobey (1890 - 1976) e Jackson Pollock (1912 1956), solo per fare qualche nome, diedero vita alla
cosiddetta arte segnica/gestuale (poetica espressiva
interna all’allora giovanissima arte informale). Sulla
tela non apparivano più figure geometriche, linee,
cerchi, quadrati e parallelepipedi. A colori e forme
riconducibili a significati e a immagini precise, seppur
apparentemente esterni al mondo reale, venivano a
sostituirsi macchie di colore dalle forme indefinite,
volutamente imprecise e difficilmente riproducibili. Il
gesto, quasi involontario ed irrazionale, sostituiva la
pennellata precisa, raffinata e attentamente ponderata
da parte dell’artista. Questa nuova prassi artistica, priva
di forme riconducibili ad elementi anteriormente
presenti nel nostro bagaglio culturale, desiderava
svincolare l’agire demiurgico dell’artista da ogni
desiderio razionalmente costruttivo. La tela diveniva il
luogo ove il pittore poteva sfogare ogni propria forza
interiore per palesarne esteriormente l’esistenza. La
cultura orientale, che ormai da tempo influenzava in
maniera significativa il pensiero occidentale, forniva a
questi tentativi estetici una vera e propria base teorica
grazie alla quale giustificare queste azioni creative.
All’interno delle dottrine facenti capo al buddismo zen,
filosofia quest’ultima nata e sviluppatasi nell’antico
Giappone, vi è presente un termine estremamente
complesso: ko-tzu. Questa misterica parola può essere
tradotta secondo le seguenti definizioni: spontaneità
d’azione, impulso creativo, sentimento creatore privo
di razionalità. Del resto la cultura giapponese ha da
sempre miscelato con sapiente armonia ragione ed
emotività, scrupoli formali e impeto creativo. Prova ne
sono, ad esempio, le antichissime forme poetiche del
tanka e dell’haiuku. In entrambe queste strutture
poetiche di piccole dimensioni, razionalità ed emotività
si saldano tra loro in perfetta unione. Il tanka è un
componimento poetico composto da due strofe aventi
un significato contrastante: la prima, denominata strofa
superiore, è formata da tre versi composti da 5, 7 e 5
sillabe, mentre la seconda, denominata strofa inferiore,
nasce dall’unione di due versi aventi 7 sillabe ognuno.
L’haiuku, forma poetica cronologicamente più recente,
deriva direttamente dal tanka e ne mantiene la sola
strofa superiore dando vita così ad una struttura
poetica ancora più sintetica e diretta. Tanka ed haiuku
sono forme poetiche estremamente razionali per via
della loro prepotente sinteticità, tuttavia, a tale attenta e
ponderata miscela di sillabe e versi, i poeti giapponesi
hanno sempre unito tematiche di stampo naturalistico e
filosofico estremamente criptiche e ricche di sfumature
emotive. Allo stesso modo l’arte informale occidentale
cercò, ed in parte vi riuscì e vi riesce tuttora, di fondere
gestualità improvvise ed irrazionali (emotività) a
visioni filosofiche ed estetiche estremamente
complesse (raziocinio). Quasi paradossalmente, grazie
alle conquiste artistiche raggiunte dall’antica cultura
giapponese, il pensiero filosofico orientale diveniva la
giustificazione estetico-filosofica dell’agire artistico
occidentale. Il ko-tzu, questa irrefrenabile energia vitale
e creatrice, trovò materializzazione perfetta, ad
esempio, nell’Action-Painting statunitense di Jackson
Pollock e William Congdon (1912 - 1998).
Questa profonda rivoluzione artistica e culturale
affondò le proprie radici storiche nei due conflitti
mondiali che travolsero il vecchio continente (1914/18
- 1939/45). La guerra, del resto, ha segnato la storia
dell’umanità fin dai suoi albori. Essa è un insieme
eterogeneo di violenza, morte, mutamenti geopolitici e
sociali. Ovviamente, come qualsiasi altro manufatto
umano, la guerra muta, si modifica con l’incedere dei
decenni, dei secoli. Tra il 1914 ed il 1918 il mondo
intero (ma soprattutto l’Europa) conobbe l’inaudita e
fino ad allora inimmaginabile violenza della guerra
moderna: milioni di uomini gettati come burattini e
bambole di pezza sotto il fuoco incrociato di
mitragliatrici, fucili e granate. A questo desolante
scenario si deve aggiungere l’enorme smottamento
sociale a cui tale conflitto diede vita per la prima volta
nella storia dell’umanità: contadini, operai, studenti
liceali ed universitari, tutti insieme, furono lasciati a
marcire in buche fangose, accuditi con cura dalla
malevola compagnia di pidocchi, acari e germi d’ogni
natura. Così il letterato, scrittore, storico e cineasta
italiano Curzio Malaparte (1898 - 1957), arruolatosi
volontario, descrisse la gerarchizzazione sociale
presente all’interno delle forze armate italiane durante
il primo conflitto mondiale:
Allo scoppiare della guerra, il nostro proletariato non fu
né neutralista né interventista: fu il popolo, come
sempre. Rimase, cioè, spettatore durante le doglie dei
nove mesi di neutralità, e partì per il fronte il 24 Maggio,
con le stellette al collo. Fu popolo: cioè capro. La
piccola borghesia (elemento spregevole e ammirevole,
abituata a stentare e ad ubbidire, a lasciarsi sfruttare
senza mai chiedere niente) imbandierò le finestre, invoco
l’elmo di Scipio e partì per il fronte il 26 Maggio (due
giorni dopo il popolo minuto) con le stellette al collo e
sulle maniche, credente in dio e nella patria, nelle
istituzioni e nel sovrano, convinta che i tedeschi fossero
barbari e che la Giustizia, il Diritto e la Civiltà fossero
figli della immacolata vergine Giovanna d’Arco. La
borghesia ricca si sparse per i mercati: accaparratrice
d’oro. Le ruote del carro della Fortuna erano unte col
grasso dei morti. L’aristocrazia si sparse per i comandi:
accaparratrice di croci ed onori. Gloria ai pochi Paolucci
dei Calboli e ai pochi Sermoneta che hanno sputato sulla
casta. [7]
Le pagine di Malaparte evidenziano una tristissima
verità storica. Contadini, operai, studenti e piccoli
possidenti furono mandati a morire mentre, viceversa,
ricchi e nobili, arroccati nei loro lussuosi palazzi, si
limitarono a parlare di patria, di sacrificio e di coraggio
incastonando sui loro lussuosi abiti le più preziose
gemme e i più luccicanti diamanti. La guerra, ahimè,
certo non sfuggì (e non sfugge tuttora) alle rigidissime
regole sociali intrinseche alla società occidentale.
Eppure l’enorme quantità di sangue versato tra il 1914
ed il 1918 non bastò a saziare gli orrendi appetiti delle
classi dirigenti europee. Tra il 1939 ed il 1945 un’altra
guerra, altri milioni di morti e di feriti. Ancora una
volta Curzio Malaparte fu attento protagonista ed
osservatore di tali nefasti avvenimenti. Questi tragici
eventi gli permisero la stesura di uno dei suoi
capolavori letterari: il romanzo Kaputt (1944).
Kaputt è un libro crudele. La sua crudeltà è la più
straordinaria esperienza che io abbia tratto dallo
spettacolo dell’Europa in questi anni di guerra. Tuttavia,
fra i protagonisti di questo libro, la guerra non è che un
personaggio secondario. Si potrebbe dire che solo un
valore di pretesto, se i pretesti inevitabili non
appartenessero all’ordine della fatalità. In Kaputt la
guerra conta dunque come fatalità. Non v’entra in altro
modo. Direi che v’entra non da protagonista, ma da
spettatrice, in quello stesso senso in cui è spettatore un
paesaggio. La guerra è il paesaggio oggettivo di questo
libro. Il protagonista principale è Kaputt, questo mostro
allegro e crudele. Nessuna parola, meglio della dura, e
quasi misteriosa parola tedesca Kaputt, che letteralmente
significa ‘rotto, finito, andato in pezzi, in malora’,
potrebbe dare il senso di ciò che noi siamo, di ciò che
ormai è l’Europa: un mucchio di rottami. E sia ben
chiaro che io preferisco questa Europa kaputt all’Europa
d’ieri, e a quella di venti, trent’anni or sono. Preferisco
che tutto sia da rifare, al dover tutto accettare come
un’eredità immutabile. [8]
L’Europa uscita dal secondo conflitto mondiale era
quindi un continente prostrato, una tabula rasa sulla
quale edificare una nuova civiltà. L’arte pittorica e
scultorea europea, con vera furia iconoclasta, ideò la
già citata poetica informale e gestuale, prima
insanabile frattura tra l’arte del passato e l’arte
contemporanea.
In questa complessa cornice storica ed artistica anche
l’arte musicale accademica decise che era necessario
abbandonare il passato per gettarsi verso nuove (ed
inesplorate) mete artistico-estetiche. Il sistema tonale
ristretto (armonia funzionale) teorizzato dal musicista
e teorico francese Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764)
nel suo celebre Trattato d’Armonia del 1722 (seppur,
cronologicamente parlando, tale sistema grammaticalesintattico possa essere fatto risalire al trionfo della
monodia accompagnata sul contrappunto durante i
primi anni del seicento) arricchitosi successivamente
del cosiddetto temperamento equabile, la cui
funzionalità tanto compositiva quanto estetica venne
palesata da Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) nel
suoi due libri del Clavicembalo ben temperato (1722 1744), iniziò ad entrare irrimediabilmente in crisi
intorno alla seconda metà del XIX secolo. Richard
Wagner (1813 - 1883), Claude Debussy (1862 - 1918)
ed Erik Satie (1866 - 1925) ben rappresentano,
storicamente parlando, quell’asse franco-tedesco a cui
si dovette l’abbattimento delle passate regole
compositive legate all’armonia funzionale e la
conseguente nascita del linguaggio atonale. Solo con
Arnold Schönberg (1874 - 1951) ed allievi, intorno ai
primi anni ‘20 del ‘900, si vide l’avvento di una nuova
grammatica e sintassi musicale capace di portare ordine
e disciplina ove il precedente linguaggio atonale, con
le sue regole sfumate, eteree ed inesistenti, aveva
generato un certo caos estetico. Era nata la
dodecafonia. Alla passata armonia triadica e alla
sapiente alternanza di accordi di area di tonica,
sottodominante e dominante, andavano a sostituirsi la
serie dodecafonica e la riorganizzazione e
manipolazione di quest’ultima tramite l’uso di tecniche
compositive quali la retrogradazione, l’inversione e la
retrogradazione/inversione (tecniche quest’ultime già
ampiamente usate nel corso del XV secolo da parte dei
musicisti fiamminghi dediti all’antica arte del
contrappunto). In realtà, proprio come la pittura
impressionista, futurista, cubista, metafisica ed astratta
non avevano completamente reciso lo stretto legame
che le collegava alle antiche prassi pittoriche
rinascimentali, così la rivoluzione dodecafonica non
aveva di certo annullato i proprio legami con il passato
linguaggio tonale ristretto. Alla centralità dell’accordo
costruito, in stato fondamentale, sul primo grado della
scala diatonica di riferimento, andò a sostituirsi la
cosiddetta serie originale. L’impianto gravitazionale
sul quale si fondava l’armonia funzionale rimaneva
quindi intatto, semplicemente non era più il Sole a
girare intorno alla Terra bensì era quest’ultima a girare
intorno al Sole (per usare un piccolo parallelismo
astronomico). Schönberg fu quindi una specie di
Niccolò Copernico. Così come in passato si continuava
a disquisire di stelle, pianeti ed oggetti celesti, così in
musica si continuò a parlare di semitoni, toni, ottave
ben temperate e note musicali. Di tale stretto legame
tra passato e contemporaneità se ne rese ben conto lo
stesso Schönberg evidenziando in alcuni suoi scritti gli
stretti legami genetici che collegavano l’antica
tradizione tonale all’allora neonato linguaggio
dodecafonico. Per Schönberg, infatti, la musica
dodecafonica nacque come naturale prolungamento
storico-estetico del linguaggio tonale. Quest’ultimo,
difatti, possiede al suo interno una serie di
caratteristiche tali che ne provocarono l’inevitabile
implosione e la conseguente nascita della dodecafonia.
Schönberg così sintetizzò tali elementi implosivi
interni al sistema tonale ristretto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ogni triade maggiore, presa isolatamente, può
di per sé esprimere una tonalità d’impianto
Se non viene aggiunto nulla in contraddizione,
può essere considerata una tonica
Ma ogni accordo successivo mette in
discussione questo senso tonale e spinge in
direzione di altre tonalità
Soltanto certe successioni particolari di accordi
permettono di identificarne alcuni, di solito
l’ultimo, come accordi fondamentali di una
tonalità d’impianto.
Ma anche questa determinazione è valida
soltanto se non segue nulla in contraddizione!
Senza l’uso di mezzi tecnici ben precisi non si
può esprimere in modo inequivocabile una
tonalità d’impianto. [9]
Fu proprio l’instabilità interna al linguaggio tonale
ristretto a provocarne l’inevitabile scomparsa. Tuttavia,
oltre a tali legami tanto lessicali quanto materici, anche
fortissime relazioni organologiche, orchestrali e
coloristiche legavano in maniera strettissima il
linguaggio tonale passato alla musica dodecafonica.
Legni, ottoni, pianoforti, archi (eccetera) erano
esattamente gli stessi del secolo precedente (per non
parlare del sistema notazionale che rimaneva,
sostanzialmente, lo stesso). Del resto legami genetici
ancora più forti furono quelli che vennero a crearsi tra
l’arte musicale dodecafonica ed il serialismo integrale
tanto caro ai seguaci di Anton Webern (1883 - 1945)
radunatisi, dopo il secondo conflitto mondiale, attorno
alla cittadina tedesca di Darmstadt (ove, fin dal 1946, si
svolsero i celeberrimi Corsi estivi di composizione per
la Nuova Musica). Alla luce di quanto finora esposto
appare evidente come il primo novecento fu, all’interno
dell’evoluzione musicale europea, figlio legittimo delle
passate tradizioni accademiche ottocentesche.
La vera e propria rottura tra passato accademico e
avanguardia musicale venne ad essere sancita soltanto
sul finire degli anni ‘40 del secolo scorso quando il
compositore ed ingegnere francese Pierre Schaeffer
(1910 - 1995) iniziò a registrare e manipolare i più
svariati suoni da lui ritenuti ‘musicalmente
interessanti’, come ad esempio il suono di una
locomotiva, trasformandoli in vere e proprie
composizioni musicali tramite profonde manomissioni
elettroacustiche dei suoni precedentemente registrati.
Era nata la musica concreta1. Tale frattura tra passato e
contemporaneità venne ad essere ulteriormente
ampliata nel corso degli anni ‘50 e ‘60 grazie a
compositori quali i tedeschi Herbert Eimert (1897 1972) e Karlheinz Stockhausen (1928 - 2005) e gli
italiani Luciano Berio (1925 - 2003), Bruno Maderna
(1920 - 1973) e Luigi nono (1924 - 1990). I primi
sperimentando e generando suoni ex novo negli studi
presenti presso la Nordwestdeutscher Rundfunk di
Colonia, i secondi utilizzando le allora avanzatissime
strumentazioni elettroniche site presso lo Studio di
Fonologia della Rai di Milano. Era nata la musica
elettroacustica. Non esistevano più solamente le
abusate note musicali occidentali ben temperate
all’interno di un intervallo d’ottava fondato sulla
proporzione armonica 2/1 di pitagorica memoria, bensì
a tali eventi acustici di matrice accademica andarono
ad aggiungersi suoni campionati o generati ex-novo
tramite i primissimi registratori e sintetizzatori. Ai
pianoforti ed ai violini si erano sostituite le locomotive
e le onde acustiche sinusoidali. Eppure, ad uno sguardo
attento, ci si accorge che la frattura tra l’allora presente
ed il passato accademico a questi antecedente non fu
completa. I nuovissimi suoni ottenuti tramite i più
differenti processi di genesi sonora (es. sintesi additiva,
sintesi sottrattiva) vennero, difatti, gestiti ed
organizzati, a livello compositivo, in base alle regole
grammaticali e sintattiche interne al serialismo
integrale. Tale modus operandi è facilmente
1
Erroneamente si ritiene che il termine musica concreta indichi
l’utilizzo da parte di Schaeffer di suoni registrati dalla realtà
circostante e riutilizzati per finalità musicali. Questa asserzione è
vera solamente in parte. Il termine di musique concrète venne
utilizzato da Schaeffer per evidenziare come la propria rivoluzione
musicale ribaltasse l’azione compositiva del musicista. Mentre nella
musica tradizionale il compositore pensa la musica (pensiero
astratto), scrive la partitura e poi, tramite il momento esecutivo, la
genera a livello uditivo (esecuzione), nella musique concrète prima
viene il suono (realtà uditiva concreta) e solo seguentemente l’azione
compositiva del musicista.
riscontrabile in brani quali Studie I (1953) e Studie II
(1954) di Karlheinz Stockhausen. Allo stesso modo, se
prendiamo in analisi il brano Thema (omaggio a Joyce)
del 1958 di Luciano Berio, scopriamo che tale
composizione è strutturata secondo l’antica prassi della
variazione su tema. La splendida voce di Cathy
Berberian (1925 - 1983), intenta ad interpretare un
passo estrapolato dall’Ulisse di James Joyce (1882 1941), è infatti dapprima presentata senza alcuna
manomissione da parte del compositore il quale, in
seguito a tale candido incipit, si sbizzarrisce, nel corso
del brano, in una continua manipolazione del materiale
vocale iniziale al punto da renderlo del tutto
incomprensibile (l’elemento vocale perde la sua
completa intelligibilità, viene così a smarrirsi l’antica
relazione linguistica significante/significato). Così
come la pittura informale pagò un forte debito nei
confronti delle precedenti esperienze astratte, così la
musica elettroacustica non poté ignorare del tutto le
sensibilità musicali ad essa antecedenti (anche se ciò
non deve certo svilire la forza iconoclasta e
rivoluzionaria tanto dell’arte informale quanto della
musica elettroacustica).
L’arte informale e la musica elettroacustica si
generarono dal medesimo terreno fertile, ovvero da
quella vera e propria tabula rasa sociale e culturale che
fu l’Europa seguente al secondo conflitto mondiale. Fu
proprio questa stretta parentela a permettere, nel corso
delle decadi seguenti, la genesi di rapporti sinestetici
sempre più stretti tra le arti visive e l’arte dei suoni (in
altre parole se l’estetica a fondamento di più arti è la
medesima è ovvio che tali differenti arti possano
mischiarsi dando vita a nuove potenzialità espressive).
Sfruttando tale vicinanza storica ed estetica nacquero,
nel corso degli anni seguenti, esperienze artistiche ove
l’elemento visivo e quello sonoro erano assolutamente
inscindibili e parimenti importanti per la fruizione di
un determinato evento artistico.
3. CONCLUSIONI
L’arte informale (soprattutto nella sua corrente
segnica/gestuale) e la musica elettroacustica nacquero
quali risposte ad un’allora presente profondamente
ferito dalle nefandezze che, nel corso del secondo
conflitto mondiale, segnarono il continente europeo. A
complicare ulteriormente questa situazione intervenne
l’esplicita benché dormiente conflittualità USA/URSS
(guerra fredda 1945 - 1991).
Le atrocità perpetrate dai regimi nazifascisti nel corso
del secondo conflitto mondiale richiesero una completa
rottura, in ambito artistico e culturale, nei confronti di
un passato che, nel bene e nel male, era stato il padre di
tale nefandezze. L’arte informale e la musica
elettroacustica rappresentarono, quindi, una medesima
sensibilità estetica germogliata in ambiti espressivi
differenti ma, al contempo, complementari. La tanto
agognata unione delle arti aveva finalmente trovato una
solida radice storica e culturale grazie alla quale
imporsi a livello comunitario. Come in pittura il gesto
irrazionale e la forma priva di forma ruppero gli schemi
passati, così in musica il suono registrato, manomesso
e/o ottenuto tramite sintesi elettronica distrusse il
lessico musicale accademico e, conseguentemente,
sembrò destinare all’obliò gl’innumerevoli strumenti
musicali partoriti dalla cultura europea. Tuttavia tale
energia iconoclasta fu tale solamente in parte. A ben
vedere, infatti, anche in queste rivoluzioni innovatrici
si possono scorgere legami con l’arte del passato.
Come già ricordato Stockhausen e Berio non riuscirono
a liberarsi completamente da talune sensibilità estetiche
ad essi cronologicamente precedenti così come, in
ambito pittorico, l’arte informale mostra delle
connessioni, seppur flebili, con le celebri macchie di
colore dell’italiano Giorgione (1478 - 1510) e con
l’arte astratta creata e perpetrata da Kandinskij
agl’inizi del novecento. Con l’arte informale e la
musica elettroacustica, per la prima volta, la frattura
tra presente e passato fu realmente totale. Eppure,
anche in questa situazione di completa iconoclastia nei
confronti del passato, qualcosa di quest’ultimo
sopravvisse e si perpetuò.
Il celebre drammaturgo rumeno naturalizzato francese
Eugène Ionesco (1912 - 1994) mise in bocca ad alcuni
suoi personaggi parole densissime di significato nella
sua pièce teatrale L’improvviso dell’Alma ovvero Il
camaleonte del pastore:
[…] Bartholomeus I (a Bartholomeus II e a
Bartholomeus III) Silenzio! (A Ionesco) Lei dunque non
sa che i contrari sono identici? Un esempio: Quando le
dico: una cosa è veramente vera, ciò vuol dire che è
falsamente falsa.
Bartholomeus II Ossia, inversamente: se una cosa è
falsamente falsa, è anche veramente vera…
Ionesco Non l’avrei mai creduto. Come sono dotti! [10]
Cosa ci insegnano le sopraccitate parole di Ionesco?
Esse evidenziano come, talvolta, anche ciò che ci
appare come antitetico nei confronti di un’idea o di un
dato materiale possa essere, in realtà, gemmazione di
quest’ultimo. L’arte informale e la musica
elettroacustica godettero sì d’un medesimo padre,
quello spirito rivoluzionario ed iconoclasta che si
espanse per tutta Europa successivamente al secondo
conflitto mondiale, ma, al tempo stesso, non chiusero
del
tutto,
tanto
volontariamente
quanto
involontariamente, le proprie porte alle conquiste del
passato.
Mai come oggi le arti comunicano e dialogano
fruttuosamente tra di loro. Tutto ciò è oggi possibile ed
esteticamente accettato e ricercato poiché vi fu, dopo il
secondo conflitto mondiale, la sentita necessità d’una
rottura profonda con le tradizioni passate. Arte
informale e musica elettroacustica condivisero i
medesimi natali e, forti di questa stretta parentela, non
poterono evitarsi a lungo. Oggi installazioni
audiovisive, sperimentazioni di natura cinematografica
ove suoni ed immagini sono assolutamente inscindibili
e pratiche musicali strettamente connesse con eventi
luminosi e/o tattili, sono all’ordine del giorno. Forse
siamo ancora lontani dalla nascita d’una sensibilità
estetica capace di unificare, anche forzosamente,
linguaggi espressivi differenti, tuttavia è indubbio che
il percorso intrapreso dall’arte occidentale si è volto
sempre di più, giorno dopo giorno, verso tale finalità.
4. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
[1] Richard Wagner, L’arte e la rivoluzione, Roma:
Fahrenheit 451, 2003.
[2] Daniele Lombardi e Carlo Piccardi, Rumori Futuri Studi e immagini sulla Musica Futurista, Firenze:
Vallecchi Editore, 2003 - 2004, p. 25.
[3] Kasimir Malevič, Suprematismo: il mondo della
non-oggettività, Bari: De Donato Editore, 1962.
[4] http://www.rusmuseum.ru/
[5] Gillo Dorfles, Ultime tendenze nell’arte d’oggi Dall’informale al concettuale, Milano: Feltrinelli
Editore, 1973, p. 20
[6] Dora Vallier, L’arte astratta - Il cosmo
dell’immagine pura, Italia (Milano): Garzanti Editore
s.p.a., 1984, p. 13 e p. 30.
[7] Curzio Malaparte, Viva Caporetto! La rivolta dei
santi maledetti, Firenze: Vallecchi Editore, 1995, p.
105.
[8] Curzio Malaparte, Kaputt, Milano: Adelphi, 2009,
p. 14.
[9] Arnold Schönberg, Stile e Pensiero - Scritti su
musica e società, Milano: il Saggiatore S.p.A., 2008, p.
126.
[10] AA. VV., Il Teatro contemporaneo - I Capolavori
di Beckett, Ionesco, Osborne - Il teatro di Eugène
Ionesco - L’improvviso dell’Alma ovvero Il camaleonte
del pastore, Italia: Giulio Einaudi Editore e Arnoldo
Mondadori Editore, 1961, p. 220.