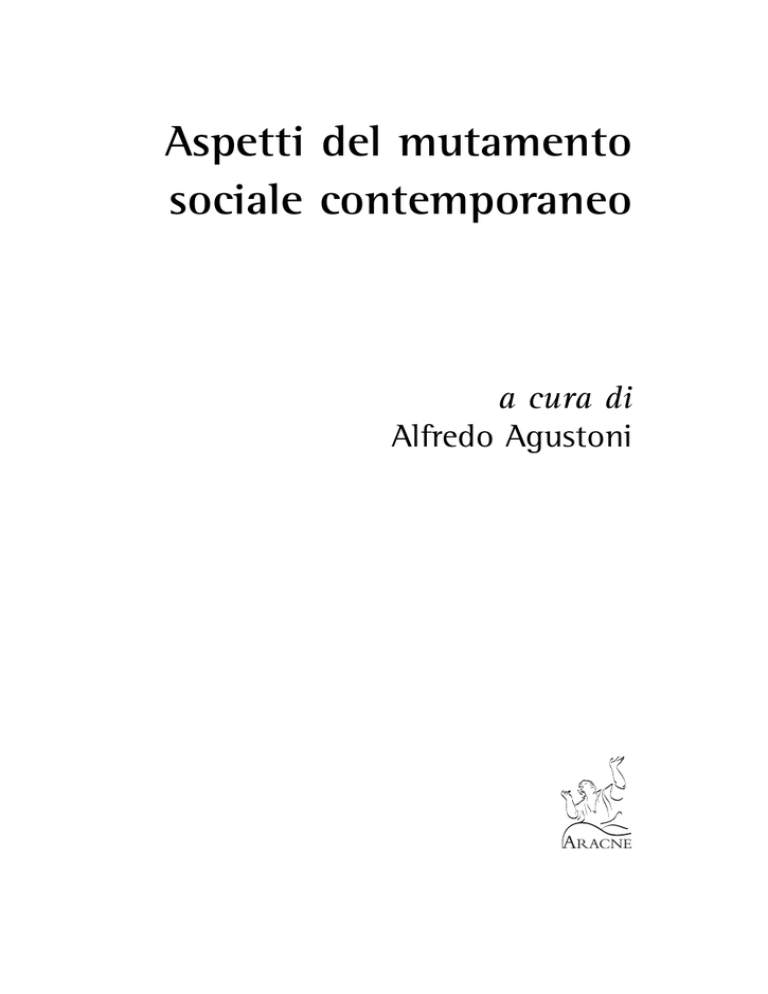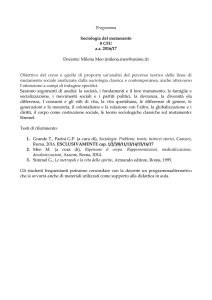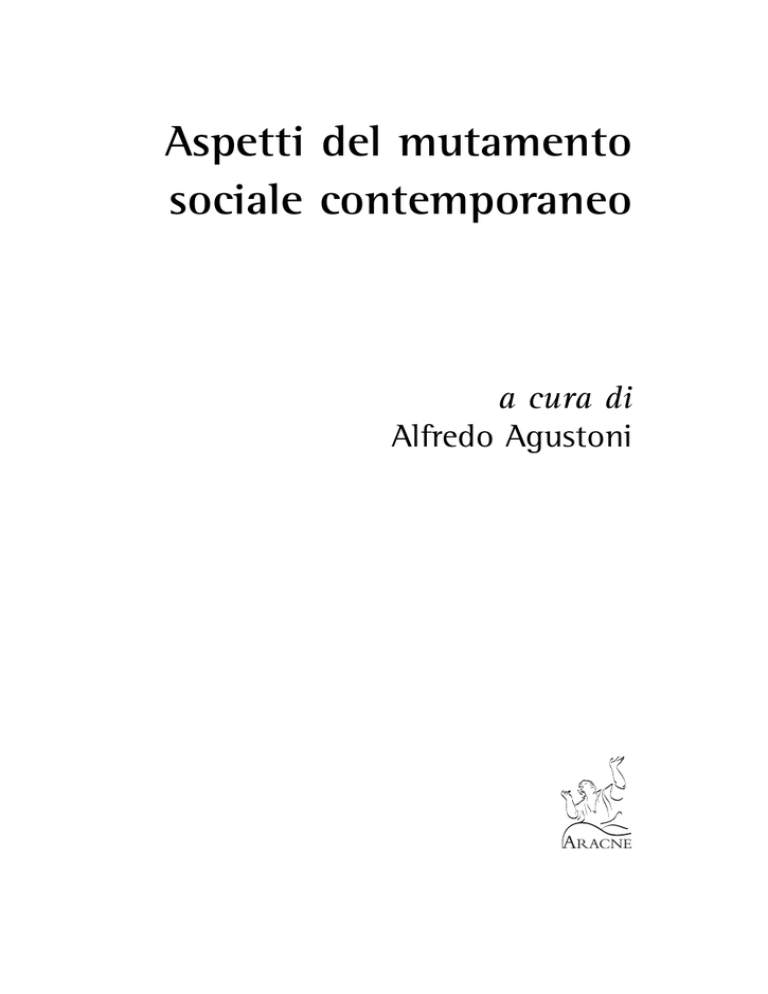
Aspetti del mutamento
sociale contemporaneo
a cura di
Alfredo Agustoni
ARACNE
Copyright © MMVIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–1646–6
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: gennaio 2008
Indice
Introduzione: globalizzazione e mutamento sociale contemporaneo
(di Alfredo Agustoni)……………………………………………
Cap. 1. Sul concetto di cultura nelle scienze sociali
(di Lia Giancristofaro) …………………………………………..
Note bibliografiche ……………………………………………………
Cap. 2. Mutamento sociale, alterità e relazioni. L’altro come fondazione della vita sociale (di Mara Maretti) ………………….…………...
Introduzione ……………………………………………………………
1. L’altro nel decostruzionismo di Jacques Derrida ……………..
2. L’etica dell’alterità in Emmanuel Lévinas ……………………...
3. L’altro come motore del mutamento sociale ……………………
4. Le relazioni con l’altro: dall’individuo alla persona …………
Note bibliografiche ……………………………………………………
Cap. 3. Mutamento sociale, razionalità e comunicazione. Agency vs.
Fluency (di Stefano Pasotti) ……………………………………….…….
1. Il mutamento sociale e la sua dinamica epistemologica ……...
2. Il mutamento sociale tra struttura e azione …………………….
3. Agency: la teoria morfogenetica della razionalità sociale …...
4. Fluency: la comunicazione come principio di razionalità
dell’attore sociale ……………………………………………………..
Note bibliografiche ……………………………………………………
Cap. 4. Mutamento sociale e differenziazione. Il contributo di Simmel e Durkheim (di Stefano Ricciuti) ………………………….
1. Premessa …………………………………………………………….
2. Uber sociale differenzierung ……………………………………..
3.De la division du travail social ……………………………………
4. Breve confronto ed epilogo ……………………………………….
Note bibliografiche ……………………………………………………
Cap. 5. Mutamento sociale e reciprocità. Il paradigma del dono
(di Ivo Germano) ………………………………………………..
Premessa. Il dono come contrappunto paradigmatico del mutamento ..………………………………………………………………….
1. I buchi neri del mutamento socioculturale ……………………..
2. Alle radici del paradigma del dono fra antropologia e sociologia …………………………………………………………………….
3. Dono, mutamento e isomorfismo sociale ……………………….
Note bibliografiche ……………………………………………………
p. 9
p. 21
p. 31
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
33
33
35
42
48
50
52
p.
p.
p.
p.
55
55
58
61
p. 65
p. 71
p.
p.
p.
p.
p.
p.
73
73
74
76
78
79
p. 83
p. 83
p. 84
p. 85
p. 93
p. 95
6
Indice
Cap. 6. Mutamento sociale e differenze di genere
(di Thea Rossi) ………………………………………………….
Note bibliografiche ……………………………………………………
Cap. 7 Mutamento sociale e relazioni internazionali. Il realismo politico e il problema della guerra (di Alessandro Orsini) ………………
Introduzione ……………………………………………………………
1. Il realismo politico. Gli assunti fondamentali ………………….
2. Quanto contano le identità? ………………………………………
3. La lezione di Waltz. Strutturalisti vs. riduzionisti …………….
4. La guerra come pericolo permanente …………………………...
5. Il realismo offensivo di John Mearsheimer ……………………..
Note bibliografiche ……………………………………………………
Cap. 8. Mutamento sociale, economia e tecnologie. Oltre Blade Runner (di Andrea Pitasi e Lucia M. Giraldi) ……………………………..
Prologo …………………………………………………………………
1. Paradigm Shifts …………………………………………………….
Note bibliografiche ………………………………………………….
Cap. 9. Mutamento sociale e pubblica amministrazione. Il caso della
dirigenza pubblica (di Francesco Ferzetti) …………………………..
Introduzione ……………………………………………………………
1. Gli stadi della riforma del reclutamento ………………………..
2. Accesso alla qualifica di dirigente mediante concorso ……….
3. Il sistema del corso-concorso …………………………………….
4. Il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigenziale ……………………………………………….
5. Il riconoscimento e la valutazione dei titoli utili per l’accesso
al corso–concorso selettivo di formazione dirigenziale ………….
6. Conclusioni …………………………………………………………
Note bibliografiche ……………………………………………………
Cap. 10. Mutamento sociale, morte e genesi dell’individuo contemporaneo. Terry Schiavo e l’eutanasia nei media
(di G. Caramaschi e G. Capanna Piscè) ………………………….
Introduzione ……………………………………………………………
1. Emarginazione della morte fra modernità e contingenza…….
2. La riflessione etica come strategia della società ………………
3. Terry Schiavo, ovvero la vita come materia sociale..………….
4. Conclusioni……………………………. …………………………...
Note bibliografiche ……………………………………………………
p. 99
p. 111
p. 113
p. 113
p. 115
p. 118
p. 119
p. 122
p. 123
p. 127
p. 131
p. 131
p. 134
p. 142
p. 145
p. 145
p. 147
p. 149
p. 150
p. 151
p. 154
p. 155
p. 157
p. 159
p. 159
p. 161
p. 165
p. 168
p. 173
p. 174
Indice
Cap. 11. Mutamento sociale e spazi marginali. La convivenza interetnica in tre località della Provincia di Pesaro-Urbino
(di Alfredo Agustoni)…………………………………………...
1. Migrazioni e identità locali ………………………………………
2. Articolazione della ricerca ……………………………………….
3. Urbino 2, Urbania e S. Angelo in Vado ………………………..
4. Abitare ………………………………………………………………
5. Spazi pubblici e luoghi d’incontro ………………………………
6. Percorsi ……………………………………………………………..
7. Il lavoro ……………………………………………………………..
8. Andare a scuola ……………………………………………………
Sintesi e conclusioni ………………………………………………….
Note bibliografiche …………………………………………………..
7
p. 177
p. 177
p. 178
p. 179
p. 183
p. 187
p. 192
p. 203
p. 209
p. 214
p. 215
Introduzione
Globalizzazione e mutamento sociale contemporaneo
di Alfredo Agustoni
Se definiamo l’uomo alla stregua di animale culturale, dobbiamo osservare come, nella storia dell’evoluzione umana, il mutamento culturale sia proceduto con
maggiore lentezza dell’evoluzione biologica, come attestano tutte le tracce relative
alla lavorazione della pietra e alla domesticazione del fuoco. La tecnica di lavorazione della pietra cosiddetta olduwaiana, fa la propria comparsa con l’homo habilis, ma continua ad accompagnare i suoi “successori”, l’africano ergaster e
l’asiatico erectus, per buona parte della loro esistenza sul pianeta. La successiva
tecnica acheuleiana, che si afferma con l’homo erectus, continua ad esistere, al di
là dell’estinzione della specie, con l’uomo di Neanderthal – che utilizza il fuoco,
per riscaldare la sua permanenza nell’Europa glaciale, esattamente come aveva
cominciato a fare l’homo erectus (salvo avere, in aggiunta, acquisito qualche rudimentale conoscenza relativa alla lavorazione delle pelli). Anche le forme
dell’organizzazione sociale, nell’arco di un paio di milioni d’anni, non sembrano
conoscere trasformazioni di rilievo. Risulta, pertanto, difficile parlare del mutamento sociale e culturale come di una realtà contrassegnata da una propria autonomia rispetto alle trasformazioni di carattere biologico.
Solo con la comparsa dell’homo sapiens moderno, ci troviamo di fronte ad un
complesso di mutamenti che prescindono dall’evoluzione biologica. Essi possono
essere, pertanto, riferiti ad una sfera autonoma, la cultura, che possiamo definire
come il «patrimonio intellettuale e materiale, relativamente stabile e condiviso,
proprio dei membri di una determinata collettività, costituito da valori, norme, definizioni, linguaggi, simboli, segni, modelli di comportamento e oggetti materiali»
(Bichi, 1997: 11). Con la nascita della cultura assistiamo, in un certo senso, alla
genesi di una “seconda natura”. Un oggetto diventa uno strumento; lo stesso oggetto, come anche un gesto corporeo (per esempio un determinato suono derivato da
un’emissione vocale), possono diventare un simbolo. La realtà viene cognitivamente organizzata attraverso visioni del mondo, costituite da sistemi organici di rappresentazioni, che integrano al proprio interno conoscenze ed esperienze relative ai diversi oggetti ed aspetti della realtà.
La “seconda natura”, creata dall’uomo, tende in un certo modo a naturalizzarsi,
in virtù di un fenomeno che (con più specifico riferimento alla sfera dell’economia
10
Alfredo Agustoni
capitalistica) Marx definisce feticismo1. Le forme sociali e culturali, che si generano e si trasformano in relazione con l’agire umano, appaiono agli occhi degli uomini come entità naturali, dotate di una vita propria, scontate e necessarie. Il faraone regna sull’Egitto come vi ha sempre regnato, per le stesse ragioni che portano il
sole a nascere ogni mattina. Il sole si chiama proprio “sole”, per le stesse ragioni
che lo portano, ogni sera, a tramontare.
Questa “seconda natura” ha un ruolo di prim’ordine nella creazione di un equilibrio ecologico tra i differenti gruppi di homo sapiens e i contesti al cui interno si
vengono ad inserire. Poco meno di 100mila anni fa, ha inizio la diaspora che porta
questo primate bipede, l’homo sapiens moderno, fuoruscito dalla sua nativa Africa,
ad espandersi attraverso tutte le terre emerse, approfittando della scomparsa di altri
ominidi che l’avevano preceduto – o, forse, provocandola. Nelle terre che non erano state interessate dalla presenza di precedenti specie umane (è il caso
dell’Australia e delle Americhe) l’arrivo dell’homo sapiens si pone peraltro alla base di spaventosi cataclismi ecosistemici, caratterizzati da estinzioni di massa, autentiche ecatombi di specie vegetali e animali.
Le successive “globalizzazioni” possono essere in qualche modo identificate
con il progressivo ricongiungimento, nel corso dell’Olocene, di quella specie umana che nel Pleistocene si era dispersa in ogni angolo della terra. La prima globalizzazione è una sorta di globalizzazione millenaria, fatta di economie mondo, articolate attorno a nuclei centrali, corrispondenti ai “fari” delle diverse civiltà, che nella
loro espansione si incontrano, si scontrano, si influenzano reciprocamente. Nel
contempo, settori della popolazione mondiale, caratterizzati da stili di vita nomade,
sono sempre pronti a presentarsi come una minaccia che preme ai loro confini, contribuendo pur tuttavia ampiamente all’incontro tra i differenti “mondi”2.
Consideriamo, tra il XV e il XVI secolo, conclusa questa globalizzazione “millenaria” e passiamo alla terza, “secolare”, che prende il proprio avvio dall’Europa,
dopo che nei millenni precedenti il concorso di un complesso di fattori contingenti,
egregiamente sintetizzati da Jared Diamonds (1997, 2005) e Carlo Maria Cipolla
(1965, 1988), ne avevano preparato l’incubazione in Eurasia. Quest’ultima globalizzazione “secolare” è caratterizzata dall’affermazione dell’economia e della “civiltà” capitalistiche e, per adoperare l’espressione di David Harvey (1989), dalla
compressione spazio-temporale.
1
Le merci, prodotte dal lavoro umano, sostiene nel Capitale il filosofo di Treviri, “sembrano
dotate di una propria vita, figure indipendenti che sono in rapporto tra di loro e con gli uomini”, al
punto che i rapporti si manifestano “non come rapporti direttamente sociali tra persone nei loro stessi
lavori, ma come ... rapporti sociali tra cose”.
2
La pastorizia transumante, praticata da Abramo e dai suoi discendenti, non è di molto più
giovane dell’agricoltura stanziale. Il nomadismo “classico” della civiltà delle steppe, che nel nostro
immaginario è egregiamente rappresentato dagli unni e dai mongoli, si afferma invece tra il II e il I
millennio a.C., con la diffusione del cavallo nell’Asia centrale, come evidenziato da Walter Pohl
(2000).
Introduzione
11
Cosa si intende con quest’ultima espressione? Tra le svariate altre cose, il buon
Leopardi si lamentava, negli anni venti dell’Ottocento, di un mondo divenuto ormai troppo piccolo, tanto da non lasciare più spazio per l’ignoto e il mistero; ma, a
dire il vero, il globo dei suoi tempi era ancora smisurato rispetto a quello che, di lì
a poco, doveva prenderne il posto. Chi avesse inviato un messaggio da Londra a
Bombay, attorno al 1850, avrebbe rischiato di attendere oltre un anno per ottenere
una risposta. Verso il 1880, il tempo di attesa si era ridotto a poche ore, tutt’al più
ad una giornata. Il telegrafo a fili aveva fatto il suo primo, timido, capolino negli
anni che avevano seguito la Rivoluzione francese, per essere perfezionato nella
prima metà dell’Ottocento ed arrivare ad avvolgere il mondo, attorno agli anni Settanta di quel secolo, con i propri cavi transoceanici3. D’altro canto, le nuove tecnologie evolvono a questo punto con un’inaudita rapidità, al di là della telegrafia a fili
(Kern, 1982; Hugill, 1998). Nel 1912, il naufragio del Titanic «fu la prima sciagura
a cui il mondo assistette praticamente in diretta. Essa era simultanea alla vita di coloro che, nelle loro case, ne venivano a conoscenza […] in un certo senso, una simultaneità despazializzata» (Jedlowski, 2005: 68).
A questo punto, arguiscono alcuni (Guehenno, 1993; Ohmae, 1995; Sassen,
1996; Hobsbawm, 2007), l’accelerazione che ha caratterizzato le fasi più recenti
della compressione spazio-temporale, sarebbe stata tale da compromettere drasticamente quelle stesse potenzialità di controllo sul territorio che, negli ultimi due
secoli, essa stessa aveva reso possibile, erodendo, di conseguenza, la sovranità della principale incarnazione della politica moderna, lo stato territoriale sovrano. In
poche parole,
la tesi del logoramento del modello di sintesi statale uscito dalla modernità europea è
stata comunque sostenuta anche con argomentazioni sistematiche e studi approfonditi
… Il sorgere e il consolidarsi di una nuova dimensione spaziale tendenzialmente globale
sembra infatti scalzare le basi della spazialità politica moderna, plasmata nel corso di
cinque secoli proprio dagli Stati nazionali (Palano, 2007: 88).
C’è chi, come Nicholas Negroponte (1995), “inguaribile ottimista” per sua propria ammissione, parla di una futuribile agorà virtuale, di un nuovo spazio despazializzato dove eserciteremo un’ancora indefinita cittadinanza globale. C’è per contro chi, come Paul Virilio, David Lion o Armand Mattelart, non nasconde le proprie inquietudini, mettendo in risalto l’attualità di quell’immagine del Panopticon
nella quale, una trentina d’anni or sono, Michel Foucault (1975) identificava il senso stesso della modernità4: le nuove tecnologie potrebbero diventare l’occhio del
3
Il primo, che collegava Londra e New York, risale al 1867.
Intesa dal filosofo francese come perfezionamento, fino ai limiti del possibile, del controllo da
parte del “potere” sulla natura e sulla società (e, soprattutto, sul corpo, in quanto elemento di
mediazione tra l’una e l’altra). Il Panopticon è quel carcere, ideato sul finire del XVIII secolo dal
filosofo utilitarista Jeremy Bentham, dove la sentinella riesce a controllare, dalla propria torretta
4
12
Alfredo Agustoni
grande fratello? Se sì, chi potrebbe, nel concreto, incarnare tale figura di orwelliana
memoria, in un mondo che sembra caratterizzato dalla frammentazione del potere?
C’è, infine, chi paventa il possibile impatto della diffusione delle nuove tecnologie in termini di esclusione sociale, fino al limite di postulare la totale segregazione di un’élite (interamente proiettata nei flussi e negli spazi digitali
dell’emergente network society), rispetto ad una massa relativamente immobile, legata alla materialità dei luoghi fisici dalla propria stessa immobilità, ancorché espulsa da questi ultimi in numerose situazioni (si pensi ai profughi, ai vagabondi e
a simili figure che costituiscono le fasce più sventurate della massa “localizzata”).
Quest’ultima è, sintetizzando e forse banalizzando, la posizione sostenuta da Castells (1996) e da Baumann (1998).
La globalizzazione, in virtù dell’accelerazione indotta nei processi di scambio
culturale, rende problematico il concetto stesso di cultura che, per i suoi legami con
il patrimonio storico di discipline sviluppatesi a cavallo tra il XIX e il XX secolo,
risente delle idee di nazionalità allora egemoni in Europa. «Non esistono ormai che
pochissimi paesi, e forse non sono mai esistiti – sostiene Clifford Geertz (1995: 28)
– , che coincidano almeno in parte con società culturalmente solidali». Rende problematico tale concetto al punto che noti antropologi, come Ulf Hannerz (1996) e
Pieterse (2004), propongono di sostituirlo con altri concetti e categorie d’analisi
(per esempio, ibridazione, creolizzazione, ecumene culturale e habitat di significato) tali da evitare la rigida segmentazione del primo.
Ogni soggetto, occupando una determinata posizione (in termini spaziali, ma
anche “sociali”) nel complesso delle relazioni mondiali, sviluppa un suo modo peculiare di appropriarsi della totalità dei significati che circolano nella sua epoca:
piuttosto che dall’appartenenza culturale, la visione del mondo sembra cioè dipendere dalla posizione occupata nell’ambito dei flussi culturali planetari – «Il mio
habitat di significato quotidiano cambiò improvvisamente il giorno in cui nel mio
palazzo fu installata la televisione via cavo … tuttavia, il nostro habitat di significato non dipende soltanto dalla misura in cui gli siamo fisicamente esposti, ma anche
dalle nostre capacità di confrontarci con esso» (Hannerz, 1996: 31).
Per tanta gente – ciò nondimeno – il termine globalizzazione significa soprattutto questo: un’omogeneizzazione globale in cui certe idee e certe pratiche dilagano in tutto il
mondo, impedendo alle altre di esistere. Per alcuni questa è la marcia trionfale della
modernità. Altri lamentano che sia la sopraffazione dei colossi mercantili, i quali impongono di bere Coca Cola, di vedere Dallas o di giocare con la Barbie ovunque (Hannerz, 1996: 31).
Con un’efficace espressione, un’ecologista indiana, Vandana Shiva (1993: 11),
parla di monocolture della mente, con riferimento al fatto che «le monocolture
centrale, in ogni momento tutti i carcerati, senza essere mai visibile da essi. Il Panopticon costituisce,
secondo Foucault, la più egregia metafora di tale progetto totalitario della modernità.
Introduzione
13
prima invaderebbero la mente e solo dopo si trasferirebbero nei campi». L’autrice,
in breve, sostiene l’esistenza di un legame inscindibile tra cultura e ambiente.
L’affermarsi, a livello planetario, di un pensiero unidimensionale, capace di vedere
il mondo esclusivamente in un’ottica quantitativa e in termini di redditività si collega, a suo avviso, alle minacce che la diffusione delle monocolture comporta per
la biodiversità. Le pratiche di monocoltura risponderebbero, pertanto, alla medesima logica di quelle dello sradicamento culturale: il genocidio delle forme di vita
inutili, improduttive, inefficienti è intimamente collegato a quello delle forme culturali “arretrate”.
In quest’ottica ci troveremmo, dunque, di fronte ad una “cultura unica” che trasforma “gli altri” in “periferia”, interpretandone le peculiarità alla stregua di un
“sottosviluppo” e sprofondandoli nell’anomia (Latouche, 1998). «Trovare un modo
per preservare e stimolare la diversità delle culture in un’economia di reti globali
sempre più fondate sull’accesso a pagamento a servizi culturali, sarà una delle questioni politiche prioritarie del nuovo secolo». Di conseguenza, le eventuali permanenze culturali autoctone, parrebbero costituire una sorta di cavallo di Troia: «Le
multinazionali dei media stanno cominciando a sfruttare le risorse culturali di ogni
angolo del pianeta, manipolandole e presentandole come merci d’intrattenimento
culturale» (Rifkin, 2000).
Sul versante opposto si colloca l’altrettanto monolitica immagine dello “scontro
di civiltà”, con cui Samuel Huntington (1995) esprime l’idea del carattere mutuamente irriducibile, e forse necessariamente conflittuale, delle differenti civiltà.
Huntington ritiene che la modernizzazione del mondo non ne implichi necessariamente l’occidentalizzazione. Egli è inoltre convinto che l’aumento dei contatti, in
un contesto di globalizzazione, invece di diminuire le distanze culturali, esasperi il
sentimento che ciascuna civiltà ha della propria identità.
In seguito al crollo del blocco sovietico, il futuro geopolitico e culturale si caratterizzerebbe come “scontro di civiltà”. Huntington identifica otto civiltà differenti.
Gli antagonisti più temibili per l’occidente sarebbero, su di un piano economico, la
civiltà cinese confuciana, e, da un punto di vista politico e culturale, quella islamica, attraversata dal cosiddetto “rinnovamento”, ovvero dalla riscoperta delle proprie radici religiose di fronte al fallimento del nazionalismo occidentalista di Kemal Atatürk e del panarabismo modernista di Gamal Abdel Nasser.
Nel disegno sottostante, vediamo rappresentati i diversi modelli presi in considerazione, dove le frecce a doppia direzione rappresentano un rapporto di contrapposizione tra due modelli, mentre la linea discontinua rappresenta un rapporto di
compatibilità tra i due. Naturalmente, il carattere ambiguo e polimorfo che caratterizza al loro interno i diversi modelli, conduce ad esiti che possono sembrare, per
certi versi, non del tutto coerenti.
Alfredo Agustoni
14
monocolture
della mente
(V. Shiva, S. Latouche)
Scontro di civiltà
(S. Huntington)
“ecumene” culturale
(U. Hannerz, C. Geertz)
Inclusi vs. esclusi
(M. Castells, Z. Bauman,
B. Barber)
Villaggio globale,
agorà digitale
(Th. Friedman,
N. Negroponte)
Troviamo, in primo luogo contrapposta l’immagine della monocoltura della
mente, che contempla l’occidentalizzazione del mondo, rispetto a quella dello
scontro di civiltà, che si fonda sulla supposizione di una persistenza delle diverse
culture, reciprocamente contrapposte. L’una e l’altra, d’altro lato, si contrappongono all’immagine della globalizzazione come creazione di una “ecumene” planetaria, così come espressa da Geerz, Hannerz e Pieterse, dal momento che
quest’ultima respinge il monolitismo culturale delle prime due a vantaggio di
un’idea di cultura come frammentazione e ibridazione. L’idea di Hannerz, a sua
volta, è conciliabile tanto con il carattere “escludente” di modelli teorici come
quelli di Castells (1996), Barber (1995) e Bauman (1998), che vedono un’umanità
divisa in una minoranza integrata negli spazi della comunicazione globale, contrapposta ad una maggioranza di esclusi, quanto con il carattere “inclusivo” di una
certa letteratura apologetica, erede dell’immagine del “villaggio globale” di Mc
Luhann, che interpreta la globalizzazione culturale come un’abbattimento tout
court di spazi e barriere. Chiaramente, il carattere inclusivo dell’immaginario del
“villaggio globale” si oppone a quello escludente del primo: per gli uni, la jihad (e
gli altri conflitti di natura identitaria) è la folle risposta di chi respinge la globalizzazione (Friedman, 1992), per gli altri è la risposta disperata di chi ne è respinto.
D’altro canto, l’uno e l’altro non sembrano andare molto d’accordo con l’idea dello
scontro di civiltà, che vede nella jihad come la manifestazione di un naturale antagonismo tra visioni del mondo differenti.
L’immaginario del “villaggio globale”, peraltro, può essere interpretato come la
rappresentazione “integrata” di un’idea di omologazione rispetto alla quale
l’immagine della “monocoltura della mente” rappresenterebbe la versione “apocalittica”, tanto da giustificare una loro, almeno parziale, conciliabilità. D’altro canto,
l’idea delle monocolture della, caratterizzata dalla marginalizzazione delle forme
biologiche e culturali che esulano dalla razionalità formale e strumentale della
scienza newtoniana e dell’economia capitalistica, si coniuga in maniera eccellente
Introduzione
15
con l’antitetica prospettiva della globalizzazione come esclusione, come ghettizzazione, come creazione di una riserva indiana.
Siamo in un mondo che, per la prima volta nella sua storia, è abitato da una popolazione a prevalenza urbana (il primo paese a raggiungere questo traguardo, giusto un secolo fa, è stato la Gran Bretagna).
Nei prossimi uno o due anni – scrive Mike Davis (2006: 11) – una donna partorirà in
uno slum di Ajegunle a Lagos, un giovane abbandonerà il suo villaggio di Giava Ovest
attratto dalle luci di Giacarta, un contadino si trasferirà con la sua famiglia impoverita in
uno degli innumerevoli pueblos jovenes di Lima. L’evento specifico in sé non sarà nulla
di speciale e passerà del tutto inosservato, però costituirà una rivoluzione nella storia
umana paragonabile alla rivoluzione del neolitico o a quella industriale. Per la prima
volta la popolazione urbana della terra supererà numericamente quella rurale.
Di qui a vent’anni – aggiunge Oswaldo de Rivero (1999) – la popolazione dei Pvs raggiungerà i sei miliardi e mezzo d’individui, e sarà prevalentemente urbana. Salvo una
drastica caduta della natalità e delle migrazioni verso la città, coniugata ad una crescita
senza precedenti nel campo delle risorse alimentari5, dell’acqua e dell’energia, la maggioranza della popolazione mondiale vivrà nel cuore di un grave squilibrio fisico e sociale.
I fenomeni d’inurbamento, a livello planetario, non mancano di presentare, su
più larga scala, alcune analogie con i processi che caratterizzarono, nel corso
dell’Ottocento, i paesi interessati dall’industrializzazione. Tuttavia, con
un’eccessiva enfasi sulle analogie, ci esporremmo ai rischi di una forte ingenuità
epistemologica, tanto da ipotizzare un legame univoco tra sviluppo ed urbanizzazione – mentre, al contrario, Mike Davis (2006) evidenzia il carattere storicamente
contingente e contestualizzato del gigantismo urbano dei paesi in via di sviluppo.
Tenuto a freno dalle amministrazioni coloniali, l’inurbamento delle masse rurali di
questi ultimi ha conosciuto un iniziale decollo negli anni ’50 e ’60, per ragioni che
spesso si legano all’espulsione della manodopera rurale e all’instabilità geopolitica
dei rispettivi contesti nazionali.
Generalmente, all’inurbamento non corrisponde un’analoga domanda di manodopera da parte dei sistemi economici urbani, e questo conduce allo sviluppo di un
economia parallela fatta di lavori occasionali, di sottoccupazione, di “terziario arretrato”. Malgrado le promesse dei nuovi governi post-coloniali, inoltre, non si sviluppa nella sostanza alcuna consistente risposta governativa alla domanda
d’alloggio, mentre si tollerano, legittimandole nella sostanza, un complesso di pratiche che portano alla formazione di giganteschi slum (favela o bidonville, a seconda del differente contesto geografico) o a forme di squatting generalizzato. La real-
5
Occorrerrebbe raddoppiare la produzione agricola entro il 2025, calcola la FAO, per garantire la
sicurezza alimentare dei 7,8 miliardi di persone previste per quella data
16
Alfredo Agustoni
tà dello slum, nel suo complesso, interessano oltre la metà della popolazione di
numerose città dei paesi cosiddetti “in via di sviluppo”.
Come ricorda Saskia Sassen (2001: 71):
L’effetto più importante dell’investimento estero è quello di sradicare gli individui dai
loro modi di esistenza tradizionali. [Infatti], si è riconosciuto da molto tempo che lo sviluppo dell’agricoltura commerciale tende a soppiantare i contadini dell’agricoltura di
sussistenza, creando un’offerta di bracciantato agricolo salariato e dando vita ad
un’emigrazione di massa verso le città.
Così, lo sviluppo di impieghi industriali nelle città, attirando manodopera femminile dai contesti rurali in crisi, produce un circolo vizioso: «L’esodo delle giovani riduce la possibilità per gli uomini di guadagnarsi da vivere in molte aree rurali,
dove le donne sono indispensabili per la sopravvivenza». D’altro canto, «con il
contrarsi delle possibilità economiche tradizionali nelle aree rurali, per chi viene
licenziato diviene difficile, se non impossibile, ritornare a casa» (Sassen, 2001: 72).
Le donne, respinte ad un tempo dalla fabbrica e dal loro contesto d’origine, sono
pronte per una successiva scelta migratoria, anche in ragione «dell’espansione
dell’offerta di impieghi a basso salario negli Stati Uniti», come in altre economie
avanzate, derivante tra l’altro «dagli stessi processi economici internazionali che
hanno incanalato investimenti e attività industriali verso i paesi con bassi costi del
lavoro» (Sassen, 2001: 76).
Come evidenzia Manuel Castells (2000: 75-79):
L’avvento dell’informazionalismo, al volgere del millennio, si associa a disuguaglianza
e crescita dell’esclusione sociale in tutto il mondo … Il processo di ristrutturazione capitalista, con tutta la sua logica di competitività, ha molto a che fare con tutto ciò … I
dati sono però contraddittori, alimentando così un dibattito dai toni ideologici sulle reali
condizioni delle popolazioni del globo. Dopotutto, l’ultimo quarto del XX secolo, ha visto accedere allo sviluppo, all’industrializzazione e al consumo decine di milioni di cinesi, coreani, malesi, indiani, tailandesi, indonesiani … D’altra parte, individualizzazione del lavoro, ipersfruttamento dei lavoratori, esclusione sociale e integrazione perversa
sono legati a specifici processi associati ai rapporti di produzione … Il processo
d’esclusione sociale colpisce sia le persone che i territori. Avviene così che, se valgono
date condizioni, quartieri, regioni, città, paesi interi finiscono per essere esclusi, coinvolgendo nell’esclusione la maggior parte, se non la totalità, della popolazione.
Tali considerazioni ci introducono un ulteriore aspetto, costituito dalle fenomenologie del cambiamento – ovvero dai differenti modi di manifestarsi del cambiamento nell’esperienza dei membri delle società che ne sono investite. Storicamente,
il cambiamento culturale ha un andamento prevalentemente “carsico”, costituendosi di trasformazioni abbastanza graduali da risultare relativamente inavvertite, da
non sconvolgere cioè la normalità quotidiana degli attori sociali. In alcuni casi, tut-
Introduzione
17
tavia, esso assume la forma che un famoso antropologo, Ernesto De Martino
(1977)6, ha definito dell’apocalisse culturale, con riferimento allo sconvolgimento
delle coordinate quotidiane, di quelle certezze sulle quali si basa la sensazione della
stabilità del reale.
L’apocalisse culturale è egregiamente rappresentata nel Ritratto di signora di
Khushwant Singh, un narratore indiano contemporaneo, dove l’amorevole nonna,
nel momento in cui il protagonista va a scuola e le racconta quello che impara, comincia a sentirsi straniera rispetto al mondo, perché non vi riconosce più la propria
visione “tradizionale”: la terra gira intorno al sole invece di starsene ferma … .
L’incantesimo che legava la nonna al nipote si rompe e la prima, sempre più sola in
una realtà che ha perso significato, ormai, riesce a comunicare solo con i passeri ed
imbocca la via di una repentina vecchiaia, fino alla morte.
La consapevolezza della relatività delle forme culturali e delle istituzioni sociali
è un fenomeno relativamente recente. Esso si collega, in buona parte, al traumatico
incontro con i “nuovi mondi”, seguito alle scoperte geografiche della prima modernità e, poi, all’accelerazione del mutamento sociale e alla conseguente “crisi
dell’ovvietà” (Spedicato, 2006). La sociologia, in qualche modo, nasce di fronte a
questa “crisi dell’ovvietà” tipicamente moderna. Già dal suo sorgere, essa si propone cioè come una riflessione sul mutamento, in una fase storica (la prima metà
del XIX secolo) nel quale il mondo sembrava non essere più quello che, fino ad allora, era sempre stato. L’irrompere della modernità in un contesto tradizionale,
spesso, assume la fisionomia di un’apocalisse culturale. La modernità, ciò nondimeno, finisce per caratterizzarsi come esperienza di un mutamento accelerato ed
ininterrotto, che in qualche misura produce assuefazione, come ebbe ad evidenziare
egregiamente Georg Simmel nel suo estremo saggio del 1918, relativo al Conflitto
nella cultura moderna.
Il mutamento sociale e culturale è il tema che accomuna i saggi, per quanto eterogenei, di questo volume. Inizialmente il volume contiene alcuni contributi che
affrontano il tema dal punto di vista della teoria sociale, ponendolo in relazione con
aspetti quali la cultura (Lia Giancristofaro), la relazionalità e la figura dell’“altro”
(Mara Maretti), la razionalità e la comunicazione (Stefano Pasotti), la differenziazione sociale (tema caro, quest’ultimo, a classici come Simmel e Durkheim, presi
in esame da Stefano Ricciuti), la reciprocità (Ivo Germano). I saggi della seconda
parte sono, invece, maggiormente calati negli aspetti e nei risvolti del mutamento
sociale dei nostri giorni. È il caso delle differenze di genere, analizzate da Thea
Rossi, delle relazioni internazionali, considerate da Alessandro Orsini con particolare attenzione per la tradizione teorica del realismo politico; è ancora il caso delle
trasformazioni tecnologiche ed economiche nelle loro reciproche implicazioni, analizzate con particolare attenzione ed efficacia da Andrea Pitasi e Lucia Giraldi. È di
nuovo il caso della pubblica amministrazione, che Francesco Ferzetti analizza evi6
Vedi anche, a questo proposito, Agustoni (2007).
18
Alfredo Agustoni
denziando i rapporti tra il mutamento sociale e le trasformazioni di carattere normativo (con uno sguardo rivolto soprattutto alla formazione della dirigenza). È, infine, il caso dei rapporti tra il mutamento sociale e gli atteggiamenti nei confronti
della morte, che Guido Capanna e Giulia Caramaschi prendono in esame, con particolare riferimento al caso di Terry Schiavo. L’ultimo saggio, steso dallo scrivente,
è concentrato su di un ultimo aspetto delle dinamiche culturali, costituito dalla
convivenza interetnica.
Note bibliografiche
Agustoni, A. (2007), Intorno al mondo nuovo. Modernità e apocalissi culturali, Aracne,
Roma.
Barber, B. (1995), Jihad versus Mc World, Times Books, Londra.
Bauman, Z. (1998), Dentro la globalizzazione, Il Saggiatore, Milano, 1999.
Bauman, Z. (1998), Dentro la globalizzazione, Il Saggiatore, Milano, 1999.
Bichi, R. (1997), Il concetto di cultura, in V. Cesareo, a cura di, Sociologia: concetti e tematiche, Vita e Pensiero, Milano.
Castells, M. (1996), La nascita della società in rete, Università Bocconi, Milano, 2004.
Castells, M. (1996), La nascita della società in rete, Università Bocconi, Milano, 2004.
Castells, M. (2000), Volgere di millennio, Università Bocconi, Milano, 2004.
Cesareo, V. (2000), Società multietniche e multiculturalismi, Vita e Pensiero, Milano.
Cipolla, C.M., (1965), Vele e cannoni, Il Mulino, Bologna, 1999.
Cipolla, C.M., (1988), Allegro ma non troppo, Il Mulino, Bologna.
Coppola Pignatelli, P. (1992), L’identità come processo, Officina, Roma.
Davis, M. (2006), Il pianeta degli slum, Feltrinelli, Milano.
De Martino, E. (1977), La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali,
Einaudi, Torino.
De Rivero, O. (1999), in Le Monde Diplomatique, aprile 1999 : pp. 10-11.
Diamonds, J. (1997), Armi, acciaio e malattie. Storia dell’umanità negli ultimi 13mila anni,
Einaudi, Torino, 1998.
Diamonds, J. (2005), Collasso, Einaudi, Torino.
Foucault, M. (1975), Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1993.
Friedman, Th. (1992), Le radici del futuro. La sfida tra la lexus e l’ulivo, Mondadori, Milano, 2000.
Geertz, C. (1995), Mondo globale, mondi locali, Il Mulino, Bologna, 1999.
Giddens, A. (1991), Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 1994.
Guehenno, J. (1993), La fine della democrazia, Garzanti, Milano, 1995.
Hall, E. (1966), La dimensione nascosta, Boringhieri, Torino, 1988.
Hannerz, U. (1997), La diversità culturale, Il Mulino, Bologna, 2001.
Harvey, D. (1989), La fine della modernità, Il Saggiatore, Milano, 1993.
Hillman, J. (2001), Il piacere di pensare, conversazione con S. Ronchey, Rizzoli, Milano.
Hobsbawm, E. (2007), La fine dello stato, Garzanti, Milano.
Hugill, P.J. (1999), Le comunicazioni mondiali dal 1844. Geopolitica e tecnologia, Feltrinelli, Milano, 2005.
Huntington, S. (1995), Lo scontro di civiltà, Milano, Sperling&Kupfer, 1996.
Introduzione
19
Husson, M. (1995), Il capitalismo di fine secolo, Punto Rosso, Milano.
Jedlowski, P. (2005), Un giorno dopo l’altro, Il Mulino, Bologna.
Kern, S. (1982), Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna, 1988.
Latouche, S. (1989), L’occidentalizzazione del mondo, Torino, Boringhieri, 1992.
Marx, K. (1867), Il Capitale, Libro I, Newton Compton, Roma, 1996.
Negroponte, N. (1995), Essere digitali, Sperling&Kupfer, Milano.
Ohmae, K. (1995), La fine dello stato nazione, Sperling&Kupfer, Milano, 1996.
Palano, D. (2007), Lo spazio politico. Territori, confini e potere, in A. Agustoni, P. Giuntarelli e R. Veraldi, a cura di, Sociologia dello spazio, dell’ambiente e del territorio, Milano, FrancoAngeli.
Pieterse, J.N. (2004), Mélange globale, Carocci, Roma 2005.
Rifkin, J. (2000), L’età dell’accesso, Mondadori, Milano.
Sassen, S. (1996), Fuori controllo, Il Saggiatore, Milano, 1998
Sassen, S. (1996), Fuori controllo, Il Saggiatore, Milano, 1998.
Sassen, S. (1998), Globalizzati e scontenti, Il Saggiatore, Milano, 2001.
Shiva, V. (1993), Monocolture della mente, Einaudi, Torino, 1995.
Simmel, G. (1908), Sociologia, 1908, ed. cit. Comunità, Milano, 1989.
Simmel, G. (1918), Il conflitto nella cultura moderna, Bulzoni, Roma, 1976.
Spedicato, E. (2006), Per incontrare la sociologia, Rivista Abruzzese, Lanciano.
Touraine, A. (1992), Critica della modernità, Il Saggiatore, Milano, 2005.
Weber, M. (1905), L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, Firenze, 1965.
Cap. 1
Sul concetto di cultura nelle scienze sociali,
di Lia Giancristofaro
La cultura, quale attività oggettiva di mediazione con l’ambiente, è un’attività
pratica, non teorica. Dunque, lo studio della cultura è una disciplina intellettuale
difficile da descrivere, e questo ha creato conseguenze negative soprattutto per
l’antropologia culturale.
Lo studio della cultura, nell’intento di rappresentare, della cultura, soprattutto
l’aspetto soggettivo e di ricerca scientifica, nacque nel contesto teorico
dell’antropologia e quando apparve, con Tylor, nel 18711, non aveva equivalenti
nella maggior parte delle lingue orali che vennero in seguito studiate dagli antropologi2: il concetto interessava prevalentemente la società in seno alla quale era stato
elaborato, quella occidentale, bisognosa di autodefinirsi sia in rapporto ai gruppi
etnici coi quali era entrata in contatto nel corso del colonialismo, sia in rapporto alle sue grandi masse rurali a cultura orale, che all’epoca rappresentavano la prevalenza della popolazione europea stessa e che, similmente alle popolazioni esotiche,
si riteneva che fossero rimaste allo stadio primitivo, dunque senza storia. Tale concezione venne, nel giro di centocinquanta anni, pressoché ribaltata dal relativismo
culturale, che ebbe origine con Herskovits (1947) e che si basò sulla convinzione
che ogni cultura meritasse rispetto e riconoscimento; alla luce di questa prospettiva
ermeneutica, ogni criterio metaculturale di valutazione risultò fallace, poiché nessuna cultura era avvicinabile prescindendo dalla sua storia, dalle stratificazioni,
dall’inquadramento ambientale: a farla breve, ogni cultura doveva essere considerata nella sua irriducibile complessità3.
1
Il termine venne per la prima volta usato, con un’accezione simile a quella attuale,
dall’antropologo britannico E. B. Tylor. Questi asseriva che, nella misura in cui la cultura comprende
«tutte le capacità e i moduli di comportamento acquisiti dall'uomo in quanto membro di una società»,
lo studio di queste capacità avrebbe consentito di «risalire alle leggi del pensiero e dell'agire umano»,
p. 24.
2
Nella storia, la maggior parte delle popolazioni ha adoperato, per autodefinirsi, non termini
relativistici e di equiparazione alle altre popolazioni, bensì etnonimi come gli uomini, gli autentici o
gli eccellenti, in opposizione agli altri, non riconosciuti come umani a tutti gli effetti e considerati
“barbari” o “selvaggi”, secondo l’attitudine etnocentrica a organizzare le diversità culturali per mezzo
di una gerarchia, rivelatasi in seguito non solo scarsamente utile, ma anche molto pericolosa.
3
Spesso, questo pubblico riconoscimento della diversità culturale è stato erroneamente
interpretato come relativismo morale, confondendo il piano socio-culturale con quello filosofico; il
relativismo morale, infatti, è quella concezione filosofica che, attribuibile già a Protagora, non
ammette principi immutabili in sede morale, mettendoli bensì in relazione a circostanze, bisogni e
22
Lia Giancristofaro
La caratteristica della cultura di rappresentare la totalità dell’ambiente antropico
e di essere condivisa e distribuita in maniera omogenea all’interno dei vari gruppi o
società comportava inoltre che, nonostante lo spazio della variabilità individuale,
nella cultura permanesse una normatività intrinseca, che dagli individui era difficilmente percepibile come modello e regola esterna, poiché agente a livello intrapsichico. Contemporaneamente a questo processo di progressivo riconoscimento e
protezione delle culture in senso oggettivo4, la costruzione disciplinare
dell’antropologia culturale, ovvero lo straordinario tributo soggettivo dell’uomo
moderno nei confronti della diversità individuale e collettiva, si andava paradossalmente scostando dalla cultura (intesa come universale capacità degli esseri umani di rappresentare il mondo tramite simboli, di propagare tali simboli con l'insegnamento e di trasformare, tramite essi, il mondo esterno), per allinearsi con la tradizione teorica di Max Weber, Emile Durkheim e Marcel Mauss, i quali avevano
invece privilegiato l’osservazione della necessità di riproduzione dei gruppi sociali
e le soluzioni adottate per regolare le relazioni fra gli individui. Questo avvicinamento dello studio della cultura al terreno delle scienze sociali fu probabilmente
dovuto al fatto che lo statuto antropologico originario, all’epoca, non soddisfaceva
appieno gli intelletti, prevedendo, semplicemente, la descrizione delle culture come
sistemi normativi (elaborati in modo più o meno formale), come sapere necessario
per vivere e come totalità di ambiente socio-fisico di matrice umana.
L’allineamento tra cultura e società segnò, tuttavia, il progressivo impoverimento del concetto di cultura, per via della sua frequente assimilazione al concetto
di società. In seguito, una volta che ambedue i pilastri teorici vennero incrinati dal
dubbio riguardante non solo l’effettiva consistenza della cultura come modello
concettuale5, ma persino la sopravvivenza, nella globalizzazione, di realtà umane
caratterizzate dall’antica formula etnologica identificante un popolo con un territorio, una cultura ed una società, la definizione antropologica di cultura finì con il
teorizzarsi al livello di una amorfa struttura di significati non localizzata in territori precisi, determinando un ulteriore dissesto nell’impalcatura teorica antropologica
basata sul binario cultura-società.
Vuoi perchè il passaggio dalla semplice constatazione (fatto oggettivo) a costrutto concettuale (fatto soggettivo) aveva erroneamente ricondotto la cultura a un
sistema di valori astratti; vuoi perché l’eclettismo e la complessità delle tematiche
coinvolte avevano finito col caratterizzare l’antropologia culturale in quanto scienza dell’uomo a 360°; vuoi perchè le politiche accademico-istituzionali cominciavano a far proliferare le direzioni di ricerca, creando una grande varietà di sottodisciscopi. A livello storico, il relativismo morale ha il pregio di aver orientato la cultura greco-romana
verso il criterio scientifico delle condizioni e della verifica.
4
L’Unesco considera e protegge la cultura come “serie di caratteristiche specifiche di una società
o gruppo sociale” in termini spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali.
5
Dal fatto che la cultura è qualcosa di meno materiale della società, impersonata dalla gente, si
evince la maggiore difficoltà ad individuarla.
Sul concetto di cultura nelle scienze sociali
23
pline presso le università di tutto il mondo (antropologia visuale, economica, linguistica, storica, sociale, amazzonica, dello sviluppo, delle organizzazioni, del turismo, dell’arte, della letteratura, delle religioni, dell’alimentazione, dei fenomeni
migratori, del territorio, giusto per citarne alcune), tutti questi percorsi, variegati
quanto al contenuto e facili ad incroci e sovrapposizioni, segnalano quanto profonda sia stata la crisi che ha attraversato il significato di cultura nelle scienze sociali.
Una soluzione risiederebbe proprio nella radicale esemplificazione dello studio
della cultura, che se dalla globalizzazione sembrava essere stato, in un primo momento, terribilmente complicato, alla luce degli ultimi contributi scientifici sembra
facilitato. D’altronde, oggi che le migrazioni planetarie, i rimescolamenti e le contaminazioni sembrano aver spazzato via la diversità culturale, alla radice del problema si trova la vexata quaestio dell’identità mentale/sociale dei gruppi umani,
che, sviluppandosi a partire dalla seconda metà del XIX secolo, chiudeva il millenario lavoro preparatorio nel pensiero occidentale europeo verso una sempre maggiore consapevolezza, negli individui, della propria coscienza sociale6, aprendo la
tortuosa strada della determinazione della posizione dell’individuo rispetto allo
stratificato fluire della narrazione umana nella quale egli vive e si relaziona.
Facendo un breve flash back, è curioso che, proprio nella Francia che dava alla
luce la sociologia come disciplina scientifica, la questione identitario-culturale non
ebbe spazio, restando in un posizione ancillare rispetto alla questione sociale: in
Francia, si dovranno attendere gli anni Trenta del Novecento perché l’uso del termine cultura cominciasse a figurare nelle ricerche degli africanisti e il tema della
totalità culturale venisse ripreso da Claude Lévi-Strauss nella sua analisi strutturale7.
In quella fase iniziale, il maggior apporto allo sviluppo e all’affinamento del
concetto di cultura fu anglo-tedesco: innanzitutto, con le scoperte darwiniane e
l’ipotesi di un cambiamento che, partendo dall’adattamento genetico all’ambiente
naturale, avesse portato allo straordinario risultato dell’adattamento culturale,
principale caratteristica di Sapiens: un adattamento che, a differenza di quello genetico, è trasmissibile per mezzo di miti e segni convenzionali, dunque mutevole
nell’ambito dello stesso individuo senza dover attendere i tempi delle generazioni
successive. Questo aspetto venne, tuttavia, sottovalutato, ed il fenomeno fu interpretato in modo evoluzionistico, normativo e valoriale, tanto da sollecitare, assieme
alla contrapposizione tra cultura e civiltà, lo sviluppo del dibattito tra l’accezione
particolaristica (soffermatasi in chiave talvolta razzista sulla differenziazione del
fenomeno culturale nella storia) e quella universalistica, privilegiante l’unità del
6
L’idea di cultura, quando nacque, nei secoli XVIII e XIX, venne applicata solo al genere umano
e continuò intrinsecamente a contenere i concetti di paideia, cultura animi ed humanitas, fondamenti
ideologici del mondo greco-romano, dell’Umanesimo quattrocentesco e dell’Illuminismo.
7
Va specificato, tuttavia, che anche Emile Durkheim, pur non adoperando quasi mai il concetto di
cultura, sostenne che i fenomeni sociali, essendo fenomeni simbolici, hanno una dimensione culturale
intrinseca.
24
Lia Giancristofaro
genere umano e minimizzante le diversità culturali interne8. Solo con il grande apporto del tedesco Boas, a cavallo tra Ottocento e Novecento, si decise che le differenze erano acquisite, non innate9; non è un caso che Boas si fosse trasferito negli
Stati Uniti, dove il concetto di cultura stava ricevendo la migliore accoglienza e un
approfondimento teorico tale da rendere l’antropologia americana, ancora oggi, sinonimo di antropologia della cultura10. Da qui, le scienze sociali analizzarono la
cultura sia secondo il suo rapporto con la storia (prerogativa degli eredi di Boas11),
sia pure, parallelamente, secondo le strette relazioni che essa intesse con la personalità individuale12. La terza strada fu quella di leggere la cultura come un sistema
di comunicazione tra le persone e, sulla scorta dell’interpretazione di Sapir, per il
quale la cultura consisteva nelle interazioni individuali, di analizzare i processi
concreti di elaborazione della cultura, anziché definirla come entità ipotetica e astratta. Gli antropologi della comunicazione (Scuola di Palo Alto) concepirono la
cultura come comunicazione orchestrale finalizzata ad una interazione durevole,
sottolineando come fosse la pluralità dei contesti dell’interazione a motivarne il carattere instabile, plurale, eterogeneo13. Pur non essendo riusciti a spiegare quale sia
la sostanza della cultura, tutti questi studiosi hanno fatto almeno chiarezza su come
essa viene incorporata e, separando ciò che dipende dalla natura da ciò che dipende
8
Edward Tylor era stato il primo studioso a maturare una concezione universalista della cultura,
ritenuta essere espressione della totalità della vita sociale dell’uomo; la sua fu una definizione
oggettiva e descrittiva.
9
Boas attaccò il comparativismo, che ancora riscuoteva successo presso gli autori evoluzionisti,
sottolineò l’impossibilità di trovare leggi universali sul funzionamento delle società umane, e invitò i
colleghi a dedicarsi all’osservazione diretta delle popolazioni altre (ricerca sul campo), anziché perdersi in congetture salottiere, secondo il principio di sfuggire ad ogni forma di etnocentrismo.
10
Questo dipendeva dal particolare contesto socio-economico degli Stati Uniti e del Canada, dove
l’immigrazione stimolava ad interrogarsi sulle differenze culturali e andava allora creando le prime (e
maggiori) plurietnicità nazionali.
11
La storia culturale si sforzò, in particolare, di spiegare la distribuzione spazio-temporale degli
elementi culturali tramite il diffusionismo e nozioni come il tratto culturale, l’area culturale, il
modello culturale. In seguito, gli eccessi interpretativi del diffusionismo furono ridimensionati
dall’inglese Bronislaw Malinowski, che richiamò gli studiosi all’osservazione diretta delle culture allo
stato attuale, evitando ogni illusoria speculazione sulle loro lontane origini. Opponendosi, come Boas,
all’evoluzionismo (troppo rivolto a futuro), ma non per questo cadendo nel diffusionismo (troppo
rivolto al passato), Malinowski spiegò le differenze culturali secondo la teoria dei bisogni, per la
quale gli elementi costitutivi di una cultura avrebbero la funzione di soddisfare i bisogni essenziali
delle persone, in un funzionalismo totalmente concentrato sul presente e insufficiente a spiegare la
complessità del fenomeno.
12
Edward Sapir, Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton e Abram Kardiner misero in luce
l’importanza dell’educazione nel processo di differenziazione culturale.
13
Spiegando l’intrinseca eterogeneità di ogni cultura, gli interazionisti misero anche in
discussione la distinzione tra cultura e subcultura. Nell’elaborazione culturale, infatti, la cultura che
viene prima è quella locale, che unisce gli individui nell’interazione immediata, e non quella globale,
che riguarda una collettività più ampia.
Sul concetto di cultura nelle scienze sociali
25
dalla cultura (ossia la maggior parte dei fenomeni umani14), spianarono la strada ad
una interpretazione sociologica della cultura, vista non come una semplice combinazione di elementi, bensì come un insieme organizzato di elementi così strettamente connessi che il meccanismo di interdipendenza finisce con sopravanzare
l’importanza degli elementi stessi, cioè dei contenuti.
Un ulteriore rinnovamento fu dovuto allo studio delle relazioni tra le culture ed
al contributo europeo di Roger Bastide (1971) che, contro il culturalismo americano (considerato responsabile di un appiattimento dei fatti umani nella monodimensionalità culturale), sottolineò l’enorme diversità individuale dei vari ambiti sociali
dove possono contestualizzarsi i fenomeni culturali (sincretismo, meticciato o assimilazione), ed invitò a valutare la complessa dialettica che va dalle sovrastrutture
alle infrastrutture, nonché gli effetti secondari imprevisti. Per esempio, poiché non
sono le culture ad incontrarsi, ma le persone, in un contesto di acculturazione certe
caratteristiche della personalità umana possono essere spiegate solo ricorrendo alla
dissociazione, per la quale un individuo riesce a vivere contemporaneamente in due
universi culturali, senza metterli in comunicazione. L’acculturazione cominciò
dunque ad essere letta non come fenomeno geometrico e simmetrico, ma come fatto sociale totale, insomma di interpenetrazione culturale, espressa anche a livello di
forme inconsce (strutture percettive, mnemoniche, affettive, logiche). Contemporaneamente, ogni cultura poté essere vista come una culturazione, vale a dire un sistema dinamico e non perfettamente omogeneo, perchè intrinsecamente dotato di
un necessario margine d’azione, una fondamentale libertà fruibile a livello individuale e di gruppo.
Tuttavia, la progressiva scomparsa delle realtà socio-culturali caratterizzate dalla formula che tradizionalmente identificava un popolo con un territorio, una cultura ed una società, andava inevitabilmente ad erodere l’affidabilità teorica dei concetti di cultura e società: di questo fatto, si alimentò il nuovo filone
dell’antropologia interpretativa.
A partire dal 1970, la crisi della rappresentazione etnografica, della quale il
principale esponente fu Clifford Geertz (1997)15, portò ad interpretare le culture
come fossero testi; dunque, all’antropologo si impone di limitarsi a tradurre la cultura diversa, i cui concetti fondamentali potrebbero essergli assolutamente incomprensibili. Nel contempo, il fatto che la civiltà occidentale avesse invaso l’intero
pianeta, sconvolgendo gli equilibri ecologico-culturali e scardinando le strutture
14
Poiché la cultura interpreta la natura e la trasforma, il corpo umano è fortemente influenzato
dalla cultura: la cultura plasma anche le pratiche corporee apparentemente naturali (mangiare,
dormire, accoppiarsi, partorire, espletare le funzioni fisiologiche dell’organismo), come fu dimostrato
nel 1936 da Marcel Mauss per il quale, a causa delle tecniche culturali riguardanti il corpo, la natura
umana non può essere osservata prescindendo dalla cultura.
15
Prendendo lo spunto dalla notevole distanza che può essere intravista tra la materia culturale e
l’interpretazione che lo studioso ne fornisce, nonché calcando la mano sul ruolo di scrittore-autore
insito nell’etnografo, l’antropologia interpretativa rappresentò una seria provocazione contro la
cultura, e fece da detonatore alle tensioni precedentemente accumulate dalla materia.
26
Lia Giancristofaro
socio-culturali dei popoli di interesse etnologico, pose al centro dell’indagine il
sincretismo culturale e le culture meticcie. Il generale interessamento verso le problematiche interculturali e transculturali del pianeta ed il conseguente passaggio
dalla ratio culturale a quella delle logiche meticcie fecero sì che il sempre più inquieto panorama delle scienze sociali dichiarasse il definitivo esaurimento del concetto di cultura, il cui termine cominciò ad essere virgolettato o persino sostituito
da neologismi della disciplina, come ethnoscape (Appadurai, 1996). I dubbi su questo fondamentale strumento euristico andarono interamente a scapito
dell’antropologia culturale, che si trovò a basarsi sullo studio di un concetto ipercriticizzato, impantanato nelle storie culturali ereditate dall’antropologia interpretativa, nonché già fortemente eroso, a livello operativo, dallo sviluppo di scienze
contigue come la sociologia della cultura o della religione. Paradossalmente, nel
momento in cui tutti, persino giuristi ed economisti, hanno attinto all’antropologia
culturale, gli antropologi culturali si sono sfiduciati circa le proprie capacità di facilitare la lettura della realtà sociale, in quanto irrimediabilmente contaminata dalla
soggettività dell’etnografo (Fabietti e Matera, 1997) per l’essenza stessa della concettualizzazione della cultura, che tutto crea e… tutto distrugge.
Tuttavia, nell’intraprendere la strada della tuttologia e nell’obliterare il biglietto
della tautologia o scienza del nulla, un ruolo negativo forse anche peggiore veniva
già da tempo esercitato dal rapporto tra cultura e azione che, in una scienza come
l’antropologia culturale, non poteva risolversi in favore dell’individuo, visto come
determinato nei comportamenti e, dunque, psicologicamente svalutato. Per questo,
molti studiosi avevano evidenziato che la connotazione olistica della cultura, eccedendo nell’evidenziare gli automatismi del comportamento umano, finiva col denigrare l’individuo, la sua libertà di scelta, il suo ruolo attivo nel cambiamento culturale. Si badi bene: l’olismo altro non era che l’ennesima, nefasta conseguenza della
novecentesca confusione tra cultura e società, intesa, quest’ultima, come vita sociale. Infatti, la connotazione olistica non era molto presente agli albori della disciplina, allorquando Tylor concepì la cultura come quel complesso di capacità e abitudini acquisite dall’uomo in quanto membro di una società16; né essa è totalmente
imputabile all’organicismo della scuola di cultura e personalità che, relativamente
alle culture analizzate, stabilì l’esistenza di un modello culturale fortemente condizionante, senza però entrare nel merito della cultura come categoria analitica.
L’olismo, dunque, va ricondotto a coloro per i quali cultura coincide con società,
intendendo l’antropologia come modo di raccontare una società.
Forse, da quando l’antropologia culturale aveva cominciato a camminare sui
crinali, solo il filone di Parsons (1937) aveva individuato, in ogni azione sociale
(anche in quella apparentemente più condizionata da fattori culturali), una dimen16
L’obbiettivo principale di Tylor era stato, infatti, quello di risalire alle origini della cultura, per
il quale usò il termine evoluzionistico di cultura primitiva; questo tipo di cultura, secondo lo studioso,
ancora contraddistingueva alcune popolazioni presso cui, attraverso il metodo comparativo, era possibile documentare le sopravvivenze della cultura originale dell’umanità.
Sul concetto di cultura nelle scienze sociali
27
sione simbolica autonoma, evidenziando l’impossibilità di rinchiudere la cultura in
un unico compartimento disciplinare ed aprendo, nel contempo, la strada per distinguere ciò che è culturale da ciò che è sociale. Questo perché, quando la cultura
esce dal pantano del comportamento appreso e assurge a sistema simbolico, la sfera culturale non può più essere ritenuta coincidente con la sfera sociale, e la relazione di identità tra le due sfere precipita, a livello critico, in una interconnessione
tutta da analizzare e riccamente afferente alla linguistica, secondo la precedente lezione dello strutturalista Saussure che ridimensionava l’olismo ad un semplice ordine che, essendo unico elemento comune ai simboli e ai loro significati, non poteva essere colto attraverso lo studio isolato di simboli particolari, bensì nei termini
delle loro relazioni in sistemi. Questa prospettiva evidenzia e concretizza come la
cultura appartenga, sostanzialmente, all’orizzonte della comunicazione, nel quale,
da Aristotele in poi (vedansi gli approfondimenti di Karl Jaspers, Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer, Roman Jakobson, Luis Hjelmslev, Antonino Buttitta), l’intera
realtà umana è stata positivamente interpretata. La natura dei fatti culturali non è
diversa da quella dei fatti linguistici, da cui i fatti culturali derivano gran parte della
loro esistenza; pertanto, seguendo Saussure, in ognuno dei fatti culturali è presente
non solo il livello della parole, individuale, ma anche quello della langue, collettivo. Ma, mentre il livello parole, essendo individuale, è facilmente individuabile,
quello sociale non è immediatamente percepibile, a causa dell’ambiguità del concetto di società. L’essere sociale, infatti, rinvia a più ambiti, i quali sono dotati di
perimetro diverso e spaziano in territori diversissimi, che vanno dalla microcomunità in cui ci riconosciamo al grande mosaico dell’umanità totale, di cui la nostra
microcomunità è solo una piccola tessera. Invece, le teorie di Parsons, Hjelmslev
ed altri, attraverso la diversa temporalità degli effetti di un fatto culturale (rapida,
scandita, lenta, lentissima) ed il suo diverso stadio di consapevolezza (un fatto culturale può essere consapevole, come la parole, ma anche assolutamente inconsapevole, come lo schema), direttamente o indirettamente evidenziarono che
l’associazione tra significato e significante non è legata ad una legge naturale, ma è
l’essenza stessa del foedus culturale che unisce, sincronicamente e diacronicamente, tutto il genere umano. Ciò è dimostrato anche dalla varietà interna degli idiomi
(e delle culture) che, in ciascun linguaggio, non può essere modificata dal singolo
attore, per l’essenza stessa di totalità del sistema linguistico-culturale.
Se l’oggetto delle scienze sociali (o umane) è ancora l’uomo, e se il metodo selezionato è ancora quello sperimentale, il punto di vista dell’antropologia culturale,
secondo chi scrive, è ancora capace di cogliere le strutture comuni di fenomeni apparentemente diversi e lontani. La ricerca antropologica ha fatto un lungo cammino
per arrivare alla determinazione morfologica di fiaba, miti e rituali;
all’enucleazione dei motivi della narrativa orale o cibernetica e il loro rincorrersi,
oggi come ieri, con l’arte, i media e la letteratura; alle ricerche psicologiche sui
simboli e sui comportamenti religiosi individuali e collettivi, talvolta assurdi. E
Lia Giancristofaro
28
questo non solo ha il pregio di risolvere la contrapposizione tra culture popolari e
culture dominanti17, ma dimostra che la categoria generale di cultura conserva, anche nel contesto attuale, una capacità di analisi delle condivisioni sociali e una utilità nel loro collegamento con le altre scienze, anche se le culture intese in senso
classico sono ormai quasi scomparse.
Certamente, l’accesso alla comunicazione globale ha sostanzialmente cambiato
i confini etnologici e le rilevanze identitarie precedentemente connesse alla cultura,
riorganizzando le forme simboliche in flussi culturali complessi, dove tradizione,
modernità e post-modernità coesistono, ma ogni elemento assume un significato
diverso rispetto al passato. Tuttavia, gli uomini di oggi consumano simboli come
quelli di ieri, e la sfera simbolica di un oggetto (o un concetto) continua a suscitare
il pensiero mitico: si pensi a temi diffusi come l’affondamento del Titanic,
l’attentato alle Twin Towers, la principessa Diana, oppure a questioni universali
come l’origine della vita, il tempo, la coppia, la madre, il padre, la procreazione, il
viaggio, la fratellanza, l’acqua, la torre, il baratro, la nudità, la verginità, la morte.
Perciò, l’antropologia culturale non può fare a meno degli strumenti
dell’antropologia simbolica (Butitta, 1996) e dell’obiettivo di comprendere, a livello teorico, i meccanismi dell’immaginario umano. Dunque, la definizione di cultura formulata da Tylor continua ad essere il miglior criterio organizzativo per la
raccolta e l’ordinamento dei dati etnografici, nonostante la pecca di essere stata
formulata in modo generico e poco adatto ad evidenziare gli aspetti più complessi
del fenomeno. La definizione universalista della cultura dello studioso mirava alla
descrittività e all’oggettività e, pur senza essersi distaccata completamente dalla
prescrittività e normatività, contiene un elemento, importantissimo, di fiducia
nell’uomo e nell’umanità, su cui si fonda l’unità psichica del genere umano. Tylor,
nonostante fosse incrostato dell’evoluzionismo che caratterizzava il suo tempo, ebbe il senso del relativismo culturale: anticipando quanto esattamente un secolo dopo sarà obiettato da Geertz (1995), sembrò persino porsi il problema di verificare
punto per punto se i fatti culturali analizzati dalla scienza della cultura mantenessero una effettiva lontananza dagli psichismi dello scienziato stesso.
17
La differenziazione sociale che, a partire da Gramsci (e poi soprattutto con Alberto M. Cirese,
1973, 1976), venne identificata con l’osmotica opposizione tra ceto egemone e ceto subalterno,
venne ingiustamente colpevolizzata di inutili scissioni su basi economiche dell’unità dello spirito
umano. Riteniamo, invece, che la dialettica egemone/subalterno consentì di cogliere aspetti della
religione e del mutamento culturale del tutto nuovi. Oggi, per esempio, essa può essere attualmente
interpretata come drastica opposizione generazionale tra il ceto che detiene una identità culturale
dominante (scritta od orale che sia) ed il ceto culturalmente depauperato, che, rincresce dirlo, si
concretizza nelle nuove generazioni, in apparenza poco coinvolte dalla verticalità storica cui
partecipano. Questo perché, nell’Era dell’informazione, la storia sociale viene frammentata dai media
e somministrata ai fruitori come un oggetto di consumo. Interessante è, in proposito, il contributo di
Michel de Certeau (1980), il quale ravvisa l’osmosi tra le stratificazioni sociali nel bricolage delle
classi popolari, cioè quel consumo critico e libero che permette di accettare e, nel contempo, negare il
prodotto somministrato dalla cultura dominante.